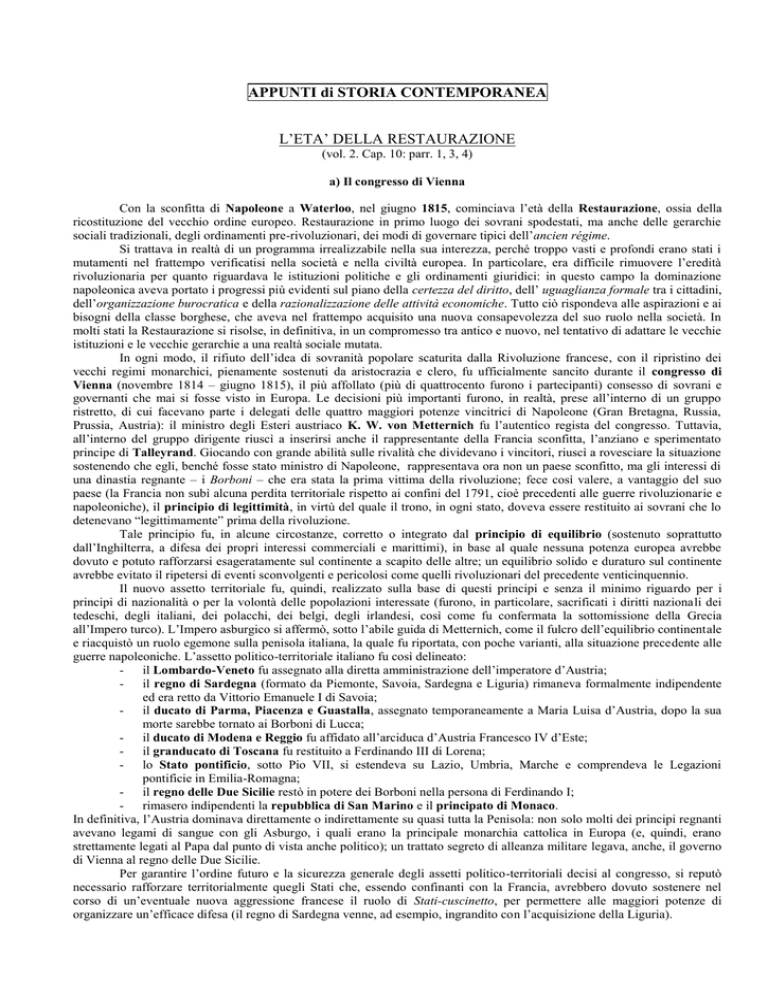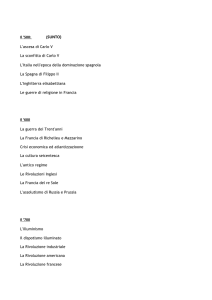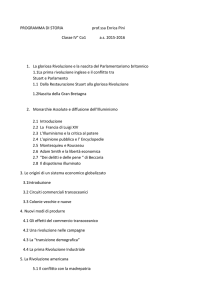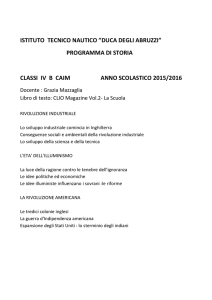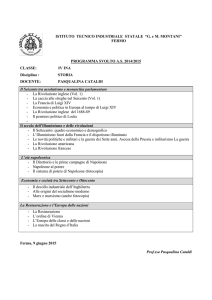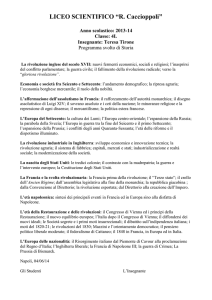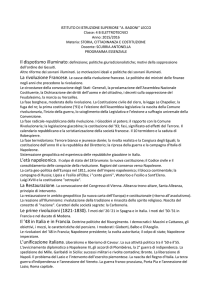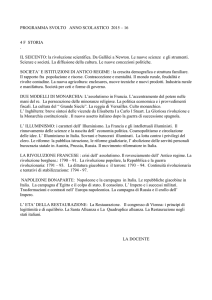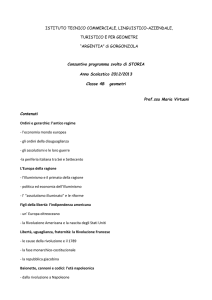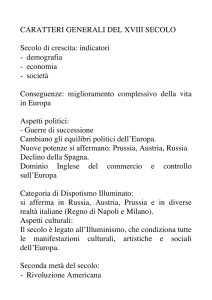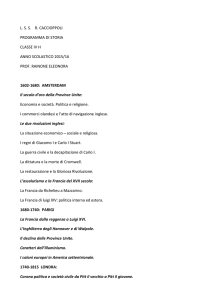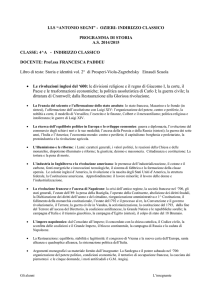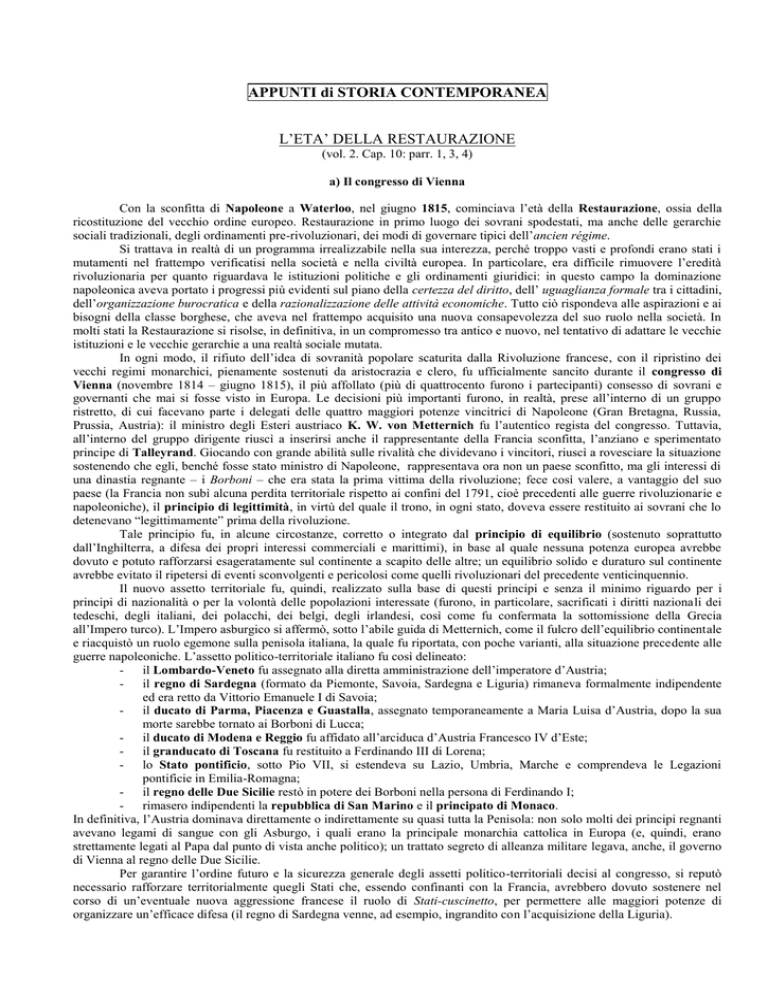
APPUNTI di STORIA CONTEMPORANEA
L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE
(vol. 2. Cap. 10: parr. 1, 3, 4)
a) Il congresso di Vienna
Con la sconfitta di Napoleone a Waterloo, nel giugno 1815, cominciava l’età della Restaurazione, ossia della
ricostituzione del vecchio ordine europeo. Restaurazione in primo luogo dei sovrani spodestati, ma anche delle gerarchie
sociali tradizionali, degli ordinamenti pre-rivoluzionari, dei modi di governare tipici dell’ancien régime.
Si trattava in realtà di un programma irrealizzabile nella sua interezza, perché troppo vasti e profondi erano stati i
mutamenti nel frattempo verificatisi nella società e nella civiltà europea. In particolare, era difficile rimuovere l’eredità
rivoluzionaria per quanto riguardava le istituzioni politiche e gli ordinamenti giuridici: in questo campo la dominazione
napoleonica aveva portato i progressi più evidenti sul piano della certezza del diritto, dell’ uguaglianza formale tra i cittadini,
dell’organizzazione burocratica e della razionalizzazione delle attività economiche. Tutto ciò rispondeva alle aspirazioni e ai
bisogni della classe borghese, che aveva nel frattempo acquisito una nuova consapevolezza del suo ruolo nella società. In
molti stati la Restaurazione si risolse, in definitiva, in un compromesso tra antico e nuovo, nel tentativo di adattare le vecchie
istituzioni e le vecchie gerarchie a una realtà sociale mutata.
In ogni modo, il rifiuto dell’idea di sovranità popolare scaturita dalla Rivoluzione francese, con il ripristino dei
vecchi regimi monarchici, pienamente sostenuti da aristocrazia e clero, fu ufficialmente sancito durante il congresso di
Vienna (novembre 1814 – giugno 1815), il più affollato (più di quattrocento furono i partecipanti) consesso di sovrani e
governanti che mai si fosse visto in Europa. Le decisioni più importanti furono, in realtà, prese all’interno di un gruppo
ristretto, di cui facevano parte i delegati delle quattro maggiori potenze vincitrici di Napoleone (Gran Bretagna, Russia,
Prussia, Austria): il ministro degli Esteri austriaco K. W. von Metternich fu l’autentico regista del congresso. Tuttavia,
all’interno del gruppo dirigente riuscì a inserirsi anche il rappresentante della Francia sconfitta, l’anziano e sperimentato
principe di Talleyrand. Giocando con grande abilità sulle rivalità che dividevano i vincitori, riuscì a rovesciare la situazione
sostenendo che egli, benché fosse stato ministro di Napoleone, rappresentava ora non un paese sconfitto, ma gli interessi di
una dinastia regnante – i Borboni – che era stata la prima vittima della rivoluzione; fece così valere, a vantaggio del suo
paese (la Francia non subì alcuna perdita territoriale rispetto ai confini del 1791, cioè precedenti alle guerre rivoluzionarie e
napoleoniche), il principio di legittimità, in virtù del quale il trono, in ogni stato, doveva essere restituito ai sovrani che lo
detenevano “legittimamente” prima della rivoluzione.
Tale principio fu, in alcune circostanze, corretto o integrato dal principio di equilibrio (sostenuto soprattutto
dall’Inghilterra, a difesa dei propri interessi commerciali e marittimi), in base al quale nessuna potenza europea avrebbe
dovuto e potuto rafforzarsi esageratamente sul continente a scapito delle altre; un equilibrio solido e duraturo sul continente
avrebbe evitato il ripetersi di eventi sconvolgenti e pericolosi come quelli rivoluzionari del precedente venticinquennio.
Il nuovo assetto territoriale fu, quindi, realizzato sulla base di questi principi e senza il minimo riguardo per i
principi di nazionalità o per la volontà delle popolazioni interessate (furono, in particolare, sacrificati i diritti nazionali dei
tedeschi, degli italiani, dei polacchi, dei belgi, degli irlandesi, così come fu confermata la sottomissione della Grecia
all’Impero turco). L’Impero asburgico si affermò, sotto l’abile guida di Metternich, come il fulcro dell’equilibrio continentale
e riacquistò un ruolo egemone sulla penisola italiana, la quale fu riportata, con poche varianti, alla situazione precedente alle
guerre napoleoniche. L’assetto politico-territoriale italiano fu così delineato:
- il Lombardo-Veneto fu assegnato alla diretta amministrazione dell’imperatore d’Austria;
- il regno di Sardegna (formato da Piemonte, Savoia, Sardegna e Liguria) rimaneva formalmente indipendente
ed era retto da Vittorio Emanuele I di Savoia;
- il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, assegnato temporaneamente a Maria Luisa d’Austria, dopo la sua
morte sarebbe tornato ai Borboni di Lucca;
- il ducato di Modena e Reggio fu affidato all’arciduca d’Austria Francesco IV d’Este;
- il granducato di Toscana fu restituito a Ferdinando III di Lorena;
- lo Stato pontificio, sotto Pio VII, si estendeva su Lazio, Umbria, Marche e comprendeva le Legazioni
pontificie in Emilia-Romagna;
- il regno delle Due Sicilie restò in potere dei Borboni nella persona di Ferdinando I;
- rimasero indipendenti la repubblica di San Marino e il principato di Monaco.
In definitiva, l’Austria dominava direttamente o indirettamente su quasi tutta la Penisola: non solo molti dei principi regnanti
avevano legami di sangue con gli Asburgo, i quali erano la principale monarchia cattolica in Europa (e, quindi, erano
strettamente legati al Papa dal punto di vista anche politico); un trattato segreto di alleanza militare legava, anche, il governo
di Vienna al regno delle Due Sicilie.
Per garantire l’ordine futuro e la sicurezza generale degli assetti politico-territoriali decisi al congresso, si reputò
necessario rafforzare territorialmente quegli Stati che, essendo confinanti con la Francia, avrebbero dovuto sostenere nel
corso di un’eventuale nuova aggressione francese il ruolo di Stati-cuscinetto, per permettere alle maggiori potenze di
organizzare un’efficace difesa (il regno di Sardegna venne, ad esempio, ingrandito con l’acquisizione della Liguria).
Affinché tutto ciò potesse meglio attuarsi, Austria Russia e Prussia si unirono il 26 settembre 1815 in una coalizione
permanente delegata a mantenere nel tempo gli equilibri interni alle varie nazioni e l’ordine internazionale, sulla base del
principio di intervento, con cui gli Stati aderenti alla Santa Alleanza (firmata, oltre che dai tre sovrani prioritariamente
interessati, anche dai sovrani di Francia, Sardegna, Paesi Bassi e Svezia) si impegnavano a intervenire con le armi per
reprimere le insurrezioni rivoluzionarie eventualmente scoppiate in qualunque paese europeo. L’Inghilterra rifiutò di firmare
questo patto per motivi ideologici (il diritto pubblico inglese respingeva l’affermazione dell’origine divina dell’autorità regia,
richiamata, invece, esplicitamente dai tre sovrani continentali), ma aderì poco dopo ad un organismo analogo, la cosiddetta
Quadruplice Alleanza. In questo modo, si legava esplicitamente il mantenimento dell’ordine internazionale all’ordine
interno ai singoli paesi, così come si affermava il diritto di altri paesi a ingerirsi negli affari interni di un paese terzo.
b) La Restaurazione in Europa e in Italia
Sul piano politico e istituzionale, la Restaurazione ebbe caratteri e intensità diversi a seconda dei paesi. Ovunque,
tuttavia, si ebbe un assestamento degli equilibri interni in senso conservatore. Ovunque il clima politico risentì della
rinnovata alleanza fra il potere temporale dei sovrani e il potere religioso delle Chiese.
Anche in Gran Bretagna – il paese in cui le istituzioni parlamentari erano nate – gli anni successivi al 1815 videro la
schiacciante prevalenza dell’ala destra del partito conservatore, che aveva la sua base nell’aristocrazia terriera e nell’alto
clero anglicano. La destra tory, per favorire gli interessi della grande proprietà terriera impose un forte dazio di importazione
sul grano, che manteneva elevati i prezzi interni. Questa politica sacrificava gli interessi dell’industria britannica e inaspriva
le tensioni sociali, spingendo verso l’alto il costo della vita, tanto che si verificarono numerose agitazioni operaie, sempre
duramente represse. Gradualmente, tuttavia, l’Inghilterra avrebbe ripreso la sua tradizionale politica di moderato riformismo,
sia dal punto di vista dei diritti politici sia dal punto di vista della politica sociale.
Nei più importanti Stati dell’Europa continentale che non avevano mai veramente vissuto l’esperienza dei regimi
rappresentativi (Austria, Prussia, Russia), la Restaurazione si risolse nella conferma del vecchio assolutismo settecentesco –
temperato da qualche iniziativa riformatrice – e nel blocco di ogni evoluzione in senso liberale.
Il caso più significativo di restaurazione “morbida” fu quello della Francia. Il nuovo re Luigi XVIII (fratello del
defunto Luigi XVI) promulgò una costituzione che concedeva ai francesi alcune limitate libertà (in tema di opinione, stampa
e culto) e prevedeva un Parlamento bicamerale (una Camera dei pari di nomina regia e una Camera dei deputati elettiva). La
carta costituzionale era presentata come una graziosa concessione del sovrano ai suoi sudditi (Charte octroyée, ossia elargita)
e il suo contenuto liberale era ulteriormente limitato sia dagli scarsi poteri di cui godeva la camera elettiva, sia dal carattere
restrittivo della legge elettorale, rigidamente legata al censo.
Nonostante ciò furono mantenute molte delle più importanti innovazioni del periodo napoleonico (codice civile,
ordinamento amministrativo, sistema scolastico statale) e, soprattutto, fu garantita l’inviolabilità di tutte le proprietà vecchie
e nuove (compresi i passaggi di proprietà dell’epoca rivoluzionaria). La moderazione del re – in realtà funzionale allo stato di
cose, dato che la borghesia aveva ormai acquisito un ruolo centrale nel paese – scontentava profondamente i legittimisti più
intransigenti (gli ultrarealisti, ultras) che sognavano un ritorno puro e semplice all’ancien régime.
In Italia, la Restaurazione dei vecchi Stati e delle vecchie dinastie comportò un rallentamento di quel processo di
sviluppo civile, economico, culturale e politico che, pur in modo parziale e contraddittorio, si era avviato durante l’età
napoleonica. Nel Regno di Sardegna la Restaurazione fu particolarmente dura e comportò l’abrogazione della legislazione
napoleonica, mentre nello Stato della Chiesa e nel Regno delle due Sicilie (in entrambi gli stati non mancò una dura
repressione) il ritorno all’assolutismo fu, in piccola parte, frenato dalla presenza di correnti moderate. Più illuminata fu la
politica seguita nel Granducato di Toscana, ove si ebbe una relativa tolleranza sul piano culturale; il governo si rivelò
tollerante e mite anche nel Ducato di Parma e Piacenza; viceversa si rivelò conservatore e repressivo il governo di Francesco
IV nel Ducato di Modena. Nel Lombardo-Veneto l’Austria, da un lato, esercitò uno stretto controllo sulla vita politica e
intellettuale, ma, dall’altro, si distinse per l’efficiente amministrazione che fece della Lombardia la regione più avanzata
d’Italia.
IL LIBERALISMO E LE SOCIETA’ SEGRETE
(Vol. 2. Cap. 10: parr. 2, 4)
a) Liberali, democratici, idea di nazione
Il termine liberalismo, entrato nel linguaggio corrente proprio all’inizio dell’800, serviva a designare non tanto una
corrente politica ben determinata, quanto un orientamento ideale, una visione del mondo fondata sull’idea di libertà quale si
era venuta definendo a opera della cultura illuministica e in alcune concrete esperienze politiche e costituzionali del ‘600700: il parlamentarismo britannico, la rivoluzione americana, l’89 francese. I nuovi ideali politici e civili erano stati diffusi in
Europa da milioni di contadini, artigiani, borghesi che avevano combattuto nelle armate francesi. Nonostante la sconfitta di
Napoleone e gli esiti del Congresso di Vienna, le nuove idee erano già profondamente radicate nella coscienza dei popoli
europei ed esprimevano i valori e la visione del mondo della classe borghese che si andava diffondendo con lo sviluppo della
società industriale.
Il liberalismo – che ideologicamente si contrapponeva ai sostenitori della restaurazione i quali rivendicavano una
rinnovata alleanza tra il trono e l’altare, cioè tra le monarchie assolute e le chiese – è una dottrina politico-economica, e
anche morale, che mette al centro di tutto la libertà dell’individuo nei confronti dell’autorità politica e religiosa.
Questa libertà si realizza concretamente nella storia attraverso il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali e
“naturali” dell’uomo: il diritto di pensare e di esprimere liberamente le proprie idee, di professare liberamente la propria fede,
di organizzarsi e di riunirsi pubblicamente, di utilizzare senza restrizioni le proprietà, il diritto di tutti i cittadini di essere
considerati uguali di fronte alla legge. Lo Stato ha dunque il compito di rappresentare e tutelare gli interessi di tutta la
collettività, attraverso assemblee elettive (il parlamento) e una carta costituzionale che definisca i termini fondamentali del
rapporto tra i cittadini e stabilisca i limiti dell’autorità statale. A uno stato autoritario, fondato sulla monarchia assoluta per
diritto divino, il liberalismo contrapponeva l’idea di uno stato di diritto nascente dalla volontà dei cittadini e garante delle
libertà (civili e politiche) dei cittadini stessi.
Sul piano economico il liberalismo (che in questo campo prendeva il nome di liberismo) proclamava una completa
libertà d’iniziativa economica: lo stato doveva limitarsi a rendere più libero possibile lo sviluppo delle attività imprenditoriali
e commerciali (lassaiz faire, lassaiz passer).
Nel movimento liberale, tuttavia, non vi era un accordo unanime: al suo interno si muovevano ipotesi e tendenze
politiche diverse. In particolare, si costituirono due gruppi distinti, i liberali moderati e i democratici. I primi erano
espressione degli interessi della ricca borghesia di proprietari terrieri, imprenditori, banchieri, uomini d’affari; giudicavano
negativamente la rivoluzione francese, per il carattere violento e popolare che aveva assunto nei momenti più radicali;
intendevano limitare la partecipazione alla vita politica (diritto di voto limitato sulla base del censo) esclusivamente alle
classi benestanti, escludendo i ceti popolari; consideravano la monarchia costituzionale come la migliore forma di stato,
perché assicurava il compromesso tra le nuove idee e i vecchi poteri monarchici. I secondi erano espressione degli interessi
della piccola e media borghesia intellettuale e artigianale; giudicavano positivamente la rivoluzione francese, proprio per il
carattere popolare e radicale che essa aveva assunto nei momenti più estremi; si battevano per il suffragio universale
maschile; consideravano la repubblica come la forma di stato più coerente con il principio della sovranità popolare e con
l’uguaglianza di tutti i cittadini.
In molti paesi europei, un ulteriore elemento di coesione fra tutti gli avversari del vecchio ordine assolutista era dato
dall’esigenza di liberazione da un dominio straniero, dalla rivendicazione dell’indipendenza nazionale. Per un verso
l’affermazione degli ideali nazionali nel primo ‘800 era strettamente legata al Romanticismo e si fondava sulla riscoperta
delle tradizioni e delle radici culturali profonde dei singoli popoli. Per un altro verso, tuttavia, l’idea di nazione affondava le
sue radici nell’Illuminismo e nella cultura democratico-rivoluzionaria del ‘700. Il diritto all’indipendenza poteva infatti
essere considerato come una estensione dei diritti fondamentali del cittadino dall’individuo alla nazione: in questo senso fu
inteso da tutti quei patrioti che coniugarono la lotta per l’indipendenza nazionale con quella per la libertà e per la democrazia.
b) Le società segrete
A Vienna i diplomatici austriaci, prussiani, russi e inglesi si erano accordati sulla base del principio di legittimità –
secondo il quale i vecchi sovrani avevano il diritto di ritornare sui troni che possedevano legittimamente prima della
espansione territoriale napoleonica – e del principio dell’equilibrio – secondo il quale nessuna potenza europea doveva
acquisire potenza e prestigio a danno delle altre, e ciò per garantire nel tempo l’ordine restaurato in Europa; di conseguenza,
le decisioni prese al Congresso dalle grandi potenze europee non avevano tenuto in nessun conto le tendenze all’unificazione
nazionale presenti in alcune zone dell’Europa, come Germania, Italia, Polonia, Belgio, Irlanda e Grecia.
Ciò, insieme alla restaurazione dei vecchi poteri politici assoluti e di una parte dei vecchi privilegi delle classi
d’antico regime, si scontrava tuttavia con l’evoluzione moderna e borghese che la rivoluzione francese e l’età napoleonica
avevano impresso a molti aspetti sociali, economici, politici e culturali dei paesi europei. Per questo motivo, a partire
dall’inizio degli anni ’20, l’ordine imposto all’Europa dal Congresso di Vienna fu seriamente minacciato da una successione
di moti insurrezionali, a carattere liberale, democratico e nazionale, che si propagavano da un paese all’altro, per la presenza
di una fitta rete di collegamenti internazionali fra i diversi centri rivoluzionari. In questo periodo, infatti, si diffusero con
grande rapidità organizzazioni clandestine che erano nate, per lo più, nel ‘700 o in età napoleonica.
Dal momento che in quasi tutti i paesi europei l’espressione del dissenso politico era impedita, o gravemente
limitata, sette e società segrete divennero nell’età della Restaurazione il principale strumento di lotta politica. Pur essendo
attive anche società di orientamento legittimista e reazionario, più numerose e importanti erano però le sette di tendenza
liberale o democratica.
L’obiettivo comune a queste ultime era la trasformazione dello Stato in senso parlamentare e costituzionale
attraverso la conquista di una costituzione liberale. A questo obiettivo alcune società segrete (greche, polacche, tedesche e
italiane) aggiungevano quello dell’indipendenza dalla dominazione straniera. Altre sette, di tendenza radicale, miravano a
una più netta trasformazione della società, ispirandosi alle teorie comunistiche ed egualitarie di Babeuf e di Filippo
Buonarroti, che propugnavano l’ideale di una società in cui i beni fossero riuniti in un unico patrimonio comune, con
l’abolizione della proprietà privata. La più importante e più diffusa setta fu comunque la Carboneria, presente soprattutto in
Italia e in Spagna, i cui aderenti si ispiravano a ideali di costituzionalismo e di liberalismo moderato.
Per sfuggire alla fittissima rete del controllo poliziesco, le società segrete erano costrette a darsi una struttura interna
rigida e chiusa, attraverso complesse norme di comportamento, che assicuravano la segretezza, e una severa gerarchia (i
membri delle sette, ordinati gerarchicamente, ignoravano talora persino i programmi e l’identità dei loro capi). Questa forma
di organizzazione non consentiva un’ampia partecipazione alle iniziative che venivano intraprese: era difficile svolgere
un’azione di propaganda che diffondesse gli scopi e i programmi delle società tra il popolo. A questo sostanziale isolamento
contribuiva, inoltre, la ristretta base su cui le sette poggiavano: pochissimi gli artigiani e in genere i popolani, qualche
membro dell’aristocrazia liberale, qualche esponente della borghesia del commercio e delle professioni, ma soprattutto
intellettuali, studenti e militari (ufficiali e sottufficiali formatisi nel periodo napoleonico). Furono proprio i militari a dare
inizio alla prima ondata rivoluzionaria che scosse l’Europa all’inizio degli anni ’20.
I MOTI LIBERALI DEL ’20-21 E DEL ’30-31
(Vol. 2. Cap.10: parr. 4, 6)
L’ondata rivoluzionaria partì dalla Spagna: il 1° gennaio 1820 alcuni reparti militari, concentrati nel porto di Cadice
in attesa di essere imbarcati per l’America dove le colonie spagnole erano in precedenza insorte proclamando
l’indipendenza, si ammutinarono; in pochi giorni la rivolta dilagò estendendosi ad altri reparti e il re Ferdinando VII fu
costretto a richiamare in vigore la Costituzione che, nel 1812, le Cortes (il Parlamento spagnolo) avevano votato a Cadice
(assediata dai francesi). Gli avvenimenti spagnoli ebbero come immediata conseguenza una generale ripresa dell’attività
rivoluzionaria, che tra l’estate del 1820 e la primavera del 1821 si manifestò nel Regno delle due Sicilie, in Portogallo, in
Lombardia (qui, in realtà, ogni ipotesi rivoluzionaria fu stroncata, prima ancora di nascere, dall’attività della polizia austriaca
che scoprì, nell’ottobre 1820, un’organizzazione carbonara e ne arrestò i capi) e nel Piemonte sabaudo.
Dopo una fase iniziale favorevole, in cui i rivoluzionari ottennero la concessione da parte dei sovrani di costituzioni
liberali, le potenze aderenti alla Santa alleanza (il trattato, nato nel settembre 1815, che impegnava i contraenti a prestarsi
reciprocamente aiuto contro chiunque minacciasse l’ordine, interno ai singoli stati ed internazionale, stabilito a Vienna)
decisero di intervenire militarmente. La Francia si occupò della repressione del moto nella penisola iberica, l’Austria di
quella nella penisola italiana.
La repressione, sia in Spagna sia in Italia, fu anche facilitata dall’incertezza nell’azione dimostrata dai liberali, dalle
discordie interne fra moderati e radicali, dalla poca chiarezza dei programmi (spesso determinati da esigenze e da una visione
politica più locali che nazionali) di questi gruppi rivoluzionari; soprattutto emerse l’isolamento delle organizzazioni
patriottiche e liberali dal resto della società nella quale operavano. Infatti la borghesia commerciale, industriale e agraria, che
costituiva il principale referente sociale del liberalismo, ancora debole e immatura restò poco coinvolta dalle iniziative della
Carboneria e delle altre sette, mentre i ceti popolari apparvero del tutto indifferenti.
Nel quadro complessivo, per cui il fronte conservatore uscì rinsaldato dalla crisi, fecero eccezione – nel corso degli
anni venti – la Grecia, che ottenne l’indipendenza dall’Impero turco nel settembre 1829 (tale rivoluzione, iniziata nel 1821 e
appoggiata da Russia Inghilterra e Francia per motivi di interesse politico in quell’area del Mediterraneo, segnò il primo
mutamento della sistemazione politica dell’Europa fissata dal congresso di Vienna e inflisse un duro colpo al principio
reazionario dell’immutabilità delle decisioni prese), e le colonie spagnole e portoghesi in Sud America, che conquistarono
l’indipendenza entro il 1823 (il moto d’indipendenza era iniziato nel 1808).
Dieci anni più tardi, l’Europa fu attraversata da una nuova ondata rivoluzionaria. I moti del 1830-31 ebbero,
tuttavia, conseguenze più profonde e durature, soprattutto perché il primo e più importante movimento insurrezionale ebbe
luogo in Francia e si concluse con un sostanziale successo.
La rivoluzione che scoppiò a Parigi nel luglio 1830 fu la diretta conseguenza del tentativo messo in atto dal re Carlo
X (salito al trono nel 1824) e dagli ambienti ultrarealisti (ultras) di restringere il più possibile le libertà costituzionali
garantite dalla Carta del 1814 e, più in generale, di mettere in atto quella restaurazione integrale cui il predecessore Luigi
XVIII aveva saggiamente rinunciato quando la monarchia borbonica era stata reinsediata sul trono di Francia. Contro la
politica di Carlo X si schierarono non solo i democratici e gli intellettuali liberal-moderati, ma anche la grande borghesia
degli affari e della finanza e un’ala consistente della stessa aristocrazia.
In risposta a un tentativo di colpo di stato messo in atto dal re e dal suo governo (il re aveva emanato quattro
ordinanze, che sospendevano la libertà di stampa, scioglievano la Camera, modificavano la legge elettorale rendendola
ancora più restrittiva e convocavano nuove elezioni), il popolo di Parigi scese in piazza e, dopo tre giorni di duri scontri con
le truppe regie (27, 28 e 29 luglio), costrinse Carlo X ad abbandonare la capitale. Protagoniste della rivoluzione erano state le
masse popolari, soprattutto artigiane, guidate dai club repubblicani e giacobini: per bloccare un processo rivoluzionario, di
cui erano in molti a temere gli sviluppi, e per dare agli eventi uno sbocco liberal-moderato, il 9 agosto il Parlamento
proclamò Luigi Filippo d’Orléans, cugino del re appena deposto, “re dei francesi per volontà della nazione”, una formula
che conciliava il principio monarchico con quello della sovranità popolare (si accentuava così il carattere costituzionale della
monarchia francese).
Il successo della insurrezione di luglio aprì nuovi spazi all’iniziativa delle forze liberali e democratiche europee: il
Belgio insorse nell’agosto del 1830 e, grazie all’appoggio della Francia e dell’Inghilterra (il delinearsi dell’intesa francoinglese segnava così l’incrinarsi dell’equilibrio conservatore stabilito a Vienna nel 1815), ottenne l’indipendenza dall’Olanda
nel gennaio 1831.
Esito opposto ebbero invece i moti rivoluzionari scoppiati in Polonia e nell’Italia centro-settentrionale, dove inglesi
e francesi non avendo interessi economici da difendere non intervennero, lasciando campo libero alla repressione militare
operata rispettivamente dalla Russia e dall’Austria.
In Italia, le insurrezioni scoppiarono all’inizio del 1831 nei Ducati di Modena e di Parma e in una parte dello Stato
pontificio, a seguito di una precedente trama settaria che aveva il suo centro nel Ducato di Modena e si giovava dell’ambiguo
appoggio dello stesso duca Francesco IV. Personaggio ambizioso, il duca sperava di allargare il proprio dominio nel centronord della penisola ed era, per questo, entrato in contatto con alcuni esponenti delle società segrete, tra cui il commerciante di
Carpi Ciro Menotti e l’avvocato Enrico Misley, ma aveva poi cambiato idea e fatto arrestare i capi della congiura.
Nonostante questo, l’insurrezione scoppiò ugualmente e, questa volta, a muoversi non furono tanto i militari, quanto
i ceti borghesi, appoggiati dall’aristocrazia liberale e sostenuti in qualche caso da una non trascurabile mobilitazione
popolare. L’esito del moto, tuttavia, fu nuovamente condizionato negativamente dalle fratture interne al movimento
rivoluzionario - sia dal persistere delle divisioni municipaliste, sia dal riproporsi del contrasto fra democratici e moderati cosicché in marzo il governo austriaco, una volta accertate le intenzioni di Luigi Filippo che dichiarò la neutralità della
Francia (il nuovo re affermò che la Francia non intendeva ripetere le esperienze del passato e tentare di esportare la
rivoluzione), poté procedere indisturbato a un nuovo intervento militare, cui seguì l’inevitabile repressione (Menotti fu
condannato a morte e impiccato).
DEMOCRATICI E LIBERALI IN ITALIA
(Vol. 2. Cap.12: parr. 1, 2)
Il fallimento dei moti liberali determinò, all’inizio degli anni trenta, la crisi irreversibile della Carboneria e delle
altre società segrete, stimolando una più matura riflessione sui problemi politici economici e sociali della penisola, sia
all’interno delle forze democratiche che di quelle liberal-moderate. Ad animare questa crescita del movimento
risorgimentale erano le classi medie borghesi: industriali, commercianti ma anche moderni proprietari terrieri che stavano,
ormai, rendendosi conto che il progresso economico e sociale e la possibilità stessa di accumulare nuove ricchezze
dipendevano dalla costruzione di un mercato nazionale, più vasto e articolato di quello dei singoli piccoli stati, e dalla libertà
dei commerci. Si trattava di una coscienza che maturava mentre il paese, pur rimanendo in generale arretrato, faceva
registrare una tendenza lenta ma costante alla crescita produttiva. L’emergere di una consapevole istanza politica unitaria si
manifestò, inizialmente, all’interno delle forze di ispirazione democratica.
a) Mazzini e la Giovine Italia
Giuseppe Mazzini era nato a Genova nel 1805 da una famiglia della borghesia medio-alta; si era accostato fin dagli
anni giovanili alle idee democratiche e patriottiche e, nel 1827, aveva aderito alla Carboneria. Gli insuccessi
dell’organizzazione in cui militava lo convinsero che essi nascevano da una insufficiente direzione politica: insufficienza del
programma, che non superava una visione provinciale e regionale del problema italiano; incapacità di riconoscere fino in
fondo l’esigenza della rivoluzione e della conquista politica del popolo; sfiducia in se stessi, attesa dell’aiuto straniero e
tendenza a scendere a compromessi con i propri nemici.
Per superare tali limiti, nell’estate del 1831, Mazzini fondò una nuova organizzazione, la Giovine Italia, che
avrebbe dovuto essere segreta nell’organizzazione interna, per garantire la sicurezza dei militanti, ma pubblica nella
propaganda del programma politico alle masse popolari. Il programma politico di Mazzini è riassumibile in tre slogan:
1. Dio e popolo. Quella mazziniana era una concezione politica personalissima, in cui l’originaria ispirazione
democratica si mescolava con una forte componente mistico-religiosa: Dio si identificava con lo spirito insito nella
storia e nella stessa umanità, spirito che spingeva ad un continuo progresso; la rivendicazione dei diritti degli
individui e delle nazioni non poteva essere separata dalla consapevolezza dei doveri dell’uomo e dalla coscienza di
una missione spettante ai popoli quali strumenti di un disegno divino. Ma i popoli avrebbero potuto assolvere alla
loro missione storica solo se uniti in nazioni (Mazzini credeva fermamente nella superiorità del gruppo rispetto
all’individuo); all’Italia, in particolare, spettava il compito di abbattere i pilastri principali del vecchio ordine
(l’Impero asburgico e lo Stato pontificio), guidando la rivoluzione di tutti i popoli europei oppressi.
2. Educazione e insurrezione. I militanti rivoluzionari, propagandando apertamente principi e obiettivi, dovevano
svolgere un’opera continua di educazione politica del popolo, per renderlo pronto a realizzare un’insurrezione
generale, cui tutti dovevano partecipare senza distinzioni di classe.
3. Unità e repubblica. Questi erano gli obiettivi politici più adatti e coerenti a mobilitare unitariamente il popolo.
La necessità di mantenere la concordia di tutte le forze nazionali in vista dell’obiettivo, per lui prioritario,
dell’indipendenza e dell’unità nazionale spiega le posizioni assunte da Mazzini sulla questione contadina e sociale. Mazzini
non ignorava i problemi sociali ed era favorevole a riforme anche audaci, ma difendeva il diritto di proprietà come base
dell’ordine sociale, poiché l’impostazione classista della lotta sarebbe stata un elemento di divisione dell’unità spirituale e
politica del popolo e, quindi, di debolezza. Ma il rifiuto della prospettiva di un mutamento rivoluzionario della distribuzione
fondiaria fu il punto di maggiore insufficienza del programma e dell’azione del movimento democratico, cui aderirono gli
artigiani e gli operai delle grandi città italiane e gli intellettuali, ma non la massa enorme dei contadini, che costituivano la
grande maggioranza della popolazione del paese.
Questo spiega perché, nonostante l’entusiasmo che animava i democratici mazziniani, tutti i tentativi insurrezionali (nel
Regno di Sardegna, nelle Legazioni pontificie, a Rimini, in Calabria) organizzati dalla Giovine Italia negli anni Trenta e
Quaranta fallissero. Il ripetersi di episodi insurrezionali dall’esito negativo contribuì ad alimentare le critiche nei confronti
dei metodi mazziniani e fornì nuovi argomenti alle polemiche di parte moderata contro le strategie rivoluzionarie.
b) Nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo
Nel corso degli anni ’40, il dibattito politico italiano si allargò e si arricchì di nuove voci. La principale novità fu il
maturare di un orientamento moderato, che si differenziava nettamente sia dal tradizionalismo conservatore e legittimista sia
dal radicalismo repubblicano di Mazzini e cercava, per il problema italiano, soluzioni graduali e indolori, tali da non
comportare l’uso della violenza e lo scontro con le autorità costituite.
Nel tentativo di conciliare la causa liberale e patriottica con la religione cattolica e col magistero della Chiesa di
Roma, si formò una scuola di pensiero che fu poi definita neoguelfa, il cui principale rappresentante fu Vincenzo Gioberti,
autore del libro Del primato morale e civile degli italiani (1843). Il primato di cui parlava l’autore era quello che veniva
all’Italia dall’essere sede del papato e dall’averne condiviso nel corso dei secoli la missione di civiltà. Per questo Gioberti
proponeva una confederazione fra gli Stati italiani, ognuno retto dal suo legittimo sovrano, presieduta dal Papa.
Il liberale piemontese Cesare Balbo, autore de Le speranze d’Italia (1844), auspicava, invece, che a guidare la
confederazione italiana fosse la dinastia piemontese dei Savoia e si poneva, inoltre, il problema, trascurato da Gioberti, della
presenza austriaca in Italia, auspicando che il ritiro dell’Austria si realizzasse con mezzi diplomatici, assecondando la
“naturale” tendenza dell’Impero asburgico a spostare il centro dei suoi interessi verso l’Europa centro orientale, in particolare
verso i Balcani dove si approfondiva la crisi dell’Impero turco. L’ ipotesi federalista si contrapponeva, quindi, alla linea
mazziniana (fondata sull’obiettivo dell’unità repubblicana) anche sul piano dei mezzi, dato che affidava le sue speranze al
gioco politico-diplomatico delle potenze (nel quale avrebbe dovuto inserirsi il Piemonte) invece che alla guerra di popolo.
Nei medesimi anni, una corrente federalista, democratica e repubblicana si sviluppava in Lombardia. Ne era
capofila il milanese Carlo Cattaneo, erede della tradizione di pragmatismo e riformismo che aveva le sue radici nella cultura
illuministica. Cattaneo, che aveva interessi culturali vastissimi orientati soprattutto verso il campo economico e sociale,
puntava sulle riforme politiche e sullo sviluppo economico all’interno dei singoli Stati (con una particolare insistenza sui
temi del liberismo doganale, delle vie di comunicazione e dell’istruzione pubblica). L’obiettivo finale, a suo parere, avrebbe
dovuto essere una confederazione repubblicana, sul modello degli Stati Uniti o della Svizzera, che lasciasse ampi spazi di
autonomia alle istanze della vita locale.
c) Il biennio delle riforme (1846-47)
Nel biennio 1846-47, il moto riformatore che si era lentamente avviato negli anni precedenti conobbe un’improvvisa
accelerazione e l’opinione pubblica italiana visse una stagione di intensa mobilitazione e di febbrile attesa di grandi
mutamenti. L’evento iniziale in questo senso fu l’elezione al soglio pontificio, nel giugno 1846, di Pio IX (cardinale
Giovanni Maria Mastai Ferretti), che scelto in alternativa al capofila dello schieramento conservatore, cardinale Pietro
Lambruschini, si guadagnò le simpatie dell’opinione pubblica liberale.
Il nuovo papa concesse un’ampia amnistia per i detenuti politici e fece una serie di concessioni moderatamente
liberali, che diedero ulteriore stimolo all’agitazione per le riforme e alla propaganda patriottica in tutti gli Stati italiani e nello
stesso Lombardo-Veneto austriaco. Fra l’estate e l’autunno del ’47, il moto riformatore dilagò in tutta Italia,
accompagnandosi in molti casi con tumulti popolari a sfondo sociale, legati alle conseguenze della crisi economica europea: i
sovrani di alcuni stati (Piemonte, Toscana e Stato della Chiesa) furono indotti ad alcune concessioni, peraltro non sostanziali.
In novembre Carlo Alberto re di Sardegna, Leopoldo II granduca di Toscana e Pio IX sottoscrissero gli accordi preliminari
per una Lega doganale italiana, che rappresentava il primo passo verso l’unificazione nazionale.
LE RIVOLUZIONI DEL 1848
(Vol. 2. Cap.12: parr. 3, 4; Cap.13: par. 2)
a) Cause e caratteri generali
Nel 1848 l’Europa fu sconvolta da una crisi rivoluzionaria di ampiezza e di intensità eccezionali. Un moto così vasto non
sarebbe stato possibile se non fosse stato favorito da alcuni fattori comuni, presenti, in gradi diversi, nell’intera società
europea:
1. La situazione economica: nel biennio 1846-47 l’Europa aveva attraversato una fase di grave crisi economica,
causata originariamente da un fenomeno di sottoproduzione agricola, che determinando una vertiginosa salita dei
prezzi dei prodotti agricoli gettò nella miseria i ceti meno abbienti, ma si trasmise anche al settore industriale perché
i beni di largo consumo rimasero invenduti, con il risultato che molte fabbriche e manifatture furono costrette a
dichiarare fallimento; i fallimenti a catena fecero lievitare la disoccupazione, che a sua volta prosciugò ulteriormente
i consumi; l’Europa scoprì una nuova malattia economica, la crisi di sovrapproduzione industriale.
2.
3.
4.
5.
L’aspetto sociale: la crisi determinò uno stato di profondo malcontento nelle classi popolari, generando forti tensioni
e contrasti sociali, e ciò spiega la partecipazione di larghi strati operai e popolari alle rivoluzioni; la questione
sociale stava per diventare un problema politico centrale nella società moderna.
Le contraddizioni politiche: la borghesia, agraria commerciale finanziaria e industriale, si era fortemente sviluppata
in Europa, nei decenni precedenti, e aveva espresso una concezione dello stato e della società (il liberalismo) che
rispondeva alla necessità di sviluppo dell’economia capitalistica e dunque ai suoi interessi; tale processo veniva
tuttavia a scontrarsi sempre più direttamente con le istituzioni politiche e amministrative chiuse e conservatrici
restaurate dal Congresso di Vienna e dominanti in gran parte degli stati europei; la richiesta di libertà politiche e di
democrazia, variamente intrecciata – in Italia, in Germania e nell’Impero asburgico – alla spinta verso
l’emancipazione nazionale, fu il contenuto dominante delle insurrezioni.
La tradizione rivoluzionaria: fondamentale fu l’azione consapevole svolta dai democratici di tutta Europa, in
particolare dagli intellettuali, depositari di una tradizione comune che affondava le sue origini nella rivoluzione
francese e si era mantenuta viva nei moti del 1820-21 e del 1830-31.
Un nuovo protagonista politico e sociale: se per un verso il 1848 chiude simbolicamente un’epoca, quella delle
rivoluzioni liberali e democratiche legate all’iniziativa della borghesia, per un altro verso ne apre una nuova, nella
quale la classe operaia si presenta – per la prima volta – come una componente sociale autonoma, capace di
costruire, sia pure in modo ancora limitato, un programma sociale e politico indipendente.
b) La rivoluzione in Francia
In Francia, la “monarchia liberale” di Luigi Filippo d’Orléans si reggeva sul precario equilibrio tra vecchie classi
aristocratiche, grandi magnati della finanza e borghesia industriale, ma la stessa maturazione economica, civile e culturale
della società francese, favorita dal regime liberale, faceva apparire sempre meno tollerabili i limiti oligarchici di quel regime
e la politica ultramoderata del re e del governo. La crisi economica, che colpì non solo le classi popolari ma anche i profitti
della borghesia affaristica e industriale, ridusse ulteriormente i consensi nei confronti del sistema di potere.
Si andò così coalizzando un vasto fronte di opposizione al governo, che andava dai liberali ai democratici, dai
bonapartisti (si richiamavano all’esperienza di Napoleone) ai socialisti. Per i democratici, in particolare, l’obiettivo da
raggiungere era il suffragio universale maschile. Fu proprio il divieto, da parte del governo, di una manifestazione
dell’opposizione per chiedere l’allargamento del suffragio, che innescò la crisi rivoluzionaria il 22 febbraio a Parigi. Dopo
due giorni di barricate e di violenti scontri, il 24 febbraio Luigi Filippo abbandonò la capitale, dove si formò un governo
repubblicano (la cosiddetta Seconda Repubblica).
Nel governo figuravano tutti i capi delle varie componenti dell’opposizione, compresi due esponenti socialisti, un
fatto nuovo e sconvolgente nella storia europea. Sotto la pressione popolare il nuovo governo pose al centro della sua azione
l’allargamento dei diritti politici e i problemi del lavoro: venne introdotto il suffragio universale maschile, fu eliminata la
pena di morte per i reati politici, fu abolita la schiavitù nelle colonie, fu fissata in dieci ore la giornata lavorativa a Parigi
(undici nelle province), fu affermato il principio del diritto al lavoro.
Per dare attuazione a quest’ultimo punto, furono istituiti gli ateliers nationaux (officine nazionali) allo scopo di
aiutare i lavoratori colpiti dalla disoccupazione, che venivano impiegati in lavori di pubblica utilità. L’esperimento poneva,
tuttavia, gravi problemi alle finanze statali e introduceva un motivo di profondo contrasto in seno allo schieramento
repubblicano, la cui ala moderata considerava pericoloso – e incompatibile con i principi del liberismo economico – un
intervento diretto dello Stato nel mercato della manodopera. Una prima secca sconfitta per le correnti di estrema sinistra
venne dalle elezioni per l’Assemblea costituente, che si tennero il 23 aprile 1848: i vincitori furono i repubblicani moderati,
che costituirono l’ossatura del nuovo governo da cui furono esclusi i socialisti.
Il governo emanò subito un decreto con cui si stabiliva la chiusura degli ateliers nationaux. Per reazione, il 23
giugno oltre cinquantamila popolani (fra cui molti ex dipendenti degli ateliers) scesero in piazza. L’Assemblea costituente
ordinò all’esercito di procedere alla repressione, che fu condotta nei giorni successivi con spietata durezza: migliaia di insorti
trovarono la morte. Le tragiche giornate di giugno segnarono una svolta decisiva non solo nella storia francese: agli occhi
della borghesia di tutta Europa, la rivolta dei lavoratori parigini dava corpo all’incubo della rivoluzione sociale, allo “spettro
del comunismo”. Tutta la società francese, dalla borghesia urbana al clero, ai contadini irritati per l’aumento delle tasse
(necessario per finanziare gli ateliers), fu attraversata da un’ondata di riflusso conservatore.
In novembre l’Assemblea costituente approvò la nuova costituzione, che prevedeva un presidente della Repubblica
eletto direttamente dal popolo e un’unica assemblea legislativa anch’essa eletta a suffragio universale. Alle elezioni
presidenziali (10 dicembre) i repubblicani si presentarono divisi, mentre i conservatori di ogni gradazione fecero blocco sulla
candidatura di Luigi Napoleone Bonaparte, figlio di un fratello dell’imperatore. Questi seppe offrire ampie assicurazioni
alla destra conservatrice e clericale, mentre garantiva, per la sola forza del suo nome, una sicura presa su vasti strati di
elettorato popolare: venne così eletto con una valanga di suffragi e ciò sancì la fine della fase democratica della Seconda
Repubblica.
Negli anni successivi, si accentuò l’evoluzione della situazione politica in senso conservatore. Dopo aver sfruttato
l’appoggio della destra parlamentare, Bonaparte operò un progressivo rafforzamento dei propri poteri presidenziali, finché il
2 dicembre 1851, con l’appoggio dell’esercito, sciolse d’autorità la Camera. Un plebiscito a suffragio universale sanzionò a
maggioranza schiacciante l’operato di Bonaparte. Nel dicembre dell’anno successivo, un nuovo plebiscito approvava, con
una maggioranza ancor più schiacciante di quella dell’anno precedente, la restaurazione dell’impero: Luigi Bonaparte
assumeva così il nome di Napoleone III. Nasceva così il secondo Impero, che avrebbe basato la propria autorità su un
esercito ben organizzato e su un potente corpo di polizia, oltre che su istituzioni amministrative rigidamente centralizzate e
sottoposte al controllo di una burocrazia di nomina esclusivamente imperiale. La svolta autoritaria ottenne l’appoggio della
ricca borghesia, del clero e del ceto agrario, nonché della maggior parte dei contadini, e fu consolidata dalla prospera
situazione economica che si sarebbe determinata negli anni cinquanta e sessanta.
c) La rivoluzione in Italia e la prima guerra di indipendenza
Il moto rivoluzionario, iniziato a Parigi alla fine di febbraio ‘48, si propagò in poche settimane a gran parte
dell’Europa. Nell’Impero asburgico e nella Confederazione germanica gli echi degli avvenimenti parigini fecero esplodere
una situazione già tesa: qui lo scontro principale fu combattuto fra la borghesia liberale (con l’appoggio di consistenti settori
delle classi popolari) e le strutture politiche dell’ancien régime. Il primo importante episodio insurrezionale ebbe luogo a
Vienna il 13 marzo; da qui i tumulti rivoluzionari si trasmisero, in successione, a Budapest, Venezia, Milano, Berlino e
Praga.
In Italia, in realtà, la situazione era in fermento già dall’inizio dell’anno. Il 12 gennaio la sollevazione di Palermo –
una sollevazione legata soprattutto alle tradizionali rivendicazioni autonomistiche dei siciliani – indusse Ferdinando II di
Borbone ad annunciare la concessione di una costituzione nel Regno delle due Sicilie. Questo evento ebbe l’effetto di
rafforzare l’agitazione costituzionale in tutto il resto d’Italia. Spinti dalla pressione popolare e dell’opinione pubblica liberale,
Carlo Alberto, Leopoldo II e Pio IX si decisero a concedere la costituzione nei propri Stati.
Erano tutte costituzioni a carattere fortemente moderato: la più importante di tutte, lo Statuto che fu promesso da
Carlo Alberto l’8 febbraio e che sarebbe poi diventato la legge fondamentale del Regno d’Italia, non era una costituzione
rigida (le leggi costituzionali potevano essere modificate dalla procedura legislativa normale) e prevedeva una Camera
elettiva (a suffragio ristretto sulla base della ricchezza), un Senato di nomina regia e una stretta dipendenza del governo dal
sovrano (poiché i ministri erano responsabili del loro operato di fronte al re e non al parlamento). Mentre si andava
delineando una soluzione costituzionale-moderata nei maggiori Stati della penisola, giunsero in Italia le notizie delle
rivoluzioni scoppiate a Parigi e a Vienna.
Venezia si ribellò il 17 marzo e il 23 un governo provvisorio presieduto dal capo dei democratici Daniele Manin
proclamava la costituzione della Repubblica veneta. A Milano l’insurrezione iniziò il 18 marzo e si protrasse per cinque
giorni (le cinque giornate): furono soprattutto gli operai e gli artigiani a sostenere il peso degli scontri, che costarono agli
insorti circa quattrocento morti. La direzione delle operazioni fu assunta da un “consiglio di guerra” composto
prevalentemente da democratici e guidato da Carlo Cattaneo. Anche gli esponenti dell’aristocrazia liberale finirono, dopo
molte esitazioni, per appoggiare la causa degli insorti e diedero vita, il 22 marzo, a un governo provvisorio. Il giorno stesso il
contingente austriaco comandato dal maresciallo Radetzky si ritirò all’interno del cosiddetto quadrilatero (fortezze di
Verona, Legnago, Mantova e Peschiera).
Contemporaneamente, esponenti influenti dell’aristocrazia e della borghesia liberale si rivolsero a Carlo Alberto
affinché intervenisse, mettendosi alla testa del movimento antiaustriaco, sia per conferire stabilità militare al successo
conseguito, sia per contenere la linea radicale e repubblicana che il movimento stava assumendo sotto la direzione
democratica. Il 23 marzo il Piemonte dichiarava guerra all’Austria. L’esempio di Carlo Alberto finì per condizionare altri
sovrani: sotto la spinta dell’agitazione democratica e patriottica, Ferdinando II di Napoli, Leopoldo II di Toscana e Pio IX
decisero di inviare contingenti di truppe regolari che partirono assieme a folte colonne di volontari. Nell’entusiasmo generale
iniziava la prima guerra di indipendenza nazionale.
Ma l’illusione durò poco. Carlo Alberto mostrò scarsa rapidità e risolutezza nel condurre le operazioni militari: si
preoccupò soprattutto di chiudere ogni spazio all’iniziativa popolare e democratica e di preparare l’annessione del
Lombardo-Veneto al Piemonte, e ciò paralizzava la sua condotta di guerra. Quando si accorsero che Carlo Alberto mirava a
perseguire interessi dinastici propri e non nazionali, gli altri sovrani ritirarono le loro truppe; rimasero a combattere contro gli
austriaci molti volontari. Questa condotta incerta e contraddittoria della guerra permise agli austriaci di riprendersi e
preparare la rivincita quando, in estate, il governo centrale riassunse gradualmente il controllo della situazione. Il 23-25
luglio, nella prima grande battaglia campale, che si combatté a Custoza in Veneto, le truppe piemontesi furono nettamente
sconfitte: Carlo Alberto si ritirò lasciando Milano nelle mani degli austriaci; il 9 agosto il generale Salasco firmò l’armistizio
con gli austriaci.
d) Lotte democratiche e restaurazione conservatrice
Dopo la sconfitta del Piemonte e della linea liberal-moderata, democratici e repubblicani rilanciarono la loro
iniziativa politica. Si trovarono, tuttavia, a combattere una serie di battaglie locali (a Roma, a Venezia, in Toscana e in
Sicilia) senza riuscire a coordinare i diversi fronti e senza poter dare alla loro lotta una dimensione autenticamente popolare.
Il loro ideale di una guerra di popolo, che unisse la prospettiva della liberazione nazionale a quella dell’emancipazione
politica e del rinnovamento sociale contrastava con la ristrettezza della base su cui effettivamente potevano contare: la
piccola e media borghesia urbana (soprattutto quella intellettuale) e i ceti artigiani delle città. Le masse contadine, ossia la
stragrande maggioranza della popolazione italiana, rimasero invece estranee, quando non apertamente ostili, alle loro
battaglie.
Tuttavia, nell’autunno del ’48, la situazione italiana era ancora abbastanza fluida. La Sicilia rimaneva sotto il
controllo dei separatisti di orientamento democratico. Venezia restava in mano agli insorti repubblicani. In Toscana la
pressione popolare costrinse il granduca a formare un governo a guida democratica (nel febbraio successivo i repubblicani
avrebbero costretto alla fuga lo stesso granduca). A Roma, in novembre, il Papa fu indotto alla fuga (si rifugiò a Gaeta sotto
la protezione di Ferdinando di Borbone) e presero il sopravvento i gruppi democratici.
Nel gennaio del 1849, in tutti i territori dell’ex Stato pontificio si tennero le elezioni a suffragio universale per
l’Assemblea costituente. Il 9 febbraio l’assemblea, fra i cui eletti figuravano anche Mazzini e Giuseppe Garibaldi (questi era
rientrato dal Sud America l’anno prima, per partecipare alla guerra antiaustriaca), proclamò la decadenza del potere
temporale dei papi e annunciò la costituzione della Repubblica romana.
In marzo, Carlo Alberto, sotto la pressione dei democratici, si decise a tentare di nuovo la via delle armi, ma
l’esercito sabaudo, il 22-23 marzo, subì a Novara una gravissima sconfitta. La stessa sera del 23 marzo, Carlo Alberto, per
non mettere in pericolo le sorti della dinastia, abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele II. Questi, il giorno dopo, firmò
a Vignale un nuovo, pesante, armistizio con gli austriaci. L’Austria poteva ora procedere alla restaurazione dell’ordine in
tutta la penisola.
Alla fine di marzo, un’insurrezione a Brescia fu duramente schiacciata dopo lunghi e durissimi combattimenti (le
dieci giornate). In aprile le truppe imperiali iniziarono l’assedio di Venezia (la città avrebbe resistito cinque mesi). In maggio
Ferdinando di Borbone riconquistò la Sicilia. Nello stesso mese gli austriaci posero fine all’esperienza della Repubblica
toscana.
Nel frattempo, a Roma il governo repubblicano, sotto la guida di Mazzini, si qualificava per l’energia con cui
tentava di portare avanti l’opera di laicizzazione dello Stato e di rinnovamento politico e sociale. In particolare, fu varato –
caso unico nella storia delle rivoluzioni italiane dell’Ottocento – un progetto di riforma agraria che prevedeva la concessione
di parte dei fondi confiscati al clero in affitto perpetuo alle famiglie più povere. Ma il presidente francese Luigi Bonaparte –
consapevole di essere stato eletto, l’anno prima, con il voto determinante dei cattolici conservatori e moderati e delle forze
clericali – decise di intervenire per favorire la restaurazione pontificia a Roma, dove inviò un corpo di spedizione, che attaccò
la città all’inizio di giugno. Dopo un mese di eroica resistenza, il 4 luglio il governo repubblicano diede l’ordine della resa.
Pio IX tornò al potere nella “città eterna”.
Restavano ancora libere solo Venezia e Budapest (nel resto d’Europa la situazione era tornata alla normalità già tra
l’estate del ’48 e il giugno del ’49), ma in agosto gli austriaci – aiutati dalla Russia nella repressione della rivolta ungherese –
riuscirono a soffocare anche questi focolai, ponendo fine all’ultima fase della stagione rivoluzionaria.
La sconfitta delle rivoluzioni va imputata ad alcuni fattori fondamentali, intrecciati tra di loro:
a. Profonde fratture attraversarono al loro interno le forze del cambiamento e della rivoluzione, dividendo sempre più
le correnti democratico-radicali dai gruppi liberal-moderati. Questi ultimi, spaventati dalla minaccia della
rivoluzione sociale, si riaccostarono alle vecchie classi dirigenti. Lasciati soli a sostenere lo scontro politico e
militare con l’antico regime, e privi di un’autentica base di massa, i democratici erano inevitabilmente destinati a
soccombere, data la loro debolezza militare.
b. Gli eserciti regolari, infatti, rimasero sempre fedeli, anche nei momenti più intensi della rivoluzione, ai poteri
tradizionali e fecero sentire il loro peso preponderante in battaglia nella fase decisiva dello scontro.
c. Gli insorti non ricevettero mai appoggio dall’esterno: Russia e Inghilterra furono le uniche due grandi nazioni
europee a non essere coinvolte nel turbine rivoluzionario, ma la prima era lo Stato più assoluto e reazionario in
Europa ed era naturalmente solidale con i governi tradizionali (aiutò infatti l’Austria a reprimere il moto ungherese),
mentre la seconda, pur caratterizzata dal regime costituzionale più liberale d’Europa, temeva che il crollo
dell’Impero asburgico nel centro dell’Europa avrebbe gravemente scosso il sistema dell’equilibrio continentale e
messo in pericolo gli interessi economici inglesi, legati al dominio dei mari e dei commerci internazionali; di
conseguenza si astenne dal dare appoggio alle forze costituzionali e democratiche, lasciando che i fatti seguissero la
loro evoluzione naturale.
Nonostante la sconfitta, tuttavia, la spinta verso una più ampia partecipazione al potere politico e l’affermazione degli
ideali di nazionalità non erano affatto morte e costituivano, ormai, un dato incancellabile del panorama europeo: si sarebbero
nuovamente manifestate nella fase successiva della storia europea.
INDUSTRIALIZZAZIONE, CLASSE OPERAIA, SOCIALISMO
(Vol. 2. Cap.11: parr. 1, 2, 3, 4; Cap.15: par. 1; Cap.18: par. 1)
a) La struttura economica e sociale
Nei paesi dell’Europa continentale, l’affermazione dell’industria moderna fu, all’inizio dell’800, piuttosto lenta e
difficile. Ciò nasceva da una serie di fattori:
a) I capitali erano ovunque scarsi e si indirizzavano preferibilmente verso gli investimenti fondiari, tradizionalmente
ritenuti più sicuri.
b) Il sistema bancario era poco sviluppato.
c)
Il basso livello dei prezzi (fenomeno che avrebbe caratterizzato tutto il periodo 1815-50) riduceva i possibili margini
di profitto.
d) Il tenore di vita del grosso della popolazione era mediamente molto più basso che in Gran Bretagna, e ciò limitava
fortemente la capacità di assorbimento dei prodotti industriali da parte di un mercato già indebolito e frammentato
da molti ostacoli, naturali e artificiali.
Cionondimeno, alcuni nuclei di industria moderna – soprattutto nel settore tessile, ma anche in quello meccanico –
riuscirono ad affermarsi, già nell’età della Restaurazione, in alcune regioni favorite da particolari condizioni geografiche,
sociali o politiche (Belgio, Francia nord-orientale, Alsazia francese, Renania tedesca, altre zone più limitate della Francia e
della Germania).
Queste aree industrializzate si vennero man mano allargando, e il processo subì una accelerazione intorno al 1830 (anche
se non presentò esattamente le forme “classiche” con le quali si era manifestato in Inghilterra), grazie al concorrere di
elementi di diversa natura:
1) il parziale miglioramento della congiuntura economica, che ebbe effetti positivi sui redditi;
2) i rivolgimenti politici all’inizio degli anni ’30 (l’affermazione della “monarchia borghese” in Francia,
l’indipendenza del Belgio, l’Unione doganale tedesca),
3) l’avvento della ferrovia, che diede un notevole impulso ai lavori pubblici e favorì il decollo delle industrie
meccaniche e siderurgiche.
In generale vi fu un nuovo interesse dei poteri pubblici nei confronti dell’industria, che si giovò anche dell’importazione
di macchine e di tecnici dall’Inghilterra, benché il governo britannico avesse cercato di porre degli ostacoli di ordine legale a
tale fenomeno. I paesi dell’Europa orientale e di quella mediterranea, nel complesso (salvo rare eccezioni: pochi nuclei isolati
nell’Italia settentrionale, nella Spagna del Nord, la regione di Pietroburgo in Russia), mancarono l’appuntamento con la
prima fase dell’industrializzazione.
Lo sviluppo e la diffusione dell’industria moderna provocarono in tutti i paesi coinvolti in questo processo profonde
trasformazioni anche al livello della struttura sociale. Al concetto di ceto, legato alla posizione occupata per nascita o al
godimento di particolari diritti, si venne sostituendo quello di classe sociale, definito soprattutto in rapporto al ruolo svolto
nel processo produttivo in una società che, almeno dal punto di vista formale, tendeva ad assicurare l’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge. L’antagonismo fondamentale che si veniva profilando non era più quello fra l’aristocrazia e il
terzo stato, ma quello fra i borghesi, proprietari dei mezzi di produzione, e i lavoratori salariati (quarto stato), ricchi soltanto
della forza delle loro braccia e della loro prole: i proletari.
Inizialmente, imprenditori e salariati furono protagonisti del conflitto sociale in Gran Bretagna, dove lo sviluppo precoce
della grande fabbrica stava concentrando in alcune città industriali una massa operaia sempre più consistente e agguerrita.
Quella dell’operaio di fabbrica era una figura sociale nuova in tutti i sensi: nuova perché di formazione recente, risultato
di un processo continuo che vedeva muovere verso l’impiego nell’industria un numero crescente di ex- lavoratori agricoli
“espulsi” dalle campagne e di ex-lavoranti di botteghe artigiane e piccole manifatture rovinate dalla concorrenza della grande
fabbrica; ma nuova anche per le sue caratteristiche, che ne facevano qualcosa di completamente diverso dalla figura
dell’operaio tradizionale, soprattutto dell’artigiano.
Al contrario dell’artigiano indipendente, il proletario di fabbrica non possedeva gli strumenti di lavoro, ma non
possedeva – o comunque non poteva utilizzare – nemmeno quel bagaglio di abilità e di cognizioni tecniche, di “segreti del
mestiere”, che le antiche organizzazioni corporative conservavano e si tramandavano. Il grosso del lavoro era di tipo
meccanico e ripetitivo e in molti casi poteva essere svolto anche da donne e ragazzi (le une e gli altri offrivano, inoltre, il
vantaggio di poter essere retribuiti con una paga inferiore a quella degli operai maschi adulti), che in effetti erano impiegati
in modo massiccio, soprattutto nell’industria tessile.
Nella fabbrica moderna l’operaio era poco più che un’appendice della macchina: i suoi ritmi di lavoro erano modellati su
quelli della macchina e si raggiungevano orari di 12 e più ore giornaliere; i salari erano fissati in base alla legge della
domanda e dell’offerta, e poiché questa era normalmente più alta di quella (presenza di quello che Marx avrebbe chiamato
esercito industriale di riserva) le retribuzioni si attestavano normalmente al livello – e anche sotto – della sussistenza.
Da tutto ciò derivavano, per la gran massa dei lavoratori dell’industria, condizioni di vita estremamente disagiate, una
situazione tanto dura (nelle periferie operaie, dove i lavoratori vivevano ammassati in case umide e fatiscenti, dilagavano
l’alcoolismo e la prostituzione, aumentavano le nascite illegittime, salivano gli indici di criminalità) da apparire inumana
anche agli occhi di molti osservatori contemporanei. Nascevano così, da un lato, l’impulso delle classi dirigenti a farsi carico,
in forme paternalistiche e caritatevoli, della questione operaia; dall’altro, la spinta degli operai stessi ad associarsi fra loro e
a ribellarsi, con la lotta, alla propria condizione: una tendenza favorita dal fatto di lavorare in grandi unità produttive e di
vivere a stretto, continuo contatto gli uni con gli altri, condizione da cui scaturivano il senso della solidarietà e la
consapevolezza della necessità di stare uniti (maturava, quindi, una forte coscienza di classe). I primi episodi di ribellione
assunsero la forma del luddismo (dal nome di un mitico capo delle prime lotte operaie, Ned Ludd), ossia della violenza contro
le macchine. Negli anni venti, tuttavia, gli operai inglesi, guidati per lo più da leaders democratico-radicali, cominciarono a
sperimentare forme di agitazione politica (manifestazioni, comizi, scioperi) in cui le rivendicazioni economiche si
mescolavano a quelle politiche. Da queste lotte, inizialmente duramente represse dalle autorità governative ma poi
gradualmente tollerate, nacquero le prime Trade Unions (associazioni di mestiere), nucleo originario di un movimento
sindacale destinato a grandi sviluppi e a conseguire, se pur faticosamente, una serie di conquiste sul piano delle condizioni di
lavoro (sull’orario e sui salari).
Nei paesi dell’Europa continentale, il processo di formazione del proletariato di fabbrica e di crescita delle
organizzazioni operaie fu naturalmente molto più lento. Tuttavia, anche nei paesi “secondi arrivati” sulla via
dell’industrializzazione, la questione operaia si venne sempre più imponendo all’attenzione dell’opinione pubblica e delle
classi dirigenti.
b) Il pensiero socialista e il primo Marx
La diffusione in Europa delle ideologie socialiste rappresentò una risposta al diffondersi del processo di
industrializzazione, alla crescita del proletariato di fabbrica e alle nuove dimensioni assunte, in conseguenza di ciò, dalla
questione sociale. Il nucleo centrale del pensiero socialista, che in questo si distingueva – opponendovisi – dal liberalismo
borghese, stava nella convinzione che, per superare i mali e le ingiustizie del capitalismo industriale (in particolare, quelli
inerenti alla condizione operaia) era necessario colpire alla radice i principi informatori della società capitalistico-borghese
(l’individualismo, la concorrenza, il profitto) e sostituirli con i valori della solidarietà e dell’uguaglianza, mettere sotto
controllo i processi produttivi in modo da orientarli verso il soddisfacimento dei bisogni dell’intera collettività; costruire
insomma una società completamente nuova, non solo nelle istituzioni politiche, ma anche e soprattutto nelle strutture
economiche.
Per questa sua carica utopica, il pensiero socialista del primo ‘800 si collegava a progetti ed esperienze maturati
nell’ambito della società preindustriale, in particolare alle correnti radicali ed egualitarie che si erano manifestate nel corso
della prima rivoluzione inglese e della rivoluzione francese, in parte confluite nelle società segrete del periodo della
Restaurazione. Rispetto a tali esperienze, e anche a teorie e movimenti dei secoli passati, il socialismo ottocentesco si
distingueva proprio per il suo costante riferirsi alla nuova realtà dell’industrialismo.
Come si è detto più sopra, i primi teorici e militanti socialisti (Robert Owen, Claude-Henri de Saint-Simon, Charles
Fourier, Louis Blanc, Pierre-Joseph Proudhon, Auguste Blanqui) affrontarono i temi della questione sociale proponendo, in
genere, come rimedio ai mali dell’industrialismo una immagine ideale di società, regno dell’uguaglianza, della giustizia,
della felicità, una utopia appunto. Essi individuavano la causa ultima dello sfruttamento e della miseria dei lavoratori in un
errore morale, nell’egoismo degli imprenditori capitalisti; proponevano, di conseguenza, soluzioni ispirate ad uno spirito
umanitario e di collaborazione tra le classi sociali, capace di far superare in tutti i protagonisti della questione sociale egoismi
e atteggiamenti conflittuali.
L’espressione socialismo utopistico viene di solito impiegata per contrapporre questi scrittori del primo Ottocento
al socialismo di Marx, al quale viene riservata la qualificazione di scientifico, nel presupposto che il secondo, a differenza
del primo, fosse fondato su una analisi oggettiva e scientifica dei problemi socio-economici.
Negli anni trenta e quaranta, le idee socialiste conobbero una certa diffusione anche in Germania, ma, a causa
dell’assenza di libertà politiche negli stati tedeschi, i nuclei socialisti si organizzarono soprattutto all’estero: nel 1847, un
gruppo di esuli tedeschi a Londra fondò un’organizzazione chiamata Lega dei comunisti e affidò l’incarico di stenderne il
manifesto programmatico a due intellettuali non ancora trentenni, Karl Marx e Friedrich Engels.
Engels, nato nel 1820 e figlio di un ricco industriale, aveva soggiornato a lungo a Londra, dove aveva studiato gli
economisti “classici” e osservato da vicino le condizioni di vita degli operai. Marx, più anziano di due anni, aveva una
formazione essenzialmente filosofica (di stampo hegeliano), ma era insoddisfatto di un’attività puramente speculativa e si era
convinto che compito degli intellettuali fosse non tanto “interpretare il mondo” – come fino ad allora avevano fatto i filosofi
– quanto “cambiarlo”. L’incontro con Engels, avvenuto nel ’44, lo indirizzò verso gli studi economici e sociali.
Nel Manifesto dei comunisti, uscito a Londra all’inizio del ’48, Marx (che del sodalizio tra i due sarebbe diventato la
vera mente teorica) ed Engels si fecero assertori di un nuovo socialismo – da loro stessi definito scientifico – che univa una
fortissima carica rivoluzionaria a un solido fondamento economico e filosofico.
Il nucleo fondamentale del socialismo scientifico sta in una concezione materialistica e dialettica della storia
(materialismo storico), vista essenzialmente come un susseguirsi di lotte di classe, di scontri fra interessi economici. “La
classe – afferma Marx – raggiunge un’esistenza indipendente al di sopra e contro gli individui, cosicché essi trovano già
predestinata la condizione della loro esistenza, e la posizione nella vita e lo sviluppo personale vengono loro assegnati dalla
classe”. La collocazione di classe è data dalla posizione che gli individui occupano in rapporto al processo produttivo.
Nell’evoluzione del mondo moderno, la stessa borghesia ha svolto, nella fase della sua ascesa, una funzione rivoluzionaria
perché, dando vita al capitalismo industriale, ha accresciuto enormemente le capacità produttive dell’umanità e ha abbattuto
le disuguaglianze giuridiche della società feudale. Tuttavia, al tempo stesso, ha suscitato nuove contraddizioni, in particolare
quella per cui “coloro che lavorano non guadagnano e quelli che guadagnano non lavorano”, contraddizione che dovrà essere
cancellata dalla lotta di classe contemporanea tra il proletariato e la borghesia.
Secondo Marx, la realtà sociale ha la propria radice nei rapporti materiali dell’esistenza (l’economia), nelle forme
con cui gli uomini danno soddisfazione ai propri bisogni elementari: ciò costituisce la struttura della società, l’elemento
fondamentale e primario. In relazione alla fondamentale struttura economica, i fattori culturali – diritto, ideologia politica,
scienza, arte, filosofia, religione – sono elementi riflessi e secondari, sono sovrastrutture. “Non è la coscienza degli uomini
che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza”. Va tuttavia precisato
che il rapporto tra struttura e sovrastruttura va inteso in modo non meccanicistico e unidirezionale (la struttura determina la
sovrastruttura), ma dialettico (i due elementi interagiscono tra di loro, si condizionano a vicenda).
Sulla base di questi principi, Marx individua nel succedersi dei diversi modi di produzione l’elemento determinante
della storia che è passata da un modo di produzione schiavistico (nell’età antica) a quello feudale (fondato sulla servitù della
gleba), da quello feudale a quello pre-capitalistico (corporazioni e manifatture dal sec. XIII al sec. XVIII, credito, commercio
internazionale), infine a quello capitalistico, con l’avvento dell’industria moderna e del macchinismo.
La spiegazione di questa evoluzione e di queste trasformazioni produttive sta nella dialettica tra forze produttive
(risorse, tecnologia, forza-lavoro) e rapporti di produzione (posizione delle classi sociali nei confronti della produzione,
posizione che è determinata dai rapporti di proprietà). Quando, in un sistema sociale ed economico, si determina una
contraddizione tra questi due elementi (i rapporti di produzione esistenti non consentono un ulteriore sviluppo delle forze
produttive), tale situazione produce le condizioni storiche che permettono la rottura del precedente modo di produzione –
basato su rapporti di produzione che ormai costituiscono un freno allo sviluppo economico – e la costituzione di una nuova
struttura economica – basata sui nuovi rapporti di produzione che permettono la ripresa dello slancio produttivo.
Quando l’attuale modo di produzione capitalistico – basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione e sul
lavoro salariato – avrà maturato al suo interno uno stato di fondamentale contraddizione tra forze produttive e rapporti di
produzione, la classe operaia (antagonista della classe dei capitalisti, ma prodotta – nata – all’interno della stessa società
borghese e del suo modo di produrre) si farà carico di guidare e realizzare un processo rivoluzionario che abolirà la proprietà
privata dei mezzi di produzione e lo stato parlamentare borghese, sostituendo ad essi una nuova società, in cui i mezzi di
produzione passeranno alla collettività. In una prima fase che sarà di transizione – il socialismo – il principio regolatore sarà:
“tutti devono lavorare, a ciascuno secondo il proprio lavoro”. Successivamente, si raggiungerà la vera meta, la società senza
classi e senza conflitti – il comunismo – fondata sul principio: “da ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo
i propri bisogni”; nel comunismo le enormi potenzialità produttive di cui la tecnica umana è capace saranno prive di limiti e
messe al servizio dell’intera collettività.
L’organizzazione del movimento rivoluzionario, la sua dottrina, la sua opera politica sono elementi indispensabili di
tutto il processo, ma per essere veramente efficaci devono basarsi sulle tendenze reali ed oggettive che sono inerenti ai
rapporti di produzione moderni, interpretandone e sfruttandone i caratteri progressivi.
c) Economia e società dopo il biennio ’48-‘49
A partire dalla fine degli anni quaranta, superata la crisi del ’46-’47, l’economia europea conobbe una fase di forte
espansione, che fu caratterizzata dall’aumento dei prezzi, dei salari e dei profitti e che durò, salvo due brevi interruzioni, per
quasi un quarto di secolo. Gli effetti di questa fase espansiva si fecero sentire, sia pure in diversa misura, in tutti gli stati
europei e interessarono tutti i settori dell’economia, compreso quello agricolo.
I risultati più consistenti si ebbero però nell’industria che, fra il 1850 e il 1873, fece registrare un vero e proprio
boom. Il boom avvantaggiò soprattutto le “nuove” potenze industriali (la Francia del Secondo Impero e la Germania in via di
unificazione) e si fondò essenzialmente sullo sviluppo dei settori siderurgico e meccanico; si trattò di uno sviluppo
imponente sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo. I costi crescenti degli impianti e l’accresciuta
concorrenza diedero un forte impulso alla tendenza verso l’aumento delle dimensioni delle imprese e verso le concentrazioni
aziendali. Si moltiplicarono le società per azioni, che permettevano agli imprenditori di sopperire al bisogno di capitale
raccogliendolo fra numerosi sottoscrittori
Molti furono i fattori che resero possibile il boom degli anni ’50 e ’60:
1) Dopo il 1848, soprattutto in quei paesi dell’Europa centro-orientale dove più forti erano le sopravvivenze dell’antico
regime, furono cancellati o lasciati cadere in disuso molti vincoli giuridici che fin allora avevano inceppato le
attività economiche.
2) Caddero, nel giro di pochi anni, le numerose barriere (imposte e dazi di vario genere) che si frapponevano alla libera
circolazione delle merci (la politica doganale liberista venne inizialmente varata in Inghilterra nel 1846).
3) La scoperta e lo sfruttamento di nuovi giacimenti minerari nell’Europa continentale (soprattutto in Francia e in
Germania) aumentarono in misura considerevole la disponibilità delle materie prime più importanti (ferro e
carbone).
4) La scoperta, nel 1848, di nuovi giacimenti auriferi in California fece affluire in Europa cospicue quantità di metalli
preziosi. Ne derivò un rapido aumento della circolazione monetaria, che causò a sua volta l’abbassamento dei tassi
di interesse e l’espansione del credito. Le banche assunsero una funzione decisiva nel promuovere lo sviluppo,
incanalando i capitali disponibili verso gli investimenti produttivi.
5) Si affermarono e diffusero nuovi mezzi di trasporto e di comunicazione, primo fra tutti la ferrovia. La costruzione di
linee ferroviarie, treni e navi a vapore fu certamente un prodotto della rivoluzione industriale, ma al tempo stesso
contribuì potentemente ad alimentarla: sia perché allargava a dismisura le possibilità di circolazione dei prodotti
dell’industria, sia perché determinava essa stessa una domanda in continua espansione per i settori siderurgico e
meccanico.
Quest’ultimo aspetto merita un minimo di approfondimento. La rivoluzione dei trasporti e dei mezzi di comunicazione,
che conobbe il suo momento decisivo intorno alla metà dell’800, non ebbe solo conseguenze di ordine economico, ma
influenzò significativamente abitudini e modi di pensare della gente comune. La stessa immagine del mondo cambiò
radicalmente, e l’idea di un mondo unito, le cui parti erano legate fra loro da stretti rapporti di interdipendenza, cominciò a
farsi strada nella coscienza collettiva.
Va anche rilevato che, contemporaneamente alla rivoluzione dei trasporti (ferrovia e navigazione a vapore), un’altra
trasformazione non meno radicale si ebbe nel campo della comunicazione dei messaggi, grazie alla diffusione del telegrafo
elettrico. L’invenzione, che risaliva alla fine degli anni trenta, trovò le sue prime applicazioni pratiche nel decennio
successivo (il telegrafo di Morse è del 1844). Negli anni cinquanta e sessanta, tutti i paesi europei si dotarono di un sistema
di comunicazioni telegrafiche.
La comunicazione dei messaggi era così svincolata per sempre dalla dipendenza dai mezzi di trasporto e la velocità delle
notizie aumentava in modo vertiginoso, con effetti determinanti sull’economia, sull’informazione, sulla diplomazia, sulla
conduzione delle guerre.
Intorno alla metà dell’Ottocento, tuttavia, in tutta l’Europa continentale erano ancora i lavoratori della terra a costituire il
grosso della popolazione attiva. Il mondo contadino comprendeva, in realtà, una miriade di realtà economiche e di figure
sociali diverse, lavoratori salariati, piccoli e medi proprietari, mezzadri, piccoli affittuari, perfino servi della gleba (in Russia,
dove sarebbero stati liberati dallo loro condizione solo nel 1861).
I progressi, peraltro limitati, realizzati dall’agricoltura europea in coincidenza col generale sviluppo economico degli
anni ’50 e ’60 non valsero a modificare nella sostanza le condizioni di vita delle masse contadine, che rimasero notevolmente
disagiate. Dappertutto i ceti rurali costituivano l’elemento statico della società, quello più legato alle religioni tradizionali e
alle consuetudini del mondo preindustriale. La novità più rilevante stava nel fatto che lo sviluppo industriale e la rivoluzione
dei trasporti offrivano ai contadini maggiori possibilità di allontanarsi dal luogo d’origine; iniziarono così lo spostamento dei
lavoratori della terra verso i grandi centri industriali e il fenomeno dell’emigrazione dall’Europa verso il Nord-America.
Anche il proletariato delle città offriva, attorno alla metà del secolo, un quadro tutt’altro che omogeneo: accanto ai veri e
propri operai della grande fabbrica, numerosissimi erano ancora i lavoranti di piccole officine e botteghe artigiane, i
domestici, i manovali; altrettanto numeroso era l”esercito” dei lavoratori occasionali, dei vagabondi, dei mendicanti, delle
prostitute (nel linguaggio di Marx Lumpenproletariat, cioè sotto-proletariato, non organicamente inserito nelle strutture della
produzione capitalistica). Con lo sviluppo della grande industria e la decadenza della piccola impresa artigiana, il proletariato
di fabbrica venne però assumendo sempre maggiore consistenza. I salari nell’industria erano mediamente superiori a quelli
del settore agricolo e crebbero lentamente negli anni ’50 e ’60, pur senza elevarsi mai molto al di sopra del livello di
sussistenza; le condizioni di vita e di lavoro degli operai restavano estremamente precarie.
Dopo la repressione dei moti rivoluzionari del ’48-’49, che – nei paesi più moderni – avevano soprattutto colpito i nuclei
operai più combattivi, il movimento associativo fra i lavoratori appariva ovunque indebolito e per lo più lontano da nuove
iniziative rivoluzionarie, sia in Inghilterra (dove si stavano comunque affermando e diffondendo le organizzazioni sindacali
di mestiere, Trade Unions, che nel 1868 sarebbero poi confluite nel Trade Unions Congress) sia nei paesi del continente,
dove i movimenti operai risentivano, sia sul piano teorico che su quello organizzativo, delle diverse caratteristiche storiche e
socio-economiche di ogni regione o nazione, e andavano man mano differenziandosi tra loro.
d) Il Marx del Capitale
Il fallimento dei moti del ’48 e la lunga stasi delle lotte sociali che ne seguì costrinsero Marx, in esilio a Londra, a
ripensare modi e tempi del processo rivoluzionario. Lontano per molti anni da ogni possibilità di azione, Marx dedicò gran
parte del suo tempo allo studio dell’economia politica: l’analisi economica divenne sempre più la base fondamentale del suo
socialismo scientifico. Il frutto più maturo di questa fase del pensiero marxiano fu Il Capitale, il cui primo e più importante
volume uscì nel 1867.
La presenza di contraddizioni interne al sistema capitalistico viene individuata da Marx nelle crisi economiche ricorrenti.
Già in passato uno studioso svizzero, Sismondi, aveva messo in rilievo il fenomeno, riportandolo alla contraddizione tra la
produzione capitalistica e le limitate possibilità di consumo da parte degli operai. Marx ne sviluppò successivamente
l’analisi, indicando la radice del fenomeno nella contraddizione tra il carattere sociale dell’organizzazione produttiva (che ha
il suo centro nella fabbrica) e la proprietà privata dei mezzi di produzione, che impedisce ai produttori, gli operai, di
appropriarsi del frutto del loro lavoro. Secondo Marx, nelle crisi economiche viene regolarmente distrutta non solo una gran
parte dei prodotti ottenuti, ma addirittura gran parte delle forze produttive già create; nella crisi scoppia una epidemia sociale
che in tutte le epoche anteriori sarebbe apparsa un assurdo: “l’epidemia della sovrapproduzione” e l’industria ed il
commercio sembrano distrutti.
Mentre nella prima fase le fonti principali del pensiero di Marx erano stati l’hegelismo e il socialismo utopistico, ora la
sua analisi ebbe come spunto di partenza gli economisti classici e, soprattutto, Ricardo. Da quest’ultimo egli accolse e
sviluppò la teoria del valore-lavoro, giungendo all’affermazione che l’essenza del sistema capitalistico è nello sfruttamento
della forza-lavoro. Il valore delle merci, egli sostiene, è dato dalla quantità di lavoro socialmente necessario per produrle; il
profitto del capitalista non è formato che da una parte di lavoro non pagato (plusvalore). Nell’appropriazione del plusvalore
e nella conseguente miseria dei lavoratori, che creano la ricchezza, è “la legge generale dell’accumulazione capitalistica”.
Il sistema di rapporti che dovrà sostituirsi al capitalismo si viene formando attraverso la lotta del proletariato contro la
borghesia. Il nuovo sistema, basato sull’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, non potrà avere che
carattere socialista. Marx precisa che “il carattere distintivo del comunismo non è l’abolizione della proprietà individuale in
generale, ma l’abolizione della proprietà borghese. Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi dei prodotti
sociali; toglie soltanto il potere di asservire il lavoro altrui attraverso quella appropriazione”. La nuova funzione
rivoluzionaria appartiene secondo Marx al proletariato, la classe che, nata dall’industria, è interessata all’ulteriore sviluppo
delle forme moderne di produzione e non ad un ritorno indietro. Elemento fondamentale della sua forza è la sua solidarietà di
classe, che nasce dalle stesse condizioni di lavoro, dal carattere sociale dell’organizzazione produttiva.
Nella nuova società socialista l’attività produttiva non sarà più determinata dalle esigenze del profitto, ma dai bisogni
degli uomini: una volta abolita la proprietà privata, lo sviluppo delle forze produttive sarà illimitato e sarà per sempre
superata la contraddizione tra fine privato del processo di produzione e di valorizzazione del capitale e il mezzo con cui viene
realizzato (sviluppo incondizionato delle forze produttive sociali del lavoro: socializzazione e cooperazione del lavoro):
saranno eliminati sia lo sfruttamento dei lavoratori che le crisi cicliche di sovrapproduzione.
La pubblicazione del Capitale segnò una data fondamentale nella storia del movimento operaio. Per la prima volta il
socialismo veniva fatto scaturire dallo sviluppo economico, oltre che dall’azione consapevole del proletariato organizzato.
Ciò avrebbe favorito la diffusione della teoria marxista.
e)
Le associazioni internazionali dei lavoratori
Forse proprio a causa della varietà delle ideologie e delle forme organizzative in cui si articolava nei vari paesi, il
movimento operaio avvertì presto l’esigenza di dar vita a un’organizzazione internazionale di coordinamento. La riunione
inaugurale della nuova organizzazione (cui parteciparono esponenti del movimento operaio inglese, francese, tedesco e
italiano), che prese il nome di Associazione internazionale dei lavoratori, si tenne a Londra nel settembre 1864.
Assuntosi il compito di redigere lo statuto provvisorio, Marx riuscì a inserire nel documento alcuni punti che
qualificavano l’Associazione in senso classista, in particolare l’affermazione dell’autonomia del proletariato dalla borghesia
democratica e la priorità data alla lotta contro lo sfruttamento (ciò determinò l’abbandono dell’associazione da parte dei
mazziniani).
Il funzionamento della Prima Internazionale fu, in realtà, gravemente compromesso dall’eterogeneità delle sue
componenti e dalle aspre rivalità che dividevano i suoi capi, con le diverse linee teoriche di cui erano portatori. Il conflitto
più acuto fu quello che divise Marx da Michail Bakunin, massimo teorico dell’anarchismo moderno.
Ecco in sintesi ciò che divideva i due:
1) Per Bakunin, l’ostacolo principale, che impediva all’uomo il conseguimento della piena libertà, era costituito
dall’esistenza dello stato, che era, insieme alla religione, lo strumento di cui si servivano le classi dominanti per
mantenere la stragrande maggioranza della popolazione in condizioni di inferiorità economica e intellettuale.
Abbattuto il potere statale, il sistema di sfruttamento economico basato sulla proprietà privata sarebbe
inevitabilmente caduto. Il comunismo si sarebbe instaurato spontaneamente come l’ordine più consono alle esigenze
naturali delle masse, senza che allo Stato dovesse sostituirsi alcuna organizzazione di tipo centralizzato e coercitivo
(qualunque stato, anche quello proletario, per Bakunin non significava altro che oppressione e tirannide). Anche
Marx vedeva nella religione e nello Stato degli strumenti al servizio delle classi dominanti; ma collocava l’uno e
l’altra nella sfera della sovrastruttura, mentre solo la distruzione della struttura – i rapporti di produzione basati sulla
proprietà privata dei mezzi di produzione e sul lavoro salariato – avrebbe reso possibile la distruzione dello Stato
borghese. L’avvento del comunismo avrebbe portato con sé l’estinzione dello stato, ma questo stadio finale sarebbe
stato raggiunto solo dopo una fase transitoria, quella della dittatura del proletariato, necessaria per neutralizzare la
reazione delle classi dominanti.
2) Per Bakunin il vero soggetto della rivoluzione erano le masse diseredate in quanto tali, senza distinzione fra operai,
contadini o sottoproletari. Secondo Marx, invece, il protagonista del processo rivoluzionario era il proletariato
industriale dei paesi più avanzati, portatore con le sue lotte di nuovi rapporti di produzione.
3) Per Bakunin l’unica forma possibile di lotta era la rivolta armata, senza alcuna forma di compromesso con la realtà
esistente. Invece Marx, pur non credendo nella possibilità di trasformare il sistema borghese dall’interno, riteneva
utile che la classe operaia cominciasse a combattere le sue battaglie già dentro il sistema.
Il contrasto tra marxisti e bakuniniani, esploso all’inizio degli anni ’70, mise in crisi le fragili strutture
dell’Internazionale e spinse Marx a decidere di trasferire la sede centrale dell’associazione da Londra a New York (1872) e,
poi, a decretarne lo scioglimento nel 1876. Marx aveva, nel frattempo, deciso di puntare sullo sviluppo nei vari stati di forti
partiti socialisti che fossero in grado di inquadrare la maggioranza della classe operaia.
Nel 1875 si costituì il partito socialdemocratico tedesco, in cui confluirono marxisti e non marxisti. Un partito socialista
di ispirazione marxista sorse in Francia nel 1879; contemporaneamente si formarono il partito socialista belga e quello
spagnolo. In Italia, quando venne meno l’influenza di Bakunin, si formò nel 1882 un partito operaio indipendente, dal quale
dieci anni dopo sorse il partito socialista italiano. Nel 1883 (lo stesso anno della morte di Marx) si costituì un primo gruppo
marxista russo al quale seguì, nel 1898, la fondazione del partito socialdemocratico russo. In Inghilterra il passaggio di
importanti forze operaie dal radicalismo al socialismo si verificò subito dopo il 1880; furono, comunque, gli stessi dirigenti
sindacali a creare, nel 1906, il Partito laburista, privo nella sostanza di una caratterizzazione ideologica ben definita.
Da questa ripresa socialista nacque nel 1889 la Seconda Internazionale (diversamente dalla prima, che aveva avuto
l’ambizione di costituire una specie di centro dirigente della classe lavoratrice di tutto il mondo, la Seconda Internazionale fu
più che altro una federazione di partiti nazionali autonomi e sovrani), destinata a durare fino alla grande guerra e ad esercitare
un effettivo ruolo di direzione del movimento operaio internazionale nella fase della sua maggiore espansione. La direzione
del nuovo organismo fu affidata ad un “ufficio permanente” che ebbe sede a Bruxelles. Malgrado le dure persecuzioni cui
furono sottoposti quasi dappertutto, i nuovi partiti socialisti riuscirono a inserirsi stabilmente nel quadro della lotta politica
dei singoli paesi e a esercitare un’influenza crescente sull’evoluzione della società contemporanea. In conseguenza della loro
azione, il problema della democrazia si ripropose in forme nuove, dal momento che i lavoratori organizzati nei loro partiti
rivendicavano la pienezza dei diritti politici e l’emanazione di leggi che tutelassero il lavoro nelle fabbriche e nelle campagne
(specialmente in Inghilterra e in Germania, dove il movimento operaio era più forte che altrove, i governi furono costretti ad
attuare passi significativi nell’ambito della legislazione sociale, con la riduzione dell’orario di lavoro, la tutela del lavoro
femminile e minorile, il controllo della sicurezza del lavoro). Un elemento di forza, in questa fase, fu la ricerca di un
collegamento organico tra le rivendicazioni degli operai e quelle dei contadini.
In generale, in questa fase la socialdemocrazia tedesca si affermò come il partito socialista più forte e organizzato
d’Europa, ma al suo interno si determinò una divisione teorica e politica tra due correnti: da un lato la maggioranza approvò,
nel congresso di Erfurt del 1891, la linea di Karl Kautsky, tesa a riaffermare che scopo principale del socialismo era la
conquista del potere politico da parte del proletariato con il successivo avvento di una società nuova, senza classi (accanto a
questo programma massimo, si ammetteva comunque la necessità di battersi nel frattempo per un programma minimo, teso a
raggiungere quelle riforme che avrebbero potuto migliorare la vita dei lavoratori dentro le regole della democrazia borghese);
da un altro lato nacque una tesi revisionista, elaborata da Eduard Bernstein (un altro esponente del partito socialdemocratico
tedesco) che sosteneva una visione alternativa all’idea di dittatura del proletariato espressa da Marx, secondo la quale non era
più necessario combattere e distruggere lo stato borghese, bensì superarlo gradualmente attraverso una via democratica, come
quella del suffragio universale e di ampie riforme che migliorassero le condizioni di vita delle masse popolari.
Un altro indirizzo politico di una certa rilevanza, che emerse in quest’epoca all’interno del movimento operaio, fu in
Francia il sindacalismo rivoluzionario, di ispirazione anarchica ed elaborato da Georges Sorel, che nei suoi scritti esaltava il
ruolo delle masse proletarie avverse sia allo stato sia ai partiti e prospettava la caduta del capitalismo sotto i colpi inferti dagli
scioperi generali.
L’UNITA’ D’ITALIA
(Vol. 2, Cap. 13: parr. 1, 2, 3, 4, 5)
In Italia, il ritorno dei sovrani legittimi dopo il fallimento delle rivoluzioni del ’48-’49 bloccò, in generale, gli
esperimenti riformatori e frenò pesantemente lo sviluppo economico dei vari stati, mentre veniva nuovamente sancita
l’egemonia austriaca nella penisola.
Nel panorama oscurantista che avvolgeva la penisola, fece eccezione il Piemonte sabaudo, dove poté sopravvivere
l’esperimento costituzionale inaugurato con la concessione dello Statuto albertino. Il nuovo re Vittorio Emanuele II, poiché il
parlamento si rifiutava di ratificare l’armistizio di Vignale, aveva sciolto la Camera dei deputati e indetto nuove elezioni, in
occasione delle quali aveva promesso la conservazione della costituzione, se gli elettori avessero eletto una maggioranza
moderata a lui favorevole; le cose erano poi andate in questo senso. Il nuovo governo, presieduto dal moderato Massimo
d’Azeglio, portò così avanti l’opera di modernizzazione dello Stato. Una tappa fondamentale in questo processo fu, nel
febbraio 1850, l’approvazione della legge Siccardi che riordinava i rapporti fra Stato e Chiesa, ponendo fine agli
anacronistici privilegi di cui il clero godeva ancora nel Regno sabaudo. La battaglia parlamentare per l’approvazione di tale
legge vide emergere nelle file della maggioranza liberal-moderata la figura di un nuovo e dinamico leader: il conte Camillo
Benso di Cavour.
Nato nel 1810, Cavour era cresciuto e si era formato in un clima familiare aristocratico, ma non chiuso e retrivo,
bensì culturalmente aperto e intraprendente negli stili di vita. Già negli anni giovanili si era avvicinato alle idee liberali, ma si
era dedicato agli studi, ai viaggi, agli affari e alla cura del patrimonio familiare. L’ideale politico di Cavour era quello di un
liberalismo moderato, che si poneva come il “giusto mezzo” tra il reazionarismo chiuso e violento dei regimi assoluti europei
e gli “eccessi” dei rivoluzionari democratici. Cavour era, infatti, convinto che l’allargamento delle basi dello stato doveva
essere attuato con gradualità nell’ambito di un sistema monarchico-costituzionale, unico antidoto contro la rivoluzione e il
disordine sociale; da convinto ammiratore del modello politico e sociale britannico, nutriva inoltre una fiducia pressoché
illimitata nelle virtù del liberismo economico.
Cavour entrò a far parte del governo, capeggiato da D’Azeglio, come ministro dell’agricoltura e delle finanze,
aprendo una fase di intense iniziative economiche. Ma la realizzazione della politica cavouriana richiedeva il superamento
della timida politica di D’Azeglio e il controllo diretto del governo e del parlamento. Per realizzare questo obiettivo, nei
primi mesi del 1852 Cavour strinse un’alleanza politica (il connubio) con la componente meno radicale della sinistra
democratica, capeggiata da Urbano Rattazzi, che gli consentì di guadagnarsi una solida maggioranza alla camera. Va anche
sottolineato che, con questa operazione politica, il conte avviò un’interpretazione parlamentare dello Statuto albertino che si
sarebbe poi affermata stabilmente. Nel novembre dello stesso anno, Cavour ricevette da Vittorio Emanuele II l’incarico di
formare il nuovo governo.
Divenuto primo ministro, lo statista piemontese cominciò a porre le basi del proprio programma, che, allo scopo di
fare del Piemonte la guida del processo risorgimentale italiano, si muoveva su due direttrici:
1)
Sviluppare l’economia del suo paese e integrarla nel più ampio contesto europeo, attraverso l’adozione
di una linea decisamente liberoscambista, l’attuazione di opere pubbliche, la costruzione di una rete
ferroviaria, la modernizzazione dell’agricoltura, l’impulso dato alle attività industriali e commerciali.
2)
Creare una situazione internazionale favorevole, dato che senza appoggi e senza l’assenso delle
maggiori potenze liberali europee, il Regno sabaudo non aveva la forza economica e militare per guidare
un processo di unificazione e di indipendenza in Italia.
Quanto al primo punto, va detto che, alla vigilia dell’unità italiana, dopo dodici anni di regime costituzionale, il
Piemonte poteva vantare un bilancio quanto mai lusinghiero, in termini di sviluppo economico e civile; Cavour riuscì così a
dimostrare che la causa della libertà faceva tutt’uno con quella del progresso economico, e a fare del Piemonte il naturale
punto di riferimento per la borghesia liberale di tutta Italia.
Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, una prima occasione per guadagnare l’appoggio della Francia e
dell’Inghilterra alla causa piemontese si presentò con la guerra di Crimea. Cavour decise di far partecipare al conflitto, che
opponeva le forze anglo-francesi ai russi (l’Austria si era mantenuta neutrale), un corpo di spedizione piemontese in
appoggio alle potenze anti-russe.
Il Regno sabaudo non ottenne alcun immediato vantaggio territoriale dalla partecipazione a questa impresa, ma al
Congresso di Parigi, riunito a conclusione del conflitto (1856), Cavour poté sedersi al tavolo delle trattative di pace fra i
rappresentanti delle potenze vincitrici. Egli riuscì a suscitare l’attenzione della Francia e dell’Inghilterra sulla questione
italiana, presentando l’egemonia austriaca e il malgoverno nello Stato della Chiesa e nel Regno delle due Sicilie come una
minaccia perenne alla pace e all’equilibrio europeo; presentava, quindi, il Piemonte come garante di uno sbocco non
rivoluzionario delle tensioni che si manifestavano nella penisola. In questa occasione Cavour non ottenne alcun impegno
diretto a sostegno della causa italiana, ma fece il primo passo verso un’alleanza con Napoleone III, desideroso di allargare
l’influenza francese sull’Europa ai danni dell’Austria.
Gli storici hanno coniato, per gli anni che separarono il tragico epilogo delle esperienze rivoluzionarie del 1848
dall’avvio della seconda guerra di indipendenza, la definizione decennio di preparazione, con la quale intendono
sottolineare che, in quel periodo, vennero a maturazione i processi che rappresentavano le condizioni indispensabili per la
realizzazione dell’indipendenza e dell’unificazione nazionale.
Mentre Cavour tesseva la sua accorta trama di relazioni internazionali, s’intensificò anche l’azione dei democratici.
All’indomani del ’49, nel partito di Mazzini si era avviato un vasto processo di revisione politica.
Partendo dall’analisi della sconfitta del 1848-’49, un gruppo di democratici, tra i quali spiccavano Giuseppe Ferrari
e Carlo Pisacane, sostenne che senza l’appoggio delle masse contadine e dei lavoratori poveri l’unificazione e
l’indipendenza sarebbero state impossibili. Il programma dei democratici doveva, quindi, accentuare i propri contenuti
sociali, propugnando radicali riforme che estendessero le proprietà contadine e migliorassero le condizioni di vita della classe
operaia.
A questa corrente, chiamata del socialismo risorgimentale, si contrapponeva il vecchio gruppo dirigente
mazziniano, fortemente ostile a programmi così radicali. Il comitato italiano di Londra, saldamente diretto da Mazzini,
elaborò infatti nel 1851 un programma di iniziative, nel quale erano ribaditi i tradizionali principi democratici. Inoltre, nel
1853 Mazzini, convinto che la debolezza del suo movimento derivasse non da limiti della strategia politica bensì da carenze
organizzative, fondò a Ginevra una nuova formazione politica, cui diede il nome di Partito d’azione, quasi a sottolinearne il
carattere di puro strumento di battaglia.
Tuttavia, anche i tentativi insurrezionali organizzati negli anni ’50 si conclusero con una serie di fallimenti: nel
Lombardo-Veneto tra 1852 e 1853 (martiri di Belfiore nel mantovano e fallita sommossa a Milano); in Lunigiana nel 1853;
fallita spedizione di Pisacane al sud nel 1857 (episodio di Sapri). Il totale fallimento di queste iniziative ridusse le adesioni al
partito democratico e indebolì la direzione politica di Mazzini. Gruppi consistenti di democratici (tra gli altri, Manin,
Montanelli e lo stesso Garibaldi) diedero vita, nel 1857, alla Società nazionale, che si proponeva di unire tutte le correnti
risorgimentali, moderate e democratiche, intorno all’unica forza in grado di raggiungere l’obiettivo: la monarchia
costituzionale di Vittorio Emanuele II.
Nel frattempo Cavour continuava a perseguire la strada delle trattative diplomatiche. La svolta si verificò nel
gennaio 1858, quando un democratico italiano esule in Francia, Felice Orsini, organizzò un attentato contro Napoleone III,
che non giunse a compimento ma spaventò l’imperatore francese. Cavour utilizzò abilmente anche questa occasione per
realizzare il suo progetto: presentò, attribuendo a Mazzini (che invece ne era completamente estraneo) la responsabilità
politica dell’attentato, l’Italia come una polveriera pronta a esplodere e convinse Napoleone III che era indispensabile
risolvere la questione italiana, prima che i gruppi più radicali prendessero il sopravvento.,
Nell’estate del 1858, si stipularono a Plombières, nelle Alpi svizzere, accordi segreti tra i due paesi, in virtù dei
quali la Francia si impegnava a intervenire militarmente a fianco del Piemonte, se l’Austria avesse aggredito il Piemonte. In
cambio, Napoleone avrebbe ottenuto dall’alleato la cessione di Nizza e della Savoia. Gli accordi ipotizzavano una nuova
sistemazione dell’intera penisola italiana, che avrebbe dovuto essere divisa in tre Stati: un regno dell’Alta Italia
comprendente, oltre a Piemonte Liguria e Sardegna, il Lombardo-Veneto e l’Emilia-Romagna, sotto la casa sabauda; un
regno dell’Italia centrale formato dalla Toscana e dalle province pontificie; un regno meridionale liberato dalla dinastia
borbonica (entrambi questi due regni sarebbero stati governati da principi imparentati con Napoleone III). Al papa, che
avrebbe conservato la sovranità su Roma, sarebbe stata offerta la presidenza della futura Confederazione italiana. Dietro
questo programma si celavano, in realtà, due diversi disegni: quello dell’imperatore francese, che mirava a porre l’Italia sotto
il suo controllo, e quello di Cavour che mirava, per il momento, a risolvere il problema della presenza austriaca nella
penisola, rimandando ad un secondo momento il problema dei rapporti con il vicino francese (in questa fase, Cavour riteneva
che i tempi per il conseguimento dell’unità fossero ancora piuttosto lunghi).
Premessa indispensabile per la riuscita dei progetti di Cavour era, comunque, la guerra contro l’Austria. Il governo
piemontese cercò di far salire la tensione con lo Stato vicino: particolare effetto suscitarono le manovre militari
(espressamente vietate dagli accordi sottoscritti da Vittorio Emanuele II a Vignale) al confine segnato dal fiume Ticino e
l’armamento di corpi di volontari. Il governo asburgico finì col cadere nella trappola inviando, il 23 aprile 1859, un secco
ultimatum al Piemonte, che Cavour ebbe buon gioco a respingere: iniziava la seconda guerra d’indipendenza italiana.
L’esercito franco-piemontese si scontrò con le truppe austriache in violente battaglie campali, riportando decisive
vittorie a Palestro, Montebello e Magenta, che gli aprirono la strada verso Milano. Nel frattempo, Garibaldi alla testa dei
Cacciatori delle Alpi sferrava un’offensiva nelle Prealpi lombarde e, con la vittoria di San Fermo, liberava Como, Varese,
Bergamo e Brescia. Gli austriaci tentarono un’estrema difesa sul Mincio, ma furono sconfitti nella sanguinosissima battaglia
campale di Solferino e San Martino (24 giugno 1859). Galvanizzate da questi successi militari, in Toscana e in EmiliaRomagna, le popolazioni insorsero contro i rispettivi sovrani, dando vita a governi provvisori che, guidati da gruppi di
moderati filo-piemontesi, chiesero l’annessione al Regno di Sardegna.
A questo punto, tuttavia, Napoleone III, sotto la pressione dell’opinione pubblica francese (conservatori e cattolici
erano preoccupati per la sorte del Papa e dello Stato della Chiesa) e spaventato dalla piega che gli avvenimenti stavano
prendendo (molto diversa da quella da lui auspicata negli accordi di Plombières), decise unilateralmente di interrompere le
ostilità e, l’11 luglio 1859, firmò in gran segreto a Villafranca l’armistizio con l’imperatore d’Austria: l’Austria rinunciava
alla Lombardia e la cedeva alla Francia (che l’avrebbe poi “girata” al Piemonte).
Cavour era, in questo momento, “beffato”, ma anche Napoleone III era in difficoltà, perché – avendo
unilateralmente interrotto la guerra – non poteva né chiedere l’annessione di Nizza e Savoia né giustificare, di fronte
all’opinione pubblica francese, la partecipazione al conflitto. Cavour sfruttò abilmente questa situazione, offrendo a
Napoleone III i territori di Nizza e Savoia in cambio degli stati dell’Italia centrale: nel marzo 1860, Emilia, Romagna e
Toscana furono annesse al Regno di Sardegna tramite plebiscito.
L’esito della seconda guerra d’indipendenza aveva dato un notevole scossone alla situazione politica della penisola,
alimentando le speranze e le attese delle popolazioni ancora soggette all’Austria e all’assolutismo borbonico, ma il fermento
si scontrava con la prudenza di Cavour e del governo sabaudo, decisi, per il momento, ad accontentarsi del risultato
raggiunto, per non forzare troppo la delicata situazione internazionale. In questa fase incerta, riprese l’iniziativa dei
democratici guidati da Mazzini, che tentarono di organizzare le forti aspettative popolari, per portare a compimento l’unità
nazionale in tempi brevi e aprire la strada ad un governo repubblicano.
Una rivolta scoppiata a Palermo nell’aprile del 1860, organizzata dai democratici Francesco Crispi e Rosolino Pilo,
concentrò verso il Sud le energie politiche dei democratici che avviarono i preparativi per una campagna di liberazione di
quelle terre: Garibaldi cominciò ad arruolare volontari in Liguria, senza che il governo sabaudo intervenisse a bloccare
l’iniziativa.
Nella notte fra il 5 e il 6 maggio 1860, poco più di mille volontari presero il mare a Quarto, presso Genova. L’11
maggio, i garibaldini sbarcarono a Marsala e si scontrarono con le truppe borboniche a Calatafimi, riportando la vittoria.
Dopo questo successo i Mille divennero un vero e proprio esercito di liberazione, grazie ai continui arruolamenti di giovani
siciliani, prevalentemente contadini che vedevano in Garibaldi colui che li avrebbe liberati dall’oppressione secolare dei
Borboni, ma anche dei latifondisti. Garibaldi entrò a Palermo e sconfisse, poi, le truppe borboniche a Milazzo il 20 luglio.
Nel frattempo, il clima di entusiastica concordia che aveva accolto i garibaldini al loro sbarco in Sicilia si era
dissolto: convinti di essere alla vigilia della loro liberazione da uno sfruttamento plurisecolare, molti contadini poveri
avevano dato vita a una serie di violente agitazioni contro i grandi proprietari terrieri. Garibaldi e i suoi collaboratori, per
quanto volessero venire incontro alle esigenze dei contadini, non intendevano però mettere in discussione il quadro dei
rapporti di proprietà; nacque così un contrasto insanabile, sfociato in episodi di dura repressione (il più grave dei quali si
verificò a Bronte). Intanto, i proprietari terrieri, spaventati dalle agitazioni agrarie, guardavano sempre più all’annessione al
Piemonte come all’unica efficace garanzia per la tutela dell’ordine sociale.
Garibaldi continuò, comunque, la sua marcia vittoriosa: sbarcò in Calabria all’inizio di agosto e, travolgendo ogni
resistenza, entrò a Napoli il 7 settembre; qui lo raggiunsero Mazzini e i principali capi democratici. Tutto ciò creava gravi
problemi alla strategia di Cavour e dei moderati: se Garibaldi avesse dato l’assalto anche allo Stato pontificio, ciò avrebbe
suscitato le reazioni negative dell’Europa cattolica, ma soprattutto sarebbe stata pericolosa l’affermazione politica dei
democratici (Mazzini agitava la parola d’ordine dell’assemblea costituente che avrebbe dovuto far nascere un’Italia
repubblicana).
Per riprendere il controllo della situazione, Cavour decise due mosse. Inviò suoi emissari al Sud, per contrattare, in
cambio della conservazione dell’ordine sociale tradizionale, l’appoggio dei grandi proprietari terrieri alla politica delle
annessioni al Piemonte, tramite plebisciti. Contemporaneamente, inviò un esercito piemontese verso il Mezzogiorno:
quest’ultimo invase lo stato pontificio e ne sconfisse le truppe a Castelfidardo, poi proseguì la marcia verso sud; a Teano, il
25 ottobre, avvenne l’incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi, che rimise ogni potere nelle mani del monarca sabaudo.
Cavour poté così portare a termine la sua linea politica: tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, si tennero plebisciti nel
Mezzogiorno continentale, in Sicilia, nelle Marche, in Umbria, con esiti largamente favorevoli all’annessione. Il 17 marzo
1861, il primo Parlamento nazionale (eletto secondo la legge elettorale rigorosamente censitaria vigente in Piemonte)
proclamava Vittorio Emanuele II re d’Italia; nasceva il Regno d’Italia come stato unito e indipendente.
LA COSTRUZIONE DELLO STATO UNITARIO
(Vol. 2, Cap. 14: parr. 1, 2, 3, 4)
Il nuovo stato italiano nasceva in una situazione caratterizzata da complessi e gravi problemi: il profondo distacco
esistente tra le diverse parti del Paese, specie tra Nord e Sud; l’ampia percentuale di analfabetismo (78% a livello nazionale,
con punte del 90% nel Meridione e in Sicilia) diffusa tra la popolazione; l’arretratezza dell’agricoltura nel Centro-Sud, con la
larga estensione dei latifondi; il lento sviluppo dell’industrializzazione, limitato dall’assenza di capitali, dalla scarsità di
mezzi e vie di comunicazione, dall’assenza di materie prime nel sottosuolo, dalla mancanza di un mercato interno maturo;
l’arretratezza e la povertà di molte zone del Paese, che facilitava l’insorgere di gravi malattie come pellagra, malaria, colera e
tifo; l’esistenza di moltissime abitazioni malsane e fatiscenti; la mancanza tra gli Italiani di uno spirito civico e di una
coscienza nazionale.
Il 6 giugno 1861, moriva a Torino a soli cinquant’anni il conte di Cavour: la classe dirigente moderata perdeva così
il suo leader naturale e il suo esponente più capace.
Il gruppo dirigente che governò ininterrottamente il paese nel primo quindicennio di vita unitaria non era,
comunque, molto diverso da quello che si era venuto formando dopo il ’49 nel Piemonte costituzionale. I moderati
formavano un gruppo dirigente abbastanza omogeneo, sia dal punto di vista sociale (proprietari terrieri di origine
aristocratica o borghese) sia sotto il profilo politico (le linee portanti erano un moderato liberalismo, un deciso liberismo in
campo economico, la laicità dei rapporti tra Stato e Chiesa). Nei primi parlamenti dell’Italia unita, la maggioranza si
collocava a destra e come Destra venne definita nel linguaggio politico corrente (più tardi venne aggiunto l’aggettivo
storica).
L’opposizione era costituita dai democratici, almeno da quegli esponenti che – meno intransigenti dei mazziniani di
stretta osservanza – decidevano di sedere in parlamento: costoro costituivano la Sinistra, che si appoggiava su una base
sociale formata essenzialmente dai gruppi piccolo e medio-borghesi delle città e comprendeva anche gruppi di operai e
artigiani del Nord, esclusi dall’elettorato. La Sinistra fece, inizialmente, proprie le rivendicazioni della democrazia
risorgimentale: il suffragio universale, il decentramento amministrativo e il completamento dell’unità, da raggiungersi
tramite la ripresa dell’iniziativa popolare.
La conclusione del Risorgimento aveva determinato un’ipoteca moderata sul nuovo Stato: il ruolo-guida del
Piemonte – che già, nel corso del processo risorgimentale, aveva garantito la vittoria moderata – si mantenne per gli stessi
motivi (un Risorgimento senza rivoluzione sociale e partecipazione popolare) nello Stato unitario. Venne esteso a tutto il
territorio italiano lo Statuto albertino, che prevedeva un suffragio elettorale ristrettissimo (2% della popolazione totale) sulla
base del censo (vigeva un sistema elettorale maggioritario a collegio uninominale). La continuità istituzionale con il vecchio
regno sabaudo e il rigoroso conservatorismo sociale determinavano una ristretta base sociale di consenso per il nuovo stato:
la classe dirigente era espressione di un paese legale assai poco rappresentativo del paese reale.
Al momento di determinare la fisionomia del nuovo Stato i leader della destra scelsero, per l’unificazione
amministrativa, la soluzione accentratrice, con l’istituzione in particolare dei prefetti, rappresentanti del potere esecutivo
nelle province. Ciò era un effetto della situazione creatasi al momento dell’unità, ma accentuava anche il predominio
piemontese nella penisola e la ristrettezza della base sociale (era necessario un rigido controllo centrale sulla vita politica
locale).
Nella fase conclusiva del Risorgimento, Cavour aveva rinunciato ad una parte dei suoi progetti liberali e aveva
accettato – per vincere la battaglia politica con i democratici – un compromesso con le classi dirigenti meridionali,
garantendo loro la conservazione degli equilibri sociali esistenti. Cosicché, nelle province meridionali, il permanere del
malessere antico delle masse contadine legato alla mancata realizzazione delle secolari aspirazioni alla proprietà della terra si
sommò ad una diffusa ostilità verso il nuovo ordine politico, che non aveva mutato i rapporti sociali; a ciò si aggiungeva la
notevole pressione dello stato attraverso la pesante fiscalità e il servizio di leva obbligatorio.
Tutto ciò, già nell’estate del 1861, scatenò il brigantaggio nelle regioni del Mezzogiorno continentale, un moto di
rivolta incoraggiato da una parte del clero e sovvenzionato dalla corte borbonica in esilio a Roma, che coinvolse briganti,
contadini insorti, ex militari borbonici. Lo Stato italiano rispose con una dura repressione militare, che consentì di riportare
l’ordine entro il 1865. Il governo dimostrò una sostanziale insensibilità nei confronti delle classi lavoratrici meridionali, per
le quali si protrassero miseria e oppressione sociale.
La politica economica attuata dai governi della Destra storica seguì due direzioni fondamentali:
1. l’espropriazione e la vendita – in grandi lotti – delle proprietà terriere ecclesiastiche, con un rafforzamento della
grande proprietà borghese;
2. l’unificazione del mercato nazionale, attraverso a) l’eliminazione delle barriere doganali regionali, secondo i
principi del liberismo e b) lo sviluppo delle infrastrutture (soprattutto attraverso la costruzione della rete ferroviaria,
ma anche di scuole e ospedali).
Questa politica economica ebbe effetti complessi: ci fu un incremento generale dell’agricoltura, in particolare delle
produzioni agricole, come alcune colture specializzate meridionali, più specificatamente rivolte all’esportazione, mentre
l’industria fu in generale penalizzata: gli effetti furono particolarmente negativi per il lavoro a domicilio, che andò in crisi, e
per i pochi nuclei industriali del sud, inesorabilmente cancellati dalla brusca caduta dei dazi protettivi all’ombra dei quali si
erano sviluppati.
Al crollo dell’economia, al sud si aggiunsero il limitato intervento dello stato nella creazione di infrastrutture (il
massimo sforzo nella costruzione di opere pubbliche si concentrò al centro-nord) e la fuga di capitali meridionali verso
l’investimento in titoli di stato: in queste condizioni si annidava l’origine della questione meridionale (differenza tra nord
sviluppato e sud arretrato). Nello stesso tempo, tuttavia, la crisi economica impediva la formazione del mercato al sud e ciò
costituiva un serio ostacolo per gli stessi progetti di sviluppo produttivo della borghesia industriale settentrionale. Nel
complesso, nei primi vent’anni di vita unitaria, l’Italia perse ulteriore terreno nei confronti dei paesi più progrediti e il tenore
di vita della maggioranza dei suoi abitanti non registrò mutamenti di rilievo, anzi, in alcuni casi, addirittura peggiorò
(l’arretratezza e la povertà di molte zone facilitavano, tra l’altro, l’insorgere di varie e gravi malattie, come la pellagra, la
malaria, il colera e il tifo).
A determinare quest’ultimo esito contribuì in gran parte la dura politica fiscale della Destra. Il nuovo stato nasceva con
un grave deficit di bilancio dovuto a: 1) i debiti ereditati dagli stati pre-unitari; 2) le spese di guerra sostenute negli anni
precedenti l’unità e in seguito alla repressione del brigantaggio; 3) l’avvio all’opera di creazione delle infrastrutture. Per far
fronte a tale situazione, la Destra scelse la strada dell’inasprimento della pressione fiscale sulle masse rurali e popolari,
attraverso il ricorso privilegiato alla tassazione indiretta. Il conseguente aumento dei prezzi dei prodotti di largo consumo
aggravò le condizioni di vita già misere di contadini e lavoratori urbani, determinando un grave stato di tensione sociale, che
raggiunse il culmine nell’estate del 1868, con il varo della tassa sul macinato: l’introduzione di questa tassa provocò,
all’inizio del 1869, le prime agitazioni sociali su scala nazionale della storia dell’Italia unita. La repressione fu anche in
questo caso durissima. Il pareggio del bilancio fu, a questi prezzi, conseguito nel 1875.
In tema di economia, va ancora ricordata l’introduzione del corso forzoso nel 1866, che consentì di mettere a
disposizione maggiore denaro per le attività economiche e maggiori prestiti per il finanziamento del disavanzo dello stato,
ma con conseguenze inflazionistiche.
Fra i molti difficili compiti che i governi della Destra storica furono chiamati ad assolvere c’era anche quello di
completare l’unità, con la liberazione delle tre Venezie, di Roma e del Lazio.
Nel 1866, l’Italia accolse l’invito del governo prussiano e scese nuovamente in guerra contro l’Austria (terza guerra
d’indipendenza). La guerra mise in evidenza la debolezza militare del nuovo stato, poiché gli italiani furono sconfitti dagli
austriaci sia per terra (a Custoza) che per mare (a Lissa), ma la vittoria prussiana di Sadowa costrinse gli austriaci a cedere il
possesso del Veneto, che entrò a far parte del territorio italiano (mentre restavano ancora austriache Trento e Trieste).
Quanto alla questione romana (il problema dell’annessione di Roma e dei territori dello Stato della Chiesa), essa ebbe
uno sviluppo complesso e tortuoso. I primi governi dell’Italia unita cercarono di procedere sulla strada inizialmente indicata
da Cavour. Questi credeva fermamente nella libertà religiosa e nella separazione fra Chiesa e Stato (libera Chiesa in libero
Stato), ma le trattative avviate, su questa base, sia da Cavour che dal suo successore, Bettino Ricasoli, si scontrarono contro
l’intransigenza di Pio IX, che riteneva il potere temporale garanzia imprescindibile dell’autonomia della Chiesa in Italia (nel
1864, inoltre, Pio IX emanò l’enciclica Quanta cura, nella quale accomunava in una condanna senza appello il liberalismo, la
democrazia, il socialismo e l’intera civiltà moderna, facendo seguire all’enciclica il Sillabo, una sorta di elenco degli “errori
del secolo”: sovranità popolare, laicità dello stato, libertà di stampa e di opinione).
In sintesi, lo svolgimento della questione romana ebbe i seguenti momenti chiave.
1.
1862: episodio di Aspromonte, quando un tentativo di spedizione dei garibaldini fu fermato dall’esercito italiano
con un scontro a fuoco.
2.
1864: Convenzione di settembre, firmata dal governo francese (Napoleone III manteneva, come già nel 1849, la
sua protezione sullo Stato pontificio) e da quello italiano, che si impegnava a rinunciare definitivamente alla
liberazione di Roma e trasferiva la capitale, a garanzia del suo impegno, da Torino a Firenze.
3.
1867: episodio di Mentana, quando un nuovo tentativo militare di Garibaldi fu direttamente bloccato
dall’esercito francese.
4.
20 settembre 1870: breccia di Porta Pia, quando – sconfitto Napoleone nella guerra franco-prussiana del
medesimo anno (con la conseguente caduta del Secondo Impero in Francia) – il governo italiano procedette alla
occupazione militare di Roma, che l’estate successiva fu proclamata capitale d’Italia.
5.
1871: emanazione della legge delle guarentigie, con la quale il governo italiano si impegnava unilateralmente a
garantire al pontefice le condizioni per il libero svolgimento del suo magistero spirituale, mentre gli venivano
riconosciute prerogative simili a quelle di un capo di Stato.
6.
1874: emanazione da parte di Pio IX del non expedit, col quale il papa vietava ai cattolici la partecipazione (sia
attiva che passiva) alle elezioni politiche italiane.
La questione romana si concludeva, quindi, con l’acquisto di Roma, ma anche con una grave frattura tra la borghesia
liberale e quella cattolica, frattura che restringeva la già fragile base di consenso su cui si reggevano le istituzioni dello Stato.
EUROPA E AMERICA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO
(Vol. 2: Cap. 15: parr. 2, 3, 4)
a) L’Europa
Dopo la vittoria nella guerra di Crimea, l’Inghilterra aveva imboccato con sempre maggiore determinazione la via
politica dello splendido isolamento, che la spinse a estraniarsi dalle lotte di potere costantemente presenti nel continente e a
interessarsi, invece, a fondo alla politica interna e all’espansione coloniale.
Forti di uno stabile assetto politico di tipo liberale-parlamentare, i governi inglesi si impegnarono a risolvere i più
scottanti problemi derivanti dall’evoluzione dell’industria, che già attorno agli anni cinquanta aveva trasformato la Gran
Bretagna nel primo Paese europeo a prevalente economia urbano-industriale, mentre potenti gruppi finanziari – con sede
soprattutto a Londra – diventarono veri e propri centri propulsori di ogni iniziativa imprenditoriale. Votata dagli anni
quaranta al liberismo economico, l’Inghilterra finì per dominare il commercio internazionale, grazie sia alla propria
organizzazione finanziaria sia a una imponente flotta mercantile, fattori che le consentivano di esportare nel mondo prodotti
industriali e macchine; ugualmente sviluppato era il commercio interno.
Nell’ambito di tale situazione l’Inghilterra visse la cosiddetta età vittoriana, ovvero l’età felice della regina
Vittoria, succeduta appena diciottenne – quale ultima discendente della casa di Hannover – allo zio Guglielmo IV nel 1837 e
rimasta al potere fino al 1901: durante il suo lunghissimo regno il paese raggiunse la sua massima espansione commerciale e
coloniale.
Nonostante il favorevole quadro generale, non mancavano i problemi, in primo luogo quello dell’Irlanda, sempre
più decisa a rivendicare la propria indipendenza dal Regno Unito (gli irlandesi erano cattolici e, inoltre, venivano sfruttati dai
grandi proprietari e dai grandi mercanti inglesi).
In Francia, invece, la situazione era più complessa: all’inizio degli anni sessanta la popolarità di Napoleone III
aveva cominciato a declinare, soprattutto tra i suoi iniziali sostenitori, cattolici e industriali conservatori. Ciò indusse
l’imperatore ad attuare – per bilanciare tale perdita di consensi – una politica interna sempre più liberale e disponibile a
soddisfare alcune delle richieste avanzate dall’opposizione democratica e repubblicana (vennero concessi i diritti di
associazione sindacale e di sciopero e una limitata libertà di stampa e di riunione).
L’opposizione democratica e repubblicana approfittò di queste aperture per conseguire alcuni successi, anche sul
piano elettorale; ciò indusse Napoleone III a cercare nuovamente consensi tra i cattolici e la borghesia, in questo caso
favorendo lo sviluppo della grande industria con la creazione di nuovi istituti bancari, i cui prestiti agevolati incentivarono la
costruzione delle ferrovie, l’apertura di miniere, la costruzione di porti e canali. Attuò, inoltre, una politica internazionale di
prestigio, fondata sull’ampliamento dei possedimenti coloniali e sull’intervento nella politica europea.
Per quanto riguardava la Russia, la sconfitta in Crimea aveva reso evidente l’arretratezza del sistema zarista e la
necessità di un suo rinnovamento, pur senza smantellare l’indirizzo autocratico, sentito come l’unico adatto a mantenere uniti
i numerosi e diversi gruppi etnici che costituivano il vasto impero. La testimonianza più chiara dell’arretratezza della società
russa sul piano socio-economico era individuabile nella quasi totale assenza di una borghesia attiva e intraprendente e nella
massiccia presenza di ben 47 milioni di servi della gleba (su 67 milioni di abitanti totali).
Il giovane zar Alessandro II (salito al trono nel 1855), resosi ben presto conto che la sconfitta militare aveva in gran
parte le proprie radici nelle strutture arcaiche del Paese, dette vita con la sua azione di governo a una serie di avanzate
riforme, la più significativa delle quali fu l’emanazione, il 3 marzo 1861, del cosiddetto Statuto dei contadini liberati, in
base al quale venivano concesse ai servi della gleba la libertà e la possibilità di possedere una casa e un pezzo di terra da
lavorare (quest’ultimo attraverso il mir, la comunità del villaggio), dietro pagamento di una somma adeguata. Il
provvedimento, tuttavia, suscitò il malcontento non solo dei nobili, ma anche di molti contadini, impossibilitati a pagare
l’oneroso riscatto per divenire padroni delle loro terre e, quindi, costretti a ingrossare le fila di un numeroso proletariato
agricolo.
In generale, il tentativo di modernizzazione economico-sociale, risultando frutto di un insieme di disposizioni
disorganiche, imposte e programmate dall’alto, finì per dimostrarsi sostanzialmente inefficace, soprattutto per l’incapacità di
ampie fette della società russa di comprendere e sostenere le riforme. Ciò finì per alimentare un crescente movimento di
protesta contro il regime zarista, movimento peraltro circoscritto alla cosiddetta intelligencija (la collettività degli intellettuali
russi) e alle giovani generazioni, tra le quali si diffuse la parola d’ordine “andare al popolo”, che ebbe ampia diffusione negli
anni sessanta e settanta: donde il nome di populisti col quale vennero designati gli intellettuali rivoluzionari che in questo
periodo tentarono, pur senza troppa fortuna, di compiere opera di educazione culturale e politica fra le masse contadine.
Assai diversa la situazione nei territori germanici, dove dalla metà del secolo si verificò – soprattutto in Prussia –
un intenso sviluppo industriale. Ne conseguì una rilevante prosperità, che favorì la nascita – accanto alla potentissima e
conservatrice aristocrazia fondiaria degli Junker – di una nuova e consistente classe borghese. Tale sviluppo economico e
sociale costituì la base su cui si generò la politica nazionale della Prussia, che – consapevole della forza del suo esercito –
aspirava a divenire la guida del processo di unificazione della Germania, ma al di fuori delle idealità liberali e democratiche.
A spingere in tale direzione furono due personalità dalla tendenza decisamente antiliberale: il re Guglielmo I di
Hohenzollern e il conte Ottone von Bismarck, un tipico rappresentante degli Junker; nominato primo ministro nel 1862,
Bismarck si impegnò a governare senza il consenso del Parlamento e proclamò, in un celebre discorso programmatico, di
voler risolvere il problema dell’unità nazionale “non con discorsi né con deliberazioni della maggioranza (…) bensì col
sangue e col ferro”. Applicando con decisione tale orientamento, in pochi anni portò il suo Paese a realizzare l’unificazione
tedesca e a divenire, da ultima fra le cinque grandi potenze europee, l’indiscussa egemone sul continente.
Il primo ostacolo da superare era costituito dall’Austria, che era contemporaneamente impero plurinazionale e stato
tedesco membro della Confederazione germanica. Le due potenze, dopo essersi accordate per strappare alla Danimarca – con
una rapida campagna militare – i ducati di Schleswig, Holstein e Lauenburg, entrarono in conflitto circa l’amministrazione
dei territori conquistati. La guerra tra Austria e Prussia (cui partecipò anche l’Italia, alleata con la seconda), scoppiata nel
giugno del 1866, si concluse rapidamente con la vittoria prussiana nella battaglia di Sadowa (già citata). L’Austria dovette
accettare lo scioglimento della vecchia Confederazione germanica e, dunque, la fine di ogni influenza nell’Europa centrosettentrionale, mentre gli stati tedeschi a nord del fiume Meno entrarono a far parte di una nuova Confederazione della
Germania del Nord presieduta da Guglielmo I.
L’ultimo ostacolo sulla via dell’unità tedesca era rappresentato dalla Francia di Napoleone III, deciso a non
consentire ulteriori ingrandimenti della Prussia. L’occasione per il conflitto fu offerta da una questione dinastica: nel 1868 il
trono di Spagna, rimasto vacante, fu offerto a un parente del re di Prussia; tale prospettiva spaventò la Francia e Bismarck
seppe sfruttare l’occasione per provocare il governo francese, inducendolo a dichiarare guerra alla Prussia.
Come nel ’66, le truppe prussiane comandate dal generale von Moltke si mossero con grande rapidità in base a un
preciso piano strategico. Il 1° settembre 1870 metà dell’esercito francese venne accerchiata a Sedan e costretta ad arrendersi.
Pochi giorni dopo, nella capitale accerchiata dai prussiani, si formò un governo provvisorio composto in buona parte da
repubblicani (nasceva così la Terza Repubblica, dopo quelle del 1792 e del 1848). Il nuovo governo fu però costretto a
lasciare Parigi e a chiedere l’armistizio, che fu firmato il 28 gennaio 1871.
Nel frattempo la vittoria prussiana aveva fatto cadere le residue resistenze degli Stati tedeschi indipendenti nei
confronti dell’unificazione: il 18 gennaio 1871, nella reggia di Versailles, luogo-simbolo della potenza dei re di Francia,
Guglielmo I fu incoronato imperatore tedesco (Deutscher Kaiser). Quella tedesca fu così un’unità raggiunta in modo
autoritario, attuata, in seguito a una guerra combattuta fuori dai confini nazionali, soprattutto per l’iniziativa di uno statista
geniale e dispotico, mai ratificata da un plebiscito o da una qualsiasi forma di consultazione popolare.
La stessa logica autoritaria ispirò le condizioni di pace imposte da Bismarck alla Francia (trattato di Francoforte del
maggio 1871): la Francia fu costretta a corrispondere una pesante indennità di guerra e a mantenere truppe d’occupazione
tedesche sul proprio territorio fino al pagamento di tale indennità; dovette anche cedere alla Germania l’Alsazia e la Lorena,
due province di confine di notevole importanza economica e strategica. Si trattò di una vera e propria umiliazione nazionale,
che avrebbe fatto nascere nei francesi un intenso desiderio di rivincita (revanchismo).
Nella primavera del 1871, inoltre, la Francia dovette affrontare una drammatica crisi interna, in parte causata dalla
sconfitta, in parte legata alle tensioni politiche e sociali che gli avvenimenti del ’48 avevano portato alla luce e che vent’anni
di regime bonapartista non erano riusciti a soffocare. Dopo Sedan, il popolo della capitale era insorto e aveva costituito una
Guardia nazionale; Parigi aveva vissuto la caduta di Napoleone III come una nuova occasione rivoluzionaria e come l’inizio
di una riscossa nazionale. Ma, ancora una volta, ben diverso era l’orientamento delle campagne e delle province, dove
prevalevano le tendenze conservatrici e il desiderio di una rapida firma della pace.
Quando furono rese note le durissime condizioni imposte da Bismarck (che prevedevano fra l’altro l’ingresso delle
truppe tedesche nella capitale), il popolo di Parigi protestò in massa e decise di difendere la città. Nacque così il Consiglio
della Comune, nel quale il potere venne assunto – dopo elezioni cui l’elettorato conservatore si astenne in gran parte dal
partecipare – dai gruppi di estrema sinistra. I dirigenti della Comune diedero vita a un radicale esperimento di democrazia
diretta: fu abolita la distinzione tra potere esecutivo e legislativo; tutti i funzionari furono resi elettivi e continuamente
revocabili; l’esercito fu sostituito da milizie popolari armate. Queste misure, che prefiguravano la nascita di una società
socialista, provocarono l’allarme dei conservatori e dei moderati di tutta Europa.
Gli appelli lanciati da Parigi agli altri comuni di Francia affinché si associassero alla capitale in una libera
federazione caddero, tuttavia, nel vuoto. Cosicché l’esperienza rivoluzionaria della Comune durò non più di due mesi: il
tempo necessario al primo ministro Adolphe Thiers, tipico rappresentante della Francia moderata, per raccogliere, con la
benevola neutralità degli occupanti tedeschi, un esercito abbastanza forte per muovere alla conquista della capitale, che cadde
dopo scontri particolarmente violenti e sanguinosi combattuti fra il 21 e il 28 maggio. Per la seconda volta in poco più di
vent’anni, il movimento rivoluzionario francese si trovava sconfitto e fisicamente decimato.
b) Gli Stati Uniti
Intorno alla metà del XIX secolo, gli Stati Uniti d’America offrivano l’immagine di un paese in crescente
espansione: la popolazione era in costante aumento, grazie soprattutto all’ininterrotto flusso migratorio proveniente
dall’Europa; i confini dell’Unione continuavano a spostarsi verso Ovest; la produzione agricola progrediva con ritmi che non
avevano uguali al mondo, sia per la messa a coltura di nuove terre nelle regioni di recente colonizzazione, sia per lo sviluppo
di una moderna agricoltura capitalistica negli Stati del Vicino Ovest (Midwest); contemporaneamente le regioni del Nord-est
conoscevano un rapido e tumultuoso sviluppo industriale.
Non mancavano, tuttavia, profonde fratture interne al paese. Negli Stati Uniti coesistevano infatti tre diverse
società, corrispondenti a diverse zone del paese, ciascuna col suo sistema economico, i suoi valori, le sue tradizioni culturali:
1)
C’erano gli Stati del Nord-est, nucleo originario dell’Unione; si trattava della zona più progredita, più
ricca e più industrializzata, dove sorgevano i maggiori centri urbani, dove principalmente si indirizzava
l’ondata migratoria e dove ai gruppi industriali, commerciali e bancari si contrapponeva un ormai
numeroso proletariato urbano.
2)
Quella degli Stati del Sud era invece una società agricola e profondamente tradizionalista, che fondava
la sua economia e la sua organizzazione sociale sulle grandi piantagioni di cotone (e di tabacco e canna
da zucchero). La manodopera che vi lavorava era costituita in gran parte da schiavi neri al servizio dei
grandi proprietari, una ristretta minoranza che dominava la vita politica e sociale.
3)
Esistevano infine i liberi agricoltori e allevatori di bestiame che popolavano gli Stati dell’Ovest, una
società legata all’etica e ai valori della frontiera: l’iniziativa individuale, l’indipendenza, l’uguaglianza
delle opportunità
Fu proprio l’Ovest a costituire il pomo della discordia, e al tempo stesso l’elemento risolutore nel contrasto che, a
partire dalla metà del secolo, oppose il Nord industriale e il Sud schiavistico. L’idea stessa della schiavitù mal si conciliava
con la mentalità democratica diffusa fra le popolazioni del nord (dove era attivo da tempo un vivace movimento
abolizionista); ma era anche incompatibile con la filosofia del capitalismo e con la sua esigenza di disporre di una
manodopera mobile e di un mercato interno in espansione.
Negli anni ’40 e ’50, lo sviluppo industriale si allargò a nuovi settori (in particolare, a quello meccanico), diminuì
l’importanza della produzione cotoniera nel complesso dell’economia americana e si fecero più strette le relazioni fra il Nord
industriale e l’Ovest agricolo: quest’ultimo trovava nelle aree urbane in continua espansione ampi sbocchi per i suoi prodotti
e costituiva a sua volta un ottimo mercato per l’industria meccanica, che vi collocava soprattutto macchine agricole.
Contemporaneamente, i piantatori del Sud avrebbero voluto estendere l’economia delle piantagioni (e dunque del
lavoro servile) ai nuovi territori, per allargare la coltura del cotone alle terre vergini (dove i rendimenti erano più alti); ma tale
richiesta incontrava forti opposizioni nell’opinione pubblica del Nord e fra i coloni dell’Ovest.
A ciò si aggiunsero i contrasti tra le forze politiche: all’inizio degli anni ’50 i partiti tradizionali (democratici e
liberali) entrarono in profonda crisi, tanto che dall’ala progressista del partito liberale (whig) nacque nel 1854 una nuova
formazione politica, il Partito repubblicano. Qualificandosi in senso decisamente antischiavista e facendosi interprete degli
interessi della borghesia del Nord (dazi doganali più alti, che avrebbero favorito la produzione industriale, ma danneggiato le
esportazioni di cotone del Sud) e di quelli dei coloni dell’Ovest (distribuzione gratuita dei terreni demaniali), il nuovo partito
conquistò un seguito crescente fino a portare alla presidenza, nelle elezioni del 1860, un tipico uomo dell’Ovest: Abraham
Lincoln, un avvocato di salde convinzioni democratiche, proveniente da una famiglia di modesti agricoltori.
La vittoria repubblicana fu sentita da una parte dell’opinione pubblica del Sud come l’inizio di un processo
irreversibile che avrebbe portato alla vittoria degli interessi industriali, al rafforzamento del potere centrale, alla progressiva
emarginazione degli Stati schiavisti. Di qui la decisione, presa fra il dicembre ’60 e il febbraio ’61 da dieci Stati del sud, di
staccarsi dall’Unione e di costituirsi in una confederazione indipendente. La secessione sudista suscitò inevitabilmente la
reazione del potere federale: nell’aprile 1861 iniziò la guerra civile.
Nonostante il migliore addestramento delle truppe sudiste e le notevoli capacità del loro comandante, il generale
Robert Lee, il fattore numerico e quello economico (favorevoli per i nordisti) si rivelarono decisivi. La guerra si concluse
infatti nell’aprile del 1865 con la resa dei confederati al generale Ulysses Grant, comandante delle forze del Nord. Pochi
giorni dopo, il presidente Lincoln cadeva vittima di un attentato compiuto da un fanatico sudista.
Per vincere la guerra, i nordisti dovettero non solo fare appello a tutte le loro risorse economiche, ma anche
mobilitare tutte le energie politiche disponibili. Nel 1862 era stata approvata una legge che assegnava gratuitamente ai
cittadini che ne facessero richiesta quote di terra del demanio statale. L’anno dopo era stata decretata la liberazione degli
schiavi in tutti gli Stati del Sud. In realtà, la rivoluzione democratica implicita nell’esito della guerra di secessione fu ben
lontana dal compiersi interamente. La vittoria nordista e le innovazioni legislative (va detto che la legge del ’62 sulla
distribuzione delle terre libere fu revocata pochi anni dopo la fine della guerra) non valsero a colmare le disuguaglianze
sociali, né poterono cancellare i pregiudizi razziali profondamente radicati nella società del Sud.
Negli anni successivi, sia pure a fatica e tra grandi difficoltà gli Stati Uniti riuscirono a risollevarsi dalle
drammatiche conseguenze della guerra civile, mentre l’eterogeneo mondo dei pionieri riprendeva ad avanzare verso l’Oceano
Pacifico, lanciandosi alla conquista del Far West (lontano Occidente), avventura che avrebbe provocato lo sterminio
sistematico di intere popolazioni indiane. Infatti, quando l’avanzata dei pionieri cominciò a spostare sempre più a Ovest i
limiti del confine occidentale (la cosiddetta frontiera), non tardarono ad assumere proporzioni sempre più preoccupanti non
solo i pericoli opposti dalla natura, ma anche e soprattutto la resistenza da parte degli Indiani (Pellirosse) che difendevano i
loro territori di caccia e, con essi, le loro possibilità di sopravvivenza.
Da qui nacque la lunga serie delle cosiddette guerre indiane, protrattesi per circa un trentennio (1862-1890) e
contraddistinte da grande ferocia e inaudita crudeltà da entrambe le parti. La superiorità tecnologica dei bianchi (ferrovia,
telegrafo, potenti armi da fuoco) finì per prevalere sul coraggio e sulla combattività degli indiani, che vennero
completamente distrutti come popolo libero e dotato di una propria identità. Ad annientarli definitivamente fu soprattutto la
strage dei bisonti, incentivata all’epoca della costruzione delle ferrovie transcontinentali: la scomparsa di questi animali
ridusse gli indiani alla fame e spezzò l’equilibrio naturale che essi erano sempre stati attenti a non alterare e sul quale
avevano fondato la loro civiltà.
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO
(Vol. 2: Cap.17: parr. 1, 2)
Nella seconda metà dell’Ottocento, il sistema industriale dei più sviluppati paesi europei era in grande espansione,
quando venne colpito da una generale, e grave, crisi di sovrapproduzione – iniziata nel 1873 – causata dall’esuberanza di
prodotti industriali rispetto alla possibilità di assorbimento del mercato: l’affermazione di nuovi paesi produttori (Stati Uniti,
Giappone, Russia) e la grande crescita industriale della Germania avevano rotto il precedente equilibrio tra produzione e
consumi.
La crisi industriale fu, quasi immediatamente, seguita da una crisi agricola – iniziata nel 1879/80 – dovuta alla
concorrenza del grano nordamericano sul mercato europeo. Mentre l’agricoltura europea continuava a patire gli effetti della
divisione tra aree moderne ed evolute (Inghilterra, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Francia, paesi scandinavi,
alcune regioni dell’Italia settentrionale, dell’Austria e della Boemia) e regioni arretrate (quasi tutta l’Europa orientale e buona
parte dell’area mediterranea, zone caratterizzate dalla permanenza del latifondo), negli Stati Uniti si andava sviluppando,
nella seconda metà del secolo scorso, una nuova agricoltura: qui la vasta disponibilità di terre ricche da dissodare
(amplificata dalla relativa scarsità di manodopera) si accompagnava all’adozione di tecniche avanzate e anche il piccolo
coltivatore indipendente poteva affrontare – grazie al basso prezzo di acquisto della terra e alla facilità di accesso al credito –
il rischio dell’investimento. Quando, grazie allo sviluppo della navigazione a vapore, i prodotti dell’agricoltura americana
giunsero in Europa a prezzi particolarmente competitivi, l’agricoltura europea ne ricevette un duro colpo.
A questo punto, industriali e agricoltori di quasi tutta Europa invocarono l’adozione di tariffe doganali protettive
contro la concorrenza dei prodotti esteri: a partire dal 1879, la maggioranza degli stati abbandonò il liberismo (fece eccezione
la sola Inghilterra, che rimase fedele alla sua tradizionale politica economica liberista, ma ne uscì danneggiata) e adottò il
protezionismo (inasprimento delle tariffe doganali sui prodotti delle economie straniere). Fu l’inizio della fine del lassaiz
faire, lassaiz passer.
Gli effetti della crisi (disoccupazione e fallimenti) avevano nel frattempo determinato un’intensificazione del processo di
concentrazione capitalistica: si formarono i monopoli, altra spinta al declino della libera concorrenza. I monopoli potevano
essere di tre tipi:
- Holdings: grandi consociazioni per il controllo finanziario di diverse imprese.
- Cartelli o pools: consorzi tra aziende dello stesso settore che si accordavano sulla produzione e sui prezzi.
- Trusts: vere e proprie concentrazioni industriali fra imprese prima indipendenti.
Un ruolo decisivo, in questi processi, fu svolto dalle istituzioni finanziarie, perché solo le grandi banche potevano
assicurare gli imponenti e costanti flussi di denaro necessari alla nascita e alla crescita dei nuovi colossi industriali nati dalle
concentrazioni industriali. Fra banche e imprese si venne così a creare uno stretto rapporto di compenetrazione, cui gli
economisti marxisti diedero il nome di capitalismo finanziario.
Questi fenomeni, uniti alla introduzione di nuove tecniche produttive e alla riorganizzazione e razionalizzazione dei
sistemi di lavoro in fabbrica, che permisero di ridurre progressivamente i costi di produzione (gli storici definiscono questi
processi con l’espressione seconda rivoluzione industriale), determinarono un nuovo incremento della produzione di merci
e della accumulazione di capitali, ma in una situazione – accentuata dal protezionismo – di mercati rigidi: si rendeva
necessario trovare nuovi sbocchi di mercato e di investimento.
Questa necessità si accompagnava ad una nuova concezione dei rapporti internazionali, che andò diffondendosi in
Europa dall’inizio degli anni settanta. Tramontarono alcuni fra i principi fondamentali della cultura liberal-democratica
ottocentesca, come il diritto di nazionalità e la libertà dei popoli, sostituiti dall’ideologia della forza, del fatto compiuto, della
pura politica di potenza, fondata sullo sviluppo degli armamenti e degli eserciti.
E’ in questa nuova situazione economica e politica (il protezionismo spinse il grande capitale e i governi delle grandi
potenze verso l’orizzonte di idee per cui i mercati si conquistavano e si difendevano con la forza) che affonda le radici
l’imperialismo contemporaneo, definito dagli storici di scuola marxista come protezione politica e militare degli
investimenti.
La conquista militare e la dominazione politica dei paesi sottosviluppati in Asia e in Africa – colonialismo – furono la
condizione indispensabile per realizzare i seguenti obiettivi:
1. investire capitali in condizioni favorevoli (bassi salari della manodopera, mancanza di capitali concorrenti);
2. reperire materie prime a basso costo;
3. vendere merci in condizione di monopolio.
Mentre il secondo e il terzo obiettivo erano fattori presenti anche nel colonialismo dei secoli precedenti, il primo
(l’investimento di capitali in attività produttive, e non solo commerciali) costituiva una novità caratteristica dell’imperialismo
contemporaneo; quest’ultimo si distingueva per altre due peculiarità: il fatto che l’espansione coloniale fosse esercitata
direttamente dai governi, e non da compagnie private, e la conquista militare e politica dei territori interni (mentre in passato
gli europei si erano limitati al controllo delle coste).
Secondo l’interpretazione marxista del fenomeno, furono quindi determinanti gli interessi economici del capitalismo
occidentale nel promuovere la corsa alla conquista di colonie: tutto il mondo era ormai preso nella rete dei rapporti di
produzione capitalistici, con effetti non solo economici, ma anche socio-culturali, poiché l’organizzazione sociale, civile e
statale dei paesi sottosviluppati fu, in pochi anni, sconvolta dalle fondamenta.
Altre interpretazioni, di origine liberale, puntano, o puntarono, maggiormente l’attenzione su fattori politico-ideologici.
Si trattava di una mescolanza di nazionalismo e di politica di potenza, di interpretazioni razziste del darwinismo e di spirito
missionario. Il mito di una vocazione imperiale delle singole nazioni si legava, poi, a quello di una missione nel mondo della
civiltà europea nel suo complesso. Il “fardello dell’uomo bianco” di cui parlava lo scrittore inglese R. Kipling era, appunto,
la missione civilizzatrice che l’Europa colta e sviluppata doveva compiere presso popolazioni “selvagge e inferiori”, incapaci
di sfruttare e utilizzare le proprie enormi risorse naturali (ma quasi tutte le conquiste coloniali furono segnate dall’uso
sistematico e indiscriminato della forza contro le popolazioni indigene, da un campionario di crudeltà sconosciuto agli ultimi
conflitti combattuti sul vecchio continente).
Tale sorta di scopo morale-educativo aveva animato l’opera di coloro che “avevano aperto la strada” agli eserciti: i
missionari e gli esploratori, che addentrandosi in territori rimasti fino alla metà del secolo quasi sconosciuti, avevano fornito
preziose notizie sulle loro risorse, sulle condizioni di vita delle popolazioni e sulla natura del suolo, permettendo in tal modo
la compilazione di carte abbastanza precise. Tutto ciò concorse a far sorgere il fascino dell’esotico e a generare un grande
interesse per i paesi destinati a diventare preda della colonizzazione.
In questa azione di conquista la parte del leone fu sostenuta soprattutto dall’Inghilterra e dalla Francia, che in un breve
giro di anni seppero creare imperi sterminati in Asia, in Africa e in Oceania, mentre in una posizione in qualche modo
secondaria agirono Germania, Belgio, Italia (fra le potenze europee, l’unica assente di rilievo fu l’Austria-Ungheria),
Giappone e Stati Uniti.
A partire dagli ultimissimi anni del secolo scorso, l’economia dei paesi industrializzati conobbe una fase di espansione
intensa e prolungata, interrotta solo da una breve crisi nel 1907-08: gli anni 1896-1913 furono segnati da uno sviluppo
generalizzato della produzione che interessò quasi tutti i settori e toccò anche paesi “nuovi arrivati”, come la Russia e l’Italia.
I prezzi crebbero costantemente anche se lentamente, dopo il 1896, ma crebbe anche, e in misura più consistente, il livello
medio dei salari, e il reddito pro-capite dei paesi industrializzati aumentò.
Le esigenze di un mercato che andava assumendo dimensioni di massa spinsero le imprese ad accelerare i processi di
meccanizzazione e di razionalizzazione produttiva, allo scopo di adeguare la produzione alle nuove condizioni del mercato.
Si trattava di realizzare un più razionale controllo e sfruttamento del lavoro umano. Un ingegnere statunitense, Frederick W.
Taylor, pubblicò nel 1911 un libro intitolato Principi di organizzazione scientifica del lavoro. Il metodo di Taylor si basava
sullo studio sistematico del lavoro in fabbrica, sulla rilevazione dei tempi standard necessari per compiere le singole
operazioni e sulla fissazione, in base ad essi, di regole e ritmi cui gli operai avrebbero dovuto uniformarsi, eliminando le
pause ingiustificate e gli sprechi di tempo.
La prima applicazione concreta delle idee di Taylor si verificò nel 1913, nelle officine automobilistiche Ford di Detroit,
dove fu introdotta la prima catena di montaggio: la frammentazione del processo produttivo in una serie di piccole
operazioni, ciascuna affidata a un singolo operaio, assicurava notevoli progressi in termini di produttività, ma rendeva il
lavoro ripetitivo e spersonalizzato; incontrava quindi una diffusa ostilità tra i lavoratori, anche se la riduzione dei costi
permetteva a Ford di praticare una politica (poi seguita anche da altre imprese) di salari relativamente alti.
IL PERIODO DELLA SINISTRA
(Vol. 2: Cap.16: parr. 1, 2, 3, 4)
Nel 1876 si verificò, in Italia, la cosiddetta rivoluzione parlamentare, con il passaggio del potere dalla Destra alla
Sinistra. Si era ormai allargata la frattura fra i gruppi dirigenti della Destra e la società italiana nel suo complesso:
1) la tassazione eccessiva aveva oppresso le classi più povere;
2) ciò limitava i consumi e ostacolava gli sforzi degli industriali settentrionali che chiedevano una politica economica
più attiva e decisa;
3) la piccola e media borghesia chiedeva una rappresentanza politica;
4) i proprietari terrieri meridionali erano sempre più insoddisfatti di una politica che sacrificava il sud a vantaggio del
nord.
Il 18 marzo 1876 la Destra si presentò divisa durante la discussione alla camera di un progetto governativo per il
passaggio alla gestione statale delle ferrovie. Il governo Minghetti, messo in minoranza, presentò le dimissioni e, pochi giorni
dopo, il re chiamò a formare un nuovo governo Agostino Depretis (sarebbe rimasto capo del governo, salvo brevi
interruzioni, fino al 1887) che costituì un ministero formato interamente da uomini della Sinistra. Nel novembre dello stesso
anno si tennero le elezioni politiche, cui la Sinistra (che poi le vinse) si presentò col seguente programma:
a) allargamento del suffragio elettorale;
b) riforma dell'istruzione scolastica elementare;
c) abolizione della tassa sul macinato e riforma del sistema fiscale.
Nel momento in cui arrivò al potere, la Sinistra parlamentare aveva fortemente attenuato la sua originaria
connotazione radical-democratica e si era allargata fino ad accogliere nel suo seno componenti moderate o addirittura
conservatrici. Ciò determinò una limitata e contraddittoria realizzazione delle promesse elettorali e della politica riformatrice.
Ciononostante, la nuova classe dirigente riuscì ad esprimere in qualche modo il desiderio di democratizzazione della vita
politica e di allargamento delle basi dello stato diffuso in larga parte della società; rappresentava inoltre gli interessi degli
industriali che, consapevoli della debolezza dell'apparato produttivo, chiedevano una politica protezionistica verso l'esterno e
una politica riformatrice che migliorasse le condizioni economiche dei lavoratori e favorisse lo sviluppo del mercato interno
(in sintonia con quanto stava accadendo in quegli anni in Europa).
Per consolidare la sua maggioranza e dare stabilità ai suoi governi, Depretis introdusse una nuova prassi politica che
prese il nome di trasformismo: la maggioranza non era più definita sulla base di precise discriminanti programmatiche o di
chiare distinzioni ideologiche, ma attraverso compromessi e patteggiamenti con esponenti dell'opposizione; ciò determinava
il degrado della vita politica italiana, contaminata da corruzione, deviazioni clientelari e personalistiche.
In politica estera, la Sinistra realizzò un completo cambiamento di rotta, allontanando l'Italia dalla Francia e
avvicinandosi ad Austria e Germania, con cui nel 1882 venne firmata la Triplice Alleanza, un patto militare di natura
difensiva, che impegnava i contraenti a intervenire militarmente se uno degli alleati fosse stato aggredito da altre potenze.
All'origine di questa svolta, ci furono alcune ragioni:
1) l'alleanza con gli imperi conservatori del Centro Europa sembrava la più adatta a conferire solidità alle istituzioni
del giovane stato;
2) pesava il desiderio di uscire da una situazione di isolamento internazionale, che si era fatta sentire in modo
particolare l'anno prima, quando la Francia aveva occupato la Tunisia, considerata dagli italiani il proprio naturale
sbocco coloniale;
3) si pensava di risolvere la questione delle regioni venete ancora occupate dall'Austria, affidandosi ancora una volta
alla vecchia strategia diplomatica (già proposta negli anni quaranta da C. Balbo) basata sui possibili sviluppi politici
nell'Europa balcanica: l’espansione in quella zona dell’Europa avrebbe potuto spingere l’Austria ad accettare, per
compensazione, una trattativa diplomatica per il passaggio di Trento e Trieste all’Italia.
La politica economica della sinistra fu caratterizzata dai seguenti passi:
a) primi dazi doganali a protezione dei prodotti industriali nei primi anni di governo;
b) aumento della spesa pubblica a sostegno delle industrie del settore metal-meccanico e siderurgico e sotto la spinta dei
gruppi affaristici che sostenevano la maggioranza; ciò provocò la ricomparsa di un crescente deficit nel bilancio statale;
c) nel 1887 avvio della vera e propria politica protezionistica, in seguito alla crisi agraria della fine degli anni settanta, che in
Italia si fece sentire pesantemente durante gli anni ottanta e che indusse anche gli agrari a chiedere il protezionismo
doganale; le nuove tariffe proteggevano soprattutto cereali e prodotti dell'industria tessile siderurgica e alimentare; nasceva
così un nuovo blocco di potere economico, fondato sull'alleanza fra l'industria protetta e i grandi proprietari terrieri e
sull'intreccio, non sempre limpido, fra i maggiori gruppi di interesse e i poteri statali. Gli effetti della politica protezionistica
furono comunque variegati: i complessi industriali del Nord ebbero modo di consolidarsi e di fruire di ampi margini di
guadagno; l’agricoltura meridionale, invece, finì per deprimersi ulteriormente, perché agli effetti negativi di una brusca
riduzione delle esportazioni si aggiunse l’atteggiamento dei proprietari terrieri locali, i quali, sentendosi incoraggiati dal
protezionismo a proseguire nel loro tradizionale disinteresse verso la terra, continuarono a sfruttarla su larga scala con metodi
e tecniche rudimentali; il pesante aumento delle tariffe doganali determinò, inevitabilmente, difficoltà notevoli nei rapporti
commerciali, specialmente con la Francia, con la quale si verificò la cosiddetta guerra delle tariffe (che finì per colpire,
soprattutto, le nostre esportazioni di prodotti specializzati, come il vino).
Nel 1887 morì Depretis e gli successe Francesco Crispi, ex-mazziniano ed ex-garibaldino, divenuto col passare
degli anni sempre più conservatore e ammiratore della politica di forza di Bismarck.
Da presidente del consiglio, Crispi adottò un indirizzo politico teso ad affermare il prestigio e la forza della nazione.
In politica interna, ciò si tradusse in scelte autoritarie e accentratrici, che lo portarono (nonostante una contemporanea opera
riformatrice e razionalizzatrice in campo amministrativo) a governare spesso senza e contro il parlamento e a reprimere ogni
movimento popolare che minacciasse l'equilibrio sociale esistente. Ciò fu particolarmente evidente nel biennio 1893-94
quando, dopo essere tornato al governo (era stato costretto alle dimissioni nel 1891 perché la camera non aveva approvato la
sua politica coloniale, troppo onerosa per le finanze statali) in sostituzione di Giovanni Giolitti, coinvolto indirettamente
nello scandalo della Banca romana (il primo grave scandalo politico-finanziario dell'Italia unita), Crispi si impegnò nella
repressione dei fasci siciliani, un movimento di protesta dei contadini siciliani che chiedevano migliori condizioni di vita e di
lavoro, e delle agitazioni anarchiche in Lunigiana. In questa occasione, Crispi mise fuori legge anche il Partito socialista
appena nato, ma questo riuscì comunque a resistere all'ondata repressiva.
In politica estera, l'affermazione nazionalistica si tradusse in senso espansionistico ed aggressivo con una
accentuazione della politica coloniale già avviata da Depretis alla fine degli anni ottanta (politica che aveva in seguito – nel
1890 – portato alla costituzione della Colonia Eritrea), ma il tentativo di occupare l'Etiopia (o Abissinia) si concluse con la
grave sconfitta di Adua (1 marzo 1896), che fermò le ambizioni coloniali italiane e causò l'uscita definitiva dalla scena
politica dello stesso Crispi.
Negli anni della sinistra, il movimento operaio italiano pervenne ad una più precisa definizione dei suoi obiettivi e
delle strutture organizzative: dall'egemonia mazziniana sulle società di mutuo soccorso negli anni cinquanta e sessanta,
attraverso l'influenza anarchica negli anni settanta, fino alla formazione del partito socialista - costituitosi nell'agosto del
1892 al congresso di Genova - che aggregò attorno a sé i vecchi organismi associativi operai e bracciantili. Fondatore del PSI
fu un intellettuale milanese, Filippo Turati, il cui pensiero politico era caratterizzato dai seguenti principi:
a) affermazione dell'autonomia del movimento operaio dalla democrazia borghese;
b) rifiuto della politica insurrezionale anarchica;
c) riconoscimento del carattere prioritario delle lotte economiche;
d) esigenza di collegare queste lotte con quelle politiche e di inquadrarle in un progetto generale che aveva come
obiettivo finale la socializzazione dei mezzi di produzione.
Nel dicembre del 1896, venne poi fondato l’Avanti!, organo ufficiale del Partito socialista: fu l’unico quotidiano in
grado di competere anche sul piano tecnico e grafico con la grande stampa borghese e, quindi, contribuì in modo
determinante a inserire le masse proletarie nella vita pubblica, rendendole così attive protagoniste di un sistema di vita
democratico.
Tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta nacquero anche le prime federazioni di mestiere e le prime
Camere del lavoro. La maturazione sindacale e politica del movimento operaio e contadino era il risultato dello sviluppo
della società capitalistica, sia nelle campagne come nella produzione industriale (si formava e cresceva numericamente il
proletariato), e della penetrazione in Italia delle idee socialiste (prima l'anarchia, poi il marxismo, diffuso inizialmente
soprattutto per opera del filosofo Antonio Labriola), che consentì ai lavoratori di dotarsi di strumenti teorici adeguati e
finalizzati all'azione di rivendicazione sociale e politica.
Contemporaneamente anche il mondo cattolico era in fermento: accanto al rifiuto tradizionale della società
industriale, alla duplice condanna lanciata da Roma nei confronti dell'individualismo borghese e delle ideologie socialiste, vi
fu anche il tentativo, in parte riuscito, di rilanciare la missione della Chiesa, adeguandone le forme alle mutate condizioni
storiche. Il documento più emblematico dello sforzo compiuto dalla Chiesa per riqualificare il proprio ruolo in materia di
questione sociale fu l'enciclica Rerum novarum, emanata da Leone XIII nel maggio 1891: negata la lotta di classe e
accettata la proprietà privata (considerata dalla Chiesa come l’unico vero sostegno per il libero sviluppo della personalità
umana), il papa invitava ad una più equa distribuzione della ricchezza e ad un minor sfruttamento dei lavoratori (la Chiesa
prendeva, quindi, posizione contro la logica del puro profitto sottratto a qualsiasi obbligo morale), i quali dovevano
comunque rispettare le gerarchie ed essere laboriosi e frugali. In sostanza, il documento pontificio affermava la necessità
della collaborazione tra capitale e lavoro. Su questi principi si formò un movimento sociale cattolico, attraverso cooperative,
leghe cattoliche, sindacati dei lavoratori dipendenti. Politicamente, i cattolici iniziarono a dividersi tra una posizione
conservatrice avversa, appunto, al mondo moderno e una posizione progressista, che intendeva conciliare la dottrina cattolica
con l'impegno sociale e con gli istituti della democrazia. Questo processo fu favorito dal progressivo attenuarsi della
proibizione della Chiesa verso la partecipazione alla vita politica, almeno sul piano delle rappresentanze amministrative.
Gli ultimi anni del secolo scorso furono caratterizzati da una grave crisi. Dopo la caduta di Crispi nel 1896, la
situazione sociale interna si presentava in modo drammatico: carovita e inasprimento della pressione fiscale scatenarono
scioperi e manifestazioni di protesta, cui il governo rispose con la repressione; il fatto più grave si verificò a Milano nella
primavera del 1898, quando il generale Bava Beccaris fece sparare sulla folla di scioperanti disarmati con i cannoni,
lasciando sul terreno decine di morti e centinaia di feriti. I tentativi "liberticidi" del nuovo governo, presieduto dal generale
Luigi Pelloux (limitazione delle libertà di stampa, di associazione, di sciopero e rafforzamento dei poteri dell'esecutivo)
vennero però sconfitti nelle elezioni del 1900, che segnarono l'avanzata delle opposizioni (radicali, socialisti, repubblicani).
Nello scontro tra forze conservatrici-reazionarie e forze borghesi liberali alleate con l'opposizione socialista e repubblicana,
la vittoria fu di queste ultime, anche perché nel frattempo era cambiata la congiuntura economica e si era usciti dalla fase di
depressione. La svolta politica venne sancita quando il nuovo re Vittorio Emanuele III (succeduto a Umberto I, ucciso il 29
luglio 1900 dall'anarchico Gaetano Bresci, che intendeva così vendicare i morti di Milano del 1898) nominò - all'inizio del
1901 - come primo ministro Giuseppe Zanardelli, anziano esponente della borghesia liberale.