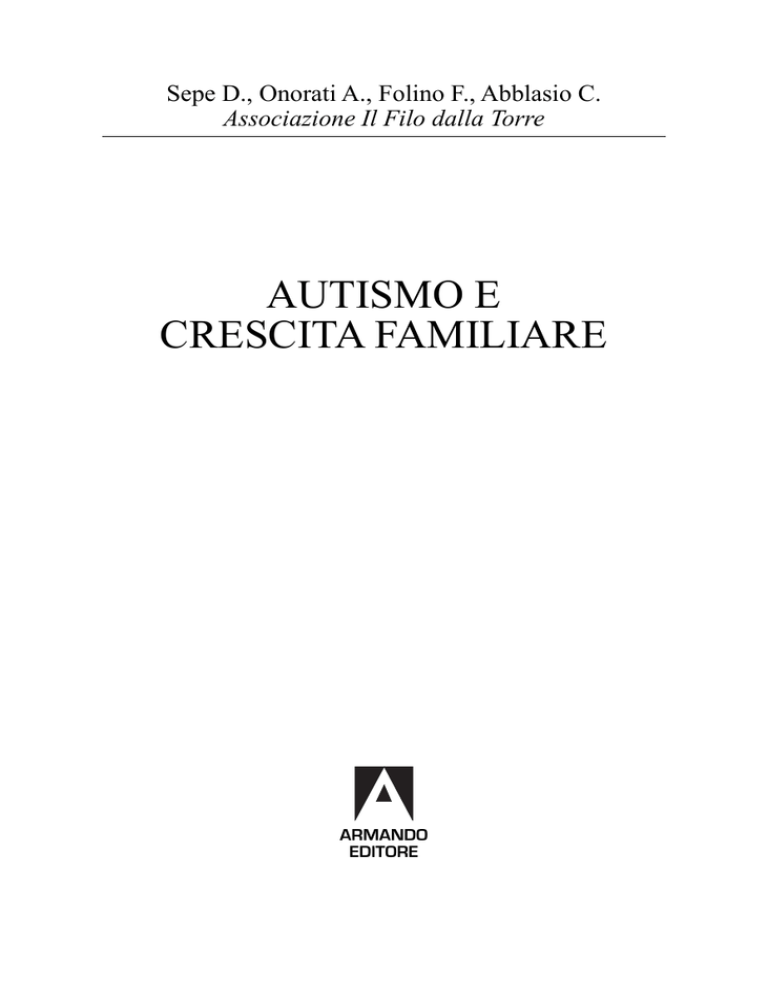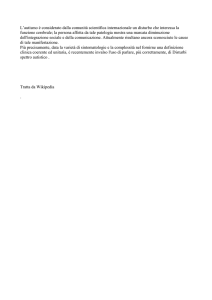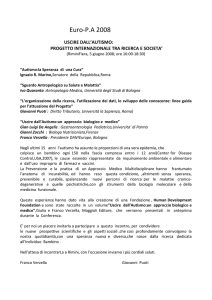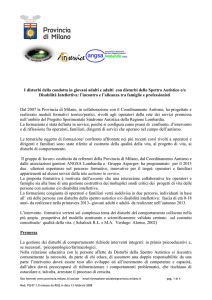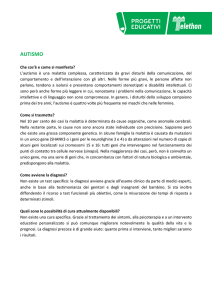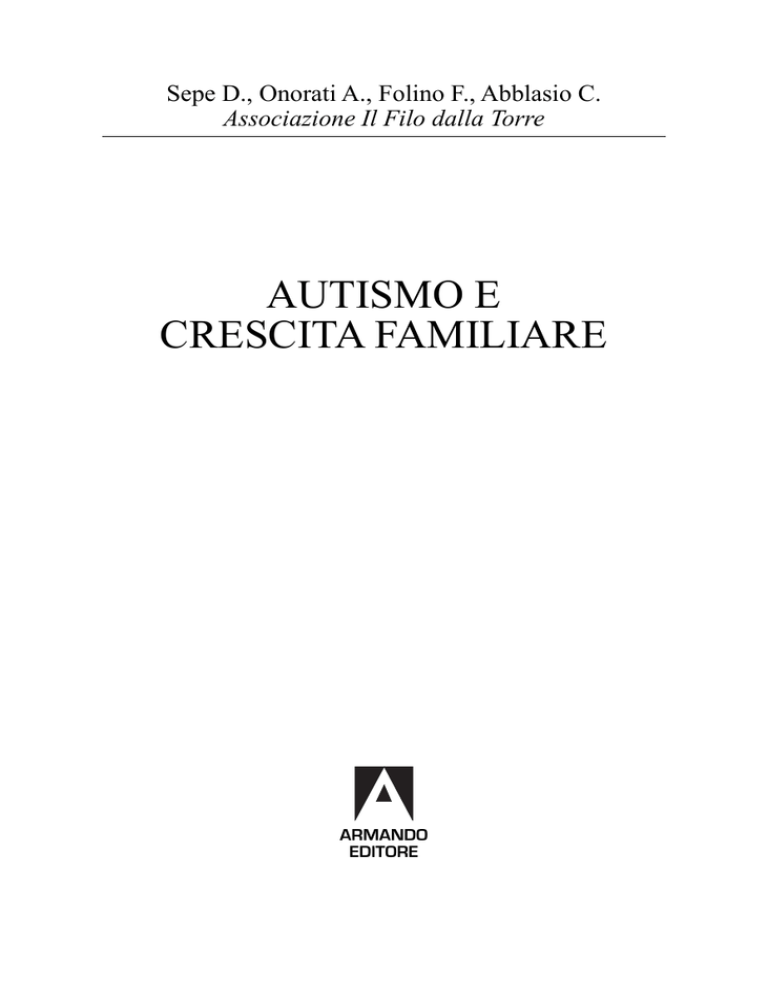
Sepe D., Onorati A., Folino F., Abblasio C.
Associazione Il Filo dalla Torre
AUTISMO E
CRESCITA FAMILIARE
ARMANDO
EDITORE
ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE
SEPE, Dario - ONORATI, Adriana - FOLINO, Fortunata - ABBLASIO, Corinna
Autismo e crescita familiare ;
Roma : Armando, © 2014
160 p. ; 21 cm. (Medico-psico-pedagogica)
ISBN: 978-88-6677-594-2
1. Approccio PEIAD
2. Autismo e disabilità
3. Famiglie con figlio autistico
CDD 300
© 2014 Armando Armando s.r.l.
Viale Trastevere, 236 - 00153 Roma
Direzione - Ufficio Stampa 06/5894525
Direzione editoriale e Redazione 06/5817245
Amministrazione - Ufficio Abbonamenti 06/5806420
Fax 06/5818564
Internet: http://www.armando.it
E-Mail: [email protected] ; [email protected]
03-00-312
I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), in lingua italiana, sono riservati
per tutti i Paesi.
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15%
di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso
previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall’accordo
stipulato tra SIAE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.
Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero
di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02
809506, e-mail [email protected]
Sommario
Capitolo 1: Famiglia, autismo e disabilità: una visione storica
1.1 Il genitore colpevolizzato: la “madre frigorifero” e
i modelli psicoanalitici
1.2 La “famiglia disabile”: dall’orientamento
“patologizzante” allo studio dei sistemi familiari
1.3 Il passaggio dal genitore colpevolizzato al genitore
esperto: la coppia genitoriale come “corresponsabile”
della terapia
1.4 Il modello di Psicologia della Salute: dal limite
alla risorsa
Capitolo 2: La nascita di un figlio autistico:
il percorso evolutivo della famiglia
2.1 I momenti critici
2.2 Il processo di elaborazione del lutto
2.3 L’idealizzazione degli altri figli
2.4 I principali fattori di stress per la famiglia
2.5 Il processo di crisi, l’adattamento e le risorse facilitanti
2.5.1 L’attribuzione di significato agli eventi e
la comprensione del problema
2.6 Il sostegno sociale
2.6.1 Il significato e la funzione del supporto sociale
2.6.2 Il supporto sociale nelle famiglie con un figlio
autistico
7
7
12
18
19
27
27
29
32
34
37
41
46
46
50
Capitolo 3: La visione teorica del PEIAD
3.1 Il percorso di consapevolezza delle famiglie
3.2 L’autismo come opportunità di crescita per la famiglia
3.2.1 L’ascolto emotivo
3.2.2 L’armonizzazione dei sistemi
55
55
58
61
63
Capitolo 4: Il lavoro con la famiglia nell’approccio PEIAD
4.1 Il processo di Valutazione Familiare
4.2 Le Consulenze Familiari
4.2.1 Monitoraggio e lavoro di crescita nelle relazioni
4.2.2 Obiettivi a lungo termine ed impegno operativo
4.3 Il Gruppo di Crescita Familiare
69
69
76
78
82
83
Capitolo 5: Indagine esplorativa sulla qualità della vita
di famiglie con un figlio autistico
5.1 Introduzione
5.2 Metodologia e campione
5.3 I risultati della ricerca
5.3.1 Le interviste ai genitori
87
87
87
92
111
Bibliografia
141
Nota sugli Autori
157
Capitolo 1
Famiglia, autismo e disabilità: una visione storica
1.1 Il genitore colpevolizzato: la “madre frigorifero” e
i modelli psicoanalitici
Nel momento in cui Kanner definisce l’autismo, nel 1943, iniziano a nascere ipotesi etiologiche, prettamente di natura psicologica,
relative a questo disturbo: diversi studi evidenziano il ruolo delle relazioni precoci tra il bambino e le figure di riferimento, con particolare attenzione alla madre, come causa determinante dell’insorgenza
dell’autismo.
Già Kanner, dopo che Sullivan, nel 1931, sottolinea la natura
interpersonale dei processi schizofrenici, descrive un determinato “profilo psicologico”, che sembra caratterizzare i genitori dei
bambini con autismo. Fromm-Reichmann (1959) conia il termine
di “madre schizofrenogena”, attribuendo, con questa etichetta, alle
madri di bambini autistici, caratteristiche quali: aggressività, intrusività e dominanza eccessive, oltre che un profondo sentimento di
insicurezza.
Szurek (1956a) utilizza il termine “madre frigorifero” e i vari autori forniscono un’attenzione sempre maggiore alle caratteristiche
e agli atteggiamenti parentali, oltre che alle dinamiche di interazione familiare, che vengono ipotizzate da molti, come fattori fondamentali e primari delle schizofrenie in generale e dell’autismo in
particolare. Si arriva a ritenere la sindrome autistica come diretta
conseguenza dei dinamismi familiari, che scaricano sul bambino i
7
propri potenziali patogeni e lo trasformano nell’oggetto privilegiato
di spostamento delle fantasie e aspirazioni dei membri della famiglia
(Foglio Bonda, 1987). Il bambino, non essendo in grado né di soddisfare né di allontanare da sé questi contenuti, ne subisce il peso, fino
al punto da causare, in lui, profondi vissuti di inadeguatezza, incapacità, fallimento, paura dell’abbandono, tali da produrre condotte di
rifiuto, estraneità, isolamento (Ibidem).
Dunque, a partire dalle affermazioni di Kanner (1943), che riscontra nei genitori di bambini autistici da lui studiati un atteggiamento di “freddezza”, si sviluppa un’estesa letteratura sul tema del
“genitore frigidaire” (Szurek, 1956b), caratterizzato da indifferenza,
distacco, insensibilità, serietà, rigidità, austerità, incapacità di comunicare in maniera aperta e sincera, di sorridere e giocare con il
proprio bambino (Foglio Bonda, 1987). Secondo l’autore, questi
genitori, a causa delle proprie caratteristiche personali, non sono in
grado di rapportarsi alla realtà del figlio, il quale viene, inconsapevolmente, utilizzato come bersaglio sul quale proiettare i propri
conflitti, bisogni, desideri (Ibidem).
Bettelheim è tra gli autori che maggiormente attribuiscono
all’inadeguata interazione precoce madre-bambino un valore etiologico primario per la determinazione dell’autismo infantile. Nella sua
opera La Fortezza Vuota (1967), Bettelheim afferma:
Credo che la causa iniziale del ritiro autistico sia l’interpretazione corretta da parte del bambino dell’attitudine negativa, con la
quale gli si accostano le figure più significative del suo ambiente
(Bettelheim, 1967, p. 47, tr. it.).
Bowen (1960) identifica, fra i genitori di bambini con autismo,
una situazione di conflitto, che sistematicamente viene riversata sul
figlio, il quale, ancora dipendente e immaturo, è utilizzato dal genitore più debole per affermare la propria autostima. Nella misura
in cui il bambino percepisce che le proprie carenze e i propri limiti
sono funzionali ad un miglior adattamento dei genitori, può inconsapevolmente decidere di continuare a comportarsi in modo funziona8
le alle loro esigenze, limitando il proprio sviluppo, la propria affermazione ed autonomia.
Altri studiosi, osservando l’autismo da una prospettiva behaviorista, identificano, tra i fattori etiologici primari della sindrome, una
situazione di stimolazione gravemente inadeguata che, da un lato,
non sostiene l’esplorazione, le attività di autonomia, la capacità di
critica e l’indipendenza del bambino, e dall’altro, favorisce la messa
in atto di comportamenti remissivi, passivi, rinunciatari e difensivi
(Foglio Bonda, 1987).
Ferster (1961) e Leff (1968) affermano che i deficit comportamentali che caratterizzano il bambino con autismo sono conseguenti
all’incapacità dei genitori di rinforzare, adeguatamente, le risposte
di socializzazione e le altre condotte del bambino. Questa situazione
impedisce al bambino di sostituire i rinforzatori biologici primitivi come l’alimento, gli abbracci, le carezze, ecc., con rinforzatori
sociali condizionati, che sono fondamentali per l’acquisizione e lo
sviluppo di molte condotte apprese.
La teoria del “doppio legame” proposta dal gruppo di ricerca di Palo Alto (Bateson et al., 1956 e 1953; Watzlawick, Beavin
e Jackson, 1967) per descrivere i modelli relazionali presenti nelle
famiglie dei soggetti schizofrenici viene ripresa ed applicata ai casi
di bambini con autismo. Il “doppio legame” (double bind) è una
modalità di comunicazione imposta da un componente familiare,
come ad esempio la madre, a cui l’altro non può opporsi. Colui che
parla, comunica con un doppio messaggio contraddittorio nel suo
contenuto, ma espresso a diversi livelli: ad esempio, un messaggio
verbale associato ad un messaggio analogico (mimica, tono della
voce, ecc.) di significato opposto, per cui uno nega necessariamente
l’altro. Il bambino si trova, allora, in una situazione difficile, dalla
quale non può liberarsi, per l’importanza vitale del mantenimento
del rapporto, ma, allo stesso tempo, nell’impossibilità di dare una
risposta adeguata, a causa dell’incongruenza dei messaggi. Marcelli
(1999) afferma che la risposta “folle” non è che il tentativo disperato
di soddisfare questo doppio legame.
Il grande successo raggiunto, negli anni ’40-’50, dalle ipotesi
9
psicosociali e ambientali relative all’etiologia dell’autismo è dovuto, secondo Eisenberg (1971), almeno in parte, al fatto che, in quel
periodo storico, esiste nell’ambito psicologico e psichiatrico una
spiccata tendenza a privilegiare le ipotesi psicosociali, per spiegare
l’origine di quasi tutti i disturbi comportamentali.
Ad oggi, gli studiosi ritengono che lo stato attuale di conoscenze non consenta più di considerare seriamente l’ipotesi secondo cui
fattori di questo tipo possono essere la causa primaria dell’autismo.
Inoltre, ci si è resi progressivamente conto che le teorie relative ai
dinamismi etiologici interazionali dell’autismo infantile sono condizionate da notevoli carenze metodologiche. Una delle principali critiche, avanzate nei confronti di tale ipotesi, riguarda la constatazione
che a suo sostegno sono sempre utilizzate osservazioni ed analisi di
interazioni familiari, realizzate dopo la manifestazione del disturbo
nel bambino. Da ciò deriva l’impossibilità di essere certi che quanto
viene osservato, in queste indagini, costituisca una causa o una conseguenza della patologia autistica o, persino, della “perturbazione
emotiva iatrogena”, causata nei genitori dalla responsabilizzazione
(e anche “colpevolizzazione”) che si sentono addossare da alcuni
operatori (Shopler, 1971).
Le altre critiche, che vengono mosse nei confronti dell’ipotesi interazionale dell’autismo, riguardano la difficoltà di comprendere in
che modo anomalie di condotte parentali possano causare tanto precocemente e in maniera così decisa danni talmente gravi e pervasivi
nello sviluppo di alcuni soggetti; considerando anche che, spesso, si
tratta di anomalie relativamente poco gravi e, di frequente, presenti
anche in genitori che non hanno figli con autismo. Viene dunque
ipotizzato che le condotte parentali “devianti”, se presenti, siano più
che la causa dell’autismo, una risposta alle anomalie comportamentali del figlio: poiché i bambini presentano disturbi nell’interazione,
spesso anche nelle fasi precocissime dello sviluppo, i genitori possono percepire l’atteggiamento del figlio, quasi come un rifiuto nei
loro confronti.
La mancanza di contatto oculare, l’assenza di comportamenti anticipatori, il dialogo tonico alterato, l’indifferenza alla voce o ai ri10
chiami, ecc. sono tutte condotte che creano frustrazione nella madre,
non offrendole nessuna delle gratificazioni attese dalla maternità. Il
non riuscire a creare un rapporto con il bambino può impedire alla
madre di rinunciare al figlio “fantasticato”. A tutto questo possono
aggiungersi i sensi di colpa presenti e, a volte, rinforzati dalle affermazioni del medico, dello psicologo o degli operatori. Tenendo in
considerazione questo quadro, è semplice comprendere la ragione di
molti comportamenti inadeguati dei genitori.
Le teorie che sostengono il ruolo patogeno primario della famiglia nei confronti dello sviluppo della sindrome autistica nel bambino hanno forti ripercussioni nelle pratiche terapeutiche adottate.
Infatti, nei suoi primi contributi, Bettelheim sostiene la necessità di
allontanare, completamente, il bambino autistico dall’ambiente familiare, per collocarlo in un ambito “totalmente terapeutico”, che
favorisca la sua crescita, annullando i condizionamenti deleteri provenienti dalla famiglia. La famiglia viene, dunque, totalmente esclusa dalla vita e dalla terapia del bambino.
A partire dagli anni ’60, s’inizia a comprendere come le variabili
in gioco nell’insorgenza del disturbo siano numerose e che l’efficacia del trattamento è direttamente correlata con il grado e la qualità
del coinvolgimento dei genitori (Foglio Bonda, 1987).
I genitori, inizialmente accusati di essere la causa del problema,
oggi sono valutati fattori indispensabili per assicurare l’efficacia di
qualsiasi trattamento (Ekstein, 1980).
E questo perché:
• viene riconosciuta l’importanza che hanno nel determinare il
cambiamento, i rinforzi, i modelli di comunicazione e di interazione presenti all’interno del sistema familiare;
• si rileva come risultino più efficaci e duraturi gli apprendimenti che il bambino acquisisce nel suo ambiente familiare e
sociale “naturale”, rispetto a quelli che avvengono nell’ambito
“artificiale” della terapia;
• i genitori possono sostenere lo sviluppo di determinate capacità del bambino, nei momenti precisi in cui la loro attuazione
è necessaria o utile per soddisfare reali bisogni o esigenze del
11
soggetto, molto più di quanto non sia possibile agli altri operatori;
• in generale, se i genitori hanno ricevuto un adeguato sostegno
nell’elaborare i propri conflitti, paure, sensi di colpa, sono più
motivati nell’insistere e perseverare, con pazienza, nell’attuazione dei programmi di recupero riguardanti il figlio, di quanto non lo siano, di per sé, gli altri operatori.
Inoltre, progressivamente è emersa la consapevolezza che, oltre
alla partecipazione attiva dei genitori, sull’intervento incidono anche gli atteggiamenti e i comportamenti che i fratelli, i nonni, gli altri
familiari, gli insegnanti e i compagni, sviluppano nei confronti del
bambino con autismo. Il programma terapeutico dovrà allora prevedere momenti di analisi e pianificazione delle forme più opportune,
attraverso le quali promuovere in tutte queste persone un’adeguata
comprensione del problema e dei comportamenti più utili, per favorire lo sviluppo delle abilità presenti nel bambino.
Secondo Foglio Bonda (1987):
Sono tre i presupposti essenziali che rendono concretamente possibile ed efficace l’azione terapeutica dei genitori: la loro reale
disponibilità; il loro sviluppo personale e come coppia; e la loro
formazione teorica e operativa specificamente riferita al tema
dell’autismo (Foglio Bonda, 1987, p. 138).
1.2 La “famiglia disabile”: dall’orientamento “patologizzante”
allo studio dei sistemi familiari
Con lo sviluppo delle teorie che ipotizzano un’origine multifattoriale della sindrome, con particolare attenzione alle cause biologiche, lo studio delle famiglie di bambini autistici, si è andato ad
inserire in un filone di ricerca più ampio, inerente l’analisi dei nuclei familiari, caratterizzati dalla presenza di un membro disabile in
generale. L’ottica si è dunque spostata dall’analisi delle relazioni e
delle disfunzioni presenti nel sistema familiare, intese come cause
12
della reazione autistica, allo studio delle stesse interazioni ed eventuali disfunzioni, considerate come reazioni dei familiari al disturbo
del bambino.
L’interesse scientifico per le dinamiche delle famiglie in cui
è presente un figlio disabile è relativamente recente e circoscritto agli ultimi cinquant’anni. Risalgono, infatti, alla fine degli anni
Cinquanta le prime opere scientificamente valide, che affrontano
l’argomento della famiglia, in relazione alla disabilità (Dall’Aglio,
1994).
Il primo approccio allo studio delle famiglie dei bambini con disabilità si può considerare “patologico”: esso può essere sintetizzato
nella frase “l’handicap di un figlio rappresenta l’handicap della famiglia”, ipotesi secondo la quale un bambino con disabilità costituisce un fattore di stress ineliminabile, che incide negativamente sul
benessere generale e sul funzionamento della famiglia.
Secondo questi studi, la disabilità rappresenta una variabile, il cui
peso non può essere modificato e dalla quale la famiglia risulta appesantita e penalizzata. La variabilità, nel danno alle famiglie, è considerata scarsa, perché i fattori omogenei sono considerati prevalenti
rispetto alle possibili diversità. Prevale il concetto della uniformità
delle famiglie con soggetti disabili, in base al quale viene data scarsa
importanza alla variabilità delle patologie menomanti, alle diversità
delle strutture familiari e alle stesse modificazioni che, di certo, si
verificano con lo scorrere del tempo, in ogni sistema. Al contrario,
considerare tale variabilità è di fondamentale importanza perché
consente di non compiere eccessive generalizzazioni e astrazioni e
di modulare una conoscenza in termini di più specifica aderenza ai
casi concreti (Dall’Aglio, 1994).
Bernard Farber è uno dei primi e più significativi studiosi nell’avvio di uno studio sistematico sulle famiglie in cui è presente un soggetto disabile.
Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, Farber
pubblica tre monografie (Farber, 1959; 1960; Farber e Jennè, 1963),
prodotto di un ampio lavoro di ricerca in cui l’autore si pone i seguenti obiettivi:
13
• identificare le condizioni che influenzano gli effetti di un bambino “gravemente ritardato” sull’integrazione familiare;
• analizzare quali sequenze di azioni e di strategie consentono
di mantenere nel tempo l’integrità familiare;
• studiare gli effetti della presenza del bambino disabile e degli
stili comunicativi dei genitori sulla crescita dei fratelli.
Secondo quest’autore, la nascita di un bambino con disabilità induce un blocco nel normale processo evolutivo della famiglia; tale
arresto può minare l’integrazione coniugale tra i genitori, intesa
come uniformità degli obiettivi e del sistema dei valori domestici,
condivisione dei significati e dei ruoli parentali (Zanobini, Manetti
e Usai, 2002).
Oggi, il presupposto su cui si basano tali studi, i problemi metodologici presenti nel modello di ricerca utilizzato, oltre che la presenza di una certa tendenza a leggere i dati facendosi influenzare dal
pregiudizio che la disabilità porti nelle famiglie sempre e comunque
uno stato di sofferenza, fanno apparire questi studi come superati e
inattuali, nonostante permanga il loro valore come spunto di tante
ricerche successive (Zanobini, Manetti e Usai, 2002).
Esiste, poi, un filone di studi che offre una lettura psicodinamica
della relazione che si instaura fra il bambino disabile e la sua famiglia (con particolare riferimento alla diade madre-bambino) ed
esplora le radici stesse del deficit, attraverso la lettura del significato
che la debolezza mentale assume per i genitori stessi.
Maud Mannoni nel 1964, con il suo libro L’enfant arriéré et sa
merè, inaugura questo nuovo approccio allo studio del soggetto disabile e della sua famiglia. L’obiettivo, da cui muove il lavoro di
questa autrice, è quello di offrire uno spazio ai risvolti psicologici
dell’insufficienza mentale, opponendosi alla tendenza di offrire solo
una visione medica del problema, che spinge ad identificare la persona con il deficit, e in base alla quale l’accanimento diagnostico e
terapeutico di medici e genitori non lascia spazio ad uno sviluppo
autonomo dell’individuo.
Maud Mannoni desidera ascoltare il soggetto, per cogliere, attraverso il discorso suo e dei suoi genitori, il significato che per l’uno
14
o per gli altri ha assunto la debolezza mentale (Mannoni, 1964, pp.
151, tr. it.).
Il merito di tale posizione è quello di aver contribuito ad una
relativizzazione del concetto di ritardo mentale, inserendosi in quel
filone di ricerca, che porta progressivamente alla consapevolezza
della necessità di una integrazione fra la valutazione del quoziente
intellettivo e informazioni relative al livello di comportamento adattivo del soggetto in relazione alle richieste ambientali (American
Psychiatric Association, 1995; Ferri e Orsini, 2000).
Tuttavia, gli studi della Mannoni offrono un’immagine della famiglia con disabilità come necessariamente patologica e conducono
ad una lettura univoca dei percorsi familiari, dove la madre è portata
a costruire con il figlio una relazione anomala, dovuta alla ferita narcisistica, causata dalla nascita di un bambino con disabilità. Secondo
l’autrice, da un lato, l’angoscia e la depressione sono i vissuti emotivi che caratterizzano sempre le madri, e dall’altro il modo in cui
le madri, solo apparentemente, colmano il vuoto rappresentato dalla
nascita di un figlio disabile condiziona pesantemente il destino dei
figli, per i quali diventa difficile riuscire a parlare di sé (Zanobini,
Manetti e Usai, 2002).
Esiste, inoltre, un certo numero di lavori, che, a partire da studi
sulle caratteristiche delle famiglie in cui è presente un figlio con disabilità, fornisce interpretazioni dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle risposte dei genitori, utilizzando concetti formulati in
ambito psicanalitico, quali quelli di diniego, rifiuto, iperprotezione,
ecc. (Ibidem).
Il punto di partenza di questo approccio è l’assunto che la nascita di un bambino disabile causi nei genitori ansie, preoccupazione
e sensi di colpa, che normalmente non si riscontrano quando il
bambino è normale. Di fronte alla caduta di autostima, indotta da
tale evento, e alla minaccia della propria identità sociale e personale, i genitori metterebbero in atto meccanismi di difesa che li
porterebbero a negare l’evento stesso, rifiutando la diagnosi; o, al
contrario, in alcuni casi, il rifiuto del bambino potrebbe essere mascherato da un coinvolgimento totale della famiglia nel problema
15
o da atteggiamenti di iperprotezione, che tra l’altro impedirebbero al bambino lo sviluppo di una propria identità personale (Crnic,
Friedrich e Greenberg, 1983).
Questo orientamento porta con sé i limiti dovuti ad una indebita
generalizzazione effettuata su alcuni casi e all’applicazione di una
griglia interpretativa rigida, che non necessariamente è quella corretta.
Inoltre, il postulato di una basilare mancanza di accettazione da
parte dei genitori porta molti operatori, ancora oggi, ad avere un
atteggiamento colpevolizzante nei confronti delle famiglie: tutto ciò
che dicono o fanno i genitori rischia di essere interpretato o come negazione del problema o come rifiuto del figlio ed eccessiva volontà
di normalizzazione, in una logica dove l’ipotesi della non accettazione rappresenta sempre il filtro interpretativo di qualunque comportamento genitoriale (Zanobini, Manetti e Usai, 2002).
Il percorso attraversato dai genitori, che da diversi studiosi è stato
considerato come l’espressione di un processo di elaborazione del
lutto, viene descritto da Zanobini, Manetti e Usai (2002) come il
tempo necessario per mettere in funzione le proprie risorse emotive,
cognitive e organizzative. In quest’ottica, anche la prevalenza, in
determinati momenti, di risposte ansiose o, all’opposto, la tendenza
a minimizzare i problemi può avere valenze positive: la prima può,
infatti, aiutare ad attivarsi nei momenti di scoraggiamento e di calo
di energia vitale; la seconda può consentire una graduale assunzione
di informazioni e moderare l’effetto traumatico di una notizia carica
di valenze negative (Ibidem). Ragionare esclusivamente in termini
di accettazione o rifiuto significa offrire una lettura univoca e semplicistica dei comportamenti familiari e non considerare la possibile coesistenza di sentimenti e parametri di valutazione contrastanti
(Zanobini, Manetti e Usai, 2002).
L’idea dell’impatto necessariamente negativo della disabilità sulla vita dei genitori e dell’intera famiglia, ha, quindi, finito con il
predominare l’intera letteratura sull’argomento.
Come sottolinea Dall’Aglio:
16
Per molti anni l’handicap, nel suo impatto psicologico sulla famiglia è stato visto per lo più, e soprattutto dagli autori di lingua
inglese, come uno stress, e gli atteggiamenti genitoriali sono stati
per lo più inquadrati come una reazione allo stress (Dall’Aglio
1994, p. 31).
Tale prospettiva si è sviluppata in un gran numero di lavori, che,
partendo da presupposti simili, hanno dato luogo, tuttavia, ad esiti
molto differenti, contribuendo, in parte, a modificare la visione della
famiglia al cui interno è presente un soggetto disabile. Per chiarire
qual è il percorso sviluppato da questi studi, si deve innanzi tutto
precisare che cosa si intende con il termine “stress”. Esso è utilizzato, nel linguaggio quotidiano, per designare una situazione di disagio, tensione e affaticamento. Anche nella pratica medica, lo stress
è identificato con una condizione di stanchezza dell’organismo. In
realtà, Farnè (1999) ritiene che lo stress possa essere rappresentato
come una medaglia a due facce, determinata dalla differenza esistente fra eustress e distress. Il primo è lo stress benefico: le ricerche
dimostrano, infatti, che un grado ottimale di stress migliora lo stato di salute e affina le capacità di attenzione, di concentrazione, di
apprendimento, di memoria e di risoluzione creativa dei problemi.
Lo stress, dunque, contenuto entro certi limiti, è estremamente utile.
L’altra faccia della medaglia è il distress, determinato da un continuo
accumularsi di stimoli stressori che porta ad un’attivazione fisiologica e psichica eccessiva, imponendo all’organismo sforzi esagerati;
ciò conduce dapprima ad un periodo di sopportazione-resistenza e,
più avanti, ad un periodo di esaurimento e logorio. Quando si entra
in questa fase compaiono ansia, tensione psichica e muscolare, disturbi funzionali e soggettivi (Farnè, 1999).
La letteratura sullo stress connesso all’evento disabilità, negli
anni ’80, considera il fenomeno soltanto in un’ottica negativa, fornendo una visione univoca e omogenea delle famiglie, che solo in
parte tiene conto della variabilità interfamiliare e dei fattori che la
influenzano, trascurando del tutto gli effetti positivi della disabilità
sulla famiglia (Ianes, 1992).
17