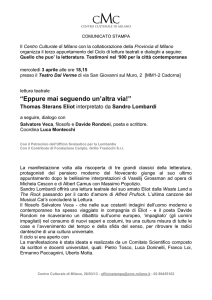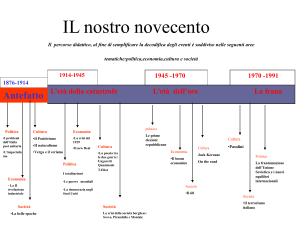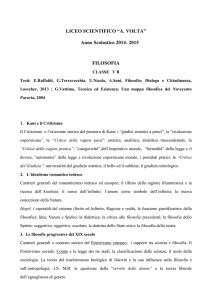RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XVII
NUOVA SERIE - N. 48 - GENNAIO-APRILE 2003
Manni
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
2
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Lecce, e dello stesso
Dipartimento.
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce),
Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno),
Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De
Leo, Lucia De Pascalis, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia,
Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 336627/8;
fax (0832) 3366626.
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto
I, 51 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/205577 - 0832/200373. Iscritto
al n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento
annuo: Italia t 25,00, Estero t 35,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero
Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da
gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo t 10,00, degli anni precedenti il doppio.
SOMMARIO
10
L. Bottani
LA BELLEZZA E IL TRAGICO IN SCHOPENHAUER
SAGGI
5
S. Vuskovic Rojo
ERNST BLOCH E LA SUA RIVENDICAZIONE DELL’UTOPIA
21
A. Caputo
PER UNA SEMIOTICA FENOMENOLOGICA DELLA PERCEZIONE
39
V. Nicolì
L’INFLUENZA DI DANTE NELL’OPERA DI ELIOT
60
DOSSIER: FILOSOFE DEL NOVECENTO
G. P. Di Nicola e A. Danese
IL FILO(SOFARE) DI ARIANNA NEL LABIRINTO POSTMODERNO
67
D. Iannotta
PENSIERO FEMMINILE E FILOSOFIA: TRA SFIDA E PROGETTO
76
G. Invitto
DAL LABIRINTO ALLA “STANZA TUTTA PER SÉ”.
PENSATRICI DEL NOVECENTO
86
A. Montano
RICORDO DI ANGELO PRONTERA
93
S. De Siena
ALTRE AURORE
99
Recensioni
125
Libri ricevuti
3
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o
Dipartimento di Filosofia – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola
facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà
superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche
su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa
comunicazione e approvazione dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
4
ERNST BLOCH
E LA SUA RIVENDICAZIONE DELL’UTOPIA
Nato da una famiglia ebrea agiata, Ernst impiegò un notevole sforzo per liberare le idee giovanili di Marx dalla liturgia ufficiale. La sua rivendicazione dell’utopia testimonia che, sopra ogni
cosa, la certezza di un futuro migliore, di una libertà matura, di un’uguaglianza più piena nel
mondo a venire, è il nuovo contenuto del nostro presente storico.
SAGGI
di Sergio Vuskovic Rojo
***
Pensieri e opere di un’epoca o di un uomo solitario si amplificano, nel dettaglio, in sentieri
interrotti, abbandonati a metà della loro marcia. Ma, una volta aperto il cammino, sono suscettibili di essere nuovamente percorsi da altri uomini, e in nuove condizioni, che rimangono meravigliati
vedendo che prima sono stati attraversati tangenzialmente da esseri umani precedenti.
***
Ogni epoca non solo sogna la successiva ma,
sognando, urge il risveglio.
Walter Benjamin
5
Quale forza spinge gli esseri umani, nel corso della loro storia, a postulare
un cambiamento verso il meglio? Che cosa li porta ad avere la speranza di
conseguire un plus di libertà, che si sviluppi nel tempo a venire?
Paradossalmente, per Ernst Bloch, profondo conoscitore di Marx, la radice
si può cominciare a indagare nella Sancta Spes, di teologica memoria e alla
quale arriva, su richiesta di sua moglie, Else von Stritzky, che gli serve da stimolo per acquisire anche una vasta cultura religiosa. La fusione conflittuale di
queste due tradizioni della filosofia tedesca determina, a partire da questo precoce momento, il destino particolare del suo genio.
La speranza non sussiste solo in quanto risposta al già dato o all’esistente, alla soddisfazione immediata delle necessità o delle inquietudini, o a quel
certo stimolo al cambiamento, ma essa persiste anche perché mai si può raggiungere la sua fine, giacché anche quando l’obiettivo è raggiunto, il nuovo
esistente reclama, ancora una volta, la necessità del suo superamento e così
fino all’infinito; è come l’effetto orizzonte, quanto più noi lo cerchiamo obiettivamente, più esso si allontana da noi; però non per questo noi smettiamo di
ricercarlo.
Nella sua più grande opera, Il Principio Speranza, pubblicata a Berlino Est
nel 1954 e nel 1959, Bloch descrive la speranza marxiana attraverso una
metafora: è come la presenza “dei raggi ultravioletti nella luce”, che esistono,
ma non li si può vedere con gli occhi. Qui trova il principio di una teoria che
non si rassegna ad essere mera esposizione dell’attuale, bensì tende anche a
trasformarlo, per cui la separazione cristallizzata tra futuro e passato cade da
sé: il futuro che non è arrivato ad essere, che non è divenuto, è visibile in alcuni tratti del passato e, a sua volta, il passato rivendicato ed ereditato, diviene
visibile nel pervenire che si intravede.
L’energia elementare della speranza la fonda, in ogni uomo o donna, nell’uomo fisico o di idee nuove (l’uomo dotto), nella coscienza di un vuoto, rivelatore di un qualcosa che manca. La speranza inizialmente è espressione del
mondo istintivo legato alla necessità e alla domanda che apre per sua soddisfazione, e in essa trova la possibilità di intendere in modo scientifico la storia
umana, in quanto pathos della trasformazione dell’eterno sorgere del novum.
La corrente fredda e la corrente calda
6
Riflettere sulla speranza significa servirsi di una distinzione blochiana che
sta alla base del suo pensiero: la corrente fredda dell’opera di Marx si adatta
all’analisi economica sviluppata ne Il Capitale, posizione critica dell’economia
politica che permette di aprire la strada ad un progetto, un’ipotesi di superamento della produzione diretta solo dall’ansia del profitto e che si trova alla
base della corrente calda: “realtà di tipo morale che accoglie la fantasia e stimola l’entusiasmo rivoluzionario, spinge gli uomini a sfidare la morte nel desiderio di passare dal regno della necessità a quello della libertà”. Nella stessa
introduzione ai corsi estivi dell’università di Zagabria, nell’agosto 1969, egli
sostenne che tale trapasso non si sia dato in “nessun luogo” e che tale nuova
alternativa attendeva di essere costruita e la chiamò “utopia concreta”, perché
solamente essa poteva emergere dalla critica teorico-pratica delle società esistenti al momento: capitalista o del socialismo reale.
L’utopia concreta
Si contrappone all’angustia e alla paura, alla ristrettezza degli orizzonti
della società manipolata, che trasforma tutto in merce o che si chiude nel totalitarismo. La proposta di Bloch non nasce in un vuoto storico, bensì trova la
sua fonte nella persona che si è perduta davanti all’emergere della società di
masse manipolate o alle involuzioni burocratiche e al totalitarismo del nazismo
e dello stalinismo o nell’individuo prigioniero del consumismo, che si ritira nella
vita privata, rimanendo però sempre prigioniero delle sue angustie solitarie,
che gli impediscono di aprirsi alla speranza e all’utopia, “perché non ritiene
che è possibile sperare in un altro mondo al di là di questo mondo” (Gonzalo
Rojas).
Gli studi di Bloch collocano il centro dell’attenzione nel cuore dell’eticità e
delle passioni dell’uomo, che il tema della sua liberazione rende esplosivi. Il
suo sforzo intellettuale è più ampio di quello della Scuola di Francoforte, perché mentre per questa resta bloccata la prospettiva della liberazione umana,
in lui la soggettività svolge un ruolo che è insostituibile, nella misura in cui, pur
Il sogno di una cosa
Il fondamento laico del suo principio speranza e della sua utopia concreta,
Bloch lo trova nella famosa e ignorata lettera di Marx a Arnold Ruge, del settembre 1843: “Apparirà chiaro […] come da tempo il mondo possiede il sogno
di una cosa Traum von einer Sache, di cui non ha più da possedere la coscienza, per averla realmente. Apparirà chiaro che non si tratta di tirare una linea
retta tra il passato e il futuro, bensì di realizzare i pensieri del passato”.
Tuttavia, il sogno di una cosa non si rivela immediatamente in forme razionali. Il bussare della sua esistenza si percepisce come inquietudine, fermento, disincanto dell’esistente, mito o proiezione eliotropica verso il nuovo sole
che spunta all’orizzonte della storia, riprendendo un’immagine di Walter
Benjamin: “Come i fiori muovono la testa verso il sole, costretti da un segreto
eliotropismo, tutto ciò che è stato, tende a voltarsi verso il sole che sale nel
cielo della storia” (quarta tesi della filosofia della storia) e che penso che in
questa fine del secolo XX e nel prospettarsi del XXI a venire, si faccia nell’espansione esponenziale della democrazia che stiamo vivendo e che tuttavia
viene anche gravida di futuro, di qualcosa che le manca, di una forma di vuoto
che solo si può riempire con l’aspirazione all’uguaglianza.
Bloch pone al centro della sua analisi la relazione tra utopia e storia nel
processo di rinnovamento della società, partendo dal fondamento che l’utopia
non è solo sogno, bensì necessità del nuovo contenuto nel presente (il novum)
e avvertenza di ciò che ancora manca all’uomo per arrivare ad essere realmente umano.
SAGGI
essendo alienata o manipolata, la sua propria struttura utopico-desiderante
tende sempre, al di là di ricadute e regressioni, verso l’esigenza del nuovo,
verso la possibilità dell’altro.
Attitudine che lo portò a confrontarsi con le sfide più importanti dei suoi
contemporanei: Heidegger, Husserl o Freud, negli anni in cui erano definiti dal
marxismo ufficiale come “decadenti” o “irrazionali”.
Oggi, che va tanto di moda parlare dei disastri delle utopie, è necessario
segnalare che Ernst Bloch fu tra i primi a rendersi conto che nei paesi del
“socialismo reale” si negava l’utopia, perché erano il regno degli slogans vuoti,
contraddetti dalla realtà effettuale. Il Principio Speranza è pieno di aporie su
“la realizzazione dell’utopia”, su “il falso Messia” verso il quale si incammina la
speranza; ma, al di là delle frustrazioni, il percorso dell’utopia continua in un
processo drammatico, aperto, che si pone nella discontinuità e sempre evoca
ciò che resta da raggiungere, senza isterilirsi nell’eterna attesa o nel viaggio
senza punto di arrivo. Motivi che trova nella speranza cristiana, nelle esperienze mistiche, specialmente di Meister Eckart e Jakob Bohme, nella tradizione casidico-giudaica, nelle utopie millenariste e nei movimenti eretici e nelle
concezioni giusnaturaliste che si concretizzano nelle loro opere: Tomas
Munzer, teologo della rivoluzione, Ateismo nel cristianesimo e Diritto naturale
e dignità umana, in ognuna delle quali la morale diviene direttiva della politica.
7
Pensieri e opere di un’epoca o di un uomo in solitudine, si espandono,
spesso in sentieri interrotti, abbandonati a metà del loro percorso. Di più,
una volta aperto il sentiero, sono suscettibili di essere ripassati di nuovo, da
altri uomini e in nuove condizioni, che se ne stanno meravigliati guardare
perché prima erano stati attraversati tangenzialmente da esseri umani precedenti.
Esistono molte tensioni latenti verso il futuro, differenti sbocchi, possibili e
a diversi gradi di maturità storica. Il futuro non è necessariamente solo davanti a noi, come qualcosa che emerge dal nulla gravido, bensì, come tendenza,
risiede anche nel passato e nel presente, pronto a uscire fuori quando si compiranno tutte le condizioni del suo essere.
Vale la pena di osservare che questa visione ottimista della vita si andò forgiando negli anni di ferro e fuoco dell’Europa Centrale.
Da un esilio all’altro
8
Ernst Bloch nacque a Ludwigshafen, in una famiglia ebrea agiata, l’8 luglio
1885. Studia con Simmel nella Università berlinese di Humboldt e frequenta in
quella di Heidelberg il circolo di Max Weber, assieme a Jaspers e Lukàcs, con
il quale ultimo mantenne un’amicizia duratura, tormentata e difficile.
All’inizio della Prima guerra mondiale e in contrapposizione col nazionalismo prussiano, emigra in Svizzera, come fecero Hermann Hesse e Romain
Rolland, e da lì pubblicò, nel 1918, Lo spirito dell’utopia, libro precursore dei
temi essenziali della sua opera posteriore e dove, inoltre, diede un teoria filosofica al principale movimento artistico tedesco, l’espressionismo. Bloch scrive saggi su Klee, Chagall, Joyce, Proust, Schonberg, che contengono pagine
decisive che lo trasformano in un protagonista della cultura di avanguardia nel
periodo tra le due guerre.
Dopo ritorna nel suo paese e nel 1923 scrive Attraverso il deserto, in cui
studia Nietzsche e, nel 1930, Tracce, in cui riflette sul suo tempo, attento a ciò
che è insolito.
Con l’arrivo del fascismo al potere, è costretto a partire per un secondo esilio svizzero e nel 1935 pubblica Eredità di questa epoca, in cui scrive su Cristo,
Bergson, Lenin, la teoria della relatività, il cinema, le grandi concentrazioni
industriali e il deterioramento ambientale, sui racconti dei pellirossa, eccetera.
Sempre con i fascisti alle calcagna, deve vivere a Zurigo, Vienna, Praga, fino
a che non giunge all’Università di Cambridge, Massachusset, dove lavora a
diverse opere: Soggetto-oggetto, commento a Hegel, il suo libro più bello e
sopra il quale varrebbe la pena di ritornare un’altra volta, e Principio Speranza,
la sua opera magna, entrambe pubblicate nella Berlino Est, dove ritornò a
vivere nel 1949, d’accordo con i suoi convincimenti comunisti. Fu nominato
professore dell’Università di Lipsia.
Come conseguenza delle polemiche scatenatesi a causa dei suoi insegnamenti sui quali giunse ad intervenire lo stesso Walter Ulbricht, fu espulso dalla
sua cattedra e alcuni suoi alunni andarono a finire in carcere, cosa che lo
SAGGI
costrinse al suo terzo esilio: dopo l’agosto 1961, a Muro costruito, decide di insegnare nell’Università di Tubinga, dove morì nell’agosto 1977, all’età di 92 anni.
Fu accusato di non essere un “marxista conseguente”, ma uno può legittimamente domandarsi che cosa significhi un’espressione come questa, se lo
stesso Marx dichiarò che egli non era marxista; se non fosse altro che la foglia
di vite con la quale potersi giustificare o celare l’oscena realtà di un dogmatismo di Stato, e se coloro che lo obbligarono al suo terzo esilio non facessero
altro che preannunciare ciò che sarebbe accaduto a loro stessi e allo Stato
che dirigevano altezzosamente: diventare abitanti dell’“altra” Germania.
Lo sforzo blochiano per liberare le idee giovanili di Marx dalla liturgia ufficiale e dalla loro collocazione in una linea canonica rigida non fu vano, perché la
sua rivendicazione dell’utopia, testimonia che, malgrado tutto, la certezza di un
futuro migliore, di una libertà sviluppata, di un’uguaglianza più piena nel mondo
a venire, è il nuovo contenuto del nostro presente storico, gravido di futuro.
(traduzione di Maurizio Nocera)
9
LA BELLEZZA E IL TRAGICO
IN SCHOPENHAUER
di Livio Bottani
10
Con K.W.F. Solger abbiamo un hegeliano, vicino tuttavia ai romantici, il
quale, pur avendo riconosciuto –per ammissione dello stesso Hegel nella sua
introduzione all’Estetica– il “momento dialettico dell’idea”1, teneva fermo alla
negatività, respingendo il ricorso alla conciliazione dialettica, volta a racchiudere ogni negatività nell’assoluto di una superiore positività sempre più inclusiva. Anche Karl Rosenkranz, altro hegeliano, tendeva a riportare all’interno
dell’hegelismo quella vasta esplorazione della negatività che era stata avviata
dai romantici, mostrando come il concetto di armonia rappresentasse ormai un
fragile argine nei confronti delle forze disarmoniche e dissonanti, al punto che
l’armonia si qualifica sulla base dell’interna conflittualità degli elementi che la
compongono (così la pensava già Eraclito). La bellezza stessa, in questo
senso, consisterebbe in quella potenza connettiva che non è in grado però di
trascendere e riscattare completamente il negativo, il quale resta –in quanto
tale– muto e impenetrabile. Qualcosa, nel negativo, resiste alla sua trasfigurazione, sia in generale sia ancor più in senso estetico, così che esso e il male
non possono essere pensati come li pensava il razionalismo metafisico, ossia
“come momenti che scompaiono nella totalità del grande ordinamento divino
del mondo”2.
Questo, per lo meno, vale nel caso dell’uomo, della sua posizione nel
mondo e dell’idea che la sua mente può averne. Nella sua esperienza, difatti,
il negativo o il male possono rappresentare tappe o limiti che si riescono a
superare o funzionalizzare col fine di pervenire a condizioni più elevate dell’esperienza. Basta pensare alla crescita pedagogica di un individuo, per comprendere come per lo più non vi sarebbe crescita alcuna se l’individuo non
fosse condotto a superare condizioni che paiono impedirla, essendone di ostacolo, in maniera tale da risolvere a proprio favore una determinata situazione
problematica. Certo è che, se si prescinde dalla situazione umana e dalle esigenze di senso dell’essere umano, dalla sua coscienza e dalla sua conoscenza, allora non è difficile ritenere che ogni negatività svanisca effettivamente
nell’ordinamento complessivo del mondo, ossia che il negativo e il positivo si
intreccino in esso in una danza senza fine, oppure che la medesima distinzione netta tra i due divenga propriamente insensata, giacché nella sostanza
indifferenziata del mondo non vi sarebbe alcuna possibilità di distinguerli come
solo una coscienza potrebbe fare. Ma il filosofo pensa in generale a partire
dall’uomo, dall’eventualità di comprendere la condizione umana dalla sua
posizione privilegiata nella disposizione del mondo, il quale è tale per lui solo
in rapporto a se stesso, sebbene egli sappia che lui e il mondo stesso sono
SAGGI
reciprocamente (e relativamente) trascendenti, quantunque anche sapendo e
avendo la certezza indubitabile di farne parte. Questo movimento infinito di
includenza e trascendenza, reciprocamente ordinate l’una rispetto all’altra,
prende avvio peraltro dal soggetto in cui si rende operante. Questo può prendere distanza dal mondo oggettivo e vederlo –almeno parzialmente– come
estraneo a sé, vedere se stesso come distante dal mondo e persino in grado
di autotrascendersi; e tuttavia il suo interesse primario (la sua intenzionalità)
va al mondo –ma in quanto appunto ne è parte integrante, in certo modo insostituibile e necessaria– inteso come supporto materiale e referente intenzionale del pensare che lo pensa, oltre che scenario di ogni evento.
Il pensiero di Schopenhauer teorizza anzitutto l’insostenibilità di ogni ottimismo. Chi per primo, secondo lui, afferma con forza tale insostenibilità e la
triste costituzione del mondo è Hume. Il fondatore dell’ottimismo sistematico è
invece –ovviamente– Leibniz, colui che istituisce un vero e proprio sistema
dell’ottimismo, con tutto il suo armamentario di teodicea3. Per Schopenhauer
la volontà è primaria e la conoscenza una specie di puro epifenomeno, uno
strumento di cui la volontà si serve per le sue manifestazioni4. La stessa libertà di volere, la facoltà di scelta e di deliberazione, che molti hanno inteso come
semplice risultato di operazioni intellettuali, non è che determinazione della
mente da parte della volontà. Questa facoltà deliberativa pone l’uomo al di
sopra di ogni altro essere vivente, eppure non è anch’essa che epifenomeno
della volontà. Le idee sono, per Schopenhauer, adeguate e immediate oggettivazioni della volontà, che sono suscettibili di vari gradi e altezze. Le cose singole, invece, costituiscono oggettivazioni mediate e non adeguate della volontà, coincidente con la cosa in sé: sono copie fenomeniche delle idee, la cui
nascita e scomparsa non cambia nulla nella realtà vera. La conoscenza rappresentativa che le riguarda dipende dal principio di ragione, che le assoggetta alle condizioni spazio-temporali e alle concatenazioni causali.
In origine, perciò, la conoscenza è tutta al servizio della volontà, e fa parte
essa stessa dell’oggettivazione della volontà nei suoi gradi superiori (M 214
sgg.). Essa non si libera mai realmente dalla servitù nei confronti della volontà; ma se questo vale soprattutto per gli animali e per la maggior parte degli
uomini, alcuni di questi ultimi hanno capacità di affrancarsene eccezionalmente e in modo più o meno ampio. Il passaggio dalla conoscenza comune
delle cose a quella delle idee può allora avvenire per l’individuo, che si svincola così dal servizio della volontà; questi cessa con ciò di essere semplicemente individuale, divenendo puro e libero soggetto conoscente della volontà,
al di là del dolore, del tempo, della volontà. Rapito e annientato nella contemplazione delle idee, l’individuo conosce le forme eterne delle cose nel grado
loro spettante. Colui che diventa portatore di una tale intuizione della natura,
nella sua contemplazione disinteressata, percepirà se stesso eterno come la
natura che contempla, e non potrà né dovrà pensarsi quale essere semplicemente transitorio.
È nell’ambito dell’arte che viene a manifestarsi questa conoscenza della
verità essenziale del mondo, della sostanza ultima dei fenomeni. Essa infatti
si rende operante attraverso il genio, che concepisce le forme mediante l’in-
11
12
tuizione pura e la contemplazione, riproducendo le idee eterne e permettendone la comunicazione, la ricezione da parte della altrui apprensione e conoscenza. L’unica origine dell’arte –dice Schopenhauer– è la conoscenza delle
idee: è modalità speciale e tipica di conoscerle, e il suo fine esclusivo è la
comunicazione delle idee (M 223). L’arte strappa sia il soggetto conoscente
sia l’oggetto conosciuto alla corrente della volontà: il soggetto, in quanto diviene puro soggetto di conoscenza; l’oggetto in quanto viene sottratto al principio
di ragione, considerato a sé stante, prescindendo dalle sue relazioni spaziotemporali e causali. Se la bellezza favorisce la conoscenza pura dell’idea,
rimuovendo senza lotta e contrasto le relazioni con la volontà e il tipo di conoscenza funzionale che vi si riferisce, l’arte corrisponde a questa conoscenza
pura. Il sublime, invece, rappresenta anch’esso la conquista di questa conoscenza pura, raggiunta però attraverso un atto di conscia violenza per sollevarsi al di sopra della volontà e della conoscenza che le è per l’appunto funzionale (M 241). Queste riflessioni dipendono direttamente da quelle analoghe
della Critica del giudizio kantiana. Ciò che in esse si rileva è che quello che
distingue il bello dal sublime consiste nel prodursi in modo spontaneo e senza
resistenza dello stato di pura conoscenza libera da volontà, mentre nel sublime esso deve essere conquistato attraverso una lotta, mediante un libero e
cosciente sollevarsi al di sopra della volontà e della relazione sfavorevole che
essa ha con l’oggetto contemplato, attenendosi alla quale l’individuo vedrebbe sopprimersi ogni contemplazione (M 248). Questo atteggiamento implica,
osserva Schopenhauer, uno stato d’animo più tragico di quello che viene vissuto nello stato d’animo del bello (M 243).
La poesia rappresenta la manifestazione dell’idea più elevata, che è quella di umanità. Il poeta, dipingendo l’uomo nella serie continua delle sue aspirazioni e delle sue azioni, esprime il grado supremo di oggettità della volontà.
L’arte architettonica invece, verso l’estremo opposto, viene intesa a “facilitare
l’intuizione di alcune di quelle idee che sono i gradi inferiori dell’oggettità della
volontà” (M 253). Essa manifesta le idee del peso e della rigidità materica,
facendo risaltare la lotta e il contrasto sussistente fra loro, la dinamica interna
delle forze naturali più elementari. La tragedia rappresenta da questa prospettiva l’esatto opposto dell’architettura, poiché in essa viene a manifestazione il conflitto tra le forze più profonde, le idee più dense di significato. Le altre
arti, l’arte idraulica, le arti del giardinaggio, la pittura di paesaggio e di animali, evidenziano idee progressivamente già più elevate rispetto a quelle che trovano espressione nell’architettura, ma meno che nella poesia e nel dramma.
Si tratta di idee concernenti il mondo della natura in movimento, e poi di quello degli esseri viventi autorganizzati, del mondo vegetale e animale, dell’intera biosfera e della cosiddetta natura ambientale.
È con la scultura e con la pittura storica che inizia a manifestarsi la bellezza dell’umanità. La bellezza umana diventa in sé l’oggettivazione più alta della
volontà, che solo l’arte riesce davvero a rappresentare ed esibire con perfetta
purezza (M 262). Essa viene intesa da Schopenhauer come oggettivazione
adeguata della volontà mediante un fenomeno puramente spaziale. Qualcosa
che può essere connesso alla bellezza è la grazia, la quale è rappresentazio-
SAGGI
ne adeguata della volontà mediante un fenomeno collocato nel tempo, un
movimento, un atto volontario compiuto nel momento giusto. Mentre si può
attribuire la bellezza alle piante, ma non la grazia (se non in senso figurato),
questa viene posseduta dagli animali e dall’uomo. Nella scultura troviamo l’unione tra una perfetta bellezza e una perfetta grazia, così che vi si dispiega “la
manifestazione più notevole della volontà nel grado supremo della sua oggettivazione” (M 264). Nella pittura storica si ha in più la configurazione del carattere, che rende la molteplicità delle possibili modificazioni cui può sottostare la
rappresentazione delle azioni umane, che l’arte raffigura guardando al loro
significato interiore, mentre l’esibizione del significato puramente esteriore
interessa per lo più la storia.
La tragedia, l’opera suprema del genio poetico, “ha il fine di mostrare il lato
terribile della vita, i dolori senza nome, le angosce dell’umanità, il trionfo dei
malvagi, il potere schernitore del caso, la disfatta irreparabile del giusto e dell’innocente” (M 294). A venire in luce è qui la lotta della volontà con se stessa,
in un conflitto mortale che si svolge tra esseri umani tendenti a imporre il loro
volere contro quello altrui, seguendo talvolta principi contrapposti, lottando col
destino, combattendo con i mostri evocati da coscienze che oscuramente percepiscono il peccato originale come peccato dell’essere esistenti, o, potremmo forse dire meglio, del sapere di essere mortali senza poterne venire definitivamente a capo nel tempo limitato dell’esistenza. Per Schopenhauer la tragedia ci fa vedere, mettendocelo appunto sotto gli occhi e insegnandocelo,
come l’eroe espii questa colpa corrispondente al delitto dell’esistenza (M 296).
Questo è secondo lui il vero significato della tragedia. La tragedia consiste,
citando i versi di Calderón, nel mostrarci che il maggior delitto dell’uomo è l’esser nato. Schopenhauer lo ripete accennando a quello che per lui è il contenuto essenziale del celebre monologo dell’Amleto, secondo cui “il nostro stato
è così misero, che l’assoluto non essere sarebbe senz’alcun dubbio preferibile” (M 365). Ciò ci ricorda da vicino il noto detto del Sileno, il quale, alla
domanda del re Mida che gli chiedeva quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l’uomo, questo rispose tra stridule risa: “Stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è
vantaggiosissimo non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo
migliore per te è morire presto”5.
Si potrebbe rilevare qui come il tragico consista per Schopenhauer nella
condizione umana in quanto tale, sottoposta com’è alle sofferenze e miserie
della vita, alla sciagura, alla malvagità, alla cieca fatalità. La tragedia ci presenta il colmo della sventura non come qualcosa di straordinario, come un’eccezione, ma come una conseguenza normale e spontanea della vita umana,
dei suoi caratteri e delle sue condizioni. La tragedia, e con essa –secondo gradazioni le più diverse– anche tutte le altre arti, avrebbe tuttavia il potere di consolare l’uomo dal tragico della vita. L’entusiasmo fa dimenticare all’artista le
pene della vita. Le fa dimenticare anche allo spettatore, ma nel caso dell’artista si tratta di un privilegio del tutto speciale “che ricompensa il genio dei dolori crescenti sempre in proporzione con la chiarezza della coscienza, che lo for-
13
14
tifica nella desolante solitudine cui si trova condannato nel seno di una moltitudine eterogenea” (M 309). Che qui si tratti di coscienza, e della sua più o
meno grande finezza, implica un aspetto conoscitivo della percezione del tragico, che richiama immediatamente una ricerca di consolazione. Il piacere
misto, o per meglio dire il dolore piacevole (o piacere doloroso), che si ottiene
dalla tragedia consiste nel riconoscimento, e perciò nella lucida consapevolezza, che le contraddizioni dominano ‘tragicamente’ l’intera esistenza. La
chiara rappresentazione di questo fatto ne sta alla radice.
In realtà, per Schopenhauer, non è solamente l’arte –oltre alla contemplazione mistica e alla santità, a rappresentare un vero e proprio quietivo della
volontà–, a costituire una consolazione (seppur provvisoria) nei confronti delle
sofferenze della vita. Tutte le manifestazioni della cultura, per la verità, ne
sono candidate a pari titolo. Egli ritiene infatti che molte pratiche e mitologie
delle più differenti civiltà sono destinate a “distrarre dal pensiero della morte”,
a spostare l’attenzione dall’idea della caducità irrimediabile dell’esistenza e
dalle limitatezze della individuazione personale (M 317). In fondo, nella rappresentazione, la volontà è destinata a divenire conscia di se stessa.
L’individuo è, come puro fenomeno della volontà, un’ombra. Per questo, non
c’è di che essere ansiosi o angosciati di fronte alla morte. La morte e la nascita appartengono entrambe alla vita, e non sono che i due poli dello stesso
fenomeno complessivo che costituisce la vita stessa nella sua integralità. Si
affaccia qui il motivo che trova il suo fondamento storico nel quadruplice farmaco di cui parlava Epicuro, un farmaco del quale riguardava appunto la
morte (quando c’è la morte non ci siamo noi, quando ci siamo noi non c’è la
morte). Possiamo, con questo, facilmente consolarci. Noi vediamo gli individui
nascere e perire, ma ciò che muore è un fenomeno che, scaturito dal nulla e
avendo ricevuta la vita come dono, ripiomba nel nulla una volta spogliatone. È
l’idea dell’uomo a restare immortale, come resta immortale la vita della natura, da cui sorgono tutti gli individui fenomenici e mortali, mentre l’individuo è
radicalmente fugace: un’ombra appunto. L’individuo dovrebbe perciò consolarsi della sua transitorietà già solo al pensiero della permanenza della specie,
mentre la pretesa di durare dovrebbe apparire come uno stravolgimento della
realtà dell’individuazione.
Schopenhauer crede che solo la specie sia eterna, che essa rappresenti l’idea e che guardando a essa l’individuo possa consolarsi della sua breve vita,
della sua morte e di quella dei suoi amici, dovendogli bastare uno sguardo alla
vita immortale di quella natura di cui fa parte (M 318). La morte non è che un
sonno, in cui l’individualità viene dimenticata, un nulla più nulla dell’individuo
stesso. Se già l’individuo non è altro che nulla, che mai sarà la morte –che è
un nulla che corona e conclude un nulla? Al massimo un nulla alla seconda
potenza. La questione è che non solo la morte –la nostra e quella dei nostri
‘amici’– non è affatto per noi e per la nostra coscienza un nulla, ma non lo è
certamente la nostra vita individuale né i singoli e concatenati eventi che vi
accadono. Qualcosa come il tragico dell’esistenza non è semplice apparenza
solo se la nostra vita –e in essa la nostra morte– non sono un nulla insignificante, il cui senso autentico sussisterebbe solamente nella specie umana che
SAGGI
la ricomprende. Questo hegelismo di maniera esclude ogni questione di senso
o non senso dell’esistenza, ma esclude anche ogni possibile rapporto con la
sofferenza o la gioia, con la progettualità e lo scacco e così via.
Tutto ciò lo si può evidenziare seguendo le ulteriori argomentazioni di questo paragrafo 54, a cui si fa qui riferimento. Nella vita singola si dà una pretesa di eternità, ma essa non dipende né dalla prosecuzione presuntiva della
vita oltre la morte né da un riferimento a una qualche eternità oltremondana.
Se c’è eternità nella vita, essa consiste o nell’eternità della specie, che è paragonabile a quella dell’idea, oppure si manifesta nei particolari momenti della
vita individuale in quanto tale, al punto che il singolo –che pure, considerato
nella sua essenza, non è che un’ombra– può ritenerla senza scrupolo come
infinita, bandendo “il timore della morte come un’illusione che suscita in lui l’insensato orrore di poter perdere un giorno il possesso del presente; bandirlo
come il sogno vano di un tempo senza presente” (M 321). Questo vuol dire
che ogni momento presente ha in sé qualcosa che non muore, qualcosa di infinito. Il presente è tutto ciò che abbiamo, giacché il nostro passato, anche quello più prossimo, anche quello di ieri, non è che un vano sogno della fantasia
(M 320). Il passato e anche l’avvenire non racchiudono per noi che vani sogni,
vuoti concetti e fantasmi. Il presente è dunque l’unica forma temporale in cui
la volontà si manifesta. Per essa non esiste né il passato né il futuro. Non bisogna quindi temere la morte, giacché fa parte di un inganno della mente. Gli
animali, che vivono immersi nel presente, non hanno timore né angoscia del
nulla, facendo essi parte della natura ed essendo indistruttibili come essa. Essi
temono e fuggono davanti al pericolo, ma non sanno cosa sia la morte: essi
sono eterni, proprio perché non lo sanno. Gli uomini, invece che sanno di
dover morire, che sono assillati dai fantasmi vani del passato e del futuro, vivono esterni a se stessi, in una trascendenza e autotrascendenza rovinosa, al
punto di pretendere a una immortalità che non possiedono, finendo talvolta
persino per credere o immaginarsi di essere immortali (Borges).
Soltanto l’uomo, afferma Schopenhauer, ha in sé “la persuasione astratta
di dover morire”. L’assurdità palese di questa affermazione schopenhaueriana
è attestata dal fatto che noi non abbiamo affatto una persuasione ‘astratta’ di
dover morire (M 323): noi siamo certi di dover morire, almeno con questo
corpo, che andrà certamente in putrefazione o almeno diventerà polvere, e
ogni memoria di noi svanirà per sempre, dovessero pure trascorrere migliaia
e migliaia di anni, oppure dovessero passarne milioni e milioni (sebbene, per
la stragrande maggioranza di noi questo avverrà molto ma molto prima, e,
secondo molti degli storici e degli studiosi che ne hanno trattato, per lo più
entro tre generazioni dalla nostra morte: il che vuol dire circa cento anni6). E
questo, nonostante ogni eventuale imbalsamazione o ibernazione, oltre ogni
fama o possibile gloria. Noi non abbiamo solo una certezza astratta della
nostra morte, ma una certezza salda e concreta; e se anche siamo ben lesti a
metterla da parte, a non sollevarne di continuo alla mente il contenuto rendendola così in ogni istante momento costitutivo di una coscienza viva e attiva, ciò nonostante essa viene spesso a disturbare il sistema perfetto delle
nostre credenze, seppur facendo anch’essa parte delle nostre credenze. Sarà
15
16
quindi pur vero che questo pensiero non ci angustia in ogni istante della nostra
esistenza, e anzi lo fa solo a intervalli, quando una rara occasione ce lo riporti alla mente; e che domina l’uomo per lo più un senso di sicurezza “come se
la sua vita dovesse durare per sempre”. E tuttavia il dubbio che la morte vanifichi ogni nostro progetto e sicurezza, non cessa, sebbene a intervalli, di turbare la nostra vita. Ben poco interessa alla coscienza dell’individuo sapere
che, diventata puro occhio del mondo, parole o pensieri come quelli inerenti
alla permanenza e alla distruzione appaiano senza senso. Noi, difatti, non
siamo che a intervalli –allorché si riesca a esserlo– anche puri apparati contemplativi, soggetti capaci di intuizione pura.
In fondo anche per Schopenhauer, come per altro verso anche per Freud,
nell’essere umano permane per lo più una netta coscienza della fondatezza
attuale della propria esistenza, della continuità indisturbata con se stesso, nel
senso che l’apparato psichico dell’uomo non lascia filtrare l’idea della morte e
non permette facilmente a questo pensiero di avvelenargli l’esistenza, in quanto la sua coscienza di essere ragionevole è dominata dalla certezza di far
parte di qualcosa di eterno, della specie in primo luogo, e della cosa in sé e
della volontà in secondo luogo, come qualcosa perciò di immortale. L’uomo
non è per niente rassicurato dalla credenza che il mondo esterno continui a
permanere dopo la sua morte, ma piuttosto –così ritiene, come s’è visto,
Schopenhauer– dal pensiero di far parte integrante di un mondo e di una specie e di una volontà che pensa eterni, mentre lui stesso solo come fenomeno
è transeunte, e per lo più solo in quanto fenomeno risulta separato dagli altri
fenomeni, dalle altre cose e dal mondo stesso. La morte non concerne la sua
coscienza solo in riferimento al proprio appartenere, quantunque come fenomeno, alla cosa in sé, alla volontà. Se il pensiero della morte rischia di porre
in dubbio il suo consistere (‘come se’ non fosse già sempre immortale! ‘come
se’ la morte ci fosse!), tuttavia la coscienza di far parte del fondamento dell’eterno dovrebbe farlo vivere lietamente. In realtà, di contro a una tale pretesa
del puro pensiero filosofico (schopenhaueriano o meno), quando si avvicina
all’individuo il momento della morte, allorché questa gli si mostri dinnanzi,
oppure qualcosa lo costringa davvero a “guardarla in faccia”, colpendolo con
l’orrore che gli ispira, egli cerca ogni mezzo di fuggirla. Che sia solo il sentimento a essere scosso dal pensiero della morte, che si rifugge almeno finché
non sia troppo il dolore, mentre talvolta si sopporta ogni male pur di sottrarsi
ancora un istante alla morte; che non sia in alcun modo la ragione a esserne
scossa mentre piuttosto dovrebbe bastare a vincerne i terrori, questo non pare
proprio plausibile come crede Schopenhauer. La conoscenza e la ragione,
piuttosto, non fanno che radicalizzare ancor più il nostro sentimento della
morte.
Schopenhauer fa, da parte sua, un esperimento mentale. Immagina un
individuo che non sia ancora pervenuto a esperire o riflettere che la vita è perpetuo soffrire e che sia pienamente soddisfatto della propria al punto da desiderarne la prosecuzione o la ripresa infinite; un individuo che sia coraggioso
nell’accettare della vita tutte le preoccupazioni e il dolore, pur di non perderne
il godimento. Un tale individuo dovrebbe vedere con indifferenza la morte che
SAGGI
gli viene incontro. Egli, armato della conoscenza, di una ragione che gli abbia
dischiuso la comprensione filosofica della natura del mondo, sarebbe in grado
di vincere il sentimento di orrore nei confronti della morte e non se ne spaventerebbe. Si tratta di una mera ipotesi, forse non impossibile a realizzarsi,
ma certo difficilmente verificabile. In ogni caso, un tale individuo sarebbe
‘armato’ di una conoscenza ben limitata e circoscritta qualora non sia ancora
arrivato a percepire alcuna sofferenza e a riflettervi, a rendersi conto del dolore e del male racchiuso nella vita umana e nella vita in genere: sarebbe un
individuo talmente inesperto da poter essere paragonato a un bambino molto
piccolo, cresciuto nella bambagia e iperprotetto di fronte a qualsiasi possibile
dispiacere, alla cui mente non si sia ancora affacciato nemmeno il pensiero
della morte, il sapere della fugacità di ogni cosa e di ogni essere.
Verificate le opinioni di Schopenhauer su questi argomenti, possiamo concludere che a partire da esse vi sia ben poco spazio per il tragico o per lo
meno che ogni tragico non sia che illusione e inganno di individui che non
sanno riconoscere l’eternità che è in loro in quanto esseri noumenici, che non
hanno ancora consapevolezza filosofica che il pensiero della morte è una presunzione del tutto astratta, che ancora non si sono sollevati alla visione e alla
certezza di far parte di qualcosa di eterno, dell’eternità propria della specie o
dell’idea o della volontà. In realtà, il fatto di vivere fenomenicamente (con le
‘sole’ prerogative, rispetto all’animale, di avere conoscenza astratta o razionale, avendo –nostro malgrado– cognizione di dover morire, e di avere capacità
progettuali e deliberative, di essere in grado di decidere tra diversi motivi, di
scegliere tra svariate opzioni) implica che la conoscenza, lungi dal liberare l’individuo dal sentimento di orrore nei confronti della morte, è proprio lei a condurvelo. Sarà sempre mediante essa, tuttavia, che la coscienza andrà in cerca
di rimedi nei riguardi delle cognizioni problematiche ottenute per suo tramite.
Giacché la conoscenza è, come avevamo già fatto notare altrove, un phármakon: origine di difficoltà e al contempo strumento eventuale di salvezza, qualcosa che è del resto stato fin dall’inizio ed è estremamente utile alla sopravvivenza umana, ma insieme anche potenzialmente pericoloso, richiedendo
riscatto e rimedio –per così dire, omeopatico– anche da parte della medesima
conoscenza (minacciosa circolarmente per l’intera esistenza umana, essendone tuttavia elemento imprescindibile e necessario per la sua economia positiva). Ciò può essere verificato andando anche solamente a esaminare le
prime leggende e mitologie delle più diverse civiltà, secondo una sapienza
espressa perfettamente dai due celebri versi della lirica hölderliniana
Pathmos, citata e commentata anche da Heidegger: “Wo aber Gefahr ist,
wächst / Das Rettende auch” (Là dove è il pericolo, cresce anche ciò che
salva) 7.
Ma la conoscenza è duplice, in fondo, per lo stesso Schopenhauer.
Abbiamo già visto come per lui essa rappresenti un puro epifenomeno della
volontà. In questo senso la conoscenza diventa un motivo della volontà,
potendo però trasformarsi anche in un suo quietivo. La volontà, in sé, non
vuole nulla di preciso, mancandole interamente un fine ultimo, una finalità che
sia differente da quella di manifestarsi sotto forma di aspirazione, che non può
17
18
tuttavia ottenere soddisfazione definitiva nei fenomeni in cui si manifesta, che
hanno in sé la medesima volontà e tendono a espandersi disputandosi in continua lotta spazio vitale e materia, cercando di vincere ogni impedimento esterno. Sotto questa veste, qualsiasi tendere nasce da una privazione indefinita e
non gli si dà alcun fine. Il tendere trova però continue resistenze, è sempre un
tendere nella lotta. Questo è causa di sofferenza incessante e impegno di
energia, alla ricerca di togliere di volta in volta tutti i possibili ostacoli che si
presentano. Sapere ciò è causa di sofferenza ulteriore, che si eleva di potenza in rapporto diretto all’aumento del sapere e del tipo di volontà in gioco, in
quanto “più perfetto è il fenomeno della volontà, tanto più manifesto è il soffrire”. Il tormento cresce con forza, aumentando sempre più fino a giungere al
parossismo, “man mano che la conoscenza diviene più distinta, e che la
coscienza si eleva”. Il tormento più sottile è quello che tocca all’uomo che sia
pervenuto al grado più elevato di complessità e affinamento, che è tanto maggiore quanto più l’uomo manifesta intelligenza. Ciò riporta immediatamente
alla mente il detto dell’Ecclesiaste biblico, secondo cui “quanto più sapienza,
tanto più inquietudine, / quanto più conoscenza, tanto più travaglio” (Koh., 1,
18). Ma è lo stesso Schopenhauer a ricordarcelo, citando il detto del Kohèlet
in latino: “qui auget scientiam, auget et dolorem” (M 351).
La vita dunque è (anche) sofferenza e travaglio, e lo è in misura vieppiù
maggiore quanto più la forma di vita in cui si manifestano risulta elevata.
Schopenhauer prosegue questo suo ragionamento anche nel § 57 del Mondo,
ma ha il suo completamento nel § 46 dei Supplementi al “Mondo” (dal titolo
“Della nullità e del dolore della vita”) –si dovrebbe a tale riguardo tener presente, soprattutto per quanto attiene alcune riflessioni cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, le considerazioni svolte anche nell’importante § 41 di tali
Supplementi, che ha per titolo “Sulla morte e sulla sua relazione con la indistruttibilità del nostro essere”– e nei capitoli 11 e 12 dei suoi Parerga e
Paralipomena8. Qui ci limitiamo a prendere in considerazione il citato § 57 e
quello successivo, avendo analizzato altrove i suddetti paragrafi dei
Supplementi e dei Parerga9. Nel § 57 Schopenhauer riprende il discorso sulla
consistenza del presente, il quale è tutto ciò che abbiamo, mentre passato e
futuro non sono che illusione (supra, p. 2), affermando che l’individuo finito
–nell’infinità dello spazio e del tempo– si sente come un nulla. Egli non esiste
che nel presente, che precipita senza posa nell’abisso del passato, mentre si
rappresenta e progetta un avvenire che però è raffigurabile anch’esso come
una fuga altrettanto incessante verso la morte: “Il presente gli sfugge ad ogni
momento per cadere nel passato; l’avvenire è incerto e breve in ogni caso. La
sua vita, quanto alla sua forma, è un perpetuo morire” (M 352). La vita viene
qui concepita nel senso di “un’agonia (uno Sterben, un morire) continuamente impedita, una morte differita (un aufgeschobener Tod) d’istante in istante”.
Derrida dirà –a questo proposito– che la vita è economia della morte, nello
stesso senso in cui la morte è economia della vita10. La vita è differimento continuo: e di cosa, prima di tutto, se non della morte e di tutto ciò che per la
coscienza significa il sapersi o il dubitarsi mortale! Ma una singola cultura (e
la cultura nella sua generalità) è –complessivamente– concepibile come risul-
Ogni nostro atto di respirazione è un allontanare la morte che ci assale; è una battaglia in ogni secondo; a cui se ne aggiungono altre a intervalli più lunghi, ogni
volta che ci nutriamo, che dormiamo, che ci riscaldiamo, ecc. Ma bisogna infine
che la morte trionfi, poiché siam divenuti sua preda per il solo fatto di esser nati;
la morte si permette un momento di giocare con la sua preda, ma non aspetta che
l’ora di divorarla. Rimaniamo nondimeno affezionati alla vita, e spendiamo ogni
cura per prolungarla quanto possiamo; proprio come chi si sforza di gonfiare
quanto più e quanto più a lungo è possibile una bolla di sapone, pur sapendola
destinata a scoppiare (ibidem).
Se già nella natura sussiste una costante aspirazione senza scopo e senza
posa, nel caso dell’uomo ciò diventa del tutto manifesto ed evidente. Qui non
si dà che volere e aspirare, bisogno di soddisfare motivi e intenzioni e progetti che, una volta soddisfatti, lasciano nuovamente spazio al sentimento della
mancanza e del bisogno, ossia al dolore. L’uomo è destinato perciò al dolore
e alla ricerca incessante di rimuoverlo. Qualora poi alla volontà vengano a
mancare gli oggetti di desiderio, o i motivi di agire, allora a farsi avanti è la
noia, che non è affatto meglio della carenza di soddisfazione (M 356). A spingere la coscienza a resisterle, come a resistere al dolore, è la paura nei suoi
confronti, restando essa tuttavia sempre sullo sfondo, annunciandole il definitivo naufragio, che cerca di differire mediante continue distrazioni, ammazzando il tempo per rimuoverla. La felicità non è mai originaria, ma proviene
sempre dalla soddisfazione di un desiderio o dalla liberazione da un dolore o
da un bisogno, ma anche dallo sfuggire all’aspirazione vuota che conduce la
coscienza alla noia. Non è quindi positiva, bensì negativa, dipendente com’è
dal duplice bisogno dell’uomo: innanzitutto di senso e di fondamento, che vuol
dire di giustificazione e rassicurazione, e in secondo luogo di occupazione e
distrazione (M § 58, 360-4).
Se tutta questa descrizione può richiamare alla mente una condizione tragica della vita umana, tuttavia il fatto che in sostanza Schopenhauer pensi che
ciò abbia per lo più pertinenza solo con il fenomeno ma non valga per l’essenza, e abbia validità solo in relazione a quel sogno di un’ombra rappresentata
dall’uomo mortale e caduco, ma non per la specie, che eterna non muore mai,
e per la quale non sussiste pericolo alcuno, allora non v’è in realtà tragedia né
tragico né vero pericolo per la sostanza dell’essere umano. Basta che questi
sappia riconoscerlo, e che, utilizzando la conoscenza come strumento di liberazione dalla volontà, finisca per affrancarsene completamente, e tutto sarà
risolto. Il genio artistico solo in parte, il santo del tutto, compiono questo processo di affrancamento, che libera anche definitivamente l’individuo dalla servitù della conoscenza nei confronti della volontà stessa. L’illusione ulteriore che
SAGGI
tato di una molteplicità infinita di differimenti incrociati, reciprocamente interagenti e retroagenti. Perfino uno scopo soggettivo o una qualsiasi finalità che la
coscienza si ponga richiede almeno differimento dei piaceri più immediati, la
cui soddisfazione indiscriminata ostacolerebbe ogni progettualità, lasciandola
del tutto racchiusa nel presente attuale.
In ogni caso, Schopenhauer riconosce perfettamente tutto ciò affermando
che:
19
sta dietro a tali riflessioni è palese. Si tratta –ripeto– della fede che sia sufficiente una conoscenza, in tal caso un processo seppur complesso di riconoscimento, affinché sia possibile la liberazione dalla volontà, mentre piuttosto la
conoscenza rende per lo più molto difficoltosa qualsiasi possibilità di affrancarsene realmente. Al massimo, la conoscenza può talvolta attenuare la forza
degli impulsi primari della volontà, ma mai dissiparla completamente. Essa piuttosto si mette al servizio della volontà, quantunque possa anche rendersi parzialmente autonoma nei suoi confronti, in un modo analogo a cui tra la forza e
la forma si dà al contempo relativa dipendenza e reciproca autonomia.
20
G.W.F. HEGEL, Estetica, trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Einaudi, Torino 1976, p. 80.
S. GIVONE, Storia dell’estetica, Laterza, Roma-Bari 1988, p. 85.
3
A. SCHOPENHAUER, Supplementi al “Mondo”, trad. it. di G. De Lorenzo, Laterza, Roma-Bari
1986, p. 600 sgg. Citato, in seguito, con la sigla S.
4
A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. it di N. Palanga, a cura
di G. Riconda, Mursia, Milano 1991, p. 334. Citato, in seguito, son la sigla M.
5
Citato da F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 1972, p. 31. Cfr. E.
SEVERINO, Socrate, il Sileno e la virtù, in Oltre il linguaggio, Adelphi, Milano 1992, p. 119 sgg. Si
veda anche M. RUGGENINI, La saggezza del Sileno e la meraviglia della filosofia, in Filosofia ‘92,
a cura di G. Vattimo e M. Ferraris, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 117-144.
6
Cfr. Memoria, testimonianza e fine della cultura, in Atti del convegno su Memoria, cultura e
differenza, a cura di L. Bottani, 24-25 novembre 2000, Mercurio Edizioni, Vercelli 2003.
7
Cfr. il mio Dalla ferita mortale alla ricomposizione dell’infranto, in L. BOTTANI, La ferita mortale e il perdono, Tirrenia, Torino 1996, p. 9-29. In realtà si tratta di riflessioni che ho sviluppato diffusamente anche in altri miei lavori: Differire la morte, Mercurio Edizioni, Vercelli 1997 e Cultura e
differimento, Tirrenia, Torino 1999.
8
Adelphi, Milano 1983.
9
Si veda il II Capitolo, Una verifica in relazione a Schopenhauer, del mio già citato Cultura e
differimento, pp. 167-200.
10
Cfr. la Sezione C, dal titolo Sapere la morte, differire la morte, del mio Differire la morte, cit.,
pp. 201-272, soprattutto le pp. 207 sgg.
1
2
PER UNA SEMIOTICA FENOMENOLOGICA
DELLA PERCEZIONE
1. Un’esaustiva, benché breve, fenomenologia della percezione richiede la
disamina di due problemi1: il problema di come avvenga effettivamente
l’“andare oltre l’informazione data”, ed il problema della presunta segmentazione del continuum percettivo ad opera dell’originaria struttura figura/sfondo,
ovvero il problema dell’effettiva sussistenza di una tale struttura.
Storicamente, si è considerata la totalizzazione o come il risultato di giudizi
inconsci (Helmholtz), o come il risultato di fattori strutturali percettivi alinguistici come la “chiusura” e la “pregnanza” (la Gestalt), o come il risultato di un’integrazione linguistica (come nella prospettiva di Bruner o nella ipotesi SapirWhorf, tutto sommato riedizioni dell’intellettualismo helmholtziano). Ora, si tralascerà qui di considerare la prima e la terza prospettiva in quanto prospettive
propriamente dualistico-sintetiche2; si considererà, invece, esclusivamente la
seconda prospettiva, in quanto essa ha di mira l’isolamento di fattori esclusivamente percettivi, mai riducibili all’operare linguistico, che segmenterebbero
(?!) originariamente il campo percettivo.
Le più forti argomentazioni tra gli autori gestaltisti a favore dell’alinguisticità dei fattori che segregano il campo percettivo, producendo la totalizzazione,
possono essere rinvenute in Kanizsa3. L’autore, però, installa la sua argomentazione sull’accettazione di un dualismo qui inaccettabile, quello eretto tra
il “processo primario”, percettivo e preattentivo, che fornisce le unità segregate percettive eventualmente processate ed elaborate poi dal “processo secondario”, cogitativo, ossia classificante e sintetizzante. Non a caso l’autore si riferisce qui al primo Neisser4. Chiaramente, però, Kanizsa rifiuta di estendere le
leggi che operano nel processo secondario, e che producono le processualità
di sintesi che categorizzano i percetti, anche nel processo primario5; preoccupazione evidentemente valida se sin dall’inizio ci si sia illusi sulla reale sussistenza della diversità tra i due processi e, soprattutto, se ci si sia illusi sulla
natura processuale-elaborante del pensiero. Questi i presupposti generali di
Kanizsa, qui inaccettabili.
L’autore, poi, distingue quattro modi di andare oltre l’informazione data,
due per il processo secondario (il riconoscere e l’identificare, in cui un oggetto è assegnato ad una classe di oggetti o “categorizzato”, e l’inferenza in
senso stretto, cioè la realizzazione di figure totali di ragionamento a partire da
alcuni elementi o premesse), e due per il processo primario: il sistema percettivo, infatti, elabora e organizza innanzitutto gli stimoli prossimali elementari
che cadono sull’organo percettore, trasformando dei dati in forma atomistica
in un certo numero di unità segregate (ipotesi qui rigettata perché extrafeno-
SAGGI
di Anselmo Caputo
21
menologica); in secondo luogo, vi sono tutti i casi di totalizzazione percettiva,
o interpolazione, che può essere modale, cadere cioè nell’ambito di un modo
di percezione (visivo, acustico, ecc.), ovvero amodale, casi cioè in cui si vivono delle totalità percettive nelle quali la presenza percettiva non si realizza in
alcun modo sensoriale6; sono questi i casi, molto più numerosi dei precedenti, che qui ci interessano e che si sono già discussi nel nostro articolo precedentemente citato. L’importanza dei casi di completamento amodale per la vita
percettiva è dichiarata dall’autore con le seguenti parole: “Dunque il sistema
ottico colma sempre delle lacune, va sempre oltre l’informazione data,
mediante l’interpolazione percettiva. Questa non va considerata come un
fenomeno soltanto interessante, curioso o degno di nota ma, al contrario, va
considerata un fenomeno che nel campo visivo è la norma, un fatto universale che si verifica ogniqualvolta ci troviamo di fronte a un campo organizzato in
figura e sfondo, ogniqualvolta esista un oggetto fenomenico”7. La peculiarità
dei fattori di segregazione nel processo primario sono enucleate attraverso
l’impiego di figure come quelle che seguono:
22
Ora, secondo Kanizsa, la “logica” con cui l’apparato percettivo procede alla
totalizzazione di queste esperienze non è la stessa che si ha nel pensiero inferenziale8. Implicita è qui l’assunzione della diversità tra la percezione, il pensiero e il linguaggio, tre ambiti diversi della vita di coscienza, in cui la cesura
più evidente si situerebbe a limite tra la percezione e le altre due forme di vita
coscienziale. In particolare il meccanismo con cui la percezione procederebbe
alla totalizzazione sarebbe non immaginato, ottenuto assolutamente senza
alcuno sforzo da parte del percettore, senza che questi, in altre parole, debba
elaborare con concetti o inferire qualcosa da qualcosa d’altro: se, infatti, argomenta l’autore, della figura precedente, si forniscono solo gli elementi base, ad
es. le sole sei righe in diagonale omettendo di esse i tratti che coprono le parti
del cubo, mai il processo secondario sarà in grado di costruire qualcosa di percettivamente simile o identico a detta figura9. Così leggiamo nel testo: “Tutte le
situazioni hanno questo in comune: quelle interpolazioni di parti mancanti tra
elementi dati che riescono facilmente, anzi coercitivamente, sul piano percettivo, non si verificano quando gli stessi elementi di base dovrebbero venire
integrati mediante inferenze “nel pensiero”. Tali interpolazioni visive obbediscono a loro precise regole, che non possono venir modificate dall’intervento
Ebbene, secondo le sue argomentazioni, solo la prima figura avrebbe conseguenze funzionali, ossia solo in essa l’apparato percettivo si sentirebbe
coercitivamente indotto a “proseguire oltre” l’informazione data in modo puramente percettivo, mentre la seconda figura farebbe testimonianza di una
“mancanza” sentita non a livello funzionale, ma solo concettuale: che in questa manchi un occhio, è cosa solo immaginata, pensata, non anche vista: la
figura, in un certo qual modo, sarebbe completa, passibile di sussistere percettivamente per se stessa11.
L’assunzione implicita che regge queste argomentazioni, oltre all’implicito
e frettoloso accostamento di pensiero e linguaggio, è che è impossibile che nel
pensiero, e tantomeno nel linguaggio, si verifichi lo stesso tipo di coercizione
ed immediatezza presenti nei processi di totalizzazione percettiva. Così, per
es., di fronte allo stimolo visivo PS.COL.GIA, che leggiamo con facilità come
PSICOLOGIA, non avremmo mai delle conseguenze funzionali, in quanto vi
sarebbe solo una interpolazione o completamento cognitivo, e non anche
un’interpolazione percettiva12. L’argomento, a noi sembra, è abbastanza capzioso, giacché, come nell’ultima esemplificazione, l’autore usa degli artifici
percettivi ad hoc per corroborare, mediante un caso specifico, una presunta
regola generale. Ora, oggetto di percezione può anche essere il seguente:
pscologia, vale a dire una parola, scritta normalmente, senza aggiungervi dei
punti al posto delle lettere mancanti –punti che evitano di per sé ogni effetto
funzionale–, la quale, in un qualsiasi contesto può fuorviare innumerevoli volte
qualsiasi lettore circa la sua correttezza: solo un correttore di bozze, infatti, è
in grado di accorgersi subito della mancanza di una lettera, il che vuol solo dire
che un lettore qualsiasi, spinto dalla totalizzazione, molte volte può leggere la
parola come se fosse scritta giustamente. È evidente che anche in questo
SAGGI
di operazioni inferenziali nel processo secondario […] In questo consiste la
profonda differenza tra i due modi di andare oltre l’informazione data: nel processo secondario andare oltre l’informazione non si traduce mai in un effetto
veramente percettivo, “visibile”, non ha conseguenze funzionali ”10.
Secondo l’autore, quindi, la totalizzazione nel processo primario ha la
caratteristica di essere coercitiva, immediata, conseguente a regole immodificabili rispetto alle leggi del pensiero, e, soprattutto, ha sempre conseguenze
sul piano funzionale, ossia sul piano dei “vissuti” psichici. Si prendano, infatti,
in considerazione questi altri due esempi figurali apportati da Kanizsa a sostegno delle sue tesi:
23
24
caso si sono avuti degli effetti “funzionali”, giacché la parola “pscologia” molte
volte può essere letta in un contesto di parole corrette come “psicologia”. In
secondo luogo, sfidiamo qualsiasi lettore a dire immediatamente che, nelle
figure dei due volti, solo la prima si completa amodalmente in senso propriamente visivo, e a dire che nella seconda, sempre da un punto di vista visivo,
non si “riceva alcun pugno nell’occhio”. Personalmente, se la cosa può avere
interesse, si vive un senso di spaesamento immediato in entrambe le figure,
con un altrettanto bisogno immediato di completamento figurale; e la cosa
rimarchevole è qui che, nella seconda figura, il bisogno di completamento, noi,
non lo si vive a seguito di un lasso di tempo più ampio di quello intercorrente
all’occorrere della prima figura –cosa che potrebbe essere interpretata come
presenza di processi centrali, cognitivi, di categorizzazione– ma con la stessa
immediatezza temporale13. In terzo luogo, è improponibile pensare che l’immediatezza del completamento amodale visivo sia il paradigma del completamento amodale percettivo tout court: se noi, in particolare, leggiamo pscologia
nel modo giusto, mentre è scritta evidentemente in modo errato, per quale
motivo il completamento amodale deve essere ritenuto agente solo a livello
visivo, come se il senso di ciò che si vede fosse estrinseco ad esso? Si consideri, per es., una partita di pallone, magari della nostra nazionale: la nazionale vince due a zero davanti a milioni di telespettatori e davanti a migliaia di
spettatori oculari: metà di questi spettatori affermano che, pur vincendo, la
nazionale “non ha giocato bene”, mentre gli altri affermano “che ha giocato
bene”: i primi dicono quanto dicono avendo in mente l’ideale del calcio aggressivo, a zona, sempre proteso verso il risultato utile, i secondi, invece, avendo
in mente l’ideale del calcio “all’italiana”, attento in difesa e furbo nel ripartire in
contropiede beffando gli avversari; ebbene, si può forse dire in questi casi che
i significati “giocare male” e “giocare bene” non vengono propriamente “visti”
dagli spettatori, visto che giocar bene per un “zonista” non è giocare all’italiana e che per un “italianista” non è necessariamente giocare a zona? È più
opportuno dire, invece, che quei significati vengono visti, non nel senso che gli
spettatori li usano come lenti per interpretare ciò che vedono, ma nel senso
che sono indissociabili da ciò che si svolge loro innanzi, ché anzi sono proprio
ciò che si svolge loro innanzi. “Vedere” in questo senso include degli aspetti
funzionali che Kanizsa non considera tali, ma che, a meno che non si abbracci un’epistemologia dualista, vanno considerati come direttamente percepibili:
il completamento amodale, infatti, avviene anche in quest’ultimo caso, visto
che il significato “giocare bene” è altrettanto un’assenza, sebbene di genere
diverso (ma non di natura diversa), dell’assenza vivibile come nell’esempio
della prima figura di volto. A noi sembra che l’argomentazione di Kanizsa si
regga sul tradimento inconsapevole dello spirito della Gestalt, ossia sul mantenimento di un senso ristretto, associazionista, della parola “senso” e delle
parole “organo di senso”, come se, cioè, ad ogni specifico organo di senso
dovesse corrispondere un preciso fascio di nervi quali canali in cui scorrono
solo certe sensazioni e non altre: così nel canale ottico, scorrerebbero impulsi elettrici convertibili solo dalla retina ed infine da specifiche sezioni del nostro
cervello, e non anche “significati” o affordances nel senso di Gibson; e così via
di essa sappiamo che è una figura reversibile, nel senso che il lato che una
volta può figurare in primo piano, di soppiatto può essere risucchiato sullo
sfondo; ora, se noi si considera la figura nel lato che emerge in primo piano,
di essa, di quel lato, non abbiamo in realtà alcun tratto che possa dirsi privilegiato a tal punto da essere dominato da parte a parte nei suoi più infimi particolari; così, se noi operiamo una prescissione tematica in quel lato, considerando attentivamente il tratto seguente:
SAGGI
per gli altri sensi. Chi ha stabilito, infatti, che il linguaggio nella sua interezza,
immensa interezza, caratterizzabile con un concetto che qui non può essere
al momento ulteriormente chiarito, come “sistema di delocalizzazione o decentramento dell’eccentricità del corpo” (soprattutto del cervello), come sistema di
significati, non sia un senso di cui la tradizione filosofica, scientifica, psicologia, medica, mai ha avuto sentore?
2. Ora, il fenomeno della coercitività del completamento amodale, su cui
Kanizsa insiste tanto per poter tracciare il discrimine tra pensiero, linguaggio
e percezione, può trovare chiarificazione attraverso l’enucleazione di un primo
grado di semiosi percettiva, chiarificazione, mercé la quale, fenomeni ritenuti
cognitivamente “superiori” come la significazione, vengono introdotti negli
stessi fenomeni percettivi, tradizionalmente ritenuti “inferiori”.
Sotto condizioni cinestitiche14 normali, l’apparato cinestetico-percettivo si
trova, in una qualsiasi scena percettiva, in una posizione fenomenologicamente assai importante: nessun tratto di tale scena può dirsi dominato per
intero, per quanto infinitesimale possa essere tale tratto. Se guardo il mio volto
allo specchio mentre mi rado, condizione per dire di vedere il mio volto, è che
nessuna parte di esso sia, come è di fatto, dominata per intero, come se lo
sguardo potesse distribuirsi e catturare dei punti matematici assoluti in ciò che
ha di mira. Se, in particolare, ho di mira l’espressione del mio sguardo, lo
posso fare, come si noterà più in là, proprio in quanto non posso guardare
direttamente gli occhi, o dominare ogni più infimo particolare di essi: se fisso
un occhio, perdo l’espressione dello sguardo, senza, d’altro canto, poter dominare l’occhio in ogni più piccolo particolare. Si consideri la seguente scena
percettiva, classica nella Gestalt:
25
26
ovvero considerando una parte ancora più piccola di questo particolare, questa
medesima parte non è mai un punto matematico assoluto, dominato percettivamente, ma sempre un campo, per quanto piccolo esso sia. Possiamo andare avanti in questa regressione fino ad un certo grado in cui è ipotizzabile un
minimum visibile, la cui caratteristica essenziale, comunque, è quella di dover
essere sempre un campo. L’essenziale delle scene percettive, quindi, in quanto campi, è quello di essere, sotto ogni aspetto, delle entità non soggette all’afferramento dello sguardo, tali da conservare anche nelle parti tradizionalmente
ritenute “in primo piano” o ritenute cadenti nel Kern della percezione15, una
natura sfuggente, afferibile, entro un certo grado, allo statuto dello sfondo: se
noi infatti si guarda ad una parte del lato emergente del cubo prima presentato, senza farsi lasciare trascinare dalla naturale tendenza percettiva a dire che
noi si percepisce effettivamente un nocciolo duro della cosa –ben messa a
fuoco– e badiamo ad un tratto magari centrale di esso, ci accorgiamo che i tratti appena limitrofi di questa parte tenuta al centro dello sguardo hanno lo stesso statuto del lato sullo sfondo; e così anche per un’ulteriore parte più centrale
di quella parte del lato emergente: troveremo insomma in qualsiasi parte ritenuta al centro del fuoco percettivo sempre delle componenti, praticamente
tutte, che somigliano, quanto al loro statuto interno, più al concetto tradizionale di sfondo che al concetto tradizionale di primo piano, o Kern percettivo, o
figura percettiva16. Ancora un esempio: guardiamo alternativamente una persona posta a pochi metri da noi ed un albero poco dietro quest’ultima: guardando la persona, l’albero è sullo sfondo, mentre, si dice, la persona è nel nocciolo della percezione, ossia ha uno statuto che la distingue intrinsecamente dallo
sfondo stesso; essa sarebbe infatti più compatta, fermamente contornata, più
simile ad una cosa rispetto allo sfondo, il quale assumerebbe un carattere quasi
impalpabile. Ebbene, nostra convinzione è che non sia sempre effettivamente
così, almeno difficilmente le cose stanno in questi termini nelle condizioni cinestetico-percettive “da fermo” del percettore: se guardiamo la persona, non solo
l’albero è sullo sfondo, ma anche gran parte di ciò che di essa non cade al centro del mio sguardo; così le sue gambe, parti delle braccia, del bacino, del torace, posto che si guardi la sua testa, hanno lo stesso statuto percettivo dell’albero sullo sfondo. Non solo: della stessa testa, che noi si ha al centro tematico
percettivo, niente è così particolarmente privilegiato da essere una cosa individuale di contro ad un indifferenziato sfondo della testa stessa; supposto che noi
si guardi al solo naso, tutte le sue componenti avranno lo stessa natura di sfondo dello sfondo per eccellenza che, in questo caso, è rappresentato dall’albero. L’effetto-Kern o effetto-figura che l’apparato cinestetico-percettivo fenomenologicamente vive è dovuto, noi crediamo, ad un effetto del contorno, contor-
SAGGI
no che a sua volta si rende possibile, per la particolare posizione della testa del
percettore, orientata in genere lungo la bisettrice che conduce il suo sguardo
perpendicolarmente verso il soggetto visto. Ma il contorno, in certo qual modo,
mente sulla natura intrinseca di ciò che è contornato: mente in particolare sul
suo carattere “gessoso”, di contro al carattere impalpabile dello sfondo. In realtà, l’impalpabilità tocca, in queste condizioni cinestetiche, anche ciò che è all’interno del contorno stesso.
La cosa si rende possibile in quanto l’intenzionalità intrinseca dei percetti,
che qui è appunto il primo grado della semiosi, intenzionalità o semiosi che
disegna il grado più immediato, inconsapevole della percezione, è quella volta
non al concentramento del percetto stesso in effettive emergenze, noccioli o
figure percettive, secondo forze psichiche che dalla periferia contornante del
percetto vadano verso il centro dello stesso; ma secondo forze esattamente
contrarie a queste –e che proprio per questo producono l’effetto contornante–
le quali, pertanto, dal centro del percetto vanno verso la periferia. Percepire è
quasi creare un inconsapevole effetto tunnell, alla maniera che segue:
27
secondo delle forze, però, che procedono in questo senso:
e non in questo senso:
Il percetto ha questa intrinseca intenzionalità che ne produce la natura
semiotica proprio in quanto essa è la scaturigine o l’origine di ogni processo di
integrazione amodale o totalizzazione. I gestaltisti, come Husserl, i quali si
sono convinti che le forze di ogni primo piano percettivo siano come quelle
esemplificate qui nella seconda figura, hanno potuto credere questo in quanto fuorviati dall’effetto immediato nelle figure reversibili dello scorrere di uno
sfondo dietro una parte emergente: in particolare, grazie a quest’effetto, e se
28
la cosa viene assunta acriticamente, come di fatto avviene nella percezione
quotidianamente atteggiata, ogni emergenza sembra effettivamente un
costrutto volto alla concentrazione del percetto.
3. Tutto questo discorso, che pone in evidenza il primo grado fenomenologicamente inconsapevole della semiosi percettiva, si noterà, si incrocia o
implica la cosiddetta struttura figura-sfondo (sulla cui importanza nella letteratura psicologica e semiotica non ci dilunghiamo). Per cui viene spontaneo
chiedersi: sussistono sempre, in ogni circostanze cinestetico-percettive, delle
strutture figura-sfondo? Ovvero: sussistono sempre, in ogni circostanza cinestetico-percettiva, delle figure o noccioli percettivi, come una lunga tradizione
psicologica, gnoseologica e semiotica vogliono farci credere?
La precedente discussione ci ha fatto intravedere che già nelle condizioni
cinestetico-percettive “da fermo” è più che discutibile accordare alla figura il
carattere di “gessosità”, di nocciolo; ma per vedere fino a che punto questo
carattere della figura sia da ricusare e fino a che punto sia da accogliere, bisognerà discutere brevemente tutti o gran parte dei casi di “doppia rappresentazione” implicanti la struttura di cui si è fatto discorso. Della rappresentazione
in generale –parola con la quale intendiamo il semplice porre-innanzi un
oggetto, e quindi niente di mentalistico– possiamo distinguere vari gradi.
Il primo grado della rappresentazione, grado impropriamente rappresentativo, in quanto in esso niente vi figura sotto un certo contorno tematico, benché le cose appaiano sempre e comunque come cose individuali, discrete,
dotate di confini netti, è quello in cui manca, appunto, un oggetto posto-innanzi, contornato; nell’esperienza percettiva che si va qui a descrivere, posto
innanzi è propriamente soltanto il campo visivo stesso: ci si riferisce in particolare all’esperienza percettiva, riferita alla visione, dello sguardo nel vuoto,
ossia di quello sguardo chiamato comunemente “assente”, che si ottiene
quando la percezione non è diretta verso un singolo oggetto ed in genere
quando si è assorti in pensieri. In questo caso l’intero campo percettivo è vissuto alla stregua di un omogeneo sfondo, benché, lo si ripete, esso sia già uno
sfondo oggettivo, uno sfondo in cui, cioè, gli oggetti sono già ritagliati, uno
sfondo che mai assomiglia ad un mero sfondo causa di stimoli caotici per sensazioni caotiche.
Nel secondo grado della rappresentazione rientrano tutti i casi che, in
generale, sono disposti asintoticamente verso l’effettiva presentazione di
nuclei o figure percettive. In questo grado della percezione, le condizioni cinestetico-percettive cambiano notevolmente, dipendendo infatti l’effettiva ostensione di nuclei percettivi dalla maggiore velocità di movimento del percettore
o dalla velocità di movimento della cosa percepita. Rientrano i casi della percezione in movimento e i casi della percezione del movimento: per es., viaggiando in macchina o in treno e guardando fuori dal finestrino o un oggetto lontano o uno vicino, più la velocità del mobile è alta, più è evidente che, se noi
si cerca di catturarlo con lo sguardo, esso assurge appunto a cosa o oggetto
nel senso quotidiano del termine solo in quanto lo si segua con il movimento
della testa, in modo da fissare più o meno stabilmente i suoi contorni. Possono
dirsi le medesime cose nei casi di percezione del movimento, nella percezio-
SAGGI
ne, cioè, di una cosa in movimento: seguendo un uomo o una macchina o
qualsiasi altra cosa in movimento col movimento ulteriore della mia testa, ho
un’esperienza visiva al cui centro si staglia un soggetto circondato da un alone
più o meno indistinto.
Consideriamo il terzo grado della rappresentazione. Con esso si abbandona gradualmente l’estremo delle esperienze che tendono asintoticamente
all’effettiva presentazione di nuclei percettivi. Vi rientrano casi in cui nel campo
percettivo vi è un “centro” di maggiore differenziazione solo per la posizione
cinestetica della testa del percettore, ovvero delle sue mani nel caso del tatto.
Di conseguenza, solo nelle figure ambigue, è possibile vivere un senso dell’emergenza direi “puro” di qualcosa che si pone innanzi rispetto a qualcos’altro.
Parlare di emergenza (come nella Gestalt o in Husserl), infatti, significa pensare che le forze percettive tendano a produrre in corrispondenza di essa
un’area psichica del vissuto simile ad una figura convessa, mentre, lo ripetiamo, è questo il caso –peraltro limitato alla subitaneità della doppia rappresentazione– delle sole figure ambigue o dei casi di percezione estrema del movimento o in movimento. In casi statisticamente molto rilevanti della vita cognitiva del singolo, invece, ciò che è posto al centro tematico della coscienza
tende ad assumere una disposizione più simile ad una figura concava, conformemente alla tendenza naturale della percezione ad assomigliare più alla
creazione di un effetto tunnell, all’ “aprirsi un varco”, al “farsi largo”, che all’afferramento ed al concentramento in nuclei. Percepire, in generale, non significa creare dei piccoli promontori di vita psichica, ma esattamente l’opposto,
ossia creare piccole depressioni, la cui sussistenza, comunque, rimane per il
percettore in gran parte latente. È questo soprattutto il caso del presente
grado della rappresentazione; grado nel quale possono essere compendiati
altri esempi tipici di percezione: la percezione di un volto umano, della sua
espressione e, più in generale, di tutto quanto è espressivo, non significa ritagliare un continuum indifferenziato dell’esperienza, sì da avere quel volto e la
sua espressione in una posizione privilegiata rispetto a quant’altro compaia
percettivamente; si percepisce un volto e la sua espressione in quanto nessun
particolare di esso, per quanto possa essere piccolo, è dominato dal mio
sguardo da parte a parte.
Giungiamo così al quarto grado della rappresentazione, grado che preannuncia un fatto veramente particolare, di cui si è fatta menzione in un precedente articolo17. Fatta in quel luogo ricusa dell’asignificanza degli “stimoli” percettivi nel loro abituale agire, come esigita da Meyer18 autore, accettabile rimane il rilievo dell’autore per cui ogni volta che il decorso percettivo normale è
interrotto il significato balza alla coscienza; ripetiamo che qui la cosa deve
essere intesa non nel senso che il significato si costituisca contestualmente a
questa esperienza, ma nel senso che di norma esso funge in maniera anonima, silente, frutto com’è della sedimentazione19. Il mondo percepito, lo strato
linguistico percettivo, infatti, è costituito da significati che, per via della sedimentazione, si solidificano in regole percettive, che, per dirla nel comune
quanto impreciso linguaggio psicologico, “tipizzano” o “categorizzano” l’esperienza stessa. Ora in questo grado della rappresentazione possiamo rinvenire
29
tutti i casi, tanto cari alla letteratura gestaltista, delle cosiddette “figure ambigue” o “reversibili”. Il motivo per cui tali fenomeni vengono appresi per “salti di
forma” sta nella peculiarità con la quale essi agiscono sul rapporto segnico
stesso, ossia sulla medesima sedimentazione, o meglio nel fatto che
30
rendono accessibile solo in parte, ossia per un attento spettatore, l’agire e il
costituirsi dei segni percettivi secondo la dinamica del riferimento al passato
chiarita in quel nostro articolo. Di essi va comunque precisato che possono
assurgere a eventi paradigmatici sotto l’aspetto appena ricordato, per il fatto
che, in genere, sono dei fenomeni creati ad arte, standardizzati e molto poveri
al lume dell’esperienza quotidiana; nondimeno, anzi proprio per questo, rendono per un momento accessibile come, nell’esperienza quotidiana, si costituisca
il rapporto segnico percettivo. In genere, infatti, il massimo della complicatezza
di queste figure può essere offerta dai manichini nelle vetrine dei negozi o dalle
statue di cera nei musei; per il resto, che esse siano delle anatre/conigli/antilopi, dei cubi, delle croci ecc., rimane il fatto che offrono una scena percettiva non
realistica per via del relativamente alto grado interpretativo che contengono: un
perfetto disegno di anatra, per es., o un perfetto disegno di coniglio, o un perfetto disegno di un cubo, danno molto difficilmente luogo a questi salti di forma
(vedi e confronta la figura precedente e quella che segue).
In ogni caso essi sono fenomeni fenomenologicamente rilevanti perché,
come detto, fanno balzare in parte alla coscienza il movimento di costituzione-sedimentazione dei segni percettivi, nonché il loro intero ciclo cognitivo.
SAGGI
Di regola, di norma, i significati percettivi, che hanno appunto un alto grado
di cogenza normativa, si sedimentano costituendo uno sfondo, la cui
ampiezza allargare è il vero scopo cognitivo della percezione; nelle figure
percettive ambigue, lo stupore e la meraviglia che ci prende al loro cospetto, insorge per il fatto che esse ci inducono alla loro considerazione sotto la
specie della regola percettiva e non anche del semplice fenomeno percettivo. Benché inconsapevolmente, il soggetto, che nella vita normale vive le
regole percettive in modo pratico-immediato, è disposto in queste esperienze a vivere le regole percettive qua regole. Le esperienze qui ad oggetto
sono infatti il paradigma di quanto avviene di norma in maniera anonima
nella mente del percettore: esse inducono ricorsivamente a riaggiustare l’ordine consueto di scorrimento delle regole sedimentate. Per cui, rammentando quanto sopra si disse, ossia il fatto che funzionalmente ciò che cade sotto
il senso non è assolutamente solo un “materiale” di sensazioni specifico ad
un canale di trasmissione, ma anche ciò che in senso tradizionale può dirsi
propriamente non percepibile, diviene chiaro che, nella fattispecie, il “non
percepibile” è qui la scena percettiva vissuta qua regola, e diviene altresì
chiaro che tale “non percepibilità” che normalmente occupa il polo più lontano della vita di coscienza, ossia lo sfondo, diviene chiaramente il polo più
prossimo. Noi viviamo la regola percettiva in quanto regola, quando normalmente la percepiamo senza esser coscienti del suo fungere da regola, da
binario che guida le nostre esperienze di totalizzazione. Queste esperienze,
infatti, tendono a riconsolidare, rivedere, riordinare l’ordine di scorrimento
delle mappe percettive, a riconsolidare cioè il fungere silente o la sedimentazione di esse, in un movimento di riproposizione che tende a ristabilire il
loro essere sfondo. Ciò che si vive come labilissimo nocciolo percettivo è il
riaggiustamento dell’ordine di scorrimento delle mappe percettive già consolidate, cosa che induce al salto gestaltico.
Queste esperienze segnano con ciò il limite verso il rovesciamento delle
comuni acquisizioni in materia di doppia rappresentazione, ossia verso il
quinto grado della rappresentazione. Finora, dalla letteratura fenomenologico-gestaltista siamo stati abituati a pensare la figura come stagliantesi sempre davanti allo sfondo, di modo che il polo più prossimo nel tema di coscienza doveva essere sempre la figura o il nucleo percettivo, mentre il polo più
remoto doveva essere lo sfondo. Cosa in generale valida per la doppia rappresentazione. Vi sono casi, però, considerati a latere dalla letteratura gestaltista, o non considerati nella giusta maniera, in cui la corrispondenza di cui
sopra viene clamorosamente a mancare, anzi viene ad essere rovesciata, nel
senso che quanto è sullo sfondo assume addirittura i caratteri di nocciolo o
figura e quanto è in primo piano assume i caratteri dello sfondo. Circostanza,
questa, inaccettabile per i gestaltisti. Esperienza appartenente a questo
grado può essere la seguente: durante la lettura di un libro o di un giornale,
o durante la stesura di un testo scritto, si vengono a creare del tutto a caso
degli spazi di battitura e interlineari che, per diverse righe, si ordinano in una
determinata direzione; la cosa può accadere, oltre che con gli spazi di cui
sopra, anche con lettere alfabetiche simili o identiche che si ordinano sempre
31
riga per riga, una sotto l’altra, in una determinata direzione, ovvero seguendo anche un decorso sinuoso. Di regola accade che, sotto la condizione del
tipo di stampa del carattere, sia le lettere che gli spazi che si prolungano per
più righe verso un’unica direzione siano, a volte anche sensibilmente, più
chiare e differenziate se il nostro interesse tematico si discosta da esse, mantenendole, come nel precedente caso, in una zona mediale tra la periferia ed
il centro del campo percettivo. In queste condizioni, è tuttavia certo che nel
primo piano del campo non sono presenti simili figure casuali; eppure esse
appaiono spessissimo molto più evidenti allorquando sono appunto sullo
sfondo. Certo esse possono essere percepite anche se poste al centro di
quest’ultimo, risultando però molto meno “dense” e “gessose” di quando sono
intraviste con la “coda dell’occhio”.
Kanizsa ne ha trattato ampiamente, considerando tali figure come “figure
dal contorno senza gradiente”, dandone degli esempi iconici anche molto perspicui, quali quelli che seguono20:
32
Nonostante l’autore rilevi che “Esaminando le figure […] si nota che nel
punto dove una linea con gradiente interseca il margine senza-gradiente quest’ultimo sparisce, come sparisce quando lo si fissa attentamente”21, e pur
riconducendo tali fenomeni al generale operare della figura/sfondo, il non aver
dato priorità nella vita percettiva, come già fece Rubin, alla struttura
Kern/Hintergrund rispetto a quella Figur/Grund, induce lo stesso a non accorgersi in generale che tali contorni, a meno che non si voglia restringere il concetto di figura in modo sì ristretto da comprendere solo le figure classiche,
sono delle figure, e che lo sono soprattutto quando si situano nello Hintergrund
SAGGI
dello sguardo. L’autore medesimo rimarca, infatti, nei casi come quelli del
triangolo, che il lato senza gradiente sparisce quando lo si fissa, mentre ricompare quando non lo si attenziona. In realtà, tali esempi figurali, testimoniano
che nella vita cognitiva di coscienza è possibile tutta una serie di esperienze
che rovesciano la normale corrispondenza figura-primo piano e sfondo-superficie posta dietro.
La cosa poi, non avviene nel senso che, alla rovescia, l’apparato cinestetico-percettivo proponga comunque dei nuclei percettivi: quelle figure,
quei contorni, quella nuvola di cui prima si parlava, hanno sì un’esistenza più
stabile se posti sullo sfondo della coscienza, ma assumono una veste più
simile ad un nocciolo solo per l’estrema indifferenziazione del primo piano,
rimanendo in gran parte fenomeni di sfondo un poco più strutturati dello
sfondo tout court.
Quale sesto ed ultimo grado della rappresentazione può essere considerata la possibilità, così poco comune, che l’appartato cinestetico-percettivo
sia sottoposto ad un tale stress da non poter offrire che uno sfondo indifferenziato. Si tratta di un caso limite, nel quale comunque siamo riluttanti a
vedere la possibilità di un mero sfondo di stimoli caotici, riproducibile ruotando fortemente su se stessi, ovvero su un mobile fatto sempre ruotare a
fortissima velocità.
4. Possiamo dire che l’operare della struttura Kern/Hintergrund è certamente universale, ma a patto di una forte relativizzazione dei casi in cui si può
effettivamente usufruire di nuclei o figure percettive. Più giusto sarebbe parlare di una doppia rappresentazione che tende alternativamente alla presentazione di sfondi rappresentati (cioè posti-innanzi) tendenti asintoticamente
all’assunzione delle fattezze di nuclei percettivi solo sotto condizioni di “stress”
per l’apparato cinestetico-percettivo medesimo. Condizioni che compendiano:
la forte velocità del mobile oggetto di percezione, ovvero la forte velocità
assunta dal percettore stesso, ovvero la tendenza alla congruenza del campo
comportamentale col campo geografico: più, infatti, un oggetto percettivo
tende ad essere comportamentalmente e geograficamente vicino, più esso
può tendere asintoticamente verso la forma nucleare.
5. Le descrizioni fenomenologiche vertenti sulla struttura nocciolofigura/sfondo sinora compiute, hanno l’intenzione di ridurre il fattore principe di
strutturazione dei campi percettivi a fattore linguistico. Più in generale, è
nostra intenzione ridurre ogni fattore di strutturazione del campo a fattore linguistico. I gestaltisti, oltre alla figura/sfondo, elencano tra tali fattori anche la
vicinanza, la somiglianza, la continuità di direzione, la direzionalità e l’orientamento, la chiusura, la coerenza strutturale e la pregnanza e, solo per ultima,
l’esperienza passata; ora, si penserà che ridurre tali fattori, fattori di pura segmentazione del campo, a fattori linguistici è, oltre che improponibile, anche
impossibile.
In questo lavoro si è già tentato una riduzione in tal senso; seguiremo ulteriormente questa strada, a partire dalla discussione di casi che sembrano clamorosamente escluderla. Kanizsa, Legrenzi, Sonino hanno visto l’irriducibilità
della percezione a linguaggio attraverso esperienze simili alla seguente22:
33
34
A giudizio degli autori, giudizio confortato da esperimenti riportati dagli
stessi, nel linguaggio quotidiano la paroletta sopra ha una naturale priorità
d’uso sulla opposta paroletta sotto; grazie alle esperienze percettive come
sopra in figura, questa priorità può essere neutralizzata, ed anzi rovesciata, in
quanto percettivamente parlando risulterebbe molto più naturale dire che “il
cerchio è sotto il triangolo” piuttosto che dire che “il triangolo è sopra al cerchio” (benché questa affermazione sia comunque possibile)23. A commento di
ciò, così leggiamo nel testo: “Questo privilegiarsi linguistico di sopra rispetto a
sotto può venire completamente annullato da una restrizione percettiva che
agisce qualora vi sia una evidente differenza nelle dimensioni dei due oggetti
[…] Tale restrizione, d’altronde, è presente in molte delle descrizioni impiegate nel corso della vita quotidiana: noi, ad esempio, diciamo che le didascalie
sono sotto la figura e non viceversa dato che di solito la figura è molto più
grande. Analogamente diciamo che l’automobile è sotto il viadotto e non che
il viadotto è sopra l’automobile”24. In altre parole, questo significa che i fattori
di segmentazione percettiva e le proprietà percettive sono indipendenti dal linguaggio, ed anzi motivano le espressioni linguistiche stesse.
Ora, che le percezioni possano motivare le espressioni linguistiche è cosa
che qui si accetta; da qui, però, inferire che le percezioni, o i fattori di segmentazione percettiva, siano indipendenti dal linguaggio è cosa che non può
discendere direttamente dal primo assunto, né può essere qui accettata. La
realtà, infatti, è creduta quotidianamente essere extralinguistica perché, affinché le proposizioni linguistiche dello strato percettivo si avvicendino ed accadano nel campo mentale e comportamentale del singolo, si abbisogna della
motivazione della stessa percezione; ma se posso capire la differenza tra
“rosso” e “blu” solo vedendoli e non basandomi sul senso delle mere parole,
questo non significa che la percezione apporta una componente esclusivamente esperienziale alinguistica alla determinazione del significato; l’esperienza linguistica, infatti, può essere di due tipi, e cioè includere o meno la
componente iletica. Ma quest’ultima componente stessa ha un senso; ora, o
questo senso, ragionando dualisticamente come idealisti e realisti, come qui
ci rifiutiamo di fare, è nella materia iletica stessa (come dire, anche, che gli
stessi neuroni attivati da ogni cosa blu siano essi stessi blu), e la cosa è visibilmente ridicola, oppure dovrà risiedere in un qualche iperuranio immateriale,
e la cosa comporta le difficoltà di ogni platonismo o le difficoltà di ogni trascedentalismo sintetico e di ogni dualismo psicofisico. Il senso dell’esperienza iletica, allora, pur verificandosi a contatto con la cosa o, come si dice, a posteriori, è pur sempre un significato linguistico corrispondente appunto alla
dimensione del senso più che a quella del significato, ma ciò non significa che
SAGGI
l’esperienza iletica non sia già esperienza ismatica. L’esperienza iletica, infatti, riempie un senso linguistico non perché quest’ultimo sia universale nei confronti della sua particolarità, ma nel senso che motiva l’apparizione o l’attualità di un’alternativa di senso che comunque già era presente a priori nell’ismo
di riferimento.
In quel nostro articolo abbiamo visto sussistere una corrispondenza necessaria tra percezione e linguaggio25. Per riesprimerla possiamo usare una metafora che De Saussure applicò al rapporto tra il significante ed il significato della
lingua: “La lingua è ancora paragonabile a un foglio di carta: il pensiero è il
recto ed il suono è il verso; non si può ritagliare il recto senza ritagliare nello
stesso tempo il verso; similmente nella lingua, non si potrebbe isolare né il
suono dal pensiero né il pensiero dal suono”26. Ora, era questa l’assunzione
implicita in ciò che noi lì si diceva, per cui la corrispondenza tra il discreto percettivo e quello linguistico si realizza in una sorta di ritaglio, già sistemato a
priori nel linguaggio, per il quale, stante una determinata percezione vi è un
determinato tratto linguistico che vi corrisponde, ovvero più tratti linguistici corrispondenti, ovvero ancora può capitare che ad un singolo tratto linguistico
corrispondano più tratti interpretativi dello stesso tratto percettivo (come nei
salti gestaltici delle figure ambigue). Percepire, così, per dirla ancora metaforicamente, è come usare della carta carbone, per cui tracciando una riga sul
foglio del discreto percettivo significa di soppiatto tracciare un corrispondente
tratto nel foglio sottostante della lingua: i tre fogli presi insieme sono tre strati
del linguaggio. Presentatasi allora una percezione, è subito ritagliata/e nella
mente la situazione/i linguistica/che corrispondente/i. Lo stesso, d’altro canto,
nel rapporto tra le possibili immagini e mappe mentali con una proposizione
(senza percezione), e nel rapporto tra mappa mentale e percezione (benché,
di norma, tutti questi termini appaiano insieme). In questo senso, la percezione o delimita le possibilità di espressione proposizionale che gli corrispondono necessariamente, ovvero viene delimitata da queste ultime. Nel caso percettivo apportato dagli autori sopra (il triangolo), si verifica la prima tra queste
due possibilità. Ma questo non significa giammai che la scena percettiva non
sia linguistica: che gli autori dicano che un privilegio linguistico di sopra venga
annullato da una restrizione percettiva, non elimina assolutamente la possibilità che la percezione delimiti dal suo stesso interno –secondo un certo grado
interpretativo– le possibilità proposizionali che essa stessa manifesta in forma
iconica e che ritaglia per corrispondenza nel discreto proposizionale. Così, è
più naturale dire, nella figura sopra riportata, che il cerchio è sotto il triangolo,
non per una presunta alinguisticità percettiva, ma semplicemente perché l’icona percettiva delimita dal suo stesso interno le possibilità interpretative linguistiche che si ritaglia a priori. Il fattore strutturale della vicinanza e, in questo
caso, quello dello schema di riferimento funto dalla figura più grande nei confronti di quella più piccola, sono dei fattori visibili immediatamente e del tutto
esprimibili linguisticamente (come ben sapeva Wittgenstein quando affermava
che una proposizione può essere formata, più che da grafemi, da rapporti spaziali tra sedie, tavoli ecc.). Non è vero, quindi, che le costanti logiche siano non
percepibili, o almeno non tutte: lo “e”, per es., funge per la vicinanza27.
35
36
Capita, come nelle figure ambigue, anche il contrario: ossia che una proposizione giunga a delimitare due o più salti di forma di un oggetto. In questo
caso, come nel primo, giungono a delimitazione comunque delle alternative
linguistiche, ora depositate iconicamente nella percezione, ora depositate linguisticamente in proposizioni, ora cognitivamente in schemi mentali. Che la
percezione assuma a volte un grado interpretativo basso, come nel caso del
cerchio sotto il triangolo, non significa che la percezione sia alinguistica, ossia
che la sua cogenza derivi da questa sua alinguisticità: significa invece, che
quella cogenza dipende da un intrinseco grado interpretativo di quello specifico strato linguistico che è la percezione. Così, le alternative “il cerchio è sotto
il triangolo” e “il triangolo è sopra il cerchio” sono direttamente visibili nel percetto ché pre-contenute in esso; la naturalità del dire “il cerchio è sotto il triangolo” dipende solo dalla delimitazione che il percetto impone dal suo stesso
interno alle due alternative proposizionali che rappresenta, ossia dal fatto che
impone un determinato grado interpretativo. Che il percetto, però, includa
quelle alternative significa che è, in tutto, linguaggio.
Roland Barthes ha insistito a lungo sul carattere muto delle immagini28;
potremmo, per traslazione, parlare anche di un carattere muto delle scene percettive stesse: esse non direbbero in realtà niente di determinato. Non è esatto: la cosa sta in termini diversi, ossia nei termini per i quali può spesso capitare che una scena percettiva proponga un’illimitata variabilità di alternative
linguistiche, cosa che induce il percettore a non privilegiarne, per induzione del
percetto, alcuna. È come se si verificasse un’ubriacatura proposizionale che il
percettore vive fenomenologicamente come sospensione o impossibilità di
ogni giudizio specifico, e che in realtà non è impossibilità di giudizio tout court.
La linguisticità dei fattori che segregano il campo, non deve essere pensata nel senso che si vede perché si parla o perché si possiede un linguaggio,
quasi che, per assurdo, un cieco, il quale pure parla, può, nonostante tutto,
possedendo un linguaggio posseduto da altri membri della sua comunità,
vedere alla stessa maniera di uno dotato di facoltà ottica normale. La differenza, però, tra un cieco ed uno visivamente normodotato, sta semplicemente nel fatto che il linguaggio del cieco non può avanzare negli strati linguistici
corrispondenti alla percezione: egli non può usare uno degli strati a più basso
grado interpretativo del linguaggio, precisamente quello che induce o che ritaglia una determinata proposizione linguistica piuttosto che un’altra. Il cieco,
cioè, si serve, rispetto alla percezione visiva, del linguaggio solo come di una
materia che contiene già in sé delle forme che egli non può attualizzare con la
visione di oggetti hic et nunc.
SAGGI
1
Il presente lavoro può essere considerato come un contributo integrativo di un articolo, Per
una semiotica fenomenologica della percezione, apparso su “Segni e comprensione”, n. 42, 2001,
pp. 47-72.
2
Intendiamo con tale espressione ogni prospettiva che considera i fenomeni come risultati
“centrali” di fenomeni di sintesi di dati sensibili provenienti da corpi definiti “esterni”; cfr. A. CAPUTO,
Per una semiotica fenomenologica della percezione, cit., punti 2-3, pp. 47-49.
3
L’autore, a dire il vero, si dimostra preoccupato di isolare una diversità dei fattori che segregano il campo percettivo da quelli che operano nel pensiero; non il confronto linguaggio-percezione è, quindi, ciò che lo preoccupa immediatamente. Inoltre, precisa l’autore, “Il fatto che si possano indicare altri casi nei quali tale identità –l’identità tra le leggi che segregano il campo percettivo e quelle che operano nel pensiero– non si verifica può far anche supporre che nei primi
casi si possa trattare di una coincidenza soltanto fortuita, ma che in realtà i due campi sono regolati da leggi diverse. Ma quando dico diverse non intendo dire che le leggi a cui obbedisce l’organizzazione percettiva siano leggi di natura diversa da quelle del pensare, ma voglio dire che
potrebbero essere semplicemente altre leggi” (G. KANIZSA, Grammatica del vedere, Il Mulino,
Bologna 1997, p. 115).
4
Cfr. ivi, p. 85.
5
Cfr. ivi, p. 86.
6
Cfr. ivi, pp. 88-89.
7
Ivi, p. 91.
8
Ivi, pp. 91-92.
9
Cfr. ivi, p. 93.
10
Cfr. ivi, pp. 95-97.
11
Cfr. ivi, pp. 108-109.
12
Cfr. ivi, p. 97.
13
A ciò si può obbiettare che simili affermazioni, come quelle da noi da ultimo asserite, non
sono passibili di conferma sperimentale, anzi sicuramente confutabili da una tale, eventuale esperienza. Ora, ammettiamo pure che sia così: su quali basi si può tirare una discriminazione netta
tra l’integrazione percettiva e quella cognitiva? Lo si può fare solo sul dato di un’eventuale diversità del lasso di tempo di risposta del singolo alle due stimolazioni? Perché un lasso di tempo
maggiore nella risposta dovrebbe essere indice di processualità cognitiva, concettuale e/o linguistica? Chi ci dice che il linguaggio o nel linguaggio la totalizzazione non avvenga, in certi suoi strati, con identica immediatezza, cosa di cui qui si è convinti, rispetto alla percezione? È evidente che
il parametro del tempo non è un parametro adeguato per tracciare un discrimine netto tra pensiero, linguaggio e percezione.
14
Cinestesi è qui usato nel senso husserliano di “percezione in movimento”, e non nel senso
di sensazione di movimento.
15
L’espressione è di Husserl: cfr. E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, § 35, p. 76 e sgg.
16
Sulla differenza tra il concetto husserliano di Kern percettivo e il concetto di Figur in Rubin,
come sulla differenza tra il concetto di Hintergrund husserliano ed il concetto di Grund rubiniano
e sulla anteriorità funzionale dello Hintergrund husserliano rispetto al Grund di Rubin, nonché sulle
enormi affinità concettuali per la prima coppia di concetti nei due autori, sia lecito rimandare alla
Dissertazione dottorale dello scrivente, A. CAPUTO, La fenomenologia della percezione in Edmund
Husserl, discussa nel 2000, cap. II, pp. 114-154.
17
Cfr. A. CAPUTO, Per una semiotica fenomenologica della percezione, cit., p. 68 e sgg.
18
Cfr. L. B. MEYER, Significato in musica e teoria dell’informazione, in U. ECO, Estetica e teoria dell’informazione, Milano, Bompiani 1972, p. 160.
19
Per i temi del significato e della sedimentazione rimando alla Krisis der europäischen
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie di Husserl.
20
Cfr. G. KANIZSA, Grammatica del vedere, cit., pp. 274 e 286.
21
Cfr. ivi. pp. 305-306.
37
22
Cfr. KANIZSA, LEGRENZI, SONINO, Percezione, linguaggio, pensiero, Il Mulino, Bologna 1983,
p. 416.
23
Cfr. ibidem.
24
Ivi, p. 417.
25
Cfr. A. CAPUTO, Per una semiotica fenomenologica della percezione, cit., pp. 48-58.
26
F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, cit., p. 137. Il presupposto inaccettabile di
Saussure era però che la lingua ritagliasse i segni in due continuum amorfi: in quello della massa
del pensiero e in quello della massa dei suoni.
27
La costante “se…allora” è non meno percepibile di ogni rapporto causa-effetto. Se si vedono cause ed effetti, non si capisce perché non debbano vedersi i controfattuali. Se mi si staglia
davanti agli occhi una scena percettiva, e per essa siamo immediatamente indotti a rappresentarla con “se hai fatto questo, allora sei matto”, ciò vuol dire che abbiamo visto il “se…allora” come
qualsiasi altra cosa, ossia come componente amodalmente esigita a completamento di ciò che si
vede, componente che, pur assente, ha avuto effetti funzionali sul nostro sistema nervoso e sul
nostro sistema psichico-cognitivo.
28
Cfr. R. BARTHES, Elementi di semiologia, Einaudi, Torino 1992, p. 27.
38
L’INFLUENZA DI DANTE
NELL’OPERA DI ELIOT
Nella conferenza tenuta il 4 luglio 1950 all’Istituto Italiano di Cultura a
Londra, poi pubblicata nella raccolta di saggi To Criticize The Critic col titolo
What Dante Means To Me, Eliot affermò che il debito che lo legava a Dante
era “di tipo progressivamente cumulativo”1: mentre la lettura di scrittori quali
Jules Laforgue e Charles Baudelaire aveva contrassegnato un periodo limitato della sua vita, pur offrendogli insegnamenti preziosi per la sua carriera poetica, lo studio del Fiorentino aveva accompagnato ogni fase della sua maturazione artistica, arricchendosi di nuovi significati lungo il suo percorso letterario
e spirituale. Nel saggio appena citato ammetteva inoltre di non riuscire a definire del tutto nemmeno a se stesso in cosa fosse consistito quel debito,
lasciando ipotizzare uno sconfinamento più o meno cosciente dal campo delle
lezioni tecnico-letterarie indicate in quella sede.
Non è dunque semplice chiarire la misura e la qualità dell’influenza dantesca su Eliot, sulla cui opera, in prosa ed in poesia, l’ombra dell’Alighieri si
allunga anche laddove non vi sono riferimenti espliciti, suggerendo una funzione simile a quella che Virgilio aveva avuto per Dante: “Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore”2.
Nell’opera eliotiana osservata retrospettivamente, inoltre, mentre sono
riscontrabili prove evidenti di un approfondimento graduale, contemporaneamente è possibile leggere fin dagli esordi affermazioni che rimandano inequivocabilmente agli sviluppi futuri. Questo empasse può essere risolto solo presupponendo un ripensamento continuo da parte del poeta di motivi, di nuclei
di pensiero, di esigenze artistiche e spirituali presenti da sempre ma la cui
armonizzazione veniva costantemente “minata” da esperienze filosofiche e
intellettuali di segno opposto, alimentando un conflitto interiore che si riverberò sulla produzione poetica fino a The Waste Land.
Attraverso la lettura dei due saggi su Dante, il primo del 1920, l’altro del
1929, è possibile delineare gli aspetti più significativi di quel percorso, ponendo in luce il peso che lo scrittore fiorentino ebbe sulla teoria letteraria di T. S.
Eliot.
I capisaldi della poetica eliotiana, almeno fino alla prima metà degli anni
Venti, possono essere racchiusi entro le formule sintetiche della “impersonal
theory of poetry”, dell’ “objective correlative” e del “sensous thought” contenute, rispettivamente, in Tradition and Individual Talent del 1917, in Hamlet and
His Problems del 1919 e in The Methapysical Poets del 1921. Il riferimento alla
teoria dell’impersonalità dell’arte impone però un accenno all’ambiente culturale dominante negli anni in cui Eliot compiva la sua formazione letteraria.
SAGGI
di Valentina Nicolì
39
40
Mentre Sigmund Freud sanzionava la scissione dell’io mostrando all’uomo
il proprio lato oscuro nell’inconscio e il mito della “Grande Società” crollava
sotto il peso del primo conflitto mondiale, in letteratura si assisteva a cambiamenti altrettanto profondi all’interno di un panorama artistico quanto mai composito, universalmente riconosciuto con il termine generico di modernismo. La
rivoluzione –soprattutto in America e in Gran Bretagna– era partita dal romanzo, con uno scardinamento delle regole codificate dell’Età Vittoriana, figlie di
una società che credeva in se stessa e rispettosa delle rigide separazioni della
gerarchia sociale. Il flusso di coscienza di James Joyce e di Virginia Woolf e il
realismo psicologico di Henry James erano le manifestazioni più immediatamente percepibili di una battaglia artistica condotta in Europa come negli Stati
Uniti, in prosa ed in poesia.
Nel campo della poesia, i primi anni del ventesimo secolo videro il maturare di una ribellione verso i modi espressivi romantici e post-romantici e verso
il vuoto opprimente e il chiacchiericcio accademico e di maniera instauratisi in
America dopo Walt Whitman. Tale ribellione si concretizzò in un movimento
anglo-americano denominato Imagism fiorito fra il 1909 ed il 1918 attorno alla
figura del filosofo inglese T. E. Hulme, che annoverava fra i suoi esponenti più
autorevoli lo scrittore Ezra Pound.
L’ansia del “nuovo” di questi poeti li condusse a trovare i referenti privilegiati della loro arte nei simbolisti francesi di fine ’800 –Baudelaire, Mallarmé,
Rimbaud, Laforgue, Corbiére– e, contemporaneamente, nei versi cinesi e
giapponesi, ravvisando in entrambi i casi un modello che contrastava le vaghe
generalizzazioni, per quanto ricche di musicalità, della poesia romantica. Le
loro opere aspiravano infatti alla presentazione della conoscenza sensibile del
mondo attraverso immagini concrete e definite, lasciando ad esse il compito di
trasmettere l’emozione poetica. L’immagine non doveva essere mero ornamento, ma divenire essa stessa veicolo di comunicazione: a questo scopo
veniva favorito l’uso di un linguaggio antipoetico tratto dall’esperienza quotidiana, sulla scorta della lezione appresa da Baudelaire e Laforgue. Tutto ciò
si accompagnava alla concezione della poesia come di un “mosaico” –ogni
parola doveva avere una esatta collocazione– pur evitando l’irrigidimento nelle
forme metriche precedenti, ritenute antiquate, ma ricercando nuovi ritmi e
nuovi schemi formali.
In Ezra Pound la ribellione antiromantica, l’ansia di rifondare i contenuti ed
i modi espressivi poetici furono sempre accompagnate da una insolita capacità di “fagocitare” le esperienze letterarie più diverse, varcando anche i confini
della tradizione europea e occidentale.
Sotto questa luce deve essere osservata la profonda ammirazione per l’opera di Dante e degli stilnovisti che lo portò a pubblicare, nel 1910, il saggio The
Spirit of Romance. Le risorse stilistiche e linguistiche della poesia toscana, e del
Fiorentino in particolare, divennero per Pound modelli da contrapporre alle
astrazioni romantiche. La precisione di quelle rappresentazioni, nell’opinione
dell’autore dei Cantos, nasceva dallo sforzo costante di riprodurre con la massima esattezza qualcosa di cui si aveva avuto esperienza reale: “la poesia toscana apparteneva ad un tempo in cui l’aver visioni era considerato rispettabile”3.
SAGGI
L’allegoria di cui Dante fece uso veniva a configurarsi come uno strumento nelle mani dell’autore per distaccarsi dalle emozioni e per visualizzarle. Per
Pound, come per Eliot, il termine emozione aveva un significato più ampio di
semplice stato d’animo: essa rappresentava per entrambi il sostrato inseparabile dall’idea e dall’esperienza.
Lo stile di Dante, l’uso della similitudine e della metafora –rivelatore della
sua capacità di cogliere e rendere poeticamente i più diversi ordini di relazione tra le cose– costituivano l’esempio concreto di quell’ideale poetico predicato da Pound e dai suoi contemporanei. Dal Fiorentino egli imparò inoltre l’utilizzo dinamico della lingua, dato dall’alternanza di diversi registri stilistici –le
“rime dolci e leggiadre” e le “rime aspre e chiocce”.
L’accenno ai fermenti letterari degli inizi del Novecento e quello alla ricezione poundiana di Dante sono necessari per comprendere maggiormente il
legame fra Eliot ed il suo tempo, poiché né le teorie cui si è accennato in precedenza né lo studio del Fiorentino nacquero e si svilupparono nel vuoto, sebbene poi egli desse ad entrambi la sua impronta originale.
In Tradition and Individual Talent Eliot affermò che la poesia non è libero
sfogo di sentimenti, ma una evasione da essi: essa richiede una “continua
estinzione della personalità”4. Ciò non significa che egli vedesse nel poeta un
cronista asettico della realtà, bensì una sorta di “catalizzatore” in grado di trasmutare le proprie esperienze private in un nuovo composto dotato di valore
concettuale ed emotivo universale. Sebbene il suo ruolo sia simile a quello di
un medium che riferisce messaggi dall’aldilà, l’operazione che svolge è deliberata: l’artista ha coscienza del “métier” della poesia, ovvero la capacità di
manovrare il linguaggio ed i materiali poetici. L’acquisizione di tale capacità
avviene a prezzo di una askesis continua, di una disciplina da esercitarsi attraverso il richiamo costante alla tradizione. Quest’ultima costituisce l’”ordine
ideale” venuto a crearsi nel corso dei secoli in letteratura, all’interno del quale
tutte le opere posseggono una “esistenza simultanea”. Ciò consente all’artista
di percepire l’elemento atemporale che scorre in ogni monumento poetico,
espresso nelle forme codificate delle diverse epoche e nazioni, attraverso
repertori immaginifici e simbolici che fanno parte del bagaglio collettivo occidentale. Tuttavia, la conquista del “senso storico” non è vuota ripetizione di
forme, giacché attraverso la presa di coscienza di quel retaggio che ci si porta
dietro inconsapevolmente è possibile arricchire quelle immagini e quei simboli di nuovi significati. Il poeta restituisce al lettore, nel prodotto artistico, un
composto in cui è stata operata una fusione di elementi eterogenei –i sentimenti, le sensazioni, le immagini tratte dall’esperienza quotidiana, le influenze
letterarie, il complesso mitico-religioso della propria cultura– in modo tale che
ognuno di essi ne esca totalmente trasfigurato e che solo da quel composto
scaturisca l’emozione poetica. Per questa via, non solo è il presente che trova
la sua guida nel passato –ovvero nell’ordine ideale dei monumenti letterari
preesistenti– ma è il passato che viene modificato dal presente.
Se l’ideale di una poesia impersonale inserisce Eliot nel contesto dell’insofferenza modernista, o proto-modernista, nei confronti dell’estetica idealista,
il suo appello alla tradizione rivela d’altra parte la distanza dai suoi contempo-
41
42
ranei. Questi, sebbene avessero dei modelli privilegiati sui quali basare la loro
battaglia anti-romantica, non avevano operato un simile riconoscimento programmatico; anzi, spesso l’affermazione della propria identità conduceva a
tendenze iconoclastiche –tipico il caso del Futurismo– almeno al livello della
propaganda.
Corollario alla teoria dell’impersonalità è quella dell’ “objective correlative”,
la cui definizione fu data da Eliot nel contesto della sua lettura critica
dell’Hamlet di Shakespeare: “Il solo modo di esprimere emozioni in forma d’arte è di scoprire un ‘correlativo oggettivo’; in altri termini, una serie di oggetti,
una situazione, una successione di eventi che saranno la formula di quella
particolare emozione; tali che quando i fatti esterni, che devono terminare in
esperienza sensibile, siano dati, venga immediatamente evocata l’emozione”5.
Le teorie eliotiane maturarono anche grazie alla sua scoperta di una ideale fratellanza metafisica che andava da Dante ai poeti inglesi della fine del ‘500
e degli inizi del ‘600 ai simbolisti francesi di fine Ottocento. Ai Metafisici inglesi Eliot dedicò un saggio pubblicato un anno dopo il primo scritto su Dante. In
esso è possibile trovare ulteriore integrazione e chiarimento alle formule
espresse negli anni precedenti. Quegli autori avevano posseduto la capacità
di operare una fusione costante fra contenuti concettuali ed esperienze sensoriali, tanto da riuscire a realizzare una “diretta e sensuosa appercezione del
pensiero, una rifondazione del pensiero nei sensi”6. Quelle potenzialità espressive affondavano le loro radici nel modo in cui la loro epoca conosceva ed
interpretava la realtà, in un meccanismo della sensibilità che consentiva loro
di assimilare ogni tipo di esperienza.
È esattamente la capacità di fondere ordini esperienziali diversi il denominatore comune che fece avvicinare nella mente di Eliot scrittori tanto diversi
tra loro quali Dante, Donne e Baudelaire.
Nel 1920 Eliot pubblicò il suo primo studio su Dante, a un tempo lettura critica e documento prezioso del suo ideale artistico. In esso, infatti, la teoria letteraria eliotiana dell’impersonalità e quella del correlativo oggettivo spiegano
la sua interpretazione del metodo allegorico dantesco.
Le riflessioni sull’allegoria, correlate alle sue dottrine estetiche, mettevano
peraltro in luce gli interessi nel campo della fenomenologia: Eliot credeva nel
valore gnoseologico della percezione e dunque nello stretto rapporto fra intelletto e sensibilità, da trasferirsi poi nell’arte in una resa oggettiva del fondo emotivo delle idee. Grazie allo strumento allegorico il Fiorentino poté costruire “la più
esauriente, la più ordinata presentazione di sentimenti che sia mai stata fatta “7.
Per Eliot come per Pound, con il quale l’autore di The Waste Land a partire dal 1914 ebbe modo di discutere assiduamente sull’opera dantesca, la
Divina Commedia rappresentava l’esempio più alto di poetica dell’oggetto e
della rappresentazione icastica delle emozioni. Nel saggio del ’20, inoltre, è
presente l’esplicita ammissione di una predilezione artistica rivelatrice dell’originalità di Eliot rispetto ai suoi contemporanei: la poetica dell’oggetto diviene
mezzo per esprimere in forma di visione il pensiero di un’epoca, quando questo abbia raggiunto il livello di accettazione immediata.
Il punto di partenza di questo studio è infatti la critica ad una affermazione
SAGGI
di Paul Valéry, secondo il quale è impossibile scrivere poesia filosofica nel
mondo moderno, poiché compito dell’arte e quello di “produrre in noi un certo
stato”8. L’obiezione di Eliot poggia sulla convinzione che, se ancor oggi si può
apprezzare una poesia che abbia alle spalle un sistema strutturato di pensiero, non vi è nessuna ragione di ritenere che non sia possibile scriverla. Il riconoscimento di questa possibilità diventa, di fatto, l’unica valida alternativa al
predominio pressoché assoluto dell’ideale artistico predicato da Valéry.
Per avvalorare la sua tesi, Eliot si propose di stabilire quale sia la poesia
filosofica veramente valida, istituendo un paragone fra la Divina Commedia e
le opere di Parmenide e Empedocle. Questi avevano fallito nel loro tentativo
poiché non erano riusciti a trovare l’equivalente poetico del pensiero. Diverso
il caso di Lucrezio, che aveva cercato di esporre una filosofia già esistente trasfigurandola artisticamente.
Ma, ancor più di Lucrezio, fu Dante colui che riuscì a trattare il pensiero del
suo tempo “non come materia di discussione, ma come materia di visione”9.
Ciò gli fu possibile perché la mitologia e la teologia di cui egli disponeva “erano
state più pienamente assorbite nella vita di quelle di Lucrezio”10. Per Eliot, tuttavia, il sistema mitologico-cristiano e la filosofia tomistica non erano, come
per l’amico Pound, semplici strumenti per conferire unità al poema: diventavano essi stessi poesia. Sebbene in questo saggio facesse ricorso a termini
quali “impalcatura” o “struttura meccanica” per definire il metodo allegorico
dantesco, pure è evidente il distanziamento dalle letture interpretative precedenti e la sua visione organicistica della Commedia.
Uno degli esempi più significativi addotti da Eliot per dimostrare l’impossibilità di una separazione fra “poesia” e “non poesia” è costituito dai versi che
concludono l’incontro con Brunetto Latini: “e parve di costoro / quelli che vince
non colui che perde”11. Così si esprimeva Eliot riguardo all’immagine della
corsa, utile a rendere l’emozione artistica di uno spirito nobile quantunque
dannato: “L’emozione del passo consiste nell’eccellenza di Brunetto pur nella
dannazione, si tratta infatti di un’anima tanto ammirevole quanto perversa”12.
Come nel caso dell’episodio di Paolo e Francesca, per citare un altro esempio
riportato da Eliot, anche in quello di Brunetto la bellezza del singolo episodio
viene arricchita dalla posizione assegnata a ciascuno entro lo schema eterno.
Quando Eliot affermava che “l’analisi di un episodio qualunque della
Commedia dimostrerebbe che non soltanto l’interpretazione allegorica o l’intenzione didascalica, ma neppure il contenuto sentimentale, si possono isolare
dal resto del poema”13, conferiva all’allegoria un valore molto più alto di cornice
alla vera poesia, sebbene essa sia innanzitutto l’impalcatura che garantisce
solidità alla struttura, ovvero alla “scala ordinata di sentimenti umani”.
L’allegoria consente di conferire ordine a tutte le esperienze umane, viste sub
specie aeternitatis, poiché in Dante “nessun sentimento […] è contemplato per
se stesso”; non si può, cioè, “capire l’Inferno senza il Purgatorio e il Paradiso”14.
Uno degli aspetti più innovativi della critica eliotiana risiede nell’aver esteso, magari in modo neanche del tutto premeditato, il termine allegoria a tutti i
modi espressivi danteschi, non solo alla presentazione visionaria dell’ordinamento morale e religioso dell’universo. Esso poteva stare ad indicare sempli-
43
44
cemente il metodo attraverso cui Dante aveva fornito “una rappresentazione
concreta del sentimento più elusivo”15. Per tale via la poesia del Fiorentino
diveniva garante inappellabile del suo ideale artistico, della lotta per la costruzione della poetica dell’oggetto.
Per spiegare il procedimento dantesco di traduzione di emozioni aliene alla
comune esperienza umana in immagini concrete, Eliot citò un brano che offre
lo spunto per un’altra riflessione: “Nel suo aspetto tal dentro mi fei, / qual si fe’
Glauco nel gustar de l’erba / che il fe’ consorto in mar degli altri dei”16. Una
metamorfosi interiore impossibile a spiegarsi con le parole in uso nella lingua
medievale –“trasumanar significar per verba / non si poria”17– viene resa
facendo ricorso al mito. Questa per Eliot era una lezione ulteriore, legata al
suo ideale di tradizione: l’uso dinamico del complesso sistema mitico-religioso
radicato nella cultura occidentale. Essa può essere ricollegata alla teoria del
“metodo mitico” espressa in Ulysses, Order and Myth del 1923: “È semplicemente un modo di controllare, ordinare e dare forma e significato all’immenso
panorama di futilità e di anarchia che è la storia contemporanea […]. Invece di
un metodo narrativo, noi ora possiamo usare il metodo mitico”18. Quella affermazione costituisce, fra l’altro, un codice d’accesso alla comprensione dei
modi espressivi utilizzati in The Waste Land.
Il percorso che avrebbe portato Eliot alla conversione non fu facile, e la produzione poetica dei primi anni Venti testimonia il conflitto interiore dello scrittore, alla ricerca di un sistema razionale che desse ordine alle vicende contraddittorie della sua esistenza e della sua epoca, seppure ancora restio ad accettare gli schemi dell’ortodossia religiosa. L’interesse per la dimensione etica
della vita umana era d’altro canto presente fin da The Love Song of J. Alfred
Prufrock (1915), protagonista un antieroe amletico incapace di riscattare le proprie esperienze sentimentali e intrappolato nel suo isolamento intellettuale e
spirituale. Prufrock ha vaga coscienza della possibilità di rompere le maglie di
quella rete, eppure la death by water con cui si conclude il poema, più che indicare una vera metamorfosi, designa piuttosto il fallimento del personaggio.
The Waste Land fu composta tra il 1921 ed il 1922, durante un periodo difficile della vita di Eliot. Le già precarie condizioni della moglie Vivienne peggiorarono, mentre il lavoro alla Loyd Bank di Londra non gli consentiva di dedicarsi completamente alla letteratura. Tali pressioni lo condussero alle soglie di
un esaurimento nervoso, tanto da dover ricorrere all’aiuto di uno psicologo.
Nel novembre del ‘21 si recò a Losanna per alcuni mesi di cura durante i quali
concluse la composizione del poemetto.
In quegli stessi anni la civiltà occidentale sperimentava un senso di profondo disorientamento, causato dai cambiamenti generati dal primo conflitto
mondiale. Gli assetti geo-politici erano stati rivoluzionati e non meno radicali
furono gli sconvolgimenti in campo economico e sociale: la coscienza di classe di ceti fino ad allora esclusi dalla vita politica favorì l’ondata socialista e
comunista nata in Russia in seguito al crollo dell’impero zarista. Tutto ciò non
poteva non ripercuotersi sul panorama culturale negli anni entre deux guerres,
alimentando posizioni anche molto diverse fra loro ma accomunate dalla presa
di coscienza del tramonto di un’epoca.
SAGGI
La crisi privata di Eliot si sovrappose e si mescolò a quella storica; questo
doppio disorientamento fu proiettato in The Waste Land. Il tentativo di “puntellare le sue rovine” attraverso l’uso programmatico del mito rifletteva sul piano
estetico-letterario il bisogno di ricostruire un ordine dalle macerie del presente.
Tuttavia, il poemetto non costituisce solo il pretesto per esorcizzare l’esperienza privata e la crisi del mondo contemporaneo: queste ultime rappresentano
piuttosto lo stimolo dal quale Eliot partì per la “costruzione” della sua poesia. In
essa l’emozione artistica dominante, resa mediante il rimaneggiamento di una
millenaria tradizione letteraria, mitica, antropologica, risiede in un senso di
desolazione e di sradicamento universale e atemporale e in un simultaneo,
seppure ancora solo adombrato, tentativo di fuga da quella desolazione.
L’acedia di Prufrock acquista in The Waste Land dimensione collettiva: la
“Unreal City”, la metropoli moderna –sia essa Londra o Parigi– viene accostata senza mediazione concettuale all’inferno dantesco dei morti-in vita19.
L’accenno alle vicende biografiche e alla produzione poetica dei primi anni
Venti serve a chiarire l’evoluzione spirituale ed intellettuale di Eliot, che iniziò
a trasferire la sua ricerca di un “ideal order” e di una composizione fra tempo
ed eternità dal piano artistico a quello morale e sociale, e in seguito anche a
quello religioso.
I saggi pubblicati dopo il 1922 testimoniano l’avvicinamento progressivo a
posizioni filosofiche anti-liberali, come quelli degli anni precedenti avevano
testimoniato l’insofferenza per l’estetica idealista20. Le lezioni di Irving Babbitt
da lui seguite ad Harvard nel 1909-10 lo avevano iniziato allo scetticismo nei
confronti del mito romantico e rousseauniano circa la natura essenzialmente
buona dell’uomo e l’infallibilità dell’istinto. A quelle lezioni si aggiunse in seguito la suggestione esercitata dal pensiero di Charles Maurras e Jacques
Maritain. La sfiducia nella perfettibilità della natura umana, segnata dall’impronta indelebile del peccato originale –comune denominatore di questi intellettuali– si traduceva, a livello politico-sociale, nella diffidenza radicale nei confronti di democrazie troppo libertarie e nell’appello alla costruzione di uno
Stato forte che fosse in grado con le sue leggi di disciplinare la corruzione
innata nell’uomo.
Il bisogno di trovare una via di uscita al disorientamento post-bellico e al conflitto fra il suo sentimento religioso ed il razionalismo ereditato dall’“Unitarianism”
nel quale era stato educato, alimentato dalle esperienze filosofiche della prima
giovinezza, condusse Eliot verso posizioni sempre più conservatrici e dogmatiche che pesarono anche sulle sue teorie e predilezioni artistiche. In questo contesto, l’ammirazione per Dante non solo crebbe ma assunse carattere del tutto
particolare.
Documento della direzione intrapresa da Eliot in questi anni è rappresentato dalle Clark Lectures21, serie di conferenze tenute a Cambridge nei primi
mesi del 1926. In esse lo scrittore anglo-americano modificava alcune sue
convinzioni sulla poesia metafisica, e ridimensionava i giudizi espressi cinque
anni prima sui poeti inglesi del ‘500 e del ‘600.
La revisione di quegli autori che fino a poco tempo prima lo avevano interessato e avevano influenzato la sua stessa pratica poetica veniva fatta attra-
45
46
verso il filtro di Dante e della filosofia medievale. Il ripensamento in campo letterario presupponeva l’avvicinamento a posizioni filosofico-religiose che, per
quanto mai del tutto rigettate, avevano convissuto in passato con lo scetticismo ed il dubbio.
Nelle conferenze del ’26 Eliot giungeva alla conclusione che il più grande
esempio di poesia metafisica è quello di Dante. Le metafore e le similitudini
del Fiorentino posseggono “necessità razionale” e la scelta degli aggettivi
ricorda quella di un “trattato scientifico”.
Per rendere evidente l’assoluto rigore nell’uso dantesco della parola poetica,
Eliot citava i versi 31- 36 del secondo canto del Paradiso: “Parev’a me che nube
ne coprisse / lucida, spessa, solida e pulita, / quasi adamante che sol ferisse. /
Per entro se’ l’etterna margarita / ne recevette, com’acqua recepe / raggio di sole
rimanendo unita”. I quattro aggettivi “lucida, spessa, solida e pulita” servono ad
indicare qualità fisiche ben precise del cielo della luna, mentre il paragone con il
raggio di luce che penetra una massa d’acqua senza disunirla ha la funzione di
rendere chiara agli occhi del lettore, attraverso un’immagine consueta, una
esperienza straordinaria: l’entrata di Dante e Beatrice nel primo cielo.
Il linguaggio di Donne e dei suoi contemporanei, confrontato con quello di
Dante, risulta tortuoso e troppo elaborato. La capacità di questi poeti di rendere l’idea attraverso l’immagine è meno efficace poiché è basata sul “conceit”, ovvero sulla tendenza a complicare ed estendere le similitudini e le
metafore di partenza. Nell’opinione di Eliot questa degradazione del linguaggio e dello stile era la manifestazione artistica della frantumazione di una filosofia organica in “frammenti di sistemi”.
Come già nel saggio del ’20, Eliot sottolineò l’importanza dell’allegoria
come strumento privilegiato dell’incarnazione poetica dantesca. Rispetto a
quel primo studio, però, le opinioni formulate nel ’26 mostrano un approfondimento ulteriore, poiché il metodo allegorico viene esplicitamente riconosciuto
come il corrispettivo artistico di una ricerca religiosa, mezzo per conferire ordine alla realtà.
L’arte del Fiorentino non è mai autoreferenziale: in essa la rappresentazione sensoriale della scala delle emozioni umane parte da una prospettiva metafisica e giunge alle soglie della religione nell’offrire all’uomo la possibilità dell’esistenza di un principio d’ordine nell’universo. In tal modo Dante arricchì l’esperienza umana, “nell’estendere le frontiere del mondo umano”22.
L’interesse nei confronti degli aspetti extra-letterari dell’opera dantesca
viene appalesato dal confronto fra il misticismo medievale e quello dei secoli
posteriori. All’interno di un paragone con l’Assoluto di Bergson, egli affermò ad
esempio: “Nel XII secolo la visione divina poteva essere raggiunta soltanto
attraverso un processo al quale prendeva parte l’intelletto; era attraverso il
pensiero analitico, e poi superandolo, che l’uomo poteva giungere alla beatitudine. Questo era il tipo di misticismo praticato al tempo di Dante”23.
La critica allo stile di Donne e dei suoi contemporanei aveva quindi radici
più profonde, poiché nasceva dal confronto fra due sistemi di pensiero: mentre la sensibilità dei medievali era “ontologica”, fondata sulla tensione umana
verso valori assoluti, quella degli autori inglesi del ‘500 e ‘600 era “romantica”
SAGGI
e “psicologica”, generatrice di un tipo di poesia che sembrava prestare più
attenzione ad ogni possibile sfumatura dell’emozione sottesa ad un’idea che
non al valore intrinseco di quell’idea metafisica.
La dissociazione della sensibilità che nel saggio The Metaphysical Poets
aveva fatto risalire a Cartesio ed al razionalismo scientifico del XVIII secolo
era quindi nata ancor prima. A questa degradazione progressiva egli opponeva la wisdom di Riccardo di S. Vittore, di S. Tommaso d’Aquino, di Dante e di
Cavalcanti.
Se le Clark Lectures testimoniano la scelta eliotiana di assumere come
modelli privilegiati Dante e l’universo culturale e filosofico medievale, The
Hollow Men, composti tra il 1923 ed il 1925 e pubblicati nella stesura definitiva nel 1925, mostrano l’allontanamento dallo stile ironico laforguiano di The
Love Song of J. Alfred Prufrock e dal metodo mitico di The Waste Land. Non
a caso essi sono considerati dalla gran parte degli studiosi di Eliot il punto di
svolta della sua carriera artistica, l’inizio della “nuova vita”. Il riferimento al
libello non è forzato, dal momento che in The Hollow Men il ricorso al repertorio immaginifico dantesco si fa più corposo.
Ancora una volta l’accenno alla coeva produzione poetica serve a chiarire
lo stadio dell’evoluzione eliotiana: in questo poemetto gli “uomini impagliati”,
pur trovandosi al di qua del “tumido fiume” –richiamo evidente ai fiumi infernali
della Commedia– intravedono l’esistenza di una possibilità di riscatto e di purificazione, incarnata negli occhi femminili che essi non osano incontrare
–immagine, anche questa, di chiara derivazione dantesca.
Il 29 giugno 1927 Eliot aderì ufficialmente alla Chiesa d’Inghilterra, battezzato dall’amico William Force Stead. Nel novembre dello stesso anno prese la
cittadinanza britannica, portando a compimento il suo “ritorno alle origini”.
È legittimo domandarsi per quale motivo un uomo dalle tendenze conservatrici quale fu Eliot avesse preferito l’Anglocattolicesimo alla Chiesa Cattolica
Romana. La risposta non deve essere ricercata solo nel suo “nazionalismo”, in
virtù del quale egli considerava anche la religione una espressione della cultura e della tradizione di un paese. Anche questo aspetto è ricollegabile all’ansia
eliotiana di composizione degli opposti. Come in letteratura aveva cercato il
punto di incontro fra tradizione e talento individuale, fra filosofia e poesia, anche
in materia di fede aspirava ad una conciliazione fra tempo ed eternità, fra l’elemento transeunte e quello permanente che scorre al di sotto del fenomeno.
Già in The Waste Land aveva trasfigurato poeticamente l’intima vicinanza
fra i miti ed i riti delle civiltà pre-cristiane e quelli del Cristianesimo. Se in quel
caso l’interesse era stato prevalentemente antropologico e letterario, in seguito esso assunse carattere metafisico e teolologico: i miti attraverso cui una
religione trasmette i suoi dogmi –nel caso specifico, il Peccato Originale,
l’Incarnazione, Crocifissione e Resurrezione di Cristo– servono a rendere visibile alle limitate capacità conoscitive dell’uomo verità altrimenti ineffabili. Il
modo in cui una religione attua questa comunicazione può variare nel corso
della storia, ma la struttura che ne è sottesa rimane invariata.
Alla luce di questa interpretazione, la scelta di aderire alla Chiesa
Anglicana può essere spiegata dalla disponibilità all’evoluzione che Eliot vide
47
48
in essa. Quattro anni dopo la conversione, in Thoughts After Lambeth affermò:
“l’opinione della Chiesa di Roma in generale mi sembra orientata verso la considerazione che un principio debba essere affermato senza eccezioni, e che
quindi le eccezioni possano essere trattate senza modificare il principio. Credo
che l’ottica naturale alla mentalità inglese tenda piuttosto a considerare che un
principio debba essere strutturato in modo da includere tutte le eccezioni
ammissibili. Ne consegue inevitabilmente che la Chiesa romana debba fare
professione della propria inamovibilità, mentre la Chiesa anglicana debba professare il proprio tener conto delle mutate condizioni”24.
È forse utile, dunque, leggere da questa prospettiva più ampia l’interpretazione della allegoria dantesca maturata a partire dalle Clark Lectures. Nel
secondo saggio su Dante ritornano infatti le opinioni espresse nelle conferenze del ’26: attraverso questi due studi è possibile rilevare l’evoluzione maturata in Eliot negli anni intercorsi tra il 1920 ed il 1929.
Nelle conferenze di Cambridge Eliot aveva sottolineato il valore unico dei
mezzi espressivi del Fiorentino, legandoli a doppio filo con il misticismo medievale. In Dante riconobbe esplicitamente che “il metodo allegorico era un procedimento ben preciso e non limitato alla sola Italia”25, radicato com’era nella
cultura europea del tempo. Esso era la forma intellettualizzata di un processo
spontaneo attraverso cui l’uomo interpretava la realtà.
Nel definire l’allegoria una “disposizione mentale”, Eliot mostrava quindi di
credere ad una coscienza mitica, di vichiana memoria, che si rappresentava
l’universale come fosse cosa concreta: i fenomeni divenivano dei “simboli esistenziali”26 dell’ordine divino. Per questo motivo egli era contrario ad una lettura del poema dantesco che si limiti ad una decodificazione simile ad un gioco
di enigmistica; è necessario, invece, tentare di penetrare quella mentalità
emblematica che consente “a chi possiede un’idea di esprimerla in immagini”27. Dante possedeva una “immaginazione visiva”; ciò gli era possibile perché
“visse in un’epoca in cui la gente aveva ancora delle visioni”28. La mentalità
medievale portava l’uomo a spiegare quelle visioni in termini metafisici, mentre il mondo moderno conosce solo “l’esperienza del sogno”, ovvero una esperienza interiore di cui si dà una spiegazione psicologica materialista, avente
“origine dal basso”.
Il Fiorentino aveva vissuto delle esperienze sulle quali aveva riflettuto in
seguito e dalle quali era nata l’idea; aveva poi trasformato quell’idea in visione, servendosi spesso di quelle stesse esperienze –una visione strutturata dal
sistema filosofico-religioso del suo tempo.
Sebbene Eliot in questo saggio non facesse riferimento alla Epistola XII
scritta da Dante a Can Grande della Scala, queste riflessioni dimostrano che
egli era ben conscio della “eterodossia” del metodo allegorico dantesco. In
quella lettera l’Alighieri annullava implicitamente la separazione fra l’allegoria
dei teologi e quella dei poeti esposta nel Convivio. La prima non era strumento creativo ma interpretativo, al fine di cogliere il valore simbolico e parabolico
dei testi sacri. I fatti narrati nella Bibbia venivano considerati come storicamente avvenuti e aventi allo stesso tempo significato traslato su tre livelli:
morale, allegorico ed anagogico.
SAGGI
Questa polisemia veniva da Dante chiarita attraverso l’accenno all’episodio
biblico dell’uscita del popolo di Israele dall’Egitto. Secondo il senso morale essa
significava la liberazione dell’anima dal peccato; secondo quello allegorico la
redenzione attuata da Cristo; secondo quello anagogico il passaggio dell’anima
dalla schiavitù del mondo terreno alla libertà della vita eterna. Quella interpretazione era anche tipologica: i fatti avvenuti nel passato erano la prefigurazione di quelli futuri, soprattutto di quelli legati alla vita di Cristo. Anche la concezione della storia veniva in tal modo informata della coscienza mitica, in quanto poggiava le sue basi sulla fede in un ordine provvidenzialistico. Ciò era valido non solo a livello collettivo, ma anche individuale: nell’esperienza terrena di
ogni uomo vi sono eventi che rimandano ad un progetto divino, ed ogni essere
umano reca in sé l’impronta del percorso di Cristo sulla terra.
L’allegoria dei poeti era quella della “veritade ascosa sotto bella menzogna”, ovvero il metodo allegorico come strumento artistico. In questo caso ci
si serviva di racconti fittizi per comunicare idee astratte, spesso legate alle dottrine della Chiesa e alle vite dei Santi. Dante aveva alle spalle una tradizione
di personificazioni e racconti allegorici, di visioni fantastiche o oniriche, ed Eliot
non ignorava questo retaggio se nel suo saggio ricordava il Roman de la
Rose, annoverandolo fra quelle che definiva “composizioni stucchevoli”.
Associare la sua opera all’allegoria dei teologi non servì al Fiorentino solo
per dare ad essa maggiore autorità agli occhi di un benefattore, ma per proporre un modello interpretativo inedito. Nell’accostare la sua visione ad una
lettura tipologica, egli conferì significato nuovo ai fatti della storia umana e a
quelli della sua esperienza privata. Le astratte personificazioni, presenti anche
nella Vita Nuova, vennero a questo scopo sostituite da personaggi realmente
esistiti o tratti dal mito e dalla letteratura, caratterizzati in maniera estremamente realistica. Eliot mostrò di aver colto la profonda motivazione morale
implicita in questa rivoluzione allorché affermò: “la conoscenza dell’intero
poema ci rivela in quale modo astuto e convincente Dante faccia apparire
come persone vere i contemporanei, gli amici e i nemici, personaggi recenti,
figure leggendarie, bibliche o dell’antica narrativa. Egli è stato accusato e compatito per aver appagato i propri rancori mettendo nell’Inferno uomini che
aveva conosciuto e odiato; ma costoro […] vengono completamente trasformati, poiché ognuno, sia esso vero o inventato, rappresenta un tipo di peccato, di sofferenza, di colpa o di merito, e tutti vengono a far parte di una medesima realtà e contemporaneità”29. La visione mistica si fondeva così con l’indagine della condition humaine, osservata da un io drammatico dichiarato fin
dall’inizio al fine di registrare la reazione emotiva all’esperienza ultraterrena.
Nel saggio del ’29, così come in quello del ’20, non si trova una spiegazione rigorosamente analitica di questa eccezionalità dantesca o dei motivi per
cui Dante può essere considerato un rivoluzionario della poesia. Eliot condusse sempre le sue argomentazioni con un metodo che rivela la sua sensibilità
di poeta. Eppure la sua lettura metafisica dello stile dantesco ha apportato un
contributo di non poco conto all’interno dell’esegesi novecentesca della
Commedia. Occorre inoltre rilevare che nel secondo scritto sul Fiorentino, a
differenza del primo, Eliot si soffermò sulle condizioni storiche che avevano
49
50
favorito la creazione del poema sacro e non mancò di mettere in luce, seppur
brevemente, il ruolo svolto dalla tradizione poetica di cui l’Alighieri era figlio,
nel contesto della sua lettura della Vita Nuova.
Il critico A. C. Charity era nel giusto allorché sosteneva che Eliot avrebbe
dovuto prestare più attenzione al peso che la rivoluzione letteraria dei predecessori e contemporanei di Dante aveva avuto sulla Divina Commedia30.
Tuttavia, lo scrittore anglo-americano era consapevole del valore di quella
rivoluzione se, in merito al libello, affermava: “La comprensione dell’opera
risulta molto più facile se si conoscono Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti,
Cino da Pistoia e altri. Si dovrebbe, in realtà, studiare lo sviluppo della poesia
d’amore dai poeti provenzali in poi tenendo conto sia delle somiglianze che
delle differenze sostanziali, come pure lo sviluppo della forma del verso, della
strofa e del lessico”31.
Una “lacuna” ulteriore di Eliot può essere rintracciata nel non aver registrato le varie fasi del percorso della filosofia medievale dell’amore, fondamentali
per comprendere quella contenuta nell’opera dantesca. In essa il termine
amore ha uno spettro semantico vastissimo che va dal sentimento più terreno
ad una ispirazione artistica di natura metafisica, all’istinto al bene innato in tutte
le creature, fino ad identificarsi col Dio creatore ed ordinatore dell’universo.
Nonostante ciò, egli dimostrò di aver colto la complessità di quel concetto
filosofico. Riconobbe ad esempio che l’episodio di Paolo e Francesca, pur godibile fin da una prima lettura, poteva essere pienamente compreso solo alla luce
dell’intero poema. Non si trattava soltanto della difesa di una interpretazione
organica della Commedia, ma anche del riconoscimento di una concezione dell’amore strutturata secondo l’etica cristiana. E a proposito dell’episodio di
Arnaut Daniel sottolineava “quanto la fiamma del Purgatorio sia diversa da
quella dell’Inferno”32. Nel Purgatorio il tormento del fuoco viene accettato dalle
vittime della passione amorosa come lasciapassare per la beatitudine.
Se da un lato i saggi eliotiani appaiono, soprattutto al lettore italiano, ingenui o frettolosi in taluni passaggi, dall’altro rivelano l’assenza di timore reverenziale nell’accostarsi al poema sacro. Questa “spregiudicatezza” nasceva
dalla volontà di fare di Dante un modello per la propria poesia, dando risalto
ad alcuni aspetti della Commedia e trascurandone, inevitabilmente, altri.
Anche l’amico Ezra Pound aveva del resto letto in modo parziale l’opera
dantesca, dimostrando scarso interesse, ad esempio, per le vicende biografiche –di natura sentimentale, intellettuale, politica, sociale– dello scrittore
medievale, strumentalmente al proprio ideale di poesia impersonale, in cui il
soggetto creatore scompare dalla sua opera. Questa “parzialità” si era estesa, clamorosamente, anche ad alcune figure centrali dell’Inferno, quali Ulisse,
Guido da Montefeltro o Brunetto Latini. Ciò era dovuto non solo all’entusiasmo che quei personaggi avevano suscitato presso quegli autori romantici
contro cui Pound condusse la sua battaglia, ma anche alla tendenza dell’autore dei Cantos ad ignorare la profonda risonanza morale e drammatica degli
incontri con essi; è attraverso quegli incontri che Dante procede nella scoperta del peccato anche dentro se stesso. Gli “errori” poundiani nascevano
dal profondo scetticismo nei confronti di quella che egli chiamava la “Aquinas
SAGGI
map” dantesca e dei significati religiosi della Commedia. Quella secolarizzazione appare per altro evidente nella sua interpretazione del viaggio di Dante
come simbolo del “cammino faticoso dell’umanità dall’ignoranza alla luce limpida della filosofia”33. Per Pound, Dante era soprattutto un maestro di stile, e
della sua opera egli accolse solo la corrente del pensiero politico, in particolar modo la lotta all’usura.
Sebbene l’autore dei Cantos avesse poi avuto peso notevole nell’acquisizione, da parte dell’amico, dell’Alighieri quale modello di poesia, la parzialità
della lettura eliotiana è di tutt’altro genere. Al contrario di Pound, ciò che interessò maggiormente Eliot fu proprio la dimensione mistica e auto-conoscitiva
del viaggio dantesco nell’oltretomba, il quale “non è un luogo ma uno stato”34.
Né egli smise mai di sottolineare l’importanza della filosofia e della religione
come sostrato indispensabile della Commedia. Egli riuscì a cogliere, molto più
di Pound, il senso profondamente cristiano dell’opera dantesca, non solo nelle
sue implicazioni escatologiche, ma anche nella sua filosofia di vita. Ne è prova
evidente la parte del saggio dedicata alla Vita Nuova, che costituisce l’aspetto indubbiamente più innovativo della sua interpretazione di Dante, e che è
utile anche per illuminare la poesia dello stesso Eliot.
Per lui il libello è “una mescolanza di biografia e allegoria”35. Esso non è
però una confessione nel senso moderno del “met son coeur a nù”: il dato
esperienziale privato –l’ “esperienza sentimentale” avuta a nove anni– venne
da Dante utilizzato strumentalmente a posteriori, caricato di valore rappresentativo. L’incontro con Beatrice rappresentava l’inevitabile risveglio al peccato
cui è destinato ogni essere umano, e in quanto tale esso possiede valore filosofico e impersonale. Il processo di sublimazione della donna che gli aveva
ispirato un amore sensuale differisce però in modo sostanziale dalle spiegazioni della psicologia moderna. In essa è sempre presente la spinta religiosa,
ciò che Eliot sapeva bene essere derivazione di un topos della poesia contemporanea a Dante: l’amore poteva divenire strumento per avvicinarsi
all’Assoluto. Così si pronunciava lo scrittore: “È possibile capire l’atteggiamento di Dante verso l’esperienza fondamentale della Vita Nuova se impariamo a trovare un senso nelle cause finali piuttosto che nelle origini […] La
causa finale è l’attrazione verso Dio”36. La Vita Nuova poggia sulla filosofia cattolica della “disillusion”, ovvero sul rifiuto di idealizzare i rapporti fra uomo e
donna, così come qualsiasi altro oggetto del desiderio umano, e sulla consapevolezza che la perfetta felicità è raggiungibile solo dopo la morte, in Dio.
Il saggio del 1930 su Charles Baudelaire costituisce una guida ulteriore
nella comprensione delle opinioni espresse riguardo la Vita Nuova, e della
concezione eliotiana dell’amore, maturata in gran parte sotto l’influsso dantesco. Nell’opera dello scrittore francese, al di là della presenza corposa di elementi romantici, Eliot intravedeva la consapevolezza del Male strutturale all’umanità, ed il suo satanismo ne è prova concreta: “quel che interessa a
Baudelaire non sono i demoni, le messe nere, la bestemmia romantica, ma il
problema del bene e del male. Il fatto che egli usi il sistema d’immagini corrente e il vocabolario del blasfemo non è che una diretta conseguenza dei
tempi”37. Rendersi conto che l’uomo è tale in quanto è cosciente che ogni sua
51
52
azione può essere buona o malvagia significa ammettere la possibilità della
dannazione e quindi, per contrasto, della beatitudine: “il riconoscimento della
realtà del peccato rappresenta una nuova vita”38. La “nuova vita” non era dunque per Eliot una formula consolatoria, bensì la lacerante presa di coscienza
dei limiti invalicabili dell’uomo, lo smascheramento di qualsiasi forma di mistificazione idealistica.
Questo scetticismo palesava il retaggio puritano di Eliot e l’influenza di
Charles Maurras e di altri pensatori contemporanei: in entrambi i casi il mito
del peccato originale costituiva la base di partenza di una rigida separazione
fra bene e male e di una concezione pessimistica dell’uomo. Non a caso il saggio su Baudelaire chiude con una riflessione di T. E. Hulme circa la necessità
di un ordine etico e politico che disciplini le azioni umane nella società; il presupposto di quella riflessione era appunto l’eredità della caduta di Adamo39.
A queste influenze Eliot aggiunse la suggestione esercitata dalla teoria dell’anima dantesca, espressa poeticamente nel canto XVI del Purgatorio. Il
brano in cui Marco Lombardo espone a Dante quella teoria era stato da Eliot
riportato per intero nel saggio del ’2940. In quei versi l’Alighieri ribadiva il concetto filosofico, già espresso nel Convivio, poggiante, secondo Eliot, sul De
Anima di Aristotele: l’anima arriva nel mondo come una sorta di tabula rasa,
pronta a ricevere ogni tipo di impressione. Poiché essa procede direttamente
da Dio è istintivamente predisposta al bene; nella ricerca della felicità, tuttavia,
essa è destinata a rivolgere il suo desiderio verso beni minori. Per questo
motivo ha bisogno di una autorità esterna che attraverso le leggi guidi il suo
amore –termine in questo caso utilizzato nell’accezione di impulso all’azione.
La poesia Animula, del 1929, testimonia la profonda impressione che quel
brano aveva avuto su Eliot. Doveva essere uno di quelli imparati a memoria in
gioventù, quando aveva sempre sotto mano una edizione tascabile della
Divina Commedia con la traduzione a fronte. In essa fuse il richiamo al canto
XVI del Purgatorio a quella concezione pessimistica appena evidenziata. Il
componimento si apre con “Esce di mano a Dio, l’anima semplicetta”, proiettandolo immediatamente in atmosfera dantesca; ma più avanti è possibile
scorgere l’impronta del dualismo puritano e del pessimismo cristiano: “Il
pesante fardello dell’anima che cresce / Rende perplessi e offende sempre
più, di giorno / in giorno; / Di settimana in settimana offende e sempre più /
Rende perplessi con gli imperativi dell’ “essere e apparire” / E del si può e non
si può, del desiderio come del ritegno. / Il dolore del vivere e la droga dei sogni
/ Piegano l’anima che siede / Accanto alla finestra dietro l’Encyclopaedia
Britannica”41.
Dalla strutturale limitatezza umana nasce, per Dante come per Eliot, l’errore circa l’amore terreno. Eliot rintracciava anche in Baudelaire una vaga consapevolezza di ciò: “Baudelaire ha avuto la percezione che ciò che distingue il
rapporto uomo-donna dall’accoppiamento animalesco è la coscienza del bene
e del male”42. Tuttavia, lo scrittore francese non era stato in grado di trascendere quel tipo di amore e di giustificarlo alla luce di un “higher love”. Fu proprio
per evidenziare questo fallimento che Eliot scelse di costruire la sua critica a
Baudelaire servendosi della comparazione con Dante: “Complemento e corre-
SAGGI
zione dei Journaux Intimes […] sono la Vita Nuova e la Divina Commedia”43.
In Baudelaire egli vedeva la stessa spinta ideale e gli stessi limiti ravvisati
pochi anni prima, all’interno delle Clark Lectures, in Jules Laforgue, anche in
quel caso servendosi della lente dantesca, e della Vita Nuova in particolare.
Laforgue aveva posseduto un innato desiderio di ordine, ovvero di una giustificazione filosofica a qualsiasi tipo di sentimento. Ma anch’egli, come John
Donne, aveva vissuto in un’epoca di “disordine intellettuale” che gli aveva
impedito di inserire le idee e le emozioni entro un sistema organico di pensiero. A causa di ciò la poesia di Laforgue, come quella di Donne, era condannata a non superare i limiti di un atteggiamento immaturo di disillusione adolescenziale. Dante, invece, grazie alla filosofia del suo tempo, era riuscito a
“utilizzare e a trasformare, invece di disperderle, le esperienze emotive dell’adolescenza”44. La Vita Nuova costituisce il miglior commento alla Divina
Commedia, poiché in essa l’Alighieri aveva posto le basi della “trasformazione marina” di eros in caritas portata a compimento nel poema sacro.
John Donne, Jules Laforgue e Charles Baudelaire erano stati punti di riferimento importanti dell’ars poetica eliotiana; quegli autori gli avevano insegnato l’uso di un linguaggio antipoetico e di immagini tratte dall’esperienza comune, da utilizzare per la costruzione di quadri espressionistici. Nella critica a
quegli scrittori è quindi possibile ravvisare un ripensamento sulla sua stessa
attività artistica, grazie alla nuova lezione appresa da Dante. Essa integrava
ed ampliava la funzione fino ad allora svolta dal Fiorentino, maestro di lingua
e di stile. Nel rileggere l’opera dantesca, Eliot aveva scoperto che è possibile
trascendere la sofferenza grazie ad un principio d’ordine più alto, manipolando a posteriori le esperienze più intense della propria vita e conferendo loro
valore filosofico universale.
Questa operazione può per altro illuminare la poesia eliotiana precedente
alla conversione alla luce di un progetto, sebbene essa non fosse stata scritta con quella intenzionalità, almeno non in modo del tutto consapevole. Da
questo angolo visuale possono essere lette le fallimentari esperienze eroticosentimentali, o la fuga da esse nel regno dell’elucubrazione e dell’autoillusione, narrate in The Love Song of J. Alfred Prufrock, in Portrait of a Lady, in La
Figlia che Piange, in Dans le Restaurant.
In The Waste Land tutti i tipi di fallimento nei rapporti uomo-donna assumono dimensione cosmica e archetipica: in “The Burial of The Dead” la “ragazza dei giacinti”45 viene accostata a Tristano; in “A Game of Chess” l’arazzo in
cui è istoriata la vicenda di Filomela “così brutalmente forzata” campeggia
nella sala in cui un lui ed una lei non ben identificati danno prova di radicale
incomunicabilità: “A cosa stai pensando? Pensando cosa? Cosa? / Io non so
mai che cosa pensi. Pensa”. / Io penso che stiamo nel vicolo dei topi / dove i
morti hanno perso le loro ossa”46, e via dicendo.
In Ash-Wednesday (1930) l’amore umano trova infine la via del riscatto e
della purificazione. L’autore stesso riconobbe che il poemetto del ’30 era un
primo tentativo di adattamento della filosofia della Vita Nuova alla vita moderna. Se il sostrato concettuale è simile a quello del libello, il repertorio si rifà
invece, perlopiù, alla Commedia, nelle allusioni esplicite e nel materiale imma-
53
54
ginifico. Con questi strumenti a disposizione, Eliot costruì un componimento in
cui l’io narrante racconta il cammino lento e faticoso della sua anima lungo il
percorso di purgazione, reso possibile dalla presa di coscienza del peccato e
dal conseguente pentimento. Per sottolineare la sacralità di questo viaggio
interiore, conferì tono liturgico ad ognuna delle sei parti, attraverso l’inserimento di rapidi cenni alle preghiere del rito cristiano o alla Bibbia o, nel caso
della Parte II, attraverso l’invocazione alla “Signora dei Silenzi”, facilmente
identificabile con la Vergine. Questo accostamento è giustificato anche dai
richiami a Dante, sia nel simbolo della rosa che nei versi “Quieta e affranta /
Consunta e più integra” e “Esausta e feconda / Stanca che dai riposo”47, che
ricordano la preghiera di S. Bernardo alla Vergine con cui si apre il canto
XXXIII del Paradiso: “Vergine Madre, figlia del Tuo Figlio, / umile e alta più che
creatura, / termine fisso d’etterno consiglio, / tu sei colei che l’umana natura /
nobilitasti sì, che ’l suo fattore / non disdegnò di farsi sua fattura. / Nel ventre
tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / così è germinato
questo fiore”48. Sia nella preghiera di Eliot che in quella di Dante la Madonna
viene denotata attraverso una serie di antitesi, ad indicare che in lei il tempo
e l’eternità si sono incontrati nell’Incarnazione. Ella è l’epitome di tutte le figure femminili presenti in Ash-Wednesday, aventi funzione di mediazione simile
a quella svolta dalle donne dantesche, da Beatrice a Matelda a S. Lucia. Molte
energie sono state spese dagli studiosi di Eliot nel tentativo di stabilire se si
tratti di un unico personaggio che racchiude in sé tutte quelle, sorta di “spettro
familiare composito”49 al femminile, o se invece Eliot avesse voluto distinguerle anche come personaggi. Ciò che è importante, in questa sede, è rilevare la
diretta influenza di Dante su questa invenzione poetica eliotiana, sia nei modi
di caratterizzazione, sia nel ruolo ad essa accordato, ovvero di mediazione fra
l’amore umano e quello divino, di guida dal peccato alla redenzione e dalla
terra al cielo.
Si è scelto di focalizzare l’attenzione sullo stretto rapporto fra il percorso
intellettuale e spirituale di Eliot e l’evoluzione della sua teoria letteraria, osservata dall’angolo visuale privilegiato dello studio di Dante. A questo scopo,
maggiore rilievo è stato dato all’influenza del metodo allegorico dantesco sull’arte eliotiana e alla dottrina dell’amore così come fu da lui recepita e riutilizzata. Vi sono tuttavia due altri punti su cui è opportuno spendere qualche parola, in quanto strettamente correlati a quelle questioni.
Come si è già avuto modo di osservare, Dante rappresentava per Eliot in
primo luogo il modello più alto per chiunque voglia scrivere, in qualsiasi lingua.
Egli giunse a questa consapevolezza dopo anni di riletture e di ripensamenti
sugli autori che più lo avevano impressionato ed influenzato lungo la sua
maturazione letteraria ed intellettuale. Nel saggio del ’29 pagò il suo tributo
definitivo alla poesia dantesca, convinto della sua “estrema facilità di lettura”50.
Ciò non significa che Eliot credesse che i concetti in essa espressi siano facili da comprendere, ma che la lingua e lo stile utilizzati hanno una “particolare
lucidità” che consente al lettore di provare apprezzamento estetico anche ad
un primo approccio. È importante rilevare, fra l’altro, che le riflessioni eliotiane
sulla lingua di Dante sconfinano dal campo strettamente letterario, poiché
SAGGI
anch’esse nascevano dal “bisogno” di vedere nello scrittore medievale il prodotto del pensiero tomistico e dell’ortodossia religiosa, nella sua ricerca di un
ordine esterno all’io individuale. Nell’opinione di Eliot, infatti, l’eccezionalità
dell’arte dantesca era dovuta alla stretta parentela fra l’italiano del Fiorentino
ed il latino medievale, idioma largamente condiviso e nato in seno all’unità culturale e spirituale dell’epoca. È anche grazie ad esso che Dante è poeta più
universale di Shakespeare, di Moliére e persino di Sofocle. Anch’essi avevano trasfigurato poeticamente, raggiungendo vette altissime, materiale universalmente umano, ma gli strumenti a loro disposizione erano più “locali” di quelli danteschi. Le loro lingue erano il risultato di un carattere nazionale più marcato. La lezione appresa dall’Alighieri venne dunque ad integrare quella dei
simbolisti francesi. Dal “volgare illustre” Eliot imparò ad operare una continua
askesis sul linguaggio al fine di restituire al lettore un idioma semplice e al
tempo stesso in grado di allargare i confini della sfera emotiva. Ciò che lo spettro dice al protagonista nell’episodio “dantesco” di Little Gidding, II può essere ugualmente riferito a Eliot e a Dante: “Poiché ci occupammo di parole, ed
esse ci spingevano / A purificare il dialetto della tribù / E a indirizzare la mente
a deduzioni e previsioni”51. Questo spiega perché, in What Dante Means To
Me, Eliot definì l’insegnamento dantesco una “lezione morale”.
Il secondo punto su cui è utile focalizzare l’attenzione è il problema del rapporto fra poetry e belief, da Eliot affrontato nel saggio del ’29 e ricollegabile a
quello della relazione fra filosofia e poesia presente nello scritto del 1920.
Esso era già stato trattato in Shakespeare and the Stoicism of Seneca, del
1927, dove l’accento era stato posto sul legame fra l’autore e le sue credenze, fino a proclamare l’autonomia dell’arte rispetto alla filosofia ed alla religione presenti in un’opera. Non è importante stabilire se uno scrittore creda oppure no al sistema di pensiero contenuto nella sua poesia, ma l’uso che riesce a
farne ai fini della sua arte: “Io dubito che la credenza propriamente detta rientri nell’attività di un grande poeta in quanto poeta. Cioè Dante, in quanto poeta,
non accettò né rifiutò la cosmologia tomistica o la teoria dell’anima: semplicemente ne fece uso, o ebbe luogo una fusione fra i suoi iniziali impulsi emotivi
e una teoria, allo scopo di produrre poesia“52.
Nel saggio del ’29 egli ribadì questa separazione, ma affrontò il problema
anche dal punto di vista del rapporto fra il lettore ed il belief. Pur ammettendo
la possibilità di un godimento estetico che prescinda dalla condivisione delle
credenze dell’autore, Eliot riconosceva la sua difficoltà personale nel separare
del tutto le due sfere: “[…] Posso solo concludere che non mi è possibile, in pratica, separare il mio apprezzamento poetico dalle mie credenze personali”53.
Eliot amò ad esempio la poesia di Shakespeare, ma solo a Dante poté accordare assenso totale; questo scarto fu da lui esemplificato e sintetizzato attraverso il confronto fra il verso shakespeariano “La maturità è tutto”54 e quello
dantesco “E ‘n la Sua Volontade è nostra pace”55. Il primo aveva un “profondo
significato emotivo”, ma solo la frase di Dante era per lui “letteralmente vera”.
Il tentativo di Eliot fu dunque quello di conciliare la consapevolezza di poeta
della necessità dell’autonomia dell’arte con la sua fede religiosa. Ma fu lui
stesso ad ammettere che, in questo caso, è impossibile trovare alcuna vera
55
56
conciliazione: “Il problema della credenza è assai complicato e forse del tutto
insolubile”56.
L’influenza di Dante su Eliot ha dunque radici di varia natura e il modo in
cui essa si manifesta nella sua opera non si limita al calco testuale o alle allusioni all’interno della sua poesia, ma informa di sé la teoria letteraria ed in un
secondo momento anche il pensiero filosofico-religioso dell’autore, riverberandosi anche per tale via sulla produzione artistica. Eliot sentì fin da giovanissimo che la ancor breve tradizione americana a sua disposizione non gli
era sufficiente; d’altro canto solo un americano avrebbe potuto con tanto fervore sottolineare l’importanza di un riferimento costante all’Europa come centro organico culturale prima, politico e religioso poi. Era in fondo un’idea, come
secoli prima lo era stata per Dante. Proprio Dante costituiva il modello supremo di quell’idea.
Non è semplice chiarire se siano state le convinzioni estetiche, etiche e
teologiche di Eliot a spingerlo nella direzione dantesca o se, al contrario, fu
l’Alighieri a indirizzarlo verso quelle convinzioni. È problema forse insolubile e
tutto sommato secondario. Spesso la strada che conduce uno scrittore a prediligere alcuni referenti piuttosto che altri ha a che fare con condizioni storiche
e biografiche incidentali. Probabilmente le forze e gli stimoli variegati che agirono su Eliot esercitarono una costante azione reciproca, fino a condurlo alle
soglie della religione.
È stato spesso affermato che le posizioni iniziali di Eliot furono di assoluto
nichilismo. Tuttavia, più che di un percorso dall’ateismo al Cristianesimo, si
deve pensare ad una evoluzione dallo scetticismo alla fede. Il dubbio in Eliot
fu piuttosto uno stadio iperbolico del suo approdo nell’ortodossia religiosa, un
atteggiamento “pascaliano” che gli servì per reagire ad una crisi privata e storica molto profonda. L’attrazione per la coerenza e la razionalità della dottrina
e della mitologia cristiane traspare peraltro fin dai saggi contenuti in The
Sacred Wood, in Blake ad esempio, o in Tradition and The Individual Talent,
mentre il rifiuto di un’arte edonistica ed autoreferenziale appare evidente fin da
The Love Song of J. Alfred Prufrock, e poi in Gerontion e in The Waste Land.
Queste poesie hanno carattere satirico in quanto contengono una critica feroce della società contemporanea; ma l’osservazione della realtà si fonde sempre ad una indagine dell’uomo nella sua essenza, con i suoi limiti, le sue autoillusioni e le sue debolezze in ogni epoca e luogo della terra. Tutto ciò rivela la
profonda spinta morale che sempre guidò Eliot nella creazione artistica.
L’approdo nel Cristianesimo, ufficializzato nel 1927, fu l’evoluzione naturale, per quanto sofferta, di un atteggiamento esistenziale presente da sempre.
Parallelamente al suo percorso in senso dogmatico e anti-liberale Eliot approfondì il suo rapporto con Dante, pur non rinnegando nessuna delle opinioni
espresse in precedenza. Anzi, la lettura della Commedia, nata anche dalla
viva conversazione con Pound, aveva aiutato Eliot a superare il dualismo tradizionale fra forma e contenuto, perenne tentazione critica, e a portare avanti
un organicismo letterario non solo nei confronti del poema sacro ma di qualsiasi opera d’arte.
Né Eliot aveva dimenticato che il Fiorentino è innanzitutto maestro di craft-
1
T. S. ELIOT, What Dante Means To Me, in To Criticize The Critic, a c. di V. Eliot, Faber and
Faber, Londra 1965; trad. it., Opere, a c. di R. Sanesi, Bompiani, Milano 1992, v. II, p. 948. Le citazioni dei brani dai saggi di Eliot verranno d’ora in avanti riportate nella traduzione di Sanesi.
2
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, a c. di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier, Milano
1993, canto I, v. 85.
3
E. POUND, The Spirit of Romance, Dent & Son, Londra 1910; cfr. M. PRAZ, T. S. Eliot e Dante,
in Machiavelli in Inghilterra, Tumminelli, Roma 1942, p. 341.
4
T. S. ELIOT, Tradizione e Talento Individuale (1919), in Opere, cit., vol. I, p. 397.
5
ID., Amleto e i suoi Problemi (1919), in Opere, cit., vol. I, p. 366.
6
ID., I Poeti Metafisici (1921), in Opere, cit., vol. I, p.575.
7
ID., Dante (I) (1920), in Opere, cit., vol. I, p. 423.
8
Ivi, p. 417.
9
Ivi, p. 419.
10
Ibidem.
11
D. ALIGHIERI, Inferno, cit., canto XV, vv. 123- 124. La figura di Brunetto Latini, e la rete complessa di nuclei morali ad essa collegati, fu una delle fonti precipue di ispirazione dell’episodio
“dantesco” contenuto in Little Gidding, II, in Four Quartets, Harcourt, Brace & Co., New York 1943.
12
T. S. ELIOT, Dante (I), cit., p. 422.
SAGGI
manship, del mestiere di scrivere poesia. Questi aveva mantenuto saldo il
legame con le radici classiche e latine e, contemporaneamente, aveva nobilitato l’idioma del volgo, facendolo accedere al Parnaso. Era quindi l’esempio
più alto dell’incontro tra tradizione e talento individuale. Ma queste lezioni poetiche acquistarono in seguito nuove sfumature, fondendosi con altri tipi di valutazione, nati da spinte extra-letterarie. Allo stesso tempo, Dante divenne una
sorta di “touchstone poet”, una pietra di paragone attraverso la quale giudicare i risultati degli altri poeti, anche grandi, che Eliot aveva amato e da cui era
stato influenzato.
La dottrina dell’amore di Dante, la sua concezione della presa di coscienza del peccato, la sofferenza insita nella purgazione, così diversa dalla sofferenza romantica chiusa in se stessa, il perfetto adeguamento della volontà
umana a quella divina come unica via alla beatitudine, entravano nella poesia
di Eliot completamente trasfigurate, a fornire l’unica via di uscita all’ennui della
vita moderna. Questo offre lo spunto per un rapido accenno ad un aspetto
ulteriore della multiforme influenza del Fiorentino: Eliot, senza esserne pienamente consapevole, accolse l’elemento profondamente agostiniano dell’opera
dantesca, ovvero la conoscenza di sé e del peccato dentro se stessi come
premessa necessaria all’avvicinamento al divino. E che Eliot avesse trovato
nella filosofia neo-platonica ed agostiniana una integrazione sostanziale alla
filosofia bergsoniana è comprovato dalle numerose allusioni presenti nei Four
Quartets, testamento poetico dell’autore. Del resto si è già sottolineata la predilezione eliotiana per gli aspetti mistici del “viaggio” dantesco e la sua attrazione verso il misticismo medievale, espressa nelle Clark Lectures.
Alla luce di un debito così variegato e complesso, non è dunque forse fuori
luogo affermare che Eliot avrebbe potuto dire a Dante ciò che Stazio disse a
Virgilio: “Per te poeta fui, per te cristiano”57.
57
Ivi, p.421.
Ivi, pp. 422-423.
15
Ivi, p. 424.
16
D. ALIGHIERI, Paradiso, cit., canto I, vv. 67-69.
17
Ivi, vv. 70-71.
18
T. S. ELIOT, Ulysses, Ordine e Mito (1923), in Opere, cit., vol. I, p.646.
19
“Città irreale, / Sotto la nebbia bruna di un’alba invernale, / Una folla fluiva sul London
Bridge, tanti, / Ch’io non avrei creduto che morte tanti n’avesse disfatti. / Sospiri, brevi e radi, venivano esalati, / Ed ognuno fissava gli occhi davanti ai suoi piedi”: T. S. ELIOT, La Sepoltura dei
Morti, in The Waste Land (1922), a c. di A. Serpieri, BUR, Milano 1985, vv.60-65. Fu lo stesso Eliot
a riconoscere, nelle Note aggiunte all’edizione in volume del 1922, il richiamo diretto, nel verso
63, ai vv. 55-57 del canto III dell’Inferno –“sì lunga tratta / di gente, ch’io non avrei creduto / che
morte tanta n’avesse disfatta”– e, nel verso 64, ai vv. 25-27 del canto IV– “Quivi, secondo che per
ascoltare, / non avea pianto mai che di sospiri, / che l’aura etterna facevan tremare”. Circa vent’anni più tardi Eliot avrebbe inoltre spiegato che quel tipo di debito serviva a “ridestare nella mente
del lettore la memoria di qualche scena dantesca, e di stabilire così una relazione tra l’inferno
medievale e la vita moderna”. Cosa Significa Dante Per Me, in Opere, cit., vol. II, p. 950.
20
ID., La Funzione della Critica, in Opere, cit., vol. I, pp. 633-634. In questo saggio la critica al
rifiuto di una autorità esterna da parte dell’estetica romantica e post-romantica dava il via ad
osservazioni che sconfinavano dal campo artistico per entrare in quello socio-politico e in quello
religioso. Eliot era convinto che l’atteggiamento mentale che porta ad una separazione fra classicismo e romanticismo conduce ad analoghe suddivisioni al di fuori della letteratura. Chi propende per il classicismo è maggiormente portato a riconoscere un principio d’autorità esterno all’individuo anche ad altri livelli: “Se l’interesse di un uomo è politico non potrà, io credo, che professare la sua fedeltà a dei principi, o a una forma di governo, o a una monarchia; e se è interessato a
una religione, e ha una fede, a una confessione religiosa”. In particolare, Eliot mostrava di non
credere ad una fede svincolata da un sistema di dogmi e di riti che disciplinino il sentimento religioso innato nell’uomo: “[…] il cattolico non ha mai creduto che lui e Dio siano la stessa cosa.
‘L’uomo che sinceramente s’interroga, finirà prima o poi con l’udire la voce di Dio’, dice Murry. In
teoria ciò conduce ad una forma di panteismo che, secondo me, non è di matrice europea”.
21
Si tratta di una serie di conferenze intitolate Lectures on The Metaphysical Poetry of
Seventeenth Century, generalmente denominate Clark Lectures, tenute da Eliot nel 1926 al Trinity
College di Cambridge. Le citazioni sono state ricavate da D. MANGANIELLO, T.S. Eliot and Dante,
Macmillan, Basingstoke 1989.
22
T. S. ELIOT, Clark Lectures, III: 3, in D. MANGANIELLO, op. cit., p.41.
23
Ivi, III: 7, p.109.
24
T. S. ELIOT, Riflessioni su Lambeth (1931), in Opere, cit., vol. I, pp. 991-992.
25
ID., Dante (II), in Opere, cit., vol. I, p. 831.
26
ENCICLOPEDIA DANTESCA, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma
1970, Commedia, 8, Allegoria, p. 94.
27
T. S. ELIOT, Dante (II), cit., p. 832.
28
Ibidem.
29
Ivi, p.837.
30
A. C. CHARITY, T. S. Eliot: The Dantean Recognitions, in The Waste Land in Several Voices,
a c. di A. D. Moody, Edward Arnold, Londra 1974, p. 133.
31
T. S. ELIOT, Dante (II), cit., pp. 864-865.
32
Ivi, p. 844.
33
E. POUND, The Spirit of Romance, cit.; cfr. S. ELLIS, Pound, Dante and Cavalcanti, in Dante
and English Poetry, Cambridge University Press, Cambridge 1983, p. 190.
34
T. S. ELIOT, Dante (II), cit., p.839.
35
Ivi, p. 861.
36
Ivi, p.863.
37
ID., Baudelaire (930), in Opere, cit., vol. I, p. 948.
38
Ibidem.
39
Ivi, p. 952: “T. E. Hulme doveva lasciarci un giudizio che Baudelaire avrebbe sottoscritto: ‘Alla
luce di questi valori assoluti, l’uomo stesso è giudicato un essere essenzialmente limitato e imper13
14
58
SAGGI
fetto. Ha in dote il peccato originale. Anche se di tanto in tanto può compiere delle azioni che
danno l’idea della perfezione, non potrà mai essere perfetto. Di qui alcune conseguenze secondarie rispetto all’azione quotidiana dell’uomo nella società. L’uomo è essenzialmente malvagio:
solo la disciplina, etica e politica, può fargli compiere qualcosa di valido. L’ordine, pertanto, non è
puramente negativo, ma creativo e liberatorio. Le istituzioni sono necessarie’ ”.
40
D. ALIGHIERI, Purgatorio, cit., canto XVI, vv. 85-96: “Esce di mano a lui che la vagheggia /
prima che sia, a guisa di fanciulla / che piangendo e ridendo pargoleggia, / l’anima semplicetta
che sa nulla, / salvo che, mossa da lieto fattore, / volentier torna a ciò che la trastulla. / Di picciol
bene in pria sente sapore; / quivi s’inganna, e dietro ad esso corre, / se guida o fren non torce suo
amore. / Onde convenne legge per fren porre; / convenne rege aver, che discernesse / de la vera
cittade almen la torre”.
41
T. S. ELIOT, Animula (1929), in Opere, cit., vol. I, p. 877.
42
ID., Baudelaire, cit., p. 950.
43
Ivi, p. 951.
44
ID., Clark Lectures, IV: 1, in D. MANGANIELLO, op. cit., p. 69.
45
T. S. ELIOT, La Sepoltura dei Morti, in The Waste Land, cit., v. 36.
46
Ivi, Una Partita a Scacchi, vv. 113-116.
47
ID., Mercoledì delle Ceneri, II, in Opere, cit., vol. I, p. 893.
48
D. ALIGHIERI, Paradiso, cit., canto XXXIII, vv. 1-9.
49
T. S. ELIOT, I Quattro Quartetti, Little Gidding, II, in Opere, cit., vol. II, p. 389.
50
ID., Dante (II), cit., p. 827.
51
ID., I Quattro Quartetti, cit., p. 391.
52
ID., Shakespeare e lo Stoicismo di Seneca, in Opere, cit., vol. I, p. 699.
53
ID., Dante (II), cit., p. 859.
54
W. SHAKESPEARE, King Lear, atto V, scena II.
55
D. ALIGHIERI, Paradiso, cit., canto III, v. 85. Quel verso, ed il suo nucleo etico e teologico, ritornano più volte nella poesia eliotiana. In Murder in The Cathedral (Assassinio nella Cattedrale)
(1935), il monito di Thomas a se stesso a rendere perfetta la volontà, unico vero viatico alla santità, è un chiaro rimando alla frase di Piccarda. Solo accettando senza alcuna riserva la volontà di
Dio è possibile raggiungere la beatitudine. Il verso è presente come citazione testuale nella parte
finale di Ash-Wednesday: “Our Peace in His will”.
56
T. S. ELIOT, Shakespeare e lo Stoicismo di Seneca, cit., p. 699.
57
D. ALIGHIERI, Purgatorio, cit., canto XXII, v. 73.
59
FILOSOFE
DEL
NOVECENTO*
IL FILO(SOFARE) DI ARIANNA
NEL LABIRINTO POSTMODERNO
di Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese
Che i manuali di filosofia riportino solo figure maschili, come se il pensiero
fosse appannaggio di uno solo dei due generi è cosa nota. L’identificazione tra
Logos e maschilità è ancora di prassi nell’insegnamento. Rispetto a questa
prassi, il libro che presentiamo Il filo(sofare) di Arianna raccoglie le provocazioni di una galleria di donne che contribuiscono a delineare il pensiero femminile quale tentativo di uscire dal labirinto postmoderno1.
60
Presenza e visibilità delle donne nella storia del pensiero
Sono donne che, pur differenti tra loro, si ritrovano alleate nel provocare,
anche a loro insaputa, una sorta di terremoto critico nei confronti della “ratio
occidentale”, con la sua ambizione di una neutralità inesistente, genericamente universale, di fatto maschile: “Il pensiero femminile è partito dalla critica alla
ratio occidentale, presentata come speculazione apparentemente neutra ed
universale, di fatto maschile” (p. 180). Una metafora è il velo di Maya: “Si deve
pertanto sollevare questa sorta di velo di Maya (Irigaray parla di specchio) rappresentato dall’universale, che nasconde un a priori arbitrario, radicale punto
cieco, l’assunzione cioè della prospettiva dell’uomo a rappresentazione del
genere umano” (p. 182). “Squarciare il velo di Maya forse non è ancora sufficiente, Irigaray parla di riattraversare lo specchio (speculum) che sottende ad
ogni speculazione, specchio cieco, che nasconde, nel quale finora si sono
annullate le differenze e le contraddizioni, per far riapparire il rimosso, per consentire quindi alla donna di ritrovare il luogo della sua autoaffermazione”.
Non si tratta soltanto di profili aggiuntivi rispetto a quelli classici, ma anche
di un modo di procedere diverso e più libero. Perciò risulta impossibile ricostruire il pensiero delle donne e\o di una singola pensatrice come fosse un
sistema: la chiave mosaicale dell’accostamento dei frammenti in un puzzle è
indispensabile per un approccio fecondo: “Contro il logos totalitario ed unificante si fa strada la ragione frammentaria inquieta, balbettante, critica e discontinua, da sempre trattenuta nei silenzi o nelle pieghe nascoste del Sapere,
* Questo dossier presenta i testi delle relazioni tenute nell’incontro del 14 dicembre 2002, presso il “Contro Italiano di Ricerche Fenomenologiche”, in Roma, a proposito del volume Il filo(sofare di Arianna.
Persona
Il senso proprio della persona emerge solo dalle differenze. Il termine persona viene declinato dalle donne in vario modo, ma sempre evitando che essa
sia intesa come un neutro, un’essenza predefinita, un apriori, una realtà da
analizzare a tavolino. La fenomenologia e la filosofia della Stein sono in questo senso un passaggio obbligato, come dimostra la Ales Bello, il cui saggio è
giustamente posto all’inizio del libro. Il vissuto diventa una volta per tutte
inscindibile dal pensiero. Specifica la Tortolici: “Il valore della persona, per A.
Heller, è universale quando si riferisce ai sentimenti; questi umanizzano il rapporto interpersonale e lo rendono particolare. E, se per un verso sono espressione della particolarità espressa dal vissuto della persona coinvolta in qualche cosa, per l’altro consentono il suo superamento nella forma della generalità. I sentimenti costituiscono la base (fisiologica) di un processo dinamico nel
quale si costruisce quanto è attorno ad essa, ma, cosa particolarmente importante, è che implicano la dimensione in cui il pensiero si realizza in azione” (p.
DOSSIER
ma presente nel mito o nella tragedia, nella metafora e nella fantasia, ragione
che parla delle donne e pone inquietanti domande” (p. 179). Le filosofe infatti
tracciano “un itinerario di cui non si conosce l’andamento o il termine, tentando l’interpretazione dei segni, disegnando una nuova mappa del mondo in cui
ci troviamo a vivere”2; “un sapere nuovo, un parlare diverso, una riflessione in
precario equilibrio tra un dire e un detto, tra parola e silenzio” (p. 179).
Sia che le donne pensino di partire dalla ricerca della verità in sé, sia che
pensino di partire dalla differenza di genere introducono un elemento di
sospetto nella cultura della totalità. Solo nella cultura postmoderna poteva
affermarsi una ”radicale pluralità” che rende possibile l’emergere delle differenze e offre quindi alle donne lo spazio per poter dire la propria nel concerto
delle posizioni discordanti. “Come è stato giustamente affermato il postmoderno rappresenta il congedo definitivo ad ogni desiderio di unità e dagli
aspetti oppressivi di questo desiderio. Esso è una radicalizzazione del pluralismo del moderno, nel senso di una sua trasformazione in ‘radicale pluralità’”
(p. 179). La cultura delle donne per certi versi si ricollega ai “maestri del
sospetto”. Se Marx ha introdotto il sospetto nel sapere teorico (condizionamenti economici: dote, scambio dei beni, l’attrazione di classe, endogamia), se
Freud lo ha introdotto nella coscienza (inconscio, attrazione sessuale, libido)
e Nietzsche nell’io (volontà di potenza, legami tra potere e amore), il femminismo ha reso lo stesso servizio corrosivo nei confronti dell’unità del genere
umano, affermando la differenza originaria (unidualità). La vivacità intellettuale delle donne ha costituito un punto di non ritorno rispetto all’idea dei rapporti tra l’uomo e la donna definiti per natura (quale?) e\o declinati solo sulla falsariga del romanticismo. Sarebbe ingiusto tuttavia giudicare questo pensiero
femminile solo in termini di rottura, di lagnanza e rivendicazione.
Significherebbe non riconoscere il valore costruttivo del loro pensare, come un
contributo positivo alla storia della cultura a partire dalla ricerca del senso della
differenza. Proprio questa ricerca è un’affermazione, più o meno consapevole
del valore della persona-in-relazione.
61
62
125). La Bettinelli fa un lavoro di recupero in questo senso a proposito della
Vanni Rovighi. La persona rivendica la sua corporeità: ciascuno ha un corpo
ma anche è il suo corpo: “La coscienza del corpo si identifica con l’affettività
originaria: per spiegarne il significato, si rifà alla teoria del conoscere come
aver presente qualcosa. Un aver presente che […] è presenza intenzionale e
presenza reale. Gli stati affettivi, quali la gioia e il dolore, il benessere fisico e
la stanchezza, sono miei, connotano il mio io. Ne è prova il fatto che “posso
tradurre l’affermazione ‘c’è un dolore’ con ‘sono addolorato’” (p. 55). La particolare attenzione alla problematica della persona si sviluppa nel pensiero della
Rovighi dal dato antropologico della corporeità a quello dell’anima: “Ero matricola –scrive la Sofia Vanni Rovighi– e fino ad allora avevo sentito parlare dell’anima in termini che, poi mi accorsi, erano cartesiani e niente affatto tomistici. Avevo sentito parlare dell’anima e del corpo in termini dualistici, anche
–anzi oserei dire specialmente– nella predicazione religiosa; la concezione
che trovavo nella questione 76 mi parve nuova, attuale, rispondente alla
nostra natura umana esperienza. Ebbi quindi la prima impressione che quei
medioevali non fossero affatto ‘colli torti’ e avessero il coraggio di riconoscere
che l’uomo non è puro spirito calato misteriosamente nel corpo, ma un unico
ente” (p.55). Sempre nella Vanni Rovighi la Bettinelli evidenzia l’attenzione alla
spiritualità della persona e alla sua libertà. “La libertà si sperimenta, è un dato
di esperienza si ha coscienza di essere liberi nelle nostre scelte”3. Il che riporta il pensiero della filosofa nel solco fenomenologico, con un progresso rispetto all’argomento kantiano che presuppone l’affermazione di una legge morale
come valore assoluto. L’atto libero si fonda perciò sulla volontà che è tendenza: “In quanto tendenza –conferma la Bettinelli– si distingue dall’istinto, che è
immediato, e si distingue specificamente dalla conoscenza” (p. 56). “Questo è
un dato fenomenologico: –conferma la Rovighi– altro è conoscere una cosa,
altro desiderarla o volerla; ma non si può desiderare o volere una cosa se non
se ne ha una qualche conoscenza”4.
Volendo dare applicazione metodologico-filosofica ad un pensiero che sia
intrinsecamente personalista e relazionale, è bene che l’uomo e la donna non
compiano percorsi paralleli, ma si conoscano e ri-conoscano nel concreto rapportarsi, non solo nel campo dell’intimità affettiva e della collaborazione fattiva, ma anche in quello del pensare, in maniera tale che l’uno possa inverare
o falsificare le affermazioni dell’altro, in un gioco dialettico delle parti che è
insieme agonico e irenico. Salvare le differenze e insieme l’universalità della
persona esige la capacità di pensare “a due voci” per dare senso compiuto ad
un orizzonte post-femminista e post-maschilista5.
Le caratteristiche del filosofare d’Arianna
Nonostante i contenuti diversi e la terminologia complessa (pensiero femminile, femminista, della differenza sessuale, pensiero al femminile) vi sono
tratti comuni nel pensare delle donne. La Brezzi offre una definizione indicativa: “un pensiero pensato da donne che fanno del loro essere donne il punto
DOSSIER
di partenza della loro esperienza pratica e teoretica o, detto altrimenti, si ritiene che la differenza di genere, mai problematizzata e considerata un accidente, determini una specificità femminile del pensiero stesso” (p. 180). Dal canto
nostro sottolineiamo alcuni di questi aspetti, già presentati da noi in alcuni
lavori precedenti e che sono rinvenibili in modi diversi nelle autrici presentate
nel testo in esame6.
a. La relazionalità dell’essere umano, che si manifesta piú marcatamente a
partire dal corpo e dal vissuto della donna. Lo conferma l’attenzione dedicata
nel libro alla C. Gilligan, che analizzando la formazione del giudizio morale nei
bambini, mette in luce la diversità tra uomo e donna nell’intendere i rapporti
umani. Si tratta di una diversità che vuole contrastare l’appiattimento unisex e
rivalutare la mutualità polifonica delle voci maschili e femminili. Viene rilevato,
d’accordo con Piaget, che mentre nei giochi infantili i maschi sono piú interessati alle regole, alle bambine interessano di piú i rapporti: gli uni –dovendo
scegliere– abbandonerebbero i rapporti per le regole, le altre, al contrario, cercherebbero di cambiare le regole, pur di salvare i rapporti. L’identità femminile sarebbe orientata a definirsi all’interno dei rapporti umani piuttosto che nell’azione e nell’avventura, come accade preferibilmente per i ragazzi. Si tratterebbe quindi di una identità che è legata alla non-lacerazione dei legami tra le
persone, alla cura della loro tessitura (affettiva, sociale, politica, religiosa). Vi
è collegata un’etica della responsabilità allargata, piú attenta all’insieme delle
dinamiche interattive per le ragazze, ed un’etica piú orientata alla moralità normativa per i ragazzi.
Più in profondità, non si può trascurare il fatto che il processo generativo
femminile contiene –come inscritti nella natura– significati paradigmatici della
relazionalità della persona (dal rapporto madre-figlio a tutti quelli della vita
quotidiana) che possono divenire metafora dell’esperienza umana in quanto
tale. Realizzando una trasgressione simbolica del dato, si può dire che è possibile solo a lei di poter dare la vita per mettere al mondo un figlio, segno e
misura di una direzione etica valida, nella sfera della libertà, per ciascuno.
b. Una piú accentuata coscienza del limite, legata ad un vissuto delle
donne piú condizionato dai ritmi fisiologici e quindi piú soggetto ad imprevisti.
Viene richiesta una veloce accettazione dell’imprevisto (spostamenti del ciclo,
gravidanze inattese) e, conseguentemente, una maggiore consapevolezza di
non essere in grado di padroneggiare il proprio corpo, pilotare la propria vita.
Sul piano culturale, la coscienza del limite implica la consapevolezza dell’infrangersi di tutti i sistemi di pensiero, di tutte le costruzioni umane di fronte
all’irrompere dell’imprevisto e della morte e quindi la sostanziale dipendenza
umana. Ne scaturisce una necessaria autolimitazione nei confronti della natura, del proprio corpo, del cosmo, del tu, di Dio, per la consapevolezza di una
dipendenza universale reciproca. Al grado massimo, la coscienza del limite è
l’obbedienza come è intesa da Simone Weil: “Dio ha creato, il che significa
non già che Egli ha prodotto qualcosa fuori di sé, ma che si è ritirato, consentendo a una parte dell’essere di essere altro da Dio. A questa rinuncia divina
risponde la rinuncia della creazione, cioè l’obbedienza. L’universo tutto intero
non è altro che una massa compatta di obbedienza”7.
63
64
c. La trasgressione inevitabile. Una certa mentalità maschilista ha attribuito
all’uomo il carattere “alto” della trascendenza, anche come capacità di trasgressione creativa del dato, in contrasto con la maggiore dipendenza della
donna dalla natura. Si può invece vedere nella femminilità una capacità di trascendere il mondo umano istituito, il sistema politico e filosofico, tutto ciò che è
sistematizzato e sistematizzabile, al fine di affermare principi considerati inalienabili. Ciò si realizza nonostante e oltre la maggiore flessibilità e adattabilità
delle donne alle diverse strutture di potere. In particolare, per delineare la
dimensione innovativa della femminilità, occultata dalla tradizionale soggezione della donna al sistema, viene messa in rilievo la figura simbolica femminile
di Antigone, figura centrale di una tragedia oggetto di ripetute interpretazioni, a
suggello del profondo significato filosofico, politico e religioso del mito greco8.
d. Il volto positivo del dolore. In tutte le culture la maternità ha un richiamo
misterioso e profondo ad una fecondità che sgorga insieme dal dolore e dall’amore. Il mito della Grande Madre è il simbolo della terra che nutre, che accoglie, mito predominante agli inizi delle civiltà, raffigurato in tutti i reperti
archeologici del bacino mediterraneo, come anche in Oriente e nelle zone nordiche. Tale mito ha un significato religioso legato alla potenza della divinità
femminile, per la capacità procreativa che colpiva fortemente l’immaginario
collettivo primitivo. Come nota Neumann, nella storia delle religioni la divinità
maschile subentra solo in un secondo momento, dopo la divinità madre, nella
quale viene rappresentata l’eterna esperienza dell’uomo che si trova disarmato e senza protezione dinanzi alla vita e alla natura, come il lattante con
la madre. Attraverso l’identificazione col bambino, l’essere umano, uomo e
donna, fa l’esperienza del femminile come il simbolo di vita, da cui ciascuno,
anche “come adulto”, dipende.
Il simbolismo della nascita, legata all’esperienza del dolore e dell’amore, si
riflette nel parto: se si pensa alla sofferenza fisica dell’uomo come a un segno di
decadenza e preannuncio di morte, la sofferenza fisica della donna in quel caso
è strettamente legata alla generazione e quindi alla dimensione positiva della vita.
Nella donna sembra impressa nel corpo l’altra faccia del negativo, la sua carica
vitale e feconda, a testimonianza del legame inscindibile tra dolore e gioia nell’amore. Il parto, come simbolo della maternità, rappresenta tale dialettica morterisurrezione per la generazione di nuova vita, in senso fisiologico e simbolico.
Queste caratteristiche si possono ritrovare diffuse nel libro che presentiamo, il quale nel suo percorso di ricostruzione dei tasselli che compongono la
storia del pensiero femminile del nostro secolo, dà visibilità a quei tratti che le
filosofe hanno esplicitamente messo in rilievo, quali:
1. L’amicizia come molla per l’ottimizzazione dei rapporti (Cfr. Gilligan p. 266)
2. L’esigenza di un più maturo “Rinascimento” a partire dalle donne ma
orientato ad una vera reciprocità tra i generi
3. Il pensare come un generare il mondo, che fa da parallelo alla forza insita nella nascita fisiologica (Cfr. Agostino e Arendt, p. 101-109-111), ma che si
estende anche alla capacità di far nascere simbolicamente un nuovo mondo
del senso e della relazione (reciprocità), nonché alla capacità di vivificare le
relazioni iniettando in esse flussi di speranza e di solidarietà
Quale (filo)sofare di Arianna
Se si vuol imparare a nuotare, osservava Hegel, non lo si può fare restando
fuori dell’acqua a mimarne i movimenti: bisogna immergersi. Non si può imparare a filosofare restando semplici spettatori. Occorre apprendere la filosofia
facendola. Siccome è proprio della filosofia, secondo l’adagio socratico, “confutare e lasciarsi confutare”, sta divenendo per le donne un gusto quello di confutare e di sottoporsi a critica, senza alcuna fretta di arrivare alla conclusione.
Pensare non significa volere ricette. Il filo d’Arianna è anche consapevolezza
dell’inevitabilità del labirinto, come nel mito di Teseo e di Arianna. Se si pensa al
filosofare come un tentativo di attraversare il ‘labirinto’, si comprendono i rischi:
ci si può perdere, si può girare a vuoto tornando e ritornando sui percorsi senza
venirne a capo. Non si può però evitare la sfida, pena la perdita del senso della
vita. Per le donne che amano la filosofia il labirinto non è una prigione, ma la
possibilità di scoprire sempre nuovi e imprevisti sentieri che si affacciano all’orizzonte per poi interrompersi, la sfida di provare prima l’uno poi l’altro sentiero
potendo tornare indietro e ricominciare, l’aprirsi di vie alternative ma anche il
ripercorrere vecchie piste abbandonate troppo in fretta e che meritano invece di
essere rivisitate. L’importante non è arrivare, ma avere un qualche sentore di
senso da dare al nostro percorso, perciò farsi condurre da un filo grazie al quale
ogni tappa del percorso è gratificante quanto il punto d’arrivo. Il viaggio diventa
un’avventura piacevole nell’attimo stesso in cui lo si affronta. Francesca Brezzi
riporta la metafora di H. Arendt: “pensare senza ringhiera” (“ho una metafora che
non ho mai pubblicato, ma conservo per me stessa, la chiamo pensare senza
ringhiera, si va su e giù per le scale, si è sempre trattenuti dalla ringhiera, così
non si può cadere. Ma noi abbiamo perduto la ringhiera. Questo mi sono detta.
Ed è quello cerco di fare”, p. 180). “Occuparsi della condizione umana richiede
che si osi pensare senza ringhiera, quella ringhiera costruita dalle maglie del
ragionamento consequenziale, strutturato in base a criteri di selezione che portano a scartare i fattori di incoerenza e di paradossalità, anche se si tratta di
incoerenze e paradossi che ineriscono alla vita. Ciò non significa che Arendt sia
attirata dall’incoerenza al pari di un rebus da risolvere, ma che intende prenderla sul serio, non come un incidente di percorso da superare” (p. 102).
Questo gusto del pensare alla ricerca del senso vale sempre: che ci si confronti
DOSSIER
4. Ricerca della verità e metodo (Cfr. Rovighi: “con cuore puro” e Weil: “probità intellettuale”)
5. Coscienza del corpo (Cfr. Rovighi p. 55 e Tymieniecka p. 66, p. 68)
6. Riflessione e cura della vita (Cfr. Rovighi p. 58 e Tymieniecka p. 66)
7. Forza vitale quale centro propulsivo dell’amore umano (Cfr. Stein p. 37-38)
8. Metafisica della vita su base antropologica (Tymieniecka p. 69-70, p. 76
e Zambrano p. 170)
9. Attenzione (Cfr. von Speyr p. 139 e, notoriamente, S. Weil)
10. Esaltazione del quotidiano (Cfr. Heller p. 118)
Sono tutti aspetti che riprendono ed accentuano quelle verità sulla persona e il suo interagire che sono spesso soffocati dalla unificazione oppressiva
della ragione.
65
con un testo da scandagliare in tutti i modi possibili (valori, idee originali, incongruenze, limiti) o che si riflessa sugli eventi, che si debbano gestire i sentimenti o
che si studi l’altro come soggetto che sta di fronte: In ogni caso, se affrontato in
modo creativo, il labirinto si trasforma da prigione in laboratorio di ricerca di verità.
66
1
Il Filo(sofare) di Arianna. Percorsi del pensiero femminile nel Novecento, a cura di A. Ales
Bello e F. Brezzi, Mimesis, Milano 2001. Le citazioni interne all’articolo indicate con la sola pagina si riferiscono al libro in questione.
2
Cfr. DIOTIMA, La sapienza di partire da sé, a cura di C. Zamboni, Liguori, Napoli 1996, p. 155.
3
S. VANNI ROVIGHI, Uomo e natura,. Appunti per un’antropologia filosofica, Vita e Pensiero,
Milano 1980, p.220.
4
Ivi, p. 210.
5
Cfr. AA. VV., Il maschile a due voci, Manni, Lecce 1999; già in “Segni e comprensione”, n. 36,
a. XIII, 1999; Il maschile e la teologia, Dehoniane, Bologna 2001.
6
Ci permettiamo di rimandare a: G. P. DI NICOLA, Uguaglianza e differenza. La reciprocità uomo
donna, Città Nuova 1988 e G. P. DI NICOLA-A. DANESE, Lei & Lui. Comunicazione e reciprocità,
Effatà, Torino 2000, con le caratteristiche parallele e a due voci del maschile e del femminile.
7
S.WEIL, La Grecia e le intuizioni precristiane, Comunità, Milano 1974, p. 277. Cfr. Aa. Vv.,
Simone Weil. Abitare la contraddizione, Dehoniane, Roma 1991; IDEM, Abissi e vette. Il percorso
spirituale e mistico di Simone Weil, LEV, Città del Vaticano 2002.
8
Cfr. G. P. DI NICOLA, Nostalgia di Antigone, Andromeda, Teramo 1998.
PENSIERO FEMMINILE E FILOSOFIA:
TRA SFIDA E PROGETTO
Tra le molte voci della riflessione occidentale contemporanea, il pensiero
contemporaneo continua ad offrirsi come una sfida, che la filosofia deve
affrontare, lasciando cadere le ultime barriere del sospetto nei confronti di un
“pensare senza ringhiere”, per usare una espressione di Hannah Arendt. Ma
la sfida, sic et simpliciter, sarebbe sterile se la proposta di un filosofare forte
non si ponesse quale progetto, il progetto di un mondo possibile –come si può
evincere da Il filo(sofare) di Arianna, volume a cura di Angela Ales Bello e
Francesca Brezzi, nel quale molte studiose affrontano il complesso panorama
del pensiero contemporaneo.1
Il contesto culturale, al quale le curatrici del volume fanno riferimento, viene
presentato come “tempo di crisi o di privazione” per il pensiero occidentale,
sottoposto al “crollo delle filosofie sistematiche, alla caduta delle ‘visioni del
mondo’, al rifiuto dei saperi universali e della stessa ragione che di quelli era
lo strumento”.2 Tempo di crisi che, se suscita imbarazzo e sconcerto, pure è
da considerarsi massimamente fecondo, giacché il crollo o il rifiuto non sono
soltanto al servizio di decostruzionismi talvolta troppo sbrigativi, ma anche –e
ben di più– sono stimolo a quel “pensare altrimenti”, che rappresenta la sfida
del pensiero femminile nella varietà delle sue sfaccettature.
Sfacettature che il testo qui preso in esame esibisce nella loro ricchezza
problematica, per cui –parafrasando il nostro Maestro, Paul Ricoeur– possiamo dire che il filo(sofare) di Arianna ci dà a pensare. E ci dà a pensare lungo
quel “filo”, che le curatrici svolgono nel loro volume dividendo il lavoro in due
parti: “Sapere della realtà” e “Sapere in prima persona”; e ancora ci dà a pensare nella complessità degli argomenti trattati, delle proposte emergenti, dei
rimandi che vengono sollecitati al lettore.
E, da lettori, non vogliamo passare sopra alle “provocazioni” che l’idea di
una “specificità femminile del pensiero” continua a suscitare. Ma forse il termine provocazione non basta a dire la perplessità che è legata all’idea di una
siffatta specificità, per un verso in quanto si tratta di una generalizzazione, che
il suddetto pensiero mira piuttosto a distruggere; per l’altro, in quanto sembra
quasi ghettizzare un patrimonio che fa parte della stessa Tradizione, che viene
contestata e che, come tale è a disposizione di “chiunque sa leggere” –e prendiamo ancora in prestito una espressione di Ricoeur. Saper leggere, cioè
saper ascoltare, e l’ascolto sta in primo piano quando si tratta di pensare a una
nuova etica– come mostrano Brezzi, Forcina e Gensabella Furnari nella
seconda parte del lavoro.
Ascolto attento, se solo scorriamo l’indice del libro, che dall’ontologia e vita
DOSSIER
di Daniella Iannotta
67
68
–livello fondativo– ci porta alla prassi e storia –livello fenomenologico– alla
sacralità e poietica –livello ermeneutico– per aprirsi poi alla considerazione di
quel “saper in prima persona” che caratterizza –potremmo dire– la metodologia del pensiero femminile in quanto tale.
Da quest’ultimo punto vogliamo partire, approfittando della libertà concessa al lettore, di ricapitolare la proposta di senso –o del mondo del testo come
direbbe Gadamer– in una proposta per sé, per ricomprendersi a partire da una
sollecitazione, da uno stimolo “a pensare di più e altrimenti”. Nella seconda
parte del lavoro, infatti, il discorso sul femminile, rimandando a quelle che
potremmo chiamare le “voci storiche” di questo discorso stesso –Simone de
Beauvoir, Luce Irigaray, nella presentazione di Marisa Forcina, Caroll Gilligan,
in quella di Marianna Gensabella Furnari, il tutto nel sapiente inquadramento
di Francesca Brezzi– ci mette di fronte alle ansie e ai progetti, che agitano la
speculazione contemporanea all’indomani della caduta delle filosofie sistematiche, o della crisi della ragione o della crisi del fondamento unitario del sapere che dir si voglia.
E, se la crisi della ragione totalitaria ha significato, per la contemporaneità,
l’ingresso dell’Alterità sulla scena del sapere –con la conseguente apertura del
pensiero stesso alla pluralità delle differenze e alla “polisemanticità”, come
dice Brezzi, del loro darsi; nel caso del “pernsiero femminile” ci troviamo di
fronte a un ambito variegato e complesso, irriducibile a una presa unitaria.
Accettiamo, allora, la “definizione generica”, sulla quale ci convoglia
Francesca Brezzi: “pensiero pensato da donne che fanno del loro essere
donne il punto di partenza della loro esperienza pratica e teoretica, o, detto
altrimenti, si ritiene che la differenza di genere, mai problematizzata e considerata un accidente determini una specificità femminile del pensiero stesso”.3
Specificità femminile che, di contro al neutro impersonale della speculazione
maschile (euro-etnica-fallo-logo-centrica!) muove alla instaurazione di quel
“saper in prima persona”, che dà il titolo alla seconda parte, di cui sopra. Saper
“senza ringhiera”, sottolinea Brezzi –riprendendo una espressione di Hannah
Arendt, cui dedica ampio spazio Margarete Durst nella sezione “Prassi e
Storia” della prima parte del volume4– che osa esplorare nuove strade senza
lasciarsi trattenere da preoccupazioni di sistematicità o di securizzazione. E
“se i problemi sono quelli eterni”, prosegue giustamente Brezzi, “le soluzioni
sono altre” e, interrogativamente pone tra parentesi la domanda: soluzioni
“(femminili?)”. Teniamo in sospeso questa domanda, poiché contiamo di ritornarci nel corso del lavoro.
Passo passo siamo condotti all’esame di questo “altrimenti” in cui dovrebbe emergere la specificità femminile del pensiero. Insomma, come dice Brezzi
riferendosi ad Irigaray, “si tratta di compiere una rivoluzione copernicana e
deve essere ancora kantianamente il soggetto a compierla, rifiutando la logica binaria gravata dalle opposizioni complementari di materia e forma, uomo
e donna, logica in cui il femminile è sempre apparso come carenza, non uomo,
polo di una mancanza che deve continuamente tendere la modello valido, Dio
o uomo”.5 Rivoluzione, dunque, che porti a un linguaggio altro, che sia “assunzione di parola e soprattutto di parola singolare ed insostituibile, che a diffe-
DOSSIER
renza del logos astratto nasce dal vissuto, è radicata nell’esistenza carnale,
concreta e corporale, di questo mondo e come tale è uscita dalla ‘solitudine
della ragione una’”.6
Insomma, il rifiuto della ragione totalitaria comporta una serie di atteggiamenti che mirano a recuperare una logica duale di contro alla logica dell’identità; a parlare in prima persona, e dunque a partire dalla domanda “chi è?” piuttosto che dalla socratica “che cos’è?”, tendente al concetto; a privilegiare il vissuto corporeo con tutto l’ambito delle emozioni e dei sentimenti, come mostra
Beatrice Tortolici presentando Agnes Heller7; a riflettere sul diverso rapporto
fra pensiero e azione; in breve, a far emergere quel “soggetto dimenticato”
dalla storia della razionalità occidentale, “ingabbiata” nella impossibile pretesa
di perseguire la verità assoluta.
Una prima osservazione che potremmo fare è, allora, che il pensiero femminile è costitutivamente etico –Etica della differenza sessuale è peraltro il titolo di una delle più famose opere di Luce Irigaray– e come tale teso a formulare “un progetto per una società migliore”, secondo la lettura di Marisa Forcina.8
Società in cui, accanto alle categorie della libertà e della giustizia, siano recuperate nozioni forti quali la responsabilità, la fiducia, l’amore, la relazione, la
fragilità –l’aria, come ci ricorda Forcina sempre a proposito di Irigaray.
Possiamo parlare di “etica della cura”, come fa Gilligan nel testo Con voce di
donna, che –sottolinea Marianna Gensabella Furnari– non è “alternativa, ma
complementare all’etica di principi e della giustizia, indicando la necessità di
una reciproca correzione: un temperare la giustizia con la compassione, che,
a sua volta, richiede un insaporire col sale della giustizia la compassione stessa”.9 Insomma, la voce di donna dovrebbe temperare la “distanza del rispetto”
con la “vicinanza della cura”, aggiungendo al soggetto morale, kantianamente
autonomo, la prospettiva dell’io relazionale.
A questo proposito, la problematica personalmente ci riavvicina alla trattazione che Paul Ricoeur fa della Regola d’Oro e del comandamento impossibile dell’amore ai nemici.10 Quanto alla Regola d’Oro, Ricoeur ci fa notare come
essa appartenga al fondo di saggezza della nostra Tradizione, che ci dà a pensare una volta che vi prestiamo attenzione. E ci dà a pensare, innanzitutto,
all’asimmetria dell’azione, laddove siamo chiamati ad assumere il posto di chi
deve fare, o non fare, all’altro quello che amerebbe, o detesterebbe, che gli
fosse fatto. Nominando questi sentimenti –di desiderio e di ripulsa– la Regola,
ad avviso di Ricoeur, fa da correttivo al formalismo del rispetto –quale emerge nella formulazione del secondo imperativo kantiano– e induce a pensare
alla relazione concreta che si instaura fra un agente e un paziente dell’azione.
Ora, se uomo e donna non sono esplicitamente nominati, pure siamo portati a
considerare quanto nella storia umana e, dunque, non soltanto nella nostra,
come dimostra la situazione della donna in larga parte delle popolazioni mondiali –il ruolo di agente sia più facilmente appannaggio dell’uomo mentre quello di paziente spetti piuttosto alla donna. Se, poi, consideriamo il comandamento evangelico impossibile dell’amore ai nemici, questa stessa impossibilità aiuta a capovolgere lo sguardo e, come dice Ricoeur, ad aggiungere la compassione e la benevolenza anche nell’ambito della giustizia. Evidentemente,
69
70
nella cinta di un tribunale, il giudice non può evitare di applicare la legge, ma
l’attenzione a queste possibilità “altre” del rapporto interumano aiutano a comprendere meglio e, vorremmo aggiungere, soprattutto a non condannare mai
la persona ipostatizzandola sul suo delitto. Ma qui è necessario che ci arrestiamo, poiché non vogliamo abbandonare le provocazioni che il filo(sofare) di
Arianna suscita al lettore.
Tuttavia, il richiamo a Paul Ricoeur ha il senso di mettere in rilievo l’ampiezza del “pensare altrimenti”, che qui indaghiamo con particolare riferimento al pensiero femminile. E qui ci piace riprendere una citazione di Luce
Irigaray da parte di Marisa Forcina, dove si auspica “l’avvento di una cultura a
due soggetti, l’uno maschile e l’altro femminile, rispettosi delle differenze reciproche, e perciò capaci di produrre una cultura necessaria alla pace e all’alleanza fra uomini e donne. Dunque una società e un mondo più giusti e, presumibilmente, più felici”.11 Ci piace far riferimento a queste parole di Luce
Irigaray perché evidenziano quanto ci sia in esse di legame con la Tradizione.
La vita felice era già il telos dell’uomo secondo Aristotele. E per parlare di una
“società più felice”, sia pur menzionando uomini e donne, necessariamente
operiamo una sorta di astrazione, di generalizzazione dell’argomento.
Insomma, il problema del rapporto theoria-praxis inevitabilmente torna sul tappeto, anche se nuovi sono i contesti del suo proporsi. Da questo punto di vista,
allora, anche all’interno del variegato mondo del pensare femminile (o al femminile o femminista, come sottolinea Brezzi), si opera una ripresa dei grandi
temi della Tradizione al modo di quella dialettica di appropriazione e distanziazione, che l’ermeneutica contemporanea ci dà a pensare nella figura del circolo –e qui pensiamo a Heidegger ma ancora di più a Gadamer e Ricoeur.
Quando, dunque, parliamo di etica relazionale, della cura, della responsabilità, a nostro avviso, non delineiamo tanto una specificità femminile del pensiero quanto una proposta di etica. E lo stesso vale se parliamo in chiave ontologica di “essere che è due”, come ricorda Forcina a proposito di Irigaray.
L’ontologia che il contemporaneo pensa all’indomani della caduta del fondamento, infatti, fa emergere l’impossibilità teorica e pratica di qualsiasi ipostasi
sostanzialistica –e Levinas può essere richiamato accanto a Irigaray.
Personalmente, quindi, condividiamo la tesi che Paul Ricoeur enuncia quanto
alla presunta unità della metafisica e pensiamo che si possa applicare anche
in ordine alla presunta specificità, sulla quale questo testo straordinario ci chiama a pensare. In una nota, che troviamo in un articolo incluso da Ricoeur nella
sua Autobiografia intellettuale, possiamo leggere: “Faccio mia la tesi di Martial
Gueroult circa la singolarità dei sistemi filosofici e mi sento maggiormente
coinvolto e imbarazzato dal problema di comunicazione, che la loro irriducibile differenza viene a porre, piuttosto che dalla pretesa perennità de ‘la’ metafisica. È sempre a prezzo di una riappropriazione, ogni volta nuova, che ci si
può arrischiare a mettere in serie le filosofie […]. La traiettoria che si delinea
così è una linea virtuale che congiunge punti singolari, ciascuno dei quali non
consiste in altro che nella traccia puntuale, lasciata ogni volta da una rischiosa operazione di appropriazione. Solo potrebbe conferire una unità più attuale a questa traiettoria virtuale il sentimento di un debito accumulato da questa
DOSSIER
serie discreta di atti di appropriazione, in cui la violenza dell’interpretazione è
compensata dalla ricettività inerente a una attenta lettura”.12
E se l’idea di debito può apparire inadeguata nel caso di voci “soffocate”
dalla Tradizione, essa ci consente tuttavia di non spezzare il legame con la
Tradizione stessa, ma di andare a restituire voce a quel rimosso, nella sicurezza di recuperare depositi di sapienza che, riattualizzati, consentono di progettare il nuovo a partire dal già là della nostra incancellabile “nascita”.
Utilizziamo ad arte la categoria-metafora arendtiana della nascita –e siamo
sicure che soltanto una donna poteva farne dono al pensiero– poiché ricca di
valenze simboliche quanto all’idea stessa di una generazione della vita e dell’azione nella dynamis del suo svolgersi. Valenze simboliche universali, vorremmo osare dire, anche se qui il termine universale va colto al di là dei
sostanzialismi della ragione totalitaria e mira piuttosto a sottolineare la disponibilità all’ascolto di una modalità universale di essere al mondo in maniera attiva –laddove effettivamente l’universale nulla toglie alla particolarità dei
movimenti e alla specificità dei progetti di ogni singolo uomo e di ogni singola donna nel contesto della loro appartenenza, essa stessa singolare.
D’altronde, Irigaray ci sembra andare nella stessa direzione quando afferma:
“Quello che noi celebriamo con il nome di Annunciazione sarebbe il tempo in
cui un uomo e una donna condividano delle parole prima di ogni atto carnale e di ogni concepimento”.13 Ci riesce, pertanto, più difficile pensare poi a una
relazione e a un riconoscersi tra donne, che dovrebbe significare “stare al
mondo con agio”. Infatti, per stare al mondo con agio sembrerebbe necessario dover escludere qualcuno, cioè l’uomo. Ma questo non rischia di diventare un nuovo ghetto? Sul piano concreto, dove si sarebbe realizzato questo
convivio ideale, in cui il potere e il rapporto con altri porta l’impronta femminile? Le donne al potere, anche le femministe o le simpatizzanti del pensiero
femminile, spesso finiscono per gestire le relazioni in maniera dispotica,
assolutistica ed esclusiva –nella misura in cui questo potere esclude il contraddittorio, lo emargina, lo priva della voce– esattamente nello stesso modo
di certi modelli maschili, che quelle pretendono combattere. Ma anche ove
una gestione “femminile” del potere si realizzi –e penso a Francesca Brezzi,
superba direttrice del Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di
Roma tre, o addirittura ad Angela Ales Bello, per due volte decana nel difficile e “maschilista” ambiente della PUL– un uomo ci si presenta, e cioè Paul
Ricoeur, che lascia la prestigiosa Sorbona per fondare la proletaria Nanterre,
dando testimonianza di essere vicino alle esigenze degli studenti, addirittura
fino a non esserne compreso.
Ora, con il nostro discorso, non vogliamo nascondere l’urgenza e la gravità delle questioni che si nascondono dietro al “femminile”, prima fra tutte
quella della condizione della donna –nella nostra società ancora, ma anche
di più in culture altre a livello mondiale, come già dicevamo– e, di conseguenza, del ruolo che essa gioca e che potrebbe giocare sul piano dei rapporti interumani. Piuttosto, nostro intento è di non confondere i piani, facendo confluire indistintamente nel pensare filosofico rivendicazioni, lotte, particolarismi che possono poi finire per creare steccati, divisioni, incomprensio-
71
72
ni. Insomma, uno dei metodi –o forse il metodo– di un’etica relazionale è proprio quello del dialogo, del dibattito, del confronto, in breve –per riprendere
Irigaray– della “condivisione delle parole”, che non è omologazione e tanto
meno rifiuto della confutazione.
In proposito, vorremmo riprendere quanto detto da Angela Ales Bello in
Fenomenologia dell’essere umano, ove afferma che “indubbiamente, i grandi
problemi filosofici sono i problemi che l’essere umano si pone al di là delle differenze sessuali, ma la loro soluzione, mai assoluta e univoca, nasce dalla
collaborazione o anche dalla contrapposizione di punti di vista, e ogni essere
umano porta con sé la propria specificità; riconoscere quest’ultima significa
anche essere pronti a vagliare il contributo degli altri, disposti ad accogliere
suggerimenti che vengono da fonti e mondi diversi, anche se sempre pronti a
considerarli criticamente avendo come punto di riferimento non la propria prospettiva, ma la ‘cosa’ che si sta esaminando”.14
Se, allora, il contributo delle pensatrici del ’900, che vengono esaminate nel
lavoro, si attesta attorno a quei “luoghi nuovi” del pensiero contemporaneo, che
vanno dal “parlare in prima persona”, privilegiando il vissuto esperienziale,
all’attenzione per le modalità di espressione della vita –nella relazione agli altri
ma anche all’Altro della mistica e della poesia, nell’impegno etico, nell’ascolto
delle emozioni e dei sentimenti, nell’analisi socio-politica, ma anche nell’indagine metafisica dell’io, del mondo e di Dio, per riprendere i luoghi classici del pensiero dell’Essere– queste “peculiarità”, che l’indagine mette in risalto, “non offuscano minimamente la validità della ricerca teoretica”, come sostiene Ales Bello
a proposito del lavoro delle fenomenologhe Hedwig Conrad Martius, Gerda
Walter ed Edith Stein, da lei esaminate nel lavoro sopraccitato. E sempre
basandoci su questa Fenomenologia dell’essere umano, vorremmo sottolineare, pertanto, che i risultati ottenuti dalle pensatrici della nostra epoca “possono
essere accettati o meno, vagliati, criticati e discussi, come è accaduto per qualsiasi altro pensatore nel passato. Intendo dire che le loro analisi non debbono
essere valutate in quanto espressione di un’indagine al femminile: si creerebbe in tal modo una contrapposizione che non consentirebbe un dialogo; in altri
termini, si arriverebbe a sostenere che nel passato la filosofia è stata fatta al
maschile e per questo le donne ne erano escluse, mentre ora si delineerebbero due modi di fare filosofia distinti e alternativi e ciò non avrebbe senso proprio
in relazione a una comunità umana e intersoggettiva per la quale il momento
culturale è importante e fondamentale”.15
Ebbene, il filo(sofare) di Arianna va proprio in questo senso, poiché se la
seconda parte delinea un quadro di contestualizzazione della problematica
femminile, mostrandone assunti, snodi e difficoltà, la prima parte, di contro, si
presenta come decisamente speculativa, anche se non presuntamente omologata su una improbabile univocità metafisica –e d’altronde, più volte abbiamo rilevato la crisi che attraversa la contemporaneità, o il postmoderno come
si suol dire, nella sua interezza. E proprio questo motivo ci ha spinto a rovesciare l’ordine pensato dalle curatrici del volume. La prima parte, cioè, ci sembra rispondere a quelle perplessità, a quei balbettii di un “pensare senza ringhiera”, già più volte richiamato, che non significano un pensiero dimesso o di
DOSSIER
secondo ordine, come le grandi tematiche ontologiche, pratiche, poetiche
dimostrano abbondantemente.
Tematiche sulle quali ci vorremmo soffermare analiticamente, in virtù della
ricchezza e della fecondità di pensiero che da esse traspare. Compito troppo
arduo nello spazio di un saggio, e tuttavia ne facciamo cenno obbedienti allo
stimolo che da esse proviene verso nuovi possibili campi di indagine. Così,
nella prima sezione della prima parte, Angela Ales Bello mostra il terreno favorevole che la fenomenologia offre per ripensare il legame dell’ontolologia e
della metafisica con la vita,16 mentre Carla Bettinelli ci dà testimonianza dell’impegno di Sofia Vanni Rovighi nella ricerca del vero17 e Daniela Verducci ci
accompagna alla scoperta di una pensatrice, tanto singolare sul piano umano
oltre che su quello intellettuale quale Anna Teresa Tyminiecka, per la quale ci
sembra davvero appropriato il titolo scelto dalla Verducci per il suo articolo18: la
trama vivente dell’essere, infatti, caratterizza bene il lavoro di questa pensatrice su scala mondiale, e anche per il suo entusiasmo vorremmo aggiungere.
E se con Conrad Martius ed Edith Stein, come dicevamo, parliamo di metafisica, è chiaro quanto questa sia al servizio delle profondità forti dell’esperienza umana, che continua a porsi le domande radicali di senso che agitano
il filosofo: chi sono? Da dove provengo? Verso dove mi dirigo? Non è un caso,
allora, che Conrad Martius miri a una filosofia dell’Essere a partire da interessi scientifici, e in particolare biologici: non è forse la filosofia della natura uno
sforzo di pensare la vita dell’habitat che ci accoglie e che, oggi come non mai,
chiede al nostro sguardo una attenta postura fenomenologica? E, sull’altro
versante, la ricapitolazione nell’Essere a cura di Edith Stein non va forse letta
come la consapevolezza di un essere all’interno di un progetto più grande, che
autentica i nostri stessi progetti, le nostre scelte? Se poi vi si aggiunge la
valenza pedagogica, sulla quale Edith Stein insiste proprio quando delinea i
tratti del femminile –e del maschile– allora questa metafisica, che si forma e
affonda le proprie radici nella fenomenologia, ci soddisfa e ci conduce a pensare “altrimenti dall’altrimenti”, vorremmo parafrasare per prendere posizione
contro le possibili derive di un pensiero debole, o meglio troppo debole, nel
pensiero qualunque, esito talvolta possibile dei nihilismi contemporanei.
Nella seconda sezione, il discorso diventa più pratico –si tratta infatti di
Prassi e Storia– ma mai a scapito di una théoria che questa stessa prassi
venga a vivificare con il suo senso. Abbiamo già menzionato Margarete Durst
e Beatrice Tortolici, che rispettivamente ci parlano di Hannah Arendt e Agnes
Heller, facendo emergere la valenza teoretica del loro pensiero pratico: per la
Arendt, infatti, “l’impegno nella storia” appare come una “pratica della filosofia”; per la Heller è proprio il pensiero ad aprire il sentimento e l’azione.
Accennando alla categoria arendtiana della nascita, già avevamo sottolineato
l’universale valenza simbolica, che essa assume in ordine a un essere-per-lavita –vorremmo dire riprendendo una espressione che avevamo già usato
altrove per Ricoeur– di contro al deprimente essere heideggeriano per la
morte. E forse non è un caso che una donna, legata tanto strettamente a
Heidegger, abbia saputo cogliere la ristrettezza della temporalità umana
(autentica?) e dire con la nascita la ricchezza e la dinamicità della progettua-
73
74
litgà dell’umano, ricchezza autentica proprio perché capace di spingersi al di
là di ogni nostra singola vita.
Singola vita che, comunque, viene al pensiero e lo abbiamo rilevato già nell’analisi della seconda parte del lavoro, dedicata proprio all’emergere di un
sapere nuovo, in prima persona. Qui, tale valenza emerge bene nelle parole
di Beatrice Tortolici, la quale sottolinea che “non esiste un concetto astratto di
uomo, di mondo, di morale, di azione, ma esiste il signor X, il contesto del
paese Y, l’azione di costruire o distruggere qualcosa di concreto, un buono o
cattivo comportamento, il tutto poi agito in un reale processo di interazione con
altre persone ed altri contesti. Si tratta di azioni e di reazioni particolari vissute nella ‘particolarità’ delle singole persone e nel concreto processo dinamico
della vita”.19 E proprio la particolarità ci richiama altre esperienze concrete,
maggiormente inclini alla dimensione spirituale, poetica, mistica quali quelle di
Simone Weil o di Maria Zambrano.
Pensatrici, queste ultime, che ci danno modo di gettare uno sguardo sulla
terza sezione della prima parte del volume, intitolata “Sacralità e Poietica”,
quasi ad indicare la produttività di un abitare poeticamente, secondo un titolo
che Rita Fulco sceglie per cominciare a parlare di Simone Weil.20 Donna spiritualmente inquieta e testimone in prima persona delle sofferenze degli operai,
che aveva voluto condividere con il lavoro in fabbrica, Simone Weil tiene desta
la luce della bellezza al di là della “miseria totale” grazie ad una “pienezza dell’attenzione” che “non è altro che preghiera”. E di una “ragione poetica” è in
cerca anche Maria Zambrano che, come sottolinea Anna Maria Pezzella, è
convinta che la filosofia sia inadeguata a “rivelare la vita”. Così, se “il filosofo
ha preso le distanze dalla vita e dalle sue presunte apparenze, il poeta, invece, ha assunto su di sé il peso e l’angoscia della carne”.21 Pensiero altro, ma
soprattutto “alto”, che nel quotidiano è capace di scorgere l’invisibile e di darne
testimonianza nella carne. Come non gettare allora un ultimo sguardo su una
mistica, come Paola Ricci Sindoni fa parlandoci di Adrienne Von Speyr?
Mistica, secondo una modalità “differente” da quella “caratterizzazione dello
specifico di genere” che emerge negli studi sul mondo mistico femminile del
Medio Evo, che finisce poi per marginalizzarlo, per rinchiuderlo in uno spazio
ben tipicizzato. Di contro, afferma Ricci Sindoni, “la lezione della von Speyr
[…] indica al contrario che il percorso della mistica femminile ha saputo
imbroccare la via dell’oggettivazione, dell’esteriorità, della missione ecclesiale, alludendo ad una più ampia comprensione dell’esperienza di Dio da parte
di donne che, al pari delle profetesse dell’Antico Testamento, assumono il proprio carisma come dono e servizio per tutto il popolo di Dio”.22 Dono, servizio,
pratica della vita alla luce di una parola che ci precede e ci chiama: altrettante modalità per pensare una possibilità di abitare il mondo senza pretendere
di conoscerlo nella sua totalità ma, nello stesso tempo, senza rinunciare a
coglierne il senso.
Il discorso, vorremmo dire, è qui appena cominciato ed è proprio questo il
valore di un testo, che ci invita a pensare a partire dalle sue righe ma senza
restarvi attaccate. Abbiamo colto tante piste di lettura, abbiamo imparato ad
ascoltare le molte voci di una contemporaneità inquieta ma ricca, complessa,
1
Il filo(sofare) di Arianna. Percorsi del pensiero femminile nel Novecento, a cura di A. Ales
Bello-F. Brezzi, Mimesis, Milano 2001.
2
Ivi, p. 7.
3
F. BREZZI, Esplorazione di nuovi territori, ivi, p. 180.
4
M. DURST, Hannah Arendt – Impegno nella storia come pratica della filosofia, ivi.
5
F. BREZZI, Esplorazione di nuovi territori, ivi, p. 183-184.
6
Ivi, p. 184.
7
B. TORTOLICI, Agnes Heller – Pensiero, sentimento, azione, ivi.
8
M. FORCINA, Luce Irigaray – Militante politica di ciò che ancora non è, ivi., p. 231.
9
M. GENSABELLA FURNARI, Carol Gilligan: una voce differente, ivi, p. 258.
10
Cfr. P. RICOEUR, Sé come un altro, tr. it. a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993, VIII
studio.
11
In M. FORCINA, op. cit., p. 244.
12
P. RICOEUR, Riflession fatta. Autobiografia intellettuale, tr. it. a cura di D. Iannotta, Jaca Book,
Milano 1998, p. 114, nota.
13
Cit. da M. FORCINA, op. cit., p. 242.
14
A. ALES BELLO, Fenomenologia dell’essere umano: lineamenti di una filosofia al femminile,
Città Nuova, Roma 1992, p. 19.
15
Ivi, p. 18.
16
A. ALES BELLO, Hedwig Conrad Martius –Ontologia e vita, e Edith Stein– Ontologia
Metafisica Vita, in Il filo(sofare) di Arianna. Percorsi del pensiero femminile nel Novecento, cit.
17
C. BETTINELLI, Sofia Vanni Rovighi – Il sapere filosofico, ivi.
18
D. VERDUCCI, Anna Teresa Tyminiecka – La trama vivente dell’essere, ivi.
19
B. TORTOLICI, op. cit., p. 116.
20
R. FULCO, L’infinito invocare – Bellezza e soprannaturale, in Il filo(sofare) di Arianna. Percorsi
del pensiero femminile nel Novecento, cit.
21
A. M. PEZZELLA, Maria Zambrano. Filosofia Poesia Mistica, ivi, p. 166.
22
P. RICCI SINDONI, Adrienne von Speyr – La luce e le immagini, per una fenomenologia della
visione, ivi, p. 134.
23
A. M. PEZZELLA, op. cit., p. 170.
DOSSIER
stimolante. Se volessimo chiudere con una specificità, che da questo testo ci
viene, ci piacerebbe utilizzare le parole di Anna Maria Pezzella, quando afferma che la filosofia “è un capire capace di accogliere con il sentimento la profonda vicinanza delle cose”23
75
DAL LABIRINTO ALLA “STANZA TUTTA PER SÉ”.
PENSATRICI DEL NOVECENTO.
di Giovanni Invitto
76
Leggendo il volume che stiamo esaminando1, mi tornava alla memoria il
brano del Don Giovanni di Kierkegaard, in cui il filosofo danese, di norma considerato teoreticamente misogino, afferma: “La mia ammirazione, la mia simpatia, la mia religione, il fanciullo e la donna che vivono in me, esigevano di
più di quello che il pensiero poteva dare. Il pensiero era tranquillo, riposava
contento nella sua cognizione; eppure io andai di nuovo da lui e lo pregai di
mettersi ancora una volta in moto per tentare l’estremo rischio”2. È evidente
che il bambino, la donna, l’affettività che erano in lui non si accontentavano del
pensiero, ma al pensiero ritornavano affinché accettasse un estremo rischio.
È il rischio che, consapevolmente, corre il pensiero femminile e della differenza: quello di essere tagliato, ignorato, omologato. Quello della differenza,
invece, non è un pensiero della cesura, della separazione. La stessa Irigaray
parla di un pensiero non oppositivo, perché i bordi si possono confondere: “Il
mio progetto è regolato sulla mia identità naturale; la mia intenzione è di assicurane la cultura per divenire quello (quella) che sono, oltre che rendere spirituale la mia natura per creare insieme all’altro”3. Il guadagno che il pensiero
femminile del Novecento propone è un guadagno per l’intera filosofia.
Nella Prefazione di quest’opera collettanea, è posta quella che potrebbe
chiamarsi scoperta epocale: “il genere come fattore imprescindibile di interpretazione” ovvero “la differenza di genere determina una specificità femminile del pensiero”. Pensiamo che nel 1929, a Sofia Vanni Rovighi, padre Gemelli
suggerì di non riportare il nome per intero nel suo primo scritto di filosofia, perché era donna, e ciò avrebbe potuto pregiudicarne l’accoglimento. Lei appuntò la S per Sofia4.
Ma quello di cui stiamo trattando è un philosopher de femmes o un philosopher en femme, come recitava un mio saggio del 1990 su Simone Weil5?
Qui le autrici sono tutte donne, ma il fatto è definito contingente. Il problema
nasce se e quando anche la scrittura femminile si leggesse solo tra donne. Per
molte, si è conquistata la lettura maschile solo quando si è raggiunta una certa
soglia di legittimazione teoretica (è il caso di Arendt, Weil, Heller,
Zambrano…).
Eppure tutte queste filosofe, normalmente, si confrontano con il pensiero
forte occidentale, quello che loro stesse criticano alle radici (Platone, Hegel,
Marx, Husserl), e non si relazionano con quello nel quale si potrebbe trovare
una via alternativa, cioè la critica radicale interna alla filosofia occidentalemaschile: Pascal, Kierkegaard, Nietzsche. Diverso è il discorso per Agostino
che trova, per la sua narrazione, uno sguardo attento e complice.
DOSSIER
La fenomenologia, tra gli orientamenti contemporanei, è quella che potrebbe essere maggiormente fruibile, quando non viene letta come idealismo e
scolastica. Ciò permette la fondazione, in queste pensatrici, di una vera e propria ontologia, secondo la distinzione sartriana: l’ontologia parla del “come”
dell’essere, la metafisica, rifiutata in quanto in-concludente, del “perché” dell’essere. Hannah Arendt, tra le altre6, sviluppando implicitamente tale impostazione, ha affermato che la ricerca di senso riguarda sì l’uomo, però non la
natura umana ma la condizione degli uomini. Ontologia fenomenologica, quindi. Quando, circa dieci anni fa, ho conosciuto di persona Luce Irigaray, il giorno prima che presentassi con Adriana Cavarero un suo volume, ella mi disse,
quasi come fosse il suo biglietto da visita: il mio discorso è ontologico.
Le sollecitazioni avvertite da me durante la lettura di quei medaglioni di filosofe, tento di riordinarle, come fossero tasselli di mosaico, in base a tematiche
che mi sono teoreticamente consuete.
Ontologia, realismo, esistenza
L’ontologia che emerge da queste pensatrici è nettamente di tipo realistico.
Pensiamo a Hedvig Conrad-Martius che parla di una datità “in carne ed ossa”7,
in parte riprendendo Husserl di Idee: “Ciò che si dà originalmente nell’intuizione (per così dire in carne ed ossa), è da assumersi come si dà, nei limiti in cui
si dà”8.
Ed Edith Stein9: “Considero il mondo e la mia persona come fenomeno, per
cui non è possibile che siano cancellati o messi in dubbio né l’io né la stessa
esperienza”10. Da ciò derivano quelle che Ales Bello riporta come eresie rispetto a Husserl: la Stein ritiene la natura prima assolutamente esistente ed è una
soggettività con determinate strutture. Ciò fu causa ed effetto dell’incontro con
Tommaso d’Aquino, mentre la forte dimensione attribuita alla temporalità e alla
finitezza dell’io aveva sicuramente referenza agostiniana.
Nel nostro contesto, Sofia Vanni Rovighi scrive la prima monografia italiana su Husserl nel 1938. È l’unica pensatrice/pensatore cattolico che non lanci
anatemi contro L’Etre et le Néant, anzi afferma, alla fine degli anni Quaranta,
che da quella ontologia non si potrà troppo facilmente prescindere. Di quell’opera farà proprio, come è ricordato nel volume, un concetto cardine da lei
ripreso testualmente: “la coscienza del corpo si identifica con l’affettività originaria”11. La filosofia è, per Vanni Rovighi, una specie di vena profonda che alimenta le filosofie, fino a costituire la “perenne filosofia dell’umanità”12. Sembra,
però, che si possa dire che per lei non esiste una philosophia perennis, costituita dalle risposte, ma un perenniter philosophare intessuto di domande che
gemmano le une dalle altre.
In questo senso leggiamo anche quello che ha detto Anna Teresa
Tymieniecka, quando ha affermato che occorre tornare al “campo di battaglia”
di Husserl, non come al filosofo che ha proposto un nuovo, definitivo approccio, ma come ad un pensatore che combatte contro i perenni enigmi, cioè le
domande che l’universo e l’uomo presentano continuamente13. In questo
77
senso, non l’intenzionalità, “ma la marcia costruttiva della vita”, tanto richiamata dall’ultimo Husserl, può spiegarci il principio di tutte le cose. Parlare della
vita, vuol dire entrare a pieno titolo nella cifra che marca il pensiero femminile.
Affettività e poetica
78
María Zambrano14 ha scritto: “L’attitudine filosofica è quanto c’è di più simile a un abbandono, alla partenza del figliol prodigo dalla casa del Padre; dalla
tradizione ricevuta, gli dei incontrati, la familiarità e persino il commercio con le
cose […]. È quanto c’è di più simile a quello strapparsi da tutto quello che si è
ricevuto”15. È l’abbandono della vita nella sua evidente concretezza, perpetrato
dai filosofi. Il cammino inverso compie la poesia, che “è vivere nella carne,
addentrarsi in essa, conoscendone l’angoscia e la morte”16. È la poesia che dà
voce al labirinto infernale delle viscere; al logos che scorre nelle viscere. Non è
l’heideggeriana filosofia che evoca un essere categoriale disincarnato. La filosofia rimane come “amore ostinato”, lungi dall’essere scienza rigorosa.
E come potrebbe esserlo se, per Hannah Arendt, l’uomo può esperire l’impensabile, l’olocausto? Sulla stessa onda, per Conrad-Martius la fonte dell’essere non può essere anche la fonte del senso di cui è pieno l’essere. Occorre,
allora, distinguere la sfera della coscienza, realtà “senza colorazioni”, dalla
sfera vitale e dei vissuti che è, invece, il centro propulsivo dell’essere umano.
Anche per Hannah Arendt l’intervento della immaginazione ideativa trae linfa
dal mondo intimo degli affetti e permette la ricerca di senso. È un mondo intimo che si apre a quello pubblico, senza confondersi con esso.
La Tymiemiecka, segnalando la necessità di poter sapere e decidere di sé,
indica l’attività immaginativa e simbolica. L’autoindividualizzazione della vita è
un processo auto-poietico attraverso l’autointerpretazione inventiva (da: invenire). Perciò può parlare di “gioco di vita”17, tanto eterogeneo dal sartriano
“gioco dell’essere” che ci portava a considerarsi cose, attraverso l’ineliminabile atteggiamento di malafede.
Se, come dice ancora Arendt, “ciò che accade”, l’evento storico e quotidiano, è la vera “filosofia prima”, questa è stata sempre ai margini del pensiero
occidentale. Perciò l’innesto produttivo può essere dato dalla poesia, dal racconto, dalla narrazione.
La nuova etica
È, in tutto il pensiero femminile, l’istanza di una nuova etica che incida sui
comportamenti e sulle strutture sociali. Simone de Beauvoir18 aveva scritto che
“un Dio può perdonare, cancellare, ricompensare, ma se Dio non esiste, gli
errori degli uomini sono inespiabili”19. Da ciò l’urgenza di un’etica basata sulla
responsabilità.
Per Agnes Heller, fortemente attenta al marxismo20, non esistono concetti
astratti, ma individui concreti e situazioni concrete. Il primo riferimento non è il
Fede e fame d’assoluto.
Una mappa del pensiero femminile non può prescindere dalle scritture sull’esperienza mistica. Come è chiarito nel volume, più che di mistica femminile
dobbiamo parlare di mistica al femminile. Qui può nascere la divaricazione più
radicale rispetto alle filosofie egemoni dell’Occidente. Edith Stein, ad esempio,
rispetto ad Heidegger e alla sua nozione di gettatezza, sottolineava la specificità dell’essere dell’uomo, perché “esige un Essere che getti il gettato”.
La tematizzazione della condizione mistica è ricorrente anche nelle filosofe presentate nel volume: Simone Weil, María Zambrano, Adrienne von Speyr.
Per questa pensatrice, l’“esperienza” mistica viene decostruita in ex-per-ire,
cioè andare verso qualcuno24. Diversamente dalle convizioni di Simone Weil,
per la quale i mistici di tutte le fedi si somigliano, in Adrienne von Speyr la
visione è cristologica ed ecclesiale. La luce è la rivelazione di Dio e le imma-
DOSSIER
gruppo sociale, ma l’Io e la dimensione affettiva poiché in essa troviamo il
gruppo, e non viceversa. La società, peraltro, è diversa dalla comunità e la religione è la vera comunità ideale.
Detto questo, per Heller la persona è il valore ed è universale quando si
riferisce ai sentimenti. Se fosse una sua fonte, ma non lo è, diremmo che già
Kierkegaard, in una nota di Timore e tremore, riprendendo Lessing, aveva
ribadito che ciò che è universale nell’uomo è la passione, non la ragione. Per
l’originale personalismo della Heller, la capacità di riprodurre la propria contingenza individuale può modificare la struttura sociale.
Per Carol Gilligan21, il problema morale pone modalità comprensive e di
narrabilità diverse. Esso sorge quando i soggetti, nei confronti dei quali ci si
sente responsabili, sono in conflitto e non quando vi è conflitto tra i diritti di due
soggetti. “La sua risoluzione richiede una modalità di pensiero contestuale e
narrativa piuttosto che formale e astratta. Una moralità intesa come cura degli
altri –conclude la psicologa americana– pone al centro dello sviluppo morale
la comprensione della responsabilità e dei rapporti, laddove una moralità intesa come equità lega lo sviluppo morale alla comprensione dei diritti e delle
norme”22.
Luce Irigaray, da parte sua, non solo ha scritto Etica della differenza sessuale, ma ha colorato l’intero suo pensiero di una sostanziale rivendicazione
etica: “Io non ho ancora trovato il luogo da cui iniziare a riconoscersi e quindi
a dire una qualsiasi cosa. Qui e ora. Cerco piuttosto di riattraversare tutti i luoghi, in cui sono stata esiliata rinchiusa perché lui potesse costituire il suo qui.
Di leggere il suo testo, di tentare di riprendere quel che mi ha preso senza
nulla in cambio. Di riaprire tutto quanto ha costruito prendendomi dentro, mettendomi fuori dicendo ‘sì’ e ‘no’, lasciandomi in una sospensione di attesa e di
oblio in cui non posso vivere, muovermi, respirare. Cerco di trovare la possibilità di un rapporto con l’aria. Ne ho bisogno prima di cominciare a parlare”23.
Si tratta di reclamare dignità e restituzione di proprietà morali (se persona est
proprietas). E si inizia dall’aria, il soffio: cioè dall’anima.
79
80
gini sono le figure del mondo che debbono essere capite secondo le intenzioni di Dio. Il mondo non è, però, mai negato. “Così la grande Teresa può anche,
durante la preghiera estatica, non dimenticarere i pesci che deve arrostire. Ella
non contempla né il proprio lavoro, né la propria vita e i suoi compiti. Ella nell’estasi contempla le cose di Dio e tuttavia viene al tempo stesso trattenuta
dalle cose quotidiane in una realtà che non è il mondo dell’estasi”25.
Per Simone Weil26, la creazione di Dio è uno specchio. La materia è “uno
specchio offuscato dal nostro respiro. Bisogna solo pulire lo specchio e leggere i simboli che fin dall’eternità sono iscritti nella materia”27. Ma, contemporaneamente, dobbiamo porre mano ad un processo di de-creazione, cioè di
annientamento dell’anima vegetale che lasci spazio all’anima soprannaturale:
“Il consenso all’assenza totale e perpetua di ogni bene è l’unico moto dell’anima che sia incondizionato. È l’unico bene […]. Un simile consenso è per la
volontà ciò che per l’intelligenza è la contraddizione in un mistero. È assurdo.
È il consenso a non essere. Acconsentire a non essere significa acconsentire
alla privazione di ogni bene, e questo costituisce il possesso del bene totale.
Solo che non lo si sa. Se lo si sa, il bene sparisce. Orfeo perde Euridice quando la guarda. Niobe assiste alla morte dei figli quando ne vanta il numero”28. Il
nichilismo weiliano è un nichilismo accostabile al nirvana richiamato da
Schopenhauer. La condizione soggettiva rimane quella di indigenza e di malheur.
L’impadronirsi del bene è perdita di salvezza. Lo fu per Adamo ed Eva. Lo
fu anche per le figure mitologiche delle quali, nel pensiero femminile, sono una
ricorrente riproposizione e un arricchimento. Perciò, possiamo aggiungere
quel Narciso che muore nel momento in cui si conosce e si possiede. In Ovidio
leggiamo: “La cerulea Liriope [..] un giorno con avvolgente gorgo fu abbracciata da Cefico e ne subì, così costretta, violenza nelle di lui onde. Fecondata,
la ninfa bellissima partorì un piccolo, tale che già allora ispirava amore. E lo
chiamò Narciso. Consultato [Tiresia] se il piccolo avrebbe visto tempi remoti di
una tarda vecchiaia, il fatidico vate rispose: ‘Purché non si miri’”. Così nella traduzione italiana. Nel testo latino leggiamo: “Si se non noverit”29: se non si
conoscerà. L’opposto dell’invito delfico e socratico.
Tornando al misticismo, esso è strettamente connesso alla perdita della
dualità. È anche connesso alla metafora del mangiare, della fame di assoluto30. Se per la Irigaray il rapporto di amore comporta la trascendenza dei due
soggetti, cioè la non di-gestione di uno da parte dell’altro, per Simone Weil
solo la bellezza suscita un desiderio senza deglutizione: “Vogliamo mangiare tutti gli oggetti di desiderio. Il bello è ciò che si desidera senza volerlo
mangiare. Noi desideriamo che quello sia”31. María Zambrano fa il controcanto. Il filosofo non ha amato l’oggetto, ma lo ha desiderato, perché lo consuma32. Ha consumato le cose, gli eventi, il quotidiano, il vissuto, anche a
vantaggio dell’astrazione. È la concupiscentia irresistibilis sciendi di cui
aveva parlato Šestov.
Il misticismo “al femminile”, se è fame che produce anoressie terrene, invita anche all’astinenza una Ragione occidentale da secoli al banchetto di una
verità dimidiata.
In libri di filosofe o in scritti ad esse dedicati, è frequente l’immagine della
tessitura. Vari motivi sono i motivi di quest’uso. Il principale è che la metafora
della tessitura accompagna il pensiero mitologico e la filosofia sin dal loro
nascere. Atena, la Ragione, nata dalla testa di Zeus, è anche la dea del filare
e del tessere. E quale attività più della paziente elaborazione razionale richiama il tessere la trama e l’ordito? Che nella cultura classica Atena, cioè la dearagione, venisse ritenuta molto legata non solo al suo compito di protettrice del
tessere, ma anche al primato, per bravura, tra tutte le tessitrici, è testimoniato
dal mito di Aracne.
Solo una volta, infatti, narra il mito, Atena, cioè la ragione, diede prova di
una incontrollata invidia. Aracne era così esperta nell’arte della tessitura che
nemmeno Atena poteva competere con lei. Ovidio, nelle Metamorfosi, racconta la gara tra le due. Atena ricamò la maestà e il trionfo degli dei dell’Olimpo,
Aracne gli intrighi e le trasformazioni adottate dagli stessi dei per soddisfare le
proprie passioni e basse voglie. La dea scrutò attentamente l’opera della
nemica e non vi trovò alcun difetto33. Aracne, duramente e ripetutamente colpita dalla spola della dea, oramai non più padrona di stessa, si impiccò per la
costernazione provocata dall’accaduto. Atena, impietosita, secondo la “partigiana” versione di Ovidio, le lasciò la vita ma la trasformò in ragno, l’animale
che detestava di più. Secondo altre versioni del mito, la corda con cui Aracne
si era impiccata fu tramutata in una ragnatela e Aracne vi si arrampicò salvandosi da sola la vita. Ma rimase sempre, come scrisse Virgilio, “invisa
Minervae”, e continuò a sospendere alle porte ampie reti34. La più brava tessitrice è invisa alla Ragione-tessitrice e sceglie di morire.
Ma cosa deve tessere la filosofia e la filosofia di donna? In una sapida ricostruzione etimologica, Francesca Brezzi dice zitella è colei che fila. Occorre
filare e tessere il pensabile e l’impensabile, il razionale e il non razionale, la
contingenza e la necessità. Hannah Arendt chiede il confronto con la frammentarietà, perché la catastrofe o il movimento tellurico, che pure non distruggono la storia, danno una nuova disposizione di frammenti. Zambrano:
“Sapere che in ogni istante della vita, per ogni evento e circostanza, esiste una
certa mescolanza di ragione e di irragionevolezza, di legge e disordine”35.
Merleau-Ponty aveva scritto che la più alta ragione confina con la déraison.
Pertanto, la filosofia, quella femminile deve intervenire per ricucire i frammenti, con la consapevolezza che la cucitura è sempre provvisoria e fragile. È
il “pensare senza ringhiera” della Arendt, cioè il pensiero che abbandona il
ragionamento consequenziale36. Occorre accettare la contraddittorietà e,
come Penelope, costruire e decostruire. Sempre per l’autrice di Vita activa,
bisogna trasformare quei fili in storia, senza che si annullino nella storia.
Anche per questo il pensiero femminile dà il primato alla narrazione, tessitura continua, purché non sia favola né leggenda né eros autistico.
DOSSIER
La tessitura
81
Nascita e seconda nascita
82
Uno dei motivi per i quali Arendt privilegia Agostino contro Heidegger, è
perché il primo collega amore e azione, in una visione in cui l’“essere per la
morte” è soppiantato dal’“essere per la nascita”: la nascita del chi, del soggetto consapevole. Perciò la filosofa parla di prima nascita e seconda nascita.
Questa è la “riappropriazione innovativa di quanto ci è stato dato prima di ogni
nostra scelta”37. Potremmo leggere ciò come rilettura di altri pensieri maschili:
il “divieni ciò che sei” di Nietzsche; il “progetto” anche del proprio passato di
cui parlava Sartre.
Ma la nascita, nel pensiero femminile, assume un ruolo nodale. Ed è comprensibile. Non si vuole, qui, parlare della “nascita in sé”, la cui centralità e
palese, ma della “nascita della donna”. Se Simone de Beauvoir ha affermato:
“Donne non si nasce ma si diventa”, Luce Irigaray ha ribattuto: “Sono nata
donna, ma devo ancora diventare quella donna che sono per natura”38, quasi
ad indicare, come è per Arendt, la necessità di una seconda nascita.
Ma, in fin dei conti, anche l’autrice di Il secondo sesso pare segnalare una
nuova vita con la fine della giovinezza. Una fine che, se richiede un narrarsi a
se stesse, per non disperdere la ricchezza e i tumulti di quella stagione esistenziale, pare arrecare una vera e propria perdita nell’età adulta: “Da molto
tempo desideravo raccontarmi i mie primi vent’anni; non ho mai dimenticato gli
appelli che rivolgevo, da adolescente, alla donna che mi avrebbe assorbita in
sé, corpo e anima: di me non sarebbe rimasto nulla, nemmeno un pugno di
cenere; la scongiuravo di strapparmi, un giorno, a quel nulla in cui essa mi
avrebbe precipitata”39.
La seconda nascita, così, peserebbe e isterilirebbe. Paradossalmente, più
di un secolo prima, proprio Kierkegaard aveva tematizzato, e solo per la
donna, la seconda nascita. Nel Diario del seduttore leggiamo: “Una fanciulla
non si sviluppa per certi riguardi come un fanciullo: non cresce, ma nasce già
fatta. Il fanciullo inizia subito lo sviluppo e ha bisogno, per compierlo, di lungo
tempo: la fanciulla ha una lunga nascita, ma nasce già fatta. In questo consiste la sua ricchezza infinita; nel momento in cui ella nasce è già cresciuta, ma
questo momento di nascita viene solo tardi. Quindi nasce due volte: la seconda volta quando va a marito o per meglio dire in questo momento finisce di
nascere e solo in questo momento è nata interamente. Per tal modo non a
Minerva soltanto fu dato in sorte di uscire già perfetta dalla fronte di Giove, non
solo a Venere di levarsi nella pienezza delle sue grazie dal mare; ma similmente accade a ogni ragazza la cui femminilità non sia stata guastata da ciò
che si vuole chiamare educazione. Ella si desta non gradualmente, ma in una
volta; e in compenso sogna tanto più a lungo, se gli uomini non sono tanto irragionevoli da destarla troppo presto. Questo stato di sogno è per una ragazza
una ricchezza infinita. Ell’era tutta occupata non con se stessa, ma in se stessa e doveva risultare da questo interno lavorio della sua anima una pace infinita, una quiete profonda in se stessa. Questa è la ricchezza immensa di una
fanciulla e chi sa impadronirsene diviene ricco a sua volta. Ell’è ricca per quanto non sappia di possedere, è ricca ed è pur ella stessa un tesoro”40.
DOSSIER
Il porre al momento del matrimonio l’evento della seconda nascita, se può
far pensare allo stereotipo del trinomio donna-moglie-madre, può, al contrario
far vedere come sia il possesso e l’esercizio pieno dell’affettività a determinare la nascita seconda della donna. Anche il danese, come Simone de
Beauvoir, esalta la ricchezza della giovinezza femminile, anche se è ricchezza “di sogno”, che si manifesta improvvisamente come Minerva e Venere,
senza mediazioni e senza fasi cadenzate.
Il pensiero femminile e il pensiero della differenza oggi pongono, sì, una
seconda nascita, ma come frutto di pratiche, di consapevolezze, di pazienti
tessiture, senza l’illusione malefica che le onde del mare o la fronte di Giove
possano miracolisticamente restituire alla donna, ed alla filosofia in genere, ciò
che all’una e all’altra è stato negato da secoli di nebbie occultanti.
Nonostante Arianna
Perché il filo(sofare) di Arianna? Me lo sono chiesto. Arianna, nella mitologia e nel lessico greci, è la “purissima”, “santissima”, è la Dea-Luna a cui si
dedicano bambole-Arianna appese agli alberi. Il filo di Arianna salva Teseo nel
Labirinto. Eppure Arianna, secondo il mito prevalente, si impicca perché è
abbandonata dallo stesso Teseo, non si sa se per la nuova amante o a causa
dei venti. Brutta metafora per la filosofia femminile.
Altra versione del mito: i venti portano via Teseo. Le donne di Amatone,
luogo in cui Arianna aveva voluto sostare, la consolano leggendole lettere che
fingevano essere state scritte da Teseo. Ma Arianna morì di parto. Metafora
più accettabile, non per l’exitus finale, ma per la solidarietà che si tesse attraverso scritture e letture femminili. È la lettura di donne a una donna a proteggere la vita.
Terza e ultima versione del mito. Arianna, durante il parto, fu uccisa con i
dardi da Artemide (la romana Diana), dopo essere stata accusata da Dioniso
di aver profanato la grotta, insieme a Teseo. Una variante: Arianna si impiccò
per paura di Artemide41. Lotta tra divinità femminili.
Non ho voluto ricordare il triste mito, con la ricorrente impiccagione (come
per Aracne a causa di Atena-Ragione), per chiudere la mia riflessione con il
timore di esiti esiziali per il pensiero delle donne e la loro tessitura teoretica. Al
contrario, ho voluto contrapporre ad antichi scenari di morte la cultura della
vita e della nascita che zampilla dal pensiero femminile e della differenza sessuale, a millennio iniziato.
Se Virgina Woolf, come ricorda Francesca Brezzi, notava che tra Ottocento
e Novecento molte donne in Inghilterra si erano dedicate alla scrittura di
romanzi, perché il romanzo con maggiore facilità si concilia con gli impegni
familiari, può essere scritto in salotto, cioè in un luogo comune a molte persone, e non richiede la concentrazione necessaria per una ricerca filosofica, che
ha bisogno di “una stanza tutta per sé”, un luogo dove potersi esprimere a
livello intellettuale42. Ora la stanza tutta per sé, per scrivere una filosofia di vita
e non di morte, la donna se l’è conquistata.
83
Per questo, vorrei chiudere con Irigaray, che propone il pensiero della differenza sessuale, come “l’orizzonte di mondi di una fecondità ancora non
avvenuta. Almeno in occidente e senza ridurre la fecondità alla riproduzione
dei corpi e della carne. Fecondità di nascita e di rigenerazione per partners
amorosi, ma anche produzione di un’epoca nuova di pensiero, arte, poesia e
linguaggio […]. Creazione di una nuova poetica”43. Non a caso ella, non cristiana, chiudeva il suo Amo a te richiamando il Magnificat che è esultanza per
una vita donata da un soffio, per una fecondità che non è solo quella biologica, in una ri-nascita che è estetica, teoretica e profondamente etica.
84
1
Nota sul volume: Il filo(sofare) di Arianna, a c. di A. Ales Bello e F. Brezzi, Mimesis, Milano
2001 (da ora questo volume sarà citato con la sigla: FA).
2
S. KIERKEGAARD, Don Giovanni. L’eros e la musica di Mozart, trad. it., a c. di R. Cantoni e M.
Guldbransen, Mondadori, Milano 1991, p. 59.
3
Amo a te. Verso una felicità nella storia, trad. it., a c. di P. Calizzano, Bollati Boringhieri,
Torino 1993, p. 54. Cfr. il saggio di M. FORCINA, Luce Irigaray militante politica di ciò che ancora
non è, FA, p.239.
4
Cfr. C. BETTINELLI, Sofia Vanni Rovighi. Il sapere filosofico, FA, pp. 45-62.
5
Cfr. Philosopher “en femme”. Raccontare Simone Weil, in Donne in filosofia, a c. di
G.A.Roggerone, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 1990, pp.113-125.
6
Cfr. M. DURST, Hannah Arendt: impegno nella storia come pratica della filosofia, FA, pp.93-114.
7
Cfr. A. ALES BELLO, Hedwig Conrad-Martius – Ontologia e vita, FA, pp. 19-29.
8
E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, trad. it., a c.
di E. Filippini, Einaudi, Torino 1965, p. 50.
9
Cfr. A. ALES BELLO, Edith Stein. Ontologia metafisica vita, FA, pp. 31-43.
10
Il problema dell’empatia, trad. it., a c. di E. Costantini, Studium, Roma 1998, p. 49.
11
Uomo e natura. Appunti per un’antropologia filosofica, Vita e pensiero, Milano 1980, p. 174.
12
Esiste la filosofia?, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano 1979, p. 18.
13
Cfr, D. VERDUCCI, Anna-Teresa Tymieniecka, FA, pp. 63-89.
14
Cfr. A. M. PEZZELLA, Maria Zambrano. Filosofia poesia mistica, FA, pp. 165-173.
15
I beati, trad. it., a c. di C. Ferrucci, Feltrinelli, Milano 1992, p. 88.
16
Filosofia e poesia, trad. it., a c. di F. Sessa, intr. di P. De Luca, Pendragon, Bologna 1998, p. 67.
17
Logos and Life: Creative Experience and the Critique of Reason, Book 1, “Analecta Husserliana”,
XXIV (1988), pp. 13-14.
18
Cfr. M. FORCINA, Simone de Beauvoir. Raccontare-raccontarsi per ritrovare il senso della
vita, FA, pp. 211-229.
19
Per una morale dell’ambiguità, trad. t., a c. di A. Bonomi, Sugar, Milano 1975, p. 21.
20
Cfr. B. TORTOLICI, Agnes Heller. Pensiero, sentimento, azione, FA, pp. 115-129.
21
Cfr. M. GENSABELLA FURNARI, Carol Gilligan. Una voce differente, FA, pp. 253-270.
22
Con voce di donna, trad. it., a c. di A. Bottini, Feltrinelli, Milano 1991, p. 26.
23
L’oblio dell’aria, trad. it., a c. di C. Resta e L. Irigaray, Boringhieri, Torino 1996, p. 40.
24
Cfr. P. RICCI SINDONI, Adrienne von Speyr. La luce e le immagini, per una fenomenologia
della visione, FA, pp. 133-145.
25
La luce e le immagini. Elementi della contemplazione, Jaca Book, Milano 1999, p. 74.
26
Cfr. R. FULCO, Simone Weil. L’infinito invocare bellezza e soprannaturale, FA, pp. 147-164.
27
La condizione operaia, trad. it., a c. di F. Fortini, SE, Milano 1994, pp. 286-287.
28
La connaissance surnaturelle, Gallimard, Paris 1950, pp. 194; tr. it. in Quaderni IV, a c. di
G. Gaeta, Adelphi, Milano 1993, p. 268.
29
Metamorfosi, l. III, vv. 348-348. La traduzione italiana è quella di E. Oddone (v. I, Bompiani,
Milano 1988, pp. 166-167).
DOSSIER
30
Cfr. Il corpo delle mistiche e la fame di assoluto, in M. FORCINA, Soggette. Corpo, politica,
filosofia: percorsi nella differenza, Angeli, Milano 2000, pp. 18-29.
31
Oeuvres complètes, t. IV, v. I, Gallimard, Paris 1994, p. 459; Quaderni II, a c. di G. Gaeta,
Adelphi, Milano 1985, p. 294.
32
Cfr. M. ZAMBRANO, La confessione come genere letterario, introd. di C. Ferrucci, trad. it., a
c. di E. Nobili, B. Mondadori, Milano 1997, p. 118.
33
Metamorfosi, l. VI, vv. 129-131.
34
Georgiche, l. IV, vv. 246-247. Sul Mito di Aracne, cfr. R. GRAVES, I miti greci, trad. it., a c. di
E. Morpurgo, Longanesi, Milano 1989, pp. 86-88.
35
Seneca, trad. it., a c. di C. Marseguerra, B. Mondadori, Milano 1998, p. 27.
36
Cfr. F. BREZZI, ESplorazione di nuovi territori, FA, pp. 179-208.
37
Cfr. M. DURST, op. cit, p. 109. Durst si riferisce, in nota, soprattutto all’appartenenza ebraica
di Hannah Arendt.
38
Amo a te, cit., p. 112.
39
L’età forte, trad. it., a c. di B. Fonzi, Einaudi, Torino 1961, p. 7.
40
S. KIERKEGAARD, Diario del seduttore, trad. it., a c. di L. Redaelli, Newton Compton, Roma
1993, p. 34.
41
Per la mitologia relativa ad Arianna, cfr. E. GRAVES, ad nomen.
42
Cfr. F. BREZZI, op. cit., p. 203.
43
Etica della differenza sessuale, trad. it., a c. di L. Muraro e A. Leoni, Feltrinelli, Milano 1985, p.11.
85
DIETRO LE IDEE.
RICORDO DI ANGELO PRONTERA
di Aniello Montano
86
Sono trascorsi poco più di quattro anni da quel terribile trenta luglio del
1998 in cui Angelo Prontera, Franco per tutti, ci ha lasciati. Quattro anni in cui
colleghi, discepoli e amici hanno continuato a domandarsi come sia stato possibile che un uomo così attivo, così dinamico, impegnatissimo nel proprio lavoro e pieno di una vitalità esuberante e contagiosa sia all’improvviso mancato.
Questo senso di smarrimento e di vuoto, che ancora oggi pesa nella mente e
nel cuore di tutti noi, ha spinto un gruppo dei suoi discepoli e dei suoi amici più
cari a tentare di mantenere con lui ancora attivo e vivo il dialogo culturale. E
quale poteva essere il modo migliore per continuare a dialogare con lui se non
riflettere e scrivere su temi a lui cari, su quei temi che erano serviti a Franco
per esercitare la sua forte passione per la ricerca, intesa come esercizio intellettuale e culturale, ma anche come pratica di vita civile e morale.
Da questa esigenza, e non solo dalla consuetudine accademica di onorare gli amici scomparsi, è nata questa bella e ampia raccolta di Studi e testimonianze per Angelo Prontera che i curatori, Andrea Calì, Jean Durand,
Marisa Forcina, Pia I. Vergine, hanno opportunamente e intelligentemente intitolato Filosofare dialogando (Milella, Lecce 2002, pp. 762). In questo titolo essi
hanno voluto racchiudere ed esprimere le doti essenziali di Angelo Prontera
studioso, vale a dire l’amore per il sapere e la pratica del dialogo. Amore per
il sapere inteso come continua ricerca, come interrogazione continua, come
tentativo di approssimarsi sempre più a una comprensione della vita e dell’esistenza umana che, per la loro complessità, mal sopportano di essere racchiuse in formule dal tono definitivo e definitorio. E pratica del dialogo inteso
come tentativo di cercare insieme all’altro, agli altri, una via per costruire una
trama di significati capaci di dare senso e valore all’esistenza degli uomini e
alla loro coesistenza.
Il numero elevato dei saggi che compongono il volume dà conto già da solo
della quantità degli studiosi italiani e stranieri che hanno avuto consuetudine
di dialogo e di studio con Franco Prontera, per dare vita a questo ricordo di lui,
nel suo paese natale.
Ricordo è parola semplice, ma carica di un significato profondo e a forte
valenza pratica e intellettuale. Ricordare, alla lettera, vale riportare al cuore,
ricostruire e rendere percettebile ai sensi interiori l’immagine di una presenza
viva e attuale ricostituendola nel suo aspetto esteriore ma anche nella densità emotiva e passionale che l’accompagnava ogni volta che veniva percepita
nella concreta esperienza della vita relazionale. La radice prima del termine
ricordo, infatti, è cor-cordis, che indica il cuore. Ricordare qualcuno, e nel caso
NOTE
specifico di stasera ricordare Franco Prontera, significa voler testimoniare la
sua presenza viva, sorridente e parlante nei nostri cuori. Immagine, questa
della presenza di una persona cara nel cuore, che, per quanto usata e abusata, non è affatto usurata. Anzi, nella comunità degli studiosi, deve mantenere intatta la sua ricchezza e la sua pregnanza evocativa e significativa. Il
cuore, in settori non secondari della cultura classica e non solo classica, ha
rappresentato la sede di tutta la vita spirituale, intellettiva e affettiva, dell’uomo. Per l’agrigentino Empedocle: “Nei flutti del sangue pulsante è nutrito [il
cuore], / dove principalmente è ciò che gli uomini chiamano pensiero; / per gli
uomini, infatti, il sangue che circonda il cuore è il pensiero” (DK 31 B 105). Per
lo stagirita Aristotele, il cuore è la sede delle sensazioni, delle emozioni e,
quindi, degli affetti (De partibus animalium, II 10, 656 a).
Ricordare Franco significa, perciò, testimoniare la presenza viva dell’uomo
nei nostri affetti e nelle nostre emozioni, ma significa anche testimoniare la
presenza dell’intellettuale, delle sue idee, delle sue riflessioni nei nostri pensieri, nella trama delle nostre argomentazioni, nei nostri programmi di lavoro.
Ma il cuore che ci impegna al pari della mente in questo ricordo di Franco,
entra in gioco anche nel veloce e sintetico tentativo di percorrere il suo cammino di pensatore, per cercare di comprendere e ricostruire le sue scelte di
fondo, il suo progetto fondamentale, quel progetto cui è rimasto fedele per l’intero arco della sua intensa, anche se breve, esistenza.
Al cuore Pascal attribuì due forme di conoscenza: la prima si riferisce ai
rapporti umani, cosicché il cuore è la guida privilegiata nella scelta della condotta pratica, dell’agire morale, nella formulazione precategoriale del progetto
fondamentale di ognuno di noi, delle nostre opzioni nel campo della fede, nelle
questioni prime e ultime; la seconda fa riferimento al campo cognitivo, sicché
indica l’orientamento originario che ci conduce ad aderire immediatisticamente a certi principi e a certe immagini della scienza che la ragione, in seguito,
dimostra e comprova come veri o falsi, o meglio rispondenti o meno al bisogno di conoscenza e di orientamento nel mondo da parte degli uomini.
Proprio dal cuore, inteso come il luogo metaforico della scelta di campo
nelle questioni fondamentali e nell’adesione ad alcuni presupposti originari
delle forme di cultura, sgorgò la decisione di Franco, giovane ricercatore appena ventisettenne, di aderire all’invito che gli veniva dalla parola e dal tratto comportamentale del suo primo maestro universitario, Giuseppe Agostino
Roggerone ad elevare a principio etico fondamentale la salvaguardia della propria libertà interiore e il rispetto della libertà interiore dell’altro. Da qui il duplice
impegno dello studioso e del docente. Da una parte l’esercizio della libertà nell’esplorare culture, filosofie e religioni diverse, senza alcuna preclusione ideologica, ma con il gusto intellettuale di allargare il proprio orizzonte e di capire le
radici, i principi fondativi e i risvolti morali di ognuna di esse. Dall’altra la pratica della libertà d’insegnamento, la libertà di parola (la parrhesìa degli antichi
Greci), senza colorarla mai con i toni profetici di chi crede di possedere la verità tutta intera, da imporre con il fascino e la seduzione della retorica ai suoi giovani ascoltatori. Egli, come accennò con calda e commossa parola nella testimonianza del 31 luglio 1998 Giovanni Invitto, “non permise mai che il ‘sistema
87
88
filosofico’ esercitasse la sua violenza sulle coscienze, sulla ragione, sui sentimenti” dei suoi ascoltatori. Ed è proprio in nome di queto principio fondamentale rappresentato dalla libertà interiore che Prontera disegna la intensa e ricca
mappa della propria ricerca. Mappa che ha come punti di riferimento privilegiati un No e due Sì. Un No pronunciato agli inizi degli anni Settanta e due Sì pronunciati a partire dalla metà di quegli stessi anni e confermati e consolidati per
tutto l’arco della sua densa, anche se breve, esistenza.
Il No alto e forte risuonò nella sua prima opera a stampa, Il naufragio della
libertà. Saggio su Althusser, pubblicata presso Lacaita a Manduria nel 1972.
Ed era un No che risuonava e si espandeva in una duplice direzione. Era un
No alla cultura con l’elmetto, alla cultura acquartierata e in trincea a difesa di
specifiche e intransigenti posizioni politiche, alla cultura che demonizzava dal
suo particolare punto di vista ogni alterità, ogni altra possibile, diversa posizione. Era, cioè, un No alla negazione del dialogo aperto, dell’incontro dialogico e non agonico che deve contrassegnare la comunicazione intellettuale.
Ed era un No alla cristallizzazione della dialettica aperta, del confronto e del
dibattito, con l’intenzione di demonizzare e annientare le ragioni dell’altro. Ma
era soprattutto un No a una pratica che tentava un’operazione bollata come
mineralizzazione dell’uomo dalla facondia intellettuale e dalla penna magica di
Sartre. Una pratica, cioè, intesa a sminuire, fino a cancellare, la libertà della
coscienza e la natura progettuale dell’uomo per sottometterle alla necessità
necessitante intrinseca alle strutture storico-economiche. Era, quello dello
strutturalismo da Prontera simboleggiato in questo scritto dalla figura di
Althusser, un tentativo di pensare la storia, il sapere e tutto quanto si riferisce
al “mondo umano” facendo riferimento esclusivamente a relazioni sistematiche e costanti intercorrenti tra i fenomeni socio-culturali ed economico-materialistici –le strutture, appunto–, con la sostanziale esclusione di ogni possibile partecipazione attiva e determinante da parte del soggetto. La sostanziale
esclusione della soggettività dai processi storico-sociali, non tanto implicita e
sottaciuta, puntava a mettere totalmente fuori gioco la funzione e il ruolo dell’uomo nella costruzione degli eventi storico-economici. Puntava a rimuovere
la coscienza umana (quale curioso, strano e assurdo impasto di emozione e
logica, di natura e cultura) dal centro operativo e significativo di ogni evento.
Puntava a negare, insomma,il ruolo dell’uomo quale punto d’origine o di riferimento dei fatti storici e del loro significato.
Il giovane Prontera avvertì e stigmatizzò immediatamente la pericolosità di
questo “antiumanesimo” tendente a occultare ed escludere ogni traccia del
soggetto e del suo vissuto. Si era reso conto che se avesse prevalso avrebbe
costretto la filosofia a svolgere un ruolo subordinato e ancillare di semplice
supporto delle scienze positive o di critica delle ideologie e avrebbe comportato il naufragio della libertà, intesa come spontaneità e creatività del soggetto. Contro il tentativo rappresentato da Althusser Prontera è pronto a rivalutare l’opera giovanile di Marx, di Marx uomo del suo tempo, che di quel tempo
avverte ansie e speranze, incarnate e rese manifeste da uomini veri, in carne
e ossa, in preda a tensioni volitive e desiderative, vogliosi di sperimentare progetti e programmi intuiti e nutriti in quella forma precategoriale che è tipica del-
NOTE
l’immaginazione creativa. Ed è incline a ripensare le antinomie esistenziali
poste in luce da Karl Jaspers e da Edmund Husserl per trasformarle in tensioni
vitali capaci di svolgere una funzione importante, di grande incidenza nella
messa in essere dell’azione umana costruttiva e trasformatrice della realtà.
L’occultamento del soggetto, quale ente progettante e realizzante del sapere filosofico e scientifico, civile e morale, suona come occultamento della complessa realtà esistenziale e come messa in crisi del sapere umano, estenuantesi in una sorta di ideologia prettamente intellettualistica incline a ridurre tutti i
fenomeni della vita e della storia a fenomeni casualisticamente e necessaristicamente concatenati. Alla tentazione strutturalistica di sterilizzare sapere storico
e sapere scientifico della destabilizzante presenza del soggetto umano volente
e desiderante il giovane Prontera rispose riproponendo l’intangibile e inestinguibile funzione dell’uomo, della sua libertà, della sua capacità progettuale, della
cifra sua più propria consistente nell’essere immerso nelle contraddizioni della
vita, nell’abitare la temporalità, nella capacità di guardare vis-à-vis le contraddizioni della vita tentando di armonizzarle e di segnare uno stretto e ineludibile
rapporto tra sapere ed esistenza, tra pensiero e azione, tra ragione ed emozioni, tra senso della vita e senso della morte, tra temporalità e corporeità.
Da questa forma di umanesimo, assorbita e fatta propria attraverso le figure storiche di Socrate e Agostino, di Rousseau e Bergson, di Marcel e Mounier,
viene formandosi la disponibilità emotiva e intellettuale che lo indurrà a pronunciare i due Sì cui abbiamo accennato. Due Sì relativi a due modi di intendere la pratica intellettuale e riferiti a due autori assunti quali modelli paradigmatici di essi. Questi due modi rappresentano la concezione della “filosofia
come metodo” e l’assunzione della libertà e del pluralismo come cifre essenziali del rapporto tra soggetti paritariamente considerati. È importante osservare e fare osservare che le ragioni ideali e teoriche che inducono Prontera ai
due Sì, a consentire cioè con due filosofi che l’accompagneranno per tutto l’arco della sua intensa riflessione filosofica, sono già presenti, passionalmente
avvertite e idealmente prefigurate, prima dell’incontro con quegli autori. Con
questa osservazione si vuole precisare che i due Sì non sono il frutto di un’adesione immediatistica e acritica e che a partire da quegli incontri e dagli studi
da essi sollecitati siano poi maturate nella mente del giovane studioso idee e
posizioni ideali prima assenti. L’adesione esplicitata con i due Sì, perciò, è frutto di un ri-conoscimento, dell’affinità intravista tra le tensioni e le pulsioni della
sua personalità intellettuale e quelle degli autori cui con-sente e che elegge a
suoi interlocutori privilegiati, ma che considera anche quali compagni maggiori nel difficile tentativo di portare a maturazione completa i germi originari della
naturale disponibilità teorica.
Quella stessa intuizione originaria che aveva sollecitato e sostenuto il giovanissimo Prontera a dire No allo strutturalismo antiumanistico e in particolare ad
Althusser ora lo incoraggia e lo induce a dire Sì a una posizione etico-esistenziale nei cui confronti, però, non si verifica mai un allentamento della vigilanza
critica, un’accettazione cieca, assoluta e incondizionata e neppure un atteggiamento di pacifico e pacioso ottimismo ingenuo. Non è un caso che tra i primi,
brevi, saggi dedicati al primo degli autori con i quali consente e ai quali dice Sì,
89
90
Charles Péguy, il più significativo del 1979 reca il titolo Péguy per un cristianesimo vigile e contestatore. Proprio questa vigilanza cauta e contestativa, caratterizzante la militanza civile e culturale di Péguy, impegnerà Prontera per tutto il
corso della sua ricerca e impronterà di sé tutta la sua attività di docente universitario. Dalla fine di quei lontani anni Settanta fino all’ultimo momento della sua
attività, Prontera dedicherà a Péguy gran parte delle sue forze intellettuali e della
sua attività di ricerca. Pubblicherà sul filosofo francese saggi, monografie, articoli. Curerà la traduzione italiana di molte sue opere. Organizzerà convegni e
seminari di studio per favorire l’incontro di studiosi italiani e francesi e per confrontare i rispettivi modi e i contenuti delle diverse interpretazioni della filosofia di
Péguy. È convinto che leggere Péguy, comprenderlo, assorbirlo è come leggere in se stesso, capire meglio e più se stesso, rendere chiaro ed esplicito ciò che
in se stesso si agitava talvolta in maniera magmatica e involuta o in forma talmente implicita e silente da non affiorare alla coscienza. Leggendo il saggio di
Péguy dedicato a Il denaro, Prontera avverte immediatamente una forte consonanza non solo intellettuale ma anche esistenziale con il filosofo francese.
Immediatamente decide di conoscerlo più e meglio.
In un saggio del 1985, Nel solco della memoria, leggibile in Echi di una
voce, un volume collettaneo di commosse testimonianze pubblicato all’indomani della scomparsa del giovane docente e a lui dedicato dalle “Edizioni
Milella di Lecce Spazio vivo”, si legge: “Subito mi si impose la necessità di leggere Péguy direttamente, senza commenti, in lingua francese, alla scoperta di
un uomo, di una storia, di un’avventura, di una lotta, di un pensiero […], alla
scoperta di me stesso […], di un riconoscimento esistenziale di me stesso proprio da parte mia. La sua opera mi lavorava. Io d’altra parte lo lasciavo operare in me. Lo lasciava fare il suo Lavoro sul lettore che ero io. Indocile ed
attento, disponibile e qualche volta impertinente, ho colto così un metodo in
azione”. A fargli sentire questa consonanza patica e intellettuale con Péguy
era il modo di intendere la pratica filosofica come esercizio di analisi e di comprensione della vita, della vita concreta di uomini in carne e ossa, considerati
nelle loro occupazioni quotidiane, nella loro concreta e vitale esistenza, dei
tanti uomini che popolano il nostro mondo, che osserviamo lavorare come
contadini, vignaioli, artigiani, di uomini “immersi nel lavoro come se fosse preghiera” e che pregano “come se ciò fosse lavorare”.
In questo mondo della provincia artigiana e contadina, in cui lavoro e preghiera costituivano un modo efficace per dare senso alla vita, per tentare di
comporre le sue antinomie altrimenti dilaceranti, per tentare di ridurre fratture
assurde e doloranti contraddizioni, Prontera –attraverso Péguy– riconosce il
mondo della sua infanzia, della sua prima formazione umana. Scopre l’identità di esistenza e coesistenza. Avverte la stretta connessione tra individuo e
gruppo sociale ed etnico che lo accompagna nella crescita e lo aiuta nella
maturazione. Intuisce che un’approfondita analisi dei comportamenti e degli
atteggiamenti esistenziali di quel gruppo, delle sue tensioni interne, delle
comuni speranze e del reciproco sostegno può aiutare molto a comprendere
la vita, i suoi schemi, i suoi complessi meccanismi.
Nello stesso saggio, Nel solco della memoria, Prontera con la schiettezza
NOTE
dell’uomo sincero ribadisce più volte il suo debito nei confronti di Péguy.
Scrive, infatti; “Il mio problema era allora di trovare la mia identità personale
come modalità esistenziale che mi aiutasse ad essere pienamente il popolo
che ero, quanto meglio era possibile. Péguy sapeva tutto ciò per esperienza
e, raccontandomela, mi aiutava […]. Ho così appreso ad incarnare alcune
idee, a scoprire dietro le idee e dietro gli schemi intellettuali o politici, religiosi
o morali, delle condizioni e dei bisogni reali, sia materiali, sia spirituali”.
Sulla linea delle riflessioni e delle battaglie civili e intellettuali di Péguy,
Prontera matura la convinzione che filosofia e vita non sono pratiche differenti, che il mondo delle idee nasce dentro e al servizio del mondo della vita, intesa questa sia in senso economico-sociale che in senso spirituale e culturale.
Péguy assurge, perciò, a modello paradigmatico della lunga tradizione dei
maestri non di dominazione o di comando, ma di insegnamento e di competenza. Per Prontera, come scrive Marisa Forcina, “Péguy non era solo uno
strano poeta e uno scrittore eccezionale, ma un filosofo e un politico attento ai
problemi della libertà e della democrazia, della morale, del potere e di tutte le
degenerazioni, svelatore degli inganni della retorica e delle buone coscienze
permeate solo da abitudini e accomodamenti”. Péguy, come Socrate, è considerato come la torpedine che dà la scossa, accende la tensione critica, invita
a riconsiderare il mondo con occhi nuovi, con mente sveglia, desta, pronta a
discutere tutto, a tutto esaminare, dopo averlo spogliato della falsa sacralità o
dell’alone del mistero prodotti dalla pigrizia abitudinaria e dallo spirito di gregge. Péguy, si potrebbe dire, svegliò il giovane filosofo dal sonno dogmatico che
spesso induce molti a credere di possedere tutta intera e soltanto loro la verità su cui misurare, saggiare ed eventualmente condannare morali e fedi altrui.
Péguy svolge a pieno il ruolo di maestro di umiltà, l’unica disposizione mentale in grado di farci cercare l’altro e di tentare di confrontarci con lui su un piano
di parità. Si rivela portatore di quel saggio relativismo che senza scadere nello
scetticismo suggerisce di prendere sul serio l’altro non per piegarlo alle nostre
ragioni, per convertirlo o processarlo, ma per confrontarsi paritariamente con
la sua libertà e le sue convinzioni. In un passaggio di estrema e calda professione di fede in Péguy, leggibile nello stesso saggio Nel solco della memoria,
Prontera scrive: “Péguy è il nostro ‘maestro’ perché ci ha insegnato soprattutto: a) Che “sono le morali duttili, i metodi duttili, le logiche duttili che esercitano le prese più impeccabili. È proprio per questo che l’uomo più onesto non è
quello che rientra in regole apparenti. È quello che resta al suo posto, lavora,
soffre, tace”. b) Che l’altro, la sua novità e la sua libertà, spesso insopportabili, sono fra le nostre necessità più vitali e più difficili”.
L’assidua frequentazione delle pagine di Péguy induce Prontera ad aprirsi
al nuovo, di cui l’altro è portatore, con fiducia e speranza. Lo sollecitò a interessarsi con spirito aperto e dialogante al pensiero africano. Gli instillò il desiderio, purtroppo non pienamente soddisfatto, di più e meglio conoscere il pensiero islamico. Lo avvicinò al pensiero femminile, considerato innovativo in
quanto capace di dare la scossa e di mettere in crisi inveterate e non sempre
giusitificate abitudini mentali. Proprio il pensiero femminile, per Prontera, rappresentava la novità filosofica della seconda metà del Novecento.
91
92
Rappresentava l’apertura di nuovi territori intellettuali da attraversare con
mente libera, sgombra da pregiudizi e con il desiderio di comprendere, non di
mortificare o reprimere, le nuove istanze di libertà e di impegno partecipativo
provenienti dai settori più vivi e più impegnati del mondo femminile.
Questo aprirsi a nuove latitudini di pensiero, questo dialogare con gli altri
avendo abbandonato l’etica espansionistica e omologante che è sempre violenza e guerra produce quella che, con finezza di sentire, Giovanni Invitto indica come “liberazione degli altri e nostra liberazione perché apriamo le orecchie alla parola e al linguaggio degli altri”. Ma offre anche la possibilità per
mettere intelligentemente a frutto i motivi portanti di un’etica della differenza.
Non è un caso che Prontera abbia prestato molta attenzione al pensiero di
Hannah Harendt, certamente un polo originario da cui è derivata l’elaborazione critica dell’ontologia esistenziale comprendente non poche tesi della teoria
della differenza. E, proprio sulla scorta delle considerazioni di Péguy e della
Harendt, Prontera matura il rifiuto dell’“idea di totalità che contraddistingue la
tradizione filosofia occidentale, ed è radice di totalitarismo, sopraffazione e
violenza”. E, di conseguenza, fa propria “una prassi della differenza e del
rispetto della molteplicità, fondata sul riconoscimento della propria responsabilità nei confronti dell’altro”, come lucidamente osserva Mario Signore commentando la posizione di Emmanuel Lévinas.
L’altro Sì, oltre a quello espresso per Péguy, Prontera lo pronuncia per
Pierre Leroux, l’intellettuale francese che nella prima metà dell’Ottocento, fondando il giornale Le Globe, rivendicava la libertà di stampa come “garanzia
della libertà del popolo” e che nel 1832 –come ci ricorda Bruno Viard– mette
all’ordine del giorno “la grande questione del proletariato”. Questione da porre
e da risolvere nello spirito della non violenza che è alla base del metodo e
della ideologia della democrazia. Ideologia che Prontera indaga e delucida
attraverso le considerazioni di Leroux. Lo spirito libertario, egualitario, a forte
caratura comunitaria che anima Péguy e che entusiasma Prontera ha sicuramente quale suo luogo originario gli scritti di Leroux che nei giorni inquieti degli
anni Venti e Trenta dell’Ottocento tentava di collegare leggi particolari e leggi
generali, codice e costituzione ai bisogni reali e concreti dei meno abbienti; e
che, in nome della filosofia e del cristianesimo, sviluppava una forte critica
all’economia sulla base della dichiarazione dei diritti sanciti nel 1793 nella
Francia rivoluzionaria. A Leroux Prontera dedicherà più di un saggio e, per
meglio farlo conoscere, renderà leggibile in italiano la monografia di Jacques
Viard dedicata a Pierre Leroux, Georg Sand, Mazzini, Péguy e noi.
Attento ai drammi e ai lutti della vita e della storia, Prontera con il viatico di
Péguy e di Leroux, predicò e praticò una filosofia del dialogo, del confronto,
dell’attenzione all’altro, agli altri, e orientò il suo occhio e il suo spirito nella
direzione del futuro. In ciò spinto e sorretto da un’inesauribile capacità progettuale all’insegna della speranza, la stessa cui nel 1858 Pierre Leroux volle
dedicare la nuova rivista di sua creazione che titolò, appunto L’Esperance; la
stessa cui volgiamo il nostro sguardo, convinti che Franco sia con noi, a fianco a noi, nel tentativo di trasformare la speranza che ha animato la sua opera
e che sorregge il nostro impegno in conquista concreta e duratura.
ALTRE AURORE
Un’altra Aurora di Angelo Semeraro (I Liberrimi, Lecce 2002), gravida di
significati, segni, simboli e preludi.
Intessuta da una trama policentrica che apre ad una lettura ologrammatica
e circolare nella quale ogni parte contiene l’informazione del tutto senza inizio
né fine. Ogni thema è, infatti, connesso e implica una diversità di trattazione,
passaggi inclinati, piani trasversali, rimandi e ritorni. Con un intreccio di testualità altre, che vanno dalla descrizione-analisi alla riflessione teorica intimamente soggettiva, ci lascia scivolare, attraverso i suoi paesaggi mentali, oltre
la scrittura e l’autonarrazione che è sempre, per un autore, una nuova nascita. Una creazione, un evento di trasformazione che ci apre dialogicamente al
suo e al nostro continuo sdoppiamento dall’io al me, dall’ io al noi.
Altre Aurore non è semplicemente un libro sulla comunicazione ma è un
discorso sulla metacomunicazione (arte e tecnica insieme) e sulla sua efficacia in contesti di relazione. L’obiettivo dichiarato è di esplorare le possibilità,
nel caos del polimorfismo ideologico della comunicazione/manipolazione, di
una vera comunicazione premessa ad una autentica comprensione. È la possibilità di modificarne le forme ossia i codici del gioco interattivo e di crearne
di nuovi, inseriti in contesti dai quali far generare una nuova teoria della conoscenza. Una comunicazione altra, interculturale che implica una pluralità di
paradigmi logici e di modelli grammaticali, di pratiche e di giochi linguistici
(Wittgenstein).
Semeraro occupandosi di metacomunicazione ne esamina i diversi livelli di
astrazione e di processualità, coglie la loro natura complessa, polisemantica,
nonché l’ambivalenza, le insidie, la forza espressiva ed enunciativa che il linguaggio sottende. La sua si pone come una razionalità discorsiva (Habermas),
le cui procedure comunicative sono liberate da meccanismi di controllo e di
condizionamento, pertanto aperte alla partecipazione e al contributo di ciascuno. È un invito a conoscere come comunichiamo per conoscere come
conosciamo o ri-conosciamo, per esempio l’altro, e a interrogarci sulle modalità della nostra comunicazione per migliorarla, attraverso l’introspezione e
l’autoeducazione, apprendendo ad apprendere dagli errori e a pensare per differenze.
Non stupisce il richiamo alla costruzione di un comune codice linguistico
fondato sul consenso, come necessaria base per una convivenza civile e
democratica. Non perché il linguaggio possa essere riconducibile ad una unitaria struttura formale, ma perché sul terreno di una pragmatica comunicativa
Semeraro ritiene possibile costruire una molteplicità di pratiche linguistiche a
NOTE
di Santa De Siena
93
94
partire dallo studio della relazione tra il segno e l’interprete. Il sapere è comunicazione, afferma, e il comunicare è sapere: è sapere come comunicare,
apprendere, interagire, riconoscere, relazionarsi, ascoltare. Sentire “l’altro dietro i segni e le parole; imparare a decifrarne il non detto senza equivocarne i
significati resta ancora un alfabeto delle relazioni tutto da apprendere”. (Altre
Aurore, p.12).
Questa sfida ad una comunicazione consapevole è al tempo stesso un
ripensamento della nostra identità culturale dominatrice e di appropriazione
delle identità altrui attraverso quel procedimento che i sociologi chiamano
othering: con un complesso gioco di metafore e l’uso di una certa modalità
testuale, si riesce a ridurre, sminuire e a far percepire l’altro come altro da sé.
Ne consegue un preciso linguaggio escludente come quello di Colombo, il
quale nella rielaborazione critica di Semeraro diventa metafora di una metafora. Colombo è metafora dell’avventura, ricerca, conoscenza; ma anche del
paradigma di semplificazione e di dominio attuato con l’imposizione dei codici
della comunicazione. Il suo conoscere è in realtà –come sostiene Semeraro–
un comprendere-prendere-distruggere; uno schema che ha costituito l’archetipo del potere linguistico europeo, la nostra modalità di conoscenza e di
assoggettamento. A fronte di una secolare incomunicabilità emerge, oggi, una
letteratura contrapposta che va sotto il nome di alter-native o writing back literature, che si sta delineando come un “controdiscorso coloniale”.
La comunicazione consapevole che Semeraro propone è, invece, quella
che sviluppa l’attenzione all’ascolto dell’altro, attenta al senso che l’altro attribuisce all’ascolto, che sviluppa la condivisione del contesto e che comunicando innova. Si ha un comportamento refrattario alla trasformazione comunicativa e, dunque, autoritario quando si fa corrispondere l’ascolto con l’enunciazione. Mentre è aperto all’innovazione il comportamento di chi è disponibile a
lasciarsi attraversare dalla comunicazione e quindi a sviluppare l’ascolto dell’ascolto. L’ascolto dunque come luogo del riconoscimento dell’altro nel quale
si istituisce il suo diritto ad esistere e dal quale soltanto nasce la
relazione/comunicazione, ossia la vera metacomunicazione. L’apertura all’ascolto è al contempo innovazione linguistica, scoperta di sé e dell’altro, attenzione alle trasformazioni delle regole del gioco, evoluzione e genesi di nuove
possibilità di dialogo. Comunicazione e socialità si istituiscono nel linguaggio,
ma è nella dinamica dell’ascoltare l’ascolto e nell’insieme dei giochi linguistici
agonici che si crea il suo senso. L’assunto comunicazione è socialità ha, perciò, un duplice significato: implica non soltanto l’accomunare, ma anche il
creare comunità; la comunicazione intesa non solo come mezzo della socialità umana, ma anche come fondamento costitutivo della stessa comunità.
Nella articolazione testuale emerge una “voluta” confusione di confini che
rompe con tutto ciò che è separato, netto, regolare, ripetitivo, preciso per favorire la discontinuità, l’errore, lo slittamento, il fuori scala. È da questi giochi e
sperimentalismi che si produce la differenza e dai quali si possono generare
nuove koiné ermeneutiche (Vattimo), nuovi modelli di pensiero (Cerruti). Dove,
in luogo degli assoluti, c’è l’eclettismo, l’accanto e l’oltre, la contaminazione,
l’asimmetria, la convivenza, la ridondanza il rifiuto delle forme; istanze che rin-
NOTE
viano ad una concezione post-moderna della conoscenza non rappresentazionista e costruttivistica. Post-moderno è, infatti, per Lyotard ciò che si sottrae
alla consolazione delle buone forme.
Attraverso la ricerca precisa di alcuni nuclei percettivi, segni, tracce, emergono mappe, analogie, somiglianze, continuità, reti di comunicazione e nubi
associative fortemente significative che apparentemente descrivono ritratti di
realtà pulviscolari, dalle differenti opzioni: rimorso/rimosso, segni/parole,
logos/mythos e giochi creativi: why?, metafore, cure, estetiche, stili, congiuntivi, futuri atopici, ecc; ma che in verità sottendono o attendono a nuovi stili
cognitivi, a nuovi modi di organizzare i saperi e a nuove chiavi ermeneutiche.
Potrebbe sembrare la sua una “apertura” al cosiddetto minimalismo, a quel
fenomeno di ritorno alle forme ultime, elementari, ad una ricerca di sobrietà
che accentua l’aspetto semplice, povero che ricerca la “primitiva astrazione”,
più vicina all’atto creativo. Distante dalle luci e voci assordanti dell’intero mercato consumistico. Così egli sperimenta la discontinuità, il passaggio tra i
diversi codici dei regimi dei discorsi per aprire ad un nuovo ed inedito contatto con la realtà, Ricerca nuclei percettivi per dare senso, che è anche un dare
ordine e forma, a ciò che non è lineare, è informe e indefinito. Che non è un
ritorno alla forma, ma a pluralità di quadri, di giochi e possibilità nella consapevolezza che dietro i testi non si trovino i fatti ultimi, ma infinite interpretazioni. Nell’uscire dal linguaggio di codice egli sperimenta la drammaticità, l’erraticità ed anche l’errore che comporta l’imprevedibile senza rinunciare all’individuazione di significati propri e di propri domini cognitivi, generati da uno scatto morale che diventa etico ed estetico: che si fa destino.
Semeraro contrappone all’eccesso di estetizzazione il bisogno del ritorno
ad una tensione filosofica verso l’assoluto, conducendo la sua ricerca polidisciplinare con un approccio complesso, nel quale etica, estetica, biologia della
conoscenza, filosofia del linguaggio, politica, sociologia, antropologia, ecologia
ed educazione insieme sono volte a ritrovare quel che ci possa fare uscire dall’indistinto e indifferenziato che sembra avvolgere il mondo. Il suo è un desiderio di liberazione dal troppo che ci circonda per descrivere attraverso la
metacomunicazione un nuovo orizzonte d’essere, di vivere, di sentire e percepire, fondato sull’ascolto e non sul parlare. Rinunciando alla descrizione costitutiva di catene logiche, senza perdere di vista il rigore filologico, egli privilegia
percorsi insoliti ed effettua una sorta di “torsione etica” a partire dal rifiuto estetico di ciò che è pervasivo, ossessionante, abbondante, kitch. Per avviare così
una riflessione autogenerativa sulla crisi della razionalità moderna.
Il suo stile di pensiero rinvia ad una ecologia della mente nella riconquista
della percezione emotiva e nella rivalutazione del corpo originario strumento
di conoscenza, di costruzione di sensi, di dominio del sé, di individualità e relazionalità umana; la corporeità quale luogo della cognizione e della comunicazione (Varela). In luogo della separazione di mente-corpo, imposta dalla visione scissionista moderna, egli avverte l’urgenza di una inscindibile unità e di
una concezione complessa e dinamica dell’esistenza. Perde di senso così la
visione isolata, statica di una corporeità esterna al soggetto, concepita invece
come immersa in contesti di perturbazione e interazione, portatrice di senso e
95
96
perciò capace di incidere e modificare profondamente la realtà. Il soggetto
–dunque– protagonista, nella sua unitarietà di mente-corpo, della sua storia,
della sua esperienza, che genera intelligenza riflessa e comprensione della
propria e dell’altrui esistenza.
Il punto di vista di Semeraro sulla seduzione al femminile, quale discorso
di una comunicazione amorosa diversa e diversificata, evidenzia il suo stile
cognitivo che riconosce pertinenza al pensiero al femminile e il suo ruolo
“eversivo”, capace di rompere con il paradigma razionalista occidentale.
Delinea un’immagine straordinaria della donna che è un inno alla sua libertà;
una libertà che si è “costruita su mille libri di storie, di cui ha nutrito la propria
capacità di dire di no alla violenza e di dare un colore al mondo”. (Altre Aurore,
p. 53). Un altro modo di affermare che il figlio della chingada è il frutto del singolare maschile, mentre la libertà vuole il plurale.
Esempio di incapacità a comunicare e a problematizzare è il Narciso contemporaneo edonista, metacognitivo, depresso, arcieretico, espressione dell’attuale società di massa e del suo ineluttabile processo evolutivo/regressivo
che va dal piccolo Io al grande Sé; dal quale più che una società adultocentrica, si profila una società costituita da adulti-bambini globalizzati.
Il suo diventa un allarme di percezione che fa seguito alla crisi delle grandi narrazioni, di rappresentazione delle scienze e dei saperi, alla dissoluzione
del metalinguaggio universale, che sta producendo una proliferazione di
descrizioni, di codici, di generi, ma non un pensare al congiuntivo, riportando
l’umanità allo sradicamento e alla solitudine cosmica (Morin) da cui proviene.
Per questo oggi occorre un’educazione al plurale per trovare modalità nuove
di relazione e modelli più dinamici. L’interrogativo che si pone è –in assenza
di nuovi valori– come convivere, impedire, evitare, cooguidare i processi omologanti di una comunicazione che sterilizza i rapporti interpersonali e nel “flusso ininterrotto delle informazioni le parole scomposte in bit elettronici sono
senza corpo e senza proprietà”? (Altre Aurore, p. 73). Quando l’atto del parlare non è una cosciente descrizione di sé, un discendere dentro se stessi con
sofferenza, rimane un parlare e scrivere superficiale, non diviene mai grammatica profonda (Wittgenstein). Perciò il dramma della comunicazione contemporanea è posto sul piano estetico, emotivo e cognitivo, su ciò che il dire,
la parola, l’autoreferenza senza reciprocità sta creando: una comunicazione
senza contenuti, astratta e vuota. L’etica della comunicazione presuppone
invece lo sforzo di discendere in profondità nei recessi della propria coscienza, in una continua ridescrizione di sé e del propio io. Un io duale e plurale,
non un Grande Sé. È attraverso la libertà di svelarsi, di descrivere la realtà che
si attiva il processo eduttivo di cui parla Semeraro: un procedimento auto-educativo capace di attivare processi cognitivi di secondo ordine, di inventare
nuove metafore e nuovi giochi linguistici con i quali soltanto si esprime l’essenza della verità. La prospettiva ecologica suppone, infatti, lo slittamento
dalla nozione di educazione a quella di eduzione, concepita quale diritto di ciascuno a condursi da sé, ad autocrearsi ed auto-eco-organizzarsi nell’ambiente in cui vive, nell’oikos. Perciò più ricco “di comunicazione orizzontale è un
ambiente, più ricche si fanno le occasioni eduttive” (Altre Aurore, p. 205).
NOTE
Convinto come è che la costruzione di una identità autonoma e critica sia possibile nonostante i limiti di una razionalità dimezzata e di una emotività effimera nello spazio fisico della vera relazionalità, della comunicazione dialogica
basata sulle emozioni, sull’autopoiesis ossia la capacità di creare autonomamente significati, sensi, nuovi spazi di relazione, metafore vive. La metafora
viva o live metaphor non è una pura figura retorica, un ornamento al discorso,
ma quel dispositivo semantico e cognitivo (Lakoff e Johnson) con il quale il
soggetto crea un nuovo scenario di senso, entro la cornice del quale si costruisce una nuova concettualizzazione dell’esperienza.
Il senso della metafora Altre Aurore è proprio quello di ridefinire continuamente la libertà propria di creare nuove metafore, di creare nuove creazioni
(Nietzsche) con le quali “aprire” a nuovi orizzonti di significato, a nuovi paradigmi interpretativi a nuove ecologie costitutive di nuove teorie, per produrre
narrazioni nuove nel vuoto degli assoluti e nello smarrimento degli antichi fondamenti. Un’ermeneutica della domanda che si configura come una transizione del linguaggio di codice (Gargani) in grado di creare contesti e di qualità
estetiche che sospendono il linguaggio ordinario attraverso il suo pensare raccontato, la ridefinizione del suo stile di pensiero. Prende atto, ad esempio, che
l’organizzazione tecnologica è talmente entrata a far parte della nostra vita che
è ormai un paradigma influente irrinunciabile e irrevocabile, come un destino.
Ma nello stesso tempo riconoscere che il sistema e l’organizzazione dei media
offrono spazi ad una nuova riorganizzazione, ad un’altra retorica, che rende
possibile una cultura dialogica. La quale nel mentre esibisce nuove forme più
evolute e modalità più libere di comunicazione, trasforma le esistenze individuali e collettive e fa emergere nuovi valori solidali e condivisi. La scelta dello
stupore ne è l’espressione più matura della liberazione da una visone ideologica per aprire ad uno spazio di comunicazione nel quale ad attivare la relazione pura sia il munus, lo scambio o dono di parole. Il solo gioco capace di
andare oltre la semplice rivendicazione dei diritti e sviluppare autentici contesti di relazione paritari.
La sfida non è più tra vecchio e nuovo, ma è una coevoluzione nel sistema
dei vincoli e delle possibilità che si offrono nella società complessa, creando e
ricercando forme più avanzate di pensiero ed esigenze più raffinate di libertà.
Per una ecologia della comunicazione quale premessa ad una riforma dell’educazione che sia eduttiva e capace di educare alla differenza, alla preferenza, al pensare congiuntivo, al dialogo, al munus, inteso come scambio comunicativo globalizzante. In uno dei suoi passaggi repentini che vanno dall’io al
noi Semeraro delinea la scelta politica di una comunicazione ideale tutt’una
con la comunità ideale, che implica la necessità di concepire una nuova relazione cosmopolitica e quindi una coscienza planetaria (Morin). Viviamo in una
società monologante ripiegata narcisisticamente su di un grande Sè, che ci fa
scartare tutto ciò che riteniamo destabilizzante per i nostri domini cognitivi e
che aprioristicamente ci può far cambiare il nostro punto di vista. Ciò rinvia alla
fenomenologia della conoscenza, al nostro essere nel mondo e nel cosmo ai
nostri bisogni di certezze, ai processi di globalizzazione geo-politici in atto, per
esigere maggiore diritto a partecipare, a comunicare e si traduce in ecologia
97
della politica. Semeraro stabilisce, infatti, una stretta relazione tra pluralismo
politico e qualità della comunicazione, tra controllo e mezzi in una società
aperta. Contro quella che definisce essere un processo di rarefazione della
politica e del messaggio auspica una comunicazione attendibile, coerente, più
carica di tensioni ideali. Assumendo il pensiero di Marx afferma che il comune
bisogno degli uomini è quello di fare circolare le idee liberamente. Soltanto su
principi di trasparenza comunicativa e solidarietà condivise, di possibilità di
creare nuovi giochi e nuove regole che si può innovare la democrazia politica
che è anche democrazia delle emozioni (Giddens).
98
Si sa che l’ultima opera cui Kant si dedica, nota come Opus postumum, è
anche quella di più difficile lettura, di più difficile decifrazione. Kant è indebolito dagli anni, scrive su grandi fogli affrontando volta per volta un dato argomento, riempiendo via via i margini rimasti liberi di note, integrazioni, rapide
trattazioni di argomenti connessi, e tentando così di dominare, con un espediente grafico, il proliferare di quelle ramificazioni d’idee che la memoria non
gli consente più di governare altrimenti.
Se il tema dell’opera –il Passaggio dai principi metafisici della scienza della
natura alla fisica, così doveva suonare il titolo– è ben chiaro nelle sue intenzioni, il procedere dei lavori si rivela però un interminabile ricominciare da
capo, ritornare su questioni già affrontate, tentare nuove redazioni: insomma,
un riscrivere idealmente ogni volta da capo, ha notato una volta Vittorio
Mathieu, l’intera opera, giorno per giorno rintracciando e ricreando da zero la
trama del lavoro.
(Qualcosa di simile, anche se per più fortunate ragioni, avviene negli
appunti di Peirce, che annota su grandi fogli ripartiti in settori le proprie riflessioni, esaminandone simultaneamente le implicazioni, diciamo così, transdisciplinari: filosofia, biologia, logica… Chissà che anche questa strategia kantiana di scrittura non meriti infine di essere interrogata anche di per sé, al di là
delle sue motivazioni “biografiche”, per quelli che sono i suoi originali effetti di
senso: un’inedita pratica del “trattato”, cioè, una fuga di fatto dall’idea tradizionale di libro, ma anche di “tema” e di “sviluppo”, dunque di “argomentazione”,
e di “soggetto” filosofico in ogni senso…).
Sta di fatto che tutto congiura ad avvolgere questo lascito estremo della
speculazione kantiana nella nebbia dell’incompiuto. Quasi certamente l’ordine
dei fascicoli di appunti è manomesso rispetto all’originale: come se un giorno,
cadendo, questi si fossero scompaginati e qualcuno ne avesse ricomposto la
sequenza in fretta e furia, senza badare ad alcuna coerenza o fedeltà all’ordine iniziale. Uno dei massimi studiosi di Kant, Erich Adickes, si dedicò ad una
minuziosa datazione dei fogli, basandosi sull’evoluzione delle caratteristiche
morfologiche della grafia, sui diversi tipi di inchiostro usato, sugli indizi interni
al testo (spesso intessuto, come le paperoles su cui Marcel Proust scriveva
negli ultimi anni, di brani di conversazioni quotidiane, di indicazioni pratiche
banali e insieme enigmatiche, se non, a volte, di inserti sconcertanti…).
L’edizione integrale del manoscritto fu portata a termine da Artur Buchenau
e Gerhard Lehmann tra il 1936 e il 1938, nei volumi XXI e XXII della sterminata Akademie Ausgabe di Berlino: un totale di mille e quattrocento pagine
circa per un’opera che, a redazione ultimata, avrebbe potuto constare forse di
cento, centocinquanta pagine in tutto. Eppure, nonostante quest’edizione,
nonostante quella sorta di Kant-renaissance inaugurata da Heidegger nel
1929 sulle ceneri del neokantismo, con il suo Kant e il problema della metafisica, e nonostante i successivi settant’anni di interrogazioni su Kant –anche
sul Kant degli ultimi anni– siamo lontani, sembra, dall’avere fatto chiarezza
RECENSIONI
AA.VV., Années 1796-1803. Kant, Opus postumum, sous la direction de I.
Schüssler, Vrin, Paris 2001, pp. 256.
99
100
sull’Opus postumum, e dall’averne colte appieno le potenzialità teoretiche
oltre che le caratteristiche storiche. Se si dovesse dire univocamente per quali
ragioni Kant stesso vedesse in questo suo ultimo lavoro il coronamento dell’intero sistema e la conferma definitiva della tenuta e della fecondità del criticismo, ci si troverebbe verosimilmente in qualche imbarazzo.
Perciò è quanto mai opportuna la recente pubblicazione di questo volume
di studi, che raccoglie i contributi di più studiosi e che da più punti di vista
affronta l’Opus kantiano, mettendone a fuoco scorci, linee tematiche, aperture
prospettiche. Volume che si intitola Années 1796-1803, e che esce a cura di
Ingeborg Schüssler (che si occupa anche di idealismo tedesco e di fenomenologia, e che insegna all’università di Losanna) proseguendo la bella serie di
atti dei congressi da una decina d’anni a questa parte dedicati dalla “Société
d’études kantiens de langue française”, ogni due anni, al pensatore di
Königsberg.
Come sempre accade, nel caso di libri tanto ricchi e compositi, è difficile
dire, nel breve spazio di una recensione, qualcosa di significativo rispetto a
tutta la varietà di posizioni e preoccupazioni presenti. Più utile, allora, il tentativo di tracciare nelle sue grandi linee il panorama entro cui situare e valutarne l’oggetto comune, segnalando almeno qualcuna delle linee di fondo lungo
le quali un discorso sull’Opus postumum –magari un discorso non solo storiografico, non solo filologico– dovrebbe oggi organizzarsi.
Vediamone qualcuna: i rapporti con il precedente tentativo kantiano di un
confronto tra filosofia critica e scienze della natura, i Primi principi metafisici
della scienza della natura del 1786; poi, i legami col tronco originario della
Critica della ragion pura, di cui quest’opera doveva essere, in qualche modo,
il compimento e l’approfondimento. Ancora, il confronto di Kant con le scienze
del Settecento (ne scrivono F.Capeillères e S. Marcucci): con la questione
della “forza” e della “materia”, da una parte, e, dall’altra, con la questione dell’organismo vivente, rimasta aperta con la Critica del giudizio e qui rilanciata
con audacia in direzione di quelli che saranno i grandi temi romantici, sia filosofici sia scientifici, della natura e del “senso” che in essa vi è deposto. Poi, le
tensioni con il criticismo delle opere maggiori (C. Piché, F. Marty), qui spesso
arrischiato in direzione di soluzioni apparentemente lontane dall’originario progetto trascendentalista (un idealismo incombente –Fichte o Schelling, su cui
scrive F. Duque– e un realismo e materialismo non meno netti e perentori). E
le prospettive sui temi dell’etica e della religione (su cui intervengono, rispettivamente, S. Goyard-Fabre, Z. Kuderowicz, e J. Castaing, L. Langlois tra gli
altri). Infine, le aperture dell’ultimo Kant al progetto di una vera e propria fenomenologia dell’esperienza, dello spazio, del tempo, del corpo: estrema riformulazione ed approfondimento della grande, forse unica questione kantiana,
quella del trascendentale (se ne occupano Guerrero Jiménez, PentzopoulouValalas, H.Wickmann).
Proprio da qui, allora, conviene prendere le mosse per tentare di situare
queste pagine incompiute, sia rispetto a Kant sia rispetto a noi, sia rispetto a
ciò che in esse si compie, sia rispetto a ciò che rimane, a chi si occupi di Kant
e della sua eredità, come compito speculativo a venire. È merito di Fernando
Federico Leoni
J.-B. BOTUL, La vita sessuale di Immanuel Kant, a c. di F. Pagès, Ombre corte,
Verona 2001, pp. 94.
Questo piccolo libro sarebbe piaciuto a Foucault. Si intitola La vita sessuale di Immanuel Kant e raccoglie cinque conferenze di Jean-Baptiste Botul –un
erudito eccentrico e farraginoso, acuto e inaffidabile, vissuto nella prima metà
RECENSIONI
Guerrero Jiménez mostrare con molta chiarezza e perspicuità, in queste
pagine, come la domanda fondamentale a partire da cui Kant scrive l’ Opus
postumum sia, ancora una volta, quella che inaugura e governa tutta la strategia del criticismo, quella che, ancora nello scritto sui Progressi della metafisica, si riaffaccia alla mente di Kant come la questione centrale, come la
sola questione della sua filosofia: come è possibile l’esperienza? A partire da
che un soggetto e un oggetto si pongono in relazione? Su che base mi è dato
un mondo e io sono dato a un mondo? E come accade che il modo di questo
reciproco darsi, mio e del mondo, sia quello della verità e poi, per citare i trascendentali medievali, quello del bene (seconda Critica), e quello del bello
(terza Critica)?
È nota la risposta della prima Critica: c’è esperienza perché c’è intuizione
e c’è categoria, perché c’è sensibile e c’è soprasensibile, e perché c’è un termine medio grazie al quale questa eterogeneità, questo vuoto enigmatico
viene sempre di nuovo colmato. Termine medio che Kant identifica nella facoltà dell’immaginazione, nello schematismo, nel tempo. Eppure, ragiona Kant
nell’Opus postumum, se non si riprendesse da capo a fondo l’intera questione
rimarrebbe pur sempre, così si esprime letteralmente, “una lacuna nel criticismo”. Rimarrebbe, nota Guerrero Jiménez, una lacuna che è quella sempre
incombente, appunto, tra empiria e concetto, tra oggetto e soggetto, tra particolare e universale. La verità risulterebbe, insomma, sempre mancata per un
soffio. La verità dell’esperienza scientifica, ma, anche, con essa e a monte di
essa, la possibilità dell’esperienza tout court, e, per dire così, la sua verità non
logica ma fenomenologica, e, in ultimo, estetica.
Di qui l’inquietudine di Kant. Se intuizione e categoria, sensibile e soprasensibile racchiudono la possibilità dell’esperienza, dove rintracciare la possibilità di questa possibilità, cioè la possibilità che si diano appunto intuizione e
categoria, sensibile e soprasensibile? Dove cercare, cioè, la radice di questa
possibilità –o di questa originarietà, di questo luogo originario dell’esperienza–
di secondo grado? È per questa via che la domanda della prima Critica si trasforma in quella della terza Critica (Schiller se ne ricorderà bene, e con lui i
romantici). E, più tardi, nella domanda dell’Opus postumum. Dal cui cono di
luce o di ombra, chissà, potremmo non essere ancora usciti, con tutta la nostra
fenomenologia, e con tutta la nostra decennale decostruzione e ricostruzione
della fenomenologia.
101
102
nel Novecento– intorno ai più riposti recessi della vita e delle opere del maestro di Königsberg. Della vita e delle opere, dico, perché Botul tenta appunto
di collocare la propria indagine a cavallo tra le due dimensioni, biografia e pensiero, mostrando come l’una rimanga, in Kant, inintelligibile senza l’altra. “Per
me –scrive appunto Botul– il kantismo è un modo di vita prima di essere una
dottrina. Un insieme di gesti e di posture più che una collezione di testi e un
sistema di concetti. Pensare significa condurre una vita da pensatore. Una
parola esprime questa definizione: ascesi, che nel senso antico non significa
mortificazione ma addestramento, esercizio, regola di vita.”
È un Kant minore, quello che Botul indaga in queste pagine. È il Kant dei
suoi biografi, il Kant degli aneddoti, delle giornate e delle passeggiate condotte con ossessiva regolarità nella natia Königsberg, il Kant dell’ipocondria e dell’instancabile meticolosità con cui una salute malferma, un corpo fragile, un’attività infaticabile vengono sottoposti ad un regime implacabile di cautele, cure,
stratagemmi. “Kant è molto attento a regolare la respirazione, l’andatura, la
traspirazione. Niente a che vedere con la passeggiata di Rousseau, occasione di fantasticheria, esperienza fondatrice, ritorno verso l’io profondo, lontano
dalla società e dalla città. Per Kant il camminare è un esercizio di recupero
delle energie mentali.”
È, questo, il Kant raramente autobiografico delle lettere, ma anche il Kant
del Conflitto delle facoltà, che, più scopertamente che mai, parla di sé, e di
come si sia via via addestrato a scrutare e governare qualcosa di perennemente incline all’ingovernabile, alla dissolutezza e alla dissoluzione, la carne.
Pare di leggere L’uso dei piaceri o La cura di sé, Foucault commentatore di
Seneca o di Galeno. Invece è Jean-Baptiste Botul, commentatore di Kant:
“Bisogna conservare i propri liquidi. Bisogna trattenersi. Ogni goccia dei nostri
preziosi umori è parte della nostra forza vitale. Ogni scarico è dispersione d’energia. Il kantismo è questa utopia della carne: vivere in un circuito chiuso,
limitare gli scambi allo stretto indispensabile.”
Molto prima di Foucault, cosa curiosa, molto prima del Kant avec Sade di
Lacan, molto prima di tutti i tentativi odierni di scrivere un testo il cui titolo
dovrebbe essere, grosso modo, Kant avec Sacher-Masoch, ecco che Botul
riflette, divaga, congettura, ipotizza: “a meno che la crudeltà kantiana verso di
sé, quell’amore torbido per il dovere che ci si impone e che fa male, non conduca l’‘elegante Magister’ verso qualche pauroso incontro clandestino in cui
schiocca la frusta e scorre il sangue. A meno che l’uomo non sia semplicemente un dandy. Le sue manie, la cura che mette nell’osservarle, l’originalità
assoluta, la stilizzazione dell’esistenza, ecco alla fine del XVIII secolo una
geniale premonizione di Brummel e di Baudelaire”.
Un Kant minore, questo. Ma anche un Kant maggiore. L’audacia di Botul
–la sua spericolata sensibilità di lettore– si spinge, in un paio di affondi almeno, dai margini al cuore del sistema kantiano. È il caso della sua lettura del
sublime e della cosa in sé.
Il sublime –questo tremito trascendentale che squassa il soggetto al
cospetto di potenze che lo sovrastano, conducendolo al limite tra dolore e piacere, tra impotenza dell’immaginazione e trionfo metafisico della ragione– non
RECENSIONI
è altro, suggerisce Botul, che una trattazione filosofica sotto mentite spoglie
(rocce acuminate, oceani in tempesta, terremoti) di quell’esperienza che i francesi chiamano petite mort: l’orgasmo. “La tempesta è una promessa di piccola morte”, scrive infatti Botul, e “tra i suoi tanti nomi” il sublime dev’essere
nominato, propone, con “il suo nome più difficile: l’osceno, che appartiene
all’ordine del sacro e dell’orribile”; perciò esso “si oppone al bello non come
l’essere all’apparire”, nota ancora Botul, “ma come lo scomparire all’apparire.”
Più di Kant, approverebbe Edmund Burke. Quanto alla kantiana cosa in sé,
scrive con incantevole sfrontatezza il nostro: “la cosa in sé, naturalmente, è il
sesso.” Aggiunge: “È evidente. Non possiamo conoscere la cosa in sé, ci
avverte Kant. Non ne siamo capaci, ma soprattutto non ne siamo autorizzati.
In questa storia c’entrano la morale e il desiderio”. E ancora: “Curiosa teoria
della conoscenza! Come se la scienza avesse a che fare con ‘cose’, con
oggetti permanenti e stabili. La scienza moderna studia non cose isolate ma
relazioni, flussi, campi e sistemi. Nel noumeno kantiano c’è un sorprendente
feticismo della cosa.” Infine chiede Botul: “Questo velo gettato sulla Cosa non
è forse il culmine dell’erotismo? Kant ci fa intravedere la verità in un gioco che
Nietzsche ha riassunto brillantemente: ‘Non crediamo più che la verità resti
ancora verità, se le si tolgono i veli di dosso’”.
Sono tempi duri per ogni interpretazione che tenti di cogliere, si diceva poco
fa, la biografia a partire dall’opera e l’opera a partire dalla biografia, ed è per di
più difficile negare quanto poco interessante sia, dopotutto, indagare sui rapporti che Kant intratteneva con la cosa in sé nel senso di Botul. Un ampio dibattito neppure troppo recente –sulla morte dell’autore, sull’anonimato di ogni pratica filosofica, sull’impersonalità di ogni gesto di scrittura– ci ha reso cauti e
sospettosi, e già Benedetto Croce, senza scomodare Barthes o Derrida, suggeriva che la vita di un autore è l’opera, e che tanto basta e deve bastare.
E tuttavia. Tuttavia, che accadrebbe se si pensasse sia l’opera sia la vita
al di fuori di una nozione soggettivistica dell’opera e della vita? Perché è forse
questo ciò che Botul tenta di fare, sperimentando quello che, almeno di quando in quando, potrebbe diventare un buon uso del pettegolezzo. Il criticismo
si rivelerebbe, in questa luce, anche come una specie di esperimento (anche
Kant parla della vita del filosofo, e della propria vita, in particolare, come di
“un esperimento fatto con se stessi”, ed è un peccato che Botul non citi questo passo, illuminante, del Conflitto delle facoltà). Il criticismo si rivelerebbe
una lunga, tormentosa autobiografia del soggetto trascendentale, e un interminabile esercizio di formazione ed autoformazione alla verità, una lunga
educazione logica oltre che sentimentale. Conterebbero così tanto l’autore
che scrive (la sua biografia), tanto ciò che l’autore scrive (la sua opera), tanto
l’autore che viene scritto, come Montaigne una volta ha detto nei Saggi, dalla
scrittura stessa che egli va scrivendo (la sua vita e opere non soggettivistica,
la preistoria comune all’una e all’altra, e dunque costantemente elusa e dall’una e dall’altra.
Nessuna di queste tre carte, suggerisce Botul, risulta mai intelligibile al di
fuori del gioco che le scambia di continuo sotto i nostri occhi. Forse non ha
torto, in questo caso almeno.
103
104
Per finire, qualche notizia, per dire così, filologica su questo libretto.
Pochissimo si sa di Jean-Baptiste Botul, francese, nato nel 1896, morto nel
1947, amante di Marie Bonaparte, corrispondente di Lou-Andreas Salomé,
amico di André Malraux, “filosofo di tradizione orale”. Così recita, difatti, la definizione del curatore francese del libro, Fréderic Pagès, autore a sua volta di un
libro dedicato a René Descartes e alle sue abitudini di tossicomane in
Amsterdam, e frequentatore (Pagès, non Descartes) della “Association des
amis de J.-B. Botul”. Per inciso, presso l’Association risulta siano conservati i
pochi scritti superstiti del nostro, tra cui ben due redazioni –la più antica delle
quali sarebbe nota come “argentina”, o Ur-Botul– delle conferenze kantiane. Le
quali, pronunciate nel 1937 in Paraguay, ebbero per uditorio, pare, un gruppo di
emigrati tedeschi installatisi proprio in quegli anni in una cittadina ribattezzata
“Nuova Königsberg”. E proprio alla moglie di un illustre abitante di Nuova
Königsberg –tale dottor Borowski: un nome più che familiare ai conoscitori di
Kant– si deve la trascrizione della versione delle conferenze effettivamente pronunciata in pubblico, detta perciò, ci informa Pagès, “paraguaiana”.
Difficile resistere, insomma, alla sensazione di un coltissimo, ironico gioco
delle tre carte, per l’appunto, fitto di citazioni e di autentici colpi di genio, di
strizzate d’occhio ai cultori kantiani, di grossolane imprecisioni e astute trappole. Basti pensare alla notazione, lasciata cadere con magnifica nonchalance, secondo cui “le donne di oggi” –1937– dimostrerebbero “nei confronti dell’elettricità” una paura simile a quella che il sublime induce sotto forma di petite mort. Frase difficile a concepirsi per qualsiasi uomo nato dopo il milleottocentottanta. Eppure, quante altre frasi in questo libretto –compresa quella
magnificamente foucaultiana: il “kantismo” sarebbe una “postura”, una forma
di “stilizzazione dell’esistenza”– difficili a concepirsi per qualsiasi uomo morto
come Botul nel millenovecentoquarantasette.
Tra questi due termini temporali sembra aprirsi lo spazio ironico in cui è
solito prosperare il genio dei falsari, peraltro più veraci e interessanti, a volte,
di tanti documentatissimi studiosi storiograficamente impeccabili. Che sia il
nostro caso? Oltre che a Foucault, questo piccolo libro sarebbe forse piaciuto
a quel gran maestro dell’inganno e della vertigine metafisica che è stato Jorge
Luis Borges.
Federico Leoni
PIETRO ADDANTE, La centralità della persona in Antonio Rosmini, Filosofia Etica
Politica Diritto, SPES, Milazzo 2000, pp. 270.
Pietro Addante, già noto nel campo degli studi su A. Rosmini, cone questa
nuova opera offre al mondo culturale un’analisi ampia e profonda del pensiero del Roveretano sulla persona umana. La ricerca si svolge su tutte le opere
sosminiane, dal Nuovo Saggio sull’origine delle Idee alla Teosofia, pubblicata
postuma, e porta alla luce tutte le dimensioni della persona umana, dalla costi-
RECENSIONI
tuzione fisiologica, che Rosmini analizzò con competenze scientifica nella
Psicologia, in quattro volumi, all’antropologia generale, all’agire morale, al
diritto, alla politica, alla sociologia metafisica, alla religione e al soprannaturale (Antropologia soprannaturale).
Come il sistema filosofico-teologico di Rosmini è il più poderoso del pensiero cattolico nei tempi moderni, così la persona umana, che ne costituisce
“la perla”, dal Roveretano è stata analizzata nella maniera più sistematica, da
costituire a tutt’oggi un quadro di riferimento per tutti i problemi che si agitano
nella nostra travagliata epoca.
Il grande merito di Addante consiste specialmente nell’aver penetrato le
profondità del pensiero rosminiano della persona umana e nell’averle portate
alla luce in una trattazione sistematica, precisa e rigorosa, in modo che gli studiosi, e quanti vogliano conoscere “ciò che è l’uomo” per Rosmini, possono
avere in quest’opera il quadro completo e adeguato.
Ciò è stato possibile all’Addante perché egli, a parte la modestia, la semplicità, la riservatezza che lo caratterizzano, può essere considerato uno dei
maggiori rosministi, tanti sono i saggi e gli argomenti da lui svolti da renderlo
padrone di un tesoro dottrinale incomparabile quale il pensiero di Rosmini.
L’opera di Addante cade quanto mai opportuna nell’attuale momento culturale di “pensiero malato”, come egli, in sintonia con Rosmini, si esprime, perché, crollati tutti i “grandi sistemi del passato”, l’umanità si trova di fronte a un
“vuoto culturale” tra i più tragici della storia, in quanto gli attuali “epigoni” del
razionalismo e del positivismo si accaniscono nello smantellare “le costruzioni onnirisolutive” dei loro antenati, ma non sanno sostituire ad esse elementi
validi e costruttivi, sicché “si agitano nel vuoto”, carenti di principi etici, giuridici, politici, sociali, scientifici (si veda a che cosa è stata ridotta la natura dai vari
Adorno, Putnam, Kuhn, Lyotard,…).
L’ombra del nichilismo “soggiace al pensiero laicista attuale, con le tenebre
più fitte per i destini dell’umanità, ancora sommersa nelle conseguenze spirituali delle due grandi guerre, provocate da quella cultura laicista”, irrazionalistica, anticristiana e antistorica, che aveva appunto condotto a una concezione dell’uomo “mero strumento della politica di potenza” a servizio del “dominio” di autoproclamarsi “superuomini”.
L’uomo, privato della sua dimensione religiosa, metafisica, morale, civile,
fatto oggetto degli assalti concentrici secolari delle più diverse e contrastanti
ideologie pseudofilosofiche, nei campi di sterminio ebbe a subire le estreme
conseguenze di una cultura che lo aveva privato di ogni valore.
Ben vengano perciò questi studi che ridanno all’uomo dignità e grandezza,
che ne evidenziano le eccelse facoltà, che ne rievocano le meravigliose attività, che ne tracciano gli alti ideali, che ne indicano il fine supremo e l’itinerario
aspro e doloroso, ma anche consolante ed esaltante per conseguirlo.
Rosmini, grande metafisico, altissimo teologo, mistico profondo, ma anche
mente versatissima nelle scienze, maestro di diritto, esperto di economia, fine
diplomatico, sociologo premuroso del bene delle persone singole e dei popoli,
ha tessuto su ciascuno di questi aspetti della persona umana un sistema di dottrine, di principi, di fenomenologia, oggettivo, razionale, inequivocabile. Addante,
105
106
nei nove capitoli in cui l’opera si dispiega, ci presenta con analisi chiare, rigorosamente filosofiche, profonde, le articolazioni dell’antropologia rosminiana e le
scolpisce con viva partecipazione ed eloquente apologetica. Non possiamo
neanche sommariamente entrare nell’analisi dei singoli argomenti di carattere
metafisico e religioso, morale e giuridico, psicologico e fisiologico riguardanti la
persona umana esposti da Addante, che ci danno il quadro completo dell’uomo
sotto tutte le dimensioni nella prospettiva di Rosmini; ci limitiamo a due temi di
più larga risonanza e densi di insegnamenti illuminanti per l’attuale situazione
politica dell’umanità. Temi poco conosciuti dal “grande pubblico” e non trattati da
molti ermeneuti rosministi, la cui conoscenza però avrebbe potuto imprimere alla
politica italiana risorgimentale e post un più sano orientamento e, penetrando
adeguatamente nella cultura europea dell’Ottocento e del primo Novecento,
avrebbero potuto evitare gli immani flagelli delle due guerre mondiali.
I due argomenti che vogliamo puntualizzare, tra i tanti che costellano la dottrina della persona umana in Rosmini, e che Addante ha messo in rilievo in
quest’opera sono: 1. L’organizzazione democratica della società civile; 2. la
costruzione dell’ordine internazionale con la “federazione” degli Stati
dell’Europa, e gradualmente giungere a una “società universale” mediante “la
federazione di tutti gli Stati”, fondati sui diritti umani.
Rosmini infatti, scendendo a fondo nei singoli problemi, li inquadra nel suo
sistema poderoso, che collega con saldi e irrefutabili principi, fisica e metafisica, Natura e Spirito, uomo singolo e umanità. E come della natura egli ha
messo in luce la divina grandezza, le mirabili perfezioni in quell’opera impareggiabile del Divino nella natura, così dell’uomo prospetta le inconciliabili
potenzialità nella costruzione del mondo storico, dotato, come egli è, della
ragione e della libertà.
È questa “scintilla divina”, “il lume della ragione”, “l’idea dell’essere universale”, questo abisso senza fondo della nostra anima che costituisce il fondamento della “persona umana”, impreziosita dal potere della libertà, che ci
rende tutti indipendenti e solo dipendenti da Dio, che, magnifico donatore, mai
ci coarta, ma vuole solo la libera realizzazione del nostro vero essere.
La persona umana, dal valore incommensurabile perché partecipe del divino, mai asservibile, strumentalizzabile, deificabile perché spirito libero, è elevata a fondamento della Società, dello Stato, del diritto in tutte le sue esplicazioni, istituzioni, realizzazioni.
Rosmini, vissuto nel periodo di formazione del moderno costituzionalismo,
osservatore acuto delle complesse vicende della Rivoluzione francese, esule
dalla Patria di origine per difendere la libertà di pensiero, erede della tradizione millenaria cristiana dei diritti umani, profeta precoce degli opposti errori del
liberalismo agnostico e individualista e della oppressione schiavista del comunismo (oltre alla su Filosofia della politica, si vedano gli Opuscoli politici, tra i
quali: Il Comunismo e il Socialismo, del 1847, un anno prima del Manifesto del
Comunismo di Marx), gettava le fondamenta per una “democrazia integrale”.
A lui mal si addice il comune attributo di “cattolico liberale”; vedi ad hoc “la
messa a punto” del compianto C. Riva in Attualità di Rosmini, spesso riportata da Addante nella sua opera.
RECENSIONI
La “democrazia” che Rosmini teorizzava, propugnava, auspicava, non era
quella “limitata e astratta” della Dichiarazione dei diritti del 1789, ma la democrazia della persona umana nella sua integralità, cioè promotrice e garante di
tutte le dimensioni dell’uomo, di tutti i diritti della persona, che è portatrice dei
diritti (Filosofia del diritto). Rosmini non concepiva la democrazia come “istituzione politica”, come “centro sociale storico”, quale ancora oggi qualche famoso giurista si ostina a definirla, ma la vedeva nel suo fondamento metafisico e
teologico; in quell’“Ordo aeternus” di agostiniana memoria, stabilito da Dio
nella creazione dell’uomo, che “l’umana ragione”, per il potere che ha di scoprire la verità, riconosce e scolpisce nello “Statuto ontologico dell’uomo”, sacro
e inviolabile, saldo e forte nel suo valore più del granito e dell’acciaio, perché
fondato nella “immutabile verità”.
La democrazia per Rosmini è parte integrante della sua Teologia che ha
parlato di Dio come Trinità, di Essere ideale, reale e morale (siamo nella
Teologia razionale, non ancora in quella rivelata), da cui scaturisce che i rapporti tra gli uomini e la democrazia devono essere storica situazione delle leggi
morali nella società. Democrazia è perciò conoscenza dell’uomo, studio, indagine, ricerca dell’essere dell’uomo, delle sue molteplici dimensioni, che devono essere codificate, consacrate, garantite nelle istituzioni giuridiche.
La Società, che è l’organizzazione razionale delle “persone umane”, ha
questo alto fondamento etico e ontologico, e il sistema dei diritti, che garantisce e promuove, non si risolve nel codice del lecito e dell’illecito esteriormente recepibili e perseguibili, ma ingloba anche questa estrema propaggine dell’agire umano, il diritto, nell’essere morale, da cui, pur nella sua autonomia e
necessaria specificità, scaturisce e promana.
Studioso della storia, sin dalle antichissime civiltà nell’opera Del divino
nella natura, abbiamo saggi stupendi in questo campo, sin dagli antichissimi
Veda, che egli conosce in traduzione inglese e che ha interpretato con esattezza ineccepibile, studioso delle tante Costituzioni, del diritto comparato, di
Vico e di Agostino, vedeva il cammino della storia, pur nella sua sinuosità,
negli arresti, “salti bruschi” in moto verso il progresso, ma non nell’ottimismo
illuministico o naturalistico, ma sotto lo sguardo della Provvidenza, che ispira
e richiama le coscienze nel loro cammino. Nella fiducia dello spirito umano,
che è per se stesso ricerca, attuazione, sviluppo dei valori, egli vedeva la storia, come già Vico e Agostino, in cammino verso i diritti umani, in cammino
verso la giustizia.
Uomo di azione qual era, oltre che studioso instancabile, Rosmini operava
perché gli ideali di giustizia e di libertà si realizzassero. Prese parte attiva perciò al “movimento risorgimentale”, e nella concreta situazione storica e politica del tempo proponeva l’unità nazionale sotto la forma di “federazione” (niente affatto “separatistica” –si noti bene–), che salvaguardasse “le individualità”
storiche, culturali, tradizionali dei vari Statarelli, ma li unisse in un organismo
giuridico, politico, militare (Rosmini si fa anche sostenitore delle “forze armate” per la difesa contro ingiusti aggressori). Ma la statura eccelsa di questo
pensatore si misura dalle sue idee politiche “di largo raggio”. In un’Italia divisa
da secoli in tanti “principati”, come si potrebbe chiamare realisticamente; in
107
un’Europa vissuta per secoli in guerre fratricide e di proporzioni sempre più
ampie; in un mondo costituito da Continenti lontani ed eterogenei e di popolazioni nella stragrande maggioranza ancora primitive e arretrate, egli, quasi
“pensatore dei nostri giorni”, propugnava “la defecazione europea sulla base
della grande tradizione cristiana”, e auspicava una “federazione di tutti i popoli della Terra” sulla base dei diritti umani.
Il pensiero politico-giuridico di Rosmini nella prima metà del secolo XIX
ebbe grande diffusione e seguito, ma si arrestò per le vicende dei suoi scritti
in tutta la seconda metà del secolo, con grave danno della cultura cattolica,
che avrebbe avuto in lui una “guida maestra”.
Il personalismo ne ha segnato una ripresa negli anni trenta di questo secolo e nel secondo dopoguerra si è imposto anche politicamente in vari Stati
dell’Europa (si veda in particolare il c.7, pp. 151-190). I grandi studiosi di
Rosmini: La Pira, Capograssi, Campanini, Riva, documentano l’influsso del
personalismo di Rosmini nella Costituzione italiana del 1948. Ma un più largo
influsso esso ha esercitato nella “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo” e
nella “Dichiarazione dei diritti dell’ONU”.
Addante, riportando la documentazione di illustri studiosi, dimostra il vastissimo influsso del pensiero giuridico-politico del Roveretano nella cultura attuale e
dà insieme testimonianza della sua instancabile dedizione allo studio di Rosmini,
illustrando questo aspetto originalissimo e attuale del nostro pensatore.
108
Ambrogio Giacomo Manno
CH. MORRIS, L’io aperto. Semiotica del soggetto e delle sue metamorfosi, trad.
it. e cura di S. Petrilli, Edizioni B.A. Graphis, Bari 2002, pp. XXVII, 172.
Quando nel 1948 Charles Morris (1901-1979) pubblicava questo libro l’umanità era appena uscita dalla Seconda Guerra mondiale e si apprestava ad
entrare nella Guerra Fredda, avendo già sperimentato la potenza apocalittica
dell’arma nucleare. È da questa situazione che Morris guarda alla società e
all’io statunitensi, criticandone ed evidenziandone la tendenza alla chiusura e
il temperamento dominatore. Ne parlava con cognizione di causa, essendo
stato impegnato per alcuni anni, sponsorizzato dalla Fondazione Rockefeller,
in uno studio sui tratti del carattere americano. Nel 1948, inoltre, lavorava a
una sintesi di psicologia, religione e filosofia della vita, ed era condirettore,
insieme a Carnap e Neurath, dell’Enciclopedia internazionale della scienza
unificata. Cercare l’unità delle diversità: un progetto che egli persegue attraverso la prospettiva semiotica, di cui si serve, in epistemologia, per staccarsi
dall’unificazione omologante del fisicalismo neopositivistico che vigeva ancora all’interno dell’Enciclopedia, nella scienza dell’uomo, pensando ad un “io
aperto”, e nella scienza sociale, pensando a una “società aperta”.
Chiamare ‘semiotico’ l’approccio di Morris vuol dire qualificarlo come pensiero neoilluminista, relazionista e razionalista, antiassolutista e antiriduzionista.
RECENSIONI
Morris critica l’io americano attingendo (ci tiene a precisarlo) alla filosofia di
pensatori americani come Peirce, James, Mead (suo maestro diretto), Dewey
(v. p. 148), dai quali proviene una filosofia che si sviluppa “in diretta relazione
con i risultati e metodi della scienza”, che egli sceglie di chiamare “relativismo
oggettivo”. Secondo questa filosofia non c’è nessuna prospettiva assoluta,
onnicomprensiva. “Ciò che è sostanziale non sta in isolamento ma nel perdurare attraverso interazioni diverse. Sia noi, sia la società, sia il mondo siamo
modelli perduranti della diversità”. Esempio: che cos’è il carbone? Materia
nera, come risulta all’occhio o in fotografia; materia che si spacca; materia che
pesa un tanto per unità di volume; materia che brucia. “Nerezza, frangibilità,
peso, infiammabilità –queste sono proprietà oggettive (appartengono all’oggetto carbone), eppure sono proprietà del carbone solo in determinate relazioni, contesti, prospettive. Quindi si tratta di proprietà oggettivamente relative” (pp. 120-121).
Il relativismo oggettivo ci evita le trappole dell’ipergeneralizzazione; esso è
“relazionismo” ed è fondato sul sapere critico della scienza. “Il relativismo in
fisica ci ha costretti a rivolgere la nostra attenzione alle circostanze sotto le
quali un oggetto fisico ha una data velocità, o una data massa, o un dato movimento; il relativismo nelle scienze sociali ci ha costretti a collegare una tale
caratteristica della vita sociale con l’intera costellazione di tratti culturali in cui
appare; il relativismo psicologico ci sta costringendo a collegare l’azione di un
individuo non solo con la società e il suo ambiente ma anche con i suoi particolari tratti biologici e del temperamento” (p. 122).
È questa epistemologia delle relazioni che fa dire a Morris che l’io umano
è “bio-sociale” e che “ha bisogno di tutte le sue pulsioni, di tutti i suoi conflitti
e di tutti i suoi piaceri” (p. 17). È questa epistemologia che sottende una scienza dell’uomo che smette di cospirare contro il corpo. È questa epistemologia
alla base dell’“io aperto” e della “società aperta”.
L’uomo è “il costruttore di sé, l’artefice che è egli stesso il materiale per la
sua stessa creazione” (p. 7). Egli si trova sempre sulla frontiera della costruzione della vita, della sua autocostruzione. “Mai prima d’ora –scrive Morris– ha
avuto a che fare con i problemi della terra come un tutto così insistentemente
pressante nei suoi confronti. Mai prima d’ora ha avuto così ampi poteri sull’uomo e mai ha tenuto così la natura sotto il suo controllo” (ibidem). Abbiamo
“nuovi mal di testa. Abbiamo bisogno di nuovi io. E di nuove relazioni tra gli io”
(p. 8). Abbiamo bisogno di un io multiplo e flessibile, che sia una comunità di
differenze non indifferenti: lo stesso tipo di relazione di cui si ha bisogno fra gli
io. C’è bisogno di allargare la comunità dell’io: “Siamo egoisti non perché
abbiamo troppo ego ma perché non abbiamo abbastanza ego. […] Diventiamo
non possessivi non restringendosi ma allargandoci” (p. 23). Contro questo progetto di umiltà dell’io, che è un progetto di responsabilità, si leva l’alibi dell’irrazionalismo, del determinismo e del peccato: “le maschere preferite della
nostra irresponsabilità”, scrive Morris (p. 14).
Quello dell’io aperto e della società aperta è un progetto basato sul razionalismo scientifico. “Razionale è una persona […] che esplora il terreno dell’io
e del mondo circostante prima di impegnarsi su come agire o come essere
109
110
d’ora in poi” (ibidem). La scienza, poi, dice ciò che può accadere sotto certe
condizioni e solo così siamo in grado di controllare i nostri atteggiamenti. “È
questo il contributo della scienza alla nostra libertà” (v. pp. 19-20).
In questo progetto assume un ruolo imprescindibile la scienza dei segni,
perché “l’uomo è l’unico a modellarsi mediante i segni da lui stesso prodotti”,
e “per i fini della scienza stessa si rivela necessario aggiungere allo studio dei
corpi, degli ambienti fisici e delle culture uno studio dei segni” (pp. 50, 52). Tale
studio è necessario anche agli individui per capire che cosa fanno con i segni
e che cosa i segni fanno loro fare, in modo da poter agire su se stessi con successo. “Poiché ciò che è singolare nell’essere umano è che il modo in cui agirà
nei confronti di qualcosa dipende in gran parte dal modo in cui lo significa, i
segni sono lo strumento degli strumenti per la costruzione dell’uomo. […] È
questa un’altra ragione per cui lo studio dei segni non è una moda” (p.52).
I segni ci informano (funzione designativa), influenzano le nostre preferenze e credenze (funzione apprezzativa), ci ordinano cosa fare (funzione prescrittiva) (v. p. 54).
“I segni originariamente sono segni di ciò che non è segno. Ma poi nascono
segni di segni, ed anche segni di segni di segni. […] Costantemente facciamo
confusione fra questi livelli, crediamo di parlare di cose e invece parliamo di
segni. […] Il ‘determinismo’ attribuito alla scienza cela frequentemente la stessa confusione: dire che qualcosa ‘deve’ accadere è semplicemente dire che l’affermazione che descrive l’accadere è una conseguenza logica della nostra
attuale conoscenza; il ‘deve’ significa primariamente una relazione tra segni;
come cambia la nostra conoscenza (e competenza) cambia anche il ‘deve’” (pp.
55-56). Bisogna guardarsi dalla “magia segnica” e dalla “confusione segnica”,
per “dominare i segni invece di esserne dominati. Ciò è possibile se li conosciamo” (p. 60). E tuttavia, avverte Morris, ci sono delle trappole semiotiche
“facili da individuare, ma difficili da evitare”. C’è la trappola della ipergeneralizzazione. Generalizzare è facile, seducente, ed è necessario nell’economia del
pensiero, ma pieno di pericoli se si omettono “le condizioni di specificazione”,
se si omette, cioè, di precisare il contesto e il punto di vista a partire dai quali si
generalizza. Ad esempio, come scrive ancora Morris, si dice che “‘il buddismo
è la religione migliore’ –invece di ‘il buddismo è per certe persone entro certe
condizioni storiche e culturali l’alternativa religiosa migliore’” (p. 61).
Altra trappola è quella della comunicazione perfetta: la presunzione secondo cui il fatto che si parli la stessa lingua comporti che ci si intenda completamente. L’errore consiste nel non rendersi conto che “la comunicazione è una
faccenda di grado. […] Non tutti coloro che usano le parole ‘democrazia’,
‘libertà’, ‘liberalismo’, ‘comunismo’, ‘fascismo’, intendono precisamente le
stesso cose con queste parole; e in alcuni casi il comune nucleo di significato
è davvero assai ristretto” (p. 62).
C’è poi la trappola della credulità: “I segni ci dispongono ad agire in certi
modi, e se non stiamo attenti ci manovrano come dei burattini […]. Ma noi
siamo creduloni soprattutto nei confronti delle nostre osservazioni”, afferma
Morris (p. 63), cioè dei nostri stessi segni.
L’uomo –si diceva– si automodella attraverso i suoi segni, perché solo l’uo-
RECENSIONI
mo ha il ‘linguaggio’, la capacità sintattica e inventiva, dirà Thomas A. Sebeok,
allievo di Morris. Questa capacità è condizionata e limitata dalla corporeità, ma
resta pur sempre eccedente. Differenti personalità sono collegate a differenti
corporeità.
Al corpo morbido (o endomorfo), a quello tarchiato (o mesomorfo) e al
corpo esile (o ectomorfo) Morris fa corrispondere, rispettivamente, i tratti temperamentali dominanti della dipendenza, del dominio e del distacco, avvertendo, però, che concretamente ogni personalità presenta quei tratti a gradi diversi (v. pp. 33-36).
L’io è flessibile e multiplo perché è luogo di relazione di materie fisiche,
geografiche, temperamentali, culturali. Quando la flessibilità si blocca ne derivano i disturbi della personalità.
Come gli io individuali anche le società sono aperte o chiuse secondo gradi
e modi diversi; esse sono luoghi di relazione di individui sociali. La società
chiusa è possessiva, inflessibile, bellicosa, efficiente, “ed anche solitamente
ma non sempre totalitaria”; essa nasce dall’ansia, con la promessa di alleviarla, ma vive solo perpetuando le ansie e presentando le altre società come ostili (v. pp. 136-138). La società aperta è società di io aperti; dà dignità alle diversità, usa “il suo notevole potere tecnologico per accrescere la diversità e l’abbondanza” (p. 139). È una società che si autocorregge per garantire le condizioni che sostengono l’individuo creativo. Essa così adopera i metodi della
scienza (v. p. 143).
Il connubio di potere e di ansia, dice Morris, genera forme di possessività.
Questo connubio mette in pericolo l’orientamento verso la società aperta, che
egli ritiene il carattere specifico dell’America. Noi americani, scrive, “Potremmo
replicare a modo nostro le recenti versioni della società totalitaria […], estendendo il nostro potere sul mondo per diventare una Roma moderna odiata e
temuta. […] Per mezzo del controllo dei mezzi di comunicazione di massa lo
status quo verrebbe glorificato e identificato con l’ideale americano. Qualsiasi
deviazione da esso verrebbe respinta come alto tradimento alla libertà e alla
democrazia. […] Ciò accrescerebbe l’ansia, e verrebbero invocate misure
sempre più repressive per mantenere l’ordine. A questo punto si prospetterebbe una guerra con qualche potenza straniera, per acquietare l’opposizione
e per ottenere la lealtà della gente. Attraverso il ricorso ai simboli del nazionalismo, l’individuo sarebbe costretto a identificarsi con il movimento verso la
società chiusa, in caso contrario sarebbe bollato come traditore del popolo.
Sotto la minaccia della moderna guerra totale, il controllo totale della società
diverrebbe inevitabile” (pp. 155-157).
Bisogna guardarsi dalla magia segnica, abbiamo detto, che la semiotica
contribuisce a demistificare. E al riguardo non possiamo tacere le seguenti
parole di Morris: “‘Democrazia’ è diventata una parola fortemente apprezzativa, non chiara dal punto di vista designativo. Classificarsi democratici è ora
tanto insignificante, e tanto inevitabile, quanto per i politici farsi fotografare con
i neonati. Da chi dovrebbe sapere ci è stato detto che quando il fascismo conquisterà l’America lo farà in nome della democrazia. Infatti, qualsiasi cosa si
faccia ora in America –o altrove sulla terra– sarà fatto in nome della democra-
111
zia. Sicché abbiamo bisogno di parlare in modo concreto. […] Se usassimo il
termine ‘democrazia’ in senso designativo sarebbe sinonimo dell’espressione
‘società aperta di io aperti’” (pp. 145-146; cors. ns.).
Parole scritte nel 1948 e che oggi risuonano forse come insopportabilmente critiche, ma parlano ancora di noi.
Cosimo Caputo
É. LÉVINAS, Dall’altro all’io, trad. it. di J. Ponzio, Meltemi, Roma 2002, pp. 160.
112
I saggi qui raccolti, pubblicati tra il 1953 e il 1983 e tradotti per la prima volta
in italiano, ritornano su alcuni temi peculiari della riflessione levinasiana, come
quello del rovesciamento del rapporto di priorità fra l’io e l’altro che dà il titolo
al libro. “Dall’altro all’io, questa è la sequenza nel processo di costituzione dell’io. […] Ciò comporta l’impossibilità dell’indifferenza, della buona coscienza,
della coscienza pacificata nei confronti dell’altro, la paura non dell’altro, ma per
l’altro”, come dice Augusto Ponzio, curatore della raccolta, nella sua
Introduzione (pp. 18-19).
Ma dei temi toccati da Lévinas in questi saggi vogliamo insistere su alcuni
in particolare per la loro estrema attualità e per la loro forza re-interrogante: il
tema della guerra e quello del rapporto fra il giudaismo e la politica dello Stato
di Israele.
Il new world order, che dopo il crollo dell’Unione Sovietica avrebbe portato
stabilità, pace e consenso, fondati sul neoliberismo, si è, al contrario, dimostrato un new war order. E la guerra, che “è la cosa più condivisa al mondo,
fa ripetere all’infinito gli stessi gesti e le stesse idee”, dice Michel Serres in
Chiarimenti (trad. it. Barbieri, Manduria 2001, p. 43). La guerra come scelta
realistica obbligata, garanzia della pace: qualcosa non funziona nel profondo.
Nella prospettiva levinasiana questa sconnessione è la conseguenza del perdurare del rapporto con il realismo politico, con un umanesimo distruttivo dell’alterità; è la conseguenza dell’allergia all’altro, della dedizione all’essere, dell’impossibilità per l’io di poter sfuggire a se stesso.
In Libertà e comandamento, del 1953, uno dei saggi tradotti in Dall’altro
all’io, Lévinas individua una omo-logica tra l’azione sulle cose, il lavoro e la
guerra. “L’azione violenta –scrive– non consiste nel trovarsi in rapporto con
l’Altro […]. L’azione violenta, che appare come azione diretta, come azione
immediata, deve, in realtà, essere considerata come azione che non tocca l’individualità di chi la riceve, che non tocca la sostanza. L’azione sulle cose, il
lavoro, consiste nel trovare il punto di applicazione a partire dal quale l’oggetto, in virtù di leggi generali a cui la sua individualità si riduce interamente, subirà la volontà del lavoratore. […] La violenza applicata all’essere libero è, nel
suo senso più generale, la guerra” (p. 74).
Ma la violenza bellica differisce da quella del lavoro non solo “per una maggiore complessità di forze […], ma anche per un atteggiamento diverso dell’a-
RECENSIONI
gente nei confronti del suo avversario”, la cui libertà è riconosciuta come libertà animale, selvaggia, senza volto. Questa libertà non è data nel volto dell’avversario, “che è una resistenza totale senza essere una forza”, ma è data nella
paura e nel coraggio che la supera. La guerra, la tirannia, il lavoro non guardano in faccia ciò su cui la loro azione si applica. La violenza consiste precisamente nel non abbordare le cose nella loro individualità, bensì a partire dalla
generalità, dall’universale, dalla legge, dal loro concetto (v. pp. 74-75).
La realtà sensibile, pertanto, si offre nella forma della generalità omologante; essa, cioè, non ha un senso a partire da se stessa, ma a partire dalla
sua relazione con questa rappresentazione che si è impadronita del mondo, la
cui realtà è “una realtà in-formata” (p. 76). Si pensi all’odierna comunicazioneproduzione globalizzata. E tuttavia, la relazione diretta non è una relazione
con qualcosa o qualcuno che l’io ha designato e situato, quanto piuttosto una
relazione che pone in contatto “con un essere, non semplicemente svelato,
ma spogliato della sua forma, spogliato delle sue categorie, un essere che
giunge alla nudità, sostanza non qualificata che buca la forma e presenta un
viso” (ibidem). La chiamiamo materia dell’essere o della forma dell’essere:
materia come alterità. ‘Volto’ che ha “un senso non per le sue relazioni, ma a
partire da se stesso, e l’espressione è proprio questo” (ibidem).
Lavoro e guerra sono aspetti centrali di quello che, con W. Benjamin,
Augusto Ponzio chiama il “carattere distruttivo” della forma economico-sociale della nostra epoca. “Il carattere distruttivo lavora” (Benjamin). Il lavoro “coincide con l’identità stessa, ed essere senza lavoro, perderlo, significa smarrire
la propria identità, il proprio ruolo sociale. Si tratta del lavoro che si vende e
che si compra, che risponde ai requisiti del mercato del lavoro, il lavoro quantificabile, generico, indifferenziato, misurabile in ore”, dice Ponzio (p. 33). Quel
lavoro che ha la truce ironia dello slogan nazista Arbeit macht frei (Il lavoro
rende liberi). Nella Germania nazista infatti l’identità generica di lavoratore è
portata all’estremo: Arbeit perde la connotazione di classe, il suo campo
semantico si allarga, “al punto che Arbeiter (lavoratore) s’identifica con Volk, e
la guerra stessa (Arbeiter è anche il soldato) diventa lavoro. […] La guerra
assume il significato di mezzo necessario per produrre la pace, intesa come
Deutscher Frieden, pace teutonica”. Così ancora Ponzio, che più avanti vede
gli effetti odierni della funzione omologante e violenta del lavoro astratto e del
lavoro merce: “Oggi il certificato di lavoro consente in Europa l’ingresso e la
non espulsione dell’‘extracomunitario’ […]. Nella Germania nazista il possesso dell’Arbeitsbescheinigung, certificato di lavoro, di impiego, consentiva agli
ebrei di evitare la deportazione o l’internamento” (pp. 34-35).
Veniamo ora al secondo dei temi da noi scelti fra quelli trattati nei saggi di
Lévinas qui raccolti, quello del rapporto fra giudaismo e politica.
Il nostro interesse si concentra su Laicità e pensiero giudaico, del 1960.
Qui Lévinas si chiede se il giudaismo “può aver conosciuto o soltanto sospettato un concetto come quello di Laicità” (p. 85).
Per il giudaismo il termine ‘teocrazia’ non coincide con il governo dei
sacerdoti, quanto piuttosto con la sottomissione degli uomini all’etica. “La
Torah –scrive Lévinas– non esiste nella forma di un verbo mistico. Essa vive
113
114
nella ricerca dei dottori, dei rabbi, che in ogni epoca la riprendono. Essa esige
un pluralismo e un confronto. L’originalità di ciascuno non compromette la
verità dell’insegnamento, ma gli permette soltanto di manifestarsi. Lo studio
non ripete la Torah, ma la rivela” (p. 86). Rabbi non significa sacerdote.
“L’interpretazione della Torah non è una funzione sacerdotale; i chierici, nel
giudaismo, non sono degli ecclesiastici. Il clericalismo giudaico è laico” (p.
88).
Il giudaismo non porta nel mondo l’orgoglio nazionalistico che avevano i
Greci nella loro contrapposizione ai barbari, la sua novità “consiste nell’affermare le dimensioni planetarie della società umana, l’idea di un accordo possibile tra gli uomini, ottenuto non con la guerra, ma con la fraternità, con la paternità di Noè, di Adamo e, in fin dei conti, di Dio. […] Il monoteismo giudaico,
scoprendo un’umanità fraterna […], scopre una morale eterna; indipendente
dalla politica”, dice Lévinas (pp. 91-92). L’etico precede il sacerdotale e il politico. La persona ha la sua dignità indipendentemente dalla sua adesione alla
religione dello Stato. Lo straniero partecipa alla società al di fuori di ogni obbedienza religiosa. Questa idea trova il suo approfondimento nel concetto talmudico di noahide, di discendente di Noè, membro dell’umanità. “Il razzismo
–avverte Lévinas– è estraneo al giudaismo” (p. 92).
Ma, ancora all’inizio del saggio, Lévinas si chiede se il concetto di laicità
abbia “un equivalente nel pensiero di Israele” (p. 85). E più avanti, sottolineando che l’idea forte del giudaismo “consiste nel trasfigurare l’egocentrismo
o l’egoismo individuale o nazionale in vocazione alla coscienza morale”, dice:
“È in questa prospettiva che si situa per il giudaismo stesso il ruolo proprio
d’Israele, la sua dignità di popolo eletto che è stata così spesso equivocata”
(p. 90). Una questione cruciale, visti soprattutto gli avvenimenti politici e militari seguiti alla creazione dello Stato di Israele.
Il popolo eletto ha un destino etico che lo coinvolge nella storia degli altri
popoli. Ciò diventa spesso senso di superiorità, diritto a privilegi (v. PoiriéLévinas, Entretiens, La Manufacture, Lyon 1987).
È nota la distinzione levinasiana tra il santo e il sacro e l’insistenza sull’alterità del santo rispetto all’idolatria del sacro, che è il tentativo di possedere ciò
che originariamente lo precede ed eccede. La santità della persona è “più
santa di una terra, anche quando la terra è Terra Santa”, scrive in altra occasione Lévinas (cit. in Derrida, Addio a Emmanuel Lévinas, trad. it. Jaca Book,
Milano 1998, p. 60). Sono parole dettate dalla “terrificante memoria del nostro
tempo”, ricorda Derrida, “anche se a Lévinas è accaduto di protestare contro
certi abusi di auto-giustificazionismo ai quali tale memoria e il richiamo dell’olocausto potevano talvolta cedere” (ibidem).
Lévinas non mette in questione l’elezione di Israele, ne richiama, al contrario, il surplus di responsabilità che proviene proprio da questa elezione,
che, inoltre, non significa superiorità e molto spesso impunità, bensì surplus
di obblighi. Il 1948 è la data che richiama la fondazione di uno Stato che “ s’impegna a non essere solo […] uno Stato come gli altri. Ebbene, non approvando né disapprovando il fatto giuridico, Lévinas vede nella fondazione dello
Stato moderno di Israele […] solo un impegno. […E] il tradimento dell’impe-
RECENSIONI
gno resta sempre possibile, così come lo spergiuro, e questo stato può diventare uno Stato come gli altri, anzi a volte o per certi aspetti, direbbero alcuni,
peggiore di molti altri […]. L’impegno dovrebbe portarsi […] ‘al di là’ del politico, al di là di un problema o di una soluzione strettamente ‘politica’” (Derrida,
cit., pp. 145-146).
Attraverso il suo “esigente giudaismo” (Ponzio), con “allusioni discrete
ma trasparenti (utilizziamo ancora parole di Derrida, cit., p. 139), Lévinas
orienta allora i nostri sguardi verso ciò che accade oggi in Israele, come in
Europa e in Francia, in Africa, in Asia, almeno a partire dalla prima guerra
mondiale […]: ovunque rifugiati di ogni specie, immigrati con o senza cittadinanza, esiliati o espulsi, con o senza documenti, dal cuore dell’Europa
nazista alla ex Jugoslavia, dal Medio Oriente al Ruanda, dallo Zaire alla
California, dalla chiesa di St. Bernard al XIII arrondissement di Parigi,
Cambogiani, Armeni, Palestinesi, Algerini e tanti, tanti altri –tutti questi rifugiati esigono un cambiamento dello spazio socio- e geo-politico, cambiamento giuridico-politico, ma innanzitutto […] essi fanno appello ad una conversione etica”.
Cosimo Caputo
’Αρχη’ , III (2000/2001), Lógos e storia, a c. di S. Ciurlia, pp. 304
L’ultimo numero della rivista di filosofia ’Αρχη’ , curato da Sandro Ciurlia, ha
come titolo Lógos e storia.
Il volume attrae l’attenzione per una serie di ragioni. Raccoglie contributi
che, pur nella loro varietà, vogliono essere un modo indiretto di riflessione
sulle tante forme in cui Lógos e storia s’intrecciano. L’approccio al problema
filosofico della storia, infatti, come scrive il curatore nel saggio introduttivo
(L’etere di Zeus e i passi di Hermes: dalla Weltgeschichte alla storia come racconto), è “trasversale”, nel senso che si giunge a determinarlo “senza combinazioni precostituite o riflessioni ulcerate dalle voragini di un bilancio, […]
affrontando la domanda nel concreto esercizio storiografico –e critico– su
varie questioni di ricerca, nel tentativo […] di fare il punto intorno ai risultati
conseguiti in merito ad un dato problema e di focalizzare l’attenzione sui nodi
aporetici con i quali resta ancora da confrontarsi. Ora e dopo. Nell’eternità
della ricerca critica” (pp. 17-8).
Sempre nella lunga introduzione, Ciurlia, nel definire i termini della questione della storia, si chiede e ci chiede se, in un’era dominata da tendenze
globalizzanti, ci si può ancora interrogare “sul significato della storia”, e se
“esiste ancora un concetto che possa definirsi storia ed una domanda che si
ponga il problema del suo quid est” (p.17). Egli ripercorre le tappe che
segnano il passaggio dagli storicismi ottocenteschi fino alla tesi di Ricoeur,
secondo il quale la storia è solo un “racconto” tra gli altri. Nel leggere gli
eventi del mondo, in tal modo, ci si libera da astratte logiche a priori metafi-
115
116
sicamente garantite. Viene, cosi, configurato, nel titolo, il passaggio
dall’“etere di Zeus”, in cui, quasi, si sfiora il modello hegeliano di Storia universale, “nel senso che”, osserva Ciurlia, “il confine dell’azione umana diviene solo la sfera celeste posta a custodire il sacro fuoco della Ragione”, al
cadenzato “passo di Hermes” (pp.9-10). La parte più interessante è quella
relativa allo studio delle ricadute metodologiche implicate da questo mutamento di prospettiva. Se la storia narra, lo storico interpreta, utilizzando le
più raffinate tecniche di cui dispone. Ne discende una concezione della storia come “impresa interpretativa” (p. 17). È, questa, una tesi forte e decisa,
che tenta di ricuperare le ragioni dell’ermeneutica, combinandole con quelle
della filologia.
La sezione dei Saggi è aperta da un contributo dello stesso Ciurlia (La
modernità e i suoi linguaggi. Oltre l’apofantico), nel quale egli si sofferma sul
concetto di modernità, partendo da una rigorosa chiarificazione terminologica.
Emerge, cosi, una netta distinzione fra la modernità intesa come “categoria critica” e la modernità concepita come “categoria storiografica”. In quale prospettiva, allora, devono esser letti ed interpretati termini come “crisi della
modernità”, “superamento”, “decadenza del moderno”? Le tante “aree di
senso” della modernità consentono di comprendere i numerosi elementi critici
di cui si costituisce, andando al di là di certe astratte distinzioni che la riflessione sul cosiddetto postmoderno ha ingenerato.
Segue un attento lavoro di Paolo Pastori (Su alcuni aspetti del nesso tra
filosofia ed esperienza storica. La persistenza dell’archetipo Socrate nel XIX
secolo), nel quale l’autore pone in rilievo la centralità e l’importanza di cui si
riveste la figura di Socrate, nonché la sua influenza esercitata sulla filosofia
politica europea ottocentesca. Egli, sollecitato dalla categoria storiograficocritica dell’“archetipo”, individua in Socrate un “modello”, un “emblema”, che
ha consentito di cogliere tante linee di relazione e di continuità fra l’idealismo
classico tedesco e il marxismo tardo positivistico italiano e francese
(Labriola e Sorel).
Lo studio di Antonio Quarta (L’essenziale umanità del filosofare. Nicola
Abbagnano storico della filosofia) ripercorre le tappe più significative dell’itinerario storico-critico di Nicola Abbagnano, illustre rappresentante dell’esistenzialismo italiano del XX secolo. L’autore pone in risalto il carattere militante
delle sue ricerche storiografiche, ne interpreta l’opera come espressione di
rigore storiografico e soprattutto critico.
Chiude questa sezione un altro saggio di Ciurlia (La Storia: un altro presente o il nostro passato?), nel quale l’autore, prendendo le mosse da un
recente lavoro di Paolo Rossi (Un altro presente. Saggi sulla storia della filosofia, Bologna, Il Mulino, 1999), si sofferma sul tema della “definizione dello
statuto della storia”. Ciurlia, ripercorrendo analiticamente le tematiche proposte da Rossi, sottopone agli occhi del lettore alcuni problemi, fra i più spinosi,
sottesi all’indagine storiografica: la distinzione fra filosofia e storia della filosofia; la questione relativa al metodo; la fisionomia, la funzione e il carattere di
una disciplina cosi complessa e delicata qual è quella della storia della scienza; la fedeltà ai testi. il ruolo della filologia. Originale e foriera di spunti e di sug-
Luana Rizzo
RECENSIONI
gestioni è l’obiezione sollevata dall’autore a proposito della definizione di
Rossi del passato, ripresa da Giulio Preti, come “un altro presente”. “Il passato –osserva Ciurlia– è davvero un altro presente?”. Non costituisce, piuttosto,
il nostro passato? Sottile indicazione, questa, che pone ancora in primo piano
il carattere interpretativo della stessa indagine storiografica tale da renderla
ancora un’“impresa critica”.
La seconda sezione della rivista è pensata come un forum di discussione
intorno al problema della definizione dello statuto del soggetto, che, per la sensibilità filosofica contemporanea, non è più il fondamento assoluto dell’essere,
ma il portatore di prospettive interpretative sul mondo, nessuna delle quali ultima ed ontologicamente risolutiva.
In quest’ottica, Ciurlia (Le ragioni forti del pensiero debole), prendendo
spunto dagli ultimi sviluppi del pensiero di Gianni Vattimo, cerca di fare il punto
intorno allo stato del “pensiero debole”, guidato a confrontarsi con concetti
“forti” quali vocazione e responsabilità. Nel saggio emergono tutte le difficoltà
di questa prospettiva filosofica, che presume di liberarsi dalle grandi filosofie
della storia imperniate sui fondamenti assoluti e che, quando incrocia proprio
concetti quali vocazione e responsabilità, si carica di quelle stesse strutture
ontologiche di cui ha tentato di liberarsi. Alla fine, non ci troviamo dinanzi,
come dice il titolo, ad un pensiero debole fondato su ragioni forti?
Antonio Quarta, soffermandosi sulla filosofia strutturalista francese e sulla
critica che essa conduce all’umanesimo esistenzialista, interviene con Contro
il soggetto ‘cannibale’. Rileggendo Lévi-Strauss. L’autore, avviando la discussione a partire dalla lettura dei saggi riguardanti l’antropologia strutturalista del
pensatore francese, tenta di ridimensionare la sua definizione di antropologia
intesa come scienza esclusiva dell’uomo. Cosi, Quarta ha modo di porre in
rilievo la componente antiumanistica contenuta nel relativismo antropologico
lévistraussiano.
La dimensione etno-antropologica è la visuale dalla quale si pone
Giuseppe De Lorenzis, che in Fonocamptica ricorre alla musica, al rito e alle
tradizioni popolari per spiegare e interpretare particolari fenomeni socio-culturali. L’autore, soffermandosi sui rapporti intercorrenti fra l’etnomusicologia e la
filosofia, ne coglie i sottili legami, al fine di dimostrare che poesia, filosofia e
musica sono inscindibili. Egli, spiegando fenomeni quali il tarantismo, perviene alla conclusione che la musica popolare, in particolare quella salentina, è
un elemento fondamentale e imprescindibile per la comprensione della propria
identità culturale.
Seguono le recensioni, che occupano l’ultima parte della rivista. In definitiva, sono molte le cose che attraggono: l’idea, in un’età postmetafisica, di
affrontare la questione della storia in modo trasversale, l’attenzione per il
mutamento dell’asse metodologico dell’analisi storiografica, oltre ai tanti risultati perseguiti nei singoli saggi. Per ritornare ai temi dell’introduzione, continua
ad affascinare l’idea di una storia come “impresa critica”, capace di coniugare
l’ermeneutica con il rigore dei metodi di cui dispone lo storico.
117
R. ROCCO, Dalla responsabilità alla complessità. L’etica del futuro nell’età della
tecnica, Capone, Cavallino 2002.
118
L’avvento della “Civiltà tecnologica”, a partire dai primi anni del Novecento,
ha rappresentato per la storia dell’umanità non una tappa qualsiasi del suo
percorso, ma un passaggio epocale, un punto fermo del suo progresso, che
ha segnato col sigillo della necessità l’intera storia passata e ha aperto al futuro scenari e prospettive a metà tra il terrificante e l’entusiasmante.
La disciplina che più di tutte ha subito le ripercussioni della “Rivoluzione tecnologica”, con la necessità di dover riadattare e adeguare il proprio statuto e la
propria struttura razionale alle nuove forme del fare umano, è stata, senza dubbio, l’etica. Nel giro di un secolo o poco più, infatti, scienza e tecnica hanno
scardinato alle radici le certezze su cui per millenni l’uomo aveva creduto e su
cui aveva fondato il proprio agire, gettandolo in una sorta di “rivoluzione permanente” che rimodella incessantemente il mondo attorno a lui e che interessa, principalmente, le scienze biologiche e mediche: biotecnologie, ingegneria
genetica, clonazione, procreazione assistita o surrogata, stanno, infatti, lentamente ma inesorabilmente trasformando l’uomo da usufruttuario delle trasformazioni imposte al mondo e alla natura a oggetto di una potente manipolazione che rischia di mettere in gioco la sua identità più profonda e intima. Di fronte a questa rivoluzione antropologica, la più radicale e profonda della storia
umana perché apre la possibilità di una trasformazione intenzionale e duratura
dell’identità umana e del futuro della specie, le domande sulla presunta neutralità e bontà della scienza e della tecnica cedono il passo a considerazioni più
profonde sull’umanità che dobbiamo e vogliamo essere e sulle enormi responsabilità che ciò comporta non solo per gli uomini di scienza e per i politici ma
per tutti gli uomini in quanto appartenenti al medesimo ecosistema: qual è il
confine tra scienza ed etica? Fino a dove può legittimamente spingersi la ricerca scientifica? È giusto ostacolare il progresso scientifico solo per il timore di
un suo uso improprio? Quand’è che lo scienziato va a ledere i diritti umani?
Facendo proprie le preoccupazioni connesse ad un illimitato e incontrollato sviluppo scientifico-tecnologico, svincolato e autonomo rispetto al mondo
umano dei valori, l’ultimo lavoro di Rita Rocco cerca di delimitare l’orizzonte
teorico all’interno del quale è possibile dare delle risposte a queste domande.
Prendendo a modello della sua riflessione Il Principio Responsabilità di Jonas,
di cui fornisce una interessante rilettura ai fini del confronto con le altre teorie
etiche presentate nel testo, l’autrice esplica il suo tentativo di individuare, all’interno degli intricati sentieri della riflessione filosofica contemporanea, il filo
rosso di una teoria etica, fondata sulla struttura intrinseca della natura, che si
erga ad argine agli abomini della Civiltà tecnologica e a tutela dell’identità
umana, della sopravvivenza della specie e della salvaguardia della biosfera
nel suo variegato caleidoscopio di diversità.
Di fronte all’autorità di una scienza che tutto sembra essere in grado di realizzare, a dispetto dei valori fondamentali della vita, il primo imperativo di un’etica del futuro viene individuato nella tutela delle condizioni della vita sulla terra
e nella salvaguardia dei diritti umani fondamentali. Ripercorrendo suggestioni
RECENSIONI
moltmaniane l’autrice rammenta, però, che per essere veramente efficace e
svolgere adeguatamente il suo compito di nume tutelare dell’umanità, l’etica
del futuro deve sì abbracciare i diritti dell’uomo ma deve anche estenderli ad
includere i diritti dell’umanità, i diritti della terra e i diritti di tutti gli altri esseri
viventi al fine di giungere a quella “comunità mondiale” che è il vero obiettivo
dell’impegno etico per il futuro. Ed è in questo contesto che acquista valore la
considerazione etica del paradigma della complessità proposta da alcuni autori contemporanei.
Nella prima parte del volume, dopo aver esposto i punti essenziali della
proposta etica jonasiana, fondata su una metafisica teleologica e sull’affermazione della superiorità ontologica dello scopo sull’assenza di scopo, l’autrice
ribadisce come, per Jonas, l’uomo contemporaneo deve pretendere un ridimensionamento del suo potere e deve avviare un rinnovato impegno di
responsabilità al fine di recuperare il rispetto per la natura e pronunciare il suo
sì definitivo alla vita contro la minaccia di morte collettiva che sembra accompagnare lo sviluppo tecnologico.
Nella seconda parte, la proposta jonasiana viene posta a confronto con
quella di altri autori che, afferma l’autrice, hanno avuto il merito di coniugare il
suo “principio responsabilità” col “paradigma della complessità”. G. Anders, E.
Bloch, G. Bateson, I. Prigogine e M. Serres, condividono il senso e il fine del
filosofare jonasiano e, pur da prospettive diverse, riflettono sulla necessità di un
rinnovato impegno etico dell’uomo nei confronti della natura e dell’intera biosfera in un universo ormai monopolizzato dal fare tecnico. Un impegno che, dai
meandri bui della disperazione sulle reali capacità dell’uomo di reggere il confronto con la sfida distruttrice della tecnica (Anders), avvia alla speranza di un
mondo migliore (Bloch), o nella prospettiva di una “nuova alleanza” tra uomo e
natura (Bateson e Prigogine) o in quella di un nuovo “contratto naturale”
(Serres), a patto, però, che all’arroganza della scienza odierna l’uomo dimostri
di saper reagire con un atteggiamento di umiltà (Bateson) e di ritegno (Serres).
Con Bateson e Prigogine, la riflessione etica sulla responsabilità si è aperta
alla prospettiva della complessità come nuova forma di razionalità, diversa e
alternativa rispetto a quella che ha dominato nella modernità. L’origine cibernetica della nozione di complessità è evidente nel suo rimando al concetto di sistema come insieme organizzato di elementi interagenti reciprocamente. Bateson
e Prigogine hanno portato questa concezione all’interno del discorso etico e
hanno qualificato il rapporto tra l’uomo e la natura proprio in termini cibernetici:
ciascun individuo rappresenta un sistema aperto e dinamico che interagisce con
la natura ed opera adeguandosi alle informazioni che da questa riceve; gli organismi viventi sono, pertanto, dei sistemi aperti che scambiano energia ed esistono solo in relazione al loro ambiente. Tra gli esseri viventi e la biosfera esiste
una profonda unità, risultante da una condivisione di principi generali di organizzazione e di sviluppo e, pertanto, i loro destini non possono essere divisi ma
corrono di paripasso subendo la stessa sorte: il futuro dell’uomo dipende, dunque, dal futuro del suo ambiente e la salvaguardia della vita passa dalla tutela
dell’ambiente naturale in cui questa vita deve manifestarsi.
L’inserimento del principio responsabilità nel paradigma della complessità
119
ha avuto il merito di allargare gli orizzonti della riflessione etica, schiudendo
all’orizzonte del futuro la possibilità di una nuova immagine del mondo.
Dall’esame, certo schematico, delle teorie presentate, emerge però chiaramente come il tema del rapporto tra l’uomo e il suo mondo, unitamente a quello sul futuro della specie, sia diventato la discriminante essenziale nella valutazione etica del progresso tecnico. Pur se alcuni passaggi sono più abbozzati
che esplicitati, l’autrice, con questo testo, ha certamente aperto allo sguardo
del ricercatore uno scenario teorico diverso all’interno del quale riconsiderare
il rapporto uomo-natura.
Pantaleo Antonio Conte
L. BATTAGLIA, Alle origini dell’etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire,
Michelet, Thoreau, Gandhi, pref. di F. De Sanctis, Dedalo, Bari 2002, pp. 210.
120
Scelta sapiente, quella di Luisella Battaglia, che, in un articolarsi quasi dialogico di richiami tra grandi autori, ci conduce per mano, al di là del contrattualismo e neocontrattualismo imperanti nelle teorie della giustizia, a scoprire
una tradizione nascosta e, tuttavia, ancora in grado di interpellarci e di fornirci soluzioni per un nuovo umanesimo, un umanesimo ecologico. Scelta
sapiente, perché ci parla di un umanesimo naturalistico non più fondato, come
quello antropocentrico, sull’eccellenza dell’uomo e sulla sua antitesi con l’animale e la natura, ma fondato su un piano etico-politico, dove la comunità si
allarga oltre i confini della specie verso una concezione del cosmo inteso
come unità indissolubile di cui l’uomo è parte integrante. Scelta sapiente, perché non è solo raffinata selezione di sguardi sulle parole di grandi autori circa
il rapporto uomo-ambiente, ma perché è in grado di ricostruire una tradizione
di pensiero fatta di voci di grandi “classici”, di voci di intellettuali non certo marginali nella cultura occidentale, che hanno parlato di giustizia, solidarietà,
comunicazione e di amore che si estendono oltre le frontiere della specie
umana, per abbracciare gli animali, la natura, l’ambiente.
Scelta sapiente, infine, anche quella del brano di Gregory Bateson, posto
come exergo al volume, brano che non è solo strumentale per introdurre i temi
e gli autori trattati, ma che diventa quasi una dichiarazione di autenticità che,
in un gioco degli specchi, affida alle parole di un altro il modo per dire di sé. Il
brano in questione afferma che ci sono due modi per accostare l’opera di uno
studioso: uno viene dal pensarla di fronte a noi, in tal caso essa ci parla di sé
e niente di più; l’altro è quello di pensarla in relazione a noi, allora, essa ci dice
qualche cosa di più: parla anche di noi. E, infatti, gli autori analizzati nei capitoli del volume, dove si articola l’illuminismo razionalistico di Voltaire con il satyagraha gandiano e il romanticismo di Michelet con il liberalismo di Thoreau,
parlano anche, e persino in primo luogo, di Luisella Battaglia e del suo metodo, che è anche stile di vita, oltre che di pensiero, ed è quello che, in sintonia
con le parole di Voltaire, è in grado di vivere una solidarietà estesa anche agli
RECENSIONI
animali, che ridiventano prossimi degli umani, soggetti, al pari di uomini e
donne, di amore e vittime della violenza e dell’intolleranza. Metodo che rifiuta
gli antagonismi e le gerarchie, le sicurezze delle letture accreditate o le mode
dell’ultima ora, per privilegiare, proprio nella grande tradizione dell’occidente,
le letture meno conosciute, i sentieri meno frequentati, ma che capovolgono i
sistemi tronfi nelle proprie certezze e le sicurezze della forza della ragione che
troppo spesso si è trasformata in violenza o in impotenza. Al contrario, le parole di questi “classici” parlano di un amore, che è anche quello dell’autrice del
testo, per “i piccoli della creazione”, come li chiamava Michelet, che meritano
l’impegno e la garanzia della nostra assunzione di responsabilità. Dunque,
questi classici, sulla cui opera Luisella Battaglia ricostruisce una tradizione di
etica ambientale, non parlano tanto le loro stesse parole, ma parlano, forse
anche molto di più, proprio le parole di lei, quelle che a lei sono più care. In
entrambi i casi si profila un rifiuto del linguaggio dell’utilità che si basa fondamentalmente sul diritto umano a possedere e usare la natura ed è, invece, l’esplorazione feconda di un altro linguaggio che riconosce il valore dei beni
naturali, indipendentemente dai nostri diritti e interessi.
Scopriamo così un insospettato Voltaire che rivendica, contro ogni cartesiano meccanicismo e contro ogni metafisica, anche quella del nuovo materialismo scientifico, le capacità che hanno gli animali di conoscere, di sentire,
ma anche di apprendere e di perfezionarsi, di comunicare tra loro e con noi,
perché gli animali sono in grado di corrispondere, di sognare, di amare (p. 60).
Esaminando i testi di Voltaire, Battaglia ce lo ripresenta come l’autore di un’etica del riconoscimento che, partendo dalla registrazione dell’analogia tra comportamento animale e comportamento umano, arriva non solo a condannare
ogni violenza, ma a incoraggiare a “valutare positivamente le capacità che
abbiamo in comune con gli animali e a riconoscere che aspetti importanti di ciò
che rispettiamo –o che dovremmo rispettare– nei nostri simili sono presenti
anche in loro” (p. 61).
Sono testi e voci che ci insegnano che l’area della solidarietà si estende
anche ai non umani e che il regno pacifico della ragione richiede a gran voce
una tolleranza estesa al di là della specie umana. Questa etica del riconoscimento, lontana da ogni misticismo come da ogni utopia, è basata dall’autrice,
in piena sintonia con i “suoi” autori, su un approccio realistico, ispirato a un
senso assai vivo delle leggi di natura a cui nessuno può sottrarsi (p. 71).
Ci troviamo, così, di fronte a una filosofia attiva e militante, che trova il suo
fulcro morale in un concetto di ragione capace di coniugare il sentimento della
fragilità umana con quello della responsabilità in una visione realistica della
comunità terrestre capace però anche di ridere di tutti quegli astratti moralismi
che sono cosmesi da “anime belle”, a cominciare da quelle dei filosofi.
Ci troviamo anche di fronte a una storia che vuole ridare voce a chi ne è
privo, restituire dignità e identità a chi è l’altro, l’altro animale, l’altro popolo
senza voce che reclama riconoscimento e rispetto. Una storia rivoluzionaria,
come quella di Michelet, il cui nome è legato alle innumerevoli pagine da lui
scritte sulla Rivoluzione francese, ma che, grazie alla lettura di Battaglia,
diventa anche lo storico di un’altra rivoluzione: quella morale, che richiama alla
121
122
vita una natura pietrificata, ridotta a oggetto, a materia opaca, inerte, pura res
extensa. Perché gli esclusi, dalle donne ai fanciulli, dagli animali alla natura,
nelle pagine di Michelet che in questo testo ci vengono presentate, fanno la
storia in un processo di circolarità in cui “i miei popoli si fanno me –chiarisce
lo storico– e il mio io ritorna a animare i miei popoli”. Battaglia dimostra, con
le pagine di Voltaire e di Michelet, il paradosso di una scienza che scopre e
analizza sempre di più le somiglianze tra uomo e animale, ma non sa, o piuttosto non vuole, sottolinea l’autrice con triste consapevolezza, trarre da ciò la
logica conseguenza di un riconoscimento rispettoso: “la somiglianza vale solo
come licenza a sperimentare, non come limite etico” (p. 113), commenta con
avvertita lucidità.
Ci troviamo, infine, di fronte a una politica liberale al punto da far sperimentare al soggetto come prendere coscienza della propria alterità irriducibile, ma al tempo stesso capace di individuare le condizioni di un rapporto efficace di comunicazione con la natura e con l’ambiente. Identità e differenza si
articolano senza contrapposizioni, in una serie di relazioni che permettono,
nell’identità, di scoprire ciò che in noi è assopito e diviene e, attraverso la differenza, ciò che di noi ci è sconosciuto (p. 152). Sulla frontiera della “disubbidienza” di Thoreau, che fu anche disubbidienza alle regole di lettura “troppo
umane” con cui veniva letta la natura, collocata semplicemente come oggetto
accanto agli altri o completamente assimilata all’umano, Luisella Battaglia ci
introduce nel campo politico. La simpatia, come forma di conoscenza che riposa sul sentire e dove la sensibilità dichiara la scienza incapace di spiegare tutti
i fenomeni con cui l’uomo si confronta, diventa anche categoria morale e politica che sottolinea una totale disponibilità a capire e ascoltare. È la politica dell’ascolto, del riconoscimento, del dialogo, del confronto, è la pratica della libertà come spazio e ambiente dell’incontro; dove spazio e ambiente non sono
contenitori e involucri esterni, ma enti che hanno per noi una valenza affettiva
e simbolica. È il sentimento dell’integrità e della purezza della wilderness, così
fortemente presente nelle opere di Thoreau e che storicamente ha poi dato il
via alla creazione dei grandi parchi naturali, che risuona e mostrandoci le trappole delle categorie estetiche e di quelle utilitaristiche, ci orienta verso una
politica dell’amicizia, espressa dall’autrice in questi termini: “L’amicizia per la
natura è un’esperienza che comporta l’apertura verso la sua irriducibile alterità: essa non diviene un bene in nostro possesso, non si riduce a qualcosa che
fa parte del nostro campo di proprietà esistenziali o materiali, del nostro
mondo o della nostra soggettività. L’amicizia è un indice di distanza, di rinuncia all’istinto del possesso, favorisce una cultura della ‘percezione’ capace di
far apparire al meglio le differenze specifiche e di cogliere l’altro, di vederlo, di
ascoltarlo senza perdere né l’io né il tu” (p. 170).
Infine, non poteva mancare il forte richiamo alla nonviolenza di Gandhi, che
diventa principio etico capace di articolare il piano della giustizia estesa come
regola per tutti i viventi con il piano della “cura”, paradigma per l’affermazione
di una fraternità universale che si pone oltre la nostra specie. In tale ottica,
sulla quale convergono l’idea della creaturalità degli animali e la visione del
ruolo “ministeriale” dell’uomo, l’autrice, vegetariana non dell’ultima ora, pone il
RECENSIONI
vegetarianismo come l’espressione gandhiana di una filosofia della non violenza integrale. Sicché, in straordinaria sintonia con l’insegnamento di Gandhi,
questo volume si pone lontano da ogni dommatismo etico: il bene e il male non
vengono codificati in termini assoluti, ma devono essere interpretati e definiti
nei diversi contesti.
Ed è proprio questa la peculiarità anche dello sguardo e della pratica di
politica culturale di Luisella Battaglia, uno sguardo e una pratica che, da
tempo, già in altri volumi, hanno colto la necessità di estendere le categorie
morali anche al nostro modo di trattare gli enti non umani e che oggi hanno
anche saputo portare alla luce quella che negli ultimi tre secoli, oltre ogni paradigma contrattualistico, ormai ci appare come una tradizione reale, ma misconosciuta, che ha operato per una ridefinizione morale delle relazioni tra l’uomo e gli animali, la natura, e l’ambiente.
Marisa Forcina
123
Vincenzo Consolo
Oratorio
Due testi teatrali
novità
In questi due testi teatrali l’autore porta fino alle conseguenze estreme
l’andatura della sua prosa che si compatta in un narrato contratto, sintetico,
molto ritmico, giungendo fino alla forma poetica.
In Catarsi è messo in scena il suicidio di un Empedocle contemporaneo. Il
momento estremo prima della morte in un luogo anch’esso estremo, l’Etna.
Ape Iblea è un’elegia per Noto dove si canta del terremoto, della ricostruzione
e del degrado ambientale.
Appare, in filigrana ma ben evidente, l’impegno civile sotteso a tutta l’opera
di Consolo.
124
Alda Merini
Il maglio del poeta
novità
Il libro raccoglie l’ultimissima produzione di Alda Merini; è articolato
in tre sezioni: nella prima (“Dediche”) si ricostruiscono le relazioni
intellettuali ed umane della poetessa; la seconda (“Canzoniere
d’amore”) è dedicata a d un tema dominante della poesia della Merini:
la ricerca dell’amore in tutte le sue accezioni, da quella religiosa a
quella sensuale, che in Alda si coniugano, in quanto la sensualità è
insieme spiritualità; la terza sezione, che dà il titolo alla raccolta, è
una riflessione sul mestiere del poeta, sul senso della poesia.
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “SEGNI E COMPRENSIONE”
(oltre quelle recensite nella rivista)
Volumi:
P. ADDANTE, Il dolore dell’anima e le voci della speranza, Levante, Bari 2002,
pp. 150;
S. BERNI (a c. di), La persuasione naturale tra arte e filosofia, Silere, Sesto
Fiorentino 2002, pp. 94;
C. CALÌ, Husserl e l’immagine, Supplementa, Centro Internazione Studi di
Estetica, 2002, pp. 240;
G. CASERTANO-A. MONTANO, Giuseppe Martano, Società nazionale di Scienze,
Lettere e Arti, Napoli 2002, pp. 76;
A. CORSANO, Il pensiero di Giordano Bruno nel suo svolgimento storico, a c. di
A. SPEDICATI, Congedo, Galatina 2002, pp. 270;
N. DE CIAN, Redenzione, colpa, salvezza. All’origine della filosofia di
Schopenhauer, Pubblicazioni di Verifiche 34, Trento 2002, pp. 290;
S. DE SIENA, La sfida globale di Edgar Morin, Besa, Nardò 2002, pp. 270;
Discorsi per Giuseppe Martano, G. Martano jr.-Il Tripode, Napoli 2002, pp. 226;
F. FIORENTINO, Il problema della verità nei filosofi antichi, Editrice Domenicana
Italiana, Napoli-Bari 2002, pp. 404;
D. FELICE (a c. di), Dispotismo. Genesi e sviluppo di un concetto filosofico, tt.
2, Liguori, Napoli 2002, pp. 702;
G. GIUROVICH, Filosofia, politica, religione, a c. di D. Castellano e B. Lotti,
Forum, Udine 2002, pp. 496;
G. INVITTO, La tessitura di Merleau-Ponty. Ragioni e non-ragione nell’esistenza, Mimesis, Milano 2002, pp. 154;
L. LA PUMA (a c. di), Il Federalismo nella cultura politica meridionale, Lacaita,
Manduria-Roma-Bari 2002, pp. 328;
G. MORPURGO TAGLIABUE, Il Gusto nell’estetica del Settecento, a c. di L. Russo e
G. Sertoli, Supplementa, Centro Internazione Studi di Estetica, 2002, pp. 254;
A. NAPOLI, Thomas Hobbes e gli Italiani 1981-2000. Bibliografia-Recensioni,
Cuen, Napoli 2002, pp. 370;
S. NICOLOSI, Paidea e Vangelo, Borla, Roma 2002, pp. 148;
P. PASTORI, Da Atene a Napoli via Marburgo-Treviri.L’itinerario di A. Labriola e
G. Sorel verso la rifondazione etica della politica, Publigrafic, Trepuzzi 2002,
pp. 170;
G. PRESTIPINO, Realismo e Utopia. In memoria di Lukács e Bloch, Editori
Riuniti, Roma 2002, pp. 552;
I. TOTH, Essere ebreo dopo l’olocausto, a c. di B. M. d’Ippolito, postilla di R.
Romani, Cadmo, Fiesole 2002, pp.128;
K. WOJTYLA, L’uomo nel campo della responsabilità, a c. di A. Delogu, present.
di A. Wierzbicki, trad. di L. Crisanti, Bompiani, Milano 2002, pp.200.
125
Periodici:
Acta Philosophica, f. II, v. 11, 2002;
Antologia Vieusseux, n. 22, gennaio-aprile 2002;
Aquinas, n.1 e n. 2, a. XLV, 2002;
Bollettino di Storia della Filosofia, Università degli Studi di Lecce, v. XII, 1966-2002;
Aesthetica Preprint, n. 65, agosto 2002: E. FRANZINI, Il teatro, la festa e la rivoluzione. Su Rousseau e gli enciclopedisti;
Aesthetica Preprint, n. 66, dicembre 2002: P. RICOEUR, Dal linguaggio all’immagine, a c. di R. Messori;
Chiasmi International, n. s. n. 4, 2002: Merleau-Ponty. Figures et fonds de la chair;
Hermeneutica, n. s., 2002: [in]Attualità del politico;
L’immaginazione, n. 192, n. 193, 2002; n. 194, 2003;
Itinerari, n.2, 2002;
Mathesis Revista de Educação, v. 1, n. 1 e n. 2, 2000; v. 2, n. 1 e n. 2, 2001;
Notes et documents – Inst. International J. Maritain, n. s., n. 64, a. XXVI, 2002;
Paradigmi, n. s., n. 59, a. XX, 2002: Categorie filosofiche del Novecento (II);
Rinascita della scuola, n. 3-4, n. 5, n. 6, 2002;
Rivista di Filosofia, n.2 e n. 3, 2002;
Studia Patavina, n. 3, a. XLIX, 2002;
VIA, Voices in Italian Americana, v. 13, fall 2002, n.2.
126
Bianca Gelli
Voci di donne
Discorsi sul genere
novità
La rivoluzione culturale al femminile in un saggio critico
interdisciplinare.
Questo volume offre una riflessione critica su genere, identità,
teoria e pratica della differenza: dalla filosofia, alla psicanalisi,
alla pedagogia, alla sociologia e alla psicologia di comunità.
Egidio Zacheo
Il secolo della democrazia
Politica e società nel Novecento
novità
Il secolo della democrazia, del suffragio universale, delle
dichiarazioni dei diritti, delle conquiste sociali.
Carlo Alberto Augieri
La letteratura
e le forme dell’oltrepassamento
127
novità
La capacità del testo letterario di andare oltre il contesto nel
quale è prodotto. Saggi su Bachtin, Jakobs, Lotman e De
Martino.
I saggi qui raccolti focalizzano, all’interno del rapporto tra
letteratura e significazione, un problema che interessa lo
specifico della parola letteraria: il suo essere discorso dal
senso oltrepassante (non solo aperto, dunque) rispetto al
significare determinato, necessario, chiuso entro il codice
tipologico della cultura che lo emette.
Ingrao Zanotelli
Non ci sto
Appunti per un mondo migliore
novità
Ingrao, intellettuale laico di sinistra, e Zanotelli, missionario cattolico
progressista, in lungo colloquio che ipnotizza per la forza dei contenuti,
scuote per la lucida riflessione, spaventa per l’inquietante profezia,
rincuora per l’esempio di vitalità e gioia.
Un manifesto di impegno per costruire un modello di società della pace
e dell’uguaglianza; un percorso di analisi e di denuncia di un sistema
malato che sta divorando la terra; un manuale del dissenso civile. Pagine
forti che scuotono le coscienze e che dovrebbero entrare in tutte le
case, in tutte le scuole, in tutti i luoghi di lavoro, in tutte le biblioteche.
128
novità
Tabacco e Tabacchine nella memoria storica
A cura di V. Santoro e S. Torsello
Introduzione di A. Portelli
Il fatto che gran parte dei racconti raccolti in questo libro siano
belli non è un orpello ornamentale; è la sostanza stessa del loro
significato, il risultato di un lavoro durato decenni per dare forma
al ricordo e per dare senso alla Storia attraverso la costruzione di
storie. Anche per questo, usiamo il metodo del montaggio: non
certo perché pensiamo che sia più “oggettivo” ma perché la nostra
interpretazione passa attraverso il modo in cui assembliamo questa
pluralità di voci individuali, accordandole nelle armonie e dissonanze
di una narrazione polifonica in cui le voci degli intervistati vanno
infine a comporre la nostra.