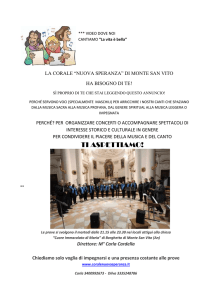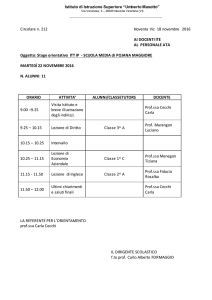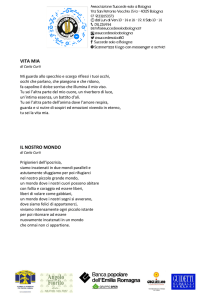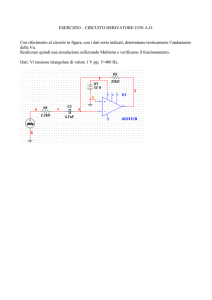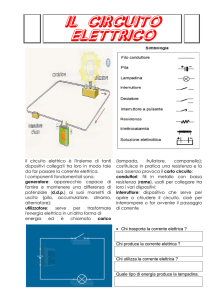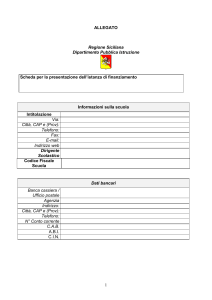Telefonia ed
evoluzioni
Evoluzione delle reti
telefoniche
Fine ‘800 – inizio ‘900:
1876: brevetto del telefono di Bell
Trasmissione analogica
e commutazione manuale
Architettura di rete non gerarchica
Evoluzione delle reti
telefoniche
Fine ‘800 – inizio ‘900:
1891: brevetto del selettore
Strowger
1894: prima centrale
elettromeccanica
1895: esperimenti di Marconi
Telefoni inizio ‘900
Telefoni inizio ‘900
Posto operatore
Centrale telefonica;
New York 1910
Cablaggi su pali
Selettore Strowger
CC1
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘40 e ‘50:
Autocommutatori
elettromeccanici (1938: relè)
Prima “teleselezione”
(coinvolge più centrali)
Diapositiva 10
CC1
relè: interruttore elettromeccanico (circuito elettronico (RC o a induttanza) + interruttore)
Carla Chiasserini; 02/12/2003
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘60:
Introduzione della trasmissione
e della commutazione numerica
PCM (Pulse Code Modulation)
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘60:
Elaboratori elettronici per
il controllo delle centrali
(programma registrato)
1965: prima centrale elettronica
(Saccasunna - USA - ESS1)
Operatrici telefoniche
Crossbar - 1952
Crossbar - 1965
ESS – 1 Console
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘70:
Diffusione delle reti PCM
Introduzione dei sistemi di
segnalazione a canale comune
(SS7)
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘70:
1975: prima centrale interamente
elettronica (Chicago - ESS4)
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘80:
Completamento (??) della IDN
(Integrated Digital Network) CC2
Definizione e prime installazioni
di ISDN (Integrated Services
Digital Network)
CC3
Diapositiva 19
CC2
IDN: rete di trasporto (distribuzione) completamente digitale doe si ha sia trasmissione che commutazione digitale (la commutazione avviene
senza trasformare il segnale da digitale ad analogico e viceversa.
Carla Chiasserini; 02/12/2003
CC3
servizi integrati: voce, video, dati
Carla Chiasserini; 02/12/2003
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘80:
Diffusione delle reti cellulari
analogiche
CC4
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘90:
Diffusione (??) di ISDN
Introduzione delle reti intelligenti
Diapositiva 21
CC4
in realtà negli anni 90 la isdn non era diffusa, la sua diffusione è iniziata solo nella seconda metà degli anni '90.
Ha avuto una grande diffusione con l'esplosione di Intenet xchè permette di avere la linea del telefono e internet allo steso momento. La ISDN
usa la tecnologia TDM. Inoltre essendo completamente digitale consente 2 o + linee a 64 kb/s (residenziale è sempre a 2 linee, per business
fino a 30 linee).
(La ADSL usa FDM, 3 canali: 1 per la telefonia,1 pr l'uplink euno per il downlink)
Carla Chiasserini; 02/12/2003
Evoluzione delle reti
telefoniche
Anni ‘90:
Definizione della BroadbandISDN (ATM)
Diffusione delle reti cellulari
numeriche
Evoluzione delle reti
telefoniche
2000:
Trasporto della voce su reti a
pacchetto (Internet telephony)
Reti cellulari a commutazione
di pacchetto (GPRS) e a larga
banda (UMTS)
Centrale ISDN - 1997
Il telefono di Bell
Fino alla metà degli anni ’60
il “telefono” è rimasto
sostanzialmente uguale
al brevetto di Bell;
ancora oggi i telefoni
analogici sono molto simili
Il telefono di Bell
Alexander Graham Bell depositò
il brevetto il 14 febbraio 1876
...qualche ora prima di Elisha Gray
...mentre Meucci sperimentava
un sistema analogo
Il telefono di Meucci
Il telefono di Meucci
Il telefono di Bell
Il 10 marzo 1876 Bell
presenta il primo
telefono funzionante
Il telefono di Bell
Comprende
un microfono (trasmettitore)
un altoparlante (ricevitore)
Il telefono di Bell
Collegati da un circuito elettrico
con una batteria in serie
trasmettitore
ricevitore
Il telefono di Bell
trasmettitore
ricevitore
Il trasmettitore è una resistenza
variabile che trasforma le onde
di pressione sonore in un segnale
elettrico
Il telefono di Bell
trasmettitore
ricevitore
Il ricevitore opera la trasformazione
inversa, vibrando al variare della
corrente
Attivazione e selezione
La linea viene attivata sganciando
il micro-telefono, che chiude
l’interruttore di linea
sento
CC12
selettore
alla
interruttore
centrale
di linea
CC9
CC11
CC13
parlo
Diapositiva 34
CC12
questo filo è il doppino: 2 cavi di rame che portano il segnale vocale in una direzione e nell'altra e costiyuiscono un circuito analogico
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC9
Quando si sgancia la corrente che passa varia dai 20 ai 60 mA
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC11
La batteria è a 48V e la tensione è fornita dalla centrale locale. Fanno eccezione i telefoni cordless che richiedono una alimentazione separata
xchè i 20 mA mandati da centrale non sono sufficienti per alimentare la stazione base del telefono cordless. Segue che se manca corrente
elettrica i cordless non funzionano.
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC13
forchetta telefonica si trova nella centrale locale e serve per passare da 2 fili (doppino) a 4 fili. Così il segnale in uplink e downlink sono separati
e possono essere amplificati in circuiti diversi sulle linee di giunzione, cioè che portano alle centrali di giunzione.
Carla Chiasserini; 03/12/2003
Attivazione e selezione
Il selettore (disco o tastiera)
è inserito in serie al circuito del telefono
selettore
alla
interruttore
centrale
di linea
alla
centrale
suoneria
CC5
interruttore di linea
Schema a blocchi complessivo
CC10
selettore
conversione
2/4
e circuito
anti--eco
anti
CC8
Diapositiva 36
CC10
selettore: provoca interruzioni della corrente ad ogni numero digitato
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC5
induttanza: a bassa freq, corto circuito -ad alta freq. circuito aperto.
condensatore: a bassa freq. e' un circuito aperto; ad alta freq. è un circuito chiuso.
Nella suoneria si ha un condensatore e 2induttanze (che pero' sono avvolte su ferrite e servono per fare il camapnello).Iil condensatore è per far
passare la sinusoide del segnale di squillo mandato dala centrale di lì e non arrivare alla cornetta.
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC8
Rx e microfono sono in serie nel circuito ma interagiscono tramite un complesso circuito.
Il circuito anti-eco, è un insieme di resistenze e induttanze che separano il rx dal microfono locale. Così il rx non viene modulato dal segnale
prodotto dal microfono locale ma solo da quello proveninete dall'utente con cui si comunica.
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC7
La centrale e il “local loop”
“local loop”
centrale di attestazione
sensore
trasform.
di sgancio
di linea
CC14
Alla forchetta, al
convertitore
A/D e ai CC15
sistemi di
commutazione
batteria di alimentazione
a 48 V
Diapositiva 37
CC7
a cosa serve il trasformatore di linea????
Probabilmnte solo a separare il local loop dal resto per proeggere il circuito da eventuali sbalzi di tensione.
Carla Chiasserini; 02/12/2003
CC14
La forchetta telefonica si trova nella centrale locale e serve per passare da 2 fili (doppino) a 4 fili. Così il segnale in uplink e downlink sono
separati e possono essere amplificati in circuiti diversi sulle linee di giunzione, cioè che portano alle centrali di giunzione.
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC15
Nelle centrali moderne i segnali analogici sono convertiti in digitali alla centrale numerica e trasferiti con tecnica TDM sulla rete digitale di
trasporto. Più canali a 64k/s sono multiplati con tecnica TDM, dalla centrale locale attarverso la rete di trasporto digitale.
Carla Chiasserini; 03/12/2003
CC6
La centrale e il “local loop”
Il sensore di sgancio
è un relè a induttanza che
sente il passaggio della
corrente di alimentazione
e abilita la porta di ingresso
in centrale dedicando
un convertitore A/D e una
posizione di commutazione
alla linea “attiva”
Diapositiva 38
CC6
quando si sgancia la cornetta e il circuito si chiude
Carla Chiasserini; 02/12/2003
Toni di centrale
La centrale invia diversi segnali
all’utente:
Squillo:
Sinusoide a 20Hz, 75V rms,
duty cycle [On/Off s - D.C.] ~1/1
Toni di centrale
La centrale invia diversi segnali
all’utente:
Selezione:
CC18
(350)+(440)Hz, tono continuo (USA)
(440)+(480)Hz, D.C. complesso tu ..
tuuu ...... (EU)
Diapositiva 40
CC18
Inoltre in U.S. la comunicazione telefonica è half-duplex, qui da noi c'è il doppino quindi è full duplex
Carla Chiasserini; 03/12/2003
Toni di centrale
La centrale invia diversi segnali
all’utente:
Linea disponibile:
(440)+(480)Hz, D.C. 2/4
Toni di centrale
La centrale invia diversi segnali
all’utente:
Linea occupata:
(480)+(620)Hz, D.C. 0.5/0.5
Toni di centrale
La centrale invia diversi segnali
all’utente:
Fascio occupato:
(480)+(620)Hz, D.C. 0.25/0.25
CC17
Diapositiva 43
CC17
2 toni con duty cycle /D.C.=Ton/Toff=0.25/0.25
Carla Chiasserini; 03/12/2003
Filtri e banda fonica
Il segnale analogico
tra telefono e centrale locale
viene filtrato tra 300 e 3400 Hz
per consentire il passaggio
della continua di alimentazione
e limitare la banda passante
del sistema
Filtri e banda fonica
Le centrali moderne
convertono immediatamente
il segnale in PCM CC16
banda
fonica
300
3400
f [Hz]
Diapositiva 45
CC16
codifica PCM è la tecnica di codifica di uso generalizzato nella rete telefonica pubblica (64kb/s)
Carla Chiasserini; 03/12/2003
Il servizio base POTS (Plain Old
Telephony Service)
La rete telefonica fornisce
connessioni bidirezionali e
simmetriche tra coppie di utenti
Il servizio base funziona secondo
un modello di chiamata in 3 fasi:
Fase di formazione (call setup)
Fase di conversazione
Fase di abbattimento
CC20
Diapositiva 46
CC20
La rete può poi fornire servizi supplementari, tipo ridirezione di chiamata, che si sovrappongono al servizio di base POTS
Carla Chiasserini; 03/12/2003
Una rete telefonica
centrale
di
commutazione
centrale
di
commutazione
trasmissione
segnalazione
Organizzazione gerarchica
Il numero di livelli,
la nomenclatura delle centrali
e degli apparati variano
da nazione a nazione.
Riflettono sia le dimensioni
del paese sia la “storia”
della telefonia nella nazione
Organizzazione gerarchica
centrale
internazionale
centrale
nazionale
centrale
regionale
centrale
locale
centrale
nazionale
centrale
regionale
centrale
locale
La rete PSTN (Public Switched
Telephone Network)
L’attuale rete telefonica oggi
è sostanzialmente una IDN
(Integrated Digital Network)
Commutazione a circuito
La rete PSTN
Trasmissione/commutazione
numerica PCM
Segnalazione a canale comune
CC19
Diapositiva 51
CC19
a pacchetto
Carla Chiasserini; 03/12/2003
Il modello di riferimento
L’architettura è divisa
in piano utente,
piano di controllo
(segnalazione)
e piano di gestione
(non visualizzato)
Il modello di riferimento
bla ... bla ... bla
protocolli
di utente
(PCM)
protocolli di
segnalazione
(SS#7)
informazione
di utente
informazione
di controllo
protocolli
di utente
(PCM)
protocolli di
segnalazione
(SS#7)
Informazione e controllo
“viaggiano” separati
centrale
locale
PCM
nodo
SS#7
SS#7
nodo
SS#7
nodo
PCM
nodo
PCM
nodo
PCM
centrale
locale
SS#7
PCM
Organizzazione
(piano utente)
È tipicamente organizzato
su 3 livelli:
Rete di accesso (da casa dell’utente
alla centrale locale)
Organizzazione
(piano utente)
È tipicamente organizzato
su 3 livelli:
Rete di giunzione (tra le centrali
locali e il centro distrettuale –
non necessariamente coincide
con un prefisso telefonico)
Organizzazione
(piano utente)
È tipicamente organizzato
su 3 livelli:
Rete di lunga distanza
(connette tra loro le centrali
di gerarchia più elevata)
Architettura della rete
rete di
lunga distanza
centrale
distrettuale
centrale
locale
rete di
giunzione
rete di
accesso
Uno sguardo
al mercato
Abbonati ai servizi cellulari %
Penetrazione cellulari vs. Internet
80
Finland
70
Wireless Internet
Oriented
60 Digital Economies
Italy
50
Austria
Sweden
Advanced
Digital Economies
Norway
Denmark
Switzerland
Netherlands
Japan
UK
Portugal
40
Spain
30
Follower
Digital Germany
25 Economies
0
10
US
France
20
Fixed Internet Oriented
Canada Digital Economies
30
40
Utenti Internet %
50
Service revenues (SN) $x1000
Worldwide revenues – All services
$350
$300
$250
$200
$150
Simple Voice
Rich Voice
Location-Based Services
Mobile Internet Access
Multimedia Messaging Service
Mobile Intranet/Extranet Access
Customised Infotainment
$100
$50
$
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wireless Penetration rates
by Region, 1999-2000
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
1990 1992 1994 1996 1998 2000
1991 1993 1995 1997 1999
West Europe
North America
East Europe
Latin America
Caribbean
Middle East
Asia Pacific
Africa