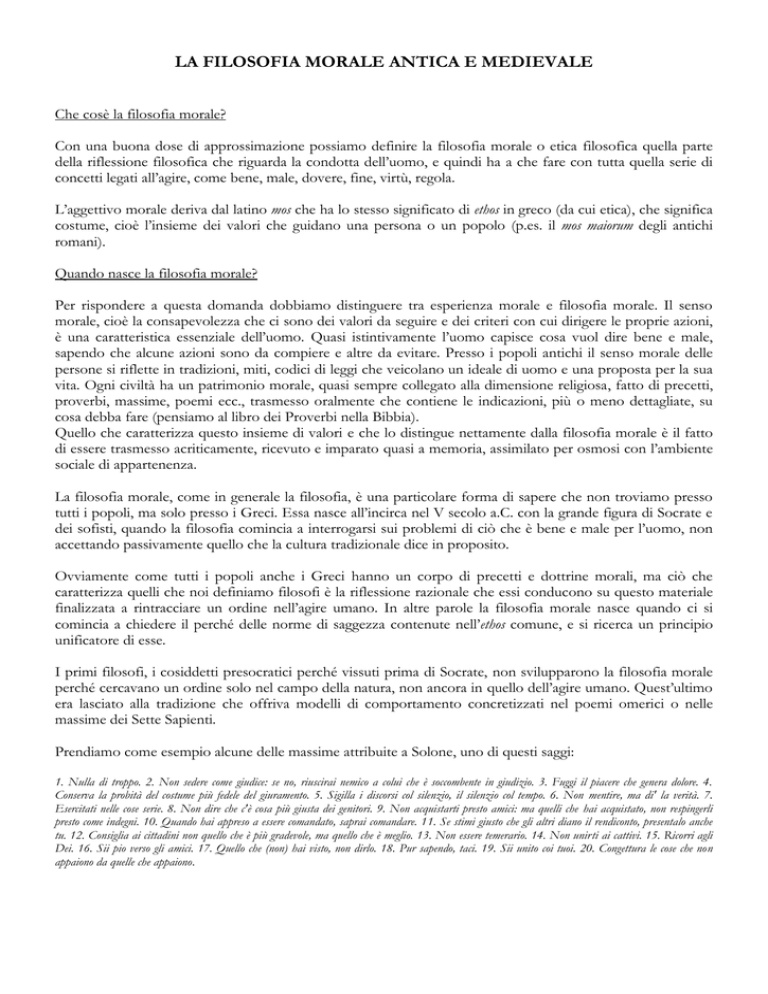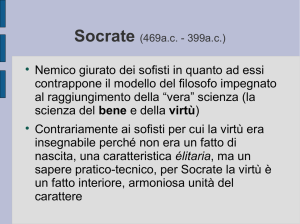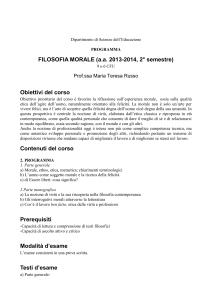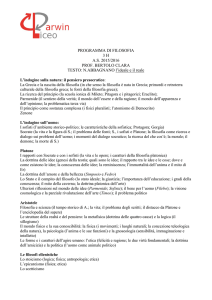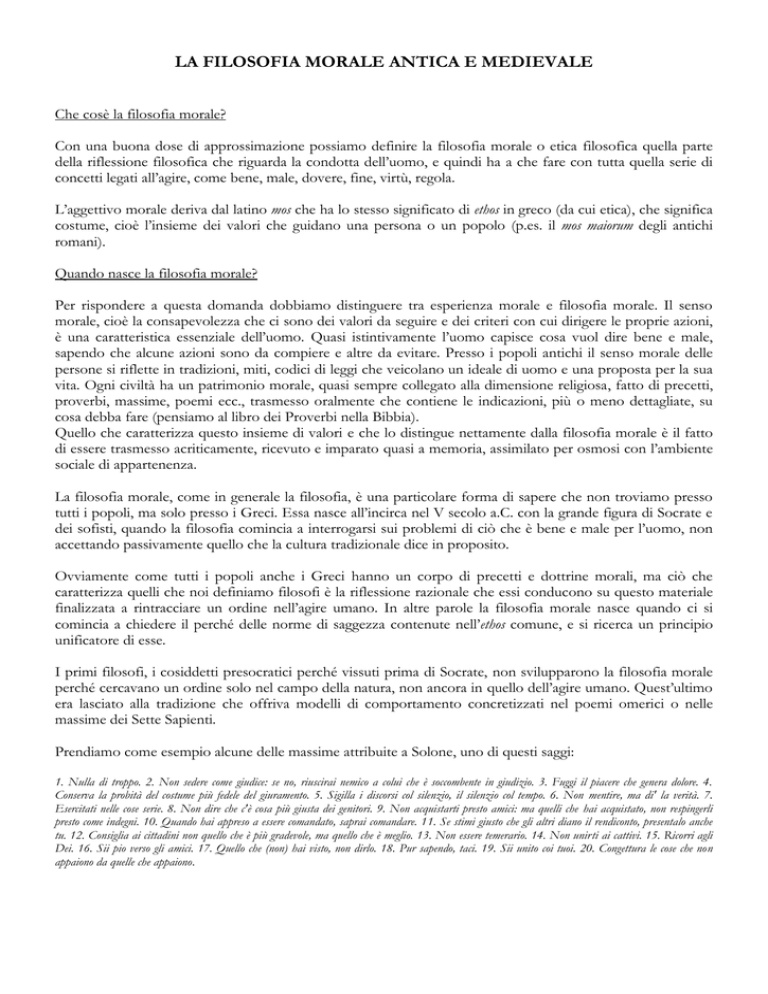
LA FILOSOFIA MORALE ANTICA E MEDIEVALE
Che cosè la filosofia morale?
Con una buona dose di approssimazione possiamo definire la filosofia morale o etica filosofica quella parte
della riflessione filosofica che riguarda la condotta dell’uomo, e quindi ha a che fare con tutta quella serie di
concetti legati all’agire, come bene, male, dovere, fine, virtù, regola.
L’aggettivo morale deriva dal latino mos che ha lo stesso significato di ethos in greco (da cui etica), che significa
costume, cioè l’insieme dei valori che guidano una persona o un popolo (p.es. il mos maiorum degli antichi
romani).
Quando nasce la filosofia morale?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo distinguere tra esperienza morale e filosofia morale. Il senso
morale, cioè la consapevolezza che ci sono dei valori da seguire e dei criteri con cui dirigere le proprie azioni,
è una caratteristica essenziale dell’uomo. Quasi istintivamente l’uomo capisce cosa vuol dire bene e male,
sapendo che alcune azioni sono da compiere e altre da evitare. Presso i popoli antichi il senso morale delle
persone si riflette in tradizioni, miti, codici di leggi che veicolano un ideale di uomo e una proposta per la sua
vita. Ogni civiltà ha un patrimonio morale, quasi sempre collegato alla dimensione religiosa, fatto di precetti,
proverbi, massime, poemi ecc., trasmesso oralmente che contiene le indicazioni, più o meno dettagliate, su
cosa debba fare (pensiamo al libro dei Proverbi nella Bibbia).
Quello che caratterizza questo insieme di valori e che lo distingue nettamente dalla filosofia morale è il fatto
di essere trasmesso acriticamente, ricevuto e imparato quasi a memoria, assimilato per osmosi con l’ambiente
sociale di appartenenza.
La filosofia morale, come in generale la filosofia, è una particolare forma di sapere che non troviamo presso
tutti i popoli, ma solo presso i Greci. Essa nasce all’incirca nel V secolo a.C. con la grande figura di Socrate e
dei sofisti, quando la filosofia comincia a interrogarsi sui problemi di ciò che è bene e male per l’uomo, non
accettando passivamente quello che la cultura tradizionale dice in proposito.
Ovviamente come tutti i popoli anche i Greci hanno un corpo di precetti e dottrine morali, ma ciò che
caratterizza quelli che noi definiamo filosofi è la riflessione razionale che essi conducono su questo materiale
finalizzata a rintracciare un ordine nell’agire umano. In altre parole la filosofia morale nasce quando ci si
comincia a chiedere il perché delle norme di saggezza contenute nell’ethos comune, e si ricerca un principio
unificatore di esse.
I primi filosofi, i cosiddetti presocratici perché vissuti prima di Socrate, non svilupparono la filosofia morale
perché cercavano un ordine solo nel campo della natura, non ancora in quello dell’agire umano. Quest’ultimo
era lasciato alla tradizione che offriva modelli di comportamento concretizzati nel poemi omerici o nelle
massime dei Sette Sapienti.
Prendiamo come esempio alcune delle massime attribuite a Solone, uno di questi saggi:
1. Nulla di troppo. 2. Non sedere come giudice: se no, riuscirai nemico a colui che è soccombente in giudizio. 3. Fuggi il piacere che genera dolore. 4.
Conserva la probità del costume più fedele del giuramento. 5. Sigilla i discorsi col silenzio, il silenzio col tempo. 6. Non mentire, ma di' la verità. 7.
Esercitati nelle cose serie. 8. Non dire che c'è cosa più giusta dei genitori. 9. Non acquistarti presto amici: ma quelli che hai acquistato, non respingerli
presto come indegni. 10. Quando hai appreso a essere comandato, saprai comandare. 11. Se stimi giusto che gli altri diano il rendiconto, presentalo anche
tu. 12. Consiglia ai cittadini non quello che è più gradevole, ma quello che è meglio. 13. Non essere temerario. 14. Non unirti ai cattivi. 15. Ricorri agli
Dei. 16. Sii pio verso gli amici. 17. Quello che (non) hai visto, non dirlo. 18. Pur sapendo, taci. 19. Sii unito coi tuoi. 20. Congettura le cose che non
appaiono da quelle che appaiono.
Da una semplice lettura capiamo che esse ci dicono soltanto che dobbiamo fare alcune cose ed evitarne altre,
senza però fornirci i motivi profondi e senza farci vedere cosa lega i precetti tra di essi. Ciononostante anche
le massime, come tutta la saggezza popolare, preparano il terreno alla filosofia morale.
La filosofia morale in età antica
L’etica nell’età classica
Socrate (469 - 399 a.C.)
Il primo filosofo morale della storia è l’ateniese Socrate. Pur non avendoci lasciato alcune opera scritta (quel
che sappiamo di lui lo dobbiamo al suo discepolo più brillante Platone), a lui è attribuita la scoperta dell’anima
(in greco psiché). Alla domanda chi è l’uomo?, egli pare abbia risposto che l’uomo è la sua anima e non il suo
corpo. L’anima è la sede della nostra intelligenza e della nostra coscienza morale. Quindi l’uomo non è il suo
corpo, ma essenzialmente la sua anima, e questa è uguale in tutti gli uomini, in quanto tutti abbiamo la
ragione. Nel dialogo platonico Alcibiade I troviamo questo passaggio:
So. Che cos’è dunque l’uomo?
Al. Non te lo so dire.
So. Sai dire però che è ciò che si serve del corpo.
Al. Sì.
So. Forse, dunque, qualcosa d’altro che non sia l’anima si serve di questo?
Al. Non altro.
So. È dunque lei che comanda?
Al. Sì.
Socrate parlando dell’anima fa un passo avanti verso la filosofia morale perché introduce il tema della natura
umana, cioè di un fondamento interiore permanente, reale anche se non sensibile, che fa da sostrato a tutte le
nostre azioni. Ciononostante Socrate ha vissuto tutto questo più che metterlo per iscritto.
Uno volta stabilito che l’uomo è la sua anima, Socrate fornisce la massima principale della sua etica: prendersi
cura dell’anima. Da questo principio deriva la possibilità di capire che il bene dell’uomo è ciò che coltiva
l’anima, mentre il male è il contrario. E cosa coltiva l’anima? O in altri termini, in cosa consiste la salute
dell’anima? Se essa è soprattutto razionalità, allora il bene sarà la saggezza/la conoscenza, in particolar modo
delle virtù, cioè di ciò che rende sana l’anima.
Tutti istintivamente riconosciamo che il bene dell’uomo sono le virtù: coraggio, amicizia, giustizia, ecc. ma
secondo Socrate noi le possiamo praticare solo se le conosciamo bene, cioè sappiamo darne una definizione
universale, rispondendo alla domanda: che cos’è. Nel Menone Socrate dichiara apertamente che la condizione
per praticare le virtù consiste nell’averne scienza, cioè nel sapere in cosa consistano
So. Dobbiamo esaminare se la virtù sia davvero scienza o altro dalla scienza.
Me. Sembra anche a me che si debba ora esaminare se la virtù sia davvero una scienza o altro dalla scienza.
So. Già! ma non affermiamo che la virtù è un bene? e l’ipotesi che sia, appunto, un bene non resta ben ferma?
Me. Senza dubbio.
[...]
So. Passiamo ora ad esaminare quel che è proprio dell’anima: c’è qualcosa che chiami temperanza, giustizia, coraggio, facilità d’aprendere,
memoria, generosità e altro di simile?
Me. Sì.
So. Ma vedi un po’, se di queste qualità quelle che non ti sembrano essere scienza, ma altro, a volte siano nocive altre volte utili: il coraggio, ad
esempio, quando non sia coraggio intelligente, ma una specie di audacia; chi agisce arditamente ma senza intelletto, non è forse danneggiato,
mentre chi è ardito con intelletto non ne ricava giovamento?
Me. Sì.
[...]
So. In linea di massima, dunque, tutto quello che l’anima intraprende e compie sotto la guida dell’intelligenza si conclude felicemente; nella
maniera esattamente opposta tutto quello che fa senza intelligenza.
La posizione socratica è stata indicata con l’espressione “intellettualismo etico”, secondo cui l'intelletto
prevale sulla volontà: si vuole il bene solo e perché lo si conosce, e si fa il male per ignoranza, ossia è
impossibile volere il male sapendolo tale, e non volere il bene sapendolo tale.
È importante sottolineare due cose della riflessione morale di Socrate che saranno presenti nella grande
maggioranza dei filosofi antichi. La prima cosa è di aver legato il problema del bene al problema della natura
dell’uomo, cioè l’etica all’antropologia. Se non sai chi sei, non puoi sapere cosa è il tuo bene. In secondo
luogo l’etica non è innanzitutto un insieme di precetti e divieti, ma cerca di rispondere alla domanda: cosa
devo fare per condurre una vita in cui mi posso realizzare come uomo?
Platone (427 - 347 a.C.)
Platone imparò da Socrate, del quale era stato discepolo fino alla morte in seguito alla condanna inflitta dalla
città di Atene, l’amore per la verità e per la giustizia. La sua filosofia si potrebbe tutta riassumere nel tentativo
di dare un fondamento oggettivo, cioè valido per tutti, al bene che noi tutti desideriamo e cerchiamo in ogni
nostra azione come in tutta la vita. Egli era convinto che solo persone profondamente desiderose del bene
potevano poi essere d’aiuto alla società, rendendola migliore e guarendola dai suoi vizi, che si riconducono
socraticamente all’ignoranza dell bene.
Per tanto egli fonda una scuola di filosofia, l’Accademia, ad Atene per formare i futuri governanti. Questo
dimostra la finalità politica dell’etica per i filosofi dell’età classica: essi concepiscono la vita dell’uomo non
individualmente ma sempre all’interno della comunità, che per essi ha la forma storica della polis, cioè la cittàstato greca.
È d’accordo con il maestro Socrate che se non si sa chi è l’uomo non si può dire cosa sia il suo bene, pertanto
anch’egli, e in maniera più approfondita parla dell’anima come nucleo spirituale profondo dell’uomo.
La concezione dell’uomo di Platone è simile a quella socratica nella distinzione fra anima e corpo; ma Platone
ha una visione tripartita dell’anima: oltre alla parte propriamente razionale, la cui virtù è la sapienza/saggezza,
vi è la parte animosa, che se ben guidata si manifesta nel coraggio e infine la parte desiderativa, che deve
essere tenuta a freno dalla virtù della temperanza. Il motivo di questa struttura più articolata sta nel fatto che
l’anima, ed è un’esperienza che tutti facciamo ogni giorno, subisce delle passioni, può essere attratta da
qualcosa e quindi provare desiderio o infiammarsi d’ira. Perché ciò sia possibile essa non può essere solo
razionalità. Quando nell’anima dell’uomo ciascuna parte ubbidisce alla ragione, venendosi così a creare una
situazione di equilibrio fra le tre parti, allora si realizza la giustizia, che è la virtù più importante.
Dal punto di vista della storia della filosofia morale, il contributo più importante di Platone è quello di
fondare l’etica non solo in una certa visione dell’uomo, ma anche in una certa visione della realtà. Platone
propose a riguardo la sua celebre dottrina delle Idee, vale a dire gli archetipi eterni delle cose che esistono in
un mondo non materiale, di cui questo nostro mondo è una copia. Esistono le Idee di giustizia, di coraggio e
delle altre virtù. In questo modo egli riteneva di avere salvaguardato l’universalità delle virtù.
Fra tutte le idee la più importante è l’idea del Bene, la quale occupa una posizione così eminente da essere
paragonata al sole definita «al di là dell’essere» in un celebre quanto oscuro passo della Repubblica:
So. Ora, questo elemento che agli oggetti conosciuti conferisce la verità e a chi conosce dà la facoltà di conoscere, di’ pure che è l’idea del bene; e
devi pensarla causa della scienza e della verità, in quanto conosciute. Ma per belle che siano ambedue, conoscenza e verità, avrai ragione se
riterrai che diverso e ancora più bello di loro sia quell’elemento. E come in quell’altro àmbito è giusto giudicare simili al sole la luce e la vista,
ma non ritenerle il sole, così anche in questo è giusto giudicare simili al bene ambedue questi valori, la scienza e la verità, ma non ritenere il bene
l’una o l’altra delle due. La condizione del bene deve essere tenuta in pregio anche maggiore.
Ad. Straordinaria deve essere, rispose, la bellezza che gli attribuisci, se è il bene a conferire scienza e verità e se le supera in bellezza; perché
dicendo “bene” non intendi certo riferirti al piacere
[...]
So. Puoi dire dunque che anche gli oggetti conoscibili non solo ricevono dal bene la proprietà di essere conosciuti, ma ne ottengono ancora
l’esistenza e l’essenza, anche se il bene non è essenza, ma qualcosa che per dignità e potenza trascende l’essenza .
Aristotele (384 - 322 a.C.)
Limitandoci solo alla sua filosofia morale, Aristotele è colui che offre la prima trattazione specifica di etica.
Scrisse tre opere su questo argomento, ma la più importante è indubbiamente l’Etica nicomachea, chiamata così
dal nome del figlio Nicomaco.
Se con Platone si può dire di essere in presenza di tutti gli ingredienti che compaginano una filosofia morale
matura, è solo con l’opera di Aristotele che possiamo vedere l’etica finalmente codificata a disciplina e ad
ambito specifico del sapere.
L’etica aristotelica presenta alcune somiglianze con l’etica di Platone: innanzi tutto l’idea che il bene dell’uomo
consiste in una vita buona, cioè riuscita, nella realizzazione della sua natura di uomo, e che questo si possa
fare esercitando le virtù. Inoltre come Platone, la politica che ha per fine il bene della polis, di cui fa parte il
bene del singolo uomo, è legata strettamente all’etica (per la gran parte del pensiero classico etica e politica
sono connesse - Macchiavelli le separerà). Infatti per indicare l’etica egli usa il termine scienza politica, per il
fatto che il bene supremo da ricercare è quello della polis, di cui l’uomo è membro, all’interno del quale trova
spazio il bene del singolo. Non è un caso che Aristotele ritenga che la pratica delle virtù sia resa possibile dal
contesto sociale con l’educazione, fatta di lodi e biasimo, con l’esempio di persone ritenute virtuose e
offrendo modelli concreti di virtù nei poemi omerici.
Nonostante questi punti di contatto, egli critica Platone per avere posto il fine ultimo dell’agire dell’uomo
nell’Idea di Bene, che trascendendo il mondo non è effettivamente raggiungibile in questa vita (che per inciso
è l’unica vita per Aristotele, assai dubbioso circa la sovravvivenza dell’anima al corpo).
L’Etica nicomachea, che avrà grande fortuna, come tutte le opere di Aristotele, soprattutto nel Basso Medioevo
e nella prima età moderna (l’affresco della Scuola di Atene di Raffaello sta a dimostrarlo), si apre sostenendo
che ogni uomo agisce in vista di un fine, e questo fine è un bene cioè qualcosa di buono per sé. Per esempio
quando ho fame, il cibo è il fine che desidero raggiungere, e lo desidero perché è un bene per me. Ma ogni
fine/bene è sempre un mezzo per qualcos’altro. Per esempio, se mi domando perché mangio, rispondo che lo
faccio per rimanere in vita.
Siccome non si può andare all’infinito per Aristotele deve esistere un fine ultimo o bene sommo che noi
ricerchiamo per se stesso, non in vista di altro. E tale è la felicità, che in greco si dice eudaimonia, per cui tutte
le etiche che pongono nella felicità il fine ultimo dell’uomo si dicono eudemonistiche, e tale è l’etica greca nei
suoi autori più importanti. Scrive nell’Etica Nicomachea
Poiché i fini sono manifestamente molti, e poiché noi ne scegliamo alcuni in vista di altri (per esempio, la ricchezza, i flauti e in genere gli strumenti), è
chiaro che non sono tutti perfetti: ma il Bene supremo è, manifestamente, un che di perfetto. Per conseguenza, se vi è una qualche cosa che sola è perfetta,
questa deve essere il bene che stiamo cercando, [30] ma se ve ne sono più, lo sarà la più perfetta di esse. Diciamo, poi, "più perfetto" ciò che è perseguito per
se stesso in confronto con ciò che è perseguito per altro, e ciò che non è mai scelto in vista di altro in confronto con quelle cose che sono scelte sia per se stesse
sia per altro; quindi diciamo perfetto in senso assoluto ciò che è scelto sempre per sé e mai per altro. Di tale natura è, come comunemente si ammette, la
felicità, [1097b] perché la scegliamo sempre per se stessa e mai in vista di altro, mentre onore e piacere e intelligenza e ogni virtù li scegliamo, sì, anche per
se stessi (sceglieremmo infatti ciascuno di questi beni anche se non ne derivasse nient’altro), ma li scegliamo anche in vista della felicità, [5] perché è per loro
mezzo che pensiamo di diventar felici. La felicità, invece, nessuno la sceglie in vista di queste cose, né in generale in vista di altro.
Analogamente a Socrate e Platone, la felicità più grande si trova nelle attività che realizzano in modo
eccellente l’essenza dell’uomo, la forma umana. Siccome la forma dell’uomo è l’anima razionale (definizione
di uomo come animale razionale) la vita felice o buona è la vita che realizza in modo eccellente le disposizioni
dell’anima razionale.
La virtù, è un abito, ossia una disposizione acquisita stabilmente a compiere bene un certo tipo di azioni. Non
si nasce virtuosi, ma si diventa con l’abitudine e l’educazione.
Le virtù per Aristotele si dividono in due grandi gruppi: virtù etiche e virtù dianoetiche.
Le virtù etiche, come il coraggio, la magnanimità, la sincerità, la temperanza ecc. rappresentano la capacità di
controllare le nostre emozioni, cioè di sapere governare la parte non razionale della nostra anima.
Le virtù dianoetiche (da dianoia= pensiero) sono le capacità raggiunte di usare bene la nostra ragione. Le due
più importanti sono la sapienza (gr. sophía) che è la virtù che produce il piacere più puro, e la saggezza (gr.
phronesis), ossia la capacità di deliberare bene in rapporto alla felicità, ossia indicare alla volontà i mezzi per
raggiungere il fine.
A differenza di Platone, che presenta un’etica prevalentemente ascetica (anche se negli ultimi dialoghi rivaluta
il ruolo del piacere) per Aristotele la vita fisica non è un male, anche se non è il bene più importante. L’uomo
è animale razionale, quindi innanzitutto è la razionalità a dover essere coltivata, ma in secondo luogo anche la
sfera fisica non va trascurata (siamo anche animali e anche la cura del corpo rientra tra i doveri).
Va tenuto presente, che la virtù per Aristotele, a differenza di ciò che dicono Socrate e Platone e che diranno
gli Stoici, è condizione necessaria ma non sufficiente per la felicità, perché ad essa concorrono sebbene in
misura minore altri beni quali la benevolenza degli dèi, la salute, un certo benessere e la fortuna.
La filosofia morale in età ellenistica
Con la morte di Aristotele nel 322 a.C. e soprattutto con quella del suo ex discepolo Alessandro Magno,
avvenuta l’anno precedente, termina l’epoca classica della Grecia e inizia un periodo nuovo nella storia della
Grecia, che fu chiamato ellenismo.
L’ellenismo è un un’epoca di crisi e disorientamento profondo perché vengono meno i punti di riferimento
antichi, a seguito della fine dell’indipendenza politica delle poleis greche, cadute sotto la dominazione
macedone. Per capire l’importanza che aveva la propria polis per l’uomo greco, possiamo riprendere quello
che Aristotele diceva nella Politica, e che ben rappresenta la mentalità greca. L’uomo è definito come animale
politico, fatto per vivere in società, e la polis è la società perfetta, perché solo in essa l’uomo può raggiungere la
propria perfezione. Fuori della polis non solo non c’è la possibilità di condurre una vita buona, ma nemmeno
di sopravvivere. Per lui solo le bestie e gli dèi possono vivere fuori dalla polis.
Con l’ellenismo tutto questo viene meno e la filosofia ne avverte il colpo. Quello che ora la filosofia vuole
essere è terapia dell’anima, arte di ben vivere e di sopportare i mali della vita. Alla figura ideale del sapiente si
sostituisce quella del saggio, colui che è autosufficiente.
Comincia in età ellenistica la divisione della filosofia in tre parti: logica (che comprende anche la teoria della
conoscenza), fisica ed etica. Vediamo che mancano grandi branche della filosofia come la metafisica e la
politica. Da questo punto di vista l’etica diventa la disciplina più importante.
Questa nuova tendenza della filosofia si esprime in nuove scuole che sorgono ad Atene, la quale rimane la
capitale della filosofia, anche se perde il suo primato per quanto riguarda gli studi scientifici, che passa ad
Alessandria, dove la scienza (geometria, matematica ecc.) raggiunge vertici assoluti, basta fare i nomi di
Euclide, Archimede, Apollonio, Eratostene, grazie al mecenatismo dei signori d’Egitto, i Tolomei, che
fondano la Biblioteca e il Museo.
Epicureismo
Epicuro di Samo (341-270 a.C) fonda una delle due grandi scuole ellenistiche, chiamata da lui epicureismo.
Siccome la sede della scuola era fuori dalle mura di Atene, in campagna, essa venne chiamata il giardino.
La posizione di Epicuro è materialistica, per la precisione atomistica: tutto, anche l’anima, è composto di
piccolissimi corpi non ulteriormente divisibili (a-tomos= non divisibile) che si muovono nel vuoto.
Per Epicuro l’ideale etico è il saggio, colui che è veramente felice. Ma cosa vuol dire essere felice per lui?
Significa raggiungere una condizione di imperturbabilità (in greco atarassia), cioè di mancanza di turbamento.
Si può vedere che il concetto di felicità epicureo è negativo. A questo serve la filosofia.
Tradizionalmente la filosofia epicurea è stata definita come edonistica, perché mette al primo posto la ricerca
del piacere. Questo non è sbagliato, se però intendiamo il piacere raccomandato da Epicuro ai suoi seguaci è
quello facilmente accessibile, e che dà meno turbamento, e quindi il suo consiglio non è di condurra una vita
dissoluta, ma nel calcolo dei piaceri.
Bisogna preferire i piaceri che derivano dal soddisfacimento dei bisogni naturali e necessari (mangiare e bere,
vestirsi ecc.) perché sono i più facili da ottenere e anche quelli che danno meno dolore quando vengono
meno. Se uno va alla ricerca di piaceri più ricercati, come mangiare bene, o essere ricco e potente, corre il
rischio di rimanere deluso.
La proposta complessiva di Epicuro è riassunta da lui stesso come quadrifarmaco, cioè come terapia ai
quattro grandi mali o paure dell’anima: il timore della morte, del dolore, degli dèi e di non essere mai felici.
Al primo risponde che la morte non è nulla per noi, perché quando c’è lei, non ci siamo più noi e viceversa; al
secondo che il dolore, se è forte, non può durare a lungo, in quanto o passa presto o ci conduce alla morte,
che, come già detto non è nulla per noi. Degli dèi non dobbiamo avere paura, perché essi non si curano
affatto degli uomini e quello che ci capita è dovuto al caso. Va ricordato che gli antichi erano molto
superstizioni e pensavano che senza il favore degli dèi la vita fosse piena di mali. La stessa parola felicità,
eudaimonia, significa avere un buon demone, cioè non incorrere nell’antipatia di qualche divinità, che
all’occorrenza sanno essere vendicative (l’Odissea lo mostra chiaramente!). Del timore di non essere felici, la
risposta è stata data con il calcolo dei piaceri.
La soluzione del quadrifarmaco è contenuta in una lettera, una delle pochissime opere di Epicuro che ci sono
pervenute, dedicata all’amico Meneceo e chiamata anche lettera sulla felicità. Epicuro è il primo a usare il
genere letterario dell’epistole per scrivere di filosofia. L’incipit di tale epistola è celebre e bellissimo, e merita di
essere ricordato indipendentemente dalla filosofia di Epicuro:
Meneceo,
mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro.
Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla conoscenza di essa, o che ormai è troppo tardi, è come se andasse dicendo che non è ancora
il momento di essere felice, o che ormai è passata l'età. Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo a conoscere la felicità. Per sentirci
sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtù del grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, irrobustiti in essa, per prepararci a
non temere l'avvenire.
L’uomo che mette in pratica queste indicazioni è il saggio:
E adesso dimmi: pensi davvero che ci sia qualcuno migliore dell’uomo [= saggio] che ha opinioni corrette sugli dèi, che è pienamente padrone di sé riguardo
alla morte, che sa sino in fondo che cosa sia il bene per l’uomo secondo la sua natura e sa con chiarezza che i beni che sono necessari sono pochi e possiamo
ottenerli con facilità, e che i mali non sono senza limiti, ma brevi nel tempo oppure poco intensi?
Facciamo notare che per Epicuro e la sua etica, viene meno il ruolo dell contesto comunitario, cioè scopo
della sua etica non è quello di costruire una società buona, come invece era per Socrate, Platone e Aristotele.
Inoltre con Epicuro è assente il tema della natura umana e il vedere la realizzazione di essa come il fine della
vita.
Stoicismo
L’altra grande scuola ellenistica dopo l’epicureismo è lo stoicismo. Fondata nel 300 a.C. da Zenone, che
proveniva da Cipro, essa prende quel nome per il fatto che egli insegnava sotto il portico dipinto (in greco
stoà) di Atene, non potendo permettersi un edificio dato che era straniero. A differenza dell’epicureismo in cui
i successori ripetevano pedissequamente l’insegnamento di Epicuro, la dottrina stoica ha conosciuto
un’evoluzione nel tempo, grazie anche alla statura dei successori di Zenone, primo fra tutti Crisippo (280-205
a.C).
Presso gli stoici permane l’idea che l’uomo abbia una natura e che questa sia la razionalità. Quello che colpisce
nell’etica degli stoici è il rigore: essi sostengono che la felicità si trovi solo ed esclusivamente nella pratica delle
virtù morali, e che queste consistano nel vivere secondo ragione. Il saggio è l’uomo virtuoso, a cui basta la
virtù per essere felice (autarchia del saggio).
Per gli stoici l’unico bene è la virtù, unico male il vizio, tutti gli altri beni sono da loro considerati indifferenti.
Questa degli indifferenti è una dottrina tipica dello stoicismo. Un’altra dottrina per la quale sono famosi è
l’apatia, cioè l’assenza di passioni, del saggio.
La misericordia fa parte dei difetti e vizi dell’anima: misericordioso è uomo stolto e leggero. Il sapiente non si commuove in favore di chicchessia; non
condona a nessuno una colpa commessa. Non è da uomo forte il lasciarsi vincere dalle preghiere e distogliere dalla giusta severità
Le passioni, che da loro sono ricondotte a quattro fondamentali, piacere, dolore, desiderio, paura, sono il
frutto di un errore di giudizio, nascono cioè dallo scambiare per bene (nel caso del piacere o del desiderio) e
per male (dolore e timore) qualcosa che non lo è. Per questo esse vanno non tanto governate, come pensano
Aristotele e anche Platone, ma estirpate, in quanto sono causa di cattive azioni. È evidente come l’ideale del
saggio proposto dagli stoici sia assolutamente utopistico e poco efficace. Gli stessi stoici lo sanno, e difatti
sostengono che pochissimi possono essere i saggi: uno di essi fu Socrate. Per la verità lo stoicismo ha
ammorbidito questo sostenendo che fra gli indifferenti alcuni sono preferibili, altri no. Ci informa lo storico
della filosofia Diogene Laerzio, vissuto nel II sec. d.C., circa questo punto:
Delle cose che sono essi dicono che alcune sono buone, altre cattive; altre ancora né buone né cattive [indifferenti]. Buone sono le virtù, prudenza, giustizia,
fortezza, moderazione ecc., cattivi sono i vizi, stoltezza, ingiustizia ecc.; indifferenti sono tutte le cose che non portano né vantaggio né danno, per esempio:
vita, salute, piacere, bellezza, forza, ricchezza, buona reputazione, nobiltà di nascita; e i loro contrari: morte, infernmità, pena, bruttezza, debolezza,
povertà, ignominia, oscura nascita e simili.
Da ultimo possiamo ricordare che essi ammettono la liceità del suicidio, qualora le circostanze esteriori
fossero tali da impedire di vivere compiendo il dovere. I primi capi dello stoicismo, da quel che si tramanda,
scelsero questa strada.
L’etica stoica vede nella virtù il dovere supremo dell’uomo, che deve quasi oscurare tutti gli altri beni.
L’epicureismo invece pone il piacere, inteso in modo non volgare, come fine da perseguire, non riuscendo a
fondare dei doveri universali e oggettivi avendo smarrito il concetto di natura umana. Invece la posizione di
Platone e Aristotele, pur nelle loro differenze, pone sì nelle virtù il fine e il senso della vita umana, ma tali beni
morali sono accompagnati legittimamente e anche naturalmente dal piacere, inteso come soddisfazione che
segue al raggiungimento di un bene vero.
La filosofia morale nel mondo romano di età imperiale
La fine dell’ellenismo si fa convenzionalmnete risalire alla battaglia si Azio, nel 31 a.c: quando Ottaviano, il
futuro Augusto, sconfigge Antonio e Cleopatra, l’ultima discendente dei Tolomei, sovrani d’Egitto. Da quella
data la potenza di Roma diventa padrona di tutto il bacino del mediterraneo.
I rapporto fra la civiltà romana e la filosofia greca cominciano a metà del II sec. a.C. e all’inizio non furono
semplici e pacifici: la forma mentis romana non era, e non sarebbe mai stata, avvezza ai sottili ragionamenti della
speculazione greca. Ciononostante con il passare del tempo sempre più famiglie patrizie romane mandavano i
figli a studiare in Grecia o piuttosto chiamavano i filosofi come precettori privati. Una figura importante che
contribuì a diffondere la filosofia, specialmente quella stoica, nel mondo romano fu Cicerone che tradusse
numerose opere.
Dal punto di vista storico i secoli di cui parliamo sono quelli che corrispondono all’ultimo periodo della storia
repubblica e all’età imperiale. Possiamo dire che i romani non si distinsero per dottrine originali, ma per la
ripetizione delle principali scuole greche che ormai avevano secoli alle spalle: platonismo, aristotelismo,
epicureismo e stoicismo.
Merita un accenno lo stocismo romano, rappresentato da Epitteto, Seneca e l’imperatore Marco Aurelio.
Tratto comune è quello di aver attrattato quasi esclusivamente tematiche etiche, disinteressandosi di
argomenti di logica e fisica che come abbiamo visto erano le altre due parti della filosofia per le scuole
ellenistiche. Di Seneca riportiamo una frase del De vita beata in cui ripropone gli ideali stoici
dell’autosufficienza del saggio:
È felice l’uomo per il quale non ci sono altro bene e altro male che non siano l’animo buono e quello malvagio, l’uomo amante del bene morale, pago della
virtù, che non può essere né esaltato né spezzato da quanto dipende dalla fortuna, che non conosce nessun bene più grande di quello che lui da solo può
darsi, l’uomo per il quale il vero piacere sarà il disprezzo dei piaceri.
e degli indifferenti:
Tutto il resto una massa di cose senza valore, che non toglie né aggiunge alcunché alla felicità, che viene e va senza accrescere il sommo bene.
Neoplatonismo
L’ultima grande corrente filosofica antica è il neoplatonismo, fondata da Plotino (205-270 d.C.) a Roma. Egli
era egiziano di nascita, ma di lingua e cultura greca, e voleva rifarsi alla filosofia di Platone, da cui il prefisso
neo-.
Il neoplatonismo è una corrente che recupera in pieno la dimensione metafisica, a tal punto da sostenere che
tutta la realtà sensibile sia il frutto di una emanazione di un principio assolutamente primo chiamato Uno. I
toni e le parole con cui egli descrive questo principio sono religiosi e si può ben dire che il neoplatonismo sia
un’alteranativa alla religione, soprattutto al cristianesimo, che al tempo in cui viveva Plotino aveva già fatto
parlare molto di sé a Roma.
Compito dell’uomo, identificato platonicamente con la sua anima, è quello di distaccarsi il più possibile dal
corpo e dai beni terreni, attraverso la virtù e la filosofia, per ricongiungersi, quasi estaticamente, con l’Uno.
L’anima deve spogliarsi di ogni realtà esterna per rivolgersi totalmente in se stessa, senza nulla concedere al mondo esteriore;bisogna pure che rinunci a
conoscere ogni realtà a partire da quelle sensibili finmo alle forme intelligibili, e addirittura a se stessa, per ritrovarsi nella contemplazione dell’Uno.
Scrive Plotino nelle Enneadi, (che significa gruppi di nove, dal momento che il discepolo Porfirio raccolse gli
scritti del maestro in 6 gruppi di nove trattati ciascuno, Enneadi appunto):
Quando volgiamo a Lui lo sguardo, soltanto allora troviamo in Lui il nostro fine e il nostro riposo e, senza alcun disaccordo, danziamo veramente intorno
a Lui una danza ispirata. In questa danza l’anima contempla lasorgente della vita, la sorgente dell’Intelligenza, il principio dell’essere, la causa del bene,
la radice dell’anima. Noi esistiamo in grado maggiore quando ci incliniamo verso di Lui, e in Lui sussiste il nostro bene: anche l’esserne lontani vuol dire
esistere in grado minore. Inoltre la vera vita è soltanto lassù; poiché la vita attuale senza Dio è una traccia di vita che imita la vita di lassù.
Quello che è importante notare è che per il neoplatonismo la radice del male sta nella materialità, dato che
esse viene intesa da Plotino come assenza di bene, dato che è la parte della realtà più lontana dalla sorgente di
bene e di essere che è l’Uno.
La materia, pertanto, è la causa della fragilità dell’anima e del vizio; quindi la materia è malvagia già da prima, anzi è il primo male.
Molti temi della filosofia di Plotino influenzeranno la nascente filosofia cristiana dei padri della Chiesa, primo
fra tutti Agostino.
La filosofia morale in età medievale
La filosofia antica finisce nel 529 d. C. quando l’imperatore d’Oriente Giustiniano ordina la chiusura delle
scuole filosofiche imperiali ad Atene. Da tempo il cristianesimo si era diffuso nell’impero romano
convertendolo: nel 381 Teodosio lo aveva dichiarato religione ufficiale.
La filosofia che si sviluppa nell’età medievale e che va approssimativamente dal VI al XIV sec. è
profondamente caratterizzata dalla fede cristiana e dalla nuova visione del mondo che essa contiene. Non è
un caso che i principali pensatori del medioevo siano teologi e in parecchi casi anche santi.
Dovendo tracciare un confronto tra la filosofia morale antica/pagana e quella medievale/cristiana, possiamo
sinteticamente evidenziare punti di continuità e di discontinuità.
Per quanto riguarda i primi possiamo dire che la riflessione medievale sulla morale continua ad adoperare i
concetti portanti usati da quella antica: il fine della vita è la felicità (per i latini beatitudo) che si raggiunge
conducendo una vita buona, in cui attraverso le virtù si realizza la natura umana; pertanto solo la persona
virtuosa è veramente felice. In termini più elaborati possiamo dire che l’etica medievale è eudemonistica come
quella antica, con la doverosa precisazione che mai la felicità si può separare dalla pratica delle virtù. A questo
riguardo ricordiamo che alle tradizionali virtù morali, i cristiani aggiungeranno quelle teologali, in primis la
carità. Inoltre un altro punto di convergenza sta nel fatto che per capire quale sia il bene dell’uomo, devo
sapere chi è l’uomo e per questo devo svolgere una visione complessiva della realtà. In termini tecnici: l’etica
si fonda in una antropologia e questa in una ontologia.
I motivi di discontinuità non sono meno importanti e prendono le mosse dalla diversa visione ontologica,
per il fatto che come già detto il pensiero medievale si radica nella rivelazione cristiana presentata nella Bibbia,
come disse il grande storico della filosofia mendievale E. Gilson è un «filosofare nella fede» nel senso che la
fede cristiana è l’orizzonte che dà senso a tutto.
Le novità più significative, che hanno una inevitabile ricaduta in ambito morale sono
1) la nuova concezione di Dio, visto come essere personale, onnipotente e buono, che si cura degli uomini;
2) il principio di creazione: Dio ha creato il mondo dal nulla per una libero atto di volontà, per amore.
La conseguenza di ciò è che tutto il creato è buono, perché lo ha voluto Dio, che non può volere il male, e
quindi anche la materia è cosa buona, e l’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, si realizza nell’amore.
Agostino d’Ippona (354 -430 d.C.)
Agostino è stato il più grande padre latino della chiesa, cioè di quegli teologi cristiani che fino al V secolo
hanno approfondito razionalmente le verità di fede (servendosi specialmente delle nozioni filosofiche
platoniche e stoiche), acquistando una grandissima autorevolezza nei secoli successivi. Dal punto di vista
storico egli è un autore tardo-antico, non più antico, ma non ancora completamente medievale essendo
vissuto a cavallo di due epoche.
Dal punto di vista morale, ricordiamo alcune dottrine importanti di Agostino, che riprendono i punti chiave
della rivelazione cristiana riletti soprattutto alla luce della filosofia neoplatonica. Agostino ritiene che Dio
abbia creato il mondo assegnando a ogni cosa un posto all’interno della gerarchia degli esseri. Ogni cosa ha
una natura, o per usare il linguaggio agostiniano, ogni cosa ha una forma, misura e peso. Al primo posto
ovviamente c’è Dio, che forma senza forma e misura senza misura, poi vengono gli spiriti creati, i corpi e i
beni terreni.
L’uomo è la sua anima, ossia una sostanza spirituale intimamente unita a un corpo. Egli è stato creato libero
da Dio, per poter amarlo liberamente. Come dice all’inizio delle Confessioni:
Ci hai fatti per Te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te
Il libero arbitrio, cioè la possibilità che ha la volontà di scegliere tra opzioni diverse non è fine a se stesso, ma a
scegliere il vero bene. La virtù consiste allora nel retto uso di questa libertà, cioè nel rispettare la gerarchia delle
creature, non preferendo i beni inferiori a quelli superiori. Ossia quando si vuole godere (in latino frui) di ciò
che deve solo essere utilizzato (uti) come strumento, o viceversa quando si vuole utilizzare come strumento
ciò di cui si deve solo godere.
la vita umana è resa cattiva e colpevole dal cattivo uso e dalla cattiva fruizione delle cose
Agostino parla della virtù come ordo amoris, cioè come amore ordinato. Il male morale o peccato allora
consiste nell’uso disordinato della libertà. È l’amore, la carità, che riassume e compendia tutte quante le virtù;
si potrebbe dire che ogni virtù sia una particolare sfumatura dell’amore, come si legge nel suo Commento al
Vangelo di Giovanni:
Ama e fa’ ciò che vuoi; sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona
per amore; sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene.
La felicità per Agostino consiste nel possesso di Dio, inteso come Bene sommo, infinito ed eterno, causa e
modello di tutti i beni parziali, finiti e transeunti. Questa condizione, sebbene anticipata dalla fede e dalla
carità, si realizzerà totalmente solo in un’altra vita, in cui:
il nostro essere non avrà la morte, il nostro conoscere non avrà l'errore, il nostro amore non avrà il dolore.
Agostino è un autore tardo-antico, perché vissuto nell’ultima fase dell’età antica. Pochi decenni dopo la sua
morte, avvenuta nel 430 d.C., crolla l’impero romano d’occidente e comincia la lunga stagione del Medioevo.
I primi secoli dell’età medievale sono i cosiddetti secoli bui per la civiltà e la cultura occidentale, e salvo
Severino Boezio (470-526) non ci sono grandi personalità filosofiche. La cultura sopravvive soprattutto nei
monasteri, dove generazioni di monaci amanuensi copiano i codici antichi. Per quanto riguarda la filosofia,
dobbiamo ricordare che la conoscenza del greco era pressoché scomparsa.
A parte la fondazione della Schola palatina da parte di Carlo Magno, e la nascita delle scuole monastiche ed
episcopali a partire dall’XI sec., dobbiamo aspettare il XIII sec., cioè l’inizio del periodo chiamato scolastica,
per vedere una fioritura eccezionale degli studi teologici e filosofici. Infatti in quel secolo dispiegano i loro
effetti tre avvenimenti decisivi:
la traduzione latina corpus aristotelico (prima di allora si conoscevano solo alcune opere di logica):
le traduzioni dall’arabo (successivamente anche dal greco) cominciarono a partire dalla seconda metà
del XII sec. e i luoghi principali furono Toledo, in Spagna, e Palermo, in Sicilia, terre che avevano
subito la dominazione araba. Ricordiamo che furono tradotti anche i testi dei suoi commentatori
arabi, primo fra tutti Averroè. Grazie a queste traduzioni la fama di Aristotele crebbe enormemente,
tanto da divenire nel corso del XIII sec. la massima autorità in campo filosofico (era il philosophus per
antonomasia). Dopo una iniziale resistenza dell’autorità ecclesiastica (condanne del 1210 e 1215) che
non vedeva di buon occhio che un autore pagano prendesse così piede, a metà del Duecento la
presenza dell’aristotelismo nei corsi universitari fu imponente.
la nascita delle università, cioè di corporazioni di intellettuali, maestri e discenti che fossero. Il centro
universitario più importante per quanto riguarda gli studi di teologia e filosofia è Parigi, seguita da
Oxford. Le università permisero al sapere filosofico di avere una collocazione istituzionale e pubblica,
sancendo la nascita anche della figura dell’intellettuale di professione.
la fondazione degli ordini mendicanti: francescani e domenicani, che ricoprirono l’Europa di conventi
nei quali spesso insegnavano confratelli che erano anche maestri universitari (p.es. Tommaso
d’Aquino).
San Bonaventura (1217 - 1274)
San Bonaventura da Bagnoregio, il doctor seraphicus, è una delle più grandi figure della cultura cristiana
medievale. Egli appartiene alla scuola francescana, studiò e insegnò a Parigi e dal 1257 fu ministro generale
dell’ordine, che si caratterizza per una fedeltà alla tradizione agostiniana e una certa diffidenza per
l’aristotelismo che stava dilagando nelle università.
L’opera più importante di Bonaventura è Itinerarium mentis in Deum (Itinerario della mente a Dio), scritto nel
1259 a La Verna, dove 35 anni prima san Francesco aveva ricevuto le stimmate. In quest’opera egli descrive le
tappe del cammino dell’anima verso il Bene Sommo.
In un primo momento bisogna uscire fuori di noi, cogliendo il mondo esterno come vestigio di Dio, poiché
ne riporta le tracce.
Il secondo momento richiede di rivolgersi dentro di noi, considerando la nostra anima, spirituale e immortale,
e che è immagine di Dio.
Infine, il terzo momento consiste nell’andare sopra di sé, unendosi attraverso una unione mistica attuata dalle
virtù soprannaturali al Bene sommo, e in questo modo raggiungendo una certa somiglianza con Lui.
Appare evidente la linea platonico.agostiniana nella fusione, ma non confusione, tra fede e ragione, grazia e
natura.
Tommaso d’Aquino (1225-1274)
A differenza dei francescani, i domenicani ebbero una grande apertura nei confronti di Aristotele,
considerandolo un pensatore troppo grande per essere trascurato. Colui che si assunse il compito di conciliare
la fede cristiana con l’aristotelismo fu Tommaso d’Aquino, il doctor angelicus. Egli costituisce, assieme a
Bonaventura, uno dei vertici del pensiero cristiano di tutti i tempi, e rappresenta, assieme alla pittura di
Giotto e alla poesia di Dante, uno dei vanti della cultura medievale (italiana per inciso) ispirata dalla fede.
Tommaso fu autore di numerosissimi scritti, ma il suo capolavoro è la Somma teologica, una poderosa
presentazione della dottrina cristiana per i principianti. È un testo esemplare per l’equilibrio mostrato tra la
fede e la ragione, due saperi distinti, ma in armonia. Non per niente egli è l’autore più raccomandato dai
pontefici (da ultimo Giovanni Paolo II nell’enciclica Fides et ratio del 1998) e la Somma è l’opera più citata nel
Catechismo della Chiesa Cattolica (1992).
La Somma è divisa in tre parti:
1. la prima parla di Dio, inteso come origine di tutto, e del creato
2. la seconda parla del ritorno dell’uomo a Dio
3. la terza parla di Gesù Cristo in quanto via che conduce l’uomo a Dio.
Come possiamo notare, la filosofia morale di Tommaso di trova nella seconda parte, divisa a sua volta in due
parti: la prima contiene l’etica generale, la seconda l’etica speciale.
I capisaldi dell’etica di Tommaso sono i seguenti (presentati nelle prime cinque questioni):
l’uomo ha un fine ultimo: infatti come tutte le cose, anche l’uomo ha una natura e agisce sempre in vista di un
fine, ma nel caso dell’uomo lo fa in maniera libera e consapevole. Il fine dell’uomo coincide con la
realizzazione della sua natura, e questo è valido per tutti gli uomini, perché la natura umana è comune. Questo
significa che la regola della moralità è la conformità al fine: un atto è buono se mi avvicina, cattivo in caso
contrario.
il fine ultimo è la beatitudine: Tommaso segue Aristotele e con lui un po’ tutta l’etica antica (che era
eudemonistica cioè poneva il bene sommo nella felicità). La beatitudine (o felicità) non può consistere in
nessun bene finito, ma solo in Dio, che è bene infinito.
Qui vediamo come la diversa ontologia porta a un’etica diversa da quella aristotelica; infatti sebbene per
entrambi il bene sommo è la felicità, per Aristotele essa consiste nell’appagamento delle potenzialità umane,
prima fra tutte la conoscenza; per Tommaso (possiamo aggiungere Agostino e Bonaventura) il fine ultimo è
Dio e trascende le possibilità umane. Questo è il paradosso dell’etica cristiana: il fine dell’uomo è al di sopra
dell’uomo e quindi occorre l’aiuto di Dio.
Riportiamo un brano che si trova all’inizio della seconda parte della Somma (S. Th. Iª-IIae q. 5 a. 3), in cui è
spiegato perché la felicità piena non è realizzabile in questa vita:
RISPONDO: In questa vita si può avere una certa partecipazione della felicità; ma non la vera e perfetta beatitudine. E questo si può confermare con due
argomentazioni. Primo, partendo dalla nozione stessa universale di felicità. Infatti la beatitudine, essendo "un bene perfetto ed esauriente", esclude ogni
male e appaga ogni desiderio. Invece in questa vita è impossibile escludere tutti i mali. Infatti la vita presente soggiace a molti mali, che sono inevitabili:
all'ignoranza dell'intelletto, agli affetti disordinati dell'appetito, ai molteplici malanni del corpo; come S. Agostino analizza con diligenza nel De Civitate
Dei. Così pure nella vita presente non può essere saziato il desiderio del bene. Infatti per natura l'uomo desidera il perdurare del bene che possiede. Invece i
beni di questa vita sono transitori: poiché è transitoria la vita stessa, che per natura desideriamo e che vorremmo far durare in perpetuo, avendo l'uomo
l'orrore
istintivo
della
morte.
Quindi
è
impossibile
il
possesso
della
beatitudine
nella
vita
presente.
Secondo, considerando il fatto in cui soprattutto consiste la beatitudine, cioè la visione dell'essenza divina, visione che l'uomo non può conseguire in questa
vita, come abbiamo dimostrato nella Prima Parte. Da ciò risulta evidente che nessuno in questa vita può acquistare la vera e perfetta beatitudine.
Tale paradosso ha due risvolti positivi. Il primo è consolante ed è che così si permette a tutti, anche al buon
ladrone evangelico, di essere felici. Per Aristotele, che non credeva nella vita dopo la morte, la felicità era la
consapevolezza di avere vissuto una vita riuscita. Mentre per l’etica cristiana, si può dissipare una intera vita,
ma non tutto è perduto.
La seconda conseguenza è che se la perfetta felicità è un’esperienza possibile solo dopo la morte, l’etica
cristiana è contraria alle utopie, nel senso che ritiene vani i tentativi di realizzare il bene perfetto in questa vita,
pensando di sradicare il male.
La beatitudine consiste nella visione di Dio: a differenza del francescano Bonaventura, per il quale la volontà
ha un primato sull’intelletto, Tommaso ritiene che sia il contrario e quindi nella vita eterna la felicità proverrà
dalla conoscenza diretta di Dio, piuttosto che dall’amore di lui.
L’implicazione importante di questa tesi, però, è che la conoscenza diretta di Dio è il fine ultimo di ogni
nostro desiderio, il senso profondo di ogni nostra inquietudine.
La seconda parte della Somma presenta l’etica speciale di Tommaso, ovvero la sua dottrina delle virtù. Le
virtù sono il mezzo che ci permette di avvicinarci a Dio, il nostro fine ultimo, e quindi di essere felici.
Come per Aristotele anche per Tommaso la virtù è un abito, ossia una disposizione acquisita a compiere bene
un certo tipo di azioni. Ora, dato che il fine dell’uomo è soprannaturale, prima vengono le virtù teologali
(fede, speranza, carità), che hanno come origine e oggetto Dio stesso; poi quelle cardinali (prudenza, giustizia,
fortezza, temperanza) che sono come i cardini su cui si imperniano tutte le altre.
Un posto centrale occupa la virtù della prudenza (in greco phronesis, cioè saggezza): essa è definita da
Tommaso recta ratio agibilium, cioè la capacità di capire cosa devo fare nelle circostanze singolari in cui mi
trovo. Essa è la capacità di applicare i principi universali, scolpiti nel nostro cuore, ai casi particolari.
Importante in Tommaso è la sinderesi (termine introdotto da san Girolamo e ripreso anche da Alberto
Magno), chiamata anche la scintilla dell’anima, ed è l’attitudine incancellabile a conoscere i primi principi
pratici. Il primo e più universale di questi è: bisogna tendere al bene ed evitare il male.
Giovanni Duns Scoto (1266-1308)
La sintesi grandiosa di Tommaso tra cristianesimo e aristotelismo non fu immediatamente compresa
dall’autorità ecclesiastica, che vedeva con profondo sospetto alcune tesi tommasiane particolarmente
innovative. Per questo si giunse nel 1277, il 7 marzo (tre anni esatti dopo la morte di Tommaso) alla
condanna di 219 proposizioni ritenute pericolose per la fede, tra le quali erano presenti alcune del
domenicano. Questa reazione di chiusura di spiega con il fatto che la linea prevalente in teologia era ancora
quella agostiniana portata avanti dai francescani; a ciò va aggiunto che a Parigi c’erano alcuni filosofi che si
richiamavano apertamente ed esclusivamente ad Aristotele (chiamati averroisti latini) e che proponevano
un’interpretazione del grande filosofo greco per alcuni versi incompatibile con la fede cristiana.
Ciononostante va detto che nel 1323 Tommaso fu proclamato santo da papa Giovanni XXII e nel 1567
dottore della Chiesa dal domenicano san Pio V.
La condanna del 1277 è un fattore importante da tenere presente per comprendere la svolta che la filosofia
prende alla fine del XIII sec. e poi nel corso del XIV per opera soprattutto di due francescani inglesi:
Giovanni Duns Scoto e Guglielmo d’Ockham, e consiste nel passaggio da una visione in cui risaltava
l’equilibrio tra fede e ragione (quella propria di Tommaso) a una di squilibrio a favore della fede. Questo
avvenne perché la filosofia aristotelica, secondo una certa interpretazione, tendeva a limitare la libertà e
l’onnipotenza di Dio e la libertà dell’uomo, per questo si sentì l’esigenza di dare il primato alla fede,
ridimensionando la portata conoscitiva della ragione e di conseguenza della filosofia.
Veniamo a Giovanni Duns Scoto. Francescano nato in Scozia (da qui il termine scoto), studente a Parigi e
Oxford, fu un teologo profondo con una grande devozione a Maria, di cui affermava, in grande anticipo sui
tempi di proclamazione del dogma, l’Immacolata Concezione, e per questo fu chiamato anche Doctor
Marianus.
Per quanto riguarda la parte del suo pensiero che interessa la filosofia morale, dobbiamo ricordare la sua
concezione volontaristica della legge morale. Ossia, secondo Duns Scoto Dio ha creato tutto liberamente, tra
cui la legge morale. Quest’ultima non è immutabile, ma permane tale finché persiste l’ordinamento voluto da
Dio. Detto in altre parole, Dio avrebbe potuto dare dei comandi diversi da quelli che ha dato nel decalogo
perché non è tenuto a rispettare nessuna norma anteriore alla sua volontà. In particolare Duns Scoto ritiene
che gli ultimi sette comandamenti (i primi tre sono immutabili perché riguardano l’amore che dobbiamo a
Dio) potevano essere diversi. Se dovessimo tradurre il suo pensiero in una frase: Dio non comanda ciò che è
bene in sé, ma è bene ciò che Dio comanda.
Scrive a riguardo Duns Scoto nella sua opera principale, l’Ordinatio:
Parecchie cose che sono proibite come illecite potrebbero diventare lecite se il legislatore le comandasse o almeno le permettesse, per esempio il furto, l’omicidio,
l’adulterio e altre cose del genere, le quali non implicano una malizia inconciliabile con il fine ultimo, allo stesso modo che i loro opposti non includono una
bontà che necessariamente conduca al fine ultimo. Come Dio poteva agire diversamente, così poteva stabilire altre leggi che, se fossero state promulgate,
sarebbero rette, perché nessuna legge è tale se non in quanto stabilita dalla volontà accettante di Dio.
Un’altra tesi di Duns Scoto riguarda il primato della volontà sull’intelletto nell’uomo. Mentre per Tommaso, e
per questo la sua posizione è stata definita intellettualismo, la volontà segue ciò che l’intelletto le propone
come bene, per il primo la libertà resta sempre libera di aderire a ciò che sa essere bene. La libertà non è
determinata da alcun bene particolare e nemmeno dal Bene ultimo. Perfino se l’uomo vedesse Dio, Bene
infinito, rimarrebbe libero di amarLo o meno, ossia la volontà sarebbe ancora in grado di autodeterminarsi,
cosa invece del tutto impensabile per Tommaso, secondo il quale noi non siamo liberi nei confronti del bene
ultimo.
Papa Benedetto XVI nel celebre Discorso di Ratisbona del 2006 dedicò un passaggio a questo momento
conclusivo della filosofia medievale, citando proprio il volontarismo di Duns Scoto:
Nel tardo Medioevo, si sono sviluppate nella teologia tendenze che rompono questa sintesi tra spirito greco e spirito cristiano. In contrasto con il cosiddetto
intellettualismo agostiniano e tomista iniziò con Duns Scoto una impostazione volontaristica, la quale alla fine, nei suoi successivi sviluppi, portò
all'affermazione che noi di Dio conosceremmo soltanto la voluntas ordinata. Al di là di essa esisterebbe la libertà di Dio, in virtù della quale Egli avrebbe
potuto creare e fare anche il contrario di tutto ciò che effettivamente ha fatto. [...] La trascendenza e la diversità di Dio vengono accentuate in modo così
esagerato, che anche la nostra ragione, il nostro senso del vero e del bene non sono più un vero specchio di Dio, le cui possibilità abissali rimangono per noi
eternamente irraggiungibili e nascoste dietro le sue decisioni effettive.
Bibliografia:
Da Re, Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, 2008