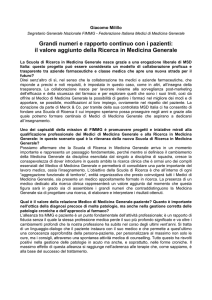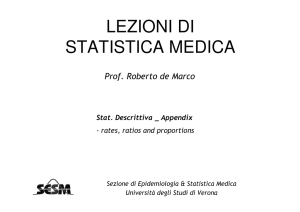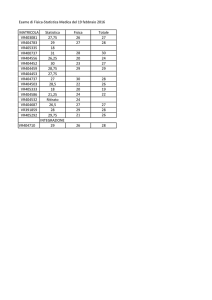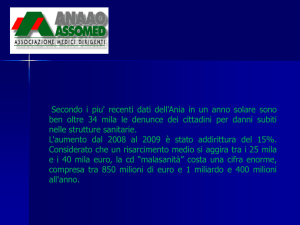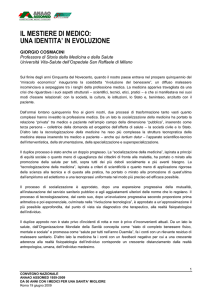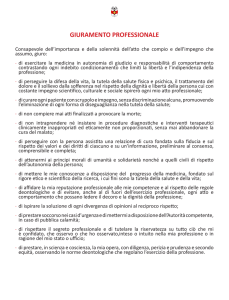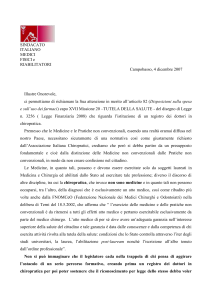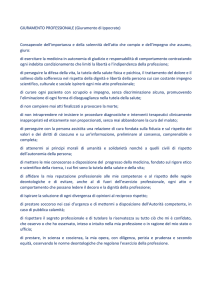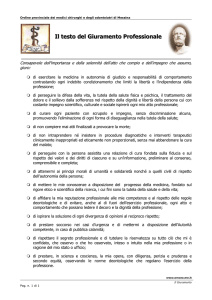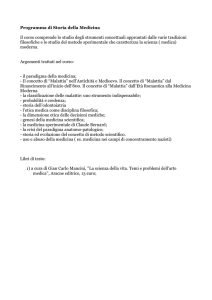La professoressa Betri, docente di storia moderna e contemporanea nell’Università degli Studi di Milano, ci fa dono
di un suo saggio dedicato all’ottocentesco “stimatissimo signor dottore”, integralmente pubblicato nella rivista
“Prometeo” (a.23, n.91, settembre 2005). Ne riportiamo, per i nostri lettori, un ampio estratto, limitato - per esigenze editoriali - alle prime pagine.
Lo“stimatissimo signor dottore”
Aspetti della professione medica nel primo Ottocento
MARIA LUISA BETRI
Nel processo di consolidamento delle professioni liberali durante il lungo Ottocento, dallo scorcio del
XVIII secolo agli esordi del XX, quella medica rivestì
indubbiamente un ruolo di protagonista, con l’ascesa
dei “figli di Esculapio” da incompresi o avversati
esercenti un’ “arte salutare” povera di efficacia terapeutica a “tecnici della salute e dell’igiene” detentori,
grazie ai progressi della scienza e alle scoperte della
batteriologia, di una credibilità crescente e di un corrispettivo prestigio sociale. L’approdo a questa condizione concludeva un lungo iter costellato di “triboli e
spine”, cui avevano dato all’epoca una particolare
risonanza la stampa medica periodica e i galatei , sorta
di trattati deontologici editi in gran numero per proporre codici di comportamento utili alla faticosa ridefinizione della figura professionale.
La vicenda del medico chirurgo moderno prese le
mosse da due profondi cambiamenti intervenuti tra
fine Settecento ed età napoleonica, l’uno sotto il profilo legale, l’altro in ambito scientifico. Abolita la
nobiltà e smantellato il sistema dei collegi ecclesiastici e professionali, prerogativa della società d’ordini di
antico regime, con il connesso monopolio degli studi e
del conferimento dei titoli di abilitazione, il radicale
mutamento dei criteri di selezione, basati non più
sulla nascita, bensì sul merito e su un curriculum formativo universitario, aveva ampiamente liberalizzato
gli accessi agli sbocchi professionali. Nel contempo
gli studi anatomici contribuirono ad eliminare la plurisecolare dicotomia che aveva mantenuto disgiunto il
medico-fisico, o medico-filosofo, depositario della
dottrina, dal chirurgo, relegato dalla manualità delle
sue funzioni nella sfera delle arti meccaniche. Ne
sarebbe emerso, sia pure nel corso di un lento processo, un nuovo soggetto professionale, provvisto di
cognizioni teoriche coniugate alla capacità non solo di
operare sul tavolo delle dissezioni anatomiche, ma
anche in vivo, sul corpo dell’infermo. Il medico così
formato veniva inoltre ad assumere un ruolo di rilievo
nell’esercizio di una “polizia medica” funzionale alle
esigenze dei governi di salvaguardare la salute e il
benessere delle popolazioni, così da assicurare agli
Stati prosperità e benessere.
L’esito più evidente di queste complesse trasformazioni fu il notevole aumento degli iscritti alle Facoltà
mediche - nel caso dell’ateneo di Pavia, ad esempio,
nel 1790 gli studenti in medicina superarono per la
prima volta quelli della tradizionalmente più frequentata Facoltà legale - di estrazione sociale piccolomedio borghese, tanto urbana quanto rurale. Si gridò
allora alla “volgarizzazione” della medicina, al “tentativo di abbassare la scienza all’uso dell’ignoranza”
deprecando che l’afflusso di una “calca di popolo”
verso una carriera sino ad allora riservata esclusivamente a un ceto svilisse la nobiltà dell’arte. Nei
decenni centrali dell’Ottocento, tuttavia, il trend delle
iscrizioni imboccò, per lo meno in alcuni degli stati
preunitari, una curva discendente a causa del saturarsi
delle possibilità di impiego nelle condotte, vale a dire
in quello che era stato uno dei principali sbocchi del
rinnovato mercato del lavoro. La prospettiva di esercitare nelle condotte per l’assistenza ai malati
poveri,ossatura di un sistema assistenziale esteso a
maglie più o meno fitte nell’intera Penisola, fu la
meta, ambita e detestata al tempo stesso per la instabilità dell’incarico, di una schiera di giovani laureati,
39
alle prese con le difficoltà di inserimento in una
“repubblica medica”in cui già si profilava la divaricazione, destinata ad accentuarsi sul far del Novecento,
tra oscuri professionisti operanti nelle periferie rurali e
più illustri colleghi capaci di mettere a frutto la loro
esperienza ospedaliera nella cura di una abbiente
clientela urbana. Figure precarie per l’intero XIX
secolo, poiché soltanto la legge sanitaria Crispi promulgata nel dicembre 1888 li sottrasse all’alea della
loro riconferma da parte delle amministrazioni comunali dopo un triennio di attività, remunerati con uno
stipendio molto modesto,talora insufficiente a coprire
il costo di una “cavalcatura” necessaria per raggiungere gli infermi in abituri dispersi nelle campagne, i condotti furono comunque il nerbo di una professione fortemente intessuta di elementi antropologici e umani e
un’avanguardia nel promuovere, affiancati dai maestri
elementari e dai farmacisti, un’opera di alfabetizzazione igienico-sanitaria. Nel 1885, dei circa 17.600 sanitari che esercitavano la professione, oltre 8.500 erano
in condotta in quasi 7.600 comuni.
All’epoca, comunque, il portato della medicina sperimentale e le scoperte della batteriologia parvero cancellare con un definitivo colpo di spugna i sospetti, lo
scetticismo, l’ostilità che in precedenza avevano non
di rado connotato il rapporto medico-paziente. La
scienza medica italiana aveva in verità vissuto nei
decenni preunitari una stagione tormentata, di “fatale
e obbrobriosa anarchia”- come si disse-, dilacerata da
dispute teoriche combattute senza risparmio di colpi
tra seguaci di scuole e tendenze diverse. L’“incerto e
vago operare” dei medici, avaro di successi terapeutici, ne era stato il più tangibile e immediato riflesso,
gettando ancora maggior discredito sull’arte cosiddetta salutare presso tutti i ceti sociali. Il medico dunque
era lungi dall’essere il primo e unico interlocutore di
chi cadeva malato, nobile o borghese che fosse, ricco
o miserabile, abitante della città o del contado. Ne è
una testimonianza il frequentissimo ricorso alla pratica del consulto, attestata dagli scambi epistolari tra
oscuri pratici di campagna, esercenti nelle città di provincia, cattedratici di chiara fama, per dirimere casi
clinici complessi e controversi, che raramente la terapeutica dell’epoca riusciva a risolvere. Accadeva spesso che in quei frangenti i pazienti agiati confrontassero il parere di esponenti della medicina ufficiale con
quello di “segretisti” , “spargirici”, acconciossa,
insomma di praticoni, interpellati di nascosto, ma il
40
cui responso era altrettanto ascoltato. A costoro di preferenza, piuttosto che all’esponente della medicina
scientifica, continuarono a rivolgersi, nel primo Ottocento, il popolo minuto delle città e gli abitanti delle
campagne, da sempre adusi a valersi dei rimedi di una
medicina empirica tramandata di padre in figlio e ad
affidarsi a un universo di mediconi, depositari di qualche nozione e tecnica terapeutica abborracciata, ma di
qualche efficacia. Un imbonitore di medicamenti che
smerciava sulle piazze in occasione di mercati e di
fiere era comunque alla portata di un contadino più di
un medico condotto residente a qualche miglio di
distanza. Fra il malato e gli esercenti illegali dell’
“arte medica”- fieramente combattuti dalla medicina
ufficiale nel corso di una prolungata, veemente crociata - si instaurava un rapporto diretto e immediato per il
tramite di un linguaggio comprensibile, privo di astrusi grecismi e latinismi che frapponevano altrimenti
un’impenetrabile barriera tra curante ed infermo: la
penetrazione psicologica del ciarlatano era quindi in
grado di far leva sulle capacità individuali di reazione
alla malattia che, assecondando la vis medicatrix naturae, erano talora in grado di condurre a guarigione.
Tanto in città quanto in campagna, infine, il medico
era chiamato spesso in extremis, quando il decorso
della malattia era ormai troppo inoltrato e non rimaneva che trasportare l’infermo nell’aborrito ospedale,
ancora ben lontano dal configurarsi, prima dell’avvento dell’asepsi, come moderna machine à guérir e vissuto nella mentalità popolare come l’ultimo approdo
prima della morte. I nosocomi ottocenteschi mantenevano in realtà la fisionomia di ricoveri indifferenziati
in cui una umanità miserabile era soccorsa con l’ausilio di una alimentazione corroborante piuttosto che
curata con presidi terapeutici efficaci, poiché soltanto
negli ultimi decenni del secolo gli ospedali italiani
cominciarono timidamente a modernizzarsi, diventando sede dei metodi di applicazione della moderna clinica e chirurgia.
Nel pieno dell’età risorgimentale, invece, la professione, in una fase di profonda crisi, divisa al suo interno
da rivalità dottrinarie e frustrata da carriere poco gratificanti, sembrava aver perduto molte attrattive e dover
dissolvere i sospetti di essere “arte di sorte e di raggiro, appoggiata a nessun cardine più sicuro della ispirazione istintiva” e in perenne conflitto con il rivale,
multiforme esercizio del ciarlatanismo. Disarmati di
fronte alla maggioranza dei mali, ma rivendicando di
essere i soli abilitati a combatterli, i medici comunque
si impegnarono da un lato a riconquistare dignità
scientifica e coesione professionale, dall’altro a
riscuotere consenso e fiducia ancor prima di essere in
grado di prestare terapie efficaci.
Fu, paradossalmente, una delle congiunture in cui più
drammaticamente si palesò l’impotenza della medicina a rafforzare presso la popolazione la figura e il
ruolo del medico. Il colera, che imperversò in ondate
epidemiche a partire dal 1836-37 lungo la Penisola,
mise ancora una volta impietosamente a nudo l’incapacità di arginare un male dalla eziologia ignota che
suscitava nelle popolazioni un terrore simile a quello
della peste. La comunità scientifica era divisa tra
“contagionisti” e “anticontagionisti”, cioè tra i sostenitori della trasmissione interumana della malattia, e
coloro che invece erano convinti delle sue origini
cosmotelluriche, vale a dire del suo insorgere per
effetto dei “miasmi” diffusi nell’atmosfera da un
ambiente naturale inquinato da acque stagnanti, liquami, rifiuti, ammassi di letame, e così via. Questa
discordanza di pareri ebbe tutto sommato riflessi di
poco conto sulle terapie, tra le quali tuttavia seguitava
ad essere ampiamente praticato il salasso, con nefasti
effetti debilitanti su organismi gravemente disidratati.
Molti colerosi quindi respinsero i medici “sì disperatamente e sì infelicemente curatori della malattia”,
oppure li accusarono di essere avvelenatori, conniventi con i governi e complici dei ricchi desiderosi di sbarazzarsi della povera gente, ma gran parte della popolazione ebbe modo di apprezzare il loro adoperarsi per
alleviare la sofferenza e per consolare. Sin dai primi
assalti dell’epidemia inoltre, i provvedimenti delle
autorità, articolati in misure di prevenzione e di diffusione di una generale normativa igienica, furono adottati in stretta collaborazione con i medici, che tennero
saldamente nelle loro mani l’intera organizzazione
sanitaria d’emergenza predisposta dalle municipalità,
dai lazzaretti alle “case di contumacia”, ove si tenevano in isolamento i sospetti . Essi poterono così avvalersene per tentare di debellare l’ostilità popolare e per
imporre all’attenzione dell’opinione pubblica la gravità e l’urgenza della questione sanitaria - dalla mancanza di infrastrutture igieniche al degrado abitativo,
all’alimentazione carente - per la quale si candidavano
a predisporre misure risolutive. E molti di loro si diedero alla stesura di trattati di topografia medico-statistica, ispirati dall’impostazione romagnosiana di una
La visita del medico, nel quadro di Domenico Induno (Collezione Privata)
statistica civile concepita come “uno studio descrittivo
di uomini e condizioni sociali”, in cui presentarono un
quadro analitico dei processi morbosi più diffusi fra le
popolazioni di alcune città e del loro contado, inquadrati secondo la lezione ippocratica nel contesto
ambientale e climatico, costituendo uno strumento
assai utile per avviare interventi risanatori.
Bibliografia
M. L. Betri, Il medico e il paziente: i mutamenti di un rapporto e
le premesse di un’ascesa professionale (1815-1859), in Storia d’Italia, Annali 7, Malattia e medicina, a cura di F. Della Peruta,
Torino, 1984, pp. 209-232.
Id., “La politica del medico nell’esercizio dell’arte sua”: splendori e miserie di una professione liberale (1815-1861), in Sanità e
società. Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria secoli XVII-XX, a
cura di F. Della Peruta, Udine, 1989, pp. 347-364.
E. Brambilla, La medicina del Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione scientifica, in Storia d’Italia, Annali 7, cit., pp.
5-147.
G. Cosmacini, Medici nella storia d’Italia. Per una tipologia della
professione medica, Roma-Bari, 1996.
Id., Il mestiere di medico. Storia di una professione, Milano, 2000.
E. Shorter, La tormentata storia del rapporto medico paziente,
Milano, 1986.
41