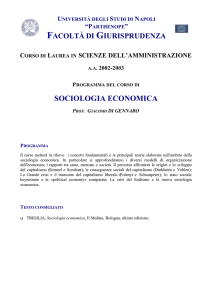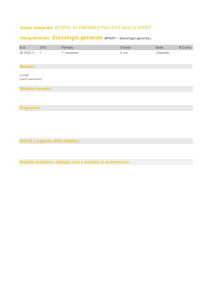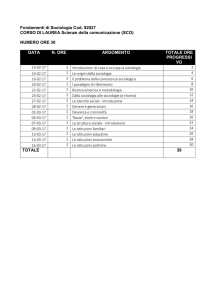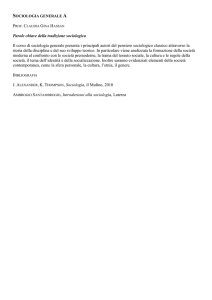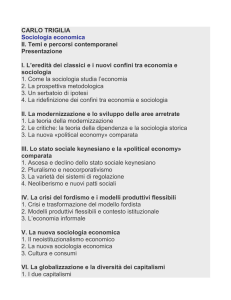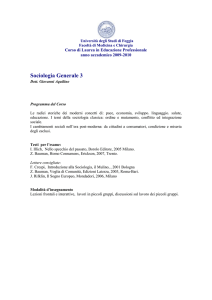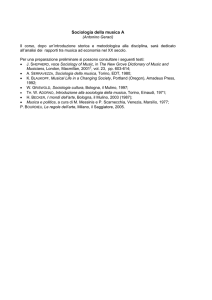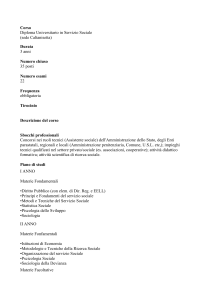SOCIOLOGIA ECONOMICA
II. Temi e percorsi contemporanei (Carlo Trigilia)
CAPITOLO 1
L’EREDITA’ DEI CLASSICI E I NUOVI CONFINI TRA ECONOMIA E SOCIOLOGIA
Nel volume primo di Sociologia economica abbiamo ricostruito gli sviluppi della sociologia
economica nel periodo che va dal 1890 al 1940. Questa prospettiva di analisi guarda
all’interdipendenza tra fenomeni economici e sociali e cerca di collocare l’economia nell’ambito
della società e delle sue trasformazioni. In questo capitolo ricostruiremo anzitutto, sinteticamente,
gli aspetti essenziali dell’eredità dei classici (Sombart, Weber, Schumpeter, Durkheim, Veblen,
Polanyi) per la definizione dello spazio analitico della sociologia economica. Che cosa distingue la
sociologia economica dall’economia? E quali sono i contributi specifici di questo approccio allo
studio dei fenomeni economici?
Nella seconda parte del capitolo, affronteremo la questione dei confini tra economia e sociologia
che si definiscono nel secondo dopoguerra, e prenderemo in considerazione i fattori di natura
teorica e storica che hanno influito sui rapporti tra le due discipline e sull’evoluzione della
sociologia economica.
1. LA PROSPETTIVA METODOLOGICA
Quando l’economia si era affermata come disciplina, in particolare con la “grande sintesi” di Adam
Smith, lo studio dei fenomeni economici non era isolato dal contesto sociale. Sappiamo che negli
sviluppi successivi l’economia si liberò progressivamente dai riferimenti a aspetti culturali e
istituzionali, nel tentativo di avvicinarsi agli standard di rigore e generalizzazione propri delle
scienze naturali. Questo percorso raggiunse il suo culmine con la “rivoluzione marginalista” degli
anni 1870. È a quel punto che lo studio dei fenomeni economici si separa programmaticamente dal
contesto culturale e istituzionale e si concentra sullo studio delle “leggi” del mercato, isolato
analiticamente dal contesto sociale.
Prende così forma un nuovo paradigma dell’economia
caratterizzato da una serie di elementi chiaramente delineati:
1) la concezione dell’economia: l’attività economica è considerata come un processo di
allocazione razionale di risorse scarse, impiegabili per finalità alternative, da parte di soggetti
che cercano di ottenere il massimo dai mezzi di cui dispongono (lavoro, reddito) per soddisfare i
loro obiettivi, sia di lavoro che di consumo, cioè le loro utilità (attività economica =
economizzare);
1
2) l’azione economica: l’azione è motivata dal perseguimento razionale dell’interesse individuale.
Nella sfera della produzione, i soggetti cercano di massimizzare il guadagno; nella sfera del
consumo cercano di massimizzare il soddisfacimento delle loro preferenze di consumo,
concepite secondo un ordine di priorità stabile e coerente, impiegando le risorse di reddito di cui
dispongono. Ne discende dunque che l’azione economica è condizionata da motivazioni
utilitaristiche. Vi è anche una visione atomistica dell’azione economica (cioè le preferenze di
lavoro e di consumo dei soggetti si formano indipendentemente dall’influenza di altri soggetti).
La formazione dei fini è considerata come un aspetto esogeno rispetto all’indagine economica,
che non deve occuparsene;
3) le regole: l’azione è influenzata da un nucleo limitato di regole (esistenza di mercati di tipo
concorrenziale; elevato numero di acquirenti e di venditori; libero scambio dei fattori produttivi;
piena informazione ai soggetti sulle offerte dei mercati per poter calcolare razionalmente). Si
studiano anche i casi in cui ci si allontana da queste regole (es. mercati monopolistici,
oligopolistici). Si tiene conto anche di istituzioni non economiche, come lo stato, ma si
considera che la sua esistenza non deve intralciare il mercato con le sue regolamentazioni ma
deve soltanto tutelare i contratti tra privati e combattere le frodi (anche lo stato è un dato
esogeno);
4) il metodo di indagine: è analitico-deduttivo e normativo. Si parte dagli assunti prima chiariti
(motivazioni atomistiche e utilitaristiche) e se ne valutano le conseguenze, date certe condizioni
prevalenti nelle regole. Può dar luogo all’applicazione di sofisticate tecniche matematiche per la
dimostrazione degli esiti. Il carattere normativo del metodo si riferisce al fatto che esso fornisce
anche dei criteri guida per l’allocazione razionale delle risorse, date certe condizioni. Menger e
Pareto sottolineano che la validità scientifica dei risultati è garantita dalla dimostrazione logica
degli esiti che discendono da determinate condizioni, a prescindere quindi dalla piena
riscontrabilità sul piano empirico di tali condizioni.
Vediamo come la sociologia economica dei classici abbia sviluppato una prospettiva relativamente
coerente e organica che si distingue da quella prevalente nell’economia dell’epoca:
1) la concezione dell’economia: i sociologi economici sono tutti interessati a guardare
all’economia di mercato come un fenomeno storico caratterizzato da un particolare contesto
istituzionale, e per questo preferiscono in genere parlare di capitalismo. Cercano di distinguere
tra i vari tipi di economia per comprendere come prende forma il capitalismo liberale, perché si
sviluppa in alcuni luoghi e non in altri; insomma la diversità nello spazio e nel tempo è al centro
del loro interesse e non si identifica esclusivamente con le attività regolate dal mercato. Essi
2
vogliono studiare come l’economia si organizzi in forme differenti nello spazio e nel tempo,
influenzate dalle istituzioni economiche e non economiche;
2) l’azione economica: l’azione orientata alla ricerca dei mezzi di sussistenza non è
necessariamente costituita dall’allocazione razionale di risorse scarse. I sociologi economici
attaccano l’atomismo dell’economia neoclassica (dove fini dei singoli soggetti si formano
indipendentemente gli uni dagli altri). L’azione economica deve invece essere vista come
azione sociale, influenzata da aspettative relative al comportamento degli altri membri della
società (tali aspettative in Weber prendono la forma di usi, costumi, norme giuridiche). Questo
modo di concepire l’azione economica è sostanzialmente condiviso da tutti i nostri autori, sia
che essi diano maggiore enfasi all’autonomia e alla libertà degli attori rispetto alle regole
istituzionali (come Sombart, Weber, Schumpeter), sia che partano invece dalle istituzioni e ne
sottolineino maggiormente i condizionamenti sui soggetti (come Durkheim, Veblen, e Polanyi).
L’azione degli individui può avere natura non utilitaristica e dipendere, per esempio, da valori
religiosi (Weber), dal grado di marginalità sociale (Sombart), dalle forme della divisione del
lavoro e della disuguaglianza sociale (Durkheim, Weber, Polanyi), dai caratteri della famiglia o
dalle forme di organizzazione dell’impresa (Schumpeter).
Nella realtà concreta l’azione
economica ha dunque di solito una pluralità di motivazioni che possono essere ricostruite solo
per via induttiva, con l’indagine storico-empirica e sempre con difficoltà;
3) le regole: i sociologi economici considerano i fenomeni istituzionali diversi dal mercato in due
direzioni (da un lato vi è il riferimento a istituzioni economiche che si fondano su obbligazioni
sociali condivise, come la reciprocità di Polanyi, lo scambio su base tradizionale di Weber;
dall’altro le istituzioni di regolazione politica dell’economica come la redistribuzione di
Polanyi, l’economia di piano o cooperativa di Sombart, il gruppo regolativo e quello
amministrativo di Weber, oppure i sindacati, la criminalità organizzata, ecc.). Le forme concrete
che assume l’attività economica nello spazio e nel tempo sono dunque influenzata dal modo in
cui queste diverse istituzioni regolano le attività di produzione, distribuzione e consumo, e
condizionano l’azione dei soggetti;
4) il metodo di indagine: mentre in economia si parte da assunti a priori circa le motivazioni
utilitaristiche degli attori e la presenza di determinate condizioni di funzionamento dei mercati, i
sociologi cercano di ricostruire attraverso l’indagine empirica i caratteri specifici dell’azione
economica, vista come possibile espressione di motivazioni non utilitaristiche, o anche come
combinazione tra elementi utilitaristici e altre spinte di natura diversa (tradizionali, affettive o
ideologiche). Gli autori che abbiamo esaminato cercano anche di mettere a fuoco, sempre con
l’indagine storico-empirica, le regole effettivamente presenti in un determinato contesto. Ne
3
2. UN SERBATOIO DI IPOTESI
Il carattere storicamente orientato dei modelli di analisi classici fa sì che non si possano ricavare dai
nostri autori generalizzazioni teoriche che vadano al di à di coordinate spaziali e temporali
delimitate; tuttavia, sarebbe sbagliato non cogliere una serie di ipotesi, convergenti e coerenti tra
loro, che emergono dai lavori esaminati in precedenza. Prendiamo in considerazione tre temi: il
mercato, lo sviluppo e il consumo.
2.1 Il mercato
Distinguiamo analiticamente due aspetti che abbiamo visto trattati con enfasi e impegno.
Il processo di costruzione del mercato capitalistico
Nel pensiero economico si ritiene in genere che le relazioni di mercato si diffondano per la loro
efficienza rispetto ad altre modalità di organizzazione economica, cioè per la capacità di soddisfare
le preferenze dei singoli a costi più bassi. Si tratta di una spiegazione che parte dai singoli soggetti
piuttosto che dalle istituzioni che ne condizionano l’azione. Col tempo, i vantaggi del mercato per i
singoli finiscono per far maturare anche quelle motivazioni e quelle istituzioni che sono congruenti
con il buon funzionamento del mercato stesso, e ne accrescono la legittimità.
La legittimità è proprio al centro della spiegazione dei sociologi economici: il mercato, per potersi
affermare come strumento di regolazione dell’economia, deve essere anzitutto socialmente
accettato, ma questo non è un esito scontato. Sombart e Weber, riguardo allo studio sulle origini del
capitalismo in Occidente, si sforzano di mostrare la complessa serie di fattori culturali e istituzionali
che rendono legittimi, incoraggiano e sostengono i rapporti di mercato (religione, stato, diritto,
città, scienza moderna). In altre parti del mondo invece la cultura e le istituzioni si oppongono e
resistono al mercato. Per Durkheim i rapporti di mercato come strumento di organizzazione
dell’economia richiede “certe variazioni dell’ambiente sociale”. Per Polanyi e Marx invece il
processo non è pacifico e può comportare l’uso della forza (enclosures) e del potere politico.
La sociologia economica è più interessata ai problemi dell’equità del mercato reale, mentre
l’economia si concentra su quelli dell’efficienza, dando per scontato che un mercato pienamente
concorrenziale risolverebbe anche problemi di equità (ciascuno avrebbe delle ricompense
4
proporzionali al suo contributo). Quindi per i sociologi i benefici no vanno interpretati solo in
termini di maggiori possibilità di accesso materiale ai beni, ma anche come accresciuta libertà di
scelta sia nell’impiego del proprio lavoro che nel consumo (soprattutto Simmel e Weber).
Non c’è dubbio però, per gli economisti come per i sociologi, che il mercato, una volta affermatosi
come meccanismo di regolazione, tenda progressivamente a ridurre lo spazio di altre istituzioni
nella sfera delle attività economiche: dalla famiglia alla parentela e alla comunità locale, dalle
corporazioni allo stato. Ma fino a che punto i mercato può essere libero da regolamentazioni sociali
e politiche senza che ne venga compromesso il suo stesso funzionamento?
Le condizioni del funzionamento del mercato capitalistico
Sappiamo che nella visione dell’economia neoclassica si suppone l’esistenza di individui ben
informati, moralmente affidabili, e capaci di calcolare razionalmente il modo ottimale di soddisfare
le loro preferenze. Essi si muovono in un contesto di regole fatte dalla piena commerciabilità di tutti
i beni e di tutti i fattori produttivi e dalla presenza di molti venditori e molti acquirenti. In questo
quadro, il ruolo di regole sociali (es. reciprocità) o politiche (come forme di redistribuzione legate
allo stato o alle corporazioni) è visto come un potenziale fattore di distorsione dell’allocazione
razionale delle risorse, e quindi dell’efficienza.
La tradizione della sociologia economica ha sviluppato un metodo più legato all’indagine storicoempirica e dunque problematizza gli assunti a priori della teoria economica. Gli individui non sono
normalmente ben informati e capaci di calcolo razionale, e non sono tutti moralmente affidabili; i
mercati non sono sempre pienamente concorrenziali (es. chi offre lavoro può influire sulle
condizioni a proprio vantaggio). Weber, seguendo Marx, parla infatti di lavoro “formalmente
libero” e di “sfruttamento monopolistico della libertà formale di mercato”.
Quindi la realtà storico-empirica ci porta a sostenere che il mercato può funzionare meglio se ci
sono delle istituzioni che vincolano il perseguimento dell’interesse individuale accrescendo la
legittimità (il grado di accettazione sociale dei rapporti di mercato). Ce ne sono di due tipi:
istituzioni che generano fiducia per via di interazioni personali (famiglia, parentela, comunità) o di
interazioni impersonali (sanzioni giuridiche per chi viola i contratti); istituzioni che riequilibrano i
rapporti di potere sul mercato (es. rapporti squilibrati nel mercato del lavoro possono mettere a
rischio le stesse attività produttive abbassando la produttività dei lavoratori; sono dunque importanti
istituzioni di rappresentanza collettiva dei lavoratori, oppure l’intervento regolativo dello stato sulle
condizioni di lavoro, orari, lavoro minorile, salute, sicurezza; interventi regolativi di redistribuzione
del reddito).
Possiamo concludere dicendo che la tradizione sociologica arriva a una posizione contrastante con
quella dell’economia neoclassica. Poiché nella realtà la presenza delle condizioni assunte dagli
5
economisti è inevitabilmente poco probabile, per funzionare meglio, in termini di efficienza, i
mercati non devono essere il più possibile isolati da condizionamento sociali e politici, ma devono
viceversa essere ben costruiti socialmente. È anche vero che, come sottolineano Weber e
Schumpeter, se tali vincoli eccedono una certa soglia (non definibile in astratto) lo stesso mercato
può deperire come forma di organizzazione economica. Se il peso delle regolamentazioni genera
aspettative negative in chi detiene il controllo dei mezzi di produzione, possono essere
compromessi gli investimenti necessari alla riproduzione delle attività regolate dal mercato. La
preoccupazione degli economisti non va dunque sottovalutata.
Ma per la sociologia economica il problema non va risolto sul piano teorico bensì su quello
empirico. Le forme di legittimazione del mercato possono variare nello spazio e nel tempo; ci sono
società nelle quali la cultura e le istituzioni prevalenti legittimano, o addirittura esigono,
un’autonomia del mercato maggiore ed accettano quindi le conseguenze sociali che possono
derivarne (disuguaglianza sociale, mobilità territoriale). Weber infatti ha indagato sulle specificità
della società occidentale rispetto a quella orientale; ma anche all’interno del contesto occidentale
possiamo distinguere tra società anglosassoni, dove l’autonomia del mercato è più forte (specie
Stati Uniti) e quelle europee, dove si sente l’esigenza di limitare l’autonomia del mercato per
controllarne meglio le conseguenze e per legittimarlo.
Insomma, non c’è una best way, ma ci sono varie strade, tutte condizionate dal contesto sociale.
Soltanto l’indagine empirica comparata può aiutarci a indentificarle e a valutarne i rispettivi punti
di forza e di debolezza.
2.2 Lo sviluppo economico
Nella tradizione della sociologia economica una più solida accettazione sociale del mercato è una
condizione non solo della stabilità, ma anche della crescita di un’economia che si basi sul mercato.
Per spiegare lo sviluppo economico non è sufficiente che il mercato sia legittimato, ma bisogna
valutare in che misura gli attori economici, che si comportano in modo variabile, usino gli scambi
di mercato per creare nuova ricchezza, uscendo dalla routine dei rapporti tradizionali e consolidati;
insomma, è necessario che alla legittimità si affianchi l’innovazione.
Per i classici la capacità innovativa dipende fondamentalmente dall’imprenditorialità (per dirla con
Schumpeter, dalla capacità di realizzare nuovi prodotti, processi, metodi di organizzazione della
produzione, mercati). Schumpeter sottolinea come l’imprenditore sia caratterizzato da qualità
particolari che permettono meglio di misurarsi con i problemi connessi all’innovazione
(determinazione, capacità di visione, impegno, voglia di affermarsi e di riconoscimento sociale).
Non si tratta di perseguimento razionale dell’interesse individuale.
6
In generale, la sociologia economica suggerisce che lo sviluppo dipende, oltre che dal istituzioni
che danno legittimità al mercato, regolando il perseguimento utilitaristico dei mezzi rispetto ai fini,
anche da istituzioni che definiscono i fini stessi dei soggetti.
La religione in Weber e Sombart, l’esclusione dai diritti di cittadinanza in Simmel e Sombart,
l’accesso alle conoscenze tecnologiche in Veblen, sono tutti esempi di questo ruolo costitutivo delle
regole istituzionali, rispetto a quello regolativo delle istituzioni di cui abbiamo prima parlato a
proposito dei problemi di legittimità del mercato, e che riguarda l’uso dei mezzi per il
perseguimento dei fini.
Tuttavia, occorre ricordare che in genere per i classici l’impatto dell’imprenditorialità sulla capacità
di innovazione e quindi sullo sviluppo economico deve essere storicizzato. Essi vedevano, proprio
come conseguenza dello sviluppo del capitalismo, una crescente spersonalizzazione e
burocratizzazione dell’impresa, che spostava dall’imprenditorialità personale alla capacità
organizzativa, la capacità di innovazione.
La tradizione della sociologia economica contribuisce anche a mettere in evidenza un problema
strutturale dell’economia capitalistica: una volta affermatosi, il mercato determina la progressiva
erosione di quelle regole costitutive che inizialmente l’avevano sostenuto (religione, istituzioni o
legami tradizionali, ecc.). Ciò accentua nel tempo i problemi di accettazione sociale delle
conseguenze del mercato e spinge alla crescita di nuove regole regolative (intervento dello stato in
campo economico e sociale, relazione industriali, ecc.). A questo punto si ripresenta quella
possibile contraddizione di cui abbiamo prima parlato: quella tra regolazione istituzionale del
mercato e efficienza; dal punto di vista dinamico, e quindi in termini di sviluppo economico, un
eccesso di regolamentazione può andare a scapito della capacità innovativa. Questa ipotesi, ricavata
dal lavoro dei classici, permette di orientare comparazioni storico-empiriche che affrontano il tema
delle differenze nello spazio e nel tempo dello sviluppo economico.
2.3 Il consumo
Sappiamo che questo fenomeno non era al centro dell’interesse degli economisti classici, la cui
prospettiva era più centrata sulla produzione. Con i neoclassici è invece la domanda dei
consumatori a fondare il valore dei beni attraverso la teoria dell’utilità marginale. Dati i vincoli
costituiti dai prezzi dei beni e dal reddito di cui dispone, il consumatore tenderà a distribuire il suo
potere d’acquisto in modo esattamente proporzionale alle sue preferenze. Assumendo che la
soddisfazione legata a un certo bene diminuisca con il consumo di unità aggiuntive (utilità
marginale), si ipotizza che verrà consumato di più di tale bene fino a quando la soddisfazione
aggiuntiva non uguaglierà quella degli altri beni che si vogliono consumare.
7
La sociologia economica mette in discussione l’atomismo e l’utilitarismo della teoria dell’azione
dei neoclassici e si concentra sui caratteri concreti che viene ad assumere il comportamento dei
consumatori in una società che vede crescere il fenomeno dei consumi di massa, in parallelo con lo
sviluppo economico e il miglioramento dei redditi. L’attenzione va subito verso i fattori
socioculturali che condizionano le preferenze degli individui. I beni sono desiderati e consumati in
misura crescente per il loro valore simbolico, cioè per il significato che essi assumono nei rapporti
con gli altri, come segnali per essere riconosciuti da alcuni soggetti e gruppi sociali con cui ci si
vuole identificare, e per distinguersi al tempo stesso da altri rispetto ai quali si vuole marcare la
propria differenza.
Simmel è tra i primi a rilevare la funzione simbolica dei consumi in una competizione per acquisire
maggiore prestigio specie nelle grandi città in crescita. Egli parla della moda che ha una duplice
finalità: identificarsi con altri gruppi sociali e distinguersi da altri gruppi sociali.
Weber lega i comportamenti di consumo alla ricerca di status tipica dei ceti 8es. liberi
professionisti, intellettuali, militari, ecc.). Anche Veblen, con la sua analisi del consumo vistoso,
lega il fenomeno a una competizione per lo status sociale. Studiando gli Stati Uniti egli sottolinea
come l’accesso crescente ai consumi di massa sia uno strumento essenziale di integrazione dei
gruppi sociali più svantaggiati. Ma questo si accompagna, a suo avviso, ad uno spreco di risorse
produttive che, lungi dall’incrementare l’effettiva utilità dei singoli consumatori, li porta a spendere
il loro reddito in beni futili, scelti per il loro valore simbolico di segni di status. Il modello
neoclassico verrebbe così smentito dalla rigidità sociale del comportamento di consumo (es. un
aumento di prezzo di un bene può non dar luogo a minor consumo se il bene ha un valore simbolico
elevato o viceversa).
Bisogna comunque dire che le imprese, per mezzo della pubblicità, riescono ad influenzare la
moda, e quindi creare un mercato di massa che consente l’impiego di nuove tecnologie e la
realizzazione di economie di scala. Questo porta all’uniformazione dei bisogni”, di cui parla
Sombart, rafforzandosi la produzione di beni di qualità inferiore che imitano le mode dei gruppi più
benestanti e vengono offerti ai consumatori a più basso reddito. Per i sociologi economici quindi
anche l’efficienza è costruita socialmente: solo se ci sono istituzioni che migliorano le conoscenze
condizionando il comportamento delle imprese ed educando il consumatore ad organizzarsi e a
diffondere modelli di consumo accettati in modo più consapevole, solo in questo modo i
consumatori possono scegliere meglio e quindi possono esercitare la loro influenza positiva
sull’efficienza delle imprese. È quindi un fenomeno variabile che va studiato con un’ottica storicoempirica e con un metodo comparato.
3. LA RIDEFINIZIONE DEI CONFINI TRA ECONOMIA E SOCIOLOGIA
8
I lavori di Schumpeter e Polanyi segnano uno spartiacque negli sviluppi della sociologia
economica: prima i classici studiavano le origini del capitalismo, nel secondo dopoguerra invece si
va verso una specializzazione tematica e disciplinare. Si possono intravedere due principali
evoluzioni:
-
il tema dello sviluppo economico perde rilevanza nello studio dei paesi più avanzati
dell’Occidente a favore delle tematiche macroeconomiche che vengono recuperate e
solidamente rielaborate dalla nuova economia keynesiana (rimane invece per lo studio dei paesi
più arretrati);
-
le
tematiche
più
macroeconomiche
(che
i
classici
studiavano
insieme
a
quelle
macroeconomiche) si autonomizzano maggiormente dal nucleo originario della sociologia
economica (sociologia industriale, sociologia del lavoro, sociologia dell’organizzazione,
relazioni industriali, ecc.).
Si assiste anche alla ridefinizione dei confini tra economia e sociologia: da un lato, l’economia
recupera capacità di aderenza alla realtà storico-empirica (specie con la “rivoluzione keynesiana”);
dall’altro, il processo di istituzionalizzazione della sociologia spinge in generale gli studiosi verso
aree meno presidiate dagli economisti e incoraggia, più in particolare, la frammentazione e la
specializzazione disciplinare della sociologia economica secondo le linee prima ricordate.
3.1 La stabilizzazione economica e sociale nel dopoguerra
Dal secondo dopoguerra fino agli anni ’70 si assiste ad una straordinaria crescita economica (molto
più che tra la prima e la seconda guerra mondiale). Un fattore che ebbe un peso rilevante su questo
esito riguarda anzitutto la politica di aiuti americani all’Europa. I paesi europei, vinti e vincitori,
erano in ginocchio e gli Stati Uniti cancellarono una parte consistente del debito degli alleati e, con
il Piano Marshall, inviarono un rilevante flusso di aiuti finanziari (anche per la Germania non
richiesero risarcimenti non sopportabili, come avvenne dopo la prima guerra). La crescita della
produzione poté valersi di una progressiva liberalizzazione degli scambi e quindi di un consistente
incremento del commercio internazionale, oltre che degli accordi per la stabilizzazione dei cambi.
Questo processo fu accompagnato da un’intensa cooperazione internazionale che portò alla
creazione di nuovi organismi (es. FMI, OCSE, CEE). Con l’utilizzo delle tecnologie moderne per la
produzione di massa di beni di consumo (automobili, elettrodomestici) la domanda di beni si alzò
notevolmente grazie anche ad un’ampia offerta di lavoro proveniente dai settori a bassa
produttività, in particolare dall'agricoltura. Tale manodopera poteva essere utilizzata anche nelle
industrie più moderne grazie all’organizzazione di tipo taylorista che permetteva di dividere e
semplificare le mansioni lavorative. Oltre a queste variabili vanno considerati i mutamenti che
intervengono nella regolazione istituzionale delle economie dei paesi più sviluppati che consiste
9
nella grande trasformazione che Polanyi aveva intravisto come reazione alla crisi degli anni ’30.
Lo sviluppo postbellico avvenne all’insegna di un crescente interventismo pubblico nell’economia e
nella società e di una crescente burocratizzazione e organizzazione delle grandi imprese più
moderne.
Possiamo servirci di una sintesi che Shonfield (1965) fece per mettere in luce i principali mutamenti
che caratterizzano il capitalismo regolato del secondo dopoguerra:
-
accresciuta influenza dello stato nella regolazione dell’economia e nel mantenimento del pieno
impiego, che va oltre al quadro di Keynes (esso si preoccupava soprattutto di realizzare il pieno
impiego di risorse date per dare una risposta alla Grande Depressione mentre i governi dei paesi
occidentali, nel dopoguerra, promuovono la crescita mediante la pianificazione dell’economia e
la redistribuzione attraverso i sistemi di welfare);
-
burocratizzazione delle corporations: si formano le grandi imprese orientate a stabilizzare i
loro profitti a lungo termine per ammortizzare gli ingenti investimenti di capitale necessari per
la produzione (si diffonde quindi la pianificazione anche nel settore privato); i governi spingono
le grandi imprese a collaborare tra loro e con le autorità pubbliche per il raggiungimento di
obiettivi a più lungo termine.
È l’integrazione tra uno stato interventista, più tardi chiamato “stato sociale keynesiano”, e le
grandi imprese poi definite “fordiste” ad assicurare il grande sviluppo postbellico. Il primo con le
sue politiche fiscali, monetarie e sociali regola la domanda, sostiene l’occupazione e stabilizza il
mercato per le grandi imprese che a loro volta possono sfruttare il potenziale tecnologico per
realizzare economie di scala nella produzione di massa di beni di consumo. Uno studioso l’ha
definito un compromesso storico.
3.2 I cambiamenti dell’economia e la “rivoluzione keynesiana
Il secondo aspetto che dobbiamo considerare, per interpretare l’evoluzione della sociologia
economica nel secondo dopoguerra, riguarda gli sviluppi interni all’economia e alla sociologia che
influiscono sulla ridefinizione dei loro confini.
Un primo mutamento importante riguarda l’indagine economica, che a partire dagli anni ’30 cerca
di ridurre lo scarto tra i modelli analitici e la realtà storico-empirica. A livello microeconomico la
teoria neoclassica tradizionale prendeva in considerazione l’esistenza di due strutture ideali di
mercato, la concorrenza perfetta ed il monopolio. Queste configurazioni apparivano tuttavia poco
adatte a descrivere la realtà concreta dei mercati. Da qui il nuovo interesse per forme di mercato
definite come concorrenza imperfetta (dovuta alla Robinson 1933) e concorrenza monopolistica
(dovuta a Chamberlin 1933). La Robinson sottolinea che i consumatori non necessariamente
rispondono in modo analogo a differenze di prezzo nei prodotti perché essi tengono conto di vari
10
fattori tra cui la localizzazione del venditore e i costi di trasporto, le garanzie sul piano della qualità
o le condizioni di vendita. Chamberlin, a sua volta, punta decisamente sulla differenziazione del
prodotto come risorsa attraverso la quale le imprese possono in parte sottrarsi alla concorrenza
determinando una segmentazione del mercato. Quest’ultimo, spostando l’attenzione dal mercato
all’impresa, apre la strada per un approccio allo studio empirico delle aziende e delle forme di
organizzazione industriale che avrà notevoli sviluppi successivi (Chamberlin preparò una
rivoluzione nella microeconomia, proprio negli stessi termini in cui si parla di una rivoluzione
keynesiana per la macroeconomia.
Non c’è dubbio che la sociologia economica dovrà misurarsi, la partire dagli anni ’30 e poi nel
dopoguerra, con lo sviluppo di studi economici più empiricamente orientati anche a livello micro;
con un approccio che mette maggiormente a fuoco non solo il funzionamento concreto dei mercati,
ma anche delle aziende.
Ma ciò che ha avuto più influenza sul piano teorico e pratico, nel quarantennio che va dalla fine
degli anni ’30 agli inizi dei ’70, è costituito dall’opera dell’economista inglese John Maynard
Keynes (1883 – 1946). La necessità di misurarsi con gli effetti drammatici della Grande
Depressione degli anni ’30 aveva spinto a rompere con l’ortodossia economica, che confidava nei
meccanismi di riaggiustamento automatico dei mercati. Così in contesti diversi (l’America nel New
Deal di Roosevelt, la Germania nazista di Hitler e la Svezia socialdemocratica) furono sperimentati
rimedi contro la disoccupazione che ruotavano intorno alla spesa statale per opere pubbliche,
sussidi di disoccupazione, nuove forme di protezione sociale. Lo stato aveva assunto un ruolo
interventista e più attivo in campo economico, contravvenendo alle prescrizioni della teoria
economia tradizionale. Keynes diede una solida fondazione teorica a tutto questo con la sua opera
Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta 1936. In una celebre conferenza del
1926 (La fine del laissez faire) sono già presenti chiaramente alcuni presupposti che animeranno la
successiva impresa teorica di Keynes. Egli disse: “molti dei maggiori mali economici del nostro
tempo sono frutto del rischio, dell’incertezza e dell’ignoranza”. Sono queste le cause principali
delle difficoltà che possono limitare il pieno impiego delle risorse produttive e possono causare la
disoccupazione. È proprio per far fronte al problema cruciale degli effetti negativi dell’incertezza
che si deve prevedere un ruolo più rilevante dello stato nella regolazione delle attività economiche
(es. se le aspettative di guadagno sul mercato non sono favorevoli, gli imprenditori investiranno una
quota non sufficiente a garantire il pieno impiego delle risorse e del lavoro). Mentre l’economia
neoclassica si interrogava intorno alla formazione dei prezzi dei beni e alla distribuzione dei redditi
(micro), l’attenzione di Keynes si concentra ora sui fattori che influiscono sul livello della
produzione e dell’occupazione, dato un certo stock di risorse di capitale, di lavoro e di tecnologia
11
(macro). Si nota come Keynes si muova in un quadro statico e di breve periodo. Egli mette in
discussione l’assunto centrale della teoria tradizionale (legge di Say: l’offerta crea sempre la sua
domanda; quale che sia il volume della produzione, il valore della domanda sarà uguale a quello dei
beni prodotti).
Per Keynes la domanda risulta da due componenti:
reddito speso in consumi
+
reddito investito (che deriva dal reddito risparmiato)
La teoria tradizionale invece supponeva l’uguaglianza tra risparmi ed investimenti (cioè che tutti i
risparmi venissero investiti) ma ciò non è sempre vero perché dipende dai tassi di interesse (alti
tassi inibiscono gli investimenti). Ma dobbiamo anche considerare il fatto che la propensione a
consumare diminuisce con il crescere del reddito e che non necessariamente bassi tassi di interesse
favoriscano necessariamente gli investimenti perché gli imprenditori valutano anche altre variabili
come la previsione di aumento della domanda di beni (quindi non si avrebbe nemmeno in questo
caso il pieno utilizzo delle risorse disponibili e quindi la garanzia di piena occupazione). Infine è da
considerare che, anche ammesso che i lavoratori siano disponibili ad accettare una riduzione dei
salari, ciò non sarebbe necessariamente vantaggioso per la ripresa dell’economia, come riteneva la
teoria tradizionale, perché avrebbe influito negativamente sulla domanda di consumo e avrebbe
quindi rafforzato le aspettative sfavorevoli degli imprenditori. Ma Keynes, pur riconoscendo che i
salari tendono a essere rigidi perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali si oppongono a
riduzioni delle retribuzioni anche in situazioni di crisi economica, non fonda la sua analisi su questo
aspetto. Egli vuole dimostrare che, seguendo i rimedi della teoria tradizionale che suggeriva in caso
di depressione il calo dei salari e dei tassi di interesse, si poteva in realtà determinare un equilibrio
di sotto-occupazione (una sorta di trappola nella quale il sistema economico rischiava di avvitarsi
senza un intervento dello stato). Ma lo stato deve intervenire, in quelle situazioni in cui le
aspettative imprenditoriali sono incerte, con la spesa pubblica colmando la differenza e
promuovendo quindi il pieno impiego.
Mentre la teoria economica tradizionale dava una giustificazione teorica al liberismo, l’analisi
keynesiana dà fondamento all’interventismo dello stato come regolatore della domanda .
Sono da ricordare alcuni aspetti delle nuove politiche economiche.
La spesa pubblica in disavanzo (deficit spending): la spesa pubblica è tanto più efficace quanto più
tende a stimolare una domanda aggiuntiva (Keynes fa l’esempio che sarebbe efficace per la ripresa
economica anche fare scavare delle buche per poi farle riempire). Vi è inoltre il problema che al
12
crescere del reddito si consuma meno e ciò significa che possono essere giustificati anche interventi
redistributivi dello stato (es. politica fiscale) a favore dei gruppi più poveri della popolazione
proprio al fine di stimolare la domanda. In altre parole, la redistribuzione può essere giustificata non
solo in relazione a problemi di equità ma anche di efficienza del sistema economico.
Come abbiamo già rilevato, l’economia keynesiana si basa sul breve periodo e considera data la
capacità produttiva. Ben presto però economisti influenzati dalle nuove idee cominciarono a
esplorare le implicazioni in termini dinamici e a porsi il problema della crescita economica (es. il
modello Harrod-Domar). Tali modelli hanno l’obiettivo di guidare le scelte dei governi non solo per
raggiungere il pieno impiego di risorse esistenti, ma anche per determinare gli obiettivi di crescita
economica nel tempo.
La modellistica macroeconomica si lega strettamente all’utilizzo dell’analisi matematica e delle
tecniche statistiche che sono affinate dall’econometria. Questo approccio permette infatti di
stabilire i rapporti di interdipendenza funzionale tra le diverse grandezze economiche (reddito,
consumi, risparmi, investimenti, ecc.) e di formulare anche previsioni sul loro andamento nel
tempo, date certe condizioni conosciute.
La macroeconomia keynesiana si pone dunque come interpretazione e guida del processo di
sviluppo, specie nei paesi avanzati.
3.3 Talcott Parsons e i nuovi confini
Negli stessi anni ’30 nei quali Keynes lavorava alla Teoria generale, Talcott Parsons (1902 –
1979) maturava la sua concezione del ruolo della sociologia (La struttura dell’azione sociale 1937).
Egli aveva iniziato la sua carriera studiando economia oltre che biologia ed avrà una grande
influenza sia sugli sviluppi dell’analisi sociologica, sia sulla questione della definizione dei confini
tra economia e sociologia.
Parsons critica l’economia neoclassica per il suo individualismo atomistico, cioè il fatto che
presuppone che gli individui definiscano i propri fini indipendentemente dall’interazione tra loro.
Egli sostiene che se non è all’opera qualche fattore che introduca elementi di coerenza, di
coordinamento e di integrazione tra i fini dei diversi individui, la società rischia di essere “un mero
caos di individui in conflitto tra loro”. Lo scopo della sociologia è proprio lo studio dei fini
condivisi, cioè dei valori comuni che orientano l’azione all’interno di una società.
Le leggi economiche hanno un carattere normativo, indicano dei criteri di azione razionale date
certe condizioni; ma la loro validità empirica è legata al fatto che gli attori si comportino
effettivamente secondo tali criteri per soddisfare i loro fini (secondo Parsons e Weber ciò è poco
probabile).
13
Quindi Parsons difende l’economia per la sua validità scientifica come disciplina analitica (così
come Menger, Pareto e Weber).
Parsons passa in rassegna tutti i tentativi di spiegazione teorica completa delle attività economiche
concrete e li raggruppa in due filoni:
-
empiricismo positivista: sviluppatosi maggiormente nel contesto anglosassone; tratta dei
condizionamenti dell’azione economica esercitati da fattori biologici o psicologici (es.
l’edonismo psicologico di Bentham, la teoria degli istinti di Veblen). Questo filone sfocerà poi
nel comportamentismo (behaviorism), cioè il approcci che tendono a svalutare il ruolo di fattori
ideali (valori, norme) nel comportamento dell’attore;
-
empiricismo storicista: qui vi è invece attenzione ai fattori ideali e normativi, per esempio con
il concetto di “spirito del popolo”.
Parsons respinge sia la soluzione istituzionalista à la Veblen, sia quella storicista in quanto
entrambe riducono l’economia a una “branca della sociologia applicata”, nel tentativo di aggiungere
altri fattori per arricchire la spiegazione empirica del comportamento economico. La sociologia
diventerebbe una sorta di “sociologia enciclopedica”, come sintesi generale delle conoscenze sulla
società. In questa prospettiva, un economista si distinguerebbe da altri scienziati sociali solo per la
maggiore conoscenza di un settore specifico delle attività sociali, quello legato all’economia.
Questa impostazione per Parsons è sbagliata, bisogna quindi lavorare a una fondazione diversa delle
due discipline. La soluzione più convincente emerge, a suo avviso, da autori essenziali per la
fondazione della sociologia (Durkheim, Pareto e Weber); essi condividono una fondazione su basi
analitiche e astratte dell’economia e della sociologia. La prima deve essere concepita come teoria
analitica di un fattore dell’azione che si basa sul perseguimento razionale dell’interesse individuale
(si occupa della catena mezzi-fini, cioè dell’adattamento razionale di mezzi scarsi rispetto a usi
alternativi); la seconda invece come teoria analitica astratta di un altro fattore dell’azione, quello
legato ai valori ultimi condivisi (la coscienza collettiva di Durkheim, le azioni non-logiche di
Pareto, l’etica influenzata da fattori religiosi di Weber).
Parsons avrebbe poco dopo presentato in modo sistematico e approfondito questa tesi in La
struttura dell’azione sociale, con la formulazione della sua teoria volontaristica dell’azione.
Lo studioso americano è consapevole è ben consapevole che la realtà storico-empirica è unitaria e
non può essere divisa in compartimenti; ciò non vuol dire che l’astrazione analitica è importante per
coltivare il fuoco centrale di interesse di una disciplina a livello teorico, ma le esigenze della ricerca
concreta sono tali che lo scienziato deve inevitabilmente avventurarsi in più direzioni. È chiara
dunque in Parsons la distinzione tra il momento teorico, in cui ciascuna disciplina approfondisce in
termini di modelli analitici astratti il suo fattore fondamentale, in isolamento da altri, e il momento
14
della ricerca sulla realtà empirica concreta, in cui bisogna invece uscire dai confini disciplinari e
cercare di esaminare come diversi fattori si combinino insieme.
Parsons lavorerà per la fondazione a livello teorico della sociologia; egli riteneva pericolosa la
strada dell’istituzionalismo à la Veblen e riteneva molto debole in generale la sociologia americana
dell’epoca basata sull’empiricismo positivista.
L’obiettivo di spostare la sociologia verso la teoria generale sarebbe da lui stato perseguito con
impegno e con notevoli risultati. La sua influenza sulla sociologia americana e su quella
internazionale è cresciuta nel secondo dopoguerra dopo la pubblicazione de Il sistema sociale
(1951) e di altri lavori importanti. Si ebbe un effetto non intenzionale di spostare gli interessi della
comunità sociologica verso temi più lontani dalla sociologia economica (studio delle istituzioni in
isolamento da altri fattori: socializzazione, controllo sociale, devianza, ecc.).
A livello macro il tema dello sviluppo veniva prevalentemente trattato dalla nuova macroeconomia
keynesiana mentre a livello micro si afferma la tendenza alla specializzazione disciplinare di
prospettive di indagine prima incluse nella sociologia economica classica (studi organizzativi,
sociologia industriale e del lavoro, e delle relazioni industriali).
Con l’opera Economia e società (1956) che Parsons scrisse insieme a Neil Smelser, essi illustrano
la teoria dei sistemi sociali applicandola al caso dell’economia.
Secondo questa teoria la società è vista come un sistema di parti interdipendenti (strutture) che per
riprodursi deve assolvere a quattro funzioni:
1) adattamento: mediante l’attività economica si risolve il problema di procurarsi dall’ambiente
risorse sufficienti in termini di beni e servizi per la riproduzione della società;
2) conseguimento dei fini: mediante il sistema politico si motivano gli individui trasmettendo loro
valori e norme;
3) latenza: famiglia, religione, scuola permettono l’assimilazione dei valori e delle norme;
4) integrazione: presiede alla stratificazione sociale, alla distribuzione delle ricompense e alla
prevenzione dei conflitti.
Parsons e Smelser cercano quindi di illustrare gli scambi complessi che avvengono tra l’economia e
le altre strutture ma nonostante l’analisi sia interessante nel sottolineare gli aspetti di
interdipendenza tra economia e società, essa resta a un livello di elevata astrazione analitica e soffre
di una complessa articolazione concettuale e di un pesante apparato classificatorio, con notevoli
complicazioni legate anche al tentativo di replicare lo schema dei diversi imperativi funzionali
all’interno di ciascun sottosistema (quindi anche dentro l’economia). Invece di rilanciare la
sociologia economica e contribuire a una maggiore integrazione fra teoria economica e sociologia,
15
Economia e società restò dunque un lavoro isolato, che non suscitò interesse tra gli economisti e
non alterò sostanzialmente l’allontanamento dei sociologi dai temi dell’economia.
Paradossalmente, mentre l’economia con Keynes cercava di recuperare adesione alla realtà
empirica e alle sue trasformazioni, la sociologia non metteva in discussione l’economia neoclassica
e si allontanava dall’indagine sulla realtà economica (con l’eccezione dello sviluppo dei paesi
arretrati che vedremo avanti). La nuova definizione dei confini tra economia e sociologia che prese
corpo tra gli anni ’30 e il dopoguerra finì dunque per agire nella stessa direzione dei cambiamenti
economico-sociali prima ricordati. Il risultato fu un declino della tradizione della sociologia
economica nello studio dei paesi sviluppati che durerà fino agli anni ’70.
16
CAPITOLO 2
LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE AREE ARRETRATE
In questo capitolo ripercorreremo i diversi approcci che affrontano il problema dello sviluppo dei
paesi arretrati. Un primo nucleo importante si forma con la teoria della modernizzazione, che insiste
sui fattori socio culturali, ma propone anche un’idea di modernità fortemente legata ai percorsi della
civiltà occidentale. Le critiche a questa teoria porranno in rilievo aspetti diversi: i condizionamenti
economici, con la teoria della dipendenza, e più di recente quelli politici, con la nuova political
economy comparata.
Nel secondo dopoguerra, l’interesse della sociologia economica per il ruolo della cultura e dei
fattori istituzionali nel processo di sviluppo economico trova un terreno più favorevole soprattutto
nello studio dei paesi e delle aree arretrate. Si alimenta così una nuova sociologia dello sviluppo. In
seguito al processo di decolonizzazione si formano molti stati indipendenti che sono fuori dai
confini dell’Occidente e che si trovano ad affrontare i problemi della crescita economica e della
costruzione di strutture istituzionali adeguate. La contrapposizione tra i due blocchi (guerra fredda)
portano gli Stati Uniti e i paesi del blocco occidentale a sostenere lo sviluppo economico dei nuovi
stati per evitare che questi cadano sotto l’influenza dell’Unione Sovietica. Anche i nuovi organismi
internazionali che si formano dopo la guerra concorrono al sostegno dei paesi arretrati.
In questo periodo l’economia era fortemente influenzata dalla rivoluzione keynesiana che
sottolineava l’importanza dell’intervento statale e degli aiuti internazionali per avviare il processo
di industrializzazioni. I primi passi della sociologia dello sviluppo, cercano di integrare il punto di
vista degli economisti, sottolineando l’importanza di fattori culturali e istituzionali come elementi
che condizionano la possibilità di successo di politiche economiche a sostegno dello sviluppo.
In questo quadro prende forma un indirizzo che va sotto il nome di teoria della modernizzazione
che contiene al suo interno diversi approcci:
1) teoria della modernizzazione in senso stretto (anni ’50 – ’60): sottolinea l’importanza dei
fattori socioculturali e politici endogeni dei paesi meno sviluppati nel condizionare il
cambiamento sociale;
2) teoria della dipendenza: fa particolare riferimento ai paesi dell’America Latina ed ai
condizionamenti economici esercitati dai paesi più sviluppati sul cambiamento di quelli
arretrati;
3) political economy comparata: al centro della sua attenzione è il ruolo delle istituzioni politiche
nel processo di modernizzazione, anche attraverso un confronto tra i paesi asiatici e quelli
dell’America Latina.
17
Le critiche portate alla teoria della modernizzazione degli anni ’60 (dall’approccio della
dipendenza; dalla sociologia storica della modernizzazione delle società occidentali) hanno
stimolato un processo di revisione degli assunti originari. Il nuovo approccio sottolinea la pluralità
dei percorsi di modernizzazione, il loro carattere più aperto, che non ha come sbocco inevitabile la
strada seguita dall’Occidente (lo vedremo nell’ultima parte del capitolo).
1. LA TEORIA DELLA MODERNIZZAZIONE
L’approccio sistemico allo studio della società elaborato da Parsons, sebbene abbia trattato solo
marginalmente il problema dello sviluppo dei paesi arretrati, ha costituito il principale serbatoio di
strumenti concettuali che sono stati utilizzati in forme diverse nell’ambito degli studi riconducibili
alla prima teoria della modernizzazione.
Il nucleo comune di questi studi è l’idea che i paesi economicamente arretrati siano caratterizzati da
un modello di società tradizionale, costituito da un sistema di elementi culturali e strutturali tra loro
strettamente interdipendenti. La forza di resistenza della tradizione, a livello culturale, strutturale e
della personalità, costituisce l’ostacolo primario che è necessario sperare per procedere sulla strada
dello sviluppo economico e avvicinarsi al modello della società moderna riscontrabile nei paesi
sviluppati dell’Occidente. Gli studi sulla modernizzazione si distinguono poi per il modo di
concepire tale passaggio, che sempre considerato auspicabile, e alla lunga inevitabile.
1.1 Approcci influenzati dallo struttural-funzionalismo
Hoselitz (1960) e Levy (1966) sono stati tra i primi a muoversi in questa direzione e sottolineano
come lo sviluppo economico dei paesi arretrati sia condizionato da aspetti relativi alla cultura e alla
struttura sociale (usano le variabili di Parsons). Alcuni orientamenti culturali delle società
tradizionali ostacolano lo sviluppo. Prevalgono le norme che fanno dipendere le relazioni
economiche dall’ascrizione piuttosto che dal principio di prestazione (es. certe posizioni lavorative
sono assegnate in base a criteri di appartenenza a un determinato gruppo piuttosto che sulla base
della capacità di svolgere un certo compito). Le società tradizionali sono orientata più al
particolarismo rispetto all’universalismo (non si applicano criteri che abbiano validità generale). E
ancora, gli orientamenti culturali prevalenti non incoraggiano la specializzazione e di conseguenza
non cresce la produttività. I modelli culturali prevalenti di tali paesi hanno un orientamento
tradizionalistico e non razionalistico come le società moderne.
Da cosa dipende allora l’avvio della modernizzazione?
In generale l’attenzione è posta sul formarsi di nuove élite intellettuali, politiche e economiche che
introducono innovazioni rispetto ai modelli tradizionali. Hoselitz insiste maggiormente sulla
crescita dell’imprenditorialità dal basso richiamando la teoria della marginalità sociale di Simmel e
Sombart (stranieri, immigrati o appartenenti a una religione diversa da quella dominante, saranno
18
più propensi a innovare sul piano economico). Gli altri autori invece si basano sulla formazione di
nuove élite che assumono un ruolo guida sul piano politico (i maggiori contatti tra le società
moderne e quelle tradizionali diffondono aspirazioni a modernizzare per accrescere il benessere
economico).
Un modello più sistematico richiama il concetto di differenziazione strutturale che sposta
l’attenzione dagli attori (élite politiche o economiche) ai problemi strutturali che ne condizionano
l’azione. Per esempio, nelle società tradizionali le attività economiche sono scarsamente
differenziate da quelle familiari o parentali, mentre quando si avvia la modernizzazione la famiglia
perde le funzioni economiche e si diffondono imprese che utilizzano forza lavoro salariata e
lavorano per il mercato piuttosto che per l’autoconsumo familiare (divisione del lavoro = più
efficienza = più differenziazione di classe = allentamento dei criteri ascrittivi a favore del principio
di prestazione). Si riducono le famiglie estese a favore di quelle nucleari che hanno minor controllo
sociale tradizionale sulle scelte individuali. Tuttavia l’indebolimento dei modelli culturali e delle
strutture sociali tradizionali genera situazioni conflittuali da parte di quelle persone che non sono
state efficacemente integrate nella nuova situazione. In questa situazione i teorici della
modernizzazione considerano inevitabile un ruolo maggiore dello stato nel processo di sviluppo per
controllare i conflitti indotti dalla modernizzazione (e non per promuovere le attività economiche e
l’industrializzazione, come in Occidente). Tale ruolo dello stato potrà essere più efficace nella
misura in cui riusciranno ad affermarsi nuove élite politiche capaci di ottenere una forte
legittimazione, attraverso ideologie nazionaliste che si sostituiscano alle vecchie credenze religiose
come base di un sistema di valori condiviso dalla popolazione (se questo non funziona si può
considerare probabile un’alternativa di tipo socialista).
Anche gli studiosi provenienti dal campo della scienza politica sono stati influenzati dallo
struttural-funzionalismo. Per loro lo sviluppo politico può avvenire attraverso l’individuazione di
una serie di sfide che il sistema deve affrontare nel corso della modernizzazione:
-
la costruzione dello stato da parte delle élite politiche;
-
la costruzione della nazione (formazione di un’identità nazionale attraverso il superamento degli
orientamenti particolaristici e localistici) da parte di élite legittimate;
-
ottenere una risposta alle nuova domande di partecipazione politica attraverso processi di
democratizzazione;
-
sviluppare interventi atti a rispondere alle domande di maggiore uguaglianza sociale.
Le difficoltà specifiche per i paesi del Terzo Mondo vengono dalla tendenza a sovrapporsi nel
tempo delle diverse sfide, che invece nelle società occidentali si sono manifestate in sequenze più
19
lunghe e scalari. Questo porta ad una forte spinta verso la conflittualità politica e un’accentuata
instabilità di tali paesi.
1.2 La formazione della personalità moderna
Alcuni studi sono stati più influenzati dalla psicologia e dalla psicologia sociale e di distinguono tra
la società tradizionale, quella moderna e quella in transizione.
Daniel Lerner (1958) effettua una ricerca empirica su alcuni paesi del Medio Oriente dalla quale ne
deduce che:
-
il contatto con le società occidentali stimola il cambiamento e spinge nuove élite a
modernizzare;
-
si innesca un processo che è stato già seguito dalle società occidentali con sequenze uguali per
tutto il continente;
-
crescita dell’urbanizzazione;
-
stimolo dell’alfabetizzazione;
-
diffusione dei mezzi di comunicazione di massa;
-
propensione alla mobilità che chiama personalità mobile, caratterizzata da razionalità e
empatia, cioè capacità di identificarsi con gi altri e desiderio di essere simili a loro migliorando
la propria posizione;
-
spinta ad una maggiore partecipazione economica e politica.
Nell’ottica di Lerner la formazione di una personalità moderna è vista essenzialmente come un
processo di socializzazione secondario, in cui molto importante è il ruolo dell’istruzione e dei
mezzi di comunicazione di massa come “moltiplicatori di empatia”.
David McClelland (1961) pone maggiore attenzione al processo di socializzazione primaria che
avviene nei primi anni di vita e coinvolge maggiormente la famiglia. Influenzato dalla ricerca di
Weber sui rapporti tra protestantesimo e spirito del capitalismo egli la reinterpreta sottolineando
come il protestantesimo avesse contribuito a generare una forte motivazione all’impegno
individuale, una spinta a far bene i propri compiti. Per lui lo sviluppo economico sarebbe
condizionato dalla presenza in una determinata società di personalità individuali caratterizzate da
un forte bisogno di realizzazione. L’impegno nel lavoro non rappresenta soltanto la ricerca di
remunerazioni meramente monetarie e questo alimenta l’imprenditorialità e quindi lo sviluppo
economico. McClelland sottopone a verifica l’ipotesi che il bisogno di realizzazione sia collegato a
delle caratteristiche particolari del processo di socializzazione primaria (laddove i genitori
stimolano i loro figli, nella prima infanzia, ad essere autonomi e ad avere fiducia nelle proprie
forze, tende a formarsi un più alto bisogno di realizzazione nei ragazzi.
20
Everett Hagen (1962): i meccanismi di socializzazione primaria nel contesto tradizionale tendono a
scoraggiare la formazione di una personalità innovativa e favoriscono piuttosto una personalità
autoritaria (il bambino percepisce il mondo esterno come arbitrario e privo di un ordine
controllabile quindi si abitua a impostare le relazioni sociali in termini di accettazione acritica della
gerarchia sociale e dell’autorità); l’opposto accade nei contesti moderni dove un atteggiamento dei
genitori (come descritto da McClelland) stimola nel bambino un’ansietà creativa cioè una spinta a
cercare di controllare razionalmente la realtà per cui da qui uscirà una personalità più aperta
all’innovazione e all’imprenditorialità.
Aleax Inkeles e Davis Smith (1974) sviluppano una ricerca sui paesi del Terzo Mondo vicina a
quella condotta da Lerner: la personalità moderna (apertura all’innovazione, razionalizzazione del
comportamento, apprezzamento dell’istruzione e della tecnica) tende ad essere maggiormente
associata all’influenza che esercitano sui soggetti alcune esperienze essenziali come la
partecipazione scolastica, l’occupazione nel settore industriale, l’esposizione ai mezzi di
comunicazione di massa, la vita urbana. Gli autori ne traggono la conclusione ottimistica che la
capacità dei paesi in via di sviluppo di potenziare il ruolo di queste istituzioni abbia rilevanti
conseguenze sulla personalità e quindi sul passaggio verso la società moderna.
1.3 Gli stadi di sviluppo e la convergenza
Walt Rostow (1960) elabora una sequenza degli stadi di sviluppo, più dettagliata e complessa di
quelle diffuse in letteratura (che in genere distinguono solo tra società tradizionale, di transizione e
moderna), che comprende 5 stadi:
-
la società tradizionale;
-
le precondizioni per il decollo;
-
il decollo economico;
-
la spinta verso la maturità;
-
la fase degli elevati consumi di massa.
Di particolare interesse per Rostow è lo stadio di preparazione al decollo industriale. Per l’avvio di
tale fase è necessaria l’intrusione delle società più sviluppate in quelle arretrate (sia per
occupazione militare che indirettamente attraverso una maggiore apertura a contatti economici e
culturali). Il nazionalismo reattivo, stimolato da appunto dall’intrusione della società moderna, è
l’elemento più potente che avvia il processo di superamento della società tradizionale. Le nuove
élite politiche e lo stato svolgono un ruolo essenziale per il decollo (trasformazione dell’agricoltura,
formazione di un mercato nazionale, creazione di un sistema fiscale, istruzione). Tutto ciò comporta
la capacità di affrontare quei complessi problemi di costruzione dello stato e della nazione, e di
legittimazione della classe politica che abbiamo già visto.
21
Rispetto all’esperienza europea originaria per il Terzo Mondo vi sono però dei vantaggi
(disponibilità di nuove tecnologie, disponibilità di prestiti internazionali a condizioni favorevoli)
ma anche degli svantaggi (i progressi nel campo della medicina riducono il tasso di mortalità per
cui aumenta la popolazione, aumenta la disoccupazione e la frustrazione per coloro che hanno
ormai un tenore di vita rivolto a maggiori consumi ma che non possono permetterselo. A volte tale
situazione può portare gli intellettuali verso soluzioni di tipo comunista. Quindi la strada verso
l’industrializzazione ha dei passaggi obbligati dal punto di vista economico ma le strutture
istituzionali possono essere differenti (comunismo o nazionalismo) finché, una volta
industrializzati, vi è una tendenza delle società industriali ad avvicinare il modello comunista a
quello del capitalismo democratico.
Clark Kerr (1960) parla dei vincoli posti dalla tecnologia. Esiste un’unica tecnologia in grado di
assicurare i risultati più efficienti dal punto di vista economico-produttivo, e ciò spinge le diverse
società ad acquisirla, organizzandosi dal punto di vista istituzionale in modo da poterla sfruttare
meglio. Questo favorisce la convergenza istituzionale: laddove il mercato ha un’influenza maggiore
si cerca di ridurlo; all’opposto, laddove è maggiore il controllo statale sull’economia (comunismo e
nazionalismo) i cerca di ridurlo. L’industrializzazione spingerebbe verso un pluralismo economico
e sociale nel quale crescono le classi medie, diminuisce il conflitto, si formano una pluralità di
interessi economici e sociali che influenzano il processo politico, si attenuano le grandi ideologie,
rigide e totalizzanti.
2. CRITICHE: LA TEORIA DELLA DIPENDENZA E LA SOCIOLOGIA STORICA
Verso la fine degli anni ’60 la teoria della modernizzazione è stata sottoposta a varie critiche.
Abbiamo visto come non esista una vera e propria teoria della modernizzazione ma piuttosto diversi
approcci che hanno in comune i seguenti elementi:
1) la concezione ottimistica dello sviluppo, come processo inevitabile e unilineare che tende a
seguire gli stadi già percorsi dalle società occidentali, arrivando in futuro ad una convergenza
istituzionale;
2) la considerazione dei modelli idealtipici di società tradizionale e moderna come contrapposti,
costituiti da un insieme di elementi tra loro strettamente interdipendenti;
3) l’idea che i rapporti che le aree e i paesi arretrati stabiliscono con l’esterno abbiano una
connotazione positiva, in termini di stimolo allo sviluppo;
4) l’assunto che il motore del cambiamento sia essenzialmente endogeno.
2.1 Inevitabilità dello sviluppo ed etnocentrismo
Sociologi, psicologi sociali e storici economici che sono protagonisti della teoria della
modernizzazione hanno una visione ottimistica dello sviluppo dei paesi arretrati. Tale strada venne
22
tuttavia perseguita più in termini teorici che di ricerca empirica; non vi era una ricerca comparata
sui concreti processi di sviluppo dei paesi arretrati e mancando un’adeguata base di ricerca, essi
finivano per ricorrere inevitabilmente all’esperienza storica delle società occidentali, sia per
definire per contrasto la società tradizionale, sia per tracciare i meccanismi del cambiamento. Vi è
dunque una debolezza empirica, accompagnata da una tendenza a generalizzare partendo
dall’esperienza occidentale. Lo sviluppo non è affatto garantito e ci possono essere fallimenti e
blocchi della modernizzazione. Le critiche investono anche i presupposti di valore della teoria che
ha una visione etnocentrica che porta a considerare l’esperienza occidentale non solo come
inevitabile, ma anche come modello positivo al quale i paesi arretrati dovrebbero adeguarsi per
migliorare le condizioni delle loro società.
2.2 Tradizione e modernità come modelli contrapposti
Un secondo elemento largamente condiviso nei primi studi sulla modernizzazione riguarda la
concezione della società tradizionale e moderna come modelli contrapposti l’uno all’altro, costituiti
di elementi tra loro interdipendenti.
Si sottolinea la notevole varietà sul piano storico-empirico delle società tradizionali e viene messo
in evidenza come elementi culturali e strutturali, sia tradizionali che moderni, sono presenti in varia
misura e in diverse combinazioni non solo nelle società dei paesi non industrializzati, ma anche in
quelle dei paesi sviluppati (es. legami familiari e parentali o credenze religiose persistono e sono
variamente
importanti
nelle
società
moderne;
valori
orientati
alla
realizzazione
e
all’imprenditorialità, o strutture burocratiche che funzionano secondo criteri universalistici, possono
riscontrarsi anche in società tradizionali). Viene messa in discussione anche l’idea della stretta
interdipendenza degli elementi costitutivi dei due modelli; ci può essere insomma una modernità
selettiva, che riguarda i mezzi di comunicazione, o la domanda di consumi, o le strutture militari,
ma può non estendersi alla sfera produttiva o al funzionamento delle istituzioni politiche, ecc.
Processi di modernizzazione di questo tipo sono frequenti sul piano storico-empirico, e non è detto
che portino alla modernità come definita dal modello.
2.3 I condizionamenti economici e l’approccio dipendentista
Veniamo al terzo aspetto: la concezione che i rapporti con l’esterno abbiamo una valenza
prevalentemente positiva e di stimolo alle forze del cambiamento viste come essenzialmente
endogene.
La critica che si fa a questa impostazione è il fatto che il progressivo inserimento nel mercato
internazionale comporta anche dei vincoli per lo sviluppo economico: competere con l’industria dei
paesi più sviluppati comporta maggiori investimenti; i paesi arretrati sono in genere specializzati
nella produzione di materie prime e beni agricoli con manodopera a bassa qualificazione e basso
23
prezzo e finiscono per esportare prodotti a basso costo che vengono scambiati con prodotti ad
elevato costo. Non si formano dunque le risorse di capitale necessarie per lo sviluppo, mentre la
concorrenza delle industrie già consolidate degli altri paesi mette in crisi le attività di tipo
artigianale meno competitive.
L’inserimento nell’economia internazionale è fonte dunque di rilevanti problemi e non solo di
opportunità. Tali problemi sono sottolineati dall’approccio dipendentista che si forma inizialmente
a partire da una riflessione sul fallimento dei tentativi di sviluppo di diversi paesi latino-americani
ma si estende poi a una visione più generale delle periferie nell’ambito della teoria dell’economiamondo di Wallerstein (1974, 1979). Comune a questo approccio è l’idea che l’incremento dei
contatti con i paesi industrializzati invece di favorire lo sviluppo provocasse una situazione di
sottosviluppo (per sottolineare lo sfruttamento da esse subìto da parte delle società centrali).
Vi sono tre meccanismi che determinano una sottrazione di risorse per le aree periferiche:
-
lo scambio ineguale (i paesi sottosviluppati esportano prodotti a prezzi bassi ed importano
prodotti a prezzo elevato);
-
la penetrazione diretta del capitale straniero: si insedia nei paesi sottosviluppati dove la
manodopera costa meno quindi ne trae vantaggi che vengono sottratti ai paesi stessi;
-
ricorso crescente ai prestiti internazionali: che comprime le risorse disponibili per lo sviluppo.
Per quanto riguarda l’America Latina si tende anche a sottolineare il ruolo scarsamente propulsivo
della borghesia nazionale che non essendo in grado di sostenere un progetto di sviluppo autonomo,
di fronte alla situazione di instabilità sociale e politica determinata dallo sviluppo dipendente sono
pronti a sostenere soluzioni autoritarie, con l’aiuto dei militari e dei paesi centrali, anch’essi
interessati al mantenimento dello status quo.
È sentita l’esigenza, anche di alcuni teorici della dipendenza, di un’analisi integrata dello sviluppo
che colleghi vincoli esterni e fattori istituzionali interni, dando più spazio e più autonomia agli
attori politici e alla loro azione.
2.4 La sociologia storica della modernizzazione
Un’altra serie di interventi hanno messo in discussione il modello di cambiamento evoluzionistico
basato sulla differenziazione strutturale che è presente negli approcci influenzati dallo strutturalfunzionalismo. Il processo di differenziazione strutturale consiste nel costituire ruoli e strutture
sociali più differenziate a causa di insoddisfazione crescente per il funzionamento di una
determinata struttura, e quindi una ricerca di maggiore efficienza che si concretizza in una più
elevata specializzazione funzionale delle nuove strutture che sostituiscono la precedente. Il
cambiamento è dunque visto come un processo di adattamento della società, considerata come un
sistema di elementi interdipendenti, rispetto ai problemi posti dall’ambiente fisico e sociale. È
24
possibile individuare dei tipi strutturali più o meno evoluti, al vertice dei quali vi sono le società
moderne occidentali.
Possiamo distinguere tre tipi di critiche rispetto a questi assunti:
1) problemi di integrazione: la differenziazione non necessariamente comporta l’incremento atteso
di efficienza perché può accompagnarsi a problemi di integrazione che determinano fenomeni di
instabilità e di blocco della modernizzazione;
2) capacità di adattamento: non si possono individuare stadi di sviluppo basati su un grado
maggiore o minore di adattamento perché non si possono conoscere a priori i problemi futuri
con cui le società devono confrontarsi. È quindi da escludere la possibilità che si possano
stabilire gerarchie di avanzamento, o stadi di sviluppo, sulla base delle caratteristiche strutturali
di ogni società;
3) rapporti tra la società e l’ambiente esterno: il cambiamento non è un processo soltanto
endogeno di adattamento ma è condizionato dai rapporti tra la società e l’ambiente esterno; un
ambiente che muta continuamente con lo sviluppo storico e che pone vincoli e opportunità
diversi da quelli del passato alle singole società. Gli stimoli che vengono dall’ambiente esterno
non sono solo positivi, come sostengono i teorici della modernizzazione (non colgono come
l’ambiente esterno possa portare a reazioni interne nelle società in via di modernizzazione, che
non necessariamente seguono l’esperienza passata delle società occidentali), e non sono solo
negativi, come ritiene l’approccio dipendentista (sono particolarmente attenti ai vincoli
economici che vengono dalla divisione internazionale del lavoro, ma perdono di vista i fattori
endogeni). Il mutamento è invece un processo complesso in cui si intrecciano condizionamenti
provenienti dall’esterno (economici, politici e culturali), eventi contingenti (guerre), e
caratteristiche interne di una determinata società.
In questo quadro è necessario prestare
maggiore attenzione ai soggetti che introducono il cambiamento (élite intellettuali, processi di
mobilitazione politica, intervento dello stato) e non a processi astratti e impersonali di cui parla
l’interpretazione struttural-funzionalista. Questa prospettiva tende dunque a guardare all’analisi
storica comparata per mettere a fuoco i processi specifici di cambiamento per i quali non è
possibile tracciare delle leggi generali.
Possiamo sintetizzare il contenuto delle diverse critiche fatte al modo in cui il processo di
modernizzazione è stato concettualizzato per le società del Terzo Mondo:
1) non c’è un percorso unico, lineare e necessario di modernizzazione. La situazione di partenza, il
percorso, gli esiti del processo sono differenziati. Ciò non porta però a negare la possibilità di
un approccio sociologico a favore di un orientamento storicistico. È possibile, invece, attraverso
25
l’analisi comparata, delineare dei tipi ideali in senso weberiano che consentono di collegare
teoria e ricerca e di formulare delle ipotesi causali;
2) il processo di modernizzazione è influenzato da fattori esogeni, e da eventi contingenti come le
guerre. Questi fattori non sono solo di natura economica, ma anche politica e culturale. I
particolare, i paesi “primi arrivati” tendono a condizionare l’esperienza di quelli che si
muovono in ritardo creando stimoli (es. mobilitazione intellettuale di cui parla Bendix, ma
anche vincoli e condizionamenti legati a rapporti di potere economico, politico e militare).;
3) il processo di modernizzazione è influenzato in modo decisivo dal tipo di risposta alle sfide
esterne che i fattori endogeni consentono.
3. LA NUOVA “POLITICAL ECONOMY” COMPARATA
Esauritosi il primo filone di studi sui paesi del Terzo Mondo, e dopo i grandi lavori di sociologia
comparata sulle società più sviluppate, il concetto di modernizzazione è stato meno direttamente
utilizzato nella teoria e nella ricerca sociale.
Negli anni ’70 il quadro delle esperienze di sviluppo dei paesi del Terzo Mondo si è fatto più
variegato: in alcuni nuovi paesi (specie nel continente africano) le difficoltà sono continuate o
addirittura aggravate ed in altri (America Latina ed Est Asiatico) invece si sono verificati processi
rilevanti di sviluppo economico.
Questa situazione ha orientato la ricerca in due direzioni:
-
si prende consapevolezza dei limiti sia della teoria della modernizzazione sia di quella della
dipendenza perché non erano in grado di rendere conto della crescente differenziazione dei
processi di cambiamento;
-
prende campo un nuovo approccio che è stato definito come nuova political economy
comparata che cerca di capire i fenomeni di dinamismo, stagnazione e regressione, servendosi
maggiormente di comparazioni tra un numero limitato di casi (alcuni studi hanno messo a
confronto i paesi dell’Est asiatico, altri quelli dell’America Latina, ecc.).
3.1 Stato e sviluppo economico
Se gli studi sulla modernizzazione ponevano l’attenzione prevalentemente sulla dimensione
culturale (lo stato doveva solo creare le precondizioni per lo sviluppo del mercato) mentre
l’approccio della dipendenza sulla dimensione economica (lo stato era debole rispetto agli interessi
economici interni e internazionali), nella political economy il fuoco è posto sul ruolo dello stato,
che deve negoziare e controllare i rapporti internazionali.
Quali sono i fattori che influenzano l’efficacia dell’intervento statale? Sono due condizioni:
26
-
una buona macchina statale che possa contrattare con gli interessi esterni per indirizzare e
guidare lo sviluppo industriale all’interno; che possa tenere sotto controllo gli interessi di settori
particolari e potenziare le esportazioni;
-
la presenza di una leadership politica orientata allo sviluppo, largamente autonoma dagli
interessi economici e sociali presenti nella società;
-
l’isolamento istituzionale delle élite statali dagli interessi privati che è importante affinché esse
possano giocare un ruolo di indirizzo strategico dello sviluppo, senza subire i condizionamenti
dei diversi settori.
Nel complesso la political economy comparata si presenta come una nuova sintesi caratterizzata da
una serie di elementi che ne distinguono l’approccio da quelli precedenti. I condizionamenti esterni
variano nei diversi contesti (es. l’influenza americana, legata a problemi geopolitici nell’ambito del
confronto con l’URSS, ha facilitato lo sviluppo di alcuni paesi asiatici, mentre ha avuto un ruolo
meno favorevole in America Latina) e sono mediati dalla capacità strategica dello stato che dipende
dal formarsi di coalizioni di interessi economici e sociali che favoriscono o meno l’autonomia delle
élite politiche; da tradizioni culturali che garantiscono la legittimazione della leadership; e da
tradizioni istituzionali che influiscono sull’efficienza della macchina statale. Fattori culturali e
istituzionali condizionano dunque il processo politico ma non è possibile predeterminare gli esiti e
le conseguenze. Su di essi incide l’interazione tra gli attori sociali e politici sulla base dei
condizionamenti interni e internazionali. Dalla political economy comparata viene dunque
un’importante conferma all’idea, già maturata nell’ambito della sociologia storica, della
fondamentale varietà dei processi di modernizzazione sul piano storico-empirico.
3.2 Civiltà e sentieri di sviluppo
Allontanandosi dall’approccio della political economy ci sono stati dei tentativi recenti di studio
delle civiltà in termini teorici, rifacendosi all’impostazione di Weber.
Da questi tentativi nasce una ricerca sul capitalismo asiatico che ha studiato le forme di
organizzazione dell’attività produttiva e le relazioni di lavoro in quei paesi. Nel capitalismo
occidentale l’impresa ha un’identità forte, una struttura organizzativa dai confini ben delimitati e
rinforzati anche dalle norme giuridiche. Quello asiatico invece è caratterizzato da imprese deboli
inserite in networks forti che comprendono oltre che le relazioni finanziarie e giuridiche, anche i
legami di tipo personale, familiare, e comunitario. Sul piano del lavoro i rapporti di tipo
contrattuale occidentali sono impersonali mentre quelli asiatici lasciano il passo a forme di
identificazione comunitaria nell’impresa.
Gary Hamilton giunge alla conclusione che:
27
-
ci si trova di fronte a specificità della sfera istituzionale economica e politica che non possono
essere spigate soltanto in una prospettiva di political economy ma che chiamano in causa il
concetto di civiltà;
-
un collegamento più stretto tra processo di modernizzazione e tipo di civiltà in cui esso prende
forma porta a negare l’ipotesi di una convergenza istituzionale dominata dal modello
occidentale.
I rapporti tra le istituzioni politiche ed economiche non possono essere compresi esclusivamente
con variabili che mirano a definire l’autonomia e la capacità strategica dello stato bensì con modelli
di legittimazione del potere che rinviano a delle visioni del mondo che hanno una matrice originaria
nell’influenza delle grandi religioni, cioè al concetto di civiltà. In particolare, per il capitalismo
asiatico, è importante il ruolo del confucianesimo (es. la civiltà cinese è distinta da quella indiana,
islamica e occidentale). In questa prospettiva è dunque necessario richiamarsi all’analisi comparata
delle civiltà che era stata avviata da Max Weber, utilizzando le visioni del mondo che sono alla
base delle grandi civiltà nel senso proposto dal sociologo tedesco. Weber aveva già intuito che il
confucianesimo costituiva un quadro di riferimento culturale tale da ostacolare lo sviluppo
capitalistico, ma che poteva anche fornire delle risorse rilevanti per adattarvisi.
Hamilton sottolinea che gli ostacoli che impediscono la piena affermazione dell’autonomia
individuale, in campo politico ed economico; la forte insistenza culturale sugli obblighi di
appartenenza alla rete familiare, parentale e comunitaria; e la visione armonica del mondo in cui
l’individuo deve mantenere tale integrazione; ci fa comprendere meglio le forme di legittimazione
del potere politico che assumono le caratteristiche dell’organizzazione basata sui networks e su
relazioni di lavoro a forte impronta comunitaria. Paradossalmente, questi elementi tradizionali e il
minor grado di differenziazione sociali che avrebbero dovuto, per i teorici della modernizzazione,
costituire un ostacolo allo sviluppo, sono invece diventati una risorsa cruciale per il dinamismo
economico che addirittura suscita l’attenzione crescente e stimola tentativi di imitazione nel mondo
occidentale.
L’esperienza asiatica porta a respingere l’idea che la diffusione del capitalismo fuori dall’Occidente
e i crescenti processi di globalizzazione dell’economia, prefigurino l’avvento di un’unica civiltà
mondiale. Quindi lo sviluppo di un’economia globale non si accompagna a una maggiore
uniformità istituzionale, ma piuttosto alla differenziazione dei processi di modernizzazione nelle
diverse civiltà che offre risorse istituzionali diverse per adattarsi alle sfide dell’economia mondiale
(vedi cap. VI).
Anche Samuel Eisenstadt (1990) matura la convinzione che fosse necessario non rinunciare al
concetto di modernizzazione, ma ridefinirlo richiamandosi alle intuizioni e alle analisi di Weber
28
sulle dinamiche interne delle diverse civiltà. Anche per Eisenstadt le prospettive di studio della
modernizzazione si legano all’indagine comparata sulle civiltà. Al centro del suo approccio vi è
l’idea delle élite intellettuali e politiche come imprenditori istituzionali che si confrontano e si
scontrano per ridefinire l’organizzazione di una determinata società sulla base dei quadri di
riferimento culturale offerti dalle diverse civiltà. Il suo impegno di ricerca, sulla scia di Weber, si è
concentrato prevalentemente all’indietro, alla ricerca dei quadri di riferimento originari delle
diverse civiltà. Resta pertanto aperto il problema di collegare più direttamente i processi di
modernizzazione contemporanei ai caratteri specifici delle diverse civiltà.
È presto per dire se questa prospettiva verrà percorsa in misura significativa in futuro, come i
contributi di Hamilton e di Eisenstadt suggeriscono, ma è certo che nonostante i successi conseguiti
dalla political economy comparata, si manifesta l’esigenza di collegare l’ormai riconosciuta varietà
dei processi di modernizzazione a variabili che non siano soltanto politico-istituzionali ma anche
culturali.
Si può dunque concludere notando come vi sia una ripresa di interesse per quella dimensione
culturale che era al centro dei primi studi e che viene oggi riconsiderata come elemento necessario,
anche se non sufficiente, per una visione più matura, più aperta e plurifattoriale della
modernizzazione e dei suoi esiti.
29
CAPITOLO 3
LO STATO SOCIALE KEYNESIANO E LA “POLITICAL ECONOMY” COMPARATA
In questo capitolo ricostruiremo anzitutto i caratteri di quel modello di regolazione economica e
sociale che va sotto il nome di “stato sociale keynesiano”. Ne esamineremo il ruolo nel grande
sviluppo postbellico e quindi cercheremo di comprendere le cause del suo declino negli anni ’70, in
parallelo con la crescita della inflazione e della disoccupazione. In tale contesto si guarda con
maggior interesse ai fattori politici e istituzionali, e al ruolo che essi svolgono nell’influenzare le
attività economiche. La sociologia economia si qualifica sempre più come political economy
comparata
Nel corso degli anni ’70 si manifesta una significativa ripresa della prospettiva di analisi della
sociologia economica nello studio dei paesi più sviluppati per il fatto che l’economia keynesiana,
che avevano acquisito una notevole influenza sul piano teorico e pratico, sembrano infatti meno
capaci di fornire un’interpretazione adeguata della nuova fase di difficoltà che investono le
economie dei paesi più industrializzati con la contemporanea crescita di inflazione e
disoccupazione. Questi fenomeni che sembravano scomparsi o sotto controllo, negli anni della
grande crescita, si manifestano ora con una virulenza inattesa.
Si parla di crisi o di declino dello stato sociale keynesiano e ci si interroga sulle evidenti differenze
che emergono tra i paesi più industrializzati nel far fronte alle nuove sfide. La comparazione tra i
diversi casi nazionali si afferma come metodo di particolare utilità per mettere a fuoco in che modo
i fattori istituzionali (soprattutto la dimensione politica ed il ruolo giocato dallo stato) influiscano
sulle tensioni economiche e sociali emergenti. Si manifesta così una ripresa della sociologia
economica come political economy comparata (che vuole mettere in evidenza come i fattori politici
influenzino le attività economiche ed interagiscono con esse), un approccio simile a quello che
abbiamo prima analizzato nello studio dei paesi arretrati. Inizialmente, il problema di ricerca
cruciale è costituito dall’origine dell’inflazione e dal suo grado di controllo nell’Occidente più
industrializzato (livello macro) ma successivamente, negli anni ’80, questo approccio affronterà la
questione più generale della competitività e del grado di dinamismo nei diversi tipi di capitalismo
(livello macro combinato a quello micro).
Si tratta di un interscambio tra la political economy comparata e un secondo approccio nel quale
prende forma la ripresa della sociologia economica a partire dagli anni ’70, la nuova sociologia
economica, che studia le trasformazioni del modello di organizzazione produttiva “fordista” e
l’emergenza di nuovi modelli flessibili.
1.ASCESA E DECLINO DELLO STATO SOCIALE KEYNESIANO
30
Nella sua brillante ricostruzione, Shonfield (1965) faceva notare come l’intervento dello stato in
campo economico e sociale del secondo dopoguerra veniva concepito come strumento per uscire da
una situazione di forte depressione in un’ottica di breve periodo che considerava date le risorse, ma
che successivamente ci si discosta da tale quadro in due direzioni:
-
si diffonde il keynesismo della crescita, cioè il tentativo di usare l’intervento statale, e
soprattutto la spesa pubblica, come strumento per sostenere lo sviluppo economico e non solo
per curare le depressioni;
-
si diffondono i programmi di welfare indipendentemente dal ciclo economico e dalla situazione
occupazionale.
È con riferimento a questi due fenomeni che si può parlare di stato sociale keynesiano intendendo
un intervento pubblico che si allontana dalle concezioni originarie di Keynes e si realizza in forme
più o meno estese nei paesi sviluppati dell’Occidente: l’idea di fondo è che la politica della
domanda debba essere usata per favorire lo sviluppo nel tempo delle risorse produttive anche in
presenza di piena occupazione mediante le selezione del credito mirata a far crescere gli
investimenti in determinati settori, la formazione di grandi aziende capaci di forti economie di
scala, l’intervento diretto di imprese pubbliche (+investimenti, + produzione e produttività,
+sviluppo economico). Questa tendenza trova gli sviluppi più consistenti in paesi che adottano
politiche dirigiste (Francia e Giappone) e che fanno largo uso dell’impresa pubblica (Italia).
Si sono contrapposti due modelli:
-
keynesismo debole: l’intervento pubblico si limita a stabilizzare il ciclo economico sostenendo
la domanda nei momenti di recessione e raffreddandola in quelli di pieno utilizzo dei fattori
produttivi; la spesa sociale è meno consistente (es. Stati Uniti fino agli anni ’70);
-
keynesismo forte: l’impegno è più vincolante sul terreno della difesa della piena occupazione e
della crescita economica che possa finanziare un incremento più consistente della spesa sociale
(es. Svezia).
Vi sono inoltre paesi che nei primi decenni postbellici sperimentano politiche di pianificazione
dell’economia di tipo più dirigista (regolamentano e orientano i settori economici senza una
crescita consistente della spesa in campo sociale) come la Francia ed il Giappone.
1.1 La crescita dei sistemi di protezione sociale
Ciò che caratterizza particolarmente lo stato sociale keynesiano è la forte crescita delle politiche di
welfare. I primi interventi nel campo della protezione sociale risalgono alla fine dell’800 ma è nel
secondo dopoguerra che in fenomeno cresce. La letteratura si è impegnata a spiegare tale tendenza
alla crescita dei programmi di protezione ed alcune analisi, dei primi anni ’60, sottolineano come la
domanda proveniente dalle classi sociali subalterne avesse portato al graduale riconoscimento dei
31
diritti civili, di quelli politici e infine di quelli sociali. La protezione di rischi per malattie, infortuni,
vecchiaia, disoccupazione, e la richiesta di un accesso equo alle istituzioni educative, viene sempre
più rivendicata come un aspetto fondante dei “diritti di cittadinanza”. Bendix, attraverso l’analisi
comparata, mostra l’importanza del grado di apertura del sistema politico come fattore che influisce
sugli esiti delle nuove domande (es. il caso inglese ci fa vedere come un sistema politico aperto ha
incanalato le nuove richieste gradualmente senza mettere in discussione le istituzioni
democratiche).
Un altro tipo di spiegazioni si muovono all’interno della teoria neomarxista dello stato (O’Connor,
Habermas 1973) che pongono l’accento sulle esigenze funzionali di riproduzione del capitalismo
(lo stato incrementa i programmi di protezione sociale per sostenere l’accumulazione ed il
mantenimento del consenso).
Il difetto di questi due tipi di spiegazioni è di muoversi ad un livello molto generale e quindi di non
valutare le differenze rilevanti che vi sono tra i diversi paesi nella spesa per le politiche sociali e
negli specifici modelli istituzionali (alcuni studi comparativi ci hanno dato un quadro più preciso
dell’evoluzione delle politiche sociali).
In Europa, nel periodo tra le due guerre, saranno soprattutto i paesi dove i partiti dei lavoratori sono
più forti e partecipano al governo a far crescere le politiche sociali (soprattutto nella forma di
assicurazioni obbligatorie nazionali). Nel secondo dopoguerra anche i partiti di centro di ispirazione
cattolica.
La letteratura ha in genere condiviso l’idea di tre idealtipi principali di welfare formulata da
Richard Titmuss (1974) e successivamente da Esping-Andersen (1990):
1) modello istituzionale-redistributivo riconosce i diritti sociali come componenti essenziali della
cittadinanza. Si tratta di programmi pubblici che forniscono benefici uniformi per tutti i
cittadini, quindi su base universalistica (es. Svezia, Norvegia e Danimarca dove vi è un forte il
movimento operaio e la presenza prolungata di partiti di sinistra al governo);
2) modello residuale in cui la protezione sociale pubblica è volta a coprire una fascia limitata di
popolazione che si trova in condizioni di particolare indigenza e bisogno, per rischi che non
sono coperti dal mercato, dalla famiglia o da forme di azione volontaria (es. Stati Uniti dove il
welfare si espande negli anni ’30 con il new Deal e poi soprattutto negli anni ’60, in un contesto
che resta però fortemente influenzato dall’ideologia liberale, dalla minore forza del movimento
operaio e dall’assenza di partiti di orientamento socialista; il Canada, l'Australia e più di recente
la Gran Bretagna che negli anni ’50 era più simile al modello socialdemocratico);
3) modello remunerativo di Titmuss in cui l’assicurazione contro i principali rischi non si basa su
un diritto di cittadinanza ma sull’appartenenza a una categoria socioprofessionale; il
32
finanziamento si basa sui contributi più che sulla tassazione per cui sono più deboli le finalità
redistributive; prevalgono nettamente i trasferimenti monetari rispetto ai servizi offerti dallo
stato (es. Germania, Austria, Belgio, Italia, Spagna, Portogallo e in parte l’Olanda). Una
caratteristica del “modello continentale” è la particolare influenza esercitata sul piano politico
dalla cultura cattolica. Nell’ambito di questo modello il caso italiano assume peraltro una
connotazione più marcatamente particolaristica e clientelare che ne segna i caratteri e le
modalità di funzionamento.
Va quindi sottolineato che in tutti i paesi più sviluppati si determinò nei due decenni postbellici
un notevole incremento dell’impegno statale nel campo della protezione sociale. Sia che
l’intervento fosse in forma di keynesismo più debole, sia più forte, la spesa sociale rappresentò
comunque un importante volano della grande crescita.
1.2 Le tensioni economiche e sociali degli anni ’70
Con gli anni ’70 vi è una generale ripresa del conflitto industriale che sembrava ormai sopito; i
tassi di inflazione crescono; diminuiscono sensibilmente i tassi di crescita della produzione; cresce
la disoccupazione. Entra in crisi l’egemonia teorica e pratica del keynesismo palesemente in
difficoltà di fronte alla contemporanea presenza di elevata inflazione e disoccupazione (in questi
anni si conia il termine stagflazione, cioè stagnazione + inflazione); viene quindi stimolata una
ripresa dell’analisi istituzionale dell’economia.
Nel secondo dopoguerra la politica di regolazione dell’economia si era allontanata dalle idee
originarie di Keynes:
-
per Keynes l’intervento dello stato doveva limitarsi ad impedire le fasi di depressione delle
attività economiche (e non che la politica attiva della domanda potesse diventare uno strumento
per pilotare la crescita economica);
-
la politica della domanda doveva essere svolta da élite burocratiche competenti e votate
all’interesse pubblico (ma nelle democrazie occidentali il controllo della spesa pubblica diventò
presto uno strumento cruciale per la classe politica allo scopo di favorire e riprodurre il
consenso; le scelte erano influenzate da valutazioni politiche piuttosto che tecniche;
-
a livello microeconomico il mercato avrebbe dovuto continuare a regolare il mercato dei
prodotti e quello del lavoro (invece in situazione di piena occupazione e di forti politiche di
protezione sociale che riducevano la dipendenza dalle chances di vita dei singoli dalla loro
posizione di mercato offrendo servizi e redditi attraverso la redistribuzione politica).
La situazione di piena occupazione aveva fatto crescere l’impiego di manodopera immigrata che
matura nuove domande sul piano retributivo e su quello del riconoscimento sociale e politico.
Inoltre riprese il conflitto industriale in quanto i sindacati traggono vantaggio dalla situazione di
33
piena occupazione chiedendo salari più alti ed alimentando così l’inflazione. La spesa sociale
(protezione dei rischi connessi a malattie, infortuni, vecchiaia, disoccupazione) entra sempre più a
far parte dei criteri di legittimazione delle democrazie capitalistiche moderne per cui resta difficile
attuare una sua riduzione.
Gli effetti perversi dello stato sociale keynesiano cominciarono a manifestarsi in modo più marcato
alla fine degli anni ’60, ma furono rinforzati da una serie di altri fattori:
-
dal processo di saturazione del mercato dei beni della produzione di massa e dal contemporaneo
intensificarsi della concorrenza proveniente dai nuovi paesi industriali (che sfruttavano il loro
più basso costo del lavoro come vantaggio competitivo per le loro esportazioni verso il mondo
sviluppato);
-
dall’impennata dei prezzi petroliferi (dovuta ai paesi arabi produttori che nel 1973
organizzarono un cartello per regolare le esportazioni di petrolio e per fa salire sensibilmente il
prezzo) e dall’abbandono dei cambi fissi con la connessa svalutazione del dollaro (nel 1971 gli
Stati Uniti, afflitti da un deficit crescente della bilancia dei pagamenti, furono costretti a
sospendere la convertibilità del dollaro in oro e a svalutare il dollaro; si passa dal sistema di
cambi fissi a uno di cambi fluttuanti con la conseguente instabilità e incertezza in cui si vennero
a trovare le imprese della produzione di massa che erano cresciute all’insegna della stabilità del
mercato internazionale sotto l’egida degli Stati Uniti).
1.3 Le spiegazioni dell’inflazione e le due “political economy”
Negli anni ’70 si sviluppa una crescente letteratura sulle origini dell’inflazione che assume la
denominazione di nuova politica economy (studia il comportamento dei governi, sindacati e
imprese nelle relazioni industriali ed il loro effetto sull’inflazione; li tratta come fattori non esogeni
ma centrali per spiegare il fenomeno) e si distingue in due filoni di tipo neoistituzionale:
-
la political economy delle teorie neoutilitarie: come la teoria delle scelte pubbliche e il “ciclo
politico-elettorale (in concomitanza delle scadenze elettorali i politici in carica per essere
rieletti aumentano la spesa o riducono le tasse). Samuel Brittan (1978) tenta di fornire
un’interpretazione delle tendenze di più lungo periodo alla crescita dell’inflazione (vi è uno
scarto temporale tra gli effetti espansivi sull’economia e il manifestarsi dell’inflazione e questo
gioca a favore dei politici che attuano politiche espansive per farsi rieleggere; la memoria degli
elettori è corta e non capiscono che la crescente inflazione post-elettorale è stata causata dai
politici stessi, inoltre questi rivendicano aumenti salariali per combattere l’effetto
dell’inflazione e alimentano continuamente la spirale inflattiva). Brittan e gli altri teorici delle
scelte pubbliche pone come rimedio norme costituzionali (es. obbligo di tenere in pareggi il
bilancio pubblico) e la preferenza per una terapia neoliberista che punta al drastico
34
ridimensionamento del ruolo dello stato nel campo economico e sociale e al ripristino della
disciplina del mercato. Questa impostazione è condivisa anche dalle teorie monetariste ed
alimenta gli esperimenti politici di Reagan e della Thatcher;
-
la political economy della sociologia economica: questo approccio cerca di comprendere cosa
spinga i governi a intensificare la ricerca di consenso attraverso un’offerta crescente di moneta
con la spesa pubblica. John Goldthorpe, come i sociologi in genere, concepiscono il mercato
come intrinsecamente instabile che deve essere controllato da fattori esogeni (valori condivisi,
governo, ecc.). L’inflazione è vista come espressione monetaria di un conflitto distributivo. Nel
tempo si sono erose le forme di legittimazione di natura tradizionale delle disuguaglianze di cui
il mercato ha potuto valersi inizialmente. Successivamente le classi svantaggiate si sono
organizzate per sfruttare l’azione collettiva e quindi migliorare la loro posizione. Ciò è potuto
accadere anche grazie al sistema di protezione sociale che ha ridotto la dipendenza dei singoli
dal mercato del lavoro e dall’impegno dei governi per la piena occupazione, che ha rafforzato le
organizzazioni dei lavoratori. Quindi le scelte dei governi non devono essere interpretate come
“scarsa decisione” o “errori tecnici”, come ritiene la teoria monetarista tradizionale, e nemmeno
in termini di mero calcolo razionale del consenso da parte della classe politica, come ritiene la
teoria delle scelte pubbliche; ma in realtà vi sono delle determinanti sociali della domanda dei
vari gruppi con cui i governi devono fare sempre di più i conti.
L’interpretazione dell’inflazione di tipo monetarista invece considera esogena la sfera delle
istituzioni (sono i governi che non sono capaci a controllare l’offerta di moneta in rapporto
all’andamento della produzione e che causano comportamenti di imprese e sindacati in una
direzione che rafforza l’inflazione).
2. PLURALISMO E NEOCORPORATIVISMO
Perché nei primi anni ’70 paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o l’Italia presentano alti tassi
di inflazione, ma anche una conflittualità sociale molto più elevata di quella dei paesi scandinavi o
dell’Austria e della Germania?
Intorno a questi interrogativi si sviluppa un modello di political economy comparata, empiricamente
fondato, che elabora i concetti di neocorporativismo e concertazione contrapponendoli a quella di
pluralismo e di politica di pressione. L’idea di fondo di questa letteratura è che migliori risultati in
termini di controllo delle tensioni economiche e sociali, ovvero degli effetti perversi dello stato
sociale keynesiano, sono associati a un sistema di rappresentanza degli interessi e di decisione
politica che si allontana dal pluralismo (modello su cui aveva insistito la sociologia e la scienza
politica dei decenni precedenti).
35
La riflessione sul neocorporativismo fu avviata da Philippe Schmitter (1974) che si concentrava
sulla dimensione relativa all’organizzazione degli interessi, mentre un lavoro di Gerhard
Lehmbruch (1977) guardava al processo di decisione politica.
La vasta letteratura successiva ha poi approfondito le relazioni di interdipendenza tra i due aspetti.
Analizziamo le due dimensioni:
-
organizzazione degli interessi può essere un sistema pluralistico caratterizzato da un numero di
associazioni volontarie di piccole dimensioni, che competono tra loro per conquistare l’adesione
dei singoli soggetti, ed esprimono in genere una rappresentanza di interessi specifici e settoriali
(esempio quelli delle imprese o dei lavoratori di natura settoriale, meccanica, tessile, ecc.).
Queste organizzazioni sono poco collegate tra loro ed hanno una debole capacità di
coordinamento degli interessi rappresentati sia a livello di settore che ancor più tra settori
diversi (perché mancano per esempio le confederazioni nazionali); oppure può essere un sistema
neocorporativo caratterizzato da un piccolo numero di grandi associazioni di rappresentanza che
raccolgono gli appartenenti ad ampi settori economici e categorie professionali (es. l’industria
nel suo complesso o l’agricoltura); una sorta di monopolio o oligopolio di fatto della
rappresentanza. L’adesione è formalmente volontaria, ma in pratica mancano alternative, sia
perché non ci sono molte organizzazioni in concorrenza tra loro, sia perché il monopolio o
l’oligopolio possono essere rafforzati dal riconoscimento dello stato che delega delle funzioni
pubbliche (es. nella gestione di determinate politiche del lavoro alle organizzazioni in
questione); questo è un incentivo per i potenziali membri ad associarsi per ottenere alcuni
benefici pubblici. In questo modello vi sono quindi organizzazioni di vertice che detengono un
elevato potere di contrattazione con le altre strutture di rappresentanza e con gli organismi
pubblici, in particolare con il governo centrale;
-
il rapporto tra gruppi di interesse e governi nel processo di decisione politica: il sistema
pluralistico si caratterizza per un’elevata concorrenza tra le organizzazioni degli interessi che
influenzano i partiti politici, le correnti di partito, singoli parlamentari, con attività di lobbying,
cioè con una politica di pressione che cerca di incidere sulle decisioni che li riguardano (le
organizzazioni degli interessi sono meno direttamente coinvolti nel processo di attuazione delle
politiche); il sistema neocorporativo è associato invece a meccanismi di decisione e attuazione
delle politiche basati sulla concertazione tra le grandi organizzazioni di rappresentanza (degli
imprenditori e dei lavoratori), il governo e gli altri attori pubblici, nella definizione delle
politiche in campo economico e sociale e sono spesso direttamente coinvolte anche nella
gestione degli interventi, specie nel campo delle politiche del lavoro e della formazione, o nelle
politiche sociali.
36
Dobbiamo ora valutare per quali motivi un sistema di rappresentanza di tipo neocorporativo e un
processo di decisione politica basato sulla concertazione possano favorire un più efficace controllo
delle tensioni economiche e sociali.
Iniziamo a specificare meglio alcuni concetti.
Per neocorporativismo si intende un modello di regolazione politica dell’economia nel quale
grandi organizzazioni di rappresentanza degli interessi partecipano insieme alle autorità
pubbliche, in forma concertata, al processo di decisione e attuazione di importanti politiche
economiche e sociali (si distingue dal corporativismo che abbiamo visto nelle esperienze dei regimi
autoritari che serviva per imporre scelte sostanzialmente definite dall’alto da parte dei governi
autoritari). Nel neocorporativismo il processo di costruzione delle organizzazioni avviene “dal
basso”, per effetto della capacità della leadership di trovare consenso nella base associativa, anche
se a un certo punto tale costruzione può essere più o meno rafforzata dal riconoscimento e dal
sostegno pubblico.
2.2 La logica dello scambio politico
Perché i sindacati sono spinti ad accettare la moderazione salariale partecipando ad assetti
neocorporativi?
Per rispondere a questa domanda possiamo fare riferimento a un contributo di Alessandro Pizzorno
(1977) sullo scambio politico (una situazione in cui un soggetto, generalmente il governo, che ha
beni da distribuire è pronto a scambiarli con consenso sociale che un altro soggetto ha facoltà di
dare o di ritirare, come per esempio di minacciare l’ordine).
I sindacati, specie nei primi anni ’70, avevano un forte potere di mercato e potevano con le loro
rivendicazioni, e con il conflitto, determinare effetti dirompenti sulla situazione economica e
occupazionale e di conseguenza sugli equilibri sociali e politici.
Ma a quali condizioni essi sono disponibili a moderare le loro domande?
Sono necessarie tre condizioni:
-
l’offerta da parte dei governi di un maggior potere politico;
-
un elevato grado di autonomia dei rappresentanti rispetto ai rappresentati (centralizzazione) per
poter imporre una moderazione delle domande alla base;
-
una situazione di bassa concorrenza da parte di organizzazioni rivali, che potrebbero sfruttare la
situazione per proporsi come rappresentanza alternativa a quei settori meno propensi ad
accettare la strategia di moderazione.
Le condizioni elencate da Pizzorno si avvicinano ai due aspetti sopra già ricordati (il monopolio
delle rappresentanza e la centralizzazione del potere di contrattazione). Resta però da chiarire quali
vantaggi i sindacati si possano attendere dallo scambio. Oltre ad accrescere il potere dei dirigenti le
37
organizzazioni dei lavoratori possono compensare la moderazione delle richieste salariali sul
mercato economico con benefici legati alle politiche pubbliche (soprattutto quelle del lavoro che
regolano orari, sicurezza, status giuridico, e quelle fiscali e sociali). Naturalmente non bisogna
dimenticare che il calcolo dei sindacati è anche influenzato dall’identità delle organizzazioni, dalla
loro storia e dai valori che la connotano. Sindacati che si ispirano a principi di rappresentanza
generale del mondo del lavoro, e non solo degli iscritti, saranno più inclini a valutare i costi
complessivi per i lavoratori, e avranno più possibilità, facendo appello a tali principi, di sviluppare
una politica solidaristica che sacrifica il potere dei gruppi più forti sul mercato del lavoro a
vantaggio di quelli relativamente più deboli.
Altri fattori che intervengono nel processo di regolazione neocorporativo sono:
-
il ruolo dei governi dinanzi alle domande di sindacati forti che devono cercare di integrare le
organizzazioni dei lavoratori nel processo di decisione politica, scambiando potere politico con
consenso e controllo sociale (bassa conflittualità);
-
il ruolo della cultura politica in quanto governi di sinistra, con la presenza di partiti socialisti,
saranno in genere più sensibili al consenso del mondo del lavoro e dei sindacati (tale scelta può
essere assunta anche da governi di centro-destra);
-
il ruolo delle organizzazioni imprenditoriali intese come rappresentanti delle imprese come
datori di lavoro (e non all’associazionismo con finalità economiche). Essi sono in posizione di
vantaggio strutturale legata al controllo dei mezzi di produzione, sia rispetto al mercato del
lavoro che nei riguardi delle autorità pubbliche che devono tenere conto degli effetti della
propria azione sulla propensione degli imprenditori all’investimento, dalla quale dipende in
economie di tipo capitalistico la produzione e l’occupazione. Se vi è un forte sindacato dei
lavoratori centralizzato e un governo che controlla una struttura istituzionale accentrata ed è
favorevole allo scambio politico, è probabile che anche le associazioni imprenditoriali si
attrezzino di conseguenza per partecipare alla concertazione.
2.3 La variabilità degli assetti neocorporativi e le sue cause
Si è ben presto fatta strada l’idea che il neocorporativismo debba essere considerato come uno
specifico modello di regolazione istituzionale che non si sviluppa necessariamente in tutte le
economie capitalistiche, e può anche manifestarsi con gradi di intensità e di stabilità variabili, e con
conseguenze diverse. Alcuni contributi
hanno sottolineato tale variabilità proponendo delle
tipologie, soprattutto con riferimento ai paesi europei dove il fenomeno è più presente:
-
neocorporativismo con organizzazioni dei lavoratori forti: a questo modello si avvicinano i
paesi scandinavi (Svezia, Norvegia, Danimarca) e l’Austria dove a sindacati forti , con elevato
grado di monopolio della rappresentanza e di centralizzazione del potere, si accompagnano
38
organizzazioni imprenditoriali altrettanto forti e centralizzate, e partiti socialisti che detengono a
lungo il controllo del governo. È in questo quadro che si sviluppa una concertazione stabile,
bassa conflittualità, impegno dei governi a sostegno della piena occupazione, uno stato sociale
di tipo universalistico. Le forze lavoro riescono in questo contesto a piegare maggiormente a
loro favore le condizioni dello scambio politico neocorporativo senza peraltro compromettere lo
sviluppo economico;
-
neocorporativismo con organizzazioni del lavoro più deboli: si trovano in Olanda, Belgio e
Svizzera (la Germania, dove i sindacati sono più forti, si trova a metà strada tra questo e il
modello precedente). Si hanno qui sindacati più deboli e più frammentati. In Olanda e Belgio vi
sono organizzazioni legate alle diverse matrici religiose, oltre che al movimento socialista. I
sindacati sviluppano però delle forme di coordinamento tra loro e presentano un grado elevato
di centralizzazione, così come le organizzazioni imprenditoriali. Tuttavia, la minor forza dei
sindacati rende meno favorevole al lavoro lo scambio politico centralizzato. Nei casi in cui i
sindacati sono più deboli (Svizzera) essi vengono in realtà cooptati e incorporati, per motivi
legati al consenso, nel processo di decisione politica; in cambio di un riconoscimento
istituzionale che altrimenti non avrebbero sulla base della forza organizzativa, esse si fanno
portatrici di una politica di moderazione salariale. Entrambi i tipi di questo modello riflettono
una situazione di debolezza del lavoro;
-
neocorporativismo instabile: laddove, nel corso degli anni ’70, la necessità di controllare la
conflittualità e le rivendicazioni mediante l’accordo con i sindacati non viene consolidata. I casi
più rilevanti sono la Gran Bretagna e l’Italia (negli anni ’70 anche la Danimarca si allontana dal
modello scandinavo). La forza dei sindacati si avvicina a quella del primo tipo ma presentano
una ridotta capacità di coordinamento centrale della rappresentanza (specie nel caso inglese) ed
un minor grado di monopolio legato alla presenza di diverse confederazioni (caso italiano).
Inoltre i governi sono meno orientati in senso pro-labour. In tali condizioni manca
l’infrastruttura istituzionale per stabilizzare le tendenze neocorporative, anche se queste si
manifestano ripetutamente: in Gran Bretagna con i tentativi di “contratto sociale” tra il 1974 e
il 1979, in Italia tra il 1977 e il 1984 (ma anche con maggior successo negli anni ’90).
Le considerazioni precedenti attirano l’attenzione sulla variabilità delle tendenze corporative e
possono aiutarci a riassumere i principali fattori causali che influiscono sulla diffusione di questo
fenomeno:
1) la forza delle organizzazioni sindacali: esse devono avere un livello di sussistenza tale da poter
mettere in discussione, con il conflitto, il controllo degli imprenditori sul mercato del lavoro e
sull’organizzazione del lavoro nelle imprese;
39
2) il monopolio della rappresentanza e la centralizzazione del potere di rappresentanza: sindacati
forti ma incapaci di coordinare e controllare le rivendicazioni della base, o di coordinarsi tra
loro quando vi sono più organizzazioni, non favoriscono l’istituzionalizzazione di stabili forme
di scambio neocorporativo;
3) la presenza nei governi di partiti di sinistra: questi ultimi sono in genere più favorevoli a
mettere in gioco benefici politici, soprattutto nel campo delle politiche sociali e del lavoro, per
facilitare la concertazione (non è da trascurare il fatto che anche partiti di centro-destra, specie
con forti componenti cattoliche, possono a loro volta valersi della concertazione, soprattutto
quando essa è già avviata e può risultare costoso rinunciarvi). Importante è anche l’efficienza
delle strutture amministrative, perché è evidente che affinché lo scambio neocorporativo possa
funzionare è necessario che gli apparati dello stato, al centro e alla periferia, siano in grado di
fornire in modo rapido ed efficiente quelle prestazioni che garantiscono i benefici politici e
l’incremento del “salario sociale” (il caso italiano è un buon esempio di come le strutture
amministrative inefficienti abbiano spesso reso più difficile lo scambio politico);
4) il grado di radicamento culturale e istituzionale del liberalismo: al liberalismo economico si
accompagna dal punto vista culturale e istituzionale il liberalismo politico. Così come viene
guardata con sospetto ogni forma di organizzazione degli interessi nel mercato economico, per
il timore che questo possa rendere meno efficiente il funzionamento del mercato, la stessa
tendenza vale nel campo politico, per il timore che i peso degli interessi particolari possa
distorcere la formazione degli interessi collettivi affidata al parlamento. Quanto più forte e
radicata è l’ideologia liberale, tanto maggiore sarà allora la diffidenza nei riguardi della
rappresentanza di quegli interessi particolari che crescono con il processo di industrializzazione
nelle classi alte e nel mondo del lavoro (tale diffidenza la si può riscontrare nell’esperienza
storica dei paesi anglosassoni e in quella francese dopo la Rivoluzione; in Europa settentrionale
invece le deboli élite liberali hanno permesso la persistenza e la valorizzazione delle tradizioni e
delle istituzioni di rappresentanza corporativa degli interessi; in Europa meridionale le deboli
élite liberali sono state sfidate dal dominio della Chiesa cattolica che si opponeva fortemente
alla costruzione dello stato liberale ed egemonizzata le strutture corporative preindustriali).
2.4 Le tendenze più recenti
Nei primi anni ’80 molti protagonisti degli studi sul neocorporativismo erano convinti che “questo
fosse il percorso che presto o tardi i vari capitalismi nazionali avrebbero finito per seguire, se
avessero voluto rispettare i diritti fondamentali dei cittadini connessi all’organizzazione degli
interessi, sia gli imperativi funzionali di garantire la pace sociale ed espandere l’accumulazione”.
Eppure proprio in quegli anni stavano prendendo forma importanti mutamenti.
40
Da un lato, paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna cercano di uscire dalle difficoltà
economiche e sociali degli anni ’70 con un esperimento neoliberale di rilancio del mercato e di
ridimensionamento dell’intervento pubblico.
Dall’altro, anche nei paesi tradizionalmente vicini a forme forti o deboli di neocorporativismo e di
concertazione si verifica un importante cambiamento: si manifesta una tendenza generalizzata al
declino della contrattazione centralizzata e crescono invece forme di concertazione, formale e
informale, a livello più decentrato, sia aziendale e settoriale che territoriale.
Questo è dovuto a due fattori:
-
la trasformazione dell’organizzazione produttiva a livello micro: si assiste alla saturazione dei
mercati per la produzione di massa ed alla crescente concorrenza su questi mercati dei paesi di
nuova industrializzazione con più basso costo del lavoro oltre che alla rottura del sistema di
cambi fissi ed all’impennata dei prezzi del petrolio. Il modello fordista entra in crisi per cui le
imprese cercano di acquisire maggiore flessibilità per far fronte a mercati più instabili e
variabili (le produzioni più semplici ma ad elevata intensità di lavoro tendono a spostarsi verso i
paesi in via di sviluppo mentre nelle economie più avanzate cresce il peso dei servizi, come
ricerca, finanza, servizi legali, marketing e pubblicità. La riorganizzazione porta alla rapida
diminuzione della classe operaia di grande fabbrica e all’incremento di fasce di lavoratori a più
elevata qualificazione nell’industria dei servizi con conseguente frammentazione degli interessi
nel mondo del lavoro che porta all’indebolimento dei sindacati ed a una maggiore articolazione
interna che rende più complessi e difficili i processi di coordinamento della contrattazione.
Sindacati più deboli hanno minore potere di condizionamento sulle scelte degli imprenditori e
dei governi. Per gli imprenditori abbiamo già notato come l’accettazione della contrattazione
centralizzata fosse in genere una seconda scelta, motivata dal tentativo di limitare la
conflittualità e la forza delle rivendicazioni aziendali. Essi sentono adesso la necessità di
adattarsi a condizioni più differenziate nell’uso e nella remunerazione della manodopera per cui
si fanno in genere sostenitori di un maggiore decentramento della contrattazione;
i vincoli crescenti posti alla spesa pubblica dallo stato sociale: i governi non sono adesso
minacciati dalle rivendicazioni sindacali e dalla conflittualità ma sono interessati da costi
crescenti dovuti alle politiche sociali attuate (l’invecchiamento della popolazione grava sulla
spesa pensionistica; il miglioramento delle tecniche di prevenzione e cura delle malattie sulla
spesa sanitaria; diminuisce l’occupazione a tempo pieno e ciò grava sul sistema di protezione
sociale). Diventa essenziale limitare le spese sociali. Vedremo nell’ultimo capitolo che i governi
saranno limitati in campo macroeconomico dalla crescente integrazione dei mercati finanziari.
41
Riassumendo possiamo dire che i fattori che minano la contrattazione politica centralizzata a partire
dagli anni ’80 sono:
-
la frammentazione degli interessi del lavoro e l’indebolimento dei sindacati;
-
la conseguente minore vulnerabilità degli imprenditori e dei governi rispetto alle rivendicazioni
sindacali e ala conflittualità;
-
le tensioni interne alle associazioni imprenditoriali, che spingono verso il decentramento della
contrattazione;
-
i vincoli macroeconomici posti all’azione dei governi che riducono la possibilità di ricorrere a
benefici politici nello scambio.
Oltre a questi fattori possiamo dire che in molti paesi, anche in alcuni di quelli scandinavi, si
interrompe il lungo predominio dei partiti di sinistra e forze politiche di centro-destra vanno al
potere; inoltre appaiono sulla scena nuovi movimenti politici, in particolare quelli ecologisti e quelli
legati a un’attivazione di identità territoriali. I partiti sembrano in genere recuperare un ruolo
maggiore, rispetto agli anni ’70, nel sistema di rappresentanza che diventa più pluralistico. Inoltre,
in Europa, il processo di costruzione delle istituzioni comunitarie forma rappresentanze
pluralistiche a livello sovranazionale.
Non si deve però commettere l’errore di considerare ormai superati i modelli corporativi perché in
gran parte d’Europa i modelli corporativi continuano a connotare forme di regolazione
dell’economia ottenendo i miglior risultati in termini di controllo dell’inflazione e della
disoccupazione (Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Austria, paesi scandinavi).
Questi stessi paesi, ma anche altri come l’Italia nei quali il neocorporativismo centralizzato era
rimasto instabile, sperimentano negli anni ’80 forme di micro o di mesoconcertazione, a livello di
azienda di settore o di territorio. L’esistenza di una infrastruttura istituzionale favorevole alla
concertazione costituisce una risorsa per affrontare, con minori costi per tutte le parti coinvolte, i
difficili problemi posti dalla trasformazione del fordismo in direzione di modelli organizzativi più
basati sulla flessibilità e la qualità (problemi di gestione degli esuberi, mobilità dei lavoratori,
formazione e riqualificazione). In questo quadro si può comprendere l’importanza crescente di
forme di micro e mesoconcertazione (la cooperazione tra gli attori si sposta dal livello
macroeconomico a quello micro). Una ricerca sul caso italiano mostra come queste forme più
decentrate di concertazione presentano due caratteristiche:
-
il loro carattere più disaggregato e meno visibile rispetto alla contrattazione centralizzata può
facilitare l’intesa tra le varie parti coinvolte perché si riducono le esigenze di mediazione tra
interessi divergenti sia delle imprese che dei lavoratori
42
-
la prima caratteristica può però creare delle contraddizioni con il controllo del quadro
macroeconomico, che è invece al centro della concertazione tradizionale. Le intese raggiunte
alla periferia, o nell’ambito dei settori, possono infatti comportare un aggravio degli oneri in
termini di spesa per le istituzioni pubbliche (come mostra il fenomeno della cassa integrazione,
ampiamente usato in Italia per favorire la ristrutturazione consensuale delle grandi imprese).
Come vedremo più avanti, gli stessi vincoli macroeconomici posti dal processo di costruzione
dell’unione monetaria europea hanno in molti casi stimolato una ripresa della macroconcertazione
propri per affrontare i problemi della moderazione salariale e del controllo dell’inflazione, della
disoccupazione e della riorganizzazione dello stato sociale.
3. LA VARIETA’ DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE
Un aspetto importante che emerge dalla political economy comparata degli anni ’70 riguarda un
terzo tipo di regolazione, diverso sia da quello neocorporativo che da quello pluralista. Esso risulta
di particolare interesse perché mostra una possibilità di regolazione istituzionale che ottiene buoni
risultati sotto il profilo economico, pur senza rientrare nel modello corporativo (i riferimenti
principali sono la Francia e il Giappone).
3.1 Il decreto tra mercato e accordo
Michele Salvati (1982) ha proposto il modello idealtipico che ha denominato decreto caratterizzato
da un’elevata autonomia dei governi dalla pressione pluralistica degli interessi. Lo stato può così
intervenire nell’economia con politiche dirigistiche che utilizzano le leve del credito, quelle fiscali e
quelle del sostegno alle esportazioni; orientando il comportamento delle imprese al fine di sostenere
lo sviluppo economico ed escludendo i sindacati, che sono deboli, dal processo di decisione politica
(es. la Commissione per la programmazione in Francia, il Ministero del commercio e dell’industria
in Giappone). Il risultato dal punto di vista economico consiste in bassa inflazione accompagnata da
bassa disoccupazione ed elevati tassi di crescita. In questo modello il governo si concentra su
politiche regolative in campo economico, più che redistributive in campo sociale.
Il contributo di Salvati è utile per mettere a fuoco le differenze tra il tipo del decreto e gli altri due
modelli, l’accordo (che coincide con il neocorporativo) ed il mercato (che coincide con il
pluralismo radicale il cui riferimento principale sono gli Stati Uniti).
Consideriamo tre dimensioni all’interno dei tre idealtipi:
1) la forza della classe operaia: nell’accordo è forte mentre nel decreto e nel mercato è debole;
2) il sistema politico: neocorporativo nell’accordo; pluralista nel mercato; di divisione politica nel
decreto con forze politiche di sinistra stabilmente escluse dall’accesso al governo (Francia);
3) la dimensione ideologica: nel mercato vi è la centralità della società civile con forte
radicamento del liberalismo, sia economico che politico (es. Gran Bretagna e Stati Uniti dove
43
la forte immigrazione e la variegata composizione etnica no ha mai costituito un terreno facile
per le idee socialiste; mentre in Europa il liberalismo è spesso debole e contrastato da forti
movimenti di orientamento socialista); nel decreto le aspettative sono più per un intervento
dirigista dello stato in campo economico che per una sua diffusa responsabilità in campo
sociale; nell’accordo invece si auspica uno stato sociale.
Il contributo di Salvati introduce un elemento di cautela, che non riguarda soltanto il “successo” del
decreto, ma anche il giudizio su quello del mercato. Anche il mercato può funzionare senza doversi
necessariamente trasformare nell’accordo neocorporativo. Si riconoscono possibilità diverse di
regolare l’economia nei paesi più sviluppati. Negli Stati Uniti il grado di accettazione sociale del
mercato è certamente più alto che nei paesi europei (la Gran Bretagna è il paese europeo che si
avvicina di più per l’influenza originaria del liberalismo nei rapporti tra stato e mercato al modello
americano). In ogni caso, gli sviluppi più recenti hanno confermato che un riaggiustamento più
basato sulla regolazione di mercato può conseguire risultati rilevanti sotto il profilo del dinamismo
economico e della creazione di occupazione. Vedremo più avanti come la sociologia economica, nei
sui sviluppi più recenti, abbia cercato di tener maggiormente conto della varietà delle forme di
regolazione e dei processi di costruzione sociale del mercato.
Ci soffermeremo invece ora su un aspetto importante della political economy degli anni ’70, cioè
sulle conseguenze sul piano metodologico di questa letteratura per il chiarimento del concetto di
regolazione dell’economia e per l’analisi della variabilità delle forme di regolazione.
3.2 Principi e sistemi di regolazione
Sappiamo che è possibile distinguere tre forme di regolazione con le relative istituzioni:
-
scambio di mercato sulla base di prezzi con le istituzioni dei mercati autoregolati;
-
la solidarietà sulla base di obbligazioni condivise (reciprocità di Polanyi) con una vasta gamma
di istituzioni (famiglia, parentela, comunità locale; nelle società moderne anche movimenti o
associazioni volontarie);
-
l’autorità: che si basa sulla coercizione dello stato (redistribuzione di Polanyi) o a livello micro
con l’impresa come organizzazione gerarchica.
Schmitter e Streeck (1985), riflettendo sull’esperienza del neocorporativismo, propongono di
aggiungere la concertazione come forma di regolazione e le associazioni di tipo neocorporativo
come istituzioni che la sostengono. Può essere accettata questa proposta?
Per i due sociologi siccome i “patti” delle organizzazioni degli interessi acquistano rilievo rispetto
alle norme prodotte dallo stato, si può considerare la concertazione neocorporativa come una
variante moderna della redistribuzione.
44
C’è da ricordare che ciascuna economia concreta non si baserà mai soltanto su un’unica forma di
regolazione (già sottolineato da Polanyi e dagli altri classici della sociologia economica a partire da
Sombart) per cui è opportuno distinguere anche tra principi o forme di regolazione e sistemi di
regolazione.
I principio le forme di regolazione riguardano le regole secondo le quali le diverse risorse vengono
combinate nel processo produttivo, il reddito prodotto viene distribuito, i potenziali conflitti tra i
soggetti coinvolti nel processo economico vengono controllati.
Con la categoria di sistema di regolazione ci si riferisce invece alla specifica combinazione e
integrazione tra diverse forme di regolazione che caratterizza una determinata economia.
Abbiamo visto come i classici della sociologia economica abbiano in genere privilegiato
comparazioni nel tempo a elevata generalizzazione (confronti tra capitalismo tradizionale e
moderno, tra capitalismo liberale e organizzato) mentre la political economy comparata sviluppatasi
a partire dagli anni ’70 si muove invece a livelli di astrazione più ridotti, mettendo a confronto le
reazioni alla crisi degli assetti keynesiani di diversi tipi di economie nazionali.
Un’ultima osservazione riguarda la possibilità di usare il concetto di sistema di regolazione anche a
livello microeconomico, per studiare la specifica organizzazione di determinati settori di imprese o
le economie di territori subnazionali.
Un esempio di uso del concetto di sistema di regolazione a livello territoriale si può ricavare dalla
ricerca italiana sullo sviluppo di piccola impresa delle regioni del centro e del Nordest. Ne
parleremo a fondo ma qui ci interessa ricordare che il sistema di regolazione della Terza Italia, nella
fase cruciale del suo sviluppo (anni ’70 e primi anni ’80) è stato ricostruito come una particolare
combinazione tra mercato, reciprocità e scambio politico neolocalistico, che ha coinvolto
associazioni e governi locali.
45
CAPITOLO 4
LA CRISI DEL FORDISMO E I MODELLI PRODUTTIVI FLESSIBILI
Con la political economy comparata si manifesta una ripresa di interesse della sociologia economica
a livello macroeconomico, stimolata dalle difficoltà e dalle trasformazioni dello stato sociale
keynesiano. Contemporaneamente prende forma una problematica teorica e di ricerca che si colloca
più a livello microeconomico e si misura con i cambiamenti nell’organizzazione delle imprese e dei
processi produttivi. Parleremo in questo capitolo della crisi del modello fordista e delle nuove
forme produttive flessibili.
Mentre negli studi di orientamento macro il fuoco era posto sul sistema di rappresentanza degli
interessi, sulla composizione dei governi, sulla struttura e l’efficienza degli apparati pubblici, in
altri studi vengono maggiormente in evidenza i fattori istituzionali che influenzano i processi di
innovazione e di adattamento a condizioni di mercato più incerte e più instabili. In altre parole si
tratta di valutare come le istituzioni influenzino l’offerta più che la regolazione della domanda:
l’innovazione nei prodotti e nei processi produttivi, la crescita dell’imprenditorialità, la formazione
professionale della manodopera, i rapporti di lavoro a livello di azienda e di territorio, la
disponibilità di servizi e infrastrutture per le imprese, e altri aspetti ancora.
Prende corpo una nuova sociologia economica a livello micro, che ha al suo centro le origini e gli
sviluppi di nuovi modelli di organizzazione produttiva basati sulla flessibilità (ricerca empirica).
Sia sul versante dell’economia che di quello sociologico si cerca anche di mettere a punto strumenti
di interpretazione della varietà delle forme di organizzazione e di governo dei processi produttivi
ibride che si formano accanto all’impresa come le joint ventures, le alleanze, i rapporti di
subfornitura (dibattito teorico). Dal lato dell’economia si fa strada un neoistituzionalismo che
ridefinisce la teoria dell’azione tradizionalmente utilizzata dagli economisti, dal lato sociologico
prende forma una nuova sociologia economica a livello micro che lega maggiormente l’emergenza
e il funzionamento delle diverse forme istituzionali a fattori culturali, rapporti fiduciari, reti di
relazioni sociali.
Infine, prenderemo in considerazione un insieme di studi che sviluppano la tradizione di indagine
della sociologia economica sui comportamenti di consumo, non soltanto come espressione di una
ricerca di status (secondo Veblen), ma come processo di costruzione attiva di un’identità che
coinvolge gli stili di vita e i consumi.
1. CRISI E TRASFORMAZIONE DEL MODELLO FORDISTA
46
Nel corso del ‘900 si è affermato un modello di organizzazione economica definito fordista o
fordista-taylorista che ha raggiunto l’apice del suo sviluppo soprattutto nel ventennio successivo
alla seconda guerra mondiale che si basa su grandi imprese le cui caratteristiche principali sono:
1) imprese verticalmente integrate: includono al loro interno diverse fasi produttive che prima
erano svolte da aziende distinte, dal controllo delle materie prime per garantirsi gli input
necessari alla produzione, alla distribuzione dei prodotti ai clienti;
2) produzione di massa: mediante lo sfruttamento della tecnologia e quindi l’utilizzo di macchine
specializzate di sfruttano le economie di scala producendo beni standardizzati in grande quantità
ed a bassi costi unitari;
3) manodopera scarsamente qualificata e organizzazione del lavoro tayloristica: il lavoro è diviso
in compiti semplici e ripetitivi che limitano l’autonomia degli operai. L’impresa funziona come
una grande organizzazione burocratica basata sul controllo gerarchico. Vi è una separazione tra
proprietà dell’impresa ed il ruolo del manager che deve dirigere l’attività produttiva.
I fattori che hanno favorito lo sviluppo di queste imprese sono stati la diffusione dell’elettricità
come fonte di energia a basso costo facilmente distribuibile (che alimenta il mercato di massa) ed il
miglioramento dei mezzi di trasporto e di comunicazione (che favorisce il flusso delle merci).
Non bisogna però immaginare che il modello si affermi uniformemente in tutti i settori produttivi e
che si diffonda con la stessa intensità e gli stessi tempi in tutti i paesi industrializzati:
-
vi sono settori con domanda di beni non standardizzati che porta al persistere di imprese di
dimensioni piccole e medie nel campo delle macchine utensili e delle macchine speciali
(prodotti ad elevata qualità, prodotti che variano notevolmente a causa della moda come nel
tessile, nell’abbigliamento, nel mobilio);
-
vi sono settori con domanda più instabile dovuta a variazioni cicliche in cui di sviluppa una
forma di “decentramento di capacità” attraverso rapporti di subfornitura e i beni vengono
commercializzati dalla grandi aziende. Anche il risparmio sul costo del lavoro favorisce il
decentramento produttivo. Il fordismo quindi può convivere con la presenza di settori in cui vi è
elevata presenza di imprese piccole e medie a gestione più tradizionale (imprenditorialità
personale, macchinari utilizzabili per produzioni multiple, organizzazione del lavoro non
tayloristica, manodopera più qualificata e più vicina all’operaio di mestiere);
-
il mercato nazionale può essere più o meno favorevole alla produzione di massa per motivi che
hanno a che fare con la differenziazione dei gusti e degli stili di vita e quindi con i caratteri della
stratificazione sociale e della cultura nazionale. Il fordismo è nato in America dove vi era un
grande mercato nazionale precocemente unificato dalle infrastrutture di comunicazione e in
particolare dalle ferrovie. Gli Stati Uniti, come paese di grande immigrazione, non segnato dalle
47
differenziazioni sociali tipiche dell’esperienza europea, avevano una popolazione in crescita
molto più incline al consumo di beni standardizzati. Tale manodopera immigrata aveva una
bassa qualificazione per cui era più facilmente impiegabile in metodi di produzione come quelli
fordisti-tayloristi. In Europa il fordismo arriverà più tardi per le ragioni appena esposte,
presenza di imprese di piccole dimensioni spesso integrate in quelli che Marshall chiamò i
distretti industriali.
Nonostante queste differenze, il fordismo presenta nei diversi paesi alcuni tratti simili:
-
l’organizzazione dei processi produttivi come sopra detto;
-
l’estensione della contrattazione collettiva e l’istituzionalizzazione delle relazioni industriali in
modo da attenuare i conflitti e garantire la collaborazione di un’estesa e omogenea classe
operaia nelle fabbriche.
Fordismo a livello micro e stato sociale keynesiano a livello macro sono dunque strettamente
legati.
A partire dagli anni ’70 le trasformazioni del modello fordista sono dovute a fattori che abbiamo già
visto:
-
la saturazione del mercato dei beni di massa riduce lo stimolo alla crescita del fordismo;
-
l’accresciuta concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione con più basso costo del
lavoro nelle produzioni più semplici aumentano la concorrenza;
-
l’impennata dei prezzi del petrolio e delle materie prime non permette più bassi costi per gli
input nei processi produttivi;
-
il venir meno del regime di cambi fissi e la maggiore instabilità che ne consegue sul mercato
internazionale no aiutano la riproduzione del vecchio modello produttivo.
L’esistenza di un sistema di rappresentanza più strutturato di tipo neocorporativo e di pratiche di
concertazione hanno reso meno dirompenti le tendenze di crisi del fordismo in alcuni paesi europei,
mentre laddove mancavano questi caratteri istituzionali (Stati Uniti, Gran Bretagna o Italia) lo
shock è stato più forte e le trasformazioni sono state socialmente più costose.
In ogni caso, anche in contesti di tipo neocorporativo le tendenze di trasformazione del fordismo
non sono state frenate e ciò è stato dovuto:
-
al crescere della domanda diversificata di beni di maggiore qualità sia per l’aumento dei redditi
che per il formarsi di nuovi gruppi sociali istruiti che sviluppano nuovi stili di vita e modelli di
consumo;
-
all’introduzione delle nuove tecnologie elettroniche che permettono l’utilizzo di macchine a
controllo numerico che possono essere programmate per compiti diversi mediante il software.
48
Ciò permette un sensibile abbassamento dei costi della produzione flessibile, la produzione di
beni non standardizzati di elevata qualità, in serie limitate, ed a costi più bassi.
Sia i cambiamenti del mercato che quelli della tecnologia pongono dunque le condizioni per una
reazione delle imprese alla nuova situazione che può giocare sulla flessibilità, la diversificazione
dei modelli e la qualità. È quindi possibile vendere beni di elevata qualità, prodotti in quantità
limitate e soggetti a rapido cambiamento, per i quali i consumatori sono disponibili a pagare prezzi
più elevati. Ciò consente di sfuggire alla concorrenza dei paesi a più basso costo del lavoro in
produzioni di massa.
Questo non vuol dire che la produzione di massa e il modello fordista siano abbandonati dalle
imprese dei paesi più sviluppati; c’è chi si muove verso la produzione flessibile ma c’è chi cerca di
ridefinire il modello fordista ed occupare gli spazi che rimangono per la produzione di massa sia nei
paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.
Vi sono due tendenze che possono variamente combinarsi tra loro:
-
l’uso delle nuove tecnologie per riadattare il modello fordista: si tratta di strategie di
adattamento neofordiste definite anche come produzione flessibile di massa che consiste
nell’incrementare le varianti di un prodotto senza abbandonare il modello che prevede la
separazione tra concezione ed esecuzione e un’organizzazione rigida del lavoro. Si introducono
anche nuove tecnologie (macchine automatiche come i robot). Si parla anche di neotaylorismo
informatizzato;
-
l’utilizzo della multinazionalizzazione: le imprese della produzione di massa investendo
direttamente all’estero e specie nei paesi in via di sviluppo cercano di ritrovare le condizioni di
vantaggio prima presenti nei paesi più avanzati (un mercato in crescita e condizioni di più basso
costo del lavoro).
2. MODELLI PRODUTTIVI FLESSIBILI E CONTESTO ISTITUZIONALE
Un particolare contributo allo studio di questo cambiamento lo dobbiamo a Michael Piore e
Charles Sabel (1984) che introducono il modello della specializzazione flessibile contrapponendolo
a quello fordista e che sottolineano anche successivamente tre aspetti da mettere meglio a fuoco:
-
la possibile persistenza della produzione di massa nei termini prima ricordati del neofordismo;
-
le forme di specializzazione flessibile praticate dalle grandi imprese, oltre che dalle piccole, con
la loro trasformazione interna e la maggiore apertura a rapporti di collaborazione con imprese
esterne;
-
l’analisi più approfondita e dettagliata dei fattori istituzionali che consentono le forme di
cooperazione tra management e lavoratori, quelle tra le imprese, e le buone condizioni di lavoro
e gli alti salari.
49
Vedremo dapprima il fenomeno delle piccole imprese e dei distretti industriali, poi i modelli più
legati alla trasformazione delle grandi imprese, infine l’altra faccia della flessibilità che può portare
forme di organizzazione con bassi salari e condizioni sfavorevoli per la manodopera che tendono a
sfociare nell’economia informale.
2.1 Piccole imprese e distretti industriali
diversi esempi di distretti di piccola impresa sono stati segnalati dalle ricerche condotte in vari paesi
(Sabel 1988) ma particolare interesse ha suscitato il fenomeno in Italia, data la sua diffusione, che
ha permesso l’elaborazione del concetto di distretto proprio nel contesto italiano.
•
I distretti industriali in Italia
Nel corso degli anni ’70 si nota una forte crescita delle piccole imprese, particolarmente concentrata
nelle regioni del centro (Marche, Toscana) e del Nordest (Veneto) che vengono denominate Terza
Italia per distinguerle dal Nordovest (zone della prima industrializzazione e delle grandi imprese) e
dal sud dove il processo di industrializzazione era rimasto fortemente limitato.
Le piccole imprese sono concentrate in sistemi locali (aree urbane di dimensioni ridotte, in genere
non superiori ai 100.000 abitanti, fatte di uno o più comuni vicini) con un mercato del lavoro
integrato e un certo grado di specializzazione settoriale: i settori presenti sono quelli tradizionali
(tessile, abbigliamento, calzature, mobilio, ceramica, ecc.) ma non mancano quelli più moderni
(meccanica e macchinari). Si parla quindi di distretti industriali (concetto ripreso da Marshall)
quando siamo in presenza di specializzazione settoriale e integrazione tra piccole imprese che
danno luogo a una divisione specialistica del lavoro. In un distretto ciascuna piccola impresa si
specializza in una particolare fase o nella produzione di una particolare componente del processo
produttivo e solo un numero più ridotto di aziende ha però rapporti diretti con il mercato finale; esse
ricevono gli ordini e decidono le quantità e le qualità di beni da produrre coordinando l’intero
processo.
La capacità di rispondere in modo flessibile ai cambiamenti del mercato si basa:
-
sui rapporti di cooperazione e non solo sull’uso delle nuove tecnologie da parte delle singole
aziende;
-
sulla capacità di innovare e migliorare la qualità dei beni prodotti mediante economie esterne
alle singole aziende ma interne all’area in cui esse sono localizzate. Marshall parlava di
atmosfera industriale che si caratterizza per la circolazione e diffusione rapida di conoscenze e
informazioni e per lo sviluppo di continue innovazioni incrementali (risorse cognitive) oltre che
l’influenza di fattori di natura culturale ed istituzionale.
I fattori istituzionali sono tre:
50
1) una rete di piccoli e medi centri nei quali vi erano tradizioni artigianali e commerciali diffuse,
non erose dalla prima industrializzazione, dall’urbanesimo e dall’immigrazione; importante è
anche il ruolo di buone scuole tecniche locali);
2) i rapporti di produzione in agricoltura prima dell’industrializzazione, specie la presenza della
famiglia appoderata nelle campagne (mezzadria e piccola proprietà contadina) che ha sostenuto
la formazione originaria di un’offerta di lavoro flessibile, a costi ridotti, e conoscenze e
motivazioni congruenti con lo sviluppo di piccola impresa;
3) presenza di subculture politiche territoriali dovute alla forte presenza di tradizioni e istituzioni
politiche locali legate al movimento cattolico e a quello socialista e comunista. Queste hanno
contribuito a rafforza un tessuto fiduciario molto importante per lo sviluppo di piccola impresa
ed hanno influenzato le relazioni industriali e l’attività dei governi locali (relazioni industriali di
tipo cooperativo e localistico).
È evidente che la produzione richiede un elevato grado di cooperazione tra le imprese e tra
imprenditori e lavoratori all’interno delle unità produttive; una cerca concorrenzialità all’interno
delle singole fasi produttive che è però mitigata da meccanismi di cooperazione (es. nella
subfornitura il committente o il subfornitore non “tirano troppo la corda” , cioè non massimizzano
l’utilità a breve termine ma puntano su vantaggi reciproci nel lungo termine grazie al tessuto
fiduciario in cui operano).
L’attività dei distretti dipende dalla capacità di produrre beni collettivi che ciascuna unità
produttiva non è in grado di realizzare da sola, ma dai quali dipende lo sviluppo complessivo; ma la
singola impresa non può sviluppare al suo interno una serie di servizi che sono necessari per
l’innovazione e la crescita della produttività (formazione
professionale, diffusione delle
informazioni sui mercati, promozione delle esportazioni, smaltimento dei rifiuti industriali) per cui
devono intervenire dei centri di servizio creati e gestiti dalle organizzazioni imprenditoriali locali
con la partecipazione anche delle organizzazioni sindacali oppure servizi svolti direttamente o
indirettamente dagli enti locali e regionali.
Anche per quel che riguarda il mercato del lavoro sono all’opera forme di cooperazione: elevata
flessibilità interna in termini di orari e straordinari, disponibilità a svolgere compiti diversi e a
contribuire alla qualità della produzione, elevata mobilità del lavoro tra le imprese. L’accettazione
di questo tipo di relazioni di lavoro è certamente favorita dal particolare tessuto culturale e
comunitario ed alle relazioni industriali di tipo cooperativo prima ricordate. La costruzione sociale
del mercato è un aspetto cruciale del successo dei distratti nella specializzazione flessibile.
•
Distretti e istituzioni
51
Il caso italiano ha avuto un ruolo di particolare rilievo nella letteratura sullo sviluppo delle piccole
imprese e dei distretti ma tale fenomeno in questione è stato segnalato anche in contesti diversi: in
vari paesi europei, negli Stati Uniti, in Giappone. Diversi contributi hanno cercato di mettere in
evidenza i principali tratti comuni ricavabili dalle ricerche sui vari paesi come segue:
1) gli aspetti cognitivi che influiscono sulle conoscenze e sulla formazione dell’imprenditorialità
come le tradizioni artigianali precedenti e le buone scuole tecniche (in Italia) o la vicinanza di
istituzioni di ricerca pubbliche o private legate a grandi imprese o alla presenza di importanti
università
che sviluppano intensi scambi con le imprese (la Silicon Valley vicino a San
Francisco specializzata nella produzione di semiconduttori; il Baden-Wurttemberg in
Germania);
2) la dimensione normativa: la capacità di cooperazione e la disponibilità di un tessuto fiduciario
sono risorse cruciali che possono avere una matrice religiosa o politica o ancora di tipo etnico. Il
radicamento territoriale consente interazioni più dirette e forme di circolazione delle
informazioni e di monitoraggio dei comportamenti che alimentano la fiducia e consentono di
isolare rapidamente e di sanzionare con meccanismi di esclusione coloro che si allontanano
dalle aspettative condivise;
3) l’esistenza di istituzioni e servizi che permettano la riproduzione nel tempo delle risorse
cognitive e normative (centri per la diffusione della tecnologia, per la formazione
imprenditoriale e del lavoro, conoscenze dei mercati, promozione delle esportazioni, ecc.;
4) per quanto riguarda i tipi di regolazione del lavoro possiamo trovare due situazioni tipiche:
condizioni salariali e di lavoro che possono essere anche sfavorevoli ma che si accompagnano a
elevate possibilità di mettersi in proprio da parte dei lavoratori dipendenti oppure relazioni
industriali più istituzionalizzate ma a carattere cooperativo che spingono verso forme di
flessibilità più contrattata e compensata (es. Italia).
Il successo nell’adattamento alle sfide esterne non è dato una volta per tutte ma deriva dalla
capacità degli attori locali di continuare a interagire efficacemente per trovare nove soluzioni, per
produrre nuovi beni collettivi da cui dipende il benessere della società locale.
2.2 La trasformazione delle grandi imprese
Dopo la scoperta dei distretti industriali l’indagine si è estesa anche alla trasformazione delle grandi
imprese verso modelli di produzione flessibile. L’esperienza di paesi come la Germania ed il
Giappone è importante perché è stata più diffusa e più anticipata.
Il punto di partenza di tale processo è costituito dalla crescente instabilità e frammentazione dei
mercati che riduce la prevedibilità che era il requisito essenziale del modello fordista e la possibilità
52
di elevati investimenti in macchinari specializzati che rischiano di non essere ripagati per i rapidi
cambiamenti della domanda e l’obsolescenza dei prodotti.
Le imprese dunque puntano su vari cambiamenti:
-
decentramento dell’autorità in modo da avvicinare le unità operative agli stimoli del mercato.
Le unità centrali diventano più snelle e si occupano solo delle decisioni strategiche. Si
smantellano i laboratori centrali di ricerca creando delle strutture simili a livello delle unità
operative in modo da avvicinare concezione ed esecuzione. Le unità operative diventano come
delle aziende semiautonome che presidiano determinate produzioni mentre dal punto di vista
finanziario la grande impresa, spesso multinazionale, si trasforma in una holding che controlla
le società specializzate nei diversi prodotti;
-
cambiamento dell’organizzazione del lavoro: vengono messi in discussione i modelli tayloristi
a favore del just in time (riduzione degli scarti, dei tempi morti, delle scorte), di un’elevata
collaborazione della manodopera che diventa più qualificata ed abituata ad operare in squadra;
-
potenziamento della collaborazione con sub-fornitori: le grandi multinazionali tendono a
concentrarsi di più sullo sviluppo di alcune tecnologie chiave, sul design e sull’assemblaggio
complessivo del prodotto facendo produrre le parti complementari da una rete di subfornitori i
quali tendono a decentrare le parti più semplici ad un rete di subfornitori di secondo livello.
Affinché la collaborazione con i subfornitori sia più efficace si lasciano lavorare con più
committenti in modo che siano più stimolati dal mercato a migliorarsi e possano mantenersi con
diverse commesse nei momenti in cui un committente è in crisi;
-
l’importanza dei fattori culturali e istituzionali (cognitivi e normativi): importante è il
potenziamento della capacità di apprendimento attraverso una più intensa e più efficace
cooperazione tra le varie strutture e i vari soggetti che lavorano nell’ambito dell’impresa (nel
caso giapponese, per effetto di una concezione dell’impresa come comunità, più che come rete
di contratti, e per l’attenzione alla formazione professionale della manodopera; nel caso tedesco,
per effetto delle procedure della “codeterminazione” che prevedono un coinvolgimento
formalizzato dei lavoratori nella gestione dell’impresa, e inoltre per la formazione
professionale). Il potenziamento delle risorse cognitive attraverso la cooperazione è favorito da
particolari risorse normative, cioè da regole istituzionalizzate che incentivano nei lavoratori un
comportamento cooperativo. Lo strumento dell’impiego a vita nelle grandi imprese, il ruolo di
un sindacalismo di azienda di tipo cooperativo, il peso di aspetti della retribuzione legati
all’andamento dell’impresa, sono tutti fattori che in Giappone sostengono la cooperazione. In
Germania, relazioni industriali molto istituzionalizzate in azienda, anche se con sindacati più
integrati a livello di settore e a scala nazionale, svolgono una funzione simile. Le aziende sono
53
aiutate dall’esistenza di istituzioni esterne di natura pubblica o mista, che sono impegnate
efficacemente nella formazione e riducono i costi dell’investimento privato;
-
maggiore apertura alle collaborazioni esterne: è un altro aspetto della strategia di
potenziamento delle risorse cognitive, che spinge le imprese a cercare contatti con reti di
subfornitori specializzati, che sono di solito di piccole dimensioni e sono localizzati in aree di
specializzazione produttiva o in veri e propri distretti. Quindi la possibilità per le grandi imprese
di sperimentare la specializzazione flessibile è condizionata dall’esistenza di piccole e medie
imprese esterne.
Le tendenze che abbiamo esaminato indicano come la sperimentazione di modelli flessibili porti a
una certa convergenza tra la variante basata sui distretti e quella centrata sulle grandi imprese
(Streeck ha introdotto il concetto di produzione diversificata di qualità che può essere realizzata sia
da grandi imprese che utilizzano tecnologie flessibili che da piccole e medie imprese). Si allentano
così i confini tra grandi e piccole imprese.
Abbiamo già sottolineato come il nuovo modello non è soltanto tecnologico ma anche un nuovo
modello organizzativo a rete: i distretti possono essere visti come reti di piccole e medie imprese
mentre la grande azienda si trasforma in impresa-rete.
Le reti funzionano come sistemi di apprendimento, cioè come insiemi di relazioni formali e
informali che potenziano le capacità di rapido aggiustamento rispetto al mercato. Nell’impresa
gerarchica fordista decide i propri obiettivi produttivi e li impone al mercato; nel nuovo sistema
invece è il mercato, diventato instabile e frammentato, che impone processi di aggiustamento più
rapidi e costosi. Le reti permetto di potenziare la velocità di aggiustamento e le capacità di
apprendimento, e insieme di ridurre i costi dei nuovi prodotti, distribuendoli su un più ampio
ventaglio di soggetti e abbassando quindi i rischi. La centralità che assume la capacità di
cooperazione nei modelli flessibili rende le imprese, grandi e piccole, che vogliono perseguirli più
dipendenti dall’ambiente sociale nel quale sono inserite.
2. L’ECONOMIA INFORMALE
Possiamo definire l’economia informale come l’insieme di attività di produzione e distribuzione di
beni e servizi che sfuggono in tutto o in parte alla contabilità nazionale.
Possiamo valutare l’economia informale sulla base di tre dimensioni: i metodi di produzione di beni
e servizi; il tipo di beni e servizi prodotti; l’orientamento al mercato degli stessi:
1) economia informale nascosta: produzione con metodi contrari alla legge (lavoro non registrato
o evasione fiscale) di beni leciti e rivolti al mercato;
2) economia informale criminale: produzione con metodi contrari alla legge di beni illegali rivolti
al mercato;
54
3) economia informale domestica-comunitaria: produzione con metodi legali di beni leciti ma
non rivolti al mercato (per autoconsumo familiare o della comunità).
Perché la distinzione regga è necessario che ci sia un’economia formale definita da regole
giuridiche precise e applicate che delimitano e organizzano le attività economiche per il mercato.
A partire dalla seconda metà degli anni ’70 l’attenzione della sociologia economica è andata in
misura crescente alla diffusione dell’economia informale, specie nei paesi sviluppati. In assenza di
informazioni e misurazioni precise è difficile dire con precisione se e in che misura le attività
dell’economia informale siano cresciute negli ultimi decenni.
Si parla dell’ipotesi che i problemi e le trasformazioni della produzione di massa abbiano
alimentato l’economia informale come forma di adattamento dei lavoratori alle accresciute
difficoltà occupazionali (ma anche mediante il doppio lavoro) ma ciò può essere dovuto anche alle
difficoltà dei sistemi di welfare che non riesce più a soddisfare la richiesta di nuovi bisogni sociali
per cui si incrementano l’autoproduzione familiare o comunitaria di beni e servizi per sopperire alla
carenza della copertura pubblica (es. prestazioni di cura ad anziani, bambini, malati, portatori di
handicap); altro fattore può essere l’elevato costo dei servizi finali offerti sul mercato per la
manutenzione o riparazione di beni come la casa o le attrezzature più diffuse tra le famiglie come
gli elettrodomestici.
Le logiche che alimentano l’economia informale sono diverse ma tutte accomunate dal ricorso a
forme di reciprocità come modalità regolative prevalenti.
Oltre alle condizioni di carattere generale un ruolo cruciale per la diffusione dell’economia è
giocato dal contesto istituzionale:
-
le reti di relazioni fiduciarie sono essenziali perché i rapporti delle imprese con gli acquirenti
finali, con le altre imprese, con i lavoratori, presuppongono un elevato grado di fiducia (in
assenza di contratti legali non si può chiedere l’intervento pubblico in caso di violazione del
patto);
-
il radicamento territoriale è un aspetto essenziale di queste forme di economia perché è sul
territorio che si possono sviluppare meglio quelle reti di relazioni e di conoscenze che
permettono la mobilitazione delle risorse ed anche il monitoraggio dei soggetti coinvolti e le
sanzioni di esclusione a carico di coloro che rompono i legami fiduciari (ciò avviene in quartieri
di grandi metropoli moderne come New York, San Francisco, Miami e molte altre città
caratterizzate da comunità etniche e da gruppi di immigrazione a forte coesione interna; ma
avviene anche in aree più arretrate come nel Mezzogiorno in Italia, in Spagna ecc.). Molte volte
i più deboli, come gli immigrati, accettano condizioni di lavoro gravosi e malpagati con la
55
prospettiva di un processo di mobilità sociale futuro basato sulla creazione di piccole imprese
autonome a base familiare.
•
La via alta e la via bassa
Possiamo dire che si intravede una via alta alla flessibilità, capace di dinamismo, innovazione e
condizioni di lavoro più favorevoli in produzioni diversificate e di qualità. Essa può essere centrata
su reti di imprese (i distretti) o su imprese-rete. I paesi più sviluppati la mettono in atto in quanto
non possono essere competitivi con quelli più arretrati per quanto riguarda le produzioni
standardizzate.
Vi è poi la via bassa alla flessibilità che gioca molto su condizioni di impiego e di costo del lavoro
per rafforzare la competitività di prezzo in produzioni di minore qualità, che spesso si radicano in
tutto o in parte nell’economia nascosta (evasione delle norme fiscali e di quelle che regolano i
rapporti di lavoro). Perché questo avvenga non bastano condizioni di disoccupazione diffusa, di
carenza di reddito o di scarsa copertura del welfare, ma necessitano un complesso di risorse
cognitive e normative che non sono sempre presenti.
56
CAPITOLO 5
LA NUOVA SOCIOLOGIA ECONOMICA
Gli studi di sociologia economica a livello micro non sono stati alimentati solo dalle ricerche sui
modelli di organizzazione produttiva flessibile. Un importante contributo è venuto dal dibattito
teorico sulla varietà delle forme di organizzazione delle attività economiche. In contrasto con le
spiegazioni proposte dal neoistituzionalismo economico, e in particolare dalla teoria dei costi di
transazione, la nuova sociologia economica mette in luce il ruolo delle reti sociali e del capitale
sociale, e quello dei fattori culturali nel plasmare l’organizzazione delle attività produttive e dei
servizi.
Nell’ultimo ventennio del Novecento economisti e sociologi hanno cercato di sviluppare nuovi
strumenti per analizzare la crescente varietà dei modelli di organizzazione economica; gli uni e gli
altri sono stati mossi dall’insoddisfazione nei riguardi delle teorie tradizionali prevalenti nelle
rispettive discipline.
1. IL NEOISTITUZIONALISMO ECONOMICO
La microeconomia tradizionale opera a un livello di astrazione troppo elevato per poter spiegare
efficacemente la fenomenologia concreta dell’organizzazione economica e tende a rinviare la
questione a determinanti tecnologiche concentrandosi sullo studio del mercato. Questa soluzione è
insoddisfacente per spiegare perché alcune “transazioni” (scambi di beni e servizi) avvengano nel
mercato e altre vengano internalizzate nell’impresa, e perché in alcuni casi l’impresa cresca e si
affidi maggiormente alla gerarchia e in altri resti di piccole dimensioni. Il nuovo approccio vede nel
mercato, nell’impresa, o nelle forme di collaborazione tra aziende, delle istituzioni economiche che
possono essere spiegate come “reti di contratti” tra soggetti volti a massimizzare il proprio
interesse. A differenza del modello neoclassico tradizionale, si ipotizza però l’esistenza di costi di
transazione variabili, dovuti a condizioni di incertezza e a carenza di informazioni, che possono
creare spazi più o meno grandi per comportamenti opportunistici. Da qui emergono una serie di
accorgimenti contrattuali volti a ridurre i costi di transazione che si presentano nelle diverse
situazioni di scambio economico.
L’analisi dei costi di transazione
Tra gli studi riconducibili al neoistituzionalismo economico ci soffermiamo sull’economia dei
costi di transazione di Oliver Williamson (1986) perché è quello che fa più riferimento a variabili
non economiche e sostiene la necessità di una maggiore collaborazione con la sociologia.
L’economista americano sostiene che per comprendere i costi di transazione non è sufficiente
riferirsi ai fattori ambientali, in particolare al mercato, ma occorre prendere in considerazione anche
57
i fattori umani. È indispensabile superare i postulati della piena razionalità e della condotta
ottimizzante dei decisori, propri del modello economico tradizionale passando al concetto di
razionalità limitata (formulato da Herbert Spencer) per caratterizzare informa più realistica le
decisioni dei soggetti economici (in pratica, è impossibile conoscere tutte le alternative e tutte le
loro possibili conseguenze quando si deve prendere una decisione per cui la razionalità è sempre
limitata e mira a ottenere risultati soddisfacenti piuttosto che ottimali, basandosi sulla selezione di
un ristretto numero di informazioni). È anche necessario tenere conto della tendenza
all’opportunismo cioè della mancanza di sincerità e onestà negli scambi che può portare al
perseguimento del proprio interesse con l’inganno.
Quando tra i fattori ambientali prevalgono condizioni di incertezza, si fanno spazio i vincoli
derivanti dai fattori umani (razionalità limitata e opportunismo) per cui si manifestano dei costi di
transazione e l’impresa può decidere di coordinare per via gerarchica tali attività attraverso
l’internalizzazione (al contrario invece ricorrerà maggiormente al mercato).
………. Vedi sociologia dell’organizzazione
2. LA NUOVA SOCIOLOGIA ECONOMICA
Nella nuova sociologia economica confluiscono approcci diversi, tra i quali distingueremo in
particolare quello centrato sulle reti sociali e quello che si può definire più specificamente come
neoistituzionalismo sociologico. Prima di esaminare il contributo di questi filoni è però opportuno
sottolineare ciò che li unisce e insieme li distingue dal neoistituzionalismo economico.
Possiamo fare riferimento a due aspetti tra loro collegati:
-
la teoria dell’azione come socialmente orientata: criticano l’atomismo e l’utilitarismo che resta
prevalente nell’economia istituzionale. Riprendendo una distinzione proposta da Mark
Granovetter (1985) si può dire che la critica della nuova sociologia economica prende uguali
distanze da una visione in cui il comportamento dei soggetti è fortemente condizionato dalla
cultura e dalle norme introiettate con il processo di socializzazione. L’approccio strutturale
sottolinea maggiormente la collocazione dei soggetti nelle reti sociali, come fattore che
condiziona l’interazione e gli orientamenti mentre il neoistituzionalismo sociologico dà invece
più peso alle componenti cognitive e normative della cultura che si producono e riproducono
nell’interazione sociale;
-
la varietà delle forme di organizzazione economica: entrambe le posizioni condividono la
critica all’economia istituzionale per quel che riguarda le origini delle varie forme di
organizzazione economica che non appaiono riducibili alla ricerca razionale di soluzioni
58
efficienti per minimizzare i costi di transazione, ma che risentono del radicamento sociale
dell’azione economica (per i sostenitori dell’approccio strutturale vale l’influenza autonoma
esercitata dalle reti in cui i soggetti sono inseriti; per i neoistituzionalisti bisogna fare
riferimento all’embeddedness cognitiva e normativa dell’azione e quindi al ruolo autonomo
della cultura).
2.1 L’approccio strutturale e le reti sociali
Per gli autori riconducibili all’approccio strutturale l’azione è sempre socialmente orientata e non
può essere spiegata soltanto sulla base di motivazioni individuali. Il radicamento sociale è visto in
termini strutturali perché si assume che l’azione sia fondamentalmente influenzata dalla
collocazione dei singoli soggetti nelle reti di relazioni sociali in cui sono coinvolti. Tra i diversi
autori, Mark Granovetter (1085) ne ha chiarito sia i presupposti metodologici che le conseguenze
applicative.
Egli critica la teoria dell’azione prevalente di Williamson e la nuova economia istituzionale in
genere perché hanno una visione iposocializzata dell’attore, si pensa che l’opportunismo possa
essere tenuto sotto controllo da istituzioni efficienti che hanno lo scopo di minimizzare i costi di
transazione. Altri economisti invece hanno una visione ipersocializzata dell’attore simile a quella
parsonsiana e pensano che sia importante la fiducia per lo svolgimento ordinato delle attività
economiche e che questo problema sia risolto dalla presenza diffusa di una “moralità
generalizzata”, cioè di norme di comportamento che vengono interiorizzate dai soggetti. Per
Granovetter entrambi le posizioni non sono soddisfacenti perché tendono a trascurare il
meccanismo principale attraverso il quale viene tenuto sotto controllo l’opportunismo e limitata la
disonestà. Con la nozione di embeddedness sottolinea i ruolo delle relazioni personali concrete e
delle strutture di tali relazioni nel generare fiducia e nello scoraggiare la prevaricazione.
L’inserimento dei soggetti in stabili reti di relazioni personali permette di diffondere le
informazioni e di tenere sotto controllo il comportamento, generando fiducia e isolando
rapidamente coloro che non la meritano. Per Granovetter, e per i seguaci dell’approccio strutturale
in genere, le forme di organizzazione economica non possono essere spiegate come risposte
efficienti al problema dei costi di transazione da parte di soggetti che perseguono razionalmente il
loro interesse ma sono invece socialmente costruite, nel senso che riflettono i condizionamenti
derivanti dall’esistenza e dai caratteri delle reti di relazioni sulle scelte dei soggetti. Continua
criticando Williamson perché sopravvaluta la capacità della gerarchia e dell’impresa di gestire
transazioni complesse (sottovalutando il mercato) quando l’evidenza empirica invece mostra che
anche transazioni complesse e potenzialmente rischiose possono essere condotte attraverso il
59
mercato se esistono delle reti di relazioni fiduciarie che legano le imprese coinvolte e quindi
abbassano autonomamente i costi di transazione. Al contrario, transazioni semplici che si svolgono
in mercati concorrenziali tendono ad assumere spesso un carattere stabile e ripetuto perché si
radicano in reti di relazioni personali tra fornitori e clienti. Il ricorso al mercato, alla gerarchia o a
forme intermedie sarà dunque autonomamente influenzato dall’esistenza e dai caratteri delle reti
sociali. Questa prospettiva permette di evitare i rischi di una spiegazione funzionalista in termini di
efficienza delle istituzioni economiche. L’adattamento istituzionale sarà mediato dal ruolo delle reti
di relazioni sociali che possono essere più o meno presenti e possono favorire o meno determinate
soluzioni (le reti di relazione possono impedire comportamenti scorretti ma possono anche
facilitarli come abbiamo visto nelle forme di economia criminale o nell’insider trading).
L’approccio strutturale ha trovato applicazione empirica in campi diversi, occorre ricordare uno
studio pionieristico dello stesso Granovetter sull’influenza delle reti sociali nel favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro: egli mostra l’importanza dei contatti informali come strumento per
trovare lavoro ed attira l’attenzione sulla forza dei legami deboli (i soggetti inseriti in relazioni
sociali deboli hanno più possibilità di accesso a un numero maggiore e più diversificato di
informazioni rispetto a quelle ottenibili attraverso legami “forti” con i familiari, parenti e amici
intimi perché i conoscenti hanno maggiori probabilità di essere inseriti in cerchie sociali diverse).
Un altro contributo teorico è stato quello della sociologia dei mercati (1994) la cui idea di fondo è
che le imprese non sono, come pensa l’approccio tradizionale, isolate e indipendenti le une dalle
altre ma si inseriscono in una rete di relazioni tra di esse. Importanti sono i condizionamenti
esercitati dalle altre imprese presenti in un determinato mercato di beni sulle specifiche strategie di
differenziazione dei prodotti per ritagliarsi una nicchia di mercato (i produttori si tengono sotto
stretta osservazione al fine di determinare la strategia più vantaggiosa in termini di qualità-prezzo
dei beni offerti.
2.2 Il capitale sociale
L’approccio strutturale sottolinea l’influenza delle reti sociali sul comportamento economico in
ambiti diversi (dimensioni delle imprese, rapporti tra imprese, mercato del lavoro, mercato dei beni
e servizi) che può favorire la cooperazione legale ma anche quella illegale.
Il concetto di capitale sociale come insieme delle relazioni sociali di cui un soggetto individuale
(es. un imprenditore o un lavoratore) o un soggetto collettivo (privato o pubblico) dispone in un
determinato momento, si ricollega allo sviluppo economico.
È grazie a James Coleman (1990) che il concetto comincia a diffondersi ma successivamente viene
esplicitamente utilizzato da Pierre Bourdieu (1980 – 2002). Un uso implicito ben più lontano lo si
deve a Max Weber (Le sette protestanti e lo spirito del capitalismo 1906) che sostiene che le sette
60
protestanti hanno avuto notevole influenza sulle origini dello sviluppo economico americano in
quanto come associazioni volontarie hanno esercitato un forte controllo sugli individui che vengono
ammessi a farne parte ed inculcano loro determinate qualità etiche che facilitano gli scambi
economici. Pur non parlando di capitale sociale, utilizza di fatto l’idea di reticoli sociali come
strumento che può influire sulla formazione dell’imprenditorialità e quindi favorire lo sviluppo
economico di una determinata area.
Coloro che usano i concetto di capitale sociale (implicitamente o esplicitamente) mettono in
evidenza le possibili conseguenze positive delle reti di relazioni sociali per le attività economiche
ma tale esito non è scontato come ha sottolineato Granovetter, Coleman e Portes; le reti possono
essere anche strumento che aggira o elude la concorrenza attraverso forme di collusione, più o
meno legali, tra i soggetti.
Spostandosi dal livello individuale a quello aggregato si potrà poi dire che un determinato contesto
territoriale risulta più o meno ricco di capitale sociale a seconda che i soggetti individuali o
collettivi che vi risiedono siano coinvolti in reti di relazioni più o meno diffuse (Coleman con
questa definizione insiste sulle reti sociali come base del capitale sociale e non sulla generica
disponibilità di cooperazioni e fiducia radicata in una certa cultura condivisa come sostengono
Putnam e Fukuyama).
Per Coleman il capitale sociale è un bene collettivo che appartiene all’insieme dei soggetti coinvolti
nelle reti di relazioni e non divisibile in quanto i suoi vantaggi non sono appropriabili
individualmente ma vanno a tutti coloro che partecipano alla rete. Proprio perché è un bene
collettivo i singoli soggetti hanno un minor incentivo a contribuire alla sua produzione e questo
spiega perché “la maggior parte delle forme di capitale sociale sono create o distrutte come
sottoprodotto di altre attività” (es. l’esistenza di relazioni familiari, parentali, comunitarie, di
appartenenza etnica, religiosa o politica, possono servire da base per la crescita di forme di capitale
sociale spendibile sul piano economico).
Questo non esclude che ci possano essere sforzi consapevoli per creare reti produttive di capitale
sociale per fini economici (es. formazione di clan basati su relazioni informali tra imprese per far
fronte a transazioni complesse; la contrattazione relazionale con accordi formalizzata tra aziende
che abbiamo visto con Williamson). Tuttavia dal punto di vista dello sviluppo economico è la
disponibilità complessiva di capitale sociale in una particolare area ad essere rilevante.
Un’ampia dotazione di capitale sociale a livello aggregato tende ad essere in genere il sottoprodotto
di relazioni sociali extra-economiche presenti in un territorio. Putnam e Fukuyama identificano il
capitale sociale con una particolare cultura che favorisce la cooperazione e mettono in rilievo il suo
radicamento nella storia precedente di un territorio, tale prospettiva comporta però due rischi:
61
-
quello di scivolare in una spiegazione culturalista piuttosto generica delle origini del fenomeno
che trascura il ruolo di fattori politici nei processi di sviluppo (il Mezzogiorno pagherebbe
ancora, in termini di eredità culturale, il fatto di non essere stato segnato dall’esperienza dei
Comuni medievali, diversi secoli fa; ma questa interpretazione trascura come la politica abbia
potuto orientare le reti sociali in tempi più recenti sostenendo il clientelismo, la mafia, ecc.);
-
quello di avere conseguenze negative: vi è sempre un potenziale particolaristico nelle reti che
può portare gli attori ad utilizzare le risorse per perseguire i loro interessi (reti che coinvolgono
criminale, forze dell’ordine o della politica e dell’amministrazione).
Non bisogna interrogarsi sulle origini ma sulle condizioni di impiego a fini di sviluppo del capitale
sociale e soprattutto in che modo la politica ne favorisca la trasformazione o meno in risorse
positive per lo sviluppo locale. La politica deve avere la capacità di modernizzarsi, di funzionare
secondo una logica più universalistica che bilancia e orienta il particolarismo insito nelle reti.
Anche la risorsa costituita da un’identità culturale favorevole può deperire o addirittura regredire a
forme di capitale sociale che ostacolano lo sviluppo, se la politica non fornisce condizioni
appropriate. Non dobbiamo escludere anche la possibilità del formarsi di nuove reti tra soggetti
collettivi che stimolino la formazione di relazioni tra attori individuali.
Una volta avviato un principio di sviluppo locale, la pressione della concorrenza di mercato limita
continuamente le possibili conseguenze negative del particolarismo sanzionando comportamenti
poco efficienti oppure sollecitando un aggiornamento del capitale sociale. Se non avviene
un’adeguata reazione ai segnali del mercato possono emergere fenomeni di chiusura, di localismo
regressivo e di blocco dello sviluppo. Cruciale è il ruolo della politica nel mediare il rapporto tra
reti e mercato; l’idea del bilanciamento tra elementi moderni e reti di relazioni sociali tradizionali
come chiave per lo sviluppo economico può anche aiutarci a leggere meglio le esperienze di
sviluppo regionale degli ultimi decenni.
2.3 Il neoistituzionalismo sociologo
Nell’approccio strutturale la collocazione nella struttura delle relazioni sociali prevale sulle
motivazioni dei soggetti mentre la posizione dei neoistituzionalisti, nell’ambito della nuova
sociologia economica, mette in evidenza il ruolo autonomo dei fattori culturali. Per gli strutturalisti
le reti determinano risorse e vincoli che condizionano il perseguimento razionale degli interessi da
parte dei soggetti, per i neoistituzionalisti i fattori culturali contribuiscono a definire gli interessi
stessi e come vengono perseguiti.
La teoria dell’azione dei neoistituzionalisti critica quella della nuova economia istituzionale, quella
degli strutturalisti e prende le distanze anche dalla teoria ipersocializzata dell’attore di derivazione
parsonsiana. In neoistituzionalismo è fortemente influenzato dall’etnometodologia di Garfinkel
62
(1967) e dall’approccio fenomenologico di Berger e Luckmann (1967), ma anche dalla psicologia
cognitiva. Ciò porta ad enfatizzare la dimensione cognitiva delle istituzioni rispetto a quella
normativa (viene dato più rilievo alle regole “costitutive” rispetto a quelle “regolative”, vedi cap. I
par. 2.2); viene messo dunque in evidenza il ruolo di regole routinarie, largamente date per scontate,
nell’orientare il comportamento.
Quali conseguenze discendono dalla teoria dell’azione del neoistituzionalismo per la spiegazione
delle diverse forme di organizzazione economica?
Di fronte alla carenza di informazioni e ai rischi delle transazioni, non è possibile seguire una
rigorosa scelta razionale delle soluzioni più efficienti (come invece sostiene la nuova economia
istituzionale) per cui i soggetti individuali e collettivi si affidano non solo alle reti, ma alle soluzioni
che sono considerate più appropriate e legittime nell’ambiente nel quale si collocano le loro
interazioni sociali.
Una buona esemplificazione delle conseguenze sul piano applicativo dell’approccio dei
neoistituzionalisti è costituito dal contributo di Powell e DiMaggio (1991) sull’isomorfismo che
cerca di spiegare l’omogeneità dei modelli all’interno di un determinato campo organizzativo
(costituito dall’insieme degli attori rilevanti in un certo campo di attività, imprese che competono in
un determinato settore, organizzazioni sindacali e di categoria, strutture pubbliche; anche se non
direttamente interagenti tra loro).
Essi criticano la teoria ecologica delle organizzazioni (Hannan e Freeman 1977, 1989), di
ispirazione darwiniana, secondo la quale l’omogeneità in un certo campo (es. un settore produttivo)
riflette la selezione delle unità che si adattano meglio alle caratteristiche dell’ambiente esterno in
cui si muovono. Questo avviene più facilmente in settori aperti alla concorrenza di mercato dove è
più forte un isomorfismo competitivo, tuttavia anche in questi settori, e in quelli più distanti dal
mercato di concorrenza, agisce l’isomorfismo istituzionale che può essere di tipo coercitivo cioè
portare a modelli simili a causa vincoli cogenti (da parte dell’antitrust, di norme sul lavoro e la
sicurezza; da parte di imprese committenti verso i subfornitori; causate dalle relazioni industriali).
Può anche svilupparsi un isomorfismo normativo dovuto al ruolo delle università e delle scuole di
specializzazione che formano manager che spostandosi all’interno delle varie imprese possono
diffondere idee e standard professionali di comportamento che assumono elevata legittimità da
parte delle imprese stesse.
L’isomorfismo mimetico invece si ha in settori nei quali le unità organizzative sono piccole e
dispongono di risorse limitate per valutare le soluzioni più efficienti; per cui per ridurre l’incertezza
seguono i modelli che appaiono più appropriati e legittimati nel campo organizzativo.
Naturalmente le diverse forme di isomorfismo possono in concreto combinarsi tra loro.
63
Numerosi contributi sono stati sviluppati anche in settori più distanti dalla concorrenza di mercato,
come le organizzazioni no-profit.
3. CULTURA E CONSUMI
I nuovi sviluppi della sociologia economica sia strutturalista che neoistituzionalista sono rimasti
prevalentemente concentrati sul versante delle attività produttive di beni e servizi tralasciando il
tema dei consumi nonostante il suo rilievo nella tradizione della sociologia economica. Vale la
pena di ricordare un filone di ricerca che negli ultimi decenni ha messo in luce l’influenza dei
fattori culturali sui comportamenti di consumo (anche se questi studi non sono connessi
direttamente al neoistituzionalismo ne condividono largamente l’ispirazione; gli autori coinvolti
sono sociologi, antropologi e storici sociali).
Abbiamo visto come la tradizione della sociologia economica si differenzi dall’approccio
economico di tipo neoclassico sottolineando l’influenza di fattori socioculturali nella formazione
delle preferenze e nelle modalità con le quali i soggetti cercano di soddisfarle (i beni hanno un
valore simbolico e sono scelti e consumati per il significato che essi assumono in relazione ad altri
membri della società con i quali si interagisce e al contempo per differenziarsi da altri gruppi).
Gli
sviluppi
più
recenti
si
caratterizzano
in
una
duplice
direzione:
l’approccio
neodifferenziazionista, che prende in parte le distanze dal modello di ispirazione vebleniana che
lega il consumo alla competizione per lo status sociale; il ruolo autonomo dei fattori culturali.
L’approccio neodifferenziazionista
Jean Baudrillard (1968): nelle società contemporanee la logica della differenziazione sociale (di
cui parlava Veblen) è ulteriormente esasperata dal venir meno delle forme tradizionali di
identificazione (criteri ascrittivi, familiari, di ceto). I modelli di consumo attraverso i quali i soggetti
tendono a differenziarsi sono sempre più mediati dai mezzi di comunicazione di massa ed i
consumatori hanno l’illusione di scegliere liberamente tra questi modelli, ma in realtà sono
fortemente condizionati dal sistema dei media che li impone (sono degli automi sociali che si
adattano passivamente agli stimoli provenienti dall’esterno).
Pierre Bourdieu (1979): anche per lui i comportamenti di consumo rispondono a una logica di
competizione per lo status che spinge a identificarsi con gli stili di vita e i gusti di alcuni gruppi e a
differenziarsi dagli altri. Tuttavia, l’attenzione non si focalizza in questo caso sui media, ma sui
condizionamenti esercitati sugli individui dalla loro posizione nella stratificazione sociale. Rispetto
al modello vebleniano la distinzione sociale è più multidimensionale: accanto al capitale economico
posseduto dai singoli vi è quello culturale (legato alle reti di relazioni). Da questo quadro emergono
gruppi sociali che si distinguono gli uni dagli altri per specifici stili di vita. La combinazione tra
diversi tipi di capitale posseduto favorisce la formazione di un determinato habitus che rappresenta
64
lo strumento essenziale di differenziazione sociale e di status. Anche qui i singoli soggetti sembrano
non disporre di margini di autonomia nella sfera dei consumi per l’influenza dei gruppi sociali di
appartenenza (e non per i media).
Il ruolo autonomo dei fattori culturali
Questo approccio è più incline a considerare i consumi come segni di identificazione, o distacco, o
addirittura di contestazione, nei riguardi dei valori culturali prevalenti (es. le subculture giovanili,
etniche, politiche, religiose). Gli oggetti che sono scelti servono per costruire l’identità delle
persone, per dare un senso alla loro esperienza e per comunicare con gli altri, non necessariamente
per competere.
65
CAPITOLO 6
LA GLOBALIZZAZIONE E LA DIVERSITA’ DEI CAPITALISMI
Se in un primo momento a suscitare l’attenzione degli studiosi sono stati soprattutto i vantaggi delle
economie coordinate di mercato (capitalismo più organizzato tipo quello tedesco e giapponese),
rispetto alle economie non coordinate di mercato (capitalismo di tipo anglosassone), negli ultimi
anni questa immagine e stata rimessa in discussione non solo per i segni di la ripresa dell’economia
americana e britannica, ma più in generale dalla necessità di fare i conti con il fenomeno della
globalizzazione. La crescente interdipendenza e integrazione delle economie a livello mondiale
sembra infatti minacciare gli equilibri dei modelli di capitalismo organizzato, in cui lo spazio del
mercato è maggiormente limitato da altre forme di regolazione, mentre il capitalismo di tipo
anglosassone, che si affida maggiormente al mercato, mostra invece segni di adattarsi meglio,
almeno nel breve periodo, a questa nuova situazione.
1. I DUE CAPITALISMI
Nel corso degli anni ’70 il problema principale che le economie dei paesi sviluppati dovevano
affrontare era costituito dall’inflazione e ciascun approccio dava una soluzione diversa:
-
neocorporativismo: l’accordo dei governi con i grandi interessi organizzati mantengono bassa
l’inflazione e la disoccupazione;
-
modello del decreto: basato su una maggiore autonomia dello stato dagli interessi dava buoni
risultati;
-
sistemi di tipo pluralista: si affidavano maggiormente al mercato (Stati Uniti e Gran Bretagna)
per cui non riuscivano a controllare facilmente l’inflazione.
Tuttavia, una volta riportata sotto controllo l’inflazione, l’attenzione si sposta verso un altro aspetto
che condiziona lo sviluppo economico dei diversi paesi: la capacità di innovazione delle imprese. A
partire dagli anni ’80 i confini delle economie si aprono sempre più, l’economia di una nazione è
maggiormente influenzata da quella delle altre, una quota crescente della produzione è orientata
verso i mercati internazionali, il reddito di un paese diventa più dipendente dalla capacità delle sue
imprese di vincere la concorrenza delle importazioni nei mercati interni e di competere con
successo su quelli esteri. È in questo quadro che agli inizi degli anni ’90 una serie di studi cercano
di mettere a fuoco la diversità di reazione dei capitalismi nazionali alle nuove sfide dell’ambiente.
David Soskice (1989) parte dai limiti del modello neocorporativo per interpretare la nuova
situazione. Il problema cruciale non è più soltanto il controllo dell’inflazione ma la bilancia dei
pagamenti, cioè la capacità delle imprese nazionali di innovare e di aumentare le esportazioni
rispetto alle importazioni. Non si può più puntare soltanto sulle istituzioni che permettono di
contenere i salari con le relazioni industriali a livello centrale, come nel modello neocorporativo,
66
ma si deve guardare alla capacità delle imprese di innovare e di mantenere e accrescere quote del
mercato internazionale. Ciò richiede anche un particolare contesto istituzionale che favorisca lo
spostamento verso produzioni flessibili e di qualità per contrariare la competizione di prezzo che
viene dai paesi in via di sviluppo, con bassi costi del lavoro.
In questa prospettiva, dunque, tendono ad integrarsi maggiormente gli approcci macro e micro che
abbiamo discusso nei due capitoli precedenti.
1.1. La capacità di innovazione delle imprese
Soskice individua 5 condizioni essenziali dalle quali dipende la capacità delle imprese dei paesi più
sviluppati di spostarsi verso una produzione flessibile di qualità, in modo da evitare la
competizione di prezzo legata al costo del lavoro:
1) gestione manageriale orientata a lungo termine: l’innovazione richiede tempo e investimenti a
resa non immediata;
2) competenze professionali qualificate: di tutte le risorse umane;
3) capacità di cooperazione tra management e lavoratori: quindi superamento delle gerarchie
rigide del fordismo;
4) capacità di cooperazione con i clienti e con i subfornitori;
5) contenimento dei salari rispetto alla crescita della produttività
Il passo successivo è quello di mostrare che le condizioni sopra elencate non si determinano per
mera scelta volontaristica del management delle imprese ma sono favorire o ostacolate
dall’ambiente istituzionale esterno alle imprese.
La letteratura sulla varietà dei capitalismi sottolinea in proposito due aspetti:
-
l’origine non meramente contrattuale delle istituzioni: che si formano storicamente e non sono
riducibili alla scelta razionale di soluzioni efficienti da parte degli attori (condivide la posizione
dell’istituzionalismo sociologico). Ciò comporta una visione del cambiamento istituzionale in
cui le capacità di adattamento alle nuove sfide sono strutturate dal percorso storico precedente;
-
la dimensione nazionale: proprio il rilievo dato al percorso storico nel plasmare il patrimonio
istituzionale porta a sottolineare il ruolo che lo stato nazionale continua ad avere nel definire un
complesso istituzionale dotato di una sua integrazione e specificità. Settori differenti all’interno
dello stesso paese mostrano delle somiglianze dal punto di vista organizzativo, chiaramente
influenzate dal contesto istituzionale nazionale. Naturalmente, ciò non vuol dire che la
dimensione subnazionale (in particolare quella regionale) non possa essere anche importante
(vedi distretti industriali italiani).
1.2 Le condizioni istituzionali della competitività
La situazione dei paesi più sviluppati può essere ricondotta a due modelli idealtipici.
67
Soskice (1989) distingue tra:
-
economie coordinate di mercato: nelle quali il ruolo del mercato è più limitato rispetto a quello
dello stato, delle associazioni, di forme di solidarietà a base comunitaria (i paesi che si
avvicinano a questo modello sono Germania, Austria, Svizzera, Olanda, paesi scandinavi,
Giappone);
-
economie non coordinate di mercato: nelle quali il ruolo di regolazione del mercato resta
invece più ampio (paesi anglosassoni come Stati Uniti, Gran Bretagna; Canada, Australia e
Nuova Zelanda).
Michel Albert (1991) ha proposto una suddivisione simile tra modello anglosassone e modello
germano-nipponico (detto anche renano).
Gli studi sulla varietà dei capitalismo vogliono mostrare come le economie coordinate (capitalismi
di tipo renano-nipponico) abbiano offerto un ambiente istituzionale più favorevole all’innovazione
per le imprese dovuto ai seguenti fattori:
1) la finanza e l’assetto proprietario delle imprese: nelle economie non coordinate le esigenze di
finanziamento delle imprese sono soddisfatte prevalentemente attraverso il reperimento di
capitale sul mercato azionario. La proprietà è quindi frazionata e gli azionisti non si sentono
vincolati a lungo termine con l’impresa di conseguenza il management tende a garantire una
redditività a breve per evitare il rischio elevato di acquisizioni ostili dell’impresa che
causerebbero la sostituzione del management a parte dei nuovi detentori del capitale. Tutto
questo ostacola l’innovazione che richiede invece investimenti a resa più rischiosa e dilazionata
nel tempo. Nelle economie coordinate di mercato (Germania e Giappone) invece le esigenze di
finanziamento a lungo termine delle imprese sono soddisfatte principalmente dalle banche, la
proprietà è detenuta da un ristretto gruppo di azionisti che tendono a intrattenere un rapporto di
più lungo periodo con le imprese. In questa situazione il management è meno minacciato dai
rischi di acquisizioni ostili che sono rese molto più difficili dalle regole istituzionali e sono
quindi incoraggiati a intraprendere investimenti e progetti a più lungo termine che stimolano
l’innovazione;
2) la regolazione della formazione professionale: nelle economie non coordinate di mercato
l’addestramento professionale viene affidato alle imprese per la parte più specifica, legata al
particolare tipo di produzione in cui i lavoratori vengono utilizzati, mentre la professionalità di
base che il singolo lavoratore può offrire sul mercato è legata all’investimento che egli è in
grado di fare. Le istituzioni finanziarie sono in genere poco disponibili a concedere prestiti
senza garanzie per un obiettivo come la formazione. L’operare congiunto di questi fattori
determina un livello di formazione professionale più limitato rispetto a quello richiesto dalle
68
esigenze dell’innovazione. Le imprese non investiranno in formazione, al di là delle loro
necessità specifiche e immediate, nel timore che i lavoratori possano poi lasciarle per altre
aziende. Nelle economie coordinate di mercato il problema è risolto non solo con un impegno
maggiore dello stato nella formazione professionale, offerta come servizio pubblico ma
soprattutto attraverso qualche forma di cooperazione con le imprese e le loro organizzazioni. Le
imprese accolgono i lavoratori nel corso del loro addestramento, come avviene in Germania con
il sistema dell’apprendistato (in Giappone la formazione iniziale non porta a una qualificazione
direttamente spendibile sul mercato ma il lavoratore è legato da un rapporto a lungo termine con
l’azienda). Questo sistema risponde dunque alle esigenze di innovazione delle imprese;
3) le relazioni industriali a livello di impresa: nelle economie non coordinate il sistema di
regolazione dei rapporti di lavoro è caratterizzato dalla debolezza delle organizzazioni di
rappresentanza sindacale, da norme giuridiche che pongono bassi vincoli alla licenziabilità della
manodopera; questi fattori portano le imprese a valersi di una elevata flessibilità quantitativa e
numerica, cioè accrescere o ridurre la manodopera rispetto alle esigenze di redditività a breve.
Questo porta ad una scarso coinvolgimento dei lavoratori e degli stessi quadri intermedi che è
una risorsa essenziale per l’innovazione nell’ambito del sentiero della produzione flessibile e di
qualità. Nelle economie coordinate invece esiste un sistema di regolazione dei rapporti di lavoro
più rigido (vincoli alla flessibilità numerica). Le imprese sono incentivate a investire di più in
formazione per valorizzare le risorse umani di cui non possono liberarsi facilmente. Anche in
Giappone l’impiego a vita, il mercato interno del lavoro, la quota elevata della retribuzione
legata ai risultati aziendali costituiscono un fattore no meno importante nell’assicurare la
cooperazione della manodopera;
4) le reti sociali informali e formali legate all’associazionismo imprenditoriale: sono sviluppate
nelle economie coordinate di mercato e favoriscono l’innovazione;
5) il contenimento salariale: nelle economie non coordinate il ruolo dei sindacati è debole per cui
il contenimento salariale deve affidarsi sulla diffusione della disoccupazione come elemento di
pressione sulle rivendicazioni salariale dei lavoratori. Nel caso in cui l’impresa ha esigenza di
disporre di manodopera con qualificazione elevata non ha interesse a licenziare lavoratori che la
possiedono per assumere altri lavoratori non specializzati ad un costo più basso (questo mette in
evidenza come gli insider godano di un vantaggio rispetto agli outsider). L’impresa può
decidere di investire in professionalità per far fronte ad esigenze di innovazione andando
incontro a costi elevati della manodopera oppure può decidere di puntare su lavoratori a basso
costo deprimendo le risorse per l’innovazione.
69
Sul piano teorico viene segnalata la difficoltà del mercato non solo a garantire risultati soddisfacenti
in termini di equità sociale, ma anche di efficienza economica qualora la sua azione non sia
sottoposta a vincoli istituzionali che ne limitino il ruolo a favore di altri principi di regolazione
(stato, associazioni, reti informali).
2. LA RIPRESA DEL CAPITALISMO ANGLOSASSONE
Alla fine degli anni ’80 il quadro appena tracciato viene rimesso in discussione perché:
-
il successo economico di Germania e Giappone ha subìto una battuta d’arresto significativa,
mentre i capitalismi anglosassoni, e soprattutto quello americano, hanno mostrato nuovi segni di
dinamismo, specie dal punto di vista occupazionale;
-
gli sviluppi della globalizzazione ed il processo di unificazione europea hanno sollevato
crescenti interrogativi sulla capacità di resistenza a lungo termine del quadro istituzionale delle
economie coordinate rispetto alle sfide poste dalla globalizzazione (riguardano il ruolo
regolativo in campo economico e sociale degli stati nazionali).
Non c’è dubbio che la crescita dell’economia americana e britannica nel corso degli anni ’90
abbia contribuito a ridimensionare l’immagine del capitalismo di tipo renano-nipponico come
modello vincente sotto il profilo sociale e insieme economico. Gli Stati Uniti hanno creato il più
elevato numero di posti di lavoro nell’ultimo decennio, soprattutto nei servizi, e hanno ridotto ai
livelli più bassi il tasso di disoccupazione. Anche la Gran Bretagna ha avuto un esito positivo ma di
entità più modesta sempre nei servizi privati. Per quanto riguarda l’andamento dell’industria
manifatturiera le tendenze sono più ambigue: in Gran Bretagna non ci sono segni consistenti
rispetto al passato e le capacità innovative si mantengono nel complesso basse; negli Stati Uniti
invece si è avuta una significativa ristrutturazione industriale, la produttività è cresciuta e
l’occupazione è rimasta stabile con uno spostamento verso nuovi settori che ha compensato quelli
in crisi.
L’industria americana mostra alcuni punti di forza nel campo dell’alta tecnologia che sembrano
essersi ulteriormente consolidati (industria aerospaziale, informatica e delle comunicazioni,
biotecnologie, ecc.). L’impegno americano in campo militare alimenta flussi di spesa per la ricerca
e l’innovazione tecnologica in settori di alta tecnologia. Particolare importanza ha poi la diffusione
di strutture universitarie e di ricerca di elevato livello, con connessioni molto strette con il mondo
delle imprese e con frequenti passaggi di personale dal campo della ricerca a quello delle imprese
innovative. Il capitalismo anglosassone si profila come un sistema economico capace di creare
occupazione specialmente nel settore dei servizi privati al consumatore, a basso valore aggiunto.
Questo sarebbe favorito dalla deregolamentazione dei rapporti di lavori e dal declino della presenza
sindacale (che non avviene nel capitalismo più organizzato). Il quadro di dinamismo occupazionale
70
del capitalismo anglosassone va però completato tenendo conto della diminuzione dei salari reali,
della crescente disuguaglianza dei redditi e quindi dell’aumento della polarizzazione sociale (ricchi
sempre più ricchi e poveri sempre più poveri).
Gli elementi che abbiamo ricordato non sono però tali da ribaltare le conclusioni alle quali era
giunto il neoistituzionalismo nell’analisi della varietà dei capitalismi. Il capitalismo anglosassone
non sembra avere maggiore competitività, né tanto meno la capacità di ridurre le disuguaglianze
sociali. Il caso americano mostra come la competitività possa essere compatibile con elevati livelli
di disuguaglianza sociale.
Più che ragionare in termini di superiorità di un modello su un altro occorre dunque guardare alla
possibilità di equilibri multipli con punti di forza e di debolezza diversi. Una società fortemente
caratterizzata in termini culturali dal liberismo individualistico, segnata storicamente dal ruolo
centrale dell’immigrazione e dalla spinta alla ricerca del successo attraverso forme di mobilitazione
individuale-familiare, può accettare livelli di disuguaglianza anche molto superiori rispetto a quelli
tollerati in società con una tradizione culturale e un patrimonio istituzionale diversi, come quelle
europee o anche quella giapponese.
3. CONVERGENZA O DIVERSITA’?
Abbiamo visto che le nuove condizioni di competizione prevalenti a livello internazionale
determinano una progressiva erosione delle istituzioni regolative delle economie coordinate e che i
vantaggi competitivi del capitalismo anglosassone nell’immediato possa mostrare, a più lungo
termine, migliori capacità di adattamento ai vincoli posti dalla globalizzazione.
Si può allora ipotizzare che la globalizzazione implichi un’estensione di modelli regolativi basati
sul mercato?
Vediamo prima una serie di tendenze che alimentano il fenomeno della globalizzazione e
successivamente ne valuteremo le conseguenze per il futuro dei capitalismi.
•
Le componenti della globalizzazione
La fase di bassi tassi di crescita delle economie dei paesi più sviluppati iniziata nei primi anni ’70
continua nel periodo successivo (1975-1995 tasso media di crescita del PIL è stato circa la metà del
periodo 1955-1975).
Questa bassa crescita è però accompagnata da un forte aumento del commercio internazionale
(l’ammontare complessivo dei flussi di scambio annuale tra i diversi paesi tra il 1967 e il 1994 è
cresciuto di 20 volte; il PIL mondiale è cresciuto di circa 10 volte). Ciò vuol dire che la torta da
dividersi tende a crescere poco, mentre la concorrenza tra i vari paesi per aggiudicarsene fette più
ampie aumenta sensibilmente. Per quanto riguarda la produzione mondiale si assiste ad un declino
71
del perso percentuale degli Stati Uniti e dell’Europa e una crescita concentrata soprattutto in
Giappone e negli altri paesi dell'Asia.
Un secondo indicatore della crescente integrazione internazionale dell’economia (oltre al
commercio internazionale) è dato dagli investimenti diretti all’estero in aumento per ricercare
localizzazioni più favorevoli sia per controllare i mercati di sbocco che per godere di condizioni di
vantaggio in termini di costi.
Il terzo aspetto che segna in misura ancor più marcata l’interdipendenza tra le diverse economie è
costituito dall’integrazione dei mercati finanziari. L’internazionalizzazione commerciale ed
industriale stimolano il movimento di capitali che è necessari per finanziare il commercio e gli
investimenti. Inoltre la rottura del sistema monetario internazionale basato sui cambi fissi (primi
anni ’70) ha a sua volta accelerato questo processo facendo crescere fortemente il mercato di
prodotti finanziari come i contratti a termine o opzioni. Ancora, il miglioramento delle
comunicazioni dovuto a nuove tecnologie informatiche abbassa nettamente i costi di transazione e
quindi favorisce l’integrazione in tempo reale tra le principali piazze finanziarie. Sono aumentate
anche le pressioni sui governi nazionali per liberalizzare i movimenti di capitali. Giornalmente si
muovono ingenti masse di capitali nei mercati delle monete, in quelli obbligazionari e azionari, dei
contratti a termine, ecc. (nei primi anni ’90 si spostavano ogni giorno circa 900 miliardi di dollari
mentre le riserve monetarie complessive di tutte le banche centrali non superavano i 700 miliardi).
Se si tiene conto congiuntamente di tutti e tre gli indicatori che abbiamo ricordato (commercio
internazionale, investimenti diretti all’estero, movimento dei capitali) si può cogliere il fenomeno
della globalizzazione economica intesa come crescita del livello di apertura e insieme di
interdipendenza delle diverse economie nazionali.
Ma quali sono le conseguenze sui diversi modelli di capitalismo? E fino a che punto si può
considerare fondata l’idea di una convergenza istituzionale verso modelli più regolati dal mercato?
•
Il futuro dei capitalismi
Suzanne Berger e Ronald Dore (1996) hanno raccolto diversi contributi con l’obiettivo di valutare
la portata dei processi di globalizzazione sul piano empirico e di discutere le implicazioni sul piano
della regolazione istituzionale; essi tendono a non enfatizzare oltre misura la portata del fenomeno.
Nonostante il commercio internazionale e gli investimenti diretti all’estero siano in crescita, come
abbiamo visto sopra, nei paesi più sviluppati di grande dimensioni circa il 90% della produzione
resta ancora rivolto al mercato interno e lo stesso vale per le origini dei prodotti che sono
consumati. Inoltre nelle economie coordinate i paesi più sviluppati che puntano alla produzione
flessibile e di qualità continuano a controllare i processi di innovazione e le fasi produttive a più
72
elevato valore aggiunto e questo dovrebbe fargli temere meno la concorrenza dei paesi in via di
sviluppo.
Nel complesso, dunque, occorre cautela nell’interpretare i fenomeni di globalizzazione che pure ci
sono e sono sicuramente in crescita.
Tuttavia, i sostenitori della tesi della convergenza istituzionale poterebbe obiettare che ciò che
conta è la tendenza complessiva, per quanto lenta e contrastata.
Ma ci si può allora aspettare che in futuro la convergenza comunque si realizzerà?
Suzanne Berger ha individuato tre tipi di argomentazioni di coloro che rispondono positivamente a
tale interrogativo:
1) forme più incisive di redistribuzione e di regolazione dei rapporti di lavoro da parte degli stati
possono indurre le imprese a spostarsi altrove e questo riduce l’autonomia della politica
economica degli stati avvantaggiano i sistemi che si basano maggiormente sul mercato;
2) si può verificare un processo di imitazione da parte delle imprese che attuano forme
istituzionali diverse (ibridazione);
3) gli accordi internazionali possono introdurre forme di regolazione simili per abbattere le
barriere protettive (es. integrazione economica europea).
La Berger ha individuato anche tre tipi di argomentazioni di coloro che rispondono negativamente
sulla portata dei processi di convergenza istituzionale:
1) l’accresciuta concorrenza segnala delle esigenze di aggiustamento nella politica economica o
nelle relazioni industriali ma non è in grado di imporre anche una soluzione istituzionale
standard ai problemi. È più probabile che tale soluzione emerga sulla base di condizionamenti
esercitati sulle scelte degli attori dal patrimonio istituzionale ereditato dal passato e dal
conflitto di interesse tra i sostenitori delle vecchie regole ed i fautori del cambiamento;
2) rispetto ai problemi competitivi possono emergere nei vari settori risposte differenti dal punto
di vista istituzionale che tuttavia si equivalgono come capacità competitiva muovendosi negli
stessi mercati (es. l’impresa tedesca, quella giapponese e i distretti industriali italiani);
3) ciascuna realtà nazionale è caratterizzata dall’esistenza di forme specifiche di interdipendenza
tra le diverse istituzioni che sono legate a una comune matrice culturale maturata storicamente;
per cui è difficile introdurre variazioni in aspetti particolari dei meccanismi di regolazione
senza intervenire sulla costruzione complessiva.
Tali argomenti non ci portano a formulare risposte semplificate agli interrogativi sulle conseguenze
istituzionali della globalizzazione, anche perché non possono essere risolti sul piano della ricerca
empirica.
73
Allo stato attuale un punto di vista equilibrato sembra quello di riconoscere che la globalizzazione
comporterà una serie di conseguenze destabilizzanti soprattutto per i modelli di capitalismo più
organizzati ma che non appare però probabile che tali mutamenti determineranno una effettiva
convergenza.
Si può invece ipotizzare una ridefinizione delle economie coordinate di mercato che si accompagni
al persistere di equilibri multipli, cioè di sistemi istituzionali caratterizzati da punti di forza e di
debolezza differenziati.
Non c’è dubbio che la liberalizzazione dei movimenti dei capitali e la crescente integrazione dei
mercati finanziari pongano seri limiti all’autonomia degli stati nazionali nella determinazione delle
politiche economiche.
Le politiche macroeconomiche tradizionali, di tipo keynesiano, che comportano un aumento del
deficit e del debito pubblico generano rapidamente aspettative negative e pressioni sfavorevoli sul
tasso di cambio della moneta nazionale (i mercati finanziari privilegiano la stabilità). Anche
politiche restrittive, basate su un rialzo del tasso di interesse nazionale, possono non dare più gli
effetti sperati perché le imprese sono in grado di rifornirsi di credito in misura crescente all’estero a
condizioni migliori di quelle interne.
Crouch e Streeck (1997) sostengono che la perdita di autonomia sul piano delle politiche
macroeconomiche tenderà a tradursi in un indebolimento complessivo dello stato che si estenderà
anche ad altre sfere regolative: al welfare, ai meccanismi istituzionali che sostengono il ruolo delle
associazioni e della concertazione nei capitalismi di tipo più organizzato. Quindi si determinerebbe
un effettivo indebolimento del capitalismo più organizzato che tenderebbe a convergere verso
quello anglosassone. La maggiore libertà di movimento del capitale finanziario e la possibilità di
cogliere occasioni di profitto a breve sul mercato internazionale tendono a destabilizzare il
rapporto di lungo periodo tra banche e imprese che caratterizzava il capitalismo di tipo renanonipponico. Così avremo le banche dei capitalismi organizzati che si muovono verso le borse
internazionali e verso occasioni di investimento in paesi del capitalismo anglosassone e viceversa
capitale finanziario americano o britannico che penetra in quello delle imprese dei capitalismi più
organizzati (Powell e DiMaggio direbbero che si sviluppa una sorta di isomorfismo normativo).
Nonostante il rilievo e il fondamento riconosciuti alle argomentazioni precedenti, altre valutazioni
condividono invece una visione più problematica circa gli esiti in termini di convergenza attraverso
la via della deregolamentazione. Esse sottolineano come i vincoli macroeconomici non
comprimono necessariamente gli spazi di autonomia per le politiche regolative o redistributive, e
per gli interventi che incidono sul livello microeconomico. Per accrescere la competitività a livello
micro si può puntare sulla formazione professionale, sulla ricerca e sviluppo, sulla
74
regolamentazione dei settori e dei rapporti di lavoro, interventi che non devono essere
necessariamente deregolamentati ed affidati unicamente al mercato.
Cautela richiede anche la valutazione dell’impatto della globalizzazione sui processi di
concertazione in quanto, se vi è stato certamente un indebolimento delle vecchie forme di
concertazione centralizzata, potrebbero crearsi spazi per forme di concertazione diversa (es. con il
processo di costruzione europea).
In conclusione, alla luce delle considerazioni precedenti ci sono buone ragioni per supporre che le
tendenze di globalizzazione si accompagneranno a mutamenti istituzionali significativi e alla
ridefinizione dei confini tra i diversi modelli di organizzazione dell’economia. Questa prospettiva
si lega all’idea di equilibri multipli, piuttosto che di un unico equilibrio che si afferma
gradualmente e inesorabilmente. La globalizzazione dei mercati creerà delle pressioni e dei vincoli
che continueranno a essere filtrati e interpretati alla luce degli specifici contesti istituzionali
ereditati dalla storia. Ci potranno così essere particolari vantaggi e svantaggi dei vari paesi e delle
diverse regioni nell’affrontare la competizione economica. E continueranno a esserci combinazioni
variabili di efficienza economica ed equità sociale (alcune società potranno scegliere di crescere di
meno in termini economici e di mantenere un quadro sociale più coeso). Ciascuna società dovrà
mettere a punto una regolazione intelligente e consapevole che cerchi di usare al meglio il
patrimonio istituzionale ereditato dal passato, non per opporsi alla globalizzazione e ai mercati con
chiusure irrealistiche e inevitabilmente perdenti, ma per rispondere alle sfide nel modo più efficace
proprio perché più congruente con i diversi presupposti culturali e di civiltà. Ci sarà molto lavoro
per la sociologia economica anche in futuro.
75