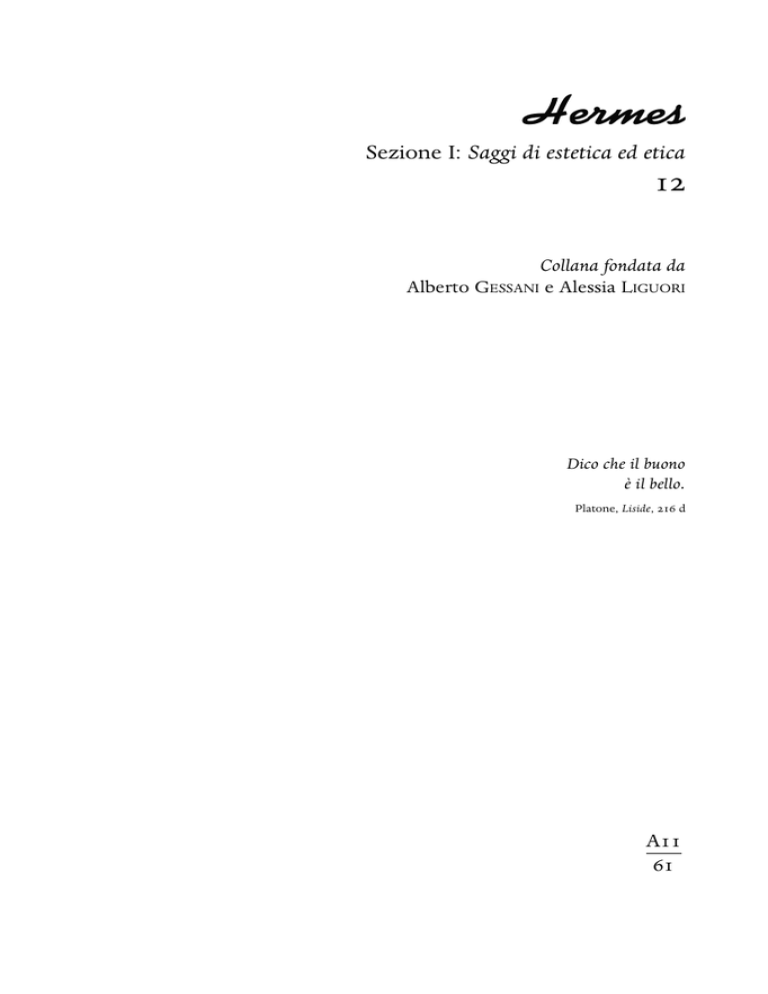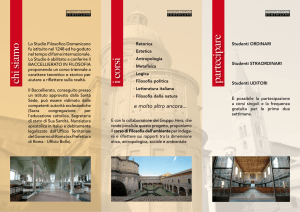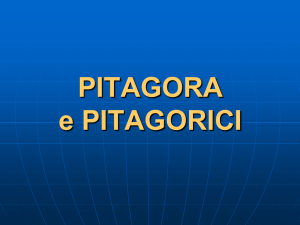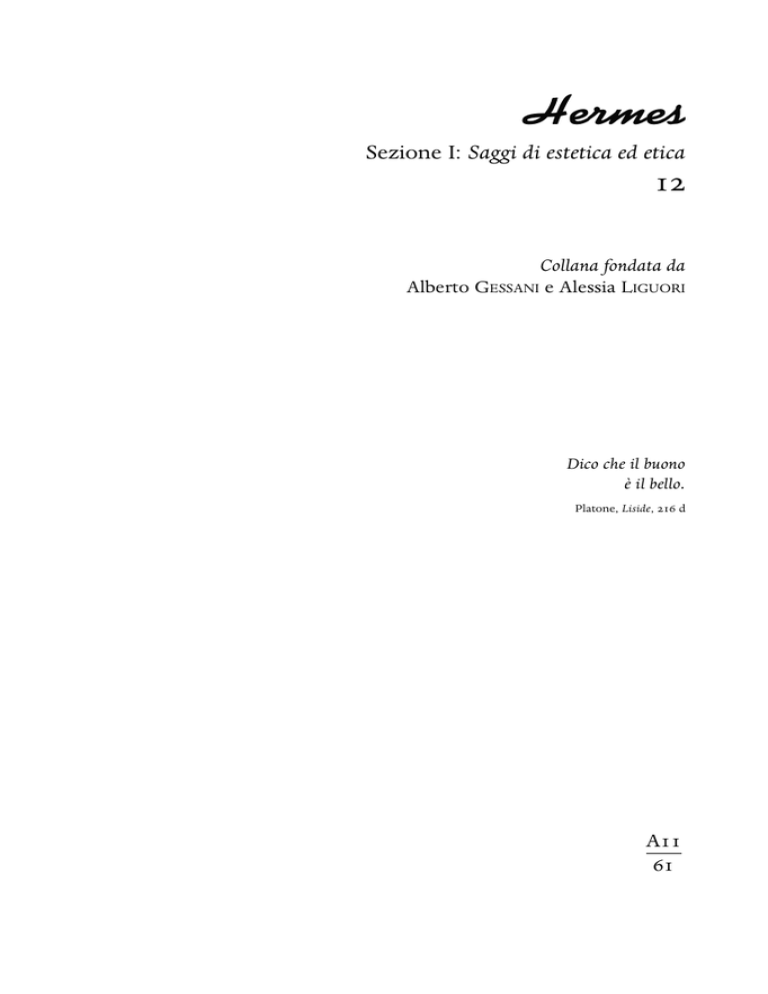
Hermes
Sezione I: Saggi di estetica ed etica
12
Collana fondata da
Alberto GESSANI e Alessia LIGUORI
Dico che il buono
è il bello.
Platone, Liside, 216 d
A11
61
Direttori
Alberto GESSANI
Alessia LIGUORI
Università degli Studi Roma Tre
Comitato scientifico
Paolo NEPI
Vittorio STELLA
Gennaro Giuseppe CURCIO
Comitato di redazione
Paolo MAROLDA
Veronica REGOLI
Hermes
Hermes è il dio del movimento, del passaggio, dell’inventiva;
gioca con le cose, con gli altri, con se stesso, facendo emergere le
potenzialità degli enti, costruendo ciò che prima non era al mondo.
L’essere è offerta continua e sfida all’intelligenza: esige, per es sere compresa, che si comprendano o si instaurino relazioni tra gli
individui e tra i generi. Come dio della relazione e dell’invenzione,
Hermes è guida dell’interprete e del ricercatore che non accetta
divisioni di campi e di scopi: rispetta ciò che è, ma sa che rispetto
significa oltrepassamento del dato puro e semplice.
Questa collana vuole ispirarsi a Hermes proprio in quanto intende accogliere lavori che istituiscano rapporti o riscoprano l’unità fra temi del sapere diversi, che tentino nuove prospettive di indagine, che offrano al lettore strumenti fondamentali per l’esercizio
del sapere e del pensiero.
Santi Barbagallo
Paraffi
La questione del parergon da Kant a Derrida
Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133/A–B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–4584–8
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 2010
II edizione: febbraio 2012
Indice
7 Il grado zero della filosofia. Prefazione alla seconda edizione
23 Proemio
23 Il problema
27 La cosa, la firma
35 In fede
35 Firmare la verità
41 Topologia della firma
46 Res, nomos, logos
52 Diversi modi di firmare
59 Spielzeug
109 La scarpetta di Cenerentola
131 Tube type
173 Paraffi. D(on)arsi la cosa
187 Appendice. Aporie — incontrarsi al bar della filosofia.
Sull’avvenire della decostruzione
199
Bibliografia
Il grado zero della filosofia
Prefazione alla seconda edizione
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi
consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
Introduco, con tutta la seriosa premeditazione (intentio) di uno stratagemma retorico d’apertura (inventio) — che è anche il travestimento
molteplice della toga d’un oratore di cui simulo, qui, il gesto della
capziosità benevola dell’imbonimento fabulatorio — il discorso sul
Nullpunkt o grado zero della filosofia, sulla possibilità del non–dire,
del non–senso e della non–significazione come tali, nella e della scrittura filosofica. Lo faccio, è chiaro, alla maniera di un dossografo truffaldino — pura esteriorità di una retrodatazione locutiva di una postdatazione illocutoria! —, cioè abusivamente, con la sopraffazione (Überfall) travolgente (überwältigend) di un discorso indifendibile, avvicinandomi in punta di piedi al lettore e sussurrando al suo orecchio attento e un po’ incredulo la frase: «L’origine dell’Unsinn in filosofia è
una verruca sul naso a forma di cece». Il naso e la verruca sono quelli
di Cicerone. Il grande oratore latino, traviato e sgrammaticalizzato, è
l’autore originario di quell’escerto nonsense o “finzione testuale” che i
grafici impaginatori utilizzano per riempire le bozze dei libri o delle
riviste non ancora pubblicati né redatti («il pensiero attraverso i miei
occhi», o dell’«ineluttabile modalità» di un occhio che pensa quel che
il pensiero non può vedere…).Si tratta di un’emergenza significante,
una protuberanza linguistica o una somma di escrescenze, di ceci, che
anticipano nella loro ostensione grammatologica (o grammatografica),
7
8
Paraffi
invaginandolo nello spessore grafico della mise en page, il rilievo semantico e ortografico con un trompe–l’oeil: fanno testo…
Un cece, così dice il mio dizionario, è anche un piccolo impertinente, una birba, o anche una cosa da nulla, una minuzia, un dettaglio irrisorio — perché è poca cosa e perché suscita un riso malizioso. Cicero
poi è il nome dato dai tipografi alla riga di scrittura. Perché, forse, la
scrittura è fatta di ceci, di dettagli trascurabili, di piccole escrescenze e
di imperfezioni che il discorso nel suo complesso trascura, ma che sono la parte viva della scrittura, la carne del linguaggio, anche del linguaggio filosofico. La filosofia ha il suo grado zero, i suoi ceci caratteristici, così come ogni filosofo ha la sua verruca sul naso riconoscibile.
Lo chiamiamo, da sempre, stile.
Il medesimo incedere stilistico, questo attraverso e con cui fingo di
introdurre questa seconda edizione del mio Paraffi, è noto, suona noto,
familiare, per chi ha famiglia o vorrebbe almeno averne una ideale, e
una qualche familiarità con una certa voce che, «prima di firmare col
suo nome», un grande filosofo ci ha lasciato in eredità, come registrata
su un nastro magnetico. Un’eredità inassumibile, peraltro, e destinata a
restare nel cassetto del notaio, nella busta col sigillo di ceralacca del
de cuius. La vertigine sfrontata, entropica, della deferenza si trasforma
in eccedenza, in saturazione della satira — doppio tautologico del
piatto ricolmo di frutta. Si finge sempre, anche quando non si crede di
farlo. Anche, o forse soprattutto in quest’ultimo caso, dal momento
che la prosa didascalica, propedeutica ed esplicativa, ha anch’essa i
suoi fintivi, termine che da un po’ di tempo utilizzo per descrivere, designare, se fosse mai possibile farlo senza uno scarto euforico e un ispessimento dei semi, senza la trama del rovescio della tela di un certo
linguaggio argotico e specialistico, tutti quegli elementi linguistici, retorici, terminologici, parafrastici, locutivi, ma anche minimali, strutturali, sintagmatici, fonologici, che ogni linguaggio possiede, deve possedere, aggiungiamo, se vuol farsi riconoscere, e perché la condizione
del conoscere è vincolata a un certo previo riconoscere, come in pittura, in musica, in letteratura. La critica ha, dunque, i suoi fintivi. Ma
che vuol dire, allora, fingere? C’è un linguaggio della finzione? Direi
di sì, ma a un duplice livello. Un primo livello è quello dell’ipocrisia
Il grado zero della filosofia
9
in campo morale, etico e religioso: fingo fraterna filantropia francescana, fomento frettolosamente farisaici feed–back formativi. Fortunatamente, faccio finta, scrivevo celiando in un tautogramma, mai
pubblicato. Il birignao melismatico dell’omelia caramellosa è un suono sgradevole, prima che un concetto, una parola, un discorso, un
“senso”. È anche, questo primo livello, quello del falso in termini logici e metalogici (tutti i principi di non–contraddizione violati, le fallacie della logica formale, i falsificazionismi mancati, le completezze,
le concordanze aberrate o fuori squadra).
I più grandi filosofi sono stati, tutti nessuno escluso, dei grandi stilisti, diceva Derrida non ricordo più in quali termini. Ed è vero. Heidegger, Adorno, Deleuze sono musicisti prima che filosofi (come aveva capito Nietzsche: il linguaggio è musica, tono, modulazione, euritmia). La loro prosa è musica, la loro musica è stile, felice combinazione di elementi morfologici e concettuali, ciascuno con una propria voce, un proprio idioma. Come la pittura e la scultura, anche la filosofia
ha le sue impronte digitali, i suoi stili. Il genio di Michelangelo soffrì
le peggiori angustie a causa del suo stile. Ma il suo fu anche uno stile
molto imitato. Gli imitatori del grande maestro si chiamavano manieristi. Ecco, il manierismo, che c’è in filosofia come in pittura, in scultura, in musica, in poesia. Insistiamo spesso sull’omologia tra arte e filosofia, ma in questo caso bisogna fare attenzione, porre un limite, un
limite necessario, che riguarda la necessità della filosofia e del filosofare. La filosofia è creazione di concetti, diceva Deleuze rimarcando la
cogenza, da parte della filosofia, di esprimere (sic!) concetti, cioè di
esprimere “anche” i concetti che, “anche”, la filosofia crea, il filosofo
crea creando la sua filosofia.
In poche e sbrigative parole, in filosofia lo stile fa parte del concetto. Fa parte di una scelta, di un’intenzione, di una volontà. Ciò che non
è mai concesso al filosofo, e a ragione, è il cieco e irriflessivo “copiato”. A meno che… A meno che, cosa? C’è forse un metastile, una
complicazione degli stili, di tutti gli stili o di uno in particolare assunto
come metonimia stilistica (questo “stile degli stili” — se ci è concesso
lo stupore a bocca aperta del superlativo semitico! — sarebbe uno stile eccentrico, fatto di Witze, di anfibolie, di calembour, di pun quasi
10
Paraffi
joyceani… Ma la morigeratezza bietolona e stracca dei conclavi filosofici nei palazzi della cultura "ufficiale" avrebbe sempre qualcosa da
ri–dire su questo divertissement della linea retta morale, rottura della
retta o della rotta, su questo dirottamento della meta olimpica nei
viaggi organizzati delle vacanze intelligenti)? Una Darstellung voluta,
scelta, esibita, rap–presentata, dello stile “in quanto tale”, dello stile
come stile? La domanda, brutalmente, ci riporta al secondo livello della finzione. Questo secondo livello, ipotetico, riguarderebbe proprio la
messa in scena della finzione. Una cosiffatta messa in scena, proprio
perché vorrebbe fingere, vorrebbe cioè essere, anche, ciò che mentre
finge fa finta di fingere, se della finzione vogliamo seguire il suo stesso interno, sovraccarico movimento e la sua interna logica paradossale, non si darebbe mai a riconoscere per quello che è, cioè finzione di
finzione, finzione di stile o stile come finzione di stile, ma si esporrebbe al fraintendimento metodologico, al misconoscimento opaco
della copia accademica, all’accusa del plagio, dell’emulazione, della
piaggeria ruffiana, all’equivoco del proselitismo prono e impersonale.
Baccio Bandinelli era, per esempio, un manierista. Il suo Ercole e Caco esposto in Piazza della Signoria a Firenze, è un rozzo michelangiolesco pezzo di marmo. Così, più o meno velatamente, la pensano i critici d’arte, cioè coloro che non sanno creare nulla da sé. Ma ne siamo
poi tanto sicuri? Sì e no, anzi, a costo di irritare qualcuno: no perché
sì! Il gruppo scultoreo di Bandinelli non è né descrittivo o informativo,
né simbolico, né stricto sensu poetico: è ottuso (obtus). È stupido, ma
di uno stupor eccessivo, che eccede la forma del concetto che vorrebbe esprimere (in scultura). Una fenomenologia dell’ottuso che dovrò
una buona volta decidermi a trattare come si deve, come è dovuto a
una grande, geniale intuizione di Roland Barthes. I puristi della bella
forma consideravano già l’arte di Michelangelo brutta, per gli stessi
motivi, per il medesimo motivo: la Darstellung sovraccarica del proprio interno concetto, il concetto di presentazione. Di esibizione. Michelangelo era già, in questo senso, un esibizionista. Figuriamoci allora un Bandinelli, che esibiva l’esibizionismo di un altro!… Bene, questa hybris indesiderata, che continua ancor oggi a suscitare scandalo, è
precisamente il genere di dinamica di cui, modestamente e forse inavvedutamente, io mi occupo da qualche anno.
Il grado zero della filosofia
11
Il manierismo stilistico è già di per sé un sintomo di decadenza. Ma
questa decadenza va presa piuttosto seriamente, letteralmente:
l’oggetto ideale cade, precipita, stramazza al suolo per eccesso di gravità. Un pallone aerostatico o una mongolfiera inzavorrati dello stesso
pondus ideale, aereo del concetto originale donde la maniera proviene
per scollamento e reduplicazione. Ed è così che la riproduzione manierista diventa produzione originale, produzione dell’originale di riproduzione, doppio euforico del classicus. Il secondo, il derivato, il precipitato come istituzione della finzione di produzione ideale e primaria,
“letteratura minore” che gioca sull’orlatura visibile della sgranatura
prosaica. È il casalingo, oleografia appesa al muro del soggiorno, sensazione concettuale e concetto di sensazione, mise en scéne del codice
classico (deuteroclassicismo). Come il periodo ellenistico all’epoca
dell’arte greca, come il sovraccarico delle linee nel Barocco, la messa
in mostra dello stile, del codice, dell’idioma, costituisce il limite e la
forza concettuale del ricupero mimetico. La “società dell’immagine”,
la nostra, non può fare a meno di produrre derealizzazione, di produrre
simulacri e idoli. Si tratta quindi di raddoppiare il movimento della
messa in scena, di raddoppiare la rappresentazione per dedurne un
nuovo genere di immagine, un’immagine seconda o potenza di immagine che non corrisponda più all’ordine mimetico della concordanza
iconologica, né all’ordine rappresentativo dell’esposizione spettacolare (nel senso di Debord) ma inauguri un affatto nuovo modello di Vorstellung, a metà strada tra il concetto e il percetto (estesiocetto). Sarebbe la strada della posticonologia. Già Foucault aveva visto in Las
Meninas di Velazquez una pittura della “rappresentazione della rappresentazione”. In filosofia il raddoppiamento garantirebbe, analogamente, il passaggio dai cogitata ai sensibilia, dai posita ai placita; garantirebbe l’accesso alla filosofia dal punto di vista di un’estetica come gnoseologia superiore. Sarebbe il transito dal concetto al percetto
ma in quanto transito in loco o surplace: le eccedenze, le fratture interne, le incrinature accidentali della logica costituirebbero una estetica involontaria, un’estetica della filosofia.
12
Paraffi
Una cifra e una intentio obliqua di ridistribuzione semiotica dunque
organizzano la processualità fintiva di Paraffi, di cui si può dire realizzi una «distorsione della pratica di consumo», come
l’amplificazione fonica in Carmelo Bene e la registrazione musicale in
Glenn Gould; una “potenza del falso” capace di riqualificare
l’artefactum, il prodotto, l’attrezzo o il mezzo, e insieme il “fuori uso”
deiettivo della loro demondificazione permanente (possiamo anche dire: finzione di funzione). Ma la meccanica di finzione, la sua applicazione nel contesto attuale, ha anche una ragione più “ideologica”. Qui
mi concedo volentieri un piccolo excursus o hors–d’oeuvre nella forma paratestuale (parergonale) dell’autocitazione da un dialogo interrotto sulla questione filosofica contemporanea, soprattutto italiana, che
pubblico per la prima volta:
Non c’è più spazio, oggi, per il disincanto della critica, per il suo principio di
realtà. Quel tale in parlamento si commuoverà ancora ascoltando l’inno nazionale, ma sarà la scarica ritardata della sua vita bambina, la nostalgia di una
marcetta al campionato dei pulcini. O forse, se il cinismo non fosse fuori luogo anch’esso di questi tempi, il tubo di saliva di Pavlov sulla bocca del cane
che sta per arraffare il bottino (in tutte le cerimonie ufficiali in cui l’inno viene suonato c’è sempre il fine partita del guadagno milionario, per il politico
come per il calciatore). Stupisce però non meno di questa fisioideologia cinica, il bisogno rinnovato della filosofia, propalato a piè sospinto da molti filosofi qui in Italia (Salvatore Natoli che sorseggia il suo caffè al bar della filosofia assieme all’intervistatore ammirato che gli chiede se oggi c’è ancora bisogno della filosofia). Stupisce il bisogno di aggrapparsi ancora alle parole,
alla soterica dei termini, al conforto del logos surgelato, alla consolazione beota della stupidità della filosofia (Severino Beozio, La consolazione della
stupidità, scrivevo in un ircocervo…). E allora come comportarsi? Come regolarsi, sulla filosofia, con la filosofia per la filosofia? Per esempio, che senso ha, che non sia la forma esplicita di un implicito tradimento del senso, creare nuove parole, nuovi composti, mettere i prefissi accanto ai sostantivi,
moltiplicare le combinazioni e i semi scempi, le agglutinazioni e le paronimie; che senso ha, anche, domandarsi tutto ciò, e vale a dire: porre ancora la
domanda filosofica, il pensiero nella forma dell’interpellanza, del punto interrogativo? Mentre mi chiedo questo, e perché me lo chiedo, la risposta mi
pende dalla lingua, pende e non esce, è attaccata al frenulo, è interdetta, come
«un bue sulla lingua»... Veramente, è un’interdizione alla parola, al dire e al
detto, al “questo” (Dieser) e al “sia” (fiat), al riportare e al ri–ferire nella forma–linguaggio quel che sento gravare come un obbligo morale nei confronti
Il grado zero della filosofia
della mia stessa coscienza, se mai ne ho una. Il fatto è che c’è un double–
bind, e che la risposta s’incornicia in questo doppio vincolo contraddittorio e
non ne esce. Una doppia natura che qui tergiverso a dire, a riferire, perché mi
si risparmi almeno l’acribia dovuta (e che do) alla mia buona coscienza, e al
mio civismo non proprio stabile. C’è una doppia natura, del linguaggio, del
sapere, della filosofia, ma anche dell’intenzione, della morale, della pratica,
del desiderio. Ne distinguo a malapena i contorni frastagliati. Da un lato mi si
offre all’occhio un certo paesaggio, sempre quello, con qualche piccola variazione del resto contemplata nell’uso del linguaggio: è il paesaggio naturale,
della natura, beninteso, come esercizio della naturalezza e del naturale, il paesaggio della mimesis, della storia naturale della tecnica culturale, tecnica di
naturalizzazione della cultura. Dall’altro c’è il diorama, la diapositiva a gettoni o la cartolina illustrata di quel medesimo paesaggio; la riproduzione, la replica, la simulazione, il doppio, il finto. Questa sovrapposizione è la doppia
linea di un perfilo o di una silhouette non totalmente aderenti, messi a registro, ma sbavati, scollati, fuori squadra quel tanto che mi permette di rintracciarli, di vedere lo sdoppiamento – tra il paesaggio e la sua riproduzione, tra
la presenza e la rappresentazione, ecc. Forse questa sdoppiatura siamo in pochi a vederla. Ancora oggi molti filosofi della vecchia generazione, diciamo
della generazione postquarantacinque, perseguono la via del convegno, della
conferenza, del seminario “su…”, del dibattito “intorno a…”, come se nulla
fosse stato dal dopoguerra a oggi, come se non fosse passato un enorme rullo
compressore a schiacciare la filosofia e i suoi concetti “naturali”, come se non
ci fosse mai stata la filosofia francese dei ’60 e ’70, il poststrutturalismo, il
decostruzionismo, la fine dell’ismo e del post, del filosofismo e della postfilosofia. Francamente mi sembra una via inutile. Intendo dire: oggi non possiamo lasciarci alle spalle come archiviato un passato recente che ha scombinato
tutti i programmi della filosofia moderna, scompaginato tutti gli allineamenti
al concetto, le adeguazioni alla cosa e le classificazioni enciclopediche, l’ipse
dixit della normografia (e della nomografia) bibliografica. Inutile nascondersi,
siamo fatti così, soprattutto noi italiani. Quello che non digeriamo lo lasciamo
all’archivio storico, magari ci facciamo su qualche bella lezione universitaria,
qualche bel libro, ma in modi e forme così lontani dai propri contenuti di riflessione da lasciare scoraggiati. Leggo uno dei cosiddetti “libri su…”.
L’impressione che ne ho (e quasi subito!) è quella dell’obolo pagato al proprietrario–autore, all’oggetto della “monografia” (come si dice con un termine che ha il sapore di una deficienza… Sarebbe meglio una “stereografia”!).
Tanto più che l’impressione è quasi sempre quella di una forma tributaria sottotono, prona perché impersonale, della prosa scientifica e accademica, senza
vigore, senza vitalità, senza spinta. E, cosa davvero singolare di questa anonimia plurale della filosofia, se spunta fuori qualcuno che ha coraggio, che
“fa” filosofia davvero, e questo vale per dire che filosofa per sé e non per
conto terzi, subito viene bollato come intempestivo, di un’originalità deprava-
13
14
Paraffi
ta, fuori tempo e fuori luogo; bollato come epigono di quel rivoluzionario del
tempo che fu, come un prosseneta, un Emilio Fede, insomma. Questo avviene
perché chi giudica è incapace di comprendere il linguaggio, non soltanto il
linguaggio filosofico ma il linguaggio tout court. Come dire che chi giudica
non sa leggere, non sa scrivere, non sa fare le due cose insieme quando legge
o scrive, così si accontenta della prima fallace impressione che gli sollecita il
suo cervello indolente; come avviene in pittura, dove la signora con la pappagorgia e truccatissima esclama al vernissage di Tal De’ Tali: “Sembra
un’opera transavanguardista!” oppure “Ha molto di Pollock!” (e solitamente
il pittore se la ride sotto i baffi…). Insomma, dico che oggi non possiamo accontentarci dell’escamotage retorico, ma nemmeno della pretesa “naturalità”
dei concetti, dei significati (dei “valori” addirittura!). Se non possiamo più fare tutto questo, se non possiamo farlo “con” questo, significa che dobbiamo
fare tutto ciò “senza”, non senza farlo, sia chiaro, ma per farlo senza, nel senza del senza valore del valore, del senza contenuto del contenuto, del senza
concetto del concetto… Fare le due cose insieme, dunque e a mio avviso: il
paesaggio naturale e la riproduzione artificiale, l’originale del valore e il valore di riproduzione dell’originale… Non più né razionalità, forte o debole
che sia (o docile razionalità, come sostiene qualche inavveduto) né metalinguaggio, non più né naturalità mimetica né pratica cosmetica, ma le due cose
insieme, e cioè un’altra cosa… Da questa falsariga ho recentemente pensato
all’idea di un volume dal titolo La condizione transmoderna. Un titolo che è
di per sé tanto una riproduzione di un originale di firma (la firma di Lyotard)
o una parafrasi “ottusa” (nel senso di Barthes), quanto un topic concettuale a
tutti gli effetti, con la sua logica di argomento vivo e attuale, cioè “naturale”… Questo significa un passaggio a doppio canale: dall’entropico
all’epistemologico, dall’artificiale formale al naturale contenutistico, e viceversa, senza soluzione di continuità. L’ipotesi euristica dunque non sarà più
solo assegnata o al contenuto o alla forma, o alla teoria concettuale o alla pratica estetica, ma agli uni e alle altre insieme, in una combinazione a X. Bisogna fare ricerca con i mezzi della pratica filosofica, trovare nuove soluzioni
con le soluzioni già raggiunte (distruggere il cliché con il cliché, diceva Deleuze a proposito di Bacon), ricreare la fisionomia naturale con l’effetto speciale, la physis con il maquillage, per farne la gigantografia del nostro tempo
volubile.
Questo sullo stile generale, sul colpo d’occhio o colpo d’orecchio
che il presente libro può, ma non necessariamente, suscitare nel lettore. Come tutte le impressioni a prima vista, si tratta di un’impressione
fallace. A ben vedere non c’è nulla in questo testo che annunci
l’emergenza, o ratifichi l’impressione, di un semplice ricalco. Innanzitutto, dicevo, il recupero stilistico è un recupero concettuale. Vediamo
Il grado zero della filosofia
15
perché. L’operazione decostruttiva è, a livello teorico, un’operazione
di spostamento del centrum iconologico, del cuore del discorso, del
thema, ecc., verso i bordi, i margini, le lateralità e le bordature, i perimetri del significato pieno, deposito dell’estensione del dictus sullo
spessore intensivo del ductus. In sintesi: spostamento dall’ergon verso
il parergon. Questa operazione, che è una pratica, è, per l’appunto, teorica prima che stilistica: consiste nel rimandare continuamente
l’istante del compimento del concetto, il momento della chiusura del
significato. Questo spostamento è perciò il colpo di scopa che accumula la polvere sui bordi, e non se ne sbarazza. Sbarazzarsi della questione, della domanda, del problema, significherebbe porre implicitamente quale precondizione della filosofia il modello apodittico della
postulazione scientifica. La filosofia non è, per quanto ci riguarda,
scienza. Può semmai solo in certi casi assumerne l’aspetto, il côté,
l’Einkleidung, l’habitus o lo schema. La lateralità, la marginalità, la
parergonalità della pratica filosofica rappresentano quindi la processualità sostruttiva del discorso. La sostruzione non è la decostruzione.
Già qui, in questa precisazione, sta tutta la distanza tra Paraffi e i migliori testi della tradizione decostruzionista. La sostruzione è la slatentizzazione radioscopica delle “archistrutture”, l’ostensione dei piani di
supporto che reggono l’impianto delle concettualità; è l’impalcatura
che rende possibile l’identificazione progettuale dell’intero movimento del pensiero formulato, delle enunciazioni teoriche e dei significati
filosofici. Sotto questo rispetto, il sostruzionismo di Paraffi combina
la decostruzione derridiana e la costruzione deleuziana. Della prima
isola l’incedere per spostamenti e aporie, per accumulazione dei bordi
e per allotropismo; della seconda la creazione di concetti nuovi, “originali”, fabbricati per zone di adiacenza semantica e di prossimità
concettuale. Ed effettivamente in Paraffi la macchina concettuale si risolve nella fabbrica materiale, fabbrica di oggetti fisici, di cose: ogni
concetto è ridotto, sintetizzato, rappreso e condensato nella materialità
dell’oggetto (il giocattolo, la scarpetta di vetro, lo pneumatico). Doppia metonimia del passaggio dal filosofo al suo nome, e dal nome alla
cosa.
Della decostruzione, ancora, l’inedita praxis di Paraffi raccoglie, in
una contiguità con la fabbrica deleuziana di concetti — ma già divenu-
16
Paraffi
ta fabbrica di concetti–cose — la sfida di insediare il senso attraverso
l’accostamento parergonale, accostamento grafico e logico (come in
Pass–partout): si tratta dell’inserimento, dell’incastonatura, diciamo,
di contenuti apofantici in forma di segnavia (pratica che sviluppo già
da La critica e i suoi fintivi). Viene offerta quindi un’altra marcia, un
altro ingranaggio alla macchina concettuale, secondo lo stile delle note
di lavoro, dell’appunto schematico e sintetico. Il linguaggio diventa
sintetico, sintetizzato, composto di grommi e concrezioni, di impasti
densi, di tessiture fitte; diventa il linguaggio gergale “in quanto tale”,
il linguaggio filosofico senza mediazioni, in ciò che di più decorativo
esso a volte rappresenta, o si mostra agli occhi dei non addetti. Ed è
l’elemento grafico e fonico, lo spessore significante il motivo
dell’esistenza del testo, testo esibito quindi come forma della critica
filosofica, immagine della filosofia (ed è qui che incrociamo di passaggio un altro importante concetto della filosofia poststrutturalista,
quello di figurale di Lyotard). D’altra parte, tale linguaggio mutua la
logica generale della sensazione deleuziana, l’isometria differenziante
(sic!) tra il piano di composizione, il blocco di sensazioni, di percetti e
affetti dell’arte e il piano d’immanenza e i personaggi concettuali della
filosofia. In secondo luogo, allora, elemento di diversificazione teorico–pratica col derridismo e il deleuzismo consiste nell’intervento decisivo della critica barthesiana, sia per ciò che concerne una fenomenologia dell’ottuso (che Paraffi vuole estendere concettualmente anche alla filosofia e alla letteratura, oltreché al cinema, alla fotografia e
alle arti visive) sia per il significativo richiamo alle analisi di Barthes
sui rapporti tra pittura e cucina, pittura e scrittura, scrittura e frittura,
ecc. Dopo il parergon derridiano e il percetto deleuziano, il culinario
barthesiano.
È qui che il nostro “tentativo di autocritica” si ricongiunge col suo
esordio sbalorditivo: come c’è un grado zero della scrittura, c’è anche,
ma più scomodamente per i luterani della riflessione salottiera, un
grado zero della filosofia. Un grado zero, un Nullpunkt, che la fonda
primariamente, una Stiftung materiale, sensibile, estesiologica, che
permette l’accesso al Diskurs filosofico ex obliquo, indirettamente o
dal basso (ipofisica del senso) o partendo da elementi singolari, irridu-
Il grado zero della filosofia
17
cibili, minimali del linguaggio e della scrittura. Sono questi elementi
secondari, marginali, questi supplementi, queste lateralità e queste parergonalità che la scrittura rilascia non meno di produrre in un automatismo involontario, indecidibile, aleatorio; questi elementi che la decostruzione chiama “traccia”, “supplemento originario”, “parergon”, “imene”, “pharmakon”, ecc., sono queste unità microniche di senso e
sensibilità (perché non c’è concetto che non abbia i suoi propri sensibilia, come suoni e colori e forme possiedono a loro volta i lor propri
cogitata) che fanno la filosofia, che producono il meccanismo di fabbricazione delle concettualità e delle idealità (simboliche, metaforiche,
referenziali, ecc.) del discorso filosofico.
Ancora una precisazione sul concetto di parergon che il titolo del nostro libro focalizza. Non si tratta del parergon propriamente detto, del
parergon kantiano per intenderci. Non si tratta, o non precipuamente,
dell’analisi dell’opera d’arte, degli accessori e dei supplementi
dell’opera d’arte visiva (la cornice, i disegni a la grècque, i fregi, ecc.).
Si tratta piuttosto del parergon o dei parerga che ineriscono ai discorsi sull’arte e sull’estetica, ma anche al discorso filosofico tout court, il
quale presenta già di per sé connotazioni estetiche, nonché elementi
struttivi sui generis del linguaggio critico–filosofico che corrispondono in distans agli elementi formali e materiali dell’arte. Sono elementi
minimali, sintagmatici, dicevamo, di raccordo o congiunzione grafica
e concettuale che intessono “dal di fuori”, da un certo esterno, da una
certa lateralità, l’interno, il cuore, il nucleo focale del senso e del concetto di ogni discorso filosofico (critico, dialettico, ontologico). In
questo contesto è evidente non solo il ricupero della lezione di Derrida, ma, forse più immodestamente, il tentativo di prolungare le analisi
del filosofo francese al di là di un certo convenzionalismo estetologico, riportando la questione estetica ai suoi minimi termini, alla piattaforma estesiologica d’origine da cui procedono i grandi discorsi
dell’etica, della morale, della religione, della politica. Riporto brevemente quanto scrivevo alcuni anni fa a proposito della concezione estetica di Derrida:
[…] la visione “critica” di Derrida in merito all’estetica, quale si delinea a
tema soprattutto in La verità in pittura, è che l’analisi dei “piani sostruttivi”,
18
Paraffi
delle impalcature e dei prefabbricati su cui poggia l’estetica moderna come
“scienza del bello”, mette in luce una generale sintomatologia dei sistemi teorici classici, segnatamente dell’impianto kantiano della Critica del giudizio,
come rimozione dei margini e delle bordature, ossia della “cornice”, a vantaggio dei corpi pieni delle forme, e, di rimando, delle parole e dei significati
essenziali, o strutturalmente portanti in linea teorica o ideale. Indicativa è al
riguardo l’analisi di Derrida sul concetto kantiano di Parergon, e la rilevazione del meccanismo di rimozione, nella dicotomia classica di materia e forma,
della prima in favore della seconda:
«Il parergon (…) può accrescere il piacere del gusto (Wohlgefallen des Geschmacks), contribuisce alla rappresentazione propria ed intrinsecamente estetica, se interviene attraverso la sua forma (durch seine Form) e solamente
attraverso la sua forma. Se ha “una bella forma”, fa parte del giudizio di gusto propriamente detto, o, in ogni caso, vi interviene essenzialmente. È, per
così dire, il parergon normale. Ma se al contrario non è bello, puramente
bello, vale dire, se non ha una bellezza formale, scade ad ornamento
(Schmuck) e nuoce alla bellezza dell’opera, le fa torto e pregiudizio (Abbruch) (…) Ora, l’esempio di questa degradazione del semplice parergon a
ornamento seducente, è ancora una cornice, la cornice dorata questa volta
(goldene Rahmen), la doratura della cornice fatta per raccomandare il quadro alla nostra attenzione con la su attrattiva (Reiz). Quel che è brutto, esteriore all’oggetto puro del gusto, è quindi ciò che seduce con la sua attrattiva; e l’esempio di ciò che svia con la sua forza d’attrazione, è il colore, la
doratura in quanto non–forma, contenuto o materia sensibile».
Una delle conseguenze in ambito etico–politico e sociologico oltreché specificamente storico–filosofico ed estetico di questa impostazione, di questo nodo problematico peraltro già individuato da Heidegger nelle sue linee generali, anche se da questi decisamente non risolto a causa di una certa “isometria”
o mancanza di dovuta distanza, anche discorsiva, da quella “sopraffazione”
(Ueberfall) linguistico–concettuale di stampo aristotelico fondata sul cosiddetto sinolo ilemorfico come statuto ontologico della “cosa”, una delle conseguenze, dicevamo, del binomio di materia e forma accolto senza il beneficio
del dubbio dall’estetica moderna e, come vedremo, perdurante ancora in
qualche modo nell’età contemporanea, è che la preferenza accordata al contenuto formale a scapito di quello materiale, visto come marginale, accessorio e
supplementare, determina, o perpetua, il monopolio del cogito e della rappresentazione simbolica sull’azione e sulle circostanze concrete, dell’idea sul reale sensibile, della teoria sulla prassi, che è quanto dire il monopolio o
l’egemonia delle istituzioni, dei linguaggi e delle società “forti” sulle minoranze, etniche, linguistiche, politico–geografiche e così via, dal momento che
il meccanismo di rimozione “filtra”, obbedendo alla logica economico–