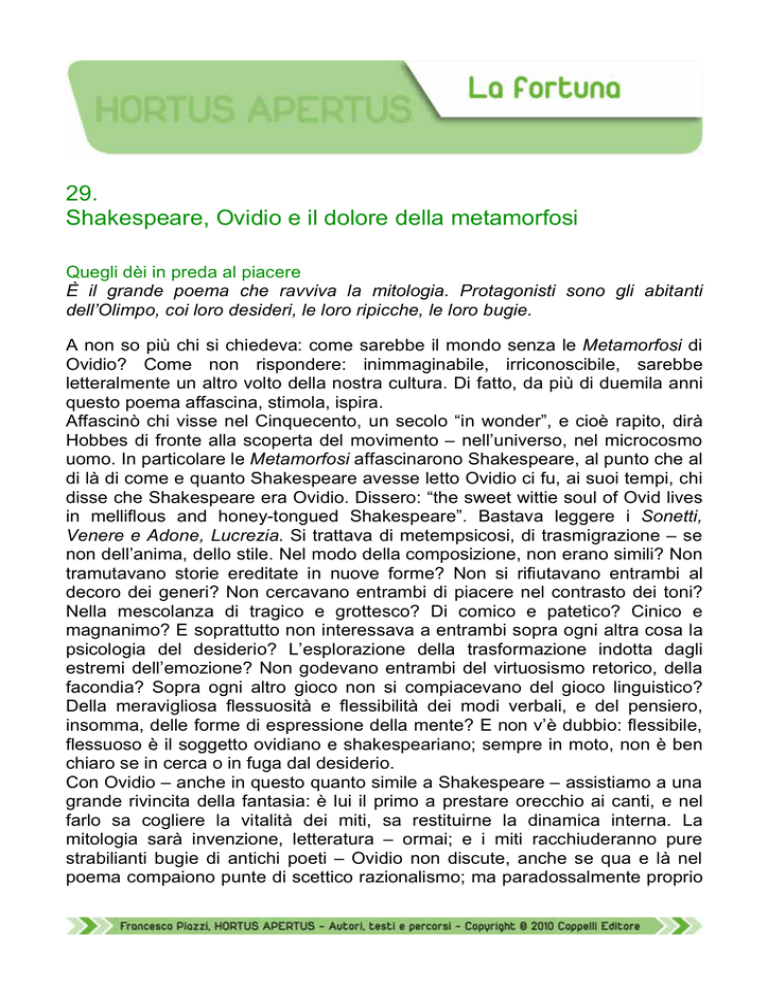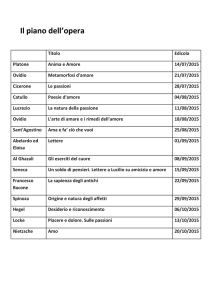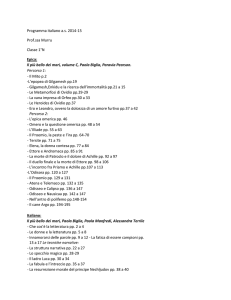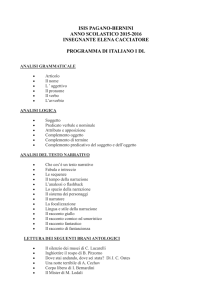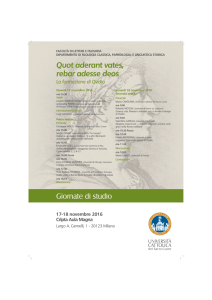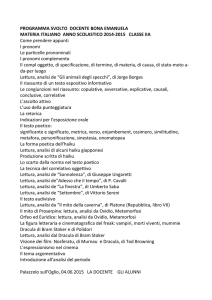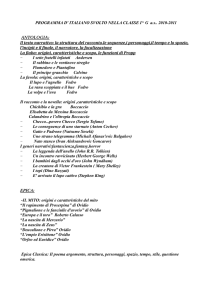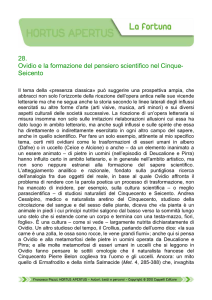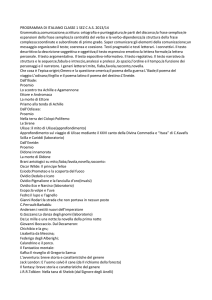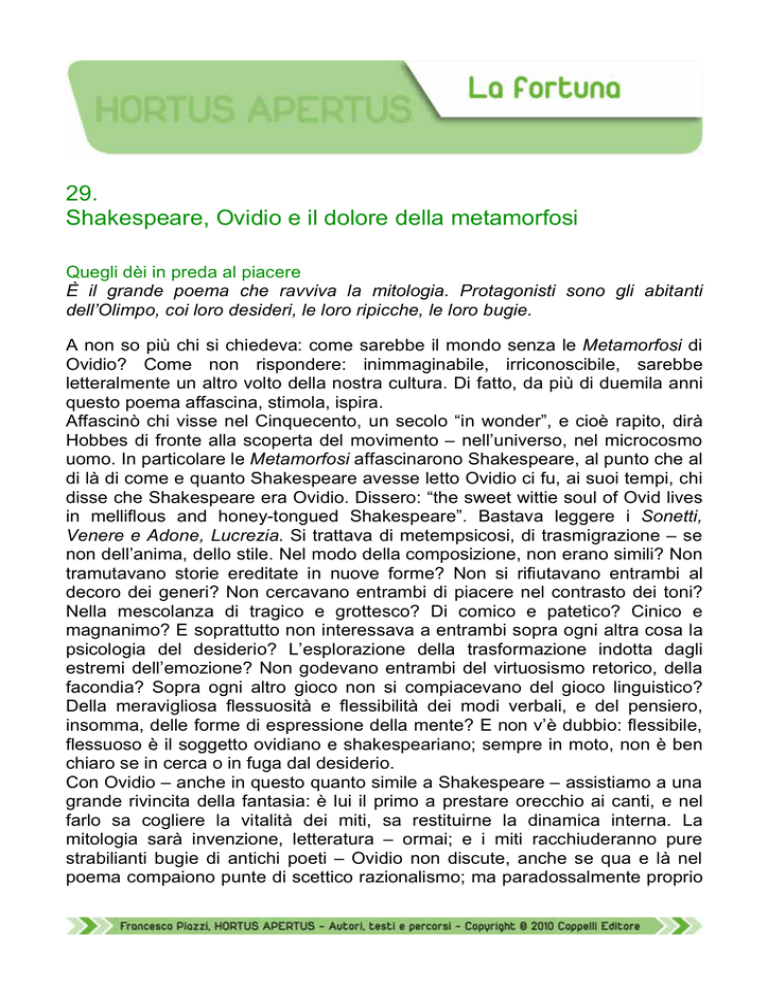
29.
Shakespeare, Ovidio e il dolore della metamorfosi
Quegli dèi in preda al piacere
È il grande poema che ravviva la mitologia. Protagonisti sono gli abitanti
dell’Olimpo, coi loro desideri, le loro ripicche, le loro bugie.
A non so più chi si chiedeva: come sarebbe il mondo senza le Metamorfosi di
Ovidio? Come non rispondere: inimmaginabile, irriconoscibile, sarebbe
letteralmente un altro volto della nostra cultura. Di fatto, da più di duemila anni
questo poema affascina, stimola, ispira.
Affascinò chi visse nel Cinquecento, un secolo “in wonder”, e cioè rapito, dirà
Hobbes di fronte alla scoperta del movimento – nell’universo, nel microcosmo
uomo. In particolare le Metamorfosi affascinarono Shakespeare, al punto che al
di là di come e quanto Shakespeare avesse letto Ovidio ci fu, ai suoi tempi, chi
disse che Shakespeare era Ovidio. Dissero: “the sweet wittie soul of Ovid lives
in melliflous and honey-tongued Shakespeare”. Bastava leggere i Sonetti,
Venere e Adone, Lucrezia. Si trattava di metempsicosi, di trasmigrazione – se
non dell’anima, dello stile. Nel modo della composizione, non erano simili? Non
tramutavano storie ereditate in nuove forme? Non si rifiutavano entrambi al
decoro dei generi? Non cercavano entrambi di piacere nel contrasto dei toni?
Nella mescolanza di tragico e grottesco? Di comico e patetico? Cinico e
magnanimo? E soprattutto non interessava a entrambi sopra ogni altra cosa la
psicologia del desiderio? L’esplorazione della trasformazione indotta dagli
estremi dell’emozione? Non godevano entrambi del virtuosismo retorico, della
facondia? Sopra ogni altro gioco non si compiacevano del gioco linguistico?
Della meravigliosa flessuosità e flessibilità dei modi verbali, e del pensiero,
insomma, delle forme di espressione della mente? E non v’è dubbio: flessibile,
flessuoso è il soggetto ovidiano e shakespeariano; sempre in moto, non è ben
chiaro se in cerca o in fuga dal desiderio.
Con Ovidio – anche in questo quanto simile a Shakespeare – assistiamo a una
grande rivincita della fantasia: è lui il primo a prestare orecchio ai canti, e nel
farlo sa cogliere la vitalità dei miti, sa restituirne la dinamica interna. La
mitologia sarà invenzione, letteratura – ormai; e i miti racchiuderanno pure
strabilianti bugie di antichi poeti – Ovidio non discute, anche se qua e là nel
poema compaiono punte di scettico razionalismo; ma paradossalmente proprio
quelle ombre di dubbio funzionano nel senso di rafforzare la credulità del
lettore.
L’inizio, l’esordio – o brevissimo proemio – definisce in modo preciso la
tematica del poema – che è sì epico, è scritto, cioè, nello stile dell’epos; ma
nella struttura e nello spirito presenta tratti non propriamente epici; perché il
poeta sembra più che altro aver voglia di “raccontare”; in questo senso,
giustamente, le Metamorfosi sono state considerate la prima grande opera
narrativa di respiro della letteratura occidentale. Sono il romanzo della
mitologia, è stato detto: dove si racconta di mutatas formas e corpora nova. E
cioè, di come certe forme tramutino in altre, in corpi nuovi, diversi, stranieri –
differenti.
Ludovica Koch traduce nova come stranieri; è una scelta forte e interessante.
Per lo più è tradotto nuovi. Ted Hughes, il poeta inglese – a cui si deve una
straordinaria versione in lingua inglese, dal titolo titolo Tales from Ovid, traduce
different; in entrambi i casi l’insistenza è sul nuovo come altro, estraneo.
Ovidio, ripeto, vuole raccontare di corpi che passano da una forma all’altra –
attraversando separazioni della materia, ordini della stessa, sovvertendo in tal
modo le gerarchie in cui tutto ciò che è stato creato è stato disposto. Non si
tratta di maquillages superficiali, di chirurgia plastica, si tratta di contatti
pericolosi, di passaggi dis-identitari, se così posso dire; dal mondo umano a
quello animale o vegetale o minerale. In questi contatti, di non so quale tipo, si
dimostra insieme la continuità e la mobilità di tutto l’edificio; del poema, intendo
dire – dove spesso la continuità e la fluidità sono raggiunte con trucchi che
Calvino farà bene a definire da romanzo d’appendice. Ma anche e soprattutto
si dimostra l’instabilità dell’edificio-mondo.
Ma perché non tutti i miti Ovidio raccoglie, ma solo quelli che culminano in
metamorfosi? Forse Ovidio è attratto dal carattere fantastico, utopico di tali
miti? In un’epoca inquieta come la sua – siamo alla fine del paganesimo – forse
proprio grazie a tali miti poteva illustrare i fenomeni di un’identità incerta e
sfuggente da parte di un io scisso in sé, o trapassante in un altro. O si potrebbe
anche dire: una volta morti i miti, una volta esaurito il loro valore sociale e
religioso, grazie alle storie e vicende di metamorfosi, il poeta, che ci creda o
meno, può comunque provare a ritessere gli intrecci tra mondo divino e umano
e naturale. In più, i racconti di metamorfosi sono i più scandalosi. Sono quelli
che meglio dimostrano il carattere perturbante dell’intreccio tra mondo umano e
natura. C’è un che di scientifico in Ovidio, osservò anni fa Sèeglov, un grande
studioso russo: insomma, Ovidio non è solo un poeta frivolo, leggero. E anche
se è forte in lui l’elemento fantastico, patetico, e forte la coloritura affettiva, non
è soltanto barocco: è uno scienziato nel modo dell’osservazione del
meccanismo metamorfico.
Allo stesso modo, per quanto scientifica sia la descrizione tecnica della
trasformazione – si legga nel libro primo la storia di Licaone, di Dafne, di Io e
nel secondo quella di Callisto e di Europa – non v’è dubbio che Ovidio sia
maestro soprattutto nel manipolare i meccanismi fisiologici e psicologici e
sentimentali che conducono alla metamorfosi. È la crudeltà del meccanismo
metamorfico a colpire – crudeltà che sta nel fatto che una volta messo in moto
il meccanismo non si ferma, e questo impressiona, emoziona. Impressiona,
emoziona la lotta del corpo contro l’invasione di proprietà e tratti che gli sono
estranei. In questo modo Ovidio introduce un’idea inquietante del movimento. Il
movimento è complicato in Ovidio; è fatto di fughe e inseguimenti di
trasformazioni che solo per gli dei sono trucchi per esprimere la propria libidine.
Sono, intendo dire, accrescimenti di potenza. Gli altri, per lo più le altre –
perché sono tutte femmine, le inseguite, le rapite, le violate – sono le vittime.
Dafne invoca la trasformazione per difendersi da Apollo, ma anche quando
sarà diventato alloro, e avrà perso quel corpo col quale godeva della corsa,
della caccia; anche allora, anche così, sarà possesso di Apollo, il quale sarà il
suo dio, il suo signore. Dunque Dafne perde una forma, ne acquisisce un’altra,
ma non è un guadagno, né la realizzazione di un ultimo desiderio. Di un
segreto slancio. Né lo è per Callisto.
Anzi, struggente è lo sguardo di Callisto-orso, fisso negli occhi del figlio che
vorrebbe abbracciare, mentre lui scappa. Struggente il desiderio di carezze che
Io-giumenta chiede invano al padre, che non la riconosce. E qui confesso un
mio proprio sentimento di lettrice. E dico lettrice, e sottolineo il genere
femminile, non grammaticale, in questo caso. Perché io donna, che leggo,
sento, o più propriamente dovrei dire, ricordo, la sensazione antica del corpo
come prigione; del corpo abitato da una forza che gli sfugge. È un sentimento
legato all’adolescenza: crescere è un’esperienza che può avere tratti
traumatici, sconfinare in un sentimento di metamorfosi; ovvero, nell’inquietante
percezione di una forza attiva nel corpo, una spinta che tutto vince: impetus lo
chiama il Sole, quando parla a Fetonte. Insomma, la sensazione di essere
animali animati da una forza muta che non controlliamo. Quando io leggo di Io,
di Callisto, di Dafne – di fronte a questi violenti riti di passaggio – ricordo lo
sbigottimento, la paura, il dolore adolescenziale di divenire me stessa,
figuriamoci un’altra, un animale, una pianta.
In questo senso la metamorfosi è dramma: c’è crudeltà implicata nel processo
metamorfico, c’è strazio. Nella zona incerta tra la demolizione di un essere e la
sua ricostruzione come altro, il passaggio non può non essere doloroso.
Tremendo è il passaggio metamorfico, non solo perché chi lo subisce perde la
propria identità, cioè l’identificazione alla propria forma; ma soprattutto perché
perde la facoltà di esprimersi. È indimenticabile, ripeto, l’immagine di Io che
bianca giovenca segue il padre e le sorelle, si fa accarezzare, lecca loro le
mani e piange. Ma loro non intendono il gesto.
Oppure di Callisto, che, orsa, brontola cupamente e leva le zampe al cielo
come fossero braccia. Sono indimenticabili, intollerabili queste figure – per lo
strazio che impongono.
Poema della rapidità, Calvino chiamò le Metamorfosi, sottolineando nel modo
della composizione qualità cinematografiche. Ogni verso come ogni
fotogramma è pieno di stimoli visuali in movimento. Il modo stesso della
tessitura è un montaggio di primi piani e panoramiche, che si avvicendano. In
cinemascope nel primo libro il diluvio che cancella il mondo; e nel secondo libro
la catastrofe solare. La cavalcata celeste di Fetonte è magnifica, grandiosa la
descrizione della terra che brucia. Apre un primo piano sulla reggia solare il
secondo, e precisamente con la descrizione della reggia del Sole alta su
eccelse colonne, fulgida d’oro e splendente, opera, anzi, capolavoro di
Vulcano. In essa Vulcano ha scolpito l’effigie simmetrica e ordinata
dell’universo, disponendo in equilibrio mare, terra, cielo coi relativi abitanti, la
geografia terrestre, lo zodiaco celeste – che presto tutti vorticheranno nel volo
di Fetonte.
Ma soprattutto qui Ovidio, artefice sublime quanto e più di Vulcano, in una
specie di mise en abîme raffigura il tema segreto del suo meraviglioso libro,
tema che affiora, per chi lo sappia leggere in quel verso che dice: materiam
superabat opus. Il verso, ripeto, è riferito alla reggia del sole, opera grande di
Vulcano – dove “il lavoro”, così traduce Ludovica Koch, “aveva più pregio del
metallo”. O dove “l’arte eclissava la materia”, è stato tradotto. O ancora “l’arte
superava la materia”.
Come che sia, non si potrebbe dire lo stesso di Ovidio? Della sua opera o arte
o lavoro? Non potremmo dire che materiam superat opus?
E non si potrebbe sostenere che la metamorfosi ultima, senza la quale non
avremmo questo libro, è proprio quella che trasforma la sua materia – i miti di
metamorfosi – in altra, nuova, lingua? Non è questa, alla fine, la metamorfosi
somma – l’evento artistico a cui ancora assistiamo con Ovidio? Che permetterà
ai suoi versi di diventare scene mobili sui teatri del mondo a venire, o
bassorilievi, o statue, e sculture, o pitture?
(Nadia Fusini, da “la Repubblica”, 11 gennaio 2006)