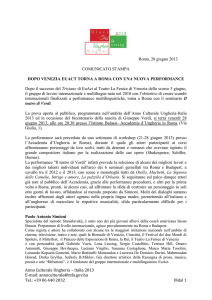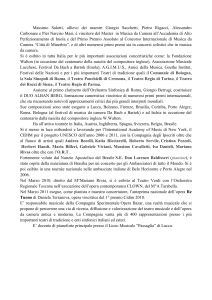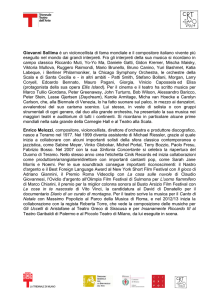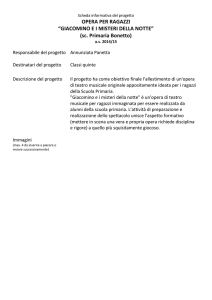Note medievali: alla ghironda,
Maria De Toni
(Belluno, Colle Santa Lucia.
Foto di Mariano Beltrame).
Anno IX - settembre / ottobre 2012 - n. 48 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241
2
VeneziaMusica e dintorni
Anno ix – n. 48 – settembre /ottobre 2012
Reg. Tribunale di Venezia n. 1496 del 19 / 10 / 2004
Reg. ROC n. 12236 del 30 / 10 / 2004
ISSN 1971-8241
Direttore editoriale: Giuliano Segre
Assistente del Direttore editoriale: Giuliano Gargano
Direttore responsabile: Leonardo Mello
Caporedattore: Ilaria Pellanda
Art director: Luca Colferai
Redazione: Enrico Bettinello, Vitale Fano,
Tommaso Gastaldi, Andrea Oddone Martin,
Letizia Michielon, Veniero Rizzardi, Mirko Schipilliti
Segreteria di redazione: Erica Molin e Antonietta Giorni
Redazione e uffici: Dorsoduro 3488/U – 30123 Venezia
tel. 041 2201932; 041 2201937 – fax 041 2201939
e-mail: [email protected]
[email protected]
web: www.euterpevenezia.it
VeneziaMusica e dintorni è stata fondata
da Luciano Pasotto nel 2004
In copertina: L’Opera Gala
del Prefestival «Lo spirito della musica di Venezia»
organizzato dalla Fondazione Teatro La Fenice
(foto di Michele Crosera).
Comitato dei Garanti: Emilio Melli (coordinatore),
Laura Barbiani, Cesare De Michelis, Mario Messinis,
Ignazio Musu, Giampaolo Vianello
Editore: Euterpe Venezia s.r.l.
Euterpe Venezia è una società strumentale
della Fondazione di Venezia che si occupa dello studio, della
produzione e della gestione di processi e interventi formativi,
di ricerca e di presenza nel campo delle arti
e dei beni e delle attività culturali, principalmente riferite
alle attività e alle installazioni dello spettacolo dal vivo
e alle discipline a esse correlate
Presidente: Gianpaolo Fortunati
Amministratore delegato: Giovanni Dell’Olivo
Consiglieri: Mariano Beltrame, Eugenio Pino
La Fondazione di Venezia è presieduta da Giuliano Segre
Consiglio generale: Giorgio Baldo, Franco Bassanini,
Vasco Boatto, Francesca Bortolotto Possati,
Riccardo Calimani, Carlo Carraro,
Antonio Foscari, Anna Laura Geschmay Mevorach,
Gianni Mion, Cesare Mirabelli, Giorgio Piazza,
Amerigo Restucci, Franco Reviglio, Giovanni Toniolo
Questo numero è stato realizzato
grazie alla collaborazione di Luca Ronconi,
Luigi Laselva, Andrea Estero, Andrea Porcheddu,
Fortunato Ortombina, Emanuela Caldirola,
Maria Stefanoni, Elena Casadoro, Adriana Vianello,
Andrea De Marchi, Andreina Forieri, Cecilia Dolcetti,
Silvia Carrer, Lorenza Cossutta, Laura Corazzol,
Maria Rita Cerilli, Alexia Boro,
Andrea Benesso, Cristina Savi, Clizia Benedettelli
Stampa: Tipografia Crivellari 1918
Via Trieste 1, Silea (Tv)
Raccolta pubblicitaria:
Luciana Cicogna
347 6176193 – [email protected]
Nicoletta Echer
348 3945295 – [email protected]
Tiratura: 3000 copie
Uscita bimestrale
Editoriale
D
di Leonardo Mello
ue maestri indiscussi e internazionalmente
riconosciuti come Luca Ronconi e Pierre Boulez
caratterizzano le due nuove edizioni della Biennale Teatro e Musica: con il Leone d’oro alla carriera l’ente veneziano ha voluto sottolineare la centralità di
queste due figure nel panorama teatrale e musicale contemporaneo. E di Biennale torniamo come sempre a parlare anche noi in questo periodo dell’anno, fondendo in un unico
focus il laboratorio estivo ideato da Álex Rigola per le arti
sceniche e il festival musicale diretto da Ivan Fedele, che avrà
invece luogo in ottobre. L’ideale contiguità tra i diversi comparti delle cosiddette performing arts è dunque ribadita anche in questo numero, che riunisce uno sguardo retrospettivo dedicato al cantiere teatrale agostano e una prospettiva futura, quella musicale, di cui cerchiamo di fornire alcuni strumenti interpretativi attraverso dei «ritratti» significativi, a partire proprio da quello di Boulez, firmato da Paolo Petazzi.
In realtà la visione progettuale della Biennale, secondo gli
obiettivi portati avanti dal suo presidente Paolo Baratta, si
è in questi
ultimi tempi parzialmente modificata, rivolgendo
attenzione
prioritaria
ai nuovi talenti, giovani già artisticamente
strutturati che giungono in laguna a incontrare
a f f er m at i
maîtres del
panorama
scenico internazionale. Questo
approccio
formativo
– che vede
addirittura un «mostro sacro»
come Luca Ronconi
svolgere un laboratorio pratico insieme a giovani attori e registi – si riverbera anche nel cantiere editoriale gestito per il
secondo anno, sempre all’interno della Biennale Teatro, da
Andrea Porcheddu, che raccoglie sei ragazzi da tempo ormai
occupati nella comunicazione online dei più rilevanti eventi
nazionali nei settori delle arti dal vivo. A loro lasciamo dunque il campo per una narrazione articolata di quanto si è sviluppato all’interno dei molti luoghi prescelti per far interagire gli artisti con la città d’acqua. L’interesse per le nuove proLuca Ronconi a Venezia (foto di Luigi Laselva).
poste è d’altro canto uno degli aspetti più interessanti della
nuova edizione del festival musicale, dove – a fianco di grandi nomi del presente e del passato più prossimo – sono previste numerose prime assolute di autori generazionalmente
giovanissimi, ascoltati e selezionati dal direttore artistico girando l’Europa in lungo e in largo.
Ma lungi dall’essere un numero «estivo», questo quarantottesimo si distingue per la varietà della sua offerta. Insieme
ai grandi nomi della musica leggera e cantautoriale – pregevole in questo senso il ritratto di Leonard Cohen che ci regala Giò Alajmo – andiamo ad approfondire l’arte filmica di
Francesco Rosi, la pittura di Giuseppe Capogrossi, i seminari fotografici dei Tre Oci, per citare solo alcuni degli articoli
presenti. L’idea è – pur volendo restare un bimestrale saldamente incentrato sulle arti performative – quella di allargare gli orizzonti cercando di creare un racconto complessivo
dell’offerta culturale del nostro territorio, che si presenta ricca e articolata nonostante soffino preoccupanti venti di crisi.
E per una volta sconfiniamo anche in un terreno a noi normalmente limitrofo, dando spazio al Festival della Politica
organizzato a Mestre dalla Fondazione Gianni Pellicani, che
tra i molti appuntamenti vede anche la partecipazione del
Presidente della Repubblica: l’importanza di quest’iniziativa – che coinvolge, tra le altre, personalità del calibro di Gustavo Zagrebelsky, Corrado Augias, Stefano Rodotà, Massi-
mo Cacciari, Ilvo Diamanti, Massimo Donà, Ernesto Galli
della Loggia, Massimo Giannini, Angelo Panebianco, Paola
Concia, Dacia Maraini ed Emanuele Macaluso – giustifica
l’interesse anche da parte di una rivista di settore come la nostra. Perché politica e cultura, in un ideale mondo da costruire, vanno sempre di pari passo, nutrendosi l’una dell’altra.
Continua infine la parentesi dedicata a Mario Bortolotto,
con altri due preziosi interventi che delineano aspetti sempre nuovi di questo grande musicologo e intellettuale. Pagine forse di nicchia, che però possono essere, ci auspichiamo,
un interessante spunto d’analisi per tutti i nostri lettori. ◼
3
sommario
4
3
Editoriale
focus on
7
Il Leone d’oro al magistero di Luca Ronconi
8
Sei giovani critici raccontano la Biennale Teatro 2012
8
Un laboratorio di critica alla Biennale
di Andrea Porcheddu
9
«Questa sera si recita a soggetto»: il lavoro sul testo ai tempi della performance
Focus sul laboratorio di Luca Ronconi
di Rossella Menna
10 To show the time: per una immaginazione del corpo
Intorno al laboratorio di Gabriela Carrizo / Peeping Tom
di Matteo Antonaci
11 Dai «barrios» di Buenos Aires alla Biennale di Venezia:
il teatro di Claudio Tolcachir
di Giada Russo
12 Quattro gruppi in residenza alla Biennale 2012
Dai laboratori 2010-2011 alla presentazione di progetti autonomi
di Elena Conti
13 Un campus d’agosto fra incontro e condivisione
Il progetto di Álex Rigola per un cantiere che lavori tutto l’anno
di Roberta Ferraresi
15 La formazione continua: una riflessione sulla Biennale Teatro
di Andrea Pocosgnich
16 Rafael Spregelburd secondo Luca Ronconi
a cura di Oliviero Ponte di Pino
20 «+Extreme-», il primo Festival di Ivan Fedele
a cura di Leonardo Mello
22 Pierre Boulez
di Paolo Petazzi
26 John Cage
di Mario Messinis
28 L’importanza del pubblico come interlocutore
Una conversazione con Yotam Haber, direttore artistico del mata
a cura di Federico Capitoni
7-29
Le Biennali Teatro e Musica:
grandi maestri e molti giovani
nelle rassegne
di Álex Rigola e Ivan Fedele
16-19
Luca Ronconi analizza
il teatro di Rafael Spregelburd
in tre interviste
di Oliviero Ponte di Pino
opera
30 30
«L’occasione fa il ladro» di Rossini secondo Betta Brusa
a cura di Arianna Silvestrini
concerti
31 Alle Sale Apollinee un omaggio a Gino Gorini
di Mario Messinis
32 Una performance in Piazza per chiudere il Prefestival
La Fenice fa un bilancio della nuova manifestazione estiva
di Leonardo Mello
34 Al Festival Monteverdi-Vivaldi due «stromenti venetiani» dimenticati
di Alberto Castelli
32
Ancora concerti per il Venetian Centre for Baroque Music
di Alberto Castelli
36 Ad Aldo Ciccolini il Premio «Rubinstein» 2012
di Vitale Fano
37 «Una vita nella musica» 2012
di Ilaria Pellanda
38 Il Festival Galuppi compie diciott’anni
di Ilaria Pellanda
39 Un nuovo autunno in musica per Palazzetto Bru Zane
di Andrea Oddone Martin
40 «L’ape musicale» degli Amici della Musica di Venezia
di Paolo Cattelan
41 42 I «Concerti della domenica» dei Solisti Veneti
di Leonardo Mello
sommario
35 5
43
45
Il «Pierrot Lunaire» di Schönberg incanta Padova
di Filippo Juvarra
l’altra musica
43
Leonard Cohen in una parola: «Hallelujah»
di Giò Alajmo
44 I Radiohead approdano a Villa Manin
Atteso a Udine il concerto della band di Thom Yorke
di Giuliano Gargano
45 Nina Zilli, l’anima soul della musica italiana
di Tommaso Gastaldi
46 Vinicio Capossela al Teatro Verde per Live in Venice
Si conclude un’estate di grandi artisti a San Giorgio
di Ilaria Pellanda
48 Slash: un nuovo progetto e un po’ di Guns N’ Roses
di Tommaso Gastaldi
49 Herbie Hancock in piano solo
di Guido Michelone
50 «E noi faremo come la Russia…»
La canzone comunista
di Gualtiero Bertelli
52
55
arte
52 Giuseppe Capogrossi secondo Luca Massimo Barbero
a cura di Ilaria Pellanda
55 A Ca’ Rezzonico l’opera grafica dei Tiepolo
di Eva Rico
56-57
cinema
56 Un ritratto di Francesco Rosi, Leone d’oro alla carriera 2012
di Roberto Pugliese
letteratura
58 «Se ti abbraccio non aver paura», storia di un padre e un figlio
di Mariano Beltrame
Un ritratto di Francesco Rosi
firmato da Roberto Pugliese
sommario
6
58 59
Una conversazione con Fulvio Ervas
a cura di Mariano Beltrame
fotografia
59 Nuovi workshop ai Tre Oci
di Ilaria Pellanda
in vetrina
60 Venezia tra salvaguardia e contemporaneità
Una conversazione con Renata Codello
a cura di Leonardo Mello
62 Le «Voci Fuori Campo» della Fondazione Pellicani
Giorgio Napolitano ospite d’onore del Festival della Politica
di Nicola Pellicani
64 «Musiche Culture Identità»
Il congresso della Società Internazionale di Musicologia a Roma
di Emanuele Senici
66 Alla Cini un convegno su Luigi Squarzina
di Leonardo Mello
I nuovi workshop
fotografici ai Tre Oci
60-61
in vetrina – Mario Bortolotto
67 Il provetto stregone
Mario Bortolotto e le vie della musicologia
di Jacopo Pellegrini
69 Bortolotto l’oscuro
di Gian Paolo Minardi
72 L’anima del Lied
di Alberto Caprioli
Renata Codello
parla di Venezia
e del suo immenso
patrimonio artistico
carta canta libri / dischi
76 Le recensioni
di Giuseppina La Face Bianconi
77 Palchi e gironi per i cantautori italiani
di Ilaria Pellanda
77 Emma Dante e la sua Biancaneve
di Ilaria Pellanda
78 «L’attore civile» di Paola Bigatto e Renata Molinari
di Leonardo Mello
78 «Scritto dentro», un libro bellissimo
di Leonardo Mello
79 Il pop-rap dei giovanissimi Rockit & Gugly
di Leonardo Mello
79 Il «Sunrise» del Masabumi Kikuchi trio
di Giovanni Greto
62-63
Giorgio Napolitano
al Festival della Politica
della Fondazione Pellicani
78
In alto: Luca Ronconi Leone d'oro (foto di Luigi Laselva).
A destra: la consegna del premio con Paolo Baratta e Álex Rigola.
A sinistra: un momento della conversazione
tra Luca Ronconi e Gianfranco Capitta
(Courtesy La Biennale di Venezia — foto di G. Zucchiati).
Musica in anni di radicali cambiamenti – tra il 1975 e il ’77
– e poi direttore artistico dei Teatri Stabili di Torino, Roma
e Milano, Ronconi ha sempre curato direttamente le attività delle accademie di teatro a questi annesse. Nel 2002 ha coronato la sua vocazione pedagogica fondando il Centro Teatrale di Santacristina a Gubbio, dedicato all’alta formazione
di attori professionisti». ◼
focus on
I
l 6 agosto scorso, presso la Sala delle Colonne di
Ca’ Giustinian, Paolo Baratta e Álex Rigola – rispettivamente
presidente della Biennale di Venezia
e direttore artistico del settore Teatro – hanno consegnato a
Luca Ronconi
(che ha condotto uno dei laboratori previsti per quest’ed i zione della Biennale Teatro) il Leone
d’oro alla carriera. A seguire,
lo stesso Ronconi è stato protagonista di una
chiacchierata sul suo lungo percorso artistico, condotta da Gianfranco Capitta. Ecco la motivazione che ha accompagnato la
cerimonia di
premiazione:
«Riconosciuto in tutto il
mondo come
uno dei massimi rappresentanti del teatro
di regia, che ha
attraversato dagli anni sessanta con passione sperimentale misurandosi
con spazi e tempi inconsueti, Luca Ronconi è stato autore
di grandi narrazioni teatrali, dall’Orlando
Furioso a Gli ultimi giorni dell’umanità e Infinities, da Pirandello e Gadda a Dostoevskij e Nabokov, ma ha anche sa-
puto generosamente e costantemente guardare alla trasmissione dei saperi tra generazioni, facendosi guida per tanti giovani allievi. Il rinnovamento del linguaggio scenico operato
da Ronconi ha lasciato un’impronta anche nel campo della lirica, dove il regista ha affrontato i grandi autori classici
– Mozart, Verdi, Rossini – insieme a compositori meno frequentati del periodo barocco e ai contemporanei.
Alla testa delle maggiori istituzioni teatrali italiane, a partire dalla Biennale stessa, di cui ha diretto i Settori Teatro e
le biennali 2012 — teatro
Il Leone d’oro
al magistero
di Luca Ronconi
7
focus on
8
Sei giovani critici
raccontano
la Biennale Teatro 2012
Q
uest’edizione della Biennale Teatro,
diretta per la seconda volta da Álex Rigola, è stata caratterizzata da una forte dimensione laboratoriale, che ha riunito – come si potrà leggere
negli articoli che seguono – maestri e artisti di generazioni e poetiche diverse.
Sono state inoltre presentate quattro «Residenze», vale a
dire lavori, più o meno compiuti, realizzati dai partecipanti
alla Biennale negli scorsi due anni. In questi sette giorni d’agosto, nei quali i protagonisti sono stati i circa centocinquanta giovani attori coinvolti, è stata attiva anche una redazione, coordinata da Andrea Porcheddu e composta da sei altrettanto giovani critici teatrali attivi nel web. A loro – dopo
l’introduzione dello stesso Porcheddu – abbiamo chiesto di
raccontare quello che hanno visto (e che non poteva, ovviamente, essere tutto) e di esprimere anche qualche valutazione conclusiva. (l.m.)
Un laboratorio
di critica
alla Biennale
introduzione di Andrea Porcheddu
le biennali 2012 — teatro
S
iamo tornati, anche quest’anno, nelle belle sale di Ca’ Giustinian: uno spazio, all’interno della sede
della Biennale, dedicato alla critica teatrale. Un laboratorio dedicato alla scrittura critica, per dare corpo e anima a
una esperienza che si ripete sistematicamente ormai da quasi cinque anni.
Picchiano le dita sui tasti dei sette pc della «redazione»:
sono tutti al lavoro, giovani e giovanissimi, seri e motivati.
Preparano gli articoli dopo aver seguito i laboratori, gli incontri, dopo aver fatto interviste e incontri. La Biennale Teatro ha voluto aprire i propri spazi formativi anche alla pratica critica: è opera meritoria, non vi è dubbio. E per quest’anno sono stati selezionati sei critici di provenienza (geografica
e redazionale) diversa.
Ci siamo trovati, quotidianamente, a discutere, analizzare,
commentare. Abbiamo fatto tarda la notte, con un bicchiere di vino, a sviscerare temi emersi durante la visione dei workshop tenuti dai Maestri internazionali che hanno animato
l’edizione 2012 della Biennale Teatro. Abbiamo fatto interviste ai partecipanti, incontri (anche informali: con Oliviero Ponte di Pino, Anna Maria Monteverdi, Leonardo Mello, Fausto Paravidino e Iris Fusetti), abbiamo ascoltato i Maestri e osservato i loro metodi di insegnamento.
Abbiamo voluto e cercato il dialogo con i laboratoristi che
erano (e sono) il vero fulcro di questo enorme campus veneziano: attori e attrici provenienti da mezza Europa per ascoltare le lezioni di Donnellan e Ormerod, di Tolcachir e Carrizo, di LaBute e Ronconi. Maestri che certo hanno depositato schegge di memorie future nell’immaginario dei giovani allievi.
Per quel che ci riguarda, abbiamo cercato di spingere l’acce-
leratore sul dubbio e sulla domanda, proponendoci come osservatori attenti, ma aperti, disponibili. Un approccio verso
la ricerca e lo studio, per fare di un laboratorio di critica un
momento non solo di testimonianza e racconto, ma anche
– e soprattutto – di riflessione. Come per gli altri laboratori della Biennale, abbiamo avuto poco tempo per affinare le
armi e calibrare una proposta: nonostante ciò, siamo riusciti a tener fede allo spirito degli Open Doors, e siamo «usciti» quotidianamente, sul sito della Biennale Teatro e sui rispettivi siti/blog coinvolti nella iniziativa. E mi piace, allora, citare e ringraziare i partecipanti a questo laboratorio critico: Matteo Antonaci, di artribune.it; Roberta Ferraresi, di
doppiozero.com; Giada Russo, di ateatro.it; Elena Conti, di
iltamburodikattrin.com; Rossella Menna di rumorscena.
com e Andrea Pocosgnich di teatroecritica.net (e chi scrive,
di myword.it, a coordinare il lavoro). Un gruppo che rispecchia, tra l’altro, e ben rappresenta, la grande vivacità della critica italiana on line.
Come sempre accade in questi casi, ci sono voluti un paio
di giorni per trovare un ritmo e uno stile comune (o quanto
meno condiviso), ma poi la «redazione» ha iniziato a lavorare. L’esperienza «critica» della Biennale nasce, va però ricordato, da un contesto ampio, ossia dalla volontà di fare di
questa attività una sorta di investigazione continua: indugiare, senza stancarsi, nel dubbio, nel cavillo. Nel «perché»: come fanno i bambini irriverenti che vogliono sempre sapere
tutto. Dunque, già negli anni di direzione di Maurizio Scaparro abbiamo aperto il laboratorio Biennale a studenti delle
Università di Venezia. Poi con Álex Rigola abbiamo in qualche modo alzato il tiro pensando a una sorta di masterclass
per giovani critici già attivi sul web. Gli obiettivi, con Rigola,
erano infatti da subito molteplici e di grande respiro. Intanto mettere a confronto – diretto, immediato, feroce – i maestri della scena con i giovani critici. Credo sia sempre un privilegio, per un critico, entrare nella fucina di un artista, vederne il momento creativo, coglierne le dinamiche inventive
o di crisi. Questo è di grande valore per chi deve fare dell’osservazione partecipata il proprio mestiere. Non solo: si trattava, poi, di rompere delle barriere di linguaggio. La giovane
critica italiana è spesso legata (a ragione o a torto) al piccolo
mondo del giovane teatro di ricerca. Dunque un’apertura internazionale, fatta di lingue, prospettive, aspettative diverse,
non poteva che far crescere la nostra critica.
Perché è ormai chiaro quanto sia necessario un bagaglio di
consapevolezze sempre più articolate – musica, opera, cinema, arti visive, danza, fumetto, politica, scienza, economia,
attualità e molto altro – per tener dietro al teatro fatto e visto, e per superare un diffuso impressionismo di molta critica italiana. Poi c’è quella parola, su cui riflettere sempre: deontologia. Esiste una deontologia professionale del critico?
Una onestà intellettuale nel rapportarsi alla scena? Il mestiere di critico si declina ormai (e non potrebbe essere altrimenti) in mille rivoli: consulenze, direzioni artistiche, traduzioni, drammaturgie. Come mantenere una propria dignità, indipendenza, franchezza e freschezza di giudizio?
Penso dunque che la nuova generazione di critici che si sta
affacciando alla scena nazionale abbia molte possibilità per
disegnare nuove aperture, nuove tendenze, nuovi codici di
comportamento, facendo tesoro degli errori del passato. Oggi mi pare che il profilo ideale del nuovo critico teatrale debba contenere una buona dose di capacità creative (se si vuole vivere di questo non-mestiere) ma anche una capacità relazionale e di gioco di squadra che spesso in passato è mancata.
Anche per questo trovo molto interessante e utile che un’istituzione come la Biennale Teatro si preoccupi, oltre che di
formare attori, attrici e registi, anche di aiutare la nuova critica italiana a formarsi. ◼
di Rossella Menna*
S
i frantuma, alla Biennale teatro di Venezia, declinata nel 2012 in forma di laboratorio, il classico binomio tradizione/innovazione. Nel campus lagunare
saltano le caselle: si applaude al Leone d’oro a Luca Ronconi, si inneggia al lavoro sui personaggi dell’argentino Claudio Tolcachir, si assiste entusiasti alle proposte dell’iper-performativa compagnia Peeping Tom. Nessun criterio predefinito di giudizio, sguardi allenati alla varietà: fila tutto troppo liscio.
Poi si entra nel laboratorio di regia guidato da Luca Ronconi, e, per fortuna, le contraddizioni tra i due termini della contrapposizione si mettono in fila sul proscenio offrendo
spunti di discussione. Coinvolto in un’insolita formula laboratoriale, Ronconi affida a quattro giovani registi un compito gravoso: il lavoro su un testo classico. Armati di un gruppo
d’attori ciascuno, di una copia di Questa sera si recita a soggetto di Pirandello e di qualche lezione seminariale del maestro, i registi si ritrovano, a loro volta, alla guida di un workshop per attori.
Alla serata di Open Doors si scoprono le carte: tre su quattro hanno lavorato sul frammento finale della commedia,
sulla parte del testo in cui la metateatralità della pièce si dissolve in univocità finzionale e gli attori decidono di ribellarsi
al loro regista per preparare, in completa autogestione, la scena madre, il litigio finale tra Verri e Mommina.
Stesso tessuto verbale per tre variazioni sul mito completamente diverse.
Licia Lanera, annunciata con qualche espediente la cornice metateatrale, si concentra sul dramma di Mommina, sulla
sua condizione di donna violentata dal marito nella propria
vitalità. La scena in cui la prima attrice viene truccata per il
finale si trasforma in una macabra seduta di vivisezione in
Al lavoro con Luca Ronconi (foto di Luigi Laselva).
focus on
Focus sul laboratorio
di Luca Ronconi
cui la giovane donna, immobilizzata su un tavolo anatomico, viene imbruttita, denudata e rivestita, spogliata della giovinezza e ornata del vuoto pallore di moglie infelice. La regista sfrutta tutti gli strumenti del mestiere: immerge la scena in una luce spettrale, recupera qualche oggetto di scena,
azzarda un brano di Vinicio Capossela, S.S. Dei Naufragati, sulla bella immagine di un drappo nero che accoglie l’amplesso tra Verri e Mommina, metafora visiva di un bozzolo
che fatica a schiudersi.
Nella stanza accanto, Luca Micheletti inverte l’ordine dei
fattori, lavorando sulla stessa porzione di testo ma col fine di
ribaltarne gli equilibri, per immettere, cioè, nelle ultime battute della commedia, la stessa dose di doppiezza contenuta
nella prima parte.
Cogliendo l’opportunità per ragionare su tutto Pirandello, Micheletti riflette sull’intera trilogia del teatro nel teatro,
sul concetto di Maschere Nude e di Uno Nessuno e Centomila. Così, al doppio inteso come contrapposizione tra attore e
personaggio, aggiunge un secondo livello di doppiezza inerente il duplice volto dell’individuo comune
e un terzo livello che oppone attore e spettatore. In scena, due coppie di Verri e Mommina e due pubblici. Due blocchi che si spiano a
vicenda, come in uno specchio in cui l’originale e l’immagine riflessa si osservano senza
distinguere la propria natura di verità o di finzione. I quattro attori agiscono specularmente. Realtà e finzione non sono più discernibili: di chi sono i corpi che si agitano imbarazzati sulla scena? Degli attori della compagnia
di Hinkfuss che interpretano Mommina e
Verri? Degli attori di Micheletti che interpretano gli attori di Hinkfuss? Sono i personaggi stessi? I piani si sovrappongono e si incastrano sottopelle: restano imbrigliati in un
sistema macchinoso e non si esplicitano mai
mentre parla con chiarezza, per controparte,
il linguaggio dei segni teatrali, che attraverso
luci fredde e toni recitativi grotteschi, calca
con forza il regime della finzione.
Fattori invertiti, si diceva, ma stesso risultato per Lanera e Micheletti: disegno registico
tangibile per una performance finita, coerente, che non si arrischia fuori dal recinto delle partiture fissate.
Chiude la triade il giovanissimo Rocco Schira, che si allontana poco dall’originale testuale, limitandosi a costruire un
contenitore metateatrale di secondo grado che apre e chiude la pièce. La sua regia poggia per lo più su un disegno dello spazio di matrice noir. Sala completamente oscurata e illuminazione a luci led per un lavoro dominato dai toni espressionisti ed esasperati delle attrici.
Tutt’altra storia per Claudio Autelli che rinuncia alla performance chiusa e sperimenta fino all’ultimo momento. Tema della ricerca: dinamiche reali della recita a soggetto. Lo
scopo è quello di mettere in gioco l’identità stessa di attore, intesa come equilibrio precario ma necessario tra la natura quotidiana e la struttura narrativa in cui muoversi. Autelli libera i suoi attori nello spazio scenico chiedendo a ciascuno di far esplodere la propria attitudine attoriale in relazione al proprio personaggio. Gli interpreti divengono quindi parte di un gioco al massacro creato per smontare a vista
il meccanismo teatrale. Nella visione di Autelli i personaggi
del dramma non perseguono alcun principio comune, si dimenano in una situazione assurda in cui ciascuno insegue un
proprio progetto di recita a soggetto dal momento che, per
paradosso, il soggetto, la trama, sono proprio gli elementi che
vengono a mancare nel testo. Così il melodramma imma-
le biennali 2012 — teatro
«Questa sera si recita
a soggetto»: il lavoro sul testo
ai tempi della performance
9
focus on
10
ginato dalla prima attrice inciampa e cade sull’idea di recita
a soggetto del primo attore, producendo un annientamento
di entrambi gli obiettivi. A interessare il regista sono proprio
urti violenti di questo tipo, le interruzioni delle dinamiche
in atto tra i partecipanti al gioco, l’esplosione delle relazioni.
Rischia e paga pegno, Autelli. Laddove
viene meno il disegno registico predefinito,
emerge con più evidenza lo sforzo di attori
disabituati alla parola, che pure è visibile in
tutte e quattro le presentazioni.
In giro per le sale dell’ex cotonificio di Santa Marta si percepisce la difficoltà degli interpreti del dover reggere la parola, del riempirla, del doverla agganciare all’azione. Gli attori, a onor del vero quasi tutti bravi professionisti, si difendono come possono da un lavoro, per cui sembrano poco attrezzati, sul testo
e sui personaggi: capita che il tono si fiacchi e
che il ritmo cali intrappolato in un corpo irrigidito, oppure che si reagisca tentando la via
della recitazione impostata.
Evidentemente, i lavori in cui la regia ha assunto un ruolo predominante hanno retto
meglio l’urto del pubblico. Regia uno. Teatro
d’attore zero.
Più interessante, però, in un laboratorio, osservare lo sforzo di un regista che tesse la trama giorno per giorno solo sulle abilità degli
attori stessi, che la più facile riuscita di lavori finiti (o quasi)
fondati su progetti di regia prescritti. ◼
*rumor(s)cena.com
To show the time:
per una immaginazione
del corpo
Intorno al laboratorio
di Gabriela Carrizo / Peeping Tom
di Matteo Antonaci*
le biennali 2012 — teatro
L
o spazio interno di una casa, delle pareti di legno verdi consumate dal tempo, una libreria semivuota, poltrone antiche, libri gettati a terra accanto ad un
letto ai cui piedi una donna canta tendendo volto e braccia
verso un anziano, probabilmente malato. Qui un ragazzo ed
una ragazza danzano, senza mai allontanare i loro volti, indissolubilmente uniti dalle labbra, mentre tra le mani tengono stretta una bambina. All’esterno della scena, dai vetri delle finestre, un uomo anziano, come un guardone, spia
questa situazione familiare e porta nell’intimità sentimentale dell’azione scenica un tempo esterno; strania il rapporto
amoroso, inquieta, taglia con la lama del surrealismo la realtà perfettamente ricostruita. Questa celebre sequenza tratta
da Le Salon potrebbe essere assunta come un marchio della
compagnia Peeping Tom, distillato di quel mood emozionale
e di quel fare scenico che caratterizza non solo tutta la produzione artistica ma anche il lavoro laboratoriale che Gabriela
Carrizo, uno dei membri fondanti del gruppo, ha svolto durante la Biennale 2012.
Trasferitasi a Parigi dall’Argentina, formatasi con Alain
Platel e Jan Lauwers, la Carrizo fonda il collettivo Peeping
Tom insieme a Frank Chartier principalmente per la volontà ed il desiderio di raccontare storie e costruire personaggi.
Ogni entità posta in scena appare come sviscerata dall’intimità di ogni singolo componente del gruppo e presentata allo spettatore attraverso nuove modalità di rappresentazione
scenica capaci di rompere ogni confine tra le varie discipline
e di rifiutare qualsiasi tipo di categorizzazione.
Improntato totalmente sulle orme della Postmodern Dance, a tratti reazionario, il lavoro del collettivo coniuga clownerie, contact, teatro e cinema concentrandosi in particolare
su una determinata concezione del tempo e della tecnica di
montaggio ad esso sottesa. Caratterizzandosi principalmente attraverso le differenti qualità di movimento e di relazione
tra corpo/scenografia, i personaggi si inseriscono, infatti, in
un flusso di immagini determinato da tecniche di montaggio e di editing dall’impronta cinematografica. Le strutture
classiche della narrazione sono ricondotte a una dimensione prettamente contemporanea attraverso la spazializzazione del codice cinematografico, lì dove «spazializzare il codice cinematografico» significa agire sul tempo della performance e modellare rapporti temporali attraverso la materia
spaziale offerta dalla scena. Se, attraverso la scenografia e l’illusione ottica è possibile costruire dinamiche vicine a quelle
del campo/fuoricampo o del campo/controcampo, il lavoro
sul montaggio e sul movimento corporeo dei «danzattori»
permette di costruire dinamiche di rallenty o di accelerazione, zoom e panoramiche. Dichiara a proposito del montaggio la Carrizo: «Il montaggio si potrebbe suddividere in due
fasi. Una prima fase consiste nel verificare i momenti fondamentali di transizione all’interno della narrazione, come nel
cinema, quando si sposta una cinepresa da un’inquadratura
ad un’altra. La seconda fase, invece, consiste nel giocare con
la struttura dello spettacolo, con il tempo e con i personaggi.
Pensiamo alla tecnica dello zoom: in teatro tale tecnica non
esiste, ma possiamo riprodurre un dispositivo simile attraverso l’utilizzo del movimento: dilatiamo il tempo dell’azione come per avvicinarla allo sguardo. Al contrario, se vogliamo allontanarla, l’acceleriamo. Alteriamo il tempo per donare all’azione nuovi significati».
Mostrare il tempo. Sembra questo uno dei principali fini di
Peeping Tom: lasciare che il corpo trattenga non solo il pensiero ma anche quelle dimensioni cronotopiche in cui esso
Il laboratorio di Gabriela Carrizo
alla Fondazione Cini (foto di Elena Conti).
*artribune.com / teatroecritica.net
Dai «barrios»
di Buenos Aires
alla Biennale di Venezia:
il teatro di Claudio Tolcachir
di Giada Russo*
N
egli ultimi anni, la vivacità del panorama
artistico argentino ha cominciato a incuriosire i teatri europei, tanto che alcuni nomi come Bartís, Veronese, Spregelburd, Tolcachir sono ormai noti agli spettatori del vecchio continente.
Questa crescente apertura testimonia un diffuso bisogno –
nel mare magnum della «ipercontemporaneità» nostrana –
di ritornare agli elementi fondanti del fare teatrale: i personaggi, le storie, i luoghi.
Claudio Tolcachir, argentino di Buenos Aires, classe 1975,
è una delle figure di spicco dell’ultima generazione di teatristas appartenenti al circuito indipendente della metropoli rioplatense. Un artista a tutto tondo che recita, scrive, dirige,
insegna e coordina il proprio gruppo teatrale, Timbre 4, fonUna sessione con Claudio Tolcachir
alla Fondazione Cini (foto di Giada Russo).
atrale, parallela a quella ufficiale e commerciale di Corrientes, che si dipana tra sobborghi, strade di periferia, case chorizo, appartamenti, ex depositi: Timbre 4 è uno dei tanti spazi di questa città invisibile. Già dal nome, che riproduce il
numero del campanello, dichiara la propria condizione indipendente e alternativa.
Dai barrios della Buenos Aires off, Tolcachir ottiene la consacrazione del pubblico europeo al Festival d’Automne nel
2010 con la pièce La omisión de la familia Coleman, primo
quadro di una trilogia sulla famiglia e sulla società. Applaudito in più di venti Paesi, il giovane artista argentino arriva in
Italia nel 2008 a Vie Festival Scena Contemporanea di Modena e, passando per il Piccolo di Milano e il Mercadante di
Napoli, approda quest’anno alla Biennale di Venezia con un
laboratorio rivolto a venticinque giovani attori.
Per sei giorni, la Sala degli Arazzi della Fondazione Cini,
sull’isola di San Giorgio, delimita uno spazio di libertà appartato, strappato a una calda e caotica Venezia.
Nella fucina di Claudio Tolcachir la parola d’ordine è gioco: vanità e competizione restano fuori dalla porta, insieme con le scarpe dei partecipanti. E le regole del gioco sono
non giudicarsi e non giudicare, coerentemente con il metodo del maestro, che non esprime sentenze né dispensa ricette di teatro.
Nel tempo sospeso del laboratorio si impara a mettersi e
togliersi maschere a comando e a fare persino la parodia di
se stessi, pregi e difetti. La prima fase di lavoro si concentra
sull’ascolto del proprio corpo, che conserva tutte le necessità
dell’azione. Dalla mattina al pomeriggio si assiste a un cambiamento di rotta: il gioco puro lascia il passo all’esercizio del
pensiero, che per Tolcachir deve essere un «pensiero visibile». Esiste sempre un surplus dietro le parole e i silenzi, e l’obiettivo dell’attore deve essere quello di mostrarlo attraverso
uno sguardo o un gesto. Tolcachir si sofferma su uno dei fondamenti del lavoro dell’attore: la costruzione del personaggio. Gli allievi vengono invitati a vestire i panni di una per-
focus on
dato nel 1998 e divenuto un importante punto di riferimento della scena culturale della città.
Proprio nel 2001, anno della crisi economica argentina, il
giovane regista trova una casa per la sua compagnia, il Teatro-Escuela Timbre 5 che comprende due spazi – in Avenida Boedo 640 e in Avenida México 3554 – situati all’interno del medesimo stabile, nel quartiere operaio di Buenos Aires. Il teatro indipendente ha disegnato una nuova mappa te-
le biennali 2012 — teatro
si estende; dunque, offrire allo spettatore non l’azione tout
court, ma le possibilità di azione che scaturiscono quando
il corpo si immobilizza (come un frame quando si mette in
pausa una videocassetta) e il caso e la mente seguono immaginarie sequenze filmiche in cui ciò che accade è carica erotica, desiderio, volontà di azione e mai mero accadimento.
Ed è con tale attitudine che Gabriela Carrizo accoglie gli
allievi del suo laboratorio. Ogni singolo partecipante è chiamato a ragionare autonomamente su un tema
o su una condizione in cui il proprio corpo si
trovi immerso, a spogliarsi del proprio essere
attore o danzatore, ad abbandonare ogni forma di teatralità per scoprire un tempo intimo, coerente con il proprio spazio interiore.
Questo spazio, creato dalla mente, deve allora mostrarsi attraverso il movimento corporeo. Improvvisazioni collettive su scene costruite al contrario, o su movimenti rallentati in atmosfere temporali astratte, sono stimoli attraverso i quali plasmare «un’immaginazione del corpo». Quell’universo in cui,
attraverso il movimento, ogni singola interiorità diviene narrazione e ogni minuscola
contrazione muscolare il disegno di un tempo nel quale lo sguardo precipita un po’ meravigliato ed un po’ inquieto, un po’ innamorato e un po’ solo.
Il conclusivo Open Doors attraverso il quale la Carrizo mostra il suo laboratorio agli
spettatori della Biennale appare allora come un momento di apertura su un tempo esistente solo nello spazio laboratoriale; un tempo fragile perché privo di fini (e di fine), perché privo di spettacolarità. Infine, un tempo in cui quel celebre bacio tratto da Le Salon e
riproposto dagli allievi, sembra riattualizzarsi e recuperare
vita, donando al marchio di fabbrica di questa compagnia
una nuova intimità. ◼
11
le biennali 2012 — teatro
focus on
12
sona incontrata per caso tra le calli veneziane per darne dimostrazione nel piccolo bar dell’isola durante la pausa pranzo; l’idea è quella di una sorta di teatro invisibile, che scardina il senso della rappresentazione per restringere sempre più
i confini fra teatro e vita. Una volta rientrati in sala, il regista sottopone gli attori a una serie di domande per conoscere
meglio i personaggi, ovvero le «nuove persone che il giorno
prima non aveva visto».
Nell’arco di appena una settimana la sala di Tolcachir è già
casa. Quello di conoscersi e identificarsi come gruppo è stato il primo obiettivo raggiunto: dentro la fucina dell’artista
porteño, come tra i banchi di scuola, il gioco quotidiano comincia dall’appello collettivo, dove vince chi per primo riconosce l’altro.
Tolcachir ha fatto una scelta coraggiosa e, per l’Open Door conclusivo della Biennale, ha abbandonato le microdrammaturgie nate durante il laboratorio e ha deciso di mettere in scena cinque situazioni (di teatro e di vita) ambientate idealmente in cinque luoghi diversi: una camera ardente,
un treno, una barca, una strada di periferia, la sala d’attesa
di un medico. Ad abitarli, i personaggi su cui gli attori hanno lavorato nei giorni precedenti: prostitute, vagabondi, uomini d’affari, scrittori, collegiali impaurite, travestiti in cerca d’amore, e chi più ne ha più ne metta. Gli spettatori entrano quasi di soppiatto a spiare le loro azioni. Non succede nulla. Dopo qualche minuto finalmente i personaggi entrano in
relazione tra di loro, ma comunicano solo attraverso sguardi, piccoli gesti e poche parole, per lo più sussurrate: nessuna
storia, almeno per chi non raccoglie la sfida ad andare oltre,
per carpire quello che gli attori vorrebbero dirsi ma non si dicono. Se si supera questo primo ostacolo invisibile, prodotto da secoli di convenzioni (nel teatro e nella vita) e si dà libero sfogo all’immaginazione, il gioco è fatto: lo spettatore, libero di muoversi tra un angolo e l’altro della sala, può inventare storie infinite e diventare autore di uno spettacolo che
nessun altro ha mai visto. Le dinamiche degli spettatori diventano interessanti quanto quelle della scena: i loro bisbigli
all’orecchio, tra sguardi di stizza o di complicità, costituiscono parte integrante dello
spettacolo.
Se oggi anche il «nuovo» ha ormai alle spalle una lunga tradizione,
questo esito teatrale non
può dirsi del tutto inedito; eppure risulta affatto originale per un
pubblico che non è ancora pronto a rinunciare alle proprie abitudini,
e con difficoltà si adegua
a una modalità di partecipazione che non gli appartiene. Il tema che accomuna le diverse situazioni è l’attesa. I personaggi aspettano – chi il
proprio turno dal medico, chi l’arrivo dopo un
lungo viaggio, altri che
la notte passi in fretta –
e ingannano il tempo vivendo; gli spettatori, dal
canto loro, attendono
che accada qualcosa che
li distolga, almeno per un’ora, dalla realtà della vita (e dalla
finzione del teatro).
Tolcachir mette in scena una riflessione sul tempo che ha
raccolto la lezione di Beckett e non si nasconde dietro falsi
intellettualismi, ma si ciba di vita vera.
E il suo lavoro sembra raccogliere, a più di mezzo secolo di
distanza, il senso delle parole con cui Peter Brook commentava The Connection del Living Theatre, augurandosi che,
a partire dalla sfida radicale alle convenzioni contenuta in
quello spettacolo, il pubblico teatrale sarebbe stato in grado,
nei decenni a venire, «di guardare persone normali, in uno
stato normale, con interesse».
Era il 1959, ma la profezia sembra stentare ad avverarsi, almeno per il momento. ◼
*ateatro.it
Quattro gruppi in residenza
alla Biennale 2012
Dai laboratori 2010-2011
alla presentazione
di progetti autonomi
di Elena Conti*
Q
uando si abita un luogo si sente presto il desiderio di visitare quegli spazi che, nel corso dell’epoca moderna, sono stati privatizzati, chiusi alla
comunità. Questo vale in particolar modo per
una città come Venezia, rinomata per lo splendore dei suoi
palazzi e giardini, pochi dei quali, purtroppo, visitabili. I 7
Peccati, i micro-show che riflettevano sul peccato contemporaneo ad opera di sette registi internazionali, presentati lo
scorso anno alla Biennale Teatro, hanno offerto l’occasione
di assistere alla presentazione pubblica dell’esito laboratoriale in spazi bellissimi, non frequentemente aperti al pubblico
e non intesi come sale teatrali. Non è stata questa certamen-
Gli esiti delle quattro Residenze della Biennale, dall’alto in senso orario:
Qui-es-tu? Tu-me-tu (es), Propaganda, Swimming B e Pocilga.
focus on
ca, la modalità perseguita nella creazione di Swimming B ha
mantenuto costante l’idea di work-in-progress trasmessa alla formazione dall’esperienza fatta precedentemente con Jan
Lauwers, ma modellata sulle specificità dei singoli. «Tutto il
gruppo che ha lavorato con il maestro a Venezia – racconta
Carlota Ferrer – è rimasto influenzato dal suo linguaggio. La
modalità che seguiamo nella creazione si avvicina al suo modo di lavorare: un continuo work-in-progress che si basa sulle proposte differenti degli attori».
A chiusura del periodo di residenza, i progetti sono stati
presentati al pubblico in Open Doors volti a fornire agli artisti un riscontro sulla ricerca intrapresa in questa breve esperienza. Osservare la pluralità di linguaggi – pur trattandosi
ancora di piccoli frammenti – portata in scena da questi ensemble multinazionali, fa riflettere sulle difficoltà che si possono incontrare all’inizio di un percorso (come la disponibilità di uno spazio), e porta a riconoscere l’opportunità che la
direzione artistica di Álex Rigola ha offerto a questi gruppi.
Ora si può guardare al futuro, a una maturazione del lavoro,
come racconta Ferrer, che nello sviluppo della performance vorrebbe coinvolgere un drammaturgo; o come dimostra
The Moors of Venice, il cui pensiero va a InSIGHT?, il secondo step della trilogia dedicato all’aspra realtà siriana, che verrà presentato a settembre a Monaco di Baviera. ◼
*iltamburodikattrin.com
Un campus d’agosto
fra incontro e condivisione
Il progetto di Álex Rigola
per un cantiere
che lavori tutto l’anno
di Roberta Ferraresi*
Á
lex Rigola, fra i rappresentanti di quella nuova
possente generazione della regia europea che – ne abbiamo visto qualche esito proprio nelle ultime sue Biennali – continua a scuotere i palcoscenici e a reinventare il linguaggio teatrale, è al secondo mandato come direttore del festival lagunare. Qui, con l’intenzione di fare di Venezia un campus internazionale delle arti sceniche, sta sperimentando una
curiosa formula di direzione, capace di intrecciare la logica laboratoriale con il momento della messinscena. Cominciamo
l’intervista ponendo le domande che, lungo tutta la settimana, abbiamo rivolto agli allievi dei workshop, per proseguire
poi verso le idee e le spinte che da questo campus, ormai alla fine, portano già verso gli orizzonti del festival 2013.
La prima domanda che abbiamo posto ai laboratoristi è:
qual è lo spettacolo che le ha cambiato la vita?
I sette rami del fiume Ota di Lepage, Shopping & Fucking di
Ostermeier, Je suis sang di Jan Fabre… che altro? Mi è piaciuto molto uno degli spettacoli che abbiamo portato in Biennale l’anno scorso: Isabella’s Room di Jan Lauwers. Poi tutti i Dostoevskij di Castorf... Fra i più recenti c’è la versione
del Maestro e Margherita di Simon McBurney. I lavori di Sidi Larbi, un artista che vorrei portare a Venezia. Poi Sasha
Waltz, Pina Bausch…Gli spettacoli che mi hanno cambiato
sono così tanti che potrebbero non finire mai!
La seconda domanda riguarda direttamente i laboratori di
questa Biennale: fra «costi e ricavi», chiediamo di fare un bilancio dell’edizione 2012.
Cos’ho guadagnato? Sicuramente la felicità. Ad esem-
le biennali 2012 — teatro
te l’unica peculiarità del lavoro, ma piace ricordare l’importanza di quell’esperienza. A segnare un’apertura e uno sviluppo di quel momento di incontro, Álex Rigola ha offerto
quest’anno a quattro gruppi la possibilità di presentare un
progetto autonomo a cui lavorare nel corso di una residenza
artistica a Venezia (dal 4 al 10 agosto 2012). Il fil rouge che lega queste formazioni alle esperienze laboratoriali delle passate edizioni, risiede nella partecipazione dei componenti ai
workshop tenuti da Jan Lauwers, Romeo Castellucci, Rodrigo García e Thomas Ostermeier nel 2010 e 2011.
«Il nostro gruppo non si è ancora formalizzato in una compagnia – racconta John Romão in un’intervista a cura di
Matteo Antonaci – non avevamo mai lavorato insieme prima d’ora. Il laboratorio di Romeo Castellucci ci ha permesso di conoscerci e di creare legami di reciproca ammirazione». La decisione di Rigola di accostare le Residenze ai Laboratori, ha posto l’attenzione sulla ricerca teatrale di nuove
formazioni, sul lavoro di artisti che, come John Romão, assieme a Georgina Oliva, Piera Formenti e Damiano Ottavio
Bigi, hanno deciso di intraprendere e condividere un percorso per affinità di interessi e di poetica. Pocilga è il progetto su
cui si è concentrato il collettivo; gli spazi del Teatro Junghans
hanno accolto un primo avvicinamento scenico a Porcile di
Pasolini, in una riflessione focalizzata sul corpo umano e sul
corpo animale quali oggetti «di desiderio “invertito” – come
scrive Romão – e cause di scandalo all’interno di un gruppo
sociale. Un giovane, invece di amare il corpo umano, lo divora; un altro, invece di mangiare il corpo del maiale, lo ama. Si
tratta di corpi trasgressori che il potere vuole cancellare e nascondere. È questa la principale linea drammaturgica di cui
voglio occuparmi».
Sempre al Teatro Junghans, la compagnia Divano Occidentale Orientale, già costituita da Giuseppe Bonifati nel
2010 e impegnata lo scorso anno nel laboratorio condotto
da Rodrigo García, ha sviluppato Qui-es-tu? Tu-me-tu (es),
una performance nata dall’idea di un televisore che genera
interferenze. «In scena – racconta Bonifati – una casalinga
ha un rapporto sessuale con un televisore dal quale sembrano
nascere due figure, Y e Z. Le due entità non si conoscono ma
stabiliscono lentamente un dialogo fino a quando una violenza domestica non crea un cortocircuito imprevisto. Non
sono interessato ad una critica massmediale – continua il regista – voglio mettere in scena un incubo nel quale i personaggi non sono che entità astratte».
Accanto a queste esperienze, altre due formazioni hanno
lavorato negli splendidi saloni del Conservatorio Benedetto Marcello: sono The Moors of Venice, il gruppo creatosi all’interno del laboratorio di Thomas Ostermeier, ora alle prese con Propaganda, la prima parte di The Revolution
Project, e l’ensemble costituito da Carlota Ferrer, Nicolas
Wan Park, Francesca Tasini e Emmanuelle Moreau, impegnato in Swimming B, una rilettura di alcuni monodrammi di Beckett.
La possibilità di seguire parte delle prove degli artisti presenti al Conservatorio, ha distolto dalla congettura che legava e restringeva il percorso di questi professionisti al nome
del regista del laboratorio, come alla ricerca di segni distintivi di un «superficiale» passaggio di testimone da maestro
ad allievo, ponendo piuttosto in evidenza la sperimentazione apportata da questi giovani autori al contemporaneo panorama performativo. Ognuno di loro ha potuto organizzare a proprio modo le giornate di lavoro: così se The Moors of
Venice, il gruppo guidato da Fèlix Pons, nel corso delle prime prove si è approcciato alla messinscena di Propaganda –
un interessante studio sull’eta, l’organizzazione terroristica basca – in maniera più consueta, per giungere in seguito
a un capovolgimento totale della costruzione drammaturgi-
13
le biennali 2012 — teatro
focus on
14
pio i due Open Doors dell’ultima sera (dai laboratori di Gabriela Carrizo e Claudio Tolcachir, ndr) mi hanno reso molto felice: non tanto perché quello che hanno mostrato fosse bello o interessante – in effetti lo era – ma per il rapporto
che hanno mantenuto con il percorso di lavoro che si è sviluppato in questi giorni. Perché abbiamo voluto presentare
degli Open Doors alla fine dei workshop? Certo non per vedere degli spettacoli: queste dimostrazioni non erano come
i 7 peccati, la serie di micro-show itinerante che ha concluso
la Biennale 2011; piuttosto rappresentano, per gli altri allievi dei laboratori, la possibilità di conoscere altri modi di lavorare e pensare il teatro. Così mi chiedo: cosa succederebbe se, per un giorno alla settimana, potessimo cambiare i nostri maestri e provare qualcosa di totalmente diverso? Credo potrebbe
essere un’esperienza fondante: una specie di
«pausa» dal proprio lavoro, in cui il cervello
si sposta per andare a incontrare un altro percorso e poi, il giorno successivo, torna rinnovato dal maestro e dal teatro che ha scelto. Mi
pare che l’esperienza dell’ultima serata abbia
saputo raccontare davvero molto bene quello
che ho provato a fare qui con il Laboratorio di
arti sceniche della Biennale.
L’ultima domanda che abbiamo posto in
questi giorni agli allievi dei laboratori: che senso ha, secondo lei, fare teatro in questi tempi di
crisi?
…che sia troppo tardi per iniziare una nuova carriera?! (ride) Ora tutto è peggiorato, ma
non penso di essere cambiato molto rispetto
a due anni fa, sono sempre ugualmente critico. Credo che, facendo regia, il mio lavoro
possa essere quello di indagare – anche se solo parzialmente – la psicologia umana e di vedere un po’ come va il mondo. Non ho soluzioni: non sono
uno statista, un economista o un filosofo, posso solo raccontare quello che mi accade intorno ogni giorno.
Tuttavia, mi è capitato spesso di pormi questa domanda e,
pur credendo che non ci sia una risposta precisa o necessaria,
sono giunto alla conclusione che facciamo teatro per sapere qualcosa in più su noi stessi. Penso sia questo il senso ultimo dell’arte scenica, anche dal punto di vista degli spettatori: andiamo a teatro per conoscere qualcosa in più sull’essere umano. Ma perché vogliamo sapere così tanto, e sempre di
più, su noi stessi? Forse questa è la vera domanda.
Una Biennale all’insegna del laboratorio: il progetto, avviato nel 2010, quest’anno si condensa in un’unica settimana e richiama a Venezia più di centocinquanta fra maestri e allievi…
Per me il laboratorio non è un luogo di lezione, ma di «simmetria». Deve essere un posto in cui il maestro sperimenta qualcosa e gli allievi lo seguono, possono vedere come lavora: ma deve essere innanzitutto anche un’occasione per il
maestro stesso, un momento che serva profondamente anche a lui, ossia uno spazio per mettersi alla prova. Il laboratorio, dunque, non può seguire una direzione univoca – una
trasmissione di sapere dal maestro agli allievi – ma diventare
una occasione di condivisione di esperienze.
Veniamo alla presenza dei maestri: nelle passate stagioni si
poteva individuare un legame empatico, quasi generazionale, fra gli artisti invitati in Biennale. Quest’anno la proposta
è «esplosa»: c’è un grande maestro come Ronconi e un regista
come Donnellan; si trovano la drammaturgia, il teatro-danza
e l’esperienza di un autore-regista come Claudio Tolcachir…
Qual è il criterio, l’interesse, che muove verso queste persone?
Il percorso di selezione – quest’anno, ma anche nelle edizioni precedenti e future – è un processo complesso. Ma non
esiste una teoria, come ad esempio lavorare con artisti che appartengono a una stessa generazione. Quella del 2011 si può
dire sia stata una pura casualità; anche se è vero che le coincidenze non esistono e si potrebbe pensare che, trattandosi di
artisti tutti miei coetanei, sono persone il cui lavoro mi piace molto e da cui ho imparato tantissimo, innanzitutto come spettatore.
Che relazione lega gli artisti coinvolti nel 2012? Ognuno
è qui con il proprio percorso, con il proprio lavoro e un’estetica specifica. Il punto, piuttosto, è un altro: un progetto laboratoriale è profondamente diverso da un festival – e noi,
in questi tre anni, ci stiamo muovendo fra entrambe queste
polarità. Workshop e spettacolo sono elementi strettamente legati, per me è un punto molto importante. Non si viene
a Venezia soltanto a seguire delle lezioni o a vedere delle messinscene; si viene alla Biennale piuttosto per un campus estivo dove il tratto determinante è la condivisione di esperienza a tutti i livelli. Qui si può incontrare il lavoro di un maestro e gli allievi possono seguirne i processi di sperimentazione. Ma la trasmissione di sapere funziona anche fra i singoli partecipanti dei laboratori, fra allievi attori e registi... Siamo tutte persone a cui piace il teatro e che vogliono imparare qualcosa in più: è per questo che ci ritroviamo tutti insieme per una settimana.
Come si rapporta questo progetto legato alla dimensione laboratoriale e della ricerca con uno spazio istituzionale come
quello della Biennale di Venezia?
Devo dire che qui c’è una grande libertà artistica. La Biennale è un luogo in cui si può provare a realizzare quello che si
desidera artisticamente. Ogni volta che ho raccontato le mie
idee e i miei progetti sono sempre stati accolti con interesse e
curiosità: non dappertutto esiste tale disponibilità nei confronti della direzione che un artista intende proporre.
In particolare, per quanto riguarda i percorsi laboratoriali,
è stata proprio la Biennale a stimolare un approccio del genere: l’idea non è soltanto mia. Ad esempio Ismael Ivo, direttore del Settore Danza, ha attivato un percorso formativo lungo cinque mesi. Ora c’è il nostro, con il teatro; e a fine ottobre ci sarà Musica. Sono progetti formativi che si dipanano
quasi per tutto l’anno. E questa è un’idea fortemente sostenuta dal Presidente Baratta: il termine «Biennale College»
è suo. Ciò significa che ci siamo incontrati su di uno stesso
Álex Rigola.
*iltamburodikattrin.com / doppiozero.com
La formazione continua:
una riflessione
sulla Biennale Teatro
di Andrea Pocosgnich *
I
l termine «condivisione» appare più volte nelle
risposte date da Álex Rigola a Roberta Ferraresi nell’intervista che compare proprio in queste pagine. Ed è in effetti questo il senso ultimo del progetto formativo ideato dal
regista catalano sin dalla prima edizione del
2010. Il tiro è andato modificandosi di anno
in anno, con in mezzo un festival direttamente connesso al precedente periodo formativo.
Se nella prima edizione i laboratori cominciavano in ottobre e terminavano in primavera
inoltrata, questa Biennale ha invece visto concentrarsi tutte le classi in meno di dieci giorni
permettendo uno scambio osmotico di esperienze non solo tra i partecipanti, ma anche
tra i maestri, mantenendo comunque intatta la durata di ogni workshop. È stato curioso
osservare l’affermato Declan Donnellan interloquire con l’astro nascente del teatro argentino Claudio Tolcachir del quale fu maestro in un laboratorio tenuto a Buenos Aires alcuni anni fa; oppure vedere l’americano
Neil LaBute incrociare il suo particolarissimo percorso (regista teatrale, drammaturgo,
filmaker) con quello del teatro europeo, distante per metodo e funzione sociale.
La «Cambridge delle arti sceniche» – così
tra speranza e ironia Rigola chiama il futuro
del suo progetto formativo – ha visto, oltre ai
tre maestri citati, il teatro-danza di Peeping Tom (alle prese
con un lavoro spietato, ma anche allegro e ironico, sul corpo
degli allievi) e il Leone d’oro alla carriera Luca Ronconi con
le sue lezioni su Pirandello che immediatamente divenivano
seminari sull’arte teatrale. Personalità che vanno a comporre un mosaico eterogeneo e complesso della scena contemporanea e in parte anche interpreti di una vocazione – per lo più
assente in Italia – che caparbiamente lega tradizione, ricerca
e commerciabilità dell’opera.
Un campus delle arti sceniche, inevitabilmente, è anche
una comunità. Il che comporta una condivisione non solo
degli spazi e dei tempi laboratoriali, il prima e il dopo si mescolano: la sveglia in ostello, la colazione prima del vaporetto, la cena, le passeggiate per le fondamenta, lo studio in notturna. Nel segno di questa condivisione si costruiscono le basi di un vero e proprio campus. Per ora rimane l’idea, romantica e affascinante, che deve vedersela con la consueta scarsiAlcuni partecipanti ai laboratori (foto di Giada Russo).
ve Creatività eti, Luca Micheletti, Premio Ubu 2011, alcuni venivano invece da recenti esperienze nel cinema e nella
televisione. Se escludiamo insomma quel senso di incontro
e condivisione per concentrarci sulla risultante pedagogica
(anche se è chiaro che mentre il primo può fare a meno della
seconda non è vero il contrario) difficilmente riusciamo a tirare le somme del progetto di Rigola. A sentire i partecipanti, a parte lo spaesamento iniziale degli attori venuti per Ronconi che poi si sono trovati a lavorare in gran parte con giovani registi, l’esperienza ha portato i suoi frutti: artisti come
Claudio Tolcachir e Gabriela Carrizo hanno avuto una presa immediata sui propri allievi stabilendo un rapporto empatico e di grande stima. Ma nel caso di una istituzione come la
Biennale un campus estivo deve anche essere l’epicentro del
dibattito artistico, luogo di eccellenza dove si misura il fermento della scena, punto nevralgico della città, realmente e
per tutto l’anno, open door; l’alternativa è l’ennesimo fast-food del workshop teatrale. ◼
*TeatroeCritica.net
focus on
tà di risorse economiche. È stato un assaggio. Come definire
d’altronde dei laboratori che nella migliore delle possibilità
hanno avuto una durata settimanale? Cosa si porteranno a
casa gli allievi di LaBute dopo tre giorni di corso? La cura del
gesto e la ricerca sul corpo drammaturgico di Gabriela Carrizo possono essere appresi con meno di una settimana di lavoro? È il segno dei tempi, certo: anni in cui gli artisti debbono vivere in una condizione di formazione perenne, perché se il lavoro scarseggia bisogna sapersi adattare, fare tutto, anche impreziosire il curriculum con momenti formativi
mordi e fuggi. La riuscita non è dunque misurabile proprio
perché strettamente legata alle esperienze pregresse di ogni
partecipante. Variegata d’altronde la platea di attori e performer, più di cento, che hanno risposto all’avviso pubblico
della Biennale, anche grazie ai costi molto contenuti. Resiste
come punto di riferimento principale l’accademia. Il percorso formativo di lunga durata sembra rimanere la prima tappa obbligata (quantomeno lo è per chi si è occupato di selezionare i curricula), ma anche per chi è già inserito nel mondo lavorativo l’appuntamento laboratoriale col grande maestro è d’obbligo. Non mancano però artisti che si stanno affermando tra le nuove generazioni – a seguire il workshop di
Ronconi vi erano ad esempio Claudio Autelli e Licia Lanera, entrambi vincitori dell’ultima edizione del premio Nuo-
le biennali 2012 — teatro
cammino: le nostre ricerche si uniscono nella volontà di abitare questa «città della conoscenza», dove abbiamo la fortuna di trovarci. Proseguendo su questa linea, la Biennale Teatro potrà diventare una sorta di «Cambridge dell’arte scenica». Sembrerà una definizione eccessiva ma, guardandosi
un po’ intorno, ci si rende conto che al giorno d’oggi, in teatro, non c’è nessuno che stia lavorando a qualcosa di simile. ◼
15
focus on
16
Rafael Spregelburd
secondo
Luca Ronconi
R
a cura di Oliviero Ponte di Pino
afael Spregelburd è uno degli autori più rappresentati in Europa. In Italia alla sua drammaturgia si è interessato nientemeno che Luca Ronconi,
che nel 2011 ha allestito La modestia, e nel prossimo futuro metterà in scena Il panico, cioè due delle sette tessere che compongono l’Eptalogia di Hieronymus Bosch. Oliviero Ponte di Pino, esperto conoscitore di entrambi, ha seguito l’avvicinamento del maestro all’autore argentino nelle
sue varie fasi, intervistando Ronconi prima del debutto della Modestia, e poi a «prima» avvenuta. A queste due conversazioni se ne aggiunge ora una terza, dedicata allo spettacolo
che verrà e realizzata per VeneziaMusica e dintorni. Cogliendo l’occasione del Leone d’oro alla carriera, pubblichiamo le
tre interviste per offrire anche diacronicamente un’idea del
lavoro e delle riflessioni che il grande regista ha svolto a partire dalle pièce del drammaturgo di Buenos Aires. (l.m.)
«La modestia» 1:
uno spettacolo infinito in un teatro in fuga
le biennali 2012 — teatro — appendice
H
ai lavorato moltissimo sui classici, ma nella tua carriera
non mancano le incursioni nella drammaturgia contemporanea. Anche se poi a volte pare quasi che la drammaturgia
contemporanea non ti soddisfi del tutto, visto che spesso senti il bisogno
di utilizzare testi non teatrali. Non è affatto vero che non mi interessa la drammaturgia contemporanea, e non solo in questi ultimissimi anni. Nel 1978, quando
ho fatto Calderón, Pasolini era contemporaneissimo...
…Wilcock, di cui nel 1971 hai portato in scena XX, pure... Anche Infinities era drammaturgia contemporanea. In realtà il
termine «drammaturgia» mi pare troppo generico. Ci sono scrittori per il teatro contemporaneo, e ce ne sono sempre stati, che però non chiamerei «autori»: sono piuttosto fornitori di copioni, secondo le regole teatrali vigenti in quel momento. Altri scrittori per
il teatro sono invece propriamente «autori»: possiedono un linguaggio particolare, hanno un modo singolare di organizzare i materiali teatrali: sono gli autori che mi interessano di più.
Dunque è in primo luogo un problema di linguaggio.
Certo. Prendi in esame gli «ultimissimi». Un autore come JeanLuc Lagarce (di cui ho allestito Giusto la fine del mondo nel 2009)
ha il suo linguaggio. Anche Botho Strauss, che ho messo in scena
due volte (Besucher, 1989, e Itaca, 2007) ha una sua fisionomia, come Edward Bond, un altro autore che ho messo in scena due volte
(Atti di guerra, 2006, e La compagnia degli uomini, 2011). D’altra
parte, perché devo dire che non è un autore contemporaneo l’autore di Infinities, John Barrow? O Giorgio Ruffolo, di cui ho portato
in scena Lo specchio del diavolo? È vero, hanno scritto due saggi, che
però hanno avuto una forte resa teatrale... La forza del linguaggio si coglie già alla lettura, sulla pagina, oppure è necessario aspettare di vederla incarnarsi in scena, nella parola degli attori? Si vede subito, dalla pagina. Quando ho letto l’epistolario di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, Il silenzio dei comunisti, mi sono detto: «Questo lo posso benissimo fare», non tanto
perché si tratta di testi scritti in prima persona, ma perché sono tre
forme di linguaggio molto precise e diverse una dall’altra.
Quando metti in scena un classico sei sempre molto consapevole di
tutte le varie messinscene di quel testo. Nel caso di un testo contemporaneo, questo non è possibile. Infatti l’approccio è abbastanza diverso. Sui classici gioca molto
la memoria che ne hai, le frequentazioni... Il lavoro su un testo contemporaneo mi piace molto e mi è sempre piaciuto, perché è sempre
un lavoro di scoperta. Un testo contemporaneo lo puoi fare in vari
modi. Per esempio, c’è chi va a vedere una commedia inglese al Fe-
stival di Edimburgo, e poi la riproduce più o meno uguale in Italia,
con gli opportuni accorgimenti. Un’operazione del genere non sarei capace di farla, per un motivo molto semplice: per me, a parte il
linguaggio del testo, anche la lingua che parlano gli attori non è facilmente trasferibile in un’altra lingua. Ecco, mi interessa lavorare
su testi contemporanei dove la scrittura presenta dei problemi. La
stessa cosa sarebbe accaduta se fossi nato quarant’anni prima e mi
fossi trovato a mettere in scena una commedia di Pirandello.
Quando dici che il linguaggio pone dei problemi, che cosa intendi?
Si tratta ogni volta di capire, non solo dal punto di vista drammaturgico, perché l’autore usa quella cadenza, quel ritmo, quel giro di
frase... Insomma, non si tratta di leggere il testo come uno spartito
che va in qualche modo ripercorso, e poi alla fine lo spettacolo viene fuori da solo. Si tratta invece di capire le ragioni che stanno dietro alle scelte dell’autore.
Quindi si tratta di andare a vedere quello che c’è aldilà e sotto il testo. Ma questo lo fai anche con Pirandello e con Shakespeare... Il presupposto è cercare di entrare nella mente di chi ha fatto una
cosa, e questo vale sia per i classici sia per i contemporanei... Arrivando a Rafael Spregelburd, che cosa ti ha interessato quando
hai incontrato i suoi testi? Mi sono subito sentito un suo parente. Una volta mi hanno chiesto: «Qual è il tuo spettacolo ideale?». Io ho risposto, e risponderei
ancora, che è uno spettacolo infinito in un teatro in fuga. Lo sguardo un tantino scettico che mi viene quando si parla di «profondità», e la curiosità che mi si sveglia immediatamente quando si parla
di “estensione”, li ritrovo perfettamente in Spregelburd. E poi, come gli ho detto quando l’ho incontrato, il motivo per cui mi piace il
suo teatro è che mi sembra che scriva commedie che si fanno da sole.
In che senso le commedie di Spregelburd «si fanno da sole»? Sono organismi che proliferano quasi indipendentemente
dall’autore. Anche se poi in realtà l’autore c’è, ed è presente in ogni
cerniera. Tuttavia i suoi testi ti danno questa impressione: tanto è
vero che in parecchie commedie, compresa La modestia, hai l’impressione che l’autore non riesca a trovarne la fine. E non lo considero un difetto o una mancanza.
Infatti Spregelburd è autore di testi molto lunghi, a puntate, che
proliferano... E questo mi piace molto. Ma secondo te qual è il meccanismo generativo che porta a questa
proliferazione infinita?
Le mie sono solo illazioni, ma credo che nel caso di Spregelburd
sia il frutto di un senso storico molto preciso, da una forte consapevolezza della contemporaneità – e con questo non voglio certo dire
dell’attualità. È un senso delle simultaneità contemporanee. In varie occasioni mi sono trovato a fare degli spettacoli in cui c’era una
sincronia strutturale, con diverse azioni che accadono simultaneamente. Spregelburd parla addirittura di «struttura frattale».
Quindi ti ha interessato il lavoro sul tempo, sulla durata e sulla
simultaneità...
Nella sua drammaturgia si sentono anche le ascendenze della sua
formazione matematica. E possiamo trovarci anche tantissimi antecedenti letterari, anche perché molto spesso la sua drammaturgia
si rifà a topoi drammaturgici e narrativi molto riconoscibili.
Ed è argentino come Borges... Tuttavia lo scheletro logico-matematico che sostiene la sua drammaturgia, e questo intreccio di citazioni
colte, poi si contaminano con l’aspetto pop, perché c’è una grande capacità di usare i linguaggi contemporanei... È anche molto ludico...
...e molto ironico: nella Modestia ci sono varie stratificazioni ironiche. Ma questo, forse, per un regista come te pone un ulteriore problema. Hai detto che, di fronte a un testo, vai a scavare quello che c’è dietro, o sotto. Di fronte a una scrittura di per sé così stratificata, che cosa puoi trovare? Devi giocare anche temporalmente, prima una cosa, poi l’altra,
poi un’altra ancora, per ricostruire la stratificazione che c’è nel
testo. Come ti poni di fronte ai meccanismi ironici della scrittura di
Spregelburd? Nella Modestia ci sono anche elementi patetici... Tutta la vicenda russa lavora sul patetico... È straziante! Come i grandi romanzi russi dell’Ottocento... Ma con tutte queste
suggestioni presenti nel testo, come riesci a richiudere il cerchio, a far
quadrare l’aspetto logico di cui si parlava prima? E chi lo sa? Vedremo... 17
focus on
tare e giocare, controllando contemporaneamente due codici completamente diversi. È una facoltà che esiste, c’è qualcosa di reale, di
fisiologico. Sono procedimenti mentali e cognitivi che possiamo seguire, una situazione in cui le parole ti vengono da sole e non devi
andarle a cercare... Questo meccanismo è già presente nel testo?
Sì, e l’attore deve eseguirlo. Questo non vuol dire che non ci deve
mettere del suo: però può metterci qualcosa di suo solo dopo aver
restituito quello che c’è nel testo: per l’appunto questo essere perennemente bilocati.
La bilocazione è una qualità che attribuivi in senso generale alla drammaturgia di Spregelburd, e che si riflette anche nel lavoro
dell’attore. La nostra tendenza «italiana» consiste nel recitare sempre per
convincere l’altro. L’attore cerca di essere convincente, vuole avere ragione. Invece in questa commedia l’obiettivo è frastornare,
deviare...
Tutto questo sullo spettatore che effetto può o deve avere?
Nel migliore dei casi, dovrebbe accadere quello che capita con certi film di Hitchcock, come Marnie o La finestra sul cortile: capisci che tutto quanto ha una regola, però fatichi un po’ a trovarne
la chiave.
Il pericolo è che la chiave venga fuori troppo facilmente?
Oppure che non venga fuori affatto...
L’altro aspetto interessante della drammaturgia di Spregelburd, come abbiamo visto, è che offre diversi livelli – e dunque chiavi – di lettura. C’è lo spettatore a livello – diciamo così – di telenovela, che viene catturato dalla trama, dalle vicissitudini dei vari personaggi. C’è
lo spettatore in grado di decodificare i riferimenti più o meno colti, teatrali, letterari e cinematografici, e quindi si diverte ironicamente a
smontare il meccanismo... Ma sotto c’è ancora qualcos’altro?
Be’, qualche ambizione filosofica c’è. Vuole essere un teatro scientifico, in qualche modo. L’oggetto di questa scienza?
La perdita d’identità è sicuramente un tema. (Milano, 16 maggio 2011)
«La modestia» 2:
un imbroglione con un senso etico fortissimo
N
el corso delle prove, rispetto alla tua lettura del testo di Spregelburd e al progetto iniziale, quanto spazio è rimasto a te e
agli attori per cambiare la tua visione della commedia e dello spettacolo?
La prima cosa che ho detto agli attori, il primo giorno di prova – e
a quel punto si sono quasi spaventati – è: «Guardate che io non sono per niente preparato. Non ho un progetto già fatto, ma credo di
conoscere molto bene la commedia. Però non mi sono posto il problema di quello che ne deve venir fuori». Non è che mi capiti sempre di trovarmi in una situazione del genere, ma in questo caso ci ho
voluto provare.
Mentre di solito, quanto inizi a provare, hai già preparato la messinscena nei dettagli? Dalla caratterizzazione dei personaggi ai movimenti degli attori…
No, questo non mi capita mai. In questo caso avevo in mente diverse ipotesi, diciamo tre o quattro possibilità di lettura del testo o
di una determinata scena. Secondo me questo è un buon punto di
partenza. In genere mi dico: «Be’, questa scena potrebbe essere così,
ma potrebbe anche essere fatta in quest’altro modo». È una logica
combinatoria: le commedie di Spregelburd sono costruite proprio
così, ed è per questo che mi piacciono. Dunque penso che il mio fosse l’atteggiamento giusto per affrontare un testo come questo… Poi,
come sempre, durante le prove sono arrivati momenti di difficoltà.
E la difficoltà può essere risolta pensando: «Be’, forse questa cosa
qui è quest’altra». […]
Spregelburd lavora per citazioni, rimandi, frammenti, e per accumulo. Dunque è come se mettesse moltissime virgolette all’interno
della sua scrittura drammaturgica. In genere, tu hai lavorato con gli
attori proprio togliendo queste virgolette, chiedendo loro di prendere
il testo alla lettera, battuta dopo battuta: «Siete in questa situazione,
e dunque dover comportarvi di conseguenza». Ma contemporaneamente, quando gli attori sono in una delle due
situazioni, diciamo nella vicenda russa, sono anche in quell’altra,
quella sudamericana… Però introducendo questo gioco del teatro nel teatro, è come se aggiungessi altre virgolette.
le biennali 2012 — teatro — appendice
Anche perché, di fronte a un testo di questo genere, il lavoro con gli
attori non può certo andare verso l’approfondimento psicologico, lo
scavo nell’interiorità dei personaggi... Non avrebbe senso. L’idea stessa di identità individuale viene
messa radicalmente in discussione. C’è un aspetto che mi piace
molto della Modestia: questi personaggi – anzi, questi attori, perché
c’è la condizione del personaggio e quella dell’attore... Ecco, quello che mi piace è che gli attori non dovrebbero mai sapere con precisione se stanno in una storia o nell’altra. Quella sensazione di essere sempre profughi, di vivere continuamente le vite degli altri, mi
pare che sia una caratteristica dei personaggi di Spregelburd. Molte delle sue commedie – penso al Panico, alla Paranoia – sono «bilocate»: si svolgono in più posti, in due luoghi se non in quattro.
Dunque emerge la sensazione di essere un po’ i fantasmi di altri:
nella Modestia questa sensazione è fortissima, si usano gli attrezzi
di altri, i personaggi si siedono dove altri si sono seduti, si sdraiano
su letti che appartengono ad altri, perché sono nell’altra storia... È
una cosa bella e interessante: la riflessione sul rapporto tra l’attore e
il personaggio si moltiplica all’ennesima potenza.
Su Spregelburd avevi un piano più ambizioso rispetto alla messinscena di un unico testo. Sarei partito quest’anno portando in scena io tre testi suoi, e poi in
futuro mi sarebbe piaciuto allargare l’esperienza anche ad altri colleghi, per presentare tutti i sette testi della Eptalogia. Forse ci si riuscirà, con il tempo.
Farò di tutto per riuscirci, perché mi pare che si tratti di un autore
che merita di essere conosciuto. Molto teatro contemporaneo prende i suoi temi dal giornalismo, dall’attualità, dalla cronaca: a volte
questo dà origine a testi belli, altre volte a testi meno belli, ma sempre un po’ precotti. Spregelburd è invece un autore che si è affidato
a una percezione della contemporaneità che corrisponde al nostro
tempo ma non è cronachistica, lavora sull’immaginario. Ho sempre pensato che in teatro un tema contemporaneo, se lo cali nelle
forme e nelle strutture consuete (il personaggio, il dialogo, la trama, l’intervallo, eccetera), alla fine tanto contemporaneo non risulta. Gira e rigira, quei testi sembrano tutte commedie dell’Ottocento: quelle forme non riescono più a contenerci, non ci stiamo
più dentro...
Un altro aspetto che ti ha incuriosito è che questi testi non sono scritti da un letterato, ma da un uomo di teatro.
Lo senti subito! Una battuta di Schiller o di Ibsen può essere recitata bene o recitata male, ma resta, ha una sua autonomia. Invece
una battuta di Spregelburd pretende di essere recitata.
Perché non è letteratura? È anche letteratura, e questo è il suo bello. Però va in due direzioni diverse: da una parte c’è un gioco letterario, e infatti il testo, se
lo leggi, funziona benissimo; d’altra parte, però, se il gesto e la voce non se ne fanno carico, improvvisamente quel gioco sparisce e rischia di restare solo una lettera piatta. Tenendo presente che il gesto
e la voce dell’attore apparentemente possono dare molto, ma possono anche togliere molto.
Un altro aspetto che conferma la forza di questo testo è la precisione
dei rapporti tra gli attori, tra i personaggi, tra gli spazi, tra i tempi...
È una consapevolezza che un autore può raggiungere solo se è abituato a fare teatro, a muovere gli attori in scena.
Del resto le didascalie che costellano il testo sono fatte sulla rappresentazione. Le ripropongo tutte, perché fanno parte del testo. A volte nel caso dei classici sei andato «contro» il testo. Nel caso di
un autore contemporaneo si può fare? Ha senso farlo? È un po’ difficile. I classici ormai sono diventati una terra di nessuno. Però con un testo contemporaneo, invece, è possibile in qualche
modo sbagliarsi, cadere in qualche equivoco, non capire.
Stai facendo lavorare duramente gli attori. Anche perché non devono sbagliare...
Non è facile. Devono capire bene perché ci sono quelle parole,
perché quella parola ne chiama un’altra... La maggior parte degli
attori ha sempre la tendenza alla psicologia, alla ricerca della verità.
Con questo testo diventa molto difficile.
A quel punto, però, se gli attori non si possono agganciare a questo,
che cosa resta?
Devono trovare qualcos’altro a cui agganciarsi. Per esempio, c’è
una scena in cui un personaggio – quello che interpreta Fausto Russo Alesi – gioca a carte un gioco che non conosce e contemporaneamente tratta un affare. Potrebbe diventare una specie di cliché comico, ma in realtà viene molto meglio, ed è più divertente, se senti che l’attore si mette in una specie di bilocazione reale: può ascol-
le biennali 2012 — teatro — appendice
focus on
18
C’è un’altra situazione di questo genere nel finale. Ti riferisci al crollo? No, ancora dopo. Tutta la confusione finale… Accade un po’ come in altre commedie di Spregelburd: sembra che l’autore non riesca a venire a capo di tutti i fili che ha tirato. E allora, per giustificare quello che è accaduto, arriva quel finale. Ma perché bisogna giustificarlo? Il finale è quello, e basta… Ma può essere utile anche tener presente che questo testo Spregelburd l’ha anche interpretato:
faceva la parte di Terzov/San Javier, quindi la parte dell’autore. Io
sono sicuro - è una mia illazione, ma puoi anche essere sicuro delle
tue illazioni, anche sapendo che restano illazioni… - sono sicuro che
Spregelburd, recitando quel testo e occupandosi anche della regia,
fosse anche un po’ curioso di vedere quello che combinavano gli altri personaggi. La situazione del suo personaggio è quella di chi capita in una certa situazione, non sa bene che cosa stia succedendo ed
è curioso di capire come potrà evolvere. È quasi una posizione autoriale: sembra un po’ un autore di fronte a un gruppo di personaggi
liberi. Nella Modestia ci sono otto personaggi, quattro per ciascuna
delle due situazioni, ma potrebbero anche essere dodici, perché c’è
anche l’essere attore dei personaggi. Infatti nello spettacolo ci sono
diversi momenti in cui questa chiave funziona benissimo. Tanto è
vero che a un certo punto ho pensato che non fosse necessario fare
dei passaggi così scanditi, bruschi, tra le due situazioni, quella «russa» e quella «sudamericana». Nei primi quadri è utile e giusto far
capire che c’è un cambio di scena: si vedono anche mobili e oggetti che si spostano a vista, per indicare il cambio di situazione, perché in una pièce a chiave è necessario avvertire gli spettatori che esiste una chiave. Però, una volta che la chiave è stata enunciata, non è
più necessario seguirla così rigidamente. Così nello spettacolo ci sono alcuni passaggi in cui i personaggi, all’inizio della scena successiva, parlano ancora come quelli della scena precedente. Addirittura in un’occasione, quando si passa alla scena «russa», uno dei personaggi parla ancora in una specie di spagnolo...
E gli attori, che cosa hanno dato a te e ai loro personaggi nel corso
delle prove?
Il ritmo! Io posso dare loro soltanto delle indicazioni molto precise sulla battuta...
Indicazioni sulle motivazioni e sulle intonazioni?
Piuttosto indicazioni di movimento e di rapporto. Soprattutto
di rapporto. Però il ritmo dello spettacolo è assolutamente merito
loro. I quattro protagonisti della Modestia sono bravissimi per due
motivi: in primo luogo fanno bene i loro personaggi, e poi hanno
un affiatamento che un regista non può costruire. Non glielo può
imporre. Ho insistito molto sul fatto che il testo è basato sui rapporti tra i personaggi: ma un personaggio non sa mai chi è l’altro, non
lo deve mai sapere, perché la situazione deve sempre rimanere sospesa. Però più di questo non potevo dare.
Dunque dagli attori sono arrivati il ritmo e il rapporto tra i
personaggi... Il modo in cui sono riusciti ad affiatarsi. Abbiamo provato relativamente poco, ma al debutto di Spoleto sembrava che avessero provato per tre mesi... Invece, per quanto riguarda le intenzioni, ci sono state scene in cui tu
avevi un problema e gli attori ti hanno tirato fuori dai guai?
Direi di no... Insomma, mi pare di capire che hai lavorato quasi più a togliere
agli attori le idee che potevano essersi fatte sul loro personaggio, i loro pregiudizi... Anche perché una qualità dei personaggi di Spregelburd che apprezzo è che nemmeno loro stessi si conoscono così bene. Uno dei
motivi del fascino della Modestia, e in genere di tutte le commedie
di Spregelburd, è che i personaggi hanno degli obiettivi sull’azione,
sanno benissimo quello che devono fare in quel preciso momento,
ma non hanno certezze sulla propria identità. È qui che la commedia diventa davvero interessante... Anche nel lavoro sugli attori... Perché nel lavoro sugli attori si riproduce il senso della commedia... Quello che deve fare ogni attore è soprattutto lasciarsi portare
da questo meccanismo. Se l’attore gestisce troppo il personaggio, se
si pone in maniera eccessiva il problema delle sue motivazioni, e se
deve metterle in relazione alle motivazioni dell’altro personaggio,
il meccanismo s’inceppa. Seguendo questa strada, ne uscirebbe una
specie di commedia psicologica, che però non terrebbe più, perché
in scena perderebbe tutto il suo ritmo. Per questo ho molto spinto
sul versante della mobilità, verso una mobilità totale.
Nei testi di Spregelburd c’è moltissima ironia, molte scene comiche.
Anche nella tua messinscena della Modestia ci sono scene molto divertenti, ma alla fine dallo spettacolo emerge una visione assai più
tragica dell’esistenza, anche rispetto ad altri allestimenti dei testi di
Spregelburd... Però lo spettacolo è molto divertente!
Ma anche profondamente tragico... Alla fine della Modestia, quello che ti resta, non tanto dalle singole battute ma dall’intera commedia, è che nessuno dei personaggi è
più al proprio posto, nessuno si sente più al proprio posto da nessuna parte. E questo non è tragico?
Può essere sia comico sia tragico... Può anche far ridere. Però a pensarci bene, e facendo riferimento anche alle nostre esperienze, non è più così divertente... Succede anche con Il panico, un altro tassello dell’Eptalogia sui sette vizi capitali di Spregelburd, che porterò in scena l’anno prossimo. La
commedia ruota intorno a un morto circondato dai vivi, e come La
modestia fa molto ridere. Però se fai attenzione ti accorgi che tutti i
personaggi «vivi» sono degli spostati: il Terapeuta fa il dogsitter, la
sensitiva Susana si «occupa di una bambina»... Tutti i personaggi
fanno centomila cose insieme e devono di fatto essere dappertutto.
Non riescono mai a essere concentrati su quello che stanno facendo in quel preciso momento, perché stanno già correndo da un’altra parte... L’unico personaggio che si sente al proprio posto è proprio Emilio, il morto intorno a cui ruota il testo: lui ha la serenità
di chi è crepato, mentre gli altri sono in preda al panico causato da
questa continua bilocazione. È una trovata che potresti incontrare
in una pièce di Coward o di Priestley, quasi un gioco da commedia
brillante. Invece in questo caso, siccome il riferimento è il cinema
horror, il testo si colora di un’altra tinta.
Quest’anno Rafael Spregelburd ha vinto per il secondo anno consecutivo il Premio Ubu per la migliore novità straniera, per Lucido.
Ha mandato un messaggio di ringraziamento, nel quale ha sottolineato l’attenzione che ha oggi l’Italia per la sua drammaturgia, che
è nata in un’Argentina profondamente segnata dalla crisi economica, proprio come l’Italia di questi ultimi anni. Questa sensazione di
incertezza, questa necessità di arrabattarsi facendo più parti in commedia, questo sdoppiamento, è certamente un riflesso di questa crisi...
Sotto sotto, però, c’è un altro aspetto, anche se non viene mai
esplicitato. Nel teatro di Spregelburd c’è incertezza su tutto, ma
non c’è alcuna incertezza sui valori fondamentali dell’esistenza: la
lealtà, l’etica... I personaggi sono altrettanti imbroglioni, ma con un
senso etico fortissimo.
Ma come è possibile essere degli imbroglioni con un senso etico
fortissimo? Sono imbroglioni che però sanno che cosa è il bene e che cosa è il
male. In loro non c’è cinismo, e questo è molto piacevole. Anche artisticamente, nell’approccio di Spregelburd al teatro, accade la stessa cosa. La sapienza con cui sono costruite le sue commedie è certamente frutto di una straordinaria furbizia drammaturgica, però al
loro interno c’è anche un elemento di saggezza. In questo senso, si
può dire che Spregelburd, a differenza di tantissimo teatro contemporaneo, non la vuol dare a bere. Che cosa vuol dire che «non la vuol dare a bere»? Che non vuol farla franca, che è sincero nel momento in cui costruisce le sue finzioni. (Milano, 21 dicembre 2011)
Una verità
non immediatamente riconoscibile
Conversazione estiva a proposito del «Panico»
C
ome avevi promesso, la tua esplorazione dei testi di Rafael
Spregelburd continua.
Sì, anche se non ho mai detto che avrei portato in scena
tutta l’Eptalogia di Hieronymus Bosch. In effetti il mio progetto era
di mettere in scena tre testi su sette.
Quindi stai lavorando sul Panico che andrà in scena a Milano… E
qui a Santacristina il progetto di questa estate 2012 comprende un altro testo dell’Eptalogia…
Sì, stiamo lavorando sull’Inappetenza, ma in questo caso la regia
non la faccio io, se ne occupa Giorgio Sangati, che ha già fatto l’assistente nella Compagnia degli uomini di Bond. In ogni caso, io avevo pensato di occuparmi personalmente della regia di La modestia,
Il panico e La paranoia.
Perché la tua scelta è caduta su questi tre testi?
Be’, non potendo fare tutti i sette testi, ho dovuto scegliere. Di-
Nelle immagini: Luca Ronconi e Rafael Spregelburd.
(Santacristina, agosto 2012)
19
focus on
una cosa, e poi si scopre che anche quel divertimento è una vernice.
L’inappetenza, su cui stiamo lavorando a Santacristina, è fondata
proprio su questo meccanismo: Spregelburd lavora sulle possibilità
di gioco con la percezione del pubblico. È un gioco senza sosta a mostrare e nascondere, anticipare e ritardare, come a dire che la percezione dell’immediatezza esiste, ma è ingannevole. In questo senso
è interessantissimo il suo uso della temporalità sulla scena. A teatro
siamo abituati un po’ rozzamente a una diacronia continua, ma già
quando parliamo di una situazione «contemporanea», in qualche
modo diciamo un’altra cosa.
Per questo sono interessanti i meccanismi delle convenzioni che
Spregelburd mette in atto e poi smonta in continuazione, perché costruisce sempre delle cornici che poi distrugge davanti allo spettatore…
In questo ha una straordinaria abilità teatrale. Senza dimenticare la qualità letteraria: non è un romanziere, però nella sua scrittura
non c’è mai nemmeno un briciolo di sciatteria, c’è invece un totale
controllo della letteratura teatrale.
Come nella Modestia, anche nel Panico Spregelburd si diverte a
giocare con i generi, che sono un altro aspetto della convenzione: li
mette in scena, li evoca, e poi li smonta in continuazione.
C’è perfino l’horror, la casa stregata… Però questi riferimenti
non devono prevaricare. Offrono al pubblico un cliché conoscitivo
troppo forte per essere messo in primo piano. Secondo me è meglio
che per chi vede lo spettacolo questi riferimenti restino una interrogazione: «È anche una parodia dell’horror?», «È un riferimento all’horror?», oppure: «Sembra un horror…» Non bisogna andare oltre a questo livello, altrimenti il genere diventa una sovrapposizione troppo esplicita – come rischia di accadere in altri testi,
per esempio nella Paranoia.
E questo non ti garba più di tanto… Un altro aspetto interessante riguarda il modo in cui gli attori devono costruire i personaggi, con una
drammaturgia di questo tipo.
Gli attori devono stare sempre anche da un’altra parte. In questo
mi sembra di essere davvero molto vicino a Spregelburd: non dico
suo fratello, ma certo suo parente. Perché questo essere sempre da
un’altra parte, so benissimo che cos’è, quando faccio qualsiasi spettacolo: quel non sapere mai che cosa stai veramente facendo, se fai
il personaggio o se non lo fai, eccetera eccetera. È una libertà condizionata, ma è pur sempre libertà: e questo è molto importante.
Questo essere da due parti contemporaneamente è forse la condizione costitutiva dell’essere attore…
Be’, questo è un po’ troppo! Purtroppo sulla figura dell’attore ci
sono tante cappe ideologiche, da secoli, e poi cappe generazionali, e
così diventa difficile dare definizioni come questa…
Ma lavorare sui testi di Spregelburd non può essere utile proprio per
smontare queste cappe ideologiche?
Spregelburd lo reciti meglio se non sai bene fino in fondo chi sei.
All’attore deve dunque restare un margine di inconsapevolezza?
Sei sei un attore che regola il suo fare, il suo dire e il suo agire rispetto al pubblico solamente per ottenere un determinato effetto,
con Spregelburd non fai sempre centro. Perché la ricerca dell’effetto è continuamente messa in discussione, già dal testo. Per esempio, spesso si sente dire: «Qui il pubblico non capisce». Ma il testo è costruito apposta perché il pubblico non capisca: perché capirà dopo… C’è la volontà di rimandare la comprensione del pubblico – e quindi, con la comprensione, anche l’accettazione di quello
che vede. Qualche volta questo «dopo» implica un posticipare che
è ancora interno alla commedia, ma a volte può anche essere esterno, come accade per esempio nella Modestia: per capire, ci devi pensare quando sei uscito.
Quindi all’inconsapevolezza dell’attore corrisponde una inconsapevolezza da parte dello spettatore…
Secondo me è molto interessante: nei testi di Spregelburd si avverte che tutto ha la sua ragione, e che tutto ha una sua verità. Ma
di quale verità di tratti, questo non è immediatamente conoscibile.
A un certo punto uno dei protagonisti del Panico dice: «In certe società organizzate intorno al capitalismo estremo ormai non dovremmo parlare dio pazzia, ma di mero adattamento». Siamo in piena
attualità…
Spregelburd è sempre molto attento all’attualità, ma è sempre altrettanto attento a riprendere lo spunto attuale per non lasciarlo a
livello giornalistico, e per farlo diventare un fatto comunicativo teatrale. ◼
le biennali 2012 — teatro — appendice
sponendo di tre sale diverse al Piccolo Teatro di Milano, mi sembravano tre testi giusti per questi tre spazi. Era previsto che La modestia si facesse il via Rovello, al Teatro Grassi, e così è stato. Il panico, che è un’opera dove non è così indispensabile uno spazio ristretto
e piccolo, e che parla anche della morte, lo faremo allo Strehler. Per
quanto riguarda La paranoia, per adesso non se ne parla, ma pensavo di farlo al Teatro Studio. Il mio sogno era di fare i tre spettacoli in contemporanea…
…in una specie di festival Ronconi-Spregelburd…
Ma è un progetto troppo ambizioso, soprattutto con i tempi che
corrono.
Uno dei motivi del tuo interesse per Il panico, dicevi, è che si tratta
di un testo che parla anche della morte...
In realtà parla della vita! Ma dal momento che poi si muore, nel testo c’è anche la morte. Però, tutto sommato, la situazione non è poi
tanto differente da certi spunti di altri testi dell’Eptalogia. Dietro
al fatto che nel Panico convivano vita e morte, non c’è niente di filosofico: la vita e la morte sono solo due territori, esattamente come
nella Modestia Buenos Aires e Villa Opicina sono due territori, oppure come lo sono i due pianeti dove si svolge l’azione della Paranoia, oppure il video e il vissuto, sempre nella Paranoia. Sono tutti testi in cui la bilocazione delle figure è tematica (una bilocazione che
per esempio nell’Inappetenza non c’è).
Come in tutte le cose che scrive Spregelburd, l’incertezza dell’identità è sempre presente. Qui è chiaramente rappresentata nei due
territori simultanei della vita e della morte. È un chiasmo, più che
una bilancia, o una alternanza, tra i due poli, perché vita e morte sono presenti nelle due storie che vengono rappresentate. Una delle
due vicende, quella che ruota intorno a un’eredità, potrebbe ricordare Non ti pago di Eduardo De Filippo: ma già il fatto che si tratti di un’eredità, significa che continua un rapporto tra chi è morto
e chi resta. L’altra vicenda si svolge su un palcoscenico dove si prova un balletto, e poi si scopre che la coreografia è ispirata al Libro dei
morti egizio…
…che è proprio il libro che il personaggio che è morto, Emilio, stava leggendo.
Quindi si tratta di una struttura circolare. Non per niente nel Panico c’è un personaggio come Emilio che è morto e circola tra i vivi, ma fino a un certo punto non sa di essere morto, e poi se ne rende conto… Insomma, non è certo Spirito allegro di Noel Coward!
Uno degli aspetti interessanti della scrittura di Spregelburd, anche
dal tuo punto di vista, è il gioco con le convenzioni teatrali…
La drammaturgia di Spregelburd è estremamente intelligente. Il
suo non è certo un teatro «alternativo»: al contrario, riesce a costruire una forma che è a mio avviso assolutamente aggiornata, in
sintonia con la nostra percezione della contemporaneità, ma utilizzando delle forme eterne.
A proposito di «alternativo», nel Panico Spregelburd si diverte a
prendere in giro la nuova danza…
Ma c’è sempre una grande leggerezza, non c’è niente di aggressivo o di acido. Ha un atteggiamento quasi cechoviano nel rapportarsi alla realtà: il suo è uno sguardo abbastanza clinico, estremamente oggettivo, anche quando affronta l’attualità. Per esempio nella
Paranoia il tema di fondo è un concetto di creatività che ci impone di inventare, inventare e inventare storie, e di conseguenza provoca la bulimia dell’informazione che ci travolge. Sono temi drammaticamente attuali, ma vengono sempre trattati con leggerezza e
competenza…
E, come in Cechov, anche con una certa dose di ironia…
È anche divertente, anche se sempre con intelligenza. La stessa
Modestia – un testo forse meno divertente di altri, che infatti può
irritare qualche spettatore – ti comincia a divertire quando capisci
attraverso quali spiragli puoi accedere al divertimento. Se non accadesse così, se questo passaggio non fosse necessario, sarebbe solo
roba precotta, barzellette già conosciute.
Nel Panico ci sono anche scene che sembrano prese pari pari dalla
farsa, per esempio quando la famiglia dei protagonisti si presenta in
banca per risolvere la pratica dell’eredità…
Sì, però Spregelburd in questo è molto bravo. Perché quella farsa
è una apparenza dietro cui ci sono cose più serie: poi si scopre che
il personaggio della funzionaria di banca – Cecilia Roviro, che fa
molto ridere – è animato da un lutto. Anche Cecilia, come Lourdes, la vedova di Emilio, è una donna in lutto. Insomma, si ride di
focus on
20
«+Extreme-»,
il primo Festival
di Ivan Fedele
I
a cura di Leonardo Mello
van Fedele è il nuovo direttore del settore Musica della Biennale, dopo i quattro anni di Luca Francesconi
(2008-2011) e di Giorgio Battistelli (2004-2007). Gli
chiediamo di raccontarci le linee guida di questa sua prima edizione, a partire dal titolo.
Il titolo «+Extreme-» dà un’indicazione, parla appunto degli «estremi» presenti nella musica d’arte d’oggi. Nei
miei viaggi degli ultimi anni mi sono reso conto che la giovane musica si orienta verso le regioni estreme del linguaggio, quelle che ho chiamato massimalismo o minimalismo:
da una parte ho incontrato compositori il cui pensiero musicale si esprime attraverso un linguaggio estremamente complesso dal punto di vista concettuale, oppure estremamente
d’impatto dal punto di vista sonoro, quindi con una compo-
le biennali 2012 — musica
1.
nente timbrica e fonica decisamente importanti. Dall’altra
mi sono imbattuto in interessanti autori che adottano strategie diverse, il loro pensiero e la loro poetica hanno la necessità di esprimersi tramite un linguaggio musicale ridotto
all’osso, partendo da un nucleo minimo di elementi, come
per esempio due note che piano piano si distanziano l’una
dall’altra creando battimento, e questo battimento da semplice fenomeno acustico diventa storia o racconto. Oppure
un solo accordo, quindi un lessico estremamente ridotto che
in realtà viene letto e osservato da più prospettive ma – come
nel pezzo di Kirill Shirokov – è l’unica struttura linguistica
presente in un brano, e le sue varianti, cioè le variazioni, sono
soltanto di tipo temporale. O ancora il pezzo su un solo bit
dell’americano Tristan Perich, con il quale arriviamo al massimo dell’economia espressiva. Ma se dietro c’è un’idea forte, anche questo atteggiamento ha una sua valenza e un suo
valore. Così come, per fare un altro esempio, sul versante del
massimalismo la corrente della saturation – di cui Raphaël
Cendo e Franck Bedrossian sono i rappresentanti più in vista
– affonda le radici in un pensiero molto profondo in senso
storico, estetico o direi anche etico. Ci si potrebbe chiedere
cosa vi sia in mezzo a questi due «estremi». Be’, sostanzial-
mente nel mezzo stanno altre due tipologie di compositori:
la prima è rappresentata da coloro che hanno una certa propensione al compendio, che cercano sempre delle coniugazioni o delle mediazioni creative degli opposti (e questo è un
fatto interessante, di casi del genere nella storia della musica
ne abbiamo avuti tantissimi). La seconda tipologia comprende chi si fa tentare da una sorta di manierismo di una nuova
koiné, di un nuovo codice, e spesso scivola nell’accademismo
del pezzo che «funziona» e «suona bene». Quel politically
correct che non vuole disturbare nessuno e che pretende allo stesso tempo
di svolgere un
ruolo di punta
dal punto di vista del linguaggio. Vorrei però
fare una precisazione: il fenomeno che ho semplificato in due
formule, massimalismo-minimalismo, non è
solo attuale, ma
è già presente,
in modi diversi, nella musica
del dopoguerra. Per esempio
viene da pensare
che il serialismo
2.
integrale sia una
forma di massimalismo degli
anni cinquanta, così come la
musica di Morton Feldman –
che comunque
aveva frequentato Darmstadt
– può in un certo modo cristallizzarsi in un’idea di «minimalismo» dove la funzione
del tempo non
è più narrativa ma espositiva, e ci porta in
una dimensione
3.
più contemplativa dell’evento.
E poi c’è John Cage, che riunisce in sé i due aspetti: se ascoltiamo i Freeman Études ci troviamo di fronte a una composizione di mirabolante virtuosismo, mentre se analizziamo il
meccanismo compositivo di altri suoi pezzi, dal punto di vista concettuale non c’è quel furore della scrittura che invece si può ritrovare in un rappresentante della nuova complessità quale è Brian Ferneyhough. Gli anni novanta sono stati
un po’ all’insegna del politically correct, cui accennavo prima, invece tra la fine del secolo scorso e quest’ultimo decen1. Ivan Fedele.
2. Raphaël Cendo (champdaction.be).
3. Franck Bedrossian (lalettredumusicien.fr).
4. Morton Feldman (lastfm.it).
5. Brian Ferneyhough.
6. Tristan Perich.
focus on
no nel campo della musica contemporanea…). Questa situazione si rivela anche un grande filtro, che fa capire chi veramente «sta sul pezzo» e chi invece preferisce trovare altre soluzioni. E devo dire che, in generale, ho avuto una buona risposta. Il secondo fattore ha a che fare con l’appeal internazionale della Biennale. La stima e la reputazione si creano
con il tempo, e nei suoi più di settant’anni di vita la Biennale Musica ha, mediamente, lavorato molto bene, acquisendo
sempre maggiore autorevolezza. Io farò di tutto per preservare e magari rafforzare quest’appeal. Mi sforzerò, attraverso
le programmazioni, di far conoscere la vivacità della musica
d’arte di oggi, a tutti i livelli. Quest’anno ho scelto un tema
concettuale, che ha direttamente a che fare con il linguaggio,
ma altri arriveranno in futuro, direi quasi che li ho già tutti in mente. Anzi, i temi che ho già individuato sono in numero eccedente rispetto agli anni che ho a disposizione. Ma,
prendendo spunto proprio dalle difficoltà finanziarie, vorrei
sottolineare un altro aspetto che considero cruciale: io penso che lo strumento-orchestra sinfonica non rappresenti più
il pensiero della musica d’oggi in maniera adeguata. In primo luogo per motivi economici: per essere di buon livello,
i concerti hanno bisogno di un certo numero di prove, e le
prove costano. Per ridurre questi costi si prova sempre meno,
6.
con un conseguente, ovvio abbassamento della qualità. Va
aggiunto che le composizioni contemporanee, anche quando
non sono troppo impegnative dal punto di vista della scrittura, richiedono comunque molta concentrazione, perché non
si tratta di musica di repertorio. E spesso le orchestre, quando
si accingono a eseguire un pezzo contemporaneo, è la prima
volta che lo studiano. In secondo luogo c’è la questione della competenza dello strumentista rispetto a un linguaggio
che è in grande evoluzione, ma che non viene insegnato nelle scuole: ognuno si deve costruire da sé la propria esperienza e le proprie conoscenze. Se un musicista d’ensemble si focalizza su questo tipo di musica, prima di tutto significa che
ha una grande passione per quel repertorio, e quindi che è disposto a studiarlo attentamente e con grande impegno. Ecco
perché secondo me gli ensemble, anche allargati, sono il futuro della nostra musica. C’è poi un terzo fattore: la tecnologia – dall’amplificazione e dalla sonorizzazione all’intervento creativo dell’area elettronica – viene oggi regolarmente utilizzata. E questi sono strumenti che moltiplicano e danno spessore al colore e al timbro, oltre a fornire novità e varietà. Personalmente favorirò questa tendenza, preferendo in
genere ensemble con appendici elettroniche alle orchestre. ◼
le biennali 2012 — musica
nio mi sembra che – seguendo quelli che sono dei riferimenti
importanti di entrambe le tendenze – molti giovani abbiano
fatto e continuino a fare esperienze coerenti con l’uno o l’altro tipo di atteggiamento. Non so se Alexander Khubeev conosca la saturation (probabilmente sì), ma in ogni caso il suo
pezzo potrebbe essere stato scritto da un saturazionista. Non
so quanto approfonditamente il ventenne Shirokov conosca
Morton Feldman, però ne sembra in qualche modo il nipote.
Con questo non voglio togliere nulla alla loro originalità, mi
riferisco esclusivamente alla filiazione intellettuale.
Come sono stati selezionati i
brani, molti dei
quali in prima
italiana?
È stato piuttosto semplice: tutti gli autori che ascolteremo durante il
festival li avevo
conosciuti precedentemente,
durante i miei
viaggi in occasione di concerti e masterclass.
Altri pezzi li ho
sentiti in festival
e rassegne in cui
ero presente co4.
me compositore
oppure semplicemente come
spettatore. Tutto il programma, come anche
la tematica prescelta, proviene
da un’esperienza personale.
Com’ è riuscito a organizzare un festival così articolato in
tempi di crisi
generalizzata?
Ci sono due
fattori molto
importanti: il
primo riguarda
una nuova con5.
sapevolezza degli artisti: in una
situazione di difficoltà, non soltanto economica, ma anche
sociale (si è persa del tutto l’idea di andare a un concerto per
scoprire cose nuove, e c’è un’assenza grave di curiosità), il
musicista ha compreso che deve cercare di esercitare la sua
arte a condizioni diverse da quelle di qualche anno fa (a patto però che restino decorose). Da questo deriva un venirsi incontro reciproco, cercando da parte nostra di offrire un’accoglienza adeguata alla professionalità ma senza eccessi (anche se non credo che in passato vi fossero molti eccessi, alme-
21
le biennali 2012 — musica
focus on
22
Pierre Boulez
Riflessioni come queste definiscono la poetica di Boulez
oggi (da qualche decennio) e implicano un atteggiamento
autocritico nei confronti di alcune partiture giovanili dove
di Paolo Petazzi
«la spinta di rinnovamento in senso radicale era così forte
l Leone d’oro alla carriera a Pierre Boulez fa
che non ci si preoccupava troppo della percezione». Quelonore a chi lo assegna più ancora che al maestro francela spinta di rinnovamento aveva davvero chiarezza e forza
se, un protagonista il cui rilievo storico è da tempo fuod’urto sconvolgenti all’epoca in cui Boulez, ventenne, si afri discussione: le ragioni della scelta si impongono con
facciava sulla scena del mondo musicale imponendosi subito
tale evidenza che un bastian contrario potrebbe trovarla ovcon straordinaria originalità. Nato a Montbrison (Loire) nel
via e tardiva usando gli stessi argomenti che la fanno appari1925, compì studi matematici prima di dedicarsi completare doverosa. Si dedicherebbe ad un esercizio
mente alla musica, fu allievo di Messiaen e
sterile, tanto più che con questo Leone d’ofu tra i primi a prendere da Leibowitz lezioro si ribadisce qualcosa che dovrebbe essere
ni sul metodo dodecafonico, in un momenovvio, ma oggi forse non lo è per tutti. Certo in cui la grandezza di Schönberg, Berg e
Il 6 ottobre
to non è invecchiata la complessità e la straWebern non appariva affatto fuori discusPaolo Baratta e Ivan Fedele
consegneranno
ordinaria ricchezza della lezione di Boulez,
sione come oggi. Fra i grandi della sua genea Pierre Boulez
nella attività del compositore e nel particorazione Boulez si mosse per primo sulla via
il Leone d’oro alla carriera.
larissimo intreccio con quella di teorico e di
che portò nel corso degli anni cinquanta ad
Con l’occasione presentiamo
direttore d’orchestra.
un radicale sconvolgimento del linguaggio
un dettagliato ritratto
Tenterò di ricordare in modo schematico
musicale. Aveva vent’anni quando compodel compositore francese.
qualche aspetto di un lungo cammino, che
se Notations (raccolta di brevi pagine piaha conosciuto percorsi non lineari e periodi
nistiche che in parte sono diventate il pundi riflessione e silenzio, un cammino in cui
to di partenza per grandi Notations orcheBoulez ama sottolineare in primo luogo gli elementi di constrali) dell’anno successivo sono la Sonatine (1946) per flautinuità: «Tutto il mio cammino ha perseguito la libertà moto e pianoforte e la Prima Sonata per pianoforte, del 1948
mentanea in una disciplina generale». E ancora, in una inla Seconda Sonata e allo stesso periodo appartengono i pritervista di molti anni fa: «... amo molto la dialettica tra l’ormi grandi incontri con la poesia di René Char nelle cantate
Le Visage nuptial (che
conoscerà la versione definitiva soltanto nel 1989) e Le Soleil des Eaux (versione
definitiva 1965).
Tra gli antecedenti
di questa originalissima esplosione creativa si possono citare
Messiaen (per le sue
ricerche sul ritmo e
per il suo interesse per
le tradizioni musicali
orientali), lo Stravinsky più inventivo dal
punto di vista ritmico, e soprattutto Debussy e Webern, uniti in una singolare costellazione (impensabile prima di Boulez).
L’amore per Webern
non comportava l’imitazione del grande
viennese: basterebbe
dine e il caos, perché è una dialettica fisica della natura ed è
a dimostrarlo il sensualismo sonoro raffinatamente filtrato
una dialettica della mente. Ci sono momenti in cui la menche emerge dalle cantate su testo di Char. E forti suggestiote ama il disordine, ma essa non può sopportare il disordine
ni schönberghiane sono riconoscibili nella lucida e furiosa
molto a lungo e a partire da un certo momento se ne distacca.
violenza del gesto espressivo della II Sonata. Lasciandosi alViceversa se la mente ama l’ordine, non ama un ordine prele spalle la tecnica dodecafonica classica Boulez non rispetvedibile. In una composizione bisogna navigare tra un mita l’integrità della serie, ma la usa liberamente come fonte di
nimo di ordine e un minimo di disordine, a costo di esplocellule da sottoporre a serrata elaborazione. Di grande comrare i territori estremi per un tempo limitato. Si può avere
plessità inoltre è la sua ricerca sul ritmo, organizzato secondo
il caos, ma fino al momento che la mente se ne disinteressa
una nuova tecnica di costante trasformazione di brevi cellue allora bisogna riportarlo a qualcosa che la mente possa afle. Fin dalle prime opere Boulez mette in discussione le traferrare. Questo problema non me lo ponevo affatto quando
dizionali categorie di tema, melodia, armonia.
ero molto giovane, perché davo e ancora non ricevevo, menLe opere immediatamente successive sono rimaste famose
tre l’attività di interprete mi ha molto insegnato sul circuito dare-ricevere...».
Pierre Boulez (foto di Catherine Panchout/Corbis).
I
In alto: René Char.
Sotto: Stéphane Mallarmé in un ritratto di Edouard Manet.
ge come punto di riferimento nella sua ricerca compositiva:
Mallarmé. A Mallarmé si lega un vasto ciclo che ha un rilievo
centrale nell’opera di Boulez, Pli selon pli (1957-1962, oggetto di revisioni fino al 1989). Convergenze di poetica si riconoscono anche in altre opere del compositore, come la Terza
Sonata (1957); ma il ciclo comincia con le prime due Improvisations sur Mallarmé (1957) alle quali tra il 1959 e il 1962
si aggiunsero la terza, Don e Tombeau a formare l’opera dove
«piega dopo piega» si delinea un «ritratto di Mallarmé».
Nel corso degli anni sessanta e settanta il catalogo di
focus on
ca sotto il segno delle qualità che Boulez dichiarava di amare in Char, la concentrazione, la violenza, la purezza. L’organico strumentale, atipico, ricerca punti di contatto con timbri esotici, con la sonorità dei gamelan giavanesi, piegandosi, senza indulgere al pittoresco, a variegate e austere seduzioni timbriche: vi sono momenti di assorta dolcezza, profili di
nitida lucentezza, dissolvenze, pulviscoli baluginanti e scintillanti, accanto a scatti violenti, di incandescente purezza.
Dopo il congedo da Char con le brevi poesie «surrealiste»
del Marteau, un altro dei poeti prediletti da Boulez emer-
le biennali 2012 — musica
per l’austero rigore e il radicalismo iconoclasta: dopo la geniale tensione inventiva del Livre pour quatuor (1948-1949)
Polyphonie X è divenuta un mito, perché Boulez ne ha ritirato la partitura, dichiarandosi insoddisfatto della realizzazione strumentale. Del primo libro delle Structures per due pianoforti (1951) Boulez disse: «Si trattava per me di una prova, di ciò che si chiama il dubbio cartesiano, rimettere tutto
in discussione, far tabula rasa di ogni eredità e ricominciare da zero per vedere come si può ricostruire la scrittura sulla
base di un fenomeno che ha annullato la invenzione individuale». La sua immagine è stata a lungo fin
troppo caratterizzata, agli occhi di molti,
dal radicalismo del primo libro delle Structures, e Boulez ebbe a sottolineare i limiti
di quella esperienza: «Il primo libro delle
Structures mi ha occupato per due mesi della mia esistenza: non è tutta la mia esistenza. Era quello che io chiamo grado zero della scrittura, dove cercavo la base di un nuovo linguaggio e in un certo modo un anonimato (per questo ho preso come punto di
partenza un materiale non mio, un materiale di Messiaen). Il radicalismo ha qualcosa di seducente proprio perché è riduttivo,
ed è molto facile parlarne. […] La prima delle Structures, quella analizzata da tutti, mi
ha preso soltanto una notte: mi sono messo al lavoro nel pomeriggio e la mattina dopo era finita; perché erano elementi di linguaggio assolutamente ridotti, e la scrittura era quasi come la scrittura automatica dei
surrealisti. Immediatamente dopo il primo
libro delle Structures ho composto il pezzo
del Marteau sans maître per voce e flauto,
che è assolutamente melodico, perché man
mano che procedevo nelle Structures ho riflettuto al problema di come arrivare alla libertà di decisioni momentanee all’interno
di una disciplina costrittiva sulla lunga misura. Tutto il mio percorso (e in ciò credo
sia giustificato) è consistito nel poter dare
la libertà del momento in rapporto ad una
disciplina generale; dunque poter procedere senza essere prevedibile.»
La svolta immediatamente successiva è
dunque il recupero dell’invenzione individuale, o meglio, la definizione di una polarità, di una dialettica tra un’organizzazione di grande rigore e lo spazio concesso a liberi interventi della fantasia del compositore. Nacque allora uno dei capolavori più
noti di Boulez, Le marteau sans maître (finito nel 1954) su tre poesie tratte dall’omonima raccolta di Char. Fu il terzo (e ultimo)
incontro con la poesia di Char, e stimolò
Boulez ad approfondire una originale indagine sul rapporto parola-musica, sull’idea
della poesia come «centro e assenza» del corpo sonoro. Nel
primo dei quattro brani vocali la poesia è cantata senza interruzione (e la parte della voce si intreccia con quella del flauto), nei seguenti mutano i rapporti voce-strumenti, nell’ultimo il testo viene intonato una volta e poi scompare, diventa
«assente» perché la voce non pronuncia più parole e si pone al livello degli strumenti. Le marteau sans maître si collo-
23
le biennali 2012 — musica
focus on
24
Boulez si arricchì di opere di grande rilievo, da Figures-Doubles-Prismes (1963) a Éclat-Multiples (1965-1970) a Rituel in
memoriam Bruno Maderna (1974-1975). Il piacere del suono, l’invenzione timbrica fascinosa, e lo straordinario magistero della scrittura strumentale si affermano sempre all’interno di una grande complessità e di un nitido rigore strutturale. Il compositore si vale anche delle nuove esperienze da lui
compiute intensificando l’attività direttoriale, iniziata nel
1954 al tempo della fondazione del Domaine Musical a Parigi, e proseguita con impegno crescente dal 1958 (data del-
la prima esperienza con una grande orchestra e dell’incarico di direttore dell’Orchestra della Radio di Baden-Baden).
Boulez aveva cominciato a dirigere quasi per necessità, quando ben pochi (Bruno Maderna, Hans Rosbaud, Hermann
Scherchen) sapevano e volevano eseguire la nuova musica;
scoperse così straordinarie doti di interprete, arricchite dalla intelligenza e dalla acuminata penetrazione analitica del
compositore con esiti rivelatori, mentre la esperienza direttoriale a sua volta fu posta al servizio della attività creativa.
Nel 1969 Boulez assunse a Londra la direzione dell’Orche-
stra della bbc, e nel 1971 succedette a Bernstein a capo della
New York Philharmonic. Nel 1966 aveva diretto a Bayreuth
il Parsifal e nel 1976 fu l’interprete del famoso Anello del Nibelungo del centenario, con la regia di Chéreau (ripreso poi
per cinque anni). Nel 1979 rivelò a Parigi la Lulu di Berg per
la prima volta con il terzo atto (completato da Cerha). Questi sono soltanto alcuni momenti fondamentali di una attività direttoriale che è continuata nelle sedi e con le orchestre
più prestigiose, ma la cui fase più intensa ebbe a coincidere con un periodo di riflessione del compositore, e si legò ad
una rimeditazione sul passato, sui maggiori protagonisti del Novecento storico e su autori come Wagner, Mahler,
Berlioz, Schumann, fino a comprendere una parte molto ampia del repertorio. Soprattutto il rapporto con Wagner e Berg segna una svolta, anche per
l’interprete: oggi Boulez ha registrato
di nuovo il suo repertorio, in una prospettiva interpretativa più libera e flessibile, meno «oggettiva» rispetto al rigore degli esordi; ma sempre con straordinaria, rivelatrice acutezza analitica. Sulla propria attività direttoriale ebbe a dichiarare Boulez: «Ho cominciato per necessità, poi l’ho fatto per piacere... Le attività di compositore e direttore richiedono qualità completamente diverse. All’inizio ero molto a disagio, poi ho capito di averne bisogno, per
molti motivi, in primo luogo apprendere, perché non si impara mai una partitura meglio che dirigendola. C’è la stessa differenza che passa fra guardare una
carta geografica e fare un percorso a piedi. Si conosce un’opera fisicamente, e
per me è molto importante. Inoltre ho
potuto compensare le lacune dell’insegnamento che avevo ricevuto. Non c’era
legame tra l’apprendimento teorico della scrittura musicale e la trascrizione reale. Per me era indispensabile ascoltare
analiticamente una partitura e non l’avevo mai veramente fatto. Naturalmente si compensa con l’intuizione; ma c’è
il rischio che una parte dell’utopia che
è in un’idea non giunga a realizzazione. Dalla direzione ho imparato molto
su come far passare l’utopia nella realizzazione, e ho smesso di dirigere regolarmente quando ho capito che non avevo
più da imparare».
Una nuova fase di riflessione iniziò
con la nomina (nel 1975) a direttore
dell’ircam (Institut de Recherche et
de Coordination Acoustique/Musique) a Parigi. Circa sei anni di silenzio
furono necessari a dominare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie: a Donaueschingen il 18 ottobre 1981 Boulez
presentò circa metà di Répons, e nel 1984 la partitura raggiunse la durata e la calibratissima forma attuale (poco più
di quaranta minuti, ma non è esclusa una prosecuzione). L’esecuzione, oltre all’elettronica dal vivo, ha impegnato molte
Sopra, a sinistra: Olivier Messiaen;
a destra: Alban Berg e Arnold Schönberg.
Sotto: l’ircam a Parigi.
Pierre Boulez (sfcmp.org).
focus on
te violinistica della versione originaria di ...explosante-fixe...
è stato il punto di partenza, radicalmente rielaborato, per un
breve pezzo violinistico del 1991, Anthèmes. Questo pezzo
è stato ripensato e dilatato con i mezzi del live-electronics in
Anthèmes 2 (1997).
Un ritorno, dopo molti decenni, al pianoforte solo è segnato da Incises, composto nel 1994 usando alcuni materiali destinati a un lavoro per pianoforte e ensemble iniziato nel
1989. Il progetto prese una forma completamente diversa:
Boulez aveva in mente qualcosa per cui gli era indispensabile avere più di un pianoforte (ad esempio un gioco d’echi
richiede uno strumento che abbia la velocità e il colore del
pianoforte, e in una intervista il compositore ha ricordato i
quattro pianoforti delle Noces di Stravinsky). Così è nato Sur
Incises (1996/98), che va molto oltre il punto di partenza senza mai citarlo alla lettera. Appartiene al pensiero di Boulez
l’arte del «dedurre», dove la deduzione non ha nulla di scolastico, perché comporta l’invenzione e la scoperta di svolgimenti imprevedibili. Sur Incises è composto per tre pianoforti, tre arpe, tre percussionisti: analizzando, per così dire, il
suono pianistico di Incises, un triplo trio ne dilata nello spazio diversi aspetti attraverso le caratteristiche delle corde velocemente percosse del pianoforte, delle corde pizzicate delle arpe, dei metalli e dei legni percossi. Caratterizzano il pezzo gli indugi su ricchi arabeschi, su una fastosa ornamentazione, o su arcani giochi di risonanze, oppure gli scatti virtuosistici: un aspetto è anche una vera e propria gara tra i tre
pianisti. Si crea un colore molto particolare con il continuo
intreccio dei pianoforti e delle arpe e con i barbagli luminosi della percussione.
La più recente partitura portata a termine da Pierre Boulez è la versione completa di Dérive 2 (1988-2006) per undici strumenti. Il pezzo fu iniziato nel 1988, quattro anni dopo il bellissimo Dérive 1, che non ha nulla in comune, salvo il fatto di «derivare» da un materiale in un certo senso occasionale. Dérive 2
aveva raggiunto una durata di circa venticinque minuti nel 2002 (ed era stato
allora registrato dallo stesso Boulez); ma poi è cresciuto ancora di circa venti minuti. Non è il solo lavoro di Boulez ad aver conosciuto una genesi complessa e stratificata, ma
nel caso di Dérive 2 la natura stessa della concezione rende possibile la graduale crescita. Partendo
da materiali «anonimi»
(esempi musicali dei suoi
corsi) e sottoponendoli a
una complessa elaborazione, Boulez studia le possibilità di processi periodici, di combinazioni e «variazioni» dei materiali di
partenza (le cui potenzialità sono esplorate in modo
magistrale), di ritorni circolari di natura non semplicemente ripetitiva, anzi
accortamente dissimulata, con esiti di straordinaria ricchezza fantastica e di
grande freschezza. ◼
le biennali 2012 — musica
volte l’Ensemble InterContemporain, lo straordinario complesso creato e all’inizio diretto da Boulez con solisti selezionatissimi per garantire alla musica contemporanea i massimi
livelli interpretativi.
Delle nuove tecnologie Boulez si serve come mezzo per trasformare il suono prodotto da strumenti dal vivo e per aprire nuove prospettive nell’uso dello spazio, mantenendo però
una continuità senza fratture nella sua ricerca, nelle linee essenziali del suo pensiero. In Répons un gruppo di ventiquattro strumenti (otto archi, otto legni e otto ottoni) sta al centro della sala con il direttore; il pubblico si colloca tra l’orchestra centrale e i sei solisti che lo circondano e suonano
due pianoforti, arpa, vibrafono, cimbalom, xilofono e glockenspiel, strumenti tutti che una volta prodotto il suono
non possono tenerlo o modificarlo, come possono fare invece gli archi e i fiati. Si ripropone così in Répons una contrapposizione tra modi fondamentalmente diversi di produrre il
suono che aveva già un rilievo essenziale ad esempio nel Boulez di Éclat-Multiples. Répons significa «responsori», un termine preso dal canto liturgico medievale solo per evocare vagamente l’idea di dialoghi tra solista e coro. I sei solisti sono collegati agli altoparlanti e alle macchine per l’elettronica dal vivo, che producono un caleidoscopico gioco di rifrazioni, frantumazioni, rispecchiamenti, prolungamenti e movimenti nello spazio, attraverso ritardi, moltiplicazioni del
suono, traiettorie da un altoparlante all’altro.
La tecnologia dell’ircam ha consentito di usare come dimensione compositiva la distribuzione del suono nello spazio anche nel Dialogue de l’ombre double (1982-1985), per
clarinetto dal vivo e clarinetto «double» registrato, dove
si alternano un musicista presente e uno «assente», il suo
«doppio».
Le successive esperienze di ricerca all’ircam sono confluite nella realizzazione del progetto di...explosante-fixe..., nato da un’idea del 1972 elaborata in diverse fasi, soprattutto tra il 1991 e il 1993, in
una versione provvisoria
che comprende le tre sezioni più ampie, fra le sette progettate, e due interludi. Vi sono tre flauti solisti (dei quali uno è collegato con un sistema informatico dell’ircam), intorno
ai quali un gruppo di ventidue strumenti e l’elettronica creano una complessa varietà di piani sonori, di mutevoli sfondi, intrecci, dilatazioni. Boulez
parla di una forma «a mosaico», perché nasce dalla
elaborazione di cellule indipendenti, che si ripresentano trasformate, ma riconoscibili, in frammentata successione, come i tasselli di un mosaico. Il pezzo rivela una straordinaria
forza di seduzione, degna
della suggestione visionaria del titolo (preso da una
definizione della bellezza
di Breton).
Un materiale di una par-
25
focus on
26
John Cage
lebri studiosi bouleziani, nella prefazione e postfazione dello
stesso volume, esprimano opinioni abbastanza diverse: Piandi Mario Messinis
cikowski privilegia Boulez e Nattiez Cage. Questa contraddizione, editorialmente stravagante, rispecchia divergenti criteohn Cage seguì le lezioni di Arnold Schönberg
ri interpretativi. In un primo tempo Cage è stato influenzato
tra il 1935 e il 1937; era poco più che ventenne e partedal più giovane Boulez, dopo la conoscenza della Seconda Socipò a quell’insegnamento solo come uditonata per pianoforte del ‘48. La svolta verso l’atemare. Dal compositore viennese apprese il rigotismo (in precedenza solo fuggevolmente adottare del pensiero, anche se seguì subito altri perto) e l’astrattismo, a mio parere, si deve alla suggeCon cinque brani
corsi sperimentali fin dalla fine degli anni trenta.
stione di Boulez, nel biennio decisivo 1950-1951.
in programma,
La percussione divenne il suo laboratorio compoCon il Concerto per pianoforte preparato e orcheJohn Cage
è certamente
sitivo con un arsenale strumentale imponente, anstra (imperturbabile, infinito), la Music of Chanuno dei protagonisti
che con oggetti della quotidianità (l’influenza da
ges per pianoforte, le Pastorali per pianoforte predella Biennale.
lui riconosciuta di Duchamp). Assimila le tecniche
parato, Cage abbandona definitivamente i lacerti
Il contributo
che inglobano il rumore di Cowell e di Varèse: Ioesotici. Le scelte radicali dimostrano la tangenziadi Mario Messinis
nisation è del 1931 e First Construction (in metal)
le vicinanza alla scuola di Darmstadt e al postwene delinea
di Cage, per cinque percussionisti e pianoforte, del con la consueta precisione bernismo anche se Cage non ha mai adottato la se1939. Nella decina di composizioni per percussiorialità integrale. In Music of Changes coniuga le geil percorso artistico.
ne, circoscritte al quadriennio 1939-1943, si allonometrie analitiche della scrittura con l’apertura al
tana spesso dalla corporeità materica del modello nella ardicaso. È indicativo però che i principi strutturali prevalgano
ta esplorazione di una timbrica sommessa che sfiora il silensugli aspetti aleatori. Molto originale è il rapporto tra suono
zio. In questi momenti umbratili e preinformali Cage supera
e silenzio in un’inedita impaginazione spaziale. Cage dilata i
J
le biennali 2012 — musica
1.
certa ingenua ossessività ritmico-melodica che altrove affiora. Contestualmente inventa il cosiddetto «pianoforte preparato»: l’inserzione tra le corde di bulloni, viti, gomme, ecc.
– con una complessa intavolatura dei materiali – nasce come
mimesi e sostituzione della percussione. La distorsione delle
altezze prefigura l’indeterminazione. Gli interventi aleatori
nel processo compositivo Cage li aveva esperiti sin dalla giovinezza: le radio ci sono già nel coreografico Credo in Us (1941);
la perdita del controllo della notazione, l’uso casuale dei giradischi accanto alle percussioni e al pianoforte con sordina figurano fin dal primo Imaginary Landscape (1939). Vorrebbe
far costruire una macchina per fabbricare microcosmi intervallari, ma rifiuta l’avventura con le «macchine controllore»:
«sono troppo stupide» amava ripetere. Dunque negli anni
quaranta Cage si interessa, con analoghi metodi compositivi,
alla elettroacustica, alle percussioni e al pianoforte preparato,
alla ricerca del suono incognito.
Si affaccia l’interesse per l’Oriente – la filosofia indiana, la
saggezza cinese, il Buddhismo Zen – come perdita della soggettività: è un interesse che riguarda per lo più il pensiero, ma
non il linguaggio (anche quando ricorre ad uno strumento
giapponese, lo Sho, è sollecitato dalle peculiarità del timbro
e non dall’orientalismo). C’è qualche allusione all’esotismo
decorativo solo nella prima stagione compositiva, come nei
celebrati e suggestivi Sonate e Interludi del ‘48. Sono tracce labili, destinate a sparire all’inizio degli anni cinquanta quando inizia il dialogo con Boulez, testimoniato da un eccezionale carteggio, risalente al quinquennio 1949-1954, recentemente pubblicato in italiano da Archinto, un’importante testimonianza teorica e tecnica. È indicativo che due ce-
2.
3.
bagliori di Webern: i silenzi sono musicali al pari del suono:
il suono del silenzio. D’altronde non è un caso che solo qualche mese dopo la composizione di questo brano, Cage inventi
il suo lavoro più provocatorio e «silenzioso», 4’ e 33”: il pianista non suona per quattro minuti e mezzo e lascia percepire al
pubblico soltanto le voci ambientali. In Imaginary Landscape
n. 4 ricorre a 24 esecutori per 12 radio. È curioso del paesaggio
sonoro (dichiara che «avrebbe voluto amplificare gli alberi e
gli arbusti»), con l’osservazione delle voci della natura, nella
convinzione sperimentale che tutto è musica, secondo il principio dadaista che tutto può essere estetico.
Prevede, prima di Schaeffer, la musica concreta; è il profeta della musica elettronica prima di Stockhausen con Imaginary Landscape n.5 per nastro magnetico. In questo periodo
le scelte di Cage si muovono in più direzioni tra indeterminazione e determinazione. L’interesse per il caso – il caso è «l’ignoto» – è sollecitato dal ricorso al libro cinese degli oracoli,
con il lancio di monete che impone il flusso compositivo: un
modo per sfuggire alla predeterminazione e all’automatismo
dell’edificio costruttivo. È una critica al determinismo della
scuola di Darmstadt. Il dialogo con Boulez comincia ad affievolirsi quanto maggiore diventa l’interesse per il caso. Qui il
rapporto tra i due compositori si rovescia. Cage non subisce
più le certezze di Boulez, ma tende ad incrinarle. D’altronde
intorno alla metà degli anni cinquanta si estende l’influenza del musicista sugli ambienti di Darmstadt. La seconda ma1. Mario Messinis e John Cage; 2. Anton Webern;
3. Merce Cunningham in un ritratto di Annie Leibovitz (1997);
4. Morton Feldman; 5. Franco Donatoni.
4.
5.
ge della fine degli anni cinquanta, intercalata all’esecuzione
di alcuni frammenti del Concerto per pianoforte e orchestra
(all’origine il pianista era David Tudor). Ironia, umorismo,
piacere del gioco: affiora la disinvoltura di un maestro che si
occultava nel gesto teatrale.
Nel ‘58 Cage per la prima volta è invitato a Darmstadt (precedentemente però si era affacciato come pianista e compositore al festival di Donaueschingen). Fu una rivoluzione, e
la sua influenza mise in crisi per oltre un decennio la musica
nuova, soprattutto in Germania e in Italia. L’opera che sconvolse il cenacolo internazionale dell’avanguardia è il Concerto per pianoforte e orchestra del ‘58, uno degli esempi estremi di apertura al caso e di coinvolgimento creativo dell’interprete (63 pagine con 84 tipi di notazione); qualche anno dopo il lunare John Tilbury suonava per la Biennale all’ingresso della Fenice, mentre l’orchestra era impegnata in ordine
sparso nel foyer del teatro. L’ascolto del Concerto determinò tempestivamente l’intervento saggistico, Cage o della liberazione, di Heinz Klaus Metzger – il luciferino allievo di
Adorno – che aveva già demolito la serialità «generalizzata»
di Boulez. Lo stesso Berio fu interessato a quel saggio «storico» e lo fece tradurre nel 1959 per la sua rivista, gli Incontri Musicali. Metzger soggiogò gli avamposti della nuova musica anche sul piano teorico, come conferma il teologo, compositore e filosofo del caso, l’adorniano Dieter Schnebel. Ma
fu un saggio arbitrario perché vedeva Cage attraverso la «negazione determinata». È un’interpretazione che successivamente è stata accolta dallo stesso Adorno e che è proliferata in
Italia. Franco Evangelisti, Mario Bortolotto, Aldo Clementi e Franco Donatoni agivano nei circuiti del pensiero nega-
(per gentile concessione di «classic voice» n. 160, settembre 2012) .
focus on
tivo secondo la «cadaverica» retorica della fine della musica
(Donatoni giunse a una temporanea afasia e alla rinuncia del
comporre). In realtà Cage era un genio atarassico, totalmente estraneo al dibattito speculativo europeo; non credeva alla fine del linguaggio, ma all’allargamento interdisciplinare
dell’esperienza creativa. L’adozione di scritture aleatorie divenne ecumenica (si pensi alle pittografie liberty di Bussotti). Il compositore europeo che comprese, senza sovrastrutture ideologiche, la lezione di Cage, anche per quanto riguarda
la vocazione teatrale, fu Mauricio Kagel; Bruno Maderna lo
ebbe presente soprattutto nell’apertura all’indeterminazione delle ultime opere.
Dopo molte ricerche grafiche, nell’ultimo quindicennio
Cage si riconvertì ai piaceri della notazione. I fluviali Freeman Etudes si appagano di un arido virtuosismo utopico nelle spettacolari acrobazie violinistiche. Negli spezzoni melodrammatici di Europeras, commissionate su suggerimento di
Bertini e di Metzger, Cage intese conciliare la multimedialità con le esigenze di un teatro di tradizione, l’Opera di Francoforte. Come è noto, alcuni artisti furono vicini negli Stati Uniti a Cage, da Cunningham a Rauschenberg, ad allievi e sodali: Morton Feldman, Earle Brown, Christian Wolff.
Marginale invece fu il rapporto con i minimalisti: l’orientalismo divulgativo di Terry Riley devastò l’ascetismo rituale di
Cage; Steve Reich ne accolse alcuni processi iterativi e l’energia ritmica delle opere giovanili. Fondamentale fu il dialogo
con Merce Cunningham. Entrambi hanno teorizzato l’indipendenza tra creazione coreografica e creazione musicale, ma
l’autonomia della sperimentazione coincide con una perfetta armonia del pensiero.
Mi sia consentito un ricordo personale. Cunningham amava molto Venezia e per questo gli proposi di dedicare una prima assoluta alla Fenice (ma il teatro bruciò un anno dopo e
il balletto Interscape si svolse nel 2000 al Palafenice). Cunningham sembrò accettare, con la mitezza che condivideva
con Cage, di coreografare un’opera di Feldman, ma poi pensò a 108, per altrettanti strumentisti, dell’amico scomparso
da un decennio, iperbole del silenzio come filosofia della quiete. Autore della scenografia fu il prediletto Rauschenberg. Le
operazioni casuali non implicavano la rinuncia alla scrittura. Negli ultimi lavori Cage prosciuga l’anarchia degli happening per vivere l’attrazione del vuoto. Non escludo sia stato
suggestionato dalla sublime immobilizzazione del tempo di
Feldman. 103, l’estrema monumentale composizione di largo organico presentata alla Biennale Musica nel 1993, un anno dopo la morte dell’autore, era associata a One, un film senza soggetto, fondamentalmente ideato, nelle linee guida, dal
musicista. Dice Cage: «C’è luce ma non ci sono persone, né
cose, né idee sulla ripetizione e sulla variazione. Si tratta di
un’attività senza senso che tuttavia è comunicativa, come la
luce stessa, che sfugge alla nostra comunicazione perché non
ha nessun contenuto. Come ha affermato McLuhan, la luce è
informazione pura senza alcun contenuto che limiti il suo potere trasformante e informativo». In questi tardi lavori si definisce il «terzo stile» dell’autore, tra appello metafisico e respiro cosmico. Trapelano assonanze con Scelsi e persino con
l’ultimo Nono. Evidentemente certe idee circolavano e la scoperta e l’invenzione di Cage si irradiavano nelle trame della
nuova musica.
Cage è stato compreso, quando era attivo, più dai compositori che dai critici. Fedele D’Amico parlò di «ebetudine» (come di «Urpernacchie» a proposito di Boulez). Ma ciò fa parte di un’aneddotica definitivamente sommersa. In realtà Cage è stato il pensatore che più
ha determinato la palingenesi di tante avanguardie. ◼
le biennali 2012 — musica
niera di Stockhausen sarebbe inconcepibile senza Cage, fino
a Momente e all’estremismo aleatorio di Aus den sieben Tagen.
Lo stesso Boulez della Terza Sonata per pianoforte risponde,
senza dichiararlo, al collega statunitense, anche se di fatto la
cosiddetta «alea controllata» è una normalizzazione delle
operazioni casuali, un modo per aprire la porta alla flessibilità, senza rinnegare le norme del sistema. Nel ‘52 Cage crea,
al Black Mountain College, il primo happening, la prima assoluta esperienza performativa. Era un insieme di musica, poesia, pittura e danza con al centro il coreografo Merce Cunningham, il pittore Robert Rauschenberg, il pianista David
Tudor e naturalmente lo stesso Cage. Era la premessa a esperienze multimediali cariche di futuro, che attraverseranno
per un quarantennio l’ansia sperimentale del musicista. Mi
accadde di assistere allo «scandaloso» e sorprendente progetto promosso da Tito Gotti per le Feste musicali di Bologna, Alla ricerca del tempo perduto: un treno viaggiante tra varie stazioni ferroviarie con musicassette, televisori, strumenti
ed esposizioni d’arte: Cage era gioiosamente impegnato nelle sue irriverenti esplorazioni ludiche. Recentemente Veniero
Rizzardi e Giovanni Mancuso hanno ricostruito, al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, una Lettura di Ca-
27
focus on
28
L’importanza
del pubblico
come interlocutore
ry Riley, forse c’è un’affinità, almeno nei termini della macrodistinzione tra massimalisti e minimalisti su cui il direttore artistico Ivan Fedele ha ragionato per questa edizione,
ma come la maggior parte dei compositori, Haber fa fatica a
collocarsi in una delle due categorie: «Io vengo da entrambi i mondi, perché a Milano ho studiato con Adriano Guarnieri che scrive una musica che sembra totalmente massimalista, molto piena, forte, ricca di note, quasi caotica, ma che
poi, dopo un po’ che la si ascolta, rivela improvvisamente un
luogo piatto, statico in cui ci si rende conto che gli strumenti fanno sempre la stessa cosa. Accade dopo venti, trenta mia cura di Federico Capitoni
nuti; è un paradosso bellissimo. D’altra parte poi ho studiato anche con i Bang on a Can, musicisti della scuola derivaarlando con i giovani compositori d’oggi si
ta direttamente da a Philip Glass e Steve Reich. Quindi direi
viene spesso investiti dalla strana sensazione d’una
che mescolare Guarnieri con l’ensemble americano potrebesibizione – un po’ sospetta – di educazione, cortebe essere un risultato nuovo, di sintesi, che comunque imposia e rispetto. Ciò farebbe sembrare finiti i tempi del
ne una mia voce». Haber ha scritto la composizione, che vermusicista ribelle, anticonformista a tutti
rà eseguita in prima italiana a Venezia, nel
i costi, che fa finta di rinnegare la tradi2008 a Roma, l’anno successivo alla vittozione e si lamenta del presente. Forse, più
ria del prestigioso Prix de Rome: «MenVenezia
semplicemente e probabilmente, lo spiritre ero borsista all’Accademia americana,
Teatro Piccolo Arsenale
to di contraddizione è messo soltanto tra
ho conosciuto l’architetto Peter Zumthor
9 ottobre, ore 18.00
parentesi, nell’esercizio di una prudente
che era molto interessato alla musica conBetween Composure and Seduction
epoché in attesa di momenti migliori (motemporanea. Mi erano rimaste impresdi Yotam Haber
menti che di solito coincidono col successe alcune parole del suo libro Atmospheper violino, contrabbasso e percussioni
so, raggiunto il quale un artista è convinto
res, nome che viene tra l’altro da un tito(2009, 12’) prima esecuzione italiana
di potersi permettere qualsiasi gesto o aflo di un pezzo di Ligeti, con cui tentava di
fermazione). Fatto sta che conversare con
descrivere un posto effimero ove lui creaYotam Haber, classe 1977 quindi «giovane» in tutti i Paeva la sua architettura; “between composure and seduction”.
si del mondo (figuriamoci da noi), concilia anche il più scetHo provato nel mio pezzo a trovare lo stesso posto, e a Zumtico e rassegnato con la speranza di un futuro rigoglioso e sothor stesso ho fatto scegliere l’organico degli strumenti per
Una conversazione
con Yotam Haber,
direttore artistico del mata
le biennali 2012 — musica
P
prattutto realistico per la composizione musicale. Nato in
Olanda, ora newyorkese dopo l’infanzia passata in Israele
e in Nigeria, Haber ha carriera e ambizioni di uno normale – bravo, studioso, sì, ma con i piedi per terra, e all’attività di compositore affianca quella di organizzatore musicale
e di direttore artistico. Ascolteremo una sua composizione,
Between Composure and Seduction, alla Biennale di Venezia
nel concerto del 9 ottobre intitolato New Russia/Old America, anche se, dice l’autore, «non ho capito perché mi abbiano
messo lì, dato che non sono né un giovane russo né un vecchio americano». Il suo pezzo è tra i lavori di tre giovani russi e il capolavoro del minimalismo americano, In C di Ter-
questo pezzo. Alla fine è un brano per tre soli musicisti: violinista, contrabbassista e percussionista. Quelli che ascoltano questo pezzo registrato talvolta non mi credono quando
dico che ci sono solo tre strumenti; questa è la cosa di cui sono più fiero: senza amplificazione questo pezzo produce un
suono enorme, volevo provare a creare un suono monolitico ma non un timbro semplice, e per me questa è la cosa essenziale dell’architettura di Zumthor che volevo esprimere:
A sinistra: Kronos Quartet
(foto di Zoran Orlic / kronosquartet.org).
A destra: Steve Reich.
uno dei più importanti festival internazionali di musica contemporanea, il mata, che si svolge a New York da quindici
anni e che ospita anche un concorso: «il mata è stato fondato nel 1996 da Philip Glass che ancora vive nell’East Village, accanto al cinema The Anthology in cui ha fatto il primo concerto dal titolo Music at the Anthology che gli dato il
nome. Per tredici anni la sede è stata a Manhattan, ora è Brooklyn dove c’è la maggior parte di compositori e ascoltatori, è il nuovo «west village» in cui si riuniscono oggi artisti
e poeti. «La nostra missione è di promuovere, commissionare e suonare la musica dei compositori giovani (meno di quarant’anni) di tutto il mondo. Quest’anno abbiamo ricevuto seicentocinquanta composizioni inedite da ogni parte del
pianeta, il che spiega che ci sono tantissimi compositori che
vogliono lavorare. Io da direttore artistico scelgo una giuria
di quattro compositori importanti americani. Poi seleziono
l’ensemble o l’orchestra che deve suonare il pezzo. Il festival è
primaverile, ma quasi ogni mese facciamo un concerto nella
serie “Interval” che è un’occasione anche per curatori esterni i quali possono proporre un’idea per un concerto. Ogni
anno premiamo qualcuno e stavolta tocca al Kronos Quartet. Verranno premiati da Glass e Reich, due luminari della
musica americana contemporanea che hanno sempre litigato: è bello vederli insieme ora che a settantacinque anni hanno messo da parte le inimicizie. Infine come mata non solo presentiamo pezzi, ma a tre o quattro compositori – quelli
che riteniamo i migliori tra chi si presenta – ogni anno commissioniamo un pezzo nuovo. Io ho avuto una commissione
Sopra: Philip Glass.
A destra: Yotam Haber.
da mata, è stato importantissimo, per i musicisti americani
ha un peso rilevante».
Haber crede molto nella musica contemporanea, e ne rivendica lo statuto di professione: «Io sono ottimista, trovo
che le opportunità per i compositori non manchino. E non
esiste solo New York, ma tante città che fino a dieci anni fa
non offrivano chance. Il Texas per esempio oggi è un importante centro di musica moderna. Noi, come mata, siamo
fieri di pagare gli autori e i musicisti, mentre è pieno di artisti che lavorano gratis. Trovo che ci sia una tradizione di direttori e orchestre che chiedono di scrivere musica solo per
l’onore di ricevere un’esecuzione e noi siamo completamente contrari a questo mercato falso». Da questo punto di vista, cioè la pretesa del rispetto
della musica, di chi la fa e di chi l’ascolta, Yotam Haber è intransigente: «Trovo che finalmente ci si muova verso la creazione di musica che abbia un’attrazione per il pubblico. Negli anni settanta Babbit scrisse un famoso articolo dal titolo Non mi interessa se ascolti, il
messaggio era chiaro. Abbiamo avuto compositori che hanno creato dei muri: i seguaci del
serialismo puro hanno contribuito a fondare
un’accademia in grado di ignorare chiunque
non seguisse quelle regole. Per fortuna oggi le cose sono cambiate, il compito è quello
di coinvolgere il pubblico. È importante che
i compositori tocchino gli spettatori. E i nuovi autori vogliono andare incontro alla gente:
la musica è narrazione, non più un gioco intellettuale». E allora Yotam Haber che tipo
di compositore ritiene di essere? «Ce ne sono due tipi: quelli definibili ricercatori e quelli che sono veri e propri musicisti. Sono entrambi importanti per l’evoluzione della musica contemporanea. Ma è un equilibrio molto delicato, perché alcuni di loro sono radicali. Ci sono posti in Europa e in America dove le accademie di ricerca si dedicano a trovare nuovi timbri, nuovi suoni, un nuovo vocabolario, ma niente di ciò che fanno è musica. In altri luoghi
ci sono posti in cui i compositori non si interessano di chi li
ha preceduti e creano musica in base a ciò che sentono di dover dire, senza che importi loro di ciò che è successo prima.
Queste due estremità sono l’apice dell’Ego, poiché in tutti e
due i casi il compositore pensa solo a sé, creando solo per sé,
stando fuori dalla storia, senza pensare al pubblico, ai musicisti che devono suonare. L’avanguardia mi
sembra proprio abbia pensato a una musica scritta per
nessun altro che per se stessa; invece io scrivo per me
ma anche per chi deve suonare: se il musicista non capisce ciò che ho scritto non
c’è possibilità che il pubblico possa capire me. Lo so che
nei posti accademici estremi
l’idea di creare qualcosa per
un pubblico è quasi un’idea
eretica, ma io non sono d’accordo. Anche io cerco un vocabolario nuovo ma la mia responsabilità di compositore è che chi suona,
come chi ascolta,
mi capisca». ◼
focus on
compostezza e seduzione». Coerentemente dunque, Haber
cerca di coniugare minimalismo e massimalismo in un risultato in cui entrambi gli indirizzi possano essere rintracciabili pur non essendo definibile né in un modo né nell’altro.
Del resto i sincretismi di cui la musica si nutre da tempo dovrebbero ormai aver superato la fase illusoria della contaminazione e quella seducente del crossover, giungendo a quella sintetica della novità. Più probabile è il raggiungimento
del risultato se al solipsismo creativo si preferisce un’apertura alla musica degli altri (cosa che i compositori non sempre
fanno). Haber non può fare a meno di ascoltare la musica dei
giovani colleghi perché è attualmente direttore artistico di
29
opera
30
«L’occasione
fa il ladro» di Rossini
secondo Betta Brusa
V
a cura di Arianna Silvestrini
posto da Chiarot. L’allestimento del foyer e dell’ingresso in
sala è fatto con carte assorbenti, tutte le scene e i costumi saranno realizzati con la carta. La storia così esce dal libro della partitura: giunti gli spettatori in sala le figure prenderanno vita, i cantanti stessi si libereranno dalla pagina per entrare in scena, mentre sul palco, sullo sfondo, ci sarà la proiezione di una lettera di Rossini indirizzata alla madre. Una delle componenti di questo progetto è infatti anche il rapporto del figlio con la madre e l’insicurezza del primo Rossini.
Ho cercato di insegnare ai ragazzi a non limitarsi alla costruzione dell’allestimento, ma di progettare una proposta
più elevata, che coinvolga molti aspetti e in cui nulla è casuale. Trovo che nella nostra epoca ci sia un grande bisogno di
fare rete, e forse questa può essere proprio la cifra di questo
periodo storico così ricco di stimoli. La lirica può tornare a
essere un punto di riferimento per le proposte culturali, perché la lirica da sempre è una costruzione e un lavoro che esige di sviluppare una rete.
enerdì 12 ottobre al Teatro Malibran
andrà in scena L’occasione fa il ladro di Gioacchino Rossini, opera scritta per Venezia, di cui si celebra quest’anno il bicentenario. Abbiamo incontrato Betta Brusa, che firma la regia della nuova messinscena.
Quali sono le novità dell’allestimento e qual è la poetica
dell’opera?
Non si tratta di una semplice messinscena, ma di un progetto più ampio che cerca di mettere insieme molte componenti e che risponde a una proposta molto intelligente del sovrintendente Chiarot. Nel 2012 assistiamo a grandi cambiamenti in tutti i settori,
compreso quello della lirica. Occorre quindi porsi delle domande. Mi sono chiesta quali siano le
ragioni per cui autori dell’Ottocento come Rossini resistano ai grandi cambiamenti e quali siano i motivi per cui le loro opere ancora ci commuovono. La proposta di Chiarot mira all’invenzione e alla costruzione del futuro del teatro grazie al patrimonio operistico, a partire dalla constatazione che la lirica è il frutto dell’insegnamento tra maestro e allievo. Questo progetto si
compone di diversi elementi, prima di tutto della collaborazione degli studenti dell’Accademia
di Belle Arti, in particolare di venti studenti molto motivati e attenti; la mia assistente alla regia
per quest’opera è una studentessa di Ca’ Foscari.
Il secondo elemento del progetto è il materiale
stesso dell’opera di Rossini. Le sue farse sono veri
gioielli teatrali, voli dello spirito di grande raffinatezza e ariIn questo senso l’opera può avvalersi delle nuove
stocraticità che non sfociano mai nella comicità e che miratecnologie?
no al sorriso più che al riso.
Non ne faremo più a meno, ma la vera rivoluL’allestimento sarà articolato in un percorso che comincia
zione sta nel nostro modo di pensare, non negli
già all’esterno del teatro, proprio perché ogni luogo ha
oggetti e nella tecnologia in sé, altrimenti sareuna sua ragion d’essere. Nella piazzetta di ingresso
mo solo un’epoca di passaggio. La grande tragedel Malibran il pubblico verrà accoldia del nostro tempo consiste nel
to da una scritta luminosa di Giovanfatto che non si scrivono più opere
ni Querini: «I libri sono un furto fatcontemporanee; invece è necessaVenezia
to alla legge del tempo». Il nostro furrio salvaguardare la tradizione
Teatro Malibran
to sta nel ricorrere a questa partitue commissionare nuovi lavori
ra aristocratica che rubiamo al temche aprano strade, poiché l’eL’occasione fa il ladro
po e restituiamo a Venezia, città dallemento fondamentale rimadi Gioacchino Rossini
burletta per musica in un atto
la quale, ai tempi di Rossini, la culne il teatro e non la comunitura si diffondeva in tutta Europa,
cazione o l’applicazione delle
libretto
anche per via delle numerosissime
nuove tecnologie. Trovo che
Luigi Prividali
tipografie che c’erano allora. L’alil teatro possa dare forma
maestro concertatore e direttore
lestimento è un omaggio a Venezia,
all’invisibile. Nella nostra
Matteo Beltrami
alla scrittura, alla biblioteca, ai libri
rappresentazione non ci
regia
e alla carta come strumento di trasarà niente di naturalistiBetta Brusa
dizione, «furto» e trasmissione di
co né di realistico, nemscene e costumi
Laboratorio Accademia
un passato. All’entrata, nel foyer, si
meno nella gestualità e
di Belle Arti di Venezia
troveranno dei librettini, che il pubnella recitazione. Troblico potrà «rubare» liberamente,
veremo un modo per
Orchestra del Teatro La Fenice
che raccolgono tutti i progetti inviati
unificare tutti questi
Orchestra del Conservatorio
dagli studenti in risposta all’intento di
elementi. ◼
Benedetto Marcello di Venezia
costituire una «bottega artigianale»
di integrazione tra formazione e realiz12, 16, 18 ottobre, ore 19.00
zazione scenico-musicale, come pro14, 20 ottobre, ore 15.30
Bozzetti di Betta Brusa.
di Mario Messinis
G
ino Gorini, 1914-1991, era un grande pianista
e un compositore ingiustamente misconosciuto.
Veneziano, era stato allievo di Gino Tagliapietra,
a sua volta allievo di Ferruccio Busoni, entrambi espressione di un gigantismo pianistico tardoromantico.
Gorini non aveva molto a che vedere con questi maestri e
predecessori. Era un artista neoclassico, legato per formazio-
la modernità. L’eccezionale allargamento dei repertori toccò
anche l’intera produzione per due pianoforti e per pianoforte a quattro mani con la collaborazione prima di Sergio Lorenzi e poi di Eugenio Bagnoli.
Si dedicò soprattutto tra gli Anni trenta e quaranta alla
composizione. Questa attività è stata riscoperta e valorizzata da Giovanni Morelli quando il figlio del maestro, Claudio,
donò alla Fondazione Cini il Fondo Gorini. Il grande studioso aveva già presentato alla Fondazione la Sonata per violino solo del 1947, scritta a ridosso della Sonata per violino
solo di Bartók, e non meno ardita nella scrittura strumentale. Uno splendido concerto monografico di indediti e pagine
rare, nel ventennale della morte appena trascorso, si è ascoltato lo scorso 25 luglio alle Sale Apollinee, nell’ambito del
Festival estivo dedicato dalla Fenice alla Civilta Marciana.
La giovanile Sonata per violoncello e pianoforte del 1938 e
1.
4.
5.
3.
2.
ne a Gianfrancesco Malipiero, con cui studiò, poco piu che
ventenne, alla fine degli anni trenta, al Conservatorio Benedetto Marcello e di cui eseguì l’intera opera pianistica. Dal
compositore veneziano aveva appreso, nel rispetto dei testi,
a contestare l’esibizionismo degli interpreti. Tutta la produzione strumentale del Novecento gli era famigliare, convinto che anche i classici dovevano essere riletti nel segno del1. Gino Gorini e Sergio Lorenzi;
2. Gianfrancesco Malipiero;
3. Dmitri Sostakovic;
4. Jakub Tchorzewski;
5. Béla Bartók.
ancora legata all’apprendistato con Malipiero, ma solo qualche anno dopo Gorini rivela una conoscenza del dibattito
culturale europeo, di Sostakovic e soprattutto di Bartók, dimostrando qualche affinità con il pensiero del primo Maderna, del quale era fraterno amico. La Sonata per viola e pianoforte del 1944 è tra le piu notevoli pagine cameristiche italiane del tempo: meriterebbe di circolare, al pari del contemporaneo Quintetto per pianoforte e archi, forse non meno interessante del celebre Quintetto di Sostakovic.
Esecuzione impeccabile, guidata dal penetrante pianista
polacco Jakub Tchorzewski, affiancato da un giovane e solido quartetto d’archi statunitense. ◼
concerti
Alle Sale Apollinee
un omaggio
a Gino Gorini
31
concerti
32
Una performance
in Piazza per chiudere
il Prefestival
La Fenice fa un bilancio
della nuova manifestazione estiva
C
di Leonardo Mello
on Cento Squilli, l’installazione-performance realizzata in piazza San Marco il 3 agosto, si è
concluso il Prefestival «Lo spirito della musica di
Venezia», ideato e organizzato dalla Fenice con
la prospettiva di continuare e ingrandire l’iniziativa nei prossimi anni (cfr. vmed n. 47, p. 17). A partire da questo evento,
Cristiano Chiarot e Fortunato Ortombina, rispettivamente
sovrintendente e direttore artistico del Teatro, fanno un bilancio della manifestazione. «Con Cento Squilli – afferma il
primo – abbiamo voluto sperimentare un altro modo di utilizzare la piazza, meno invasivo rispetto ai concerti del passato. Abbiamo considerato questo straordinario palcoscenico naturale dal punto di vista scenografico, immaginando
la performance proprio in funzione di quello spazio». «Si
è trattato di una sorta di installazione musicale – aggiunge Ortombina – durante la quale una cinquantina di ottoni
hanno suonato in vari angoli della piazza, eseguendo musiche dei Gabrieli, che hanno reso la spazializzazione del suono un elemento imprescindibile, cui tutti i compositori moderni e contemporanei ricorrono. L’anima di questi cinquanta strumentisti sono gli ottoni della Fenice, che si stanno dedicando al recupero della musica della scuola marciana, non
so perché rarissimamente eseguita in città, mentre a ogni angolo si sente suonare Vivaldi». Ideale conclusione dunque
di un’iniziativa che ha visto il costituirsi di un’inedita collaborazione tra molti diversi enti cittadini, Cento Squilli – oltre alle musiche di Andrea e Giovanni Gabrieli – ha proposto anche la fanfara dell’Otello verdiano, «che ha un valore simbolico e di continuità nel tempo – continua il direttore artistico – perché proprio quell’opera sarà allestita l’anno prossimo a Palazzo Ducale. Per la giornata conclusiva del prossimo
festival torneremo comunque a “prendere in prestito”
la piazza, ma in un contesto
diverso: la Fenice commissionerà un brano a un compositore contemporaneo,
cui verrà chiesto di pensare il pezzo proprio per quello spazio, in un momento che dunque sarà unico e
irripetibile».
Passando a considerazioni più generali, il sovrintendente non nasconde la
soddisfazione per il successo del Prefestival: «Abbiamo collaborato con diverse istituzioni, dalla basilica dei Frari alla Fondazione Cini, per fare solo i primi due nomi che mi vengono in mente. In questo periodo, funestato dalla crisi, è quasi obbligatorio fare squadra, costituire una
rete con le moltissime associazioni che operano nel
nostro territorio. Solo così sarà possibile sconfiggere le difficoltà e immaginare i festival dei prossimi anni. Ma già fin d’ora abbiamo voluto portare il nostro
enorme patrimonio musicale in posti dove solitamente non è facile ascoltarSopra: l’omaggio
a Sara Mingardo.
In basso: un momento
di Fenix.
me un coreografo come Foofwa d’Imobilité e un artista concettuale come Stefano Arienti». Qualche valutazione merita anche il tipo di spettatori che questo Prefestival ha saputo raccogliere: «Abbiamo avuto un pubblico abbastanza diverso da quello delle nostre prime, composto solitamente da
persone che provengono da tutto il mondo e che si muovono
torneremo. Tra i molti appuntamenti ricordo, per esempio,
il Gala internazionale delle Accademie di danza, in cui nella cornice magica del Cortile di Palazzo Ducale protagonisti sono stati danzatori e coreografi giovanissimi, oppure le
serate dedicate a grandi vocaliste come Sara Mingardo, all’apice della sua carriera, e Jessica Pratt, il cui repertorio abbiamo contribuito anche a noi a scoprire e valorizzare. E ancora vorrei ricordare i concerti dei vincitori del Premio Venezia, oppure gli altrettanto giovani e straordinari interpreti
delle musiche di Gino Gorini. Insomma, pur essendo partiti con un certo ritardo siamo molto soddisfatti del risultato complessivo, anche sul versante della ricerca e della sperimentazione, come dimostra Fenix, il progetto multimediale
di danza contemporanea che – grazie alla collaborazione con
la Fondazione Bevilacqua La Masa – ha visto lavorare insie-
in funzione della singola opera, prenotando con grande anticipo il viaggio e l’albergo. Tra luglio e agosto invece, oltre ai
tanti veneziani, anche molti turisti che si trovavano per caso a Venezia sono stati “catturati” dalla nostra variegata serie
di offerte, dimostrando che pure in un periodo come quello
estivo è possibile presentare proposte culturali di qualità».
E per quanto riguarda il festival 2013? «L’anno prossimo
– prosegue il sovrintendente – sarà presente anche l’opera, a
cominciare dall’Otello a Palazzo Ducale, cui accennava poco
prima il maestro Ortombina. Ma grande attenzione sarà rivolta al panorama contemporaneo, che, per motivi organizzativi, è stato un po’ sacrificato nel Prefestival. E vi sarà inoltre una riflessione ancora più articolata sul repertorio marciano. Cercheremo di intercettare un turismo colto e curioso, offrendogli la garanzia della qualità. Già con questa prima edizione, che pur è stata ridotta e ha avuto la funzione di
un prologo, la Fenice ha sperimentato nuove possibilità di
lavoro, affiancando quest’attività a quella normale per il nostro Teatro, che consiste nelle produzioni. E l’esito è stato decisamente confortante». ◼
Due eventi nel cortile di Palazzo Ducale: in alto a destra, l’Opera
Gala; a sinistra il Gala internazionale delle Accademie di danza.
A destra: Cento Squilli in piazza San Marco (tutte le foto sono di
Michele Crosera).
concerti
lo, in linea, del resto, con la tradizione musicale veneziana,
che storicamente nasce nei palazzi e nelle chiese. Quest’anno abbiamo raggiunto Burano e Mestre, in futuro dovremo
coinvolgere ancora di più le isole, portando concerti a Pellestrina, a Sant’Erasmo, al Lido, senza dimenticare, ovviamente, l’importanza della città di terraferma, dove certamente
33
concerti
34
Al Festival
Monteverdi-Vivaldi
due «stromenti
venetiani» dimenticati
n. 3 nella versione per tastiera che ne fece Johann Sebastian
Bach).
Il concerto di giovedì 6 settembre, sempre alle 21.00, darà invece la possibilità al pubblico del Festival MonteverdiVivaldi di ascoltare Jean Tubery (sempre con Loreggian al
continuo), considerato oggi il più grande virtuoso di cornetto al mondo. Il programma, dal suggestivo titolo «Il cornetto della Serenissima: uno “stromento veneziano” dimenticato», riunirà in un’ampia antologia Canzoni, Sonate, Baldi Alberto Castelli
li, Madrigali e Mottetti diminuiti di Girolamo Della Casa,
Andrea e Giovanni Gabrieli, Giovanni Bassano, Giovanni
a convergenza tra i cartelloni del Festival
Battista Riccio, Giovanni Battista Fontana, Giovanni PicMonteverdi-Vivaldi 2012 e del Prechi e Biagio Marini. L’ascolto non sarà purafestival «Lo spirito della musica di
mente musicale: per l’occasione, infatti, TuVenezia» (cfr. vmed n. 47, p. 17 e pp.
bery illustrerà ai presenti in sala le caratteristiVenezia
32-33 di questo numero) – convergenza nata
che principali di uno strumento e di un reperSale Apollinee
da una sinergia di eccellenza, quella tra il Vetorio che – perlomeno fino alla grande peste
del Teatro La Fenice
3 settemre, ore 21.00
netian Centre for Baroque Music e il Teatro
del 1630 – ebbero a Venezia un ruolo di pri6 settembre, ore 21.00
La Fenice – torna a far risuonare la musica bamissimo piano.
12 settembre, ore 18.00
rocca veneziana alle Sale Apollinee del Gran
L’incontro di mercoledì 12 settembre, previTeatro veneziano.
sto
per le 18.00, completerà il mini-cartellone
Venezia
Dopo il successo del doppio appuntamento
barocco
alla Fenice con l’incontro con ClauPalazzo Pisani Moretta
– 20 e 21 luglio appena trascorsi – dedicato
dio Cavina, uno tra i più affermati specialisti
5 settembre, ore 21.00
alla Canzone da Battello e alla barcarola tra
della musica di Monteverdi e Cavalli che conSette e Novecento, con i concerti di inizio setdividerà con il pubblico la propria esperienza
tembre il centro dell’attenzione si sposterà sul versante strudi interprete del repertorio barocco veneziano.
mentale, con un’indagine a tutto tondo intorno a due struA margine degli appuntamenti strumentali alle Sale Apol-
L
menti-principe nella Venezia tra Sei e Settecento, il cornetto e il violoncello, la cui fortuna fu successivamente oscurata dallo straripante successo della pratica e della letteratura
violinistica.
Il primo appuntamento sarà quello di lunedì 3 settembre
alle 21.00, che vedrà il violoncellista Francesco Galligioni
(già applaudito interprete, assieme all’ensemble L’Estravagante, del concerto svoltosi in Punta della Dogana lo scorso 1 luglio), accompagnato dal violone di Paolo Zuccheri e
dal clavicembalo di Roberto Loreggian, interpretare alcune
tra le più belle sonate per violoncello e basso continuo di Antonio Vivaldi (da segnalare il cameo cembalistico di Loreggian, che la stessa sera proporrà il vivaldiano concerto op. 3
linee va ricordato il concerto di mercoledì 5 settembre alle
21.00 a Palazzo Pisani Moretta con uno tra i giovani direttori emergenti per il repertorio barocco, Leonardo GarcíaAlacórn (già sul podio della Fenice lo scorso autunno per
Acis e Galatea di Händel), che accompagnerà il soprano Mariana Flores in una selezione di arie di Frescobaldi, Barbara
Strozzi, Cavalli e Händel. (Info: www.vcbm.it; e-mail: [email protected]; tel. 041 5227325. Biglietti: concerti €10-20;
incontro del 12/9 a ingresso gratuito). ◼
A sinistra:Leonardo García-Alacórn.
Al centro: Jean Tubery.
A destra: Francesco Galligioni.
alcune tra le più belle scene tratte da due Orfeo: la celebre
partitura di Monteverdi del 1607 e quella assai meno praticata di Sartorio, tenuta a battesimo il 14 dicembre 1672 al
Teatro San Salvatore a Venezia, che al perfetto equilibrio tra
dramma e musica (sulla linea Monteverdi-Cavalli) somma
una scrittura vocale che anticipa in larga misura lo stile virtuosistico dell’opera del Settecento. Il concerto è realizzato in collaborazione con la Fondazione François Pinault e
rimi sono i teatri di musica a dar princon il Festival Les Promenades Musicales (Calvados – Bascipio con una pompa e splendore incredibile,
se Normandie).
punto non inferiore a quanto si pratica in diSabato 15 settembre alle 21.00, la straordinaria cornice delversi luoghi dalla magnificenla Sala degli specchi di Ca’ Zenobio ospiteza de’ principi, con questo solo divario che,
rà il ritorno a Venezia (patrocinato dal Mudove questi lo fanno godere con generosità,
ziektheater Transparant di Anversa) dei gioin Venezia è fatto negozio […]».
vani musicisti dell’Ensemble Scherzi MusiVenezia
Le Memorie teatrali di Venezia di Cristofocali, compagine che proprio al Collegio ArPunta della Dogana
ro Ivanovich costituiscono una testimonianmeno aveva inaugurato le attività del Vene14 settembre, ore 21.00
za preziosa della vita teatrale della città lagutian Centre for Baroque Music lo scorso annare. All’altezza del 1681, anno in cui il cano. All’Ensemble belga diretto dall’eclettiVenezia
Sala degli specchi
nonico dalmata di San Marco dedicò l’opera
co Nicolas Achten (clavicembalista, tiorbidi Ca’ Zenobio
ai fratelli Grimani, Claudio Monteverdi era
sta, liutista, arpista baritono e direttore, na15 settembre, ore 21.00
scomparso da trentotto anni, Francesco Cato a Bruxelles nel 1985) il Festival Montevervalli da un lustro, Antonio Sartorio da appedi-Vivaldi ha affidato il compito di ridare voVenezia
na pochi mesi; ma il sistema-opera che ciace ai personaggi di alcune tra le più imporCa’ Zen
scuno, pur a titolo diverso, aveva contribuitanti opere di Cavalli: Didone (1641), Giaso16 settembre, ore 21.00
to a istituire e alimentare – a partire dal fane (1649) e Calisto (1652), esempi insuperati
tidico Carnevale del 1637, che, con l’allestidel genio veneziano espresso nel neonato gemento dell’Andromeda di Manelli e Ferrari al Teatro di San
nere dell’opera «pubblica».
Cassiano, aveva segnato la nascita dell’opera in musica coPer il concerto finale di domenica 16 settembre, ospitame impresa – godeva di ottima salute.
Al vivido affresco del
«tra scorso istorico»
dell’Ivanovich, il Festival
Monteverdià-Vivaldi 2012
«I Furori della gioventù»
(cfr. p. 34) fornirà una puntuale corrispondenza musicale con gli ultimi tre concerti in cartellone, dedicati
all’opera veneziana.
A partire da venerdì 14
settembre alla Punta della
Dogana (ore 21.00), quando Les Musiciens du Paradis riporteranno alla luce
P
«
In alto: l’Ensemble Scherzi Musicali
(foto di Philip Van Ottegem).
Sopra: l’Ensemble Gene Barocco.
to, sempre alle 21.00,
al piano nobile di Ca’
Zen, il festival guarderà invece alle conseguenze settecentesche
dell’opera di Monteverdi e Cavalli, dando
carta bianca a Giuseppina Bridelli, vincitrice
del primo premio al vi
Concorso di Canto barocco di Vicenza. Insieme ai musicisti del Gene Barocco, già applauditi interpreti del concerto dello scorso 6 luglio a Palazzo Zorzi, il
giovane mezzosoprano italiano canterà un programma interamente dedicato a Vivaldi. (Info: www.vcbm.it; email [email protected]; tel. 041 5227325. Biglietti: €10-20). (a.c.) ◼
concerti
Ancora concerti
per il Venetian Centre
for Baroque Music
35
concerti
36
Ad Aldo Ciccolini
il Premio
«Rubinstein» 2012
I
di Vitale Fano
l prestigioso Premio «Una vita nella musica»,
ideato dall’Associazione «Arthur Rubinstein presieduta da Bruno Tosi (cfr. pagina a fronte), giunge
quest’anno alla sua trentaquattresima edizione, e sarà
consegnato il 17 settembre, nella Sala Grande del Teatro La
Fenice, al pianista italo-francese Aldo Ciccolini.
Napoletano di nascita, attivo nelle sale da concerto di tutto il mondo fin dal 1941, anno in cui debutta sedicenne al San Carlo di Napoli, Ciccolini lascia l’Italia
nel 1971 e si stabilisce a Parigi, diventando in seguito
cittadino francese. È uno dei più grandi pianisti del
Novecento e continua tutt’oggi la sua intensa attività
concertistica, mostrando in ogni esibizione una profondità interpretativa e una sapienza musicale di straordinaria levatura.
Nel corso di sette decenni di carriera, ha inciso più
di cento dischi, consegnando alla storia della musica interpretazioni di grande nobiltà ed eleganza; basti ricordare le integrali pianistiche di Debussy, Ravel, Satie, delle sonate di Mozart e di Beethoven, i cicli completi delle Harmonies poétiques et réligieuses di
Liszt, dei Concerti di Saint-Saëns o Iberia di Albeniz.
La sua produzione discografica rivela il grande amore
per la musica francese, ma c’è anche in lui l’interesse
per autori meno frequentati (Alexis de Castillon, fra
gli altri) e l’attenzione particolare nei confronti della
musica italiana, così trascurata dai nostri connazionali da fargli maturare la convinzione che gli italiani siano i peggiori nemici della loro cultura. Ciccolini ha inciso quattro cd di musica pianistica di Mario Castelnuovo-Tedesco, il Concerto per pianoforte e orchestra di Ildebrando Pizzetti, la musica da camera di Achille Longo e il Quintetto di Guido Alberto Fano (eseguito anche al Teatro Goldoni di Venezia nel 1997 in favore della ricostruzione del Teatro La Fenice).
Dal 1972 ha insegnato per diciott’anni al Conservatorio di Parigi, e continua tutt’oggi a dedicarsi a giovani pianisti di talento che guida nel perfezionamento e nella ricerca della loro personalità artistica.
Come interprete, sorprendono la fedeltà al testo, la
nitidezza e la precisione che sembrano rifarsi all’insegnamento di Arturo Benedetti Michelangeli, pietra
miliare del suo cammino artistico. «L’osservanza del
testo non limita l’immaginazione. Anzi, più si rispetta il testo, più si è liberi. Sembra un paradosso ma è così», afferma il pianista nel volumetto Roberto Piana
incontra Aldo Ciccolini (Editoriale Documenta, Cargeghe,
Sassari, 2010), da cui sono tratti i virgolettati che seguono.
Per il pubblico veneziano, Ciccolini ha distillato dal suo
vasto repertorio alcuni brani significativi di alcuni fra gli autori più amati: Mozart, Clementi, Debussy e CastelnuovoTedesco, quasi a voler suggerire che il giusto ossequio per il
grande repertorio non deve annullare l’interesse per la «propria» musica. Del Genio di Salisburgo, il pianista sceglie la
Fantasia K475 e la Sonata K457, nate a poca distanza l’una
dall’altra ed entrambe pervase dalla stessa agitazione tragica.
Pensando a Mozart, Ciccolini sostiene che «anche quando è
drammatico, lo è come un bimbo», perché «aveva sempre la
spontaneità dell’infanzia». Dell’amato e «misterioso» Debussy («un enigma che ci accompagna tutta la vita»), propone tre Préludes, tratti dal secondo libro.
Quanto agli autori italiani, la scelta ricade emblematicamente su Muzio Clementi, padre del pianoforte (fu concertista, compositore, didatta, editore e costruttore) e capostipite dei pianisti italiani. Sono arcinote le sue composizioni
didattiche, mentre di rado si ascoltano in concerto le sue Sonate; l’op. 34 n. 2 è composizione ampia e ambiziosa, forse
trascrizione di un lavoro orchestrale. Ancor meno si sente in
concerto la musica di Castelnuovo-Tedesco, «meraviglioso
compositore completamente ignorato», costretto dalle leggi razziali a emigrare negli Stati Uniti. La suite Piedigrotta
1924, intrisa di folklore e napoletanità, rielabora materiali
popolari in chiave moderna e sperimentale.
Ciccolini manca da Venezia dal 2002, quando eseguì al Palafenice il Quarto Concerto di Beethoven diretto da Arnold
Östman. L’iniziativa di Bruno Tosi pone quindi rimedio a
un lungo periodo di disattenzione della città nei confronti di
un grande maestro dalla profonda cultura e dallo spirito sagace: per lui il pianoforte è «come l’aria che si respira» e Beethoven è come Dio. Nel corso di un’intervista radiofonica
ebbe infatti a dichiarare: «Se Dio non assomiglia a Beethoven… non m’interessa!». ◼
Aldo Ciccolini (blog.lefigaro.fr).
mo avuto la fortuna e l’onore di incontrare Andrés Segovia,
Karl Böhm, Mstislav Leopoldovich Rostropovich, Leonard
Bernstein, Isaac Stern, Renzo Piano, Luca Ronconi, Carla
Fracci, Raina Kabaivanska, Carlo Bergonzi, Daniel Barendi Ilaria Pellanda
boim e, l’anno scorso, Gidon Kremer (cfr. vmed n. 43, p. 36)
– solo per citarne alcuni – tutti grandissimi nomi. Inoltre,
i svolgerà ancora una volta in Fenice, il 17
vorrei sottolineare ancora una volta che il prestigio di questa
settembre alle 19.00, la nuova edizione del Premio
iniziativa è derivato anche e soprattutto dall’aver avuto co«Arthur Rubinstein – Una vita nella musica», che
me primo ospite un maestro del calibro di Athur Rubinstein,
quest’anno giunge a festeggiare il suo
che diede il la al Premio da un trampolino di
xxxiv compleanno.
lancio davvero importante. Conoscevo già il
Bruno Tosi, presidente dell’Associazione inMaestro, e quell’anno, il 1979 appunto, anVenezia
titolata al celebre pianista, consegnerà il predai a Parigi per incontrarlo nuovamente. DiTeatro La Fenice
mio ad Aldo Ciccolini (cfr. p. 36), uno dei ravenni quindi buon amico anche della moglie,
17 settembre, ore 19.00
ri, grandi maestri del pianoforte che, a più di
che accettò di diventare Presidente onorario
ottant’anni, continua a percorrere instancadella mia iniziativa. Rubinstein amava Venebilmente le strade della carriera mondiale, fedele a tutta una
zia e, come un giorno mi disse, la amava come si poteva fare
vita posta sotto il segno del movimento.
La cerimonia di premiazione vedrà Ciccolini salire sul palco della Fenice – che fin dal 1979 ospita l’evento nato in collaborazione proprio con il Teatro veneziano – e raggiungere il suo pianoforte per un concerto dedicato in gran parte a
Mozart, Castelnuovo Tedesco e a Scarlatti.
«Questa nuova edizione 2012 segna per noi un importante traguardo», sottolinea Bruno Tosi. «Non è sempre facile, infatti, riuscire a portare avanti iniziative di questo tipo,
mantenendo nel susseguirsi degli anni sempre un ottimo livello. Fin dal 1979, quando il Premio vide la sua prima, folgorante luce grazie alla presenza di Arthur Rubinstein a Venezia, abbiamo avuto la fortuna di poter contare sulla piena collaborazione del Teatro La Fenice, sodalizio durato nel
S
tempo e che ancora oggi gode di ottima salute. Ci prepariamo inoltre a festeggiare un importante anniversario: anche
se i miti non muoiono mai, in questo 2012 ricorrono infatti i trent’anni dalla scomparsa di Rubinstein, al quale dedicheremo più che un pensiero durante la cerimonia tributata a Ciccolini. Rubinstein – premiato a Venezia quando aveva novantré anni – è stato uno dei massimi virtuosi della tastiera, un uomo che ha girato tutti i continenti, riscuotendo
trionfi davvero incredibili, incidendo centinaia di dischi…
Insomma, un uomo record».
Tosi ricorda poi alcune delle personalità alle quali è stato
conferito il Premio «Una vita nella musica» nell’avvicendarsi delle edizioni: «Oltre ad Arthur Rubinstein, abbiaSopra: Bruno Tosi (a sinistra) e Aldo Ciccolini
in occasione del concerto del 28 dicembre 2011
al Teatro alla Pergola di Firenze.
A destra: Ciccolini al pianoforte.
con una bella donna. Suonò in laguna decine di volte. Il primo concerto, curiosamente, non lo tenne alla Fenice bensì al
Conservatorio “Benedetto Marcello”, che allora, come oggi,
aveva una sala molto prestigiosa». ◼
concerti
«Una vita nella musica»
fin dal 1979
37
concerti
38
Il Festival Galuppi
compie diciott’anni
Due anni fa abbiamo dato vita a un percorso che ha cominciato a esplorare la Venezia segreta e i suoi giardini, un itinerario che ha visto il proprio battesimo a Palazzo Minelli Spada, alla Madonna dell’Orto. Quest’anno andremo a scoprire lo splendido giardino di Palazzo Franchetti, angolo verde
di Ilaria Pellanda
affacciato sul Canal Grande, ai piedi del Ponte dell’Accademia, dove, il 15 settembre, ospiteremo l’Ensemble patavino
utti a Venezia conoscono il Festival Galupdi ottoni I Similoro, diretto da Vincenzo Montemitro. Reapi – I Luoghi di Baldassare, longeva realtà musilizzeremo poi una collaborazione molto importante con Pacale volta alla riscoperta e la riproposta delle opere
lazzetto Bru Zane che vedrà l’Ensemble Musagete presencompositive di Baldassare Galuppi, figura di notare, il 16 settembre nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenitevole rilievo ai suoi tempi, poi in parte oscurace, un programma dedicato ai Quintetti di Beta dalla fama del concittadino Antonio Vivaldi.
ethoven e Magnard. Facendo qualche passo inQuest’anno, nonostante la crisi economica che
dietro, l’inaugurazione del 9 settembre al «BeVenezia
tartassa anche il nostro Paese, la rassegna venenedetto Marcello» vedrà i Virtuosi Veneti imdal 9 settembre
ziana si prepara a compiere la maggiore età: il 9
pegnati in una serie di Concerti di Galuppi. La
al 30 ottobre
settembre – data d’inaugurazione, che si svolgepeculiarità della serata sarà quella di poter ascolrà nella Sala Concerti del Conservatorio «Benetare alcuni fra coloro che, in anni diversi, sono
detto Marcello» di Venezia – soffierà le candeline di diciotstati allievi del Conservatorio veneziano. Quest’anno inizieto anni di attività, che l’hanno vista collezionare e mettere
rà inoltre un nuovo ciclo, “Le voci sull’acqua”, che presenterà
in atto proposte da parte di studiosi di tutta Europa
musiche corali di varia provenienza. Avremo il Cocon l’intento di portare alla luce non solo i rero Latomas, compagine tutta al femminile che
pertori inediti di Galuppi ma anche quelDiana D’Alessio dirigerà ancora una volli di altri musicisti.
ta nelle Sale Apollinee accompagnata
Fin dai suoi esordi il festival ha idedal Quartetto Leggio; vi sarà poi il
ato percorsi che rendessero possiCoro polifonico Amurianum, dibile associare le musiche ai luoretto da Franco Salvadori, che il
ghi, così da proporre una Ve22 settembre suonerà sull’Inezia inedita a chi non l’avesola del Lazzaretto Nuova ancora conosciuta dal e
vo “Il Teson Grande” per
nel vivo, e una laguna da
un concerto che, così coriscoprire per coloro che,
me quello che si svolgecittadini, non avevano
rà a Palazzo Franchetti,
mai trovato l’occasiosarà totalmente gratune di osservarla, assieito. E anche per quanme al suo complesso
to concerne l’evento
di isole, con sguardo
inaugurale del 9, ai vediverso.
neziani verrà data la
«I tagli alla cultupossibilità di accedera, ahimé, sono semre in sala senza pagapre più drastici e inere. Sempre nell’amsorabili» – lamenbito del progetto “Le
ta giustamente Alesvoci sull’acqua”, l’ulsio Benedettelli, pretimo coro in cartellosidente dell’Associane sarà quello dei Canzione veneziana e direttori Veneziani, il 13 ottore artistico del festival
tobre, che la D’Alessio
– «ma anche quest’anno
dirigerà nel Salmo xxxvi
abbiamo avuto il coraggio
di Benedetto Marcello. Sadi buttare il cuore oltre la
rà inoltre presente al festival
barricata e realizzare un nuol’Ensemble vocale De’ Caracvo cartellone. Gli anni trascorci, che, diretto da Paolo Faldi
si ci hanno regalato moltissime
alla Scuola Grande di San Rocsoddisfazioni, sia dal punto di vista
co il 29 settembre, presenterà in pridella critica che da quello dell’affluenma mondiale un inedito di Galuppi: si
za di pubblico ai nostri concerti, nonotratta della Passione Secondo San Giovanstante ci siamo trovati a soffrire sempre più a
ni, alla quale seguirà lo Stabat Mater di Scarcausa della scure dei famigerati, e già citati, tagli. Di
latti. Il 30 settembre, nuovamente nelle Sale Apolanno in anno abbiamo sempre cercato di essere propositivi,
linee, ospiteremo un’orchestra tutta formata da bambini: si
aprendo anche delle sottosezioni del festival: alludo ad esemtratta dei piccoli allievi del Conservatorio “Cesare Pollini”
pio alla “Linea verde”, che, in collaborazione con la Fondadi Padova, detti i “Pollicini”, che presenteranno musiche di
zione “Santa Cecilia” di Portogruaro, ha offerto ai giovani la
Brahms e Bizet; e il 3 ottobre si potranno ascoltare il violino
possibilità di esibirsi su un palcoscenico privilegiato com’è
di Dora Bratchkova e il pianoforte di Aldo Orvieto, i Rusquello della città di Venezia, e magari di farlo la sera successian Masters, in un concerto che avrà in programma musiche
siva al concerto di un grande artista di fama internazionadi Shostakovich, Stravinsky e Prokofiev». ◼
le; abbiamo realizzato una sezione centrata sull’opera buffa, e poi ancora quella dedicata agli Oratori, ai Fondaci, ecc.
Baldassare Galuppi tra il 1770 e il 1780.
T
eseguirà una serie di trascrizioni di Richard Wagner realizzate da compositori dell’Ottocento, dando così inizio alle
celebrazioni in onore del compositore tedesco programmate durante la stagione. Assolutamente inedito sarà il ciclo di
conferenze che si svolgeranno durante questa nuova stagione, e la prima, condotta da Carlo Montanaro il 20 novembre
alle 18.00 a Palazzetto, sarà dedicata alla riproduzione musidi Andrea Oddone Martin
cale nell’Ottocento e analizzerà i metodi di diffusione della
musica dell’epoca attraverso mezzi meccanici, prima dell’avn tutte le epoche, parte della cultura non corrivento del fonografo. Adriana Guarnieri, l’11 dicembre alle
sponde allo spirito del proprio tempo ma, in un acces18.00 sempre al Bru Zane, tratterà gli argomenti della conso nostalgico, sceglie e idealizza un
ferenza successiva, intitolata a «Berlioz e
passato rievocando eden sociali e
Liszt come critici musicali». È nostro inmiti originari. Invero particolari periodi
tento, attraverso questo ciclo di incontri,
Venezia
della storia sono stati determinati da tanon fermarsi a considerare esclusivamente
dal 6 settembre all’11 dicembre
le atteggiamento, dal quale si sono potuil prodotto musicale romantico ma com(per informazioni: www.bru-zane.com)
ti ricavare i principali percorsi di pensiero.
prendere anche le qualità della contempoAd esempio il Neoclassicismo, ma ugualraneità ottocentesca nei suoi aspetti collamente l’attenzione che il Romanticismo dedica all’antichiterali. Questi saranno i primi due appuntamenti del carteltà ne sono un esempio manifesto. Il primo festival della stalone autunnale. Daremo il la anche a un programma pedagogione 2012-2013 di Palazzetto Bru Zane, organizzato dal
gico, che coinvolgerà le scuole elementari della città per dare
Centro della Musica Romantica Francese e intitolato «Anai più giovani la possibilità di assistere alle prove dei concertichità, Mitologia e Romanticismo», riprende questa temati. I programmi delle esecuzioni saranno quelli più adatti a
tica all’interno del
repertorio particolarmente sconosciuto del romanticismo musicale
francese, delineando una serie di interessanti proposte, tra settembre
e novembre, che si
terranno a Venezia
e nel mondo.
«Uno dei concerti che riteniamo più importanti», afferma Florence Alibert, direttore generale del
Centro veneziano,
«è l’A tys di Niccolò Piccinni. Sarà in prima esecuzione il 23 settembre alle 17.00 alla
Scuola Grande San
Giovanni Evangelista di Venezia
e il giorno dopo al
Théâtre des Bouffes du Nord di Parigi. Il capolavoro di Piccinni sarà proposto
un pubblico infantile, che avvicineremo maggiormente alla
in una forma tipica per le esecuzioni ottocentesche, e cioè in
musica attraverso alcuni laboratori introduttivi».
riduzione per strumentisti e alcuni cantanti, quasi una verOltre che alla realizzazione dei festival concertistici, il vostro
sione cameristica. Un altro concerto importante è quello
Centro è impegnato nell’ambito della ricerca e dell’editoria.
che si svolgerà il 22 settembre alle 20.00, sempre nella Scuola
Sono previste delle novità in questo settore?
Grande di San Giovanni Evangelista, che vedrà la mezzosoCi sono delle novità dal punto di vista internazionale, nel
prano Jennifer Borghi, oramai una nostra affezionata, affrosenso che cercheremo di far conoscere anche all’estero, attranatare un repertorio di arie di vari autori romantici dedicaverso l’organizzazione di alcuni festival, la diffusione del late alle figure tradizionali dell’antichità; da segnalare, la privoro scientifico che svolgiamo a Venezia. Il primo evento si
ma esecuzione moderna di Phèdre, scritta da Jean-Baptiste
svolgerà a Parigi nel giugno 2013: l’idea che lo anima è apLemoyne. Tra i vari artisti che collaborano costantemente
punto quella di creare un ponte con l’attività veneziana. Docon noi, anche il giovane pianista Wilhelm Latchoumia, che
po l’esperienza parigina, abbiamo in animo di sviluppare
il 13 ottobre alle 20.00, questa volta al Palazzetto Bru Zane,
questo tipo manifestazioni anche in altre città europee, che
potranno così diventare un’interessante vetrina per le attività scientifiche del Bru Zane. ◼
Un concerto a Palazzetto Bru Zane (foto di Michele Crosera).
I
concerti
Un nuovo autunno
in musica
per Palazzetto Bru Zane
39
concerti
40
«L’ape musicale»
degli Amici
della Musica di Venezia
S
di Paolo Cattelan*
u invito della azienda Rigoni di Asiago abbiamo progettato un percorso musicale sul tema delle api e del miele che sarà eseguito alle Sale Apollinee
della Fenice il prossimo 29 settembre. In un primo
momento avevamo pensato di riprendere puntualmente Lorenzo Da Ponte cui spetta il merito di aver inventato questo
titolo, L’ape musicale, alludendo al poeta impresario che crea
un’opera dal «nettare» di altre opere. Tuttavia proprio andando qua e là, di musica in musica come di fiore in fiore secondo il metodo di Da Ponte, abbiamo scoperto che non solo
c’era la possibilità di mettere insieme delle belle partiture, ma
anche di affrontare il tema con una diversa profondità d’approccio guidati nella ricerca proprio dall’ape e dal suo rapporto ancestrale con l’uomo. Vorremmo citare quanto scherzosamente Andrea Rigoni ci ha detto in un incontro preliminare: «Con l’ape vogliamo entrare nel mito». E così è stato davvero nel momento in cui ci siamo messi a seguire le situazioni
operistiche più forti, dove l’ape entra in campo come fattore
simbolico decisivo della dinamica storica.
Una di queste opere è senz’altro l’atto di Aristeo che Cristoph Willibald Gluck mette in musica su libretto di Giuseppe
Pezzana per lo sposalizio di Ferdinando di Borbone e di Maria Amalia d’Asburgo a Parma nel 1769. Aristeo è, per il mondo greco, il semidio dell’apicultura e il suo mito ci è stato tramandato, insieme a quello di Orfeo, nel Quarto libro delle
Georgiche di Virgilio cui s’ispira molto fedelmente il libretto di Pezzana per Gluck. Nell’Aristeo del compositore vi sono alcune gemme come l’Aria virtuosistica «Nocchier che in
mezzo all’onde» oppure l’Aria «Cessate fuggite» con violino e violoncello concertanti. Ma vi è persino il racconto, sviluppato in forme recitative, del rituale della Bugonia (letteralmente «genesi dal bue») che si credeva portasse le api a nascere spontaneamente dalle carcasse di animali sacrificati, secondo un processo in cui gli antichi vedevano riflessa l’immagine
dell’anima che si distacca dal corpo materiale.
Ancora più sorprendente è il rilievo che si ottiene da una rapida ricognizione su un altro titolo di grande importanza per
la mitica presenza delle api. Cominciamo dal dire che molti sono i compositori che hanno messo in musica la storia di
Sansone e Dalila, ma che uno solo è quello che lavora anche
ad un altro episodio della vicenda biblica dell’eroe ebreo che
bisogna rapidamente ricordare ancor prima di nominare il
compositore. L’episodio è dunque quello del leone che Sansone avrebbe squarciato a mani nude mentre andava in Timnata a prendere per moglie una donna filistea. Al suo ritorno
a casa Sansone vide che nella carcassa del leone le api avevano fatto un favo ch’egli
prese cibandosi del miele. Quindi rielaborò tutto quanto gli era accaduto in forma di enigma e lo pose ai Filistei durante il banchetto di
nozze. Esiste un chiaro legame tra il leone di Sansone e i tori di Aristeo, un legame adombrato nella storia stessa dei Filistei,
il popolo di origine egea che diede nome alla
Palestina e che fu alleato degli ebrei prima di
diventarne mortale nemico. Occorre a questo punto fare un po’ di chiarezza sul nome del
compositore italiano che sente talmente il fascino di Sansone
dal derivarne una specie di trilogia tragica (Sansone in Tamnata, Sansone in Gaza, La caduta del tempio di Dagone): si
tratta di Francesco Basily (o Basili, anche Basilj nelle fonti coeve) e la sua opera andò in scena al teatro San Carlo di Napoli nel 1824 con un grande cantante nel ruolo di cartello: Luigi Lablache. Vale sottolineare la qualità della musica di Basily,
scolpita in modo che non poco richiama alla mente Verdi da
una posizione storica però nettamente anticipe. Basily era nato nel 1767 a Loreto, solo undici anni dopo Mozart, da una famiglia di musicisti originaria dell’Umbria e prevalentemente attiva a Loreto. Francesco aveva appreso lo stile osservato
da Giovanni Battista Borghi e Giuseppe Jannacconi a Roma
e nel corso della sua carriera fu maestro di cappella a Foligno, Macerata, Loreto e quindi alla Cappella Giulia in Roma. Compose moltissima musica sacra, strumentale e da camera ed ebbe importanti incarichi al Conservatorio di Milano, ma anche all’Accademia di Berlino. Non disdegnò l’opera e, a giudicare dal Sansone, la sua produzione non mancherà
di essere riscoperta in un prossimo futuro. Per la cronaca la
sua conoscenza di Verdi si lega ad un fatto preciso: mentre
quest’ultimo si presentava per essere ammesso al Conservatorio di Milano, Basily presiedeva la commissione che
lo bocciò: colpito sul vivo, molti anni dopo Verdi rifiuterà di dare il proprio nome al conservatorio di Milano, come lui
stesso ebbe a dire «Non mi hanno voluto da giovane, non mi avranno da vecchio». Francesco Basily muore a Roma nel 1850, chissà se il prossimo anno verdiano porterà qualcosa anche
per lui…
L’ultima stazione è Debora, che
in ebraico significa proprio
«ape». A Debora che nel
mondo Egeo era Melissa, si
ricollegano tutte le altre storie: Aristeo, la Bugonia, Sansone… Debora ha avuto alcune ricorrenze importanti nella Storia della musica, prima fra tutte Händel (1733). L’azione sacra
per musica di Pietro Alessandro Guglielmi su libretto di Carlo Sernicola intitolata Debora e Sisara andò invece in scena al
Teatro San Carlo di Napoli nel 1788. Fu un successo memorabile. Una grande virtuosa, Brigida Banti Giorgi, gareggiò
con gli strumenti nel ruolo dell’unica donna che la Bibbia ricordi tra i Giudici d’Israele, la donna che portò il suo popolo
(e gli alleati Filistei) a sconfiggere il re di Canaan.
Protagonisti del volo dell’ape musicale al Teatro La Fenice
saranno il soprano Susanna Armani, il mezzosoprano Silvia
Regazzo, il basso-baritono Devis Fugolo, il violoncellista Simone Tieppo, il pianista Bruno Volpato: un gruppo di solisti
di raffinati interessi culturali vicino alle attività di ricerca degli Amici della Musica di Venezia. ◼
*Presidente degli Amici della Musica di Venezia
Debito a Gioachino Rossini
L’attività degli Amici della Musica
di Venezia in provincia
U
n’intensa attività si preannuncia per la stagione d’autunno degli Amici della Musica di Venezia. Tra
settembre e ottobre si inaugura il ciclo di concerti dedicato a
Rossini nel cxx anniversario della nascita.
Il progetto, che rientra nella programmazione Reteventi
2012 della Provincia di Venezia, si avvale anche della colla-
Concordia Sagittaria – Cattedrale
14 settembre – ore 20.45
Noale – Duomo
20 settembre, ore 20,45
Cavallino – Chiesa di S. Maria Elisabetta
19 ottobre, ore 20,45
Petite Messe Solennelle
per soli, coro, pianoforte e harmonium
Salzano – Filanda Romanin-Jacur
6 ottobre, ore 20.45
San Donà – Auditorium Comunale
12 ottobre, ore 20.45
Chioggia – Auditorium San Nicolò
31 ottobre, ore 20.45
Tornare a Babilonia
per soprano, mezzosoprano e pianoforte
con interventi di Carlo Borghesan
I «Concerti
della domenica»
dei Solisti Veneti
S
ono trascorsi quarantacinque anni da
quando, nell’ottobre 1967, I Solisti Veneti diretti da
Claudio Scimone hanno creato la formula, nata a Padova e divenuta ormai tradizionale, dei «Concerti
della domenica». Questi appuntamenti, che si svolgono tuttora la domenica mattina alle 11 a prezzi molto ridotti, avevano e hanno ancora lo scopo di raggiungere un pubblico
nuovo che raduni, oltre agli appassionati dei concerti serali, i
giovani e tutti coloro che per diversi motivi non amano uscire di casa la sera, come le persone anziane e le famiglie con
bambini (cui sono dedicati molti programmi speciali).
Santa Maria di Sala – Villa Farsetti
23 ottobre, ore 20.45
Scorzé – Villa Soranzo-Conestabile
27 ottobre, ore 20.45
Il cioccolatte osmazonico
per soprano, pianoforte
con interventi di Carlo Borghesan
Il percorso nasce dall’importante contributo di Carlo Borghesan, erede dello
speziale veneziano Giuseppe Ancilllo che
nel libro Veneziani e Venezia di ieri e l’altro ieri (Ibiskos editrice, Empoli, 2002) racconta della lunga amicizia di Ancillo con Rossini e dell’ambiente culturale ruotante
intorno alla farmacia «All’insegna della Vecchia e del Cedro
imperiale» in Campo San Luca a due passi dalla Fenice che
il pesarese frequentava in occasione del debutto delle sue opere, dalle prime farse al Teatro San Moisé fino a Semiramide al
Teatro La Fenice. Tre sono i programmi di concerto circuitati nelle varie sedi (cfr. gli appuntamenti qui a fianco): «Tornare a Babilonia», «Petite Messe Solennelle» e «Il cioccolatte
osmazonico». Nel gergo degli impresari ottocenteschi «Tornare a Babiblionia» significava allestire Semiramide (regina
di Babiblonia) con le sorella Barbara e Carlotta Marchisio celebri cantanti che Rossini volle anche alla première della Petite Messe Solennelle.
E «Il cioccolatte osmazonico»? Fu un brevetto dello Spicier Giuseppe Ancillo, che doveva provvedere a tutti i malanni di Rossini, provocati dai suoi ben noti peccati di gola, mentre quest’ultimo, ospite in casa sua, scriveva la Semiramide. Nel corso dello spettacolo musicale, tra un’aria e l’altra, sarà possibile degustare alcuni piatti rossiniani e finalmente scoprire insieme misteriose ricette. Interpreti principali sono il soprano Susanna Armani, il mezzosoprano Silvia Regazzo, il tenore Matteo Mezzaro, il basso Devis Fugolo, il pianista Bruno Volpato e il Coro Polifonico da camera San Filippo Neri diretto da Ubaldo Composta. Per informazioni: www.amicimusicavenezia.it;
[email protected] ◼
Caricatura di Gioachino Rossini.
A fronte: Lucas Cranach il Vecchio, Sansone e il leone
(1520, in alto) e Cupido e un favo (1537, in basso).
Per il ciclo del 2012 – che si svolgerà nell’Auditorium
«Pollini» di Padova nelle domeniche di ottobre e novembre, sempre alle ore 11 – I Solisti Veneti hanno preparato
un programma ricco e articolato. Il concerto inaugurale avrà
luogo domenica 7 ottobre e sarà intitolato «Per grandi e piccini» con la presenza – accanto all’ensemble diretto da Scimone – di Cecilia Gasdia nel ruolo di voce recitante in Pierino e il lupo di Prokofiev. La Gasdia interpreterà anche due
pagine di Rossini, il Duetto dei gatti e La chanson du bébé.
Il programma (e con esso il ciclo) verrà aperto dal Corsaro,
un’opera di Riccardo Drigo (1846-1930), compositore padovano tuttora celebre in Russia per aver diretto le «prime»
dei più famosi balletti di Čajkovskij.
Domenica 14 ottobre sarà di scena Corrado Augias, che
terrà una conversazione su «Raccontare Verdi» in preparazione del bicentenario verdiano del 2013. I programmi successivi della rassegna comprenderanno – tra le molte altre
proposte – il tradizionale omaggio al massimo genio veneto, Antonio Vivaldi, con l’Opera Quarta «La Stravaganza». Di particolare richiamo ed interesse sarà poi l’appuntamento dedicato ai walzer viennesi di Johann Strauss nelle trascrizioni effettuate per una manifestazione benefica da
Schönberg, Berg e Webern, integrato da walzer di Beethoven, Schubert e Chopin. Per informazioni: www. solistiveneti.it. (l.m.) ◼
Il primo «Concerto della domenica» dei Solisti Veneti.
concerti
borazione dei Comuni di Scorzé, Salzano, Noale, San Donà,
Concordia Sagittaria, Cavallino-Treporti, Santa Maria di Sala, Chioggia e di alcuni enti privati come il Lions Club di Noale, il Rotary club «Noale dei Tempesta», l’Associazione Lirico-Musicale Clodiense.
41
concerti
42
Il «Pierrot Lunaire»
di Schönberg
incanta Padova
d’orchestra olandese più vote presente all’interno delle stagioni musicale degli Amici della musica di Padova.
Ma la proposta del Pierrot Lunaire rimanda anche a un’altra data importante per Padova: quella del 4 aprile 1924,
giorno in cui Schönberg lo diresse nell’ambito dei concerti della «Bartolomeo Cristofori», la società nata nel 1921
di Filippo Juvarra
in stretto collegamento con l’istituto musicale «Cesare Pollini». Schönberg guidò un complesso formato da membri
il 16 ottobre 1912: alla Choralionsaal di Berlidel Quartetto Pro Arte di Bruxelles (che in apertura di prono avviene la prima esecuzione del Pierrot Lunaigramma esegue il Concerto di Alfredo Casella) e da L. Fleure di Arnold Schönberg. L’autore dirige
ry (flauto), H. Delacroix (clarinetto), E. Steuerun complesso strumentale composto da
mann (pianoforte). La voce era quella dell’attriH.W. de Fries (flauto), K. Essberger (clarinetto), J.
ce Erika Wagner (una star dello Schauspielhaus
Padova
Maliniak (violino e viola), H. Kindler (violonceldi Vienna), che, sposatasi poi con il direttore d’orAuditorium
lo), E. Steuermann (pianoforte). La voce è quelchestra F. Stiedry, inciderà in America nel 1951
«Cesare Pollini»
la della cantante e attrice Albertine Zehme (aveil Pierrot – sempre diretto da Schönberg – per la
16 ottobre, ore 20.30
va sposato a Lipsia l’avvocato Felix Zehme), che,
Columbia.
in costume da Pierrot, è accompagnata dal grupIl concerto di Padova del ’24 fu una delle tappo strumentale diretto da Schönberg che si trova invece diepe della tournée italiana del Pierrot Lunaire promossa da
tro un paravento.
Alfredo Casella con la Corporazione delle Nuove MusiEra stata la stessa Zehme a commissionare a Schönberg
che, che Casella aveva fondato assieme a Malipiero e D’Anuna riduzione in musica del Pierrot Lunaire del poeta belnunzio, nel 1924, a Roma. La tournée costituì un momento
ga A. Giraud, nella traduzione in tedesco di O.E. Hartleben.
fondamentale per l’apprezzamento in Italia della musica di
Schönberg trovò la cosa molto stimolante, come annotò nel
Schönberg, che, in occasione di un concerto a Firenze, ebbe
suo diario: «Si va senz’altro incontro a una nuova espressiol’occasione, e l’onore, di avere in sala e poi di conoscere Giane. I suoni diventano qui una espressione addirittura animacomo Puccini. Nel programma di sala preparato per la tourle di moti sensuali e spirituali».
née (con note anche di Vittorio Rieti, che accostò il Pierrot
alla Sagra di Stravinsky) Casella
scrisse: «Il lavoro illustre e singolare che la Corporazione delle
Nuove Musiche
ha l’alto onore di
far conoscere per
prima agli italiani, attraverso le
dieci esecuzioni
di Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Padova, Torino e Milano e
sotto la direzione dell’autore, va
L’entusiasmo di Alberatine fu notevole e così scrisse al maconsiderato con somma, acuta attenzione. Esso costituisce
estro: «Lei trasporta in musica tutti gli ideali della mia fansenza dubbio una delle più audaci “tappe” della moderna stotasia artistica».
ria musicale, nella quale assume un’importanza paragonabiA Berlino la prima esecuzione ebbe un successo incondile a quella dell’avvento del cubismo nella pittura o della teozionato (non sarà così poi a Vienna e a Praga). Era presente
ria della relatività nella scienza».
anche Stravinsky, che scriverà: «Di una cosa mi ricordo con
Recensendo nella «Provincia di Padova» del 5-6 aprile
grande esattezza: la sostanza strumentale del Pierrot Lunaire
1924 il concerto, Renzo Lorenzoni, pianista padovano alliemi impressionò moltissimo. Con “strumentale” io intendevo di Cesare Pollini, animatore della «Bartolomeo Cristofovo allora non solo la strumentazione di questa musica ma la
ri» e docente all’Istituto Musicale, parlò di «un concerto di
struttura contrappuntistica e polifonica complessiva di queraro e magnifico interesse», e scrisse che «la Corporazione
sto stupefacente capolavoro».
delle Nuove musiche che si è assunta l’elevato e difficile comEsattamente cento anni dopo, il 16 ottobre 2012 all’Audipito di portare alla conoscenza del pubblico italiano una deltorium «Cesare Pollini», gli Amici della musica di Padova
le opere più potentemente originali e demolitrici uscite dalriproporranno il Pierrot Lunaire affidandone l’esecuzione al
la moderna musicalità quale il Pierrot Lunaire di Schönberg,
Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli, e alla vopuò andare orgogliosa dei risultati del suo fervore di iniziace di Alda Caiello.
tiva e orgogliose possono pure andarne quelle società di conSi tratta del secondo concerto della stagione 2012-2013 orcerto che hanno voluto offrire ai loro soci questo singolarissiganizzata dall’associazione padovana, che si aprirà il 3 ottomo componimento di battaglia che è anche, rispetto alla cobre con un concerto della Petite Bande di Sigiswald Kuijken
scienza del suo autore, un atto profondo di fede». ◼
(in programma le quattro Suites per orchestra e il Concerto brandeburghese n. 5 di Johann Sebastian Bach) dedicato
A sinistra: locandina della prima esecuzione del Pierrot Lunaire;
al ricordo di Gustav Leonhardt, clavicembalista e direttore
a destra: Arnold Schönberg.
È
Leonard Cohen
in una parola:
«Hallelujah»
U
di Giò Alajmo
na stagione della musica sta certamente finendo, quella che negli anni sessanta e successivi aveva legato la canzone popolare a idee, poesia, creatività, impegno, un modo per allargare la mente con pochi versi, qualche melodia,
nuovi suoni e strumenti e la voglia di cambiare il mondo.
Oggi la canzone sembra tornata sulla strada del puro intrattenimento, la musica si costruisce in laboratorio, le macchine replicano figure ritmiche e armoniche standard e si consuma tutto piuttosto velocemente, senza soffermarsi sulla qualità, né della produzione musicale né dei suoni.
Non si va troppo per il
sottile. I reality producono successi improvvisi quanto effimeri, dalle
voci urlate troppo uguali fra loro, la tv e le radio
non osano uscire dal tranquillo trantran del già
noto, continuando a replicare presenze di personaggi decotti, antichi, ma che garantiscono
non tanto i facili ascolti
quanto la tranquillità di
chi guarda e che può sentirsi rassicurato da nomi fin troppo conosciuti.
E così mentre i giovanissimi consumano mp3 come Cocacola, scaricano
Pulcino Pio e danzano lo
stesso ritmo meccanico
riciclato con qualche coretto in più, quel che resta
della generazione degli
anni sessanta continua a
rivolgersi alla musica della propria epoca, finché l’età non ha il sopravvento sulla vita.
Leonard Cohen è uno dei punti fermi di questa generazione. Cohen è stato tra i primi a cambiare la prospettiva della
canzone moderna. Non più solo futile intrattenimento ma
un piano più elevato di comunicazione. Come Bob Dylan,
il cantautore canadese ha trasformato in canzone la poesia.
Rubo al regista e scrittore Roberto Andò una citazione: ogni
vera rivoluzione politica comincia dal linguaggio, e la poesia
anche se non fa accadere niente – come diceva Auden – è la
lingua in cui far coincidere la passione e la verità.
Se Prèvert con «Les feuilles mortes» aveva mostrato come fondere canzone e poesia, la generazione dei Cohen, dei
Dylan, usa la canzone e la poesia per raccontare passione e
verità. La lingua canzone cambia, smette di essere «canzonetta», intrattenimento anche se ne usa spesso gli stilemi. E diventa una forma di divulgazione popolare di visioni immagini sentimenLeonard Cohen (leonardcohen.com).
ti non banali, non scontati, non scritti per soddisfare i palati
ma per trasferire all’esterno il proprio mondo interiore.
La canzone non è poesia. Lo sappiamo. Ma la poesia nasce
dalla musica e talvolta vi ritorna. La funzione della poesia di
un tempo nella nostra era è stata spesso presa dalla Canzone.
Cohen è un poeta, è un cantante.
A settantasette anni (il 21 settembre) Leonard Cohen
può permettersi di scrivere un nuovo album Old Ideas... e vederlo considerare tra i migliori del 2012. Può permettersi di dire «no, grazie» all’offerta di una laurea honoris causa da parte dell’antica Università di Gent in Belgio («Grazie, molto carini ma non è necessario»), può
permettersi di tornare ancora una volta in Italia per vedere se l’effetto splendido della sua voce bassa e dei suoi versi può vestire anche l’Arena di Verona, dove si esibirà il
24 settembre, con il solito cappello, la solita folta band.
Il poeta che scoprì la canzone grazie a Judy Collins se n’è
innamorato al punto da non riuscire a smettere: «Scrivo in
continuazione. E man mano che le canzoni cominciano ad
aggregarsi, io non faccio altro che continuare a scrivere. Vorrei essere una di quelle persone che scrivono canzoni velocemente. Ma non lo sono. Così mi ci vuole un sacco di tempo per scoprire cosa sia una canzone», ha raccontato a «The
Athlantic».
Il piacere di bere un buon vino nel bicchiere giusto alla giusta temperatura e in buona compagnia è forse la metafora migliore per tradurre un suo concerto. Per fortuna la sua generazione, quella della parola che diverte facendoti pensare, è ancora attiva a dispetto del tempo che passa. Una volta Cohen scrisse: «Vorrei dire tutto ciò che c’è
da dire in una sola parola. Odio quanto possa succedere tra l’inizio e la fine di una frase».
Ma c’è una parola che raccoglie tutto, il titolo di una sua canzone fra le più famose: «HalVerona – Arena
24 settembre, ore 20.30
lelujah!» ◼
l’altra musica
43
l’altra musica
44
I Radiohead approdano
a Villa Manin
con rarissime eccezioni, ancora oggi. In verità né l’album che
contiene «Creep», Pablo Honey, né il successivo, The Bends, riscuotono lo stesso successo di quella sola canzone. La
pressione sul gruppo è molto forte, e anche l’idea che si possa trattare di una one-hit-band complica le cose. Tutte le difficoltà e le perplessità vengono spazzate dalla pubblicazione
di Ok Computer (1997), forse la loro opera migliore. Disco
onirico, visionario, psichedelico, proiettato – già dal titolo
di Giuliano Gargano
– in un futuro fantascientifico pregno di alienazione e paranoia. Il sentimento anti-commerciale è alimentato dalla sceluno dei gruppi più antisistema in circolazione.
ta – in opposizione all’etichetta discografica – del singolo
Poco amanti delle luci della ribalta, dei meccanismi
da estrarre, la suite «Paranoid Android», lunga sette minudel mondo delle major musicali, delle ovvietà. Soti. Ma sono soprattutto «Karma Police» e «No Surprises»
no stati tra i più bravi a dare voce al malessere esia consacrare i Radiohead. La vena malinconica del gruppo è
stenziale della generazione cresciuta tra gli anni
ai massimi livelli, i testi e le melodie sono intrisi
novanta e il primo decennio del duemila. Sono
di spleen di baudelariana memoria. L’intero alquelli che hanno raccolto la rabbia degli ultimi
bum è una summa dei temi cari alla band ingleCodroipo (Ud)
punk, che hanno salvato ciò che c’era da salvare
se, e a distanza di anni mantiene inalterata la sua
Villa Manin
del grunge, e che oggi si riaffacciano sulla scena
ipnotica bellezza. Seguono anni di sperimenta26 settembre, ore 21.30
musicale in un’epoca che sembra fatta apposta
zione, in coerenza con il disprezzo del successo facile. Kid A (2000)
e Amnesiac (2001) rappresentano le due facce
di una stessa medaglia.
Il primo è una raccolta di idee musicali, nelle
quali quasi sparisce l’apporto umano (la voce di
Thom Yorke è fortemente campionata e distorta), il secondo recupera invece l’aspetto melodico e cantato. Si arriva
al 2003 e a Hail To The
Thief, che segna un ritorno a sonorità già sperimentate in Ok Computer. L’album del 2007 –
In Rainbows – resta negli annali soprattutto per le modalità di distribuzione: i Radiohead decidono di metterlo in vendita on-line. Il
prezzo? Lo decidono gli
acquirenti. Abile mossa
pubblicitaria o reale voglia di andare controcorrente? La risposta la coper fare crescere di nuovo la pianta del malessere e della disilnoscono solo loro, visto che non sono mai stati diffusi i dalusione. I Radiohead, gruppo inglese nato a cavallo tra la fine
ti sugli incassi. Siamo ai giorni nostri. Gli Stati Uniti e tutto
degli anni ottanta e l’inizio dei novanta e formato da Thom
il mondo vivono ancora sotto l’ombra dell’attentato dell’11
Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood e
settembre 2001. Il primo decennio del nuovo millennio viPhil Selway, muove con relativa facilità i primi passi. Già alve sotto questa cappa opprimente. E in due virulente tornala fine del 1991 la Emi mette la band sotto contratto. Le prite, la crisi economica tocca tutto l’Occidente. Terreno fertime prove non sono però esaltanti, fino al settembre del 1992,
le per i Radiohead, che avrebbero l’occasione di insistere sulquando viene pubblicato il singolo Creep. È un successo plala precarietà di quest’epoca. Ma The King of Limbs (2011)
netario, che esplode per primo negli Stati Uniti e poi rimbalspiazza ancora: disco compatto (trentasette minuti) e comza nel Vecchio Continente (all’inizio la radio inglese bbc1
plesso, sembra destinato a restringere ulteriormente lo spazio
aveva deciso di non trasmetterla, perché ritenuta troppo dededicato alle concessioni commerciali. La scelta alternativa
primente). È l’inno di una generazione disperata, perduta,
dei Radiohead, sempre più spinta verso la sperimentazione e
indolente, che non vede un futuro davanti a sé. La canzone
la fruizione di nicchia, se da una parte li allontana inesoradiventa croce e delizia dei Radiohead: il brano più richiesto,
bilmente dal grande pubblico, dall’altra li proietta in una dil’esibizione che non può mancare durante i concerti. L’idiomensione che supera l’ambito prettamente musicale e li rensincrasia del quintetto inglese per il successo facile e per l’ide testimoni del nostro tempo. ◼
steria collettiva provocata da quella canzone li spinge a non
eseguirla più nei loro concerti. Una decisione che perdura,
Radiohead, prove prima di un concerto (radiohead.com).
Atteso a Udine il concerto
della band di Thom Yorke
È
ady: si tratta di un genere musicale di provenienza giamaicana, nato ancor prima del reggae come versione rallentata dello Ska. Collabora con artisti legati alla scena filo-giamaicana come Africa Unite e Franziska, con i quali intraprende un
tour europeo. Se però finora è per tutti ancora Maria Chiadi Tommaso Gastaldi
ra Fraschetta, diventerà ben presto Nina Zilli, concentrando
in questo nome d’arte una delle sue cantanti preferite, Nin un mercato discografico dominato da una
na Simone, e il cognome da nubile di sua madre. L’omonimo
parte da dinosauri che continuano imperterriti a venep di sei brani, fra i quali una cover in italiano di un succesdere sempre gli stessi dischi ormai da tempi immemoso delle Supremes («You Can’t Hurry Love», che nella verri e dall’altra da artisti usciti e costruiti dai talent show,
sione italiana diventa «L’amore verrà»), definisce il suono e
che di solito durano una stagione o poco più, la presenza di
l’immagine della cantautrice piacentina, che mescola il soul
Nina Zilli è la conferma che ancora si può riuscire a conquidegli anni cinquanta e sessanta a un’eleganza melodica itastare un proprio pubblico facendo un percorso
liana che guarda molto a Mina (tanto da veniartistico canonico, fatto di studi, esperienze lare soprannominata Mina Zilli) e si esprime visivorative diverse e tanta gavetta. Sacrifici che ha
vamente con una profonda sensualità e un gusto
Verona
imparato a fare sin da piccola, spedita a dieci anper l’immagine immerso nel vintage. La canzoTeatro Romano
ni da una mamma coraggiosa e lungimirante a
ne che la fa notare è «50mila», brano nostalgi7 settembre, ore 20.30
studiare l’inglese in Irlanda. Lasciata la provincamente sixties, registrato con Giuliano Palma:
cia piacentina dove era nata, si ritrova a vivere
il regista Fernan Ozpetek, sempre molto attento
I
con una coppia di arzilli signori a Killala, piccola città del
freddo nord ovest. Sarà un caso ma lì il primo film che vede
è The Commitments!, la geniale pellicola di Alan Parker che
narra le vicende della nascita di un gruppo soul in una Dublino divisa tra il profondo legame con la tradizione musicale dei Chieftains o dei Dubliners e il rock dei Thin Lizzy o
degli U2. Tornata in Italia giusto il tempo di finire le scuole superiori, comincia un viaggio di due anni tra le capitali della musica americana, Chicago e New York, dove prende contatto con la cultura jazz e soul, che forma in maniera forte i suoi gusti musicali. La parte tecnica la apprende attraverso studi di pianoforte, che abbandona poco prima del
diploma, e di canto lirico, che lascia per un’evidente maggior attrazione per altri generi. Inizia così la sua attività nel
mondo dello spettacolo, non direttamente come cantante
ma bensì come vee-jay per mtv. Il debutto discografico avviene nel 2001 con il gruppo Chiara e Gli Scuri, con il quale
abbraccia uno dei generi che maggiormente ama, il rocksteNina Zilli.
nella scelta delle colonne sonore dei suoi lavori, si innamora
del brano e lo sceglie per il film Mine Vaganti del 2010. Il primo disco, Sempre Lontano, porta Nina al suo primo Festival
di Sanremo con «L’uomo che amava le donne», che le vale
il Premio della Critica e della Sala stampa. Da qui in poi sarà
un lungo susseguirsi di concerti in tutta Italia, premi e partecipazioni a manifestazioni nazionali di rilievo, come il concerto del primo maggio del 2010. Nel 2012 è pronta a pubblicare un nuovo disco dal titolo L’amore è Femmina, non
prima però di partecipare nuovamente a Sanremo con «Per
sempre», un lento che prende spunto dalla tradizione musicale italiana degli anni sessanta, soprattutto per le atmosfere sonore che richiamano ancora una volta Mina. «L’amore
è femmina tour» è partito lo scorso aprile e continua ormai
da mesi a girare per tutta Italia: passerà al Teatro Romano di
Verona il 7 settembre nell’ambito di «Venerazioni», festival
musicale tutto al femminile, che ospiterà anche Sarah Jane
Morris, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, e Giorgia, che si
esibirà all’Arena. E chissà che un giorno in Arena non ci sia
spazio anche per Nina Zilli. ◼
l’altra musica
Nina Zilli, l’anima soul
della musica italiana
45
l’altra musica
46
Vinicio Capossela
al Teatro Verde
per Live in Venice
qualche anno eravamo alla ricerca del luogo migliore per accoglierli. Del Teatro Verde avevamo avuto notizie anche da
Fran Tomasi, e abbiamo così deciso di inviare una lettera di
presentazione della nostra agenzia alla Fondazione Giorgio
Cini, nella quale abbiamo trovato un interlocutore curioso
e disponibile. Il programma di luglio ha avuto una gestazione piuttosto veloce, che s’è svolta tra aprile e maggio con l’intenzione di dare alla luce un progetto pilota che ci consentisse di mettere a fuoco alcune questioni, non da ultima la bontà del luogo scelto. Da più parti ci erano infatti giunte voci
che descrivevano il Teatro Verde come un posto bellissimo
di Ilaria Pellanda
ma un po’ isolato. La cautela è stata molta, e alla fine abbiamo però potuto constatare che se le proposte sono interesè grande attesa per l’arrivo in laguna di
santi e ben curate il buon risultato è garantito. Per accogliere
Vinicio Capossela, che il 7 settembre presenal meglio il nostro pubblico, abbiamo anche pensato all’alterà le sue «Ballestimento di un’area relax dotata
late nella barena.
di servizio di ristorazione dove poOmbre, oriente e caìgo», progetter attendere l’inizio dei concerti
Venezia
to speciale che il noto cantautore
fra le note di alcuni dj-set. Gli apTeatro Verde
e polistrumentista italiano – napuntamenti di luglio, per i quali
(Isola di San Giorgio Maggiore)
to in Germania da genitori di oriabbiamo riscontrato molta curio7 settembre, ore 21.00
gine irpina – dedicherà alla Venesità e interesse non solo da parte
«Ballate nella barena. Ombre, oriente e caìgo»
zia porta d’oriente, città magica
dei veneziani ma anche dei turisti,
e specchiante dove le suggestioni
hanno voluto mettere assieme tre
Vinicio Capossela voce, piano, chitarra
dell’altrove trasfigurano nelle omtipi di pubblici diversi, per cercare
Alessandro Stefana chitarre, banjo, armonio
bre e nei veli del «caìgo» (che in
così di capire che tipo di attrattiVincenzo Vasi theremin, campionatori, voce
veneziano sta a indicare la nebbia).
va avrebbe potuto esercitare l’isoDimitri Sillato violino
Si tratta del quarto concerto –
la veneziana. L’ultimo dei tre conGlauco Zuppiroli contrabbasso
dopo i tre che si sono svolti lo scorcerti, quello dei Blonde Redhead,
so luglio – che la
Ponderosa Mu1.
2.
sic & Arts di Titti Santini, in collaborazione con
la Fondazione
Giorgio Cini, ha
in programma
per la prima edizione di L.i.Ve.
(Live in Venice), rassegna di
eventi in musica
ambientati nella cornice unica
e suggestiva del
Teatro Verde,
nel cuore dell’Isola di San Giorgio Maggiore.
«La Ponderosa è specializzata
nella progettazione e organizzazione di rassegne e concerti di musica jazz,
world music e
musica d’autore internazionale», ci ha spiegato Santini, «e
anche per questo
abbiamo pensato che Venezia
fosse la cornice
ideale per i no3.
stri eventi. Da
Si conclude un’estate
di grandi artisti a San Giorgio
C’
1. Teatro Verde (Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia);
2. Rufus Wainwright (rufuswainwright.com);
3. Blonde Redhead (blonde-redhead.com).
4. Vinicio Capossela in concerto (viniciocapossela.it);
5. Stefano Bollani (foto di Riccardo Sgualdini);
6. Paolo Fresu (paolofresu.it).
del Teatro Verde: nell’anfiteatro che più accoglie le istanze
della laguna, di fronte ai terreni tabulari delle barene che ora
appaiono e ora scompaiono, Capossela allestirà il suo ennesimo incanto. Un programma di ballate e canzoni, madrigali di porto e di bàcaro, distillati di melodie ottomane, armene, bizantine; e poi ancora la morna e i bolero riportati dalla
risacca, gli inni dei marinai del grande mare salato. Durante la Mostra del Cinema (dal 29 agosto all’8 settembre, cfr.
5.
6.
vmed n. 47, pp. 60-61) verrà inoltre presentato il docu-film
di Andrea Segre (il cui lungometraggio Io sono Li, presentato alla scorsa edizione del festival veneziano dedicato alla
settima arte, continua a ricevere importanti riconoscimenti ed è stato scelto tra i tre finalisti del Premio lux del Parlamento Europeo), pellicola prodotta da Jole Film che narrerà il viaggio di Vinicio in una Grecia martoriata dalla crisi economica mondiale e alla quale Capossela ha dedicato il
suo Rebetiko Gymnastas, disco che, uscito lo scorso giugno,
è più di un omaggio a quella terra che «ha donato al mondo
la civiltà». ◼
l’altra musica
ha visto coinvolto un pubblico più giovane rispetto a quello
presente alla data di Ludovico Einaudi e Paolo Fresu e a quella di Rufus Wainwright. Le risposte ai tre eventi sono state
tutte positive».
La prima parte della rassegna L.i.Ve. si è dunque aperta il
18 luglio con il concerto di Ludovico Einaudi e Paolo Fresu, appuntamento che, a cinque anni di distanza dalla prima estemporanea e applauditissima apparizione all’Auditorium di Roma (era l’aprile
del 2006), ha proposto an4.
cora una volta il connubio
tra questi due protagonisti
della nostra musica, che al
Verde hanno fatto il tutto
esaurito.
Anche la serata dedicata a Rufus Wainwright il
20 dello stesso mese – unica data italiana – ha potuto contare su un notevole afflusso di spettatori, accorsi ad ascoltare le note del
suo settimo album in studio, Out of the Game, lavoro prodotto da Mark Ronson, conosciuto per le sue
collaborazioni con artisti del calibro di Amy Winehouse, Adele e Christina Aguilera. I risultati di
quest’ultimo album portano a una musica più accessibile rispetto a precedenti produzioni della carriera
di Wainwright, mantenendo comunque inalterato il
suo spiccato senso narrativo e ironico.
Il 21 luglio è stata la volta dei Blonde Redhead, attesissimi dal pubblico più
giovane, come ci ha confermato poche righe fa lo stesso Santini. Penny Sparkle,
ultimo cd in studio, propone un’ulteriore inversione sonora nel loro già intricato percorso artistico, una
sorta di chiusura di quel
cerchio tracciato a partire
da Misery Is a Butterfly (sesto album della band, pubblicato nel 2004) e consistente nell’oramai definitivo assestamento del gruppo americano su sonorità
di un pop elettronico liquido ed etereo.
L’appuntamento è ora con la seconda parte della rassegna,
che il 7 settembre – così si scriveva in apertura di articolo –
vedrà approdare Vinicio Capossela nelle magiche atmosfere
47
l’altra musica
48
Slash:
un nuovo progetto
e un po’
di Guns N’ Roses
ni in cui il successo è decretato dai passaggi video su mtv, e
l’immagine del gruppo passa attraverso i video di Welcome
to the Jungle, Paradise City e Sweet Child O’Mine. I Guns N’
Roses diventano il nutrimento musicale delle trasgressioni
adolescenziali di quegli anni. L’anno successivo esce G N’ R
Lies, disco che contiene materiale di poca qualità, scritto precedentemente al primo album, fatta eccezione per la ballata
acustica «Patience». L’apice arriva nel 1991 con l’uscita di
Use Your Illusion i e ii, due dischi venduti separatamente ma
di Tommaso Gastaldi
uniti dai contenuti e dalla grafica di copertina: il numero di
copie vendute è enorme, anche grazie a una promozione che
ualche anno fa, nella sua autobiografia, ha
investe fiumi di denaro. Il video November Rain, con i suoi
candidamente ammesso di averlo rubato. Non
otto minuti conditi da un lunghissimo assolo, ancora oggi
per un impulso clepto-maniacale ma solo perrimane uno dei più costosi della storia. L’estenuante «Use
ché gli sembrava perfetto per
Your Illusion Tour» durò ben tre anni, tocquello che aveva in mente. In
cando ogni angolo del globo a dimostrazione
un negozio qualsiasi di Los Angeles, l’ha vidella popolarità che i Guns avevano raggiunsto addosso a un manichino, l’ha sfilato ed è
to in quegli anni. Terminata la tournée, iniPadova
uscito. Da quel giorno, con quel cilindro alla
zia anche l’inesorabile declino: i continui proGran Teatro Geox
Mandrake e i riccioli neri a nascondergli il viblemi dei vari membri con l’eroina e l’alcol e
26 ottobre, ore 21.00
so, è diventato Slash, il chitarrista più famoso
le innumerevoli intemperanze di Axl avevano
degli anni novanta, il guitar hero che ha suominato il già fragile equilibrio all’interno del
nato con Lenny Kravitz, Iggy Pop e Michael Jackson, tanto
gruppo. La pubblicazione dell’album di cover The Spaghetti
per citarne qualcuno, lui che con un gruppo chiamato The
Incident segna la fine dell’epopea dei Guns N’ Roses, benché
Cospirators, guidato dal cantante Gibson Les Paul, è divennegli anni a venire Axl Roses abbia provato più volte a rimettato protagonista di un vendutissimo videogioco. Oggi si
tere insieme la band con altri musicisti.
presenta con Myles Kennedy alla voce in un tour
Slash è ora libero di seguire i propri
mondiale che toccherà Padova il 26 ottobre.
progetti musicali: il primo a nasceCon questa formazione ha da poco pubre è il gruppo Slash’s Snakepit, con
blicato anche l’album Apocalyptic love:
cui pubblica due album: It’s Fitredici pezzi di puro hard rock che pove O’Clock Somewhere del ’95
co si allontanano da quel suono che lo
e Ain’t Life Grand del 2000.
ha portato a un livello di celebrità plaPoi è la volta dei Velvet Revolnetaria con i Guns N’ Roses. Non si può
ver, in cui convogliano parte
scindere Slash dalla band che ha segnato
dei Guns e che per iniziare inciin maniera così decisa la storia deldono una cover di «Money» dei
la musica, dei concerti e dell’inPink Floyd: con loro Slash pubdustria discografica tra la fiblica l’album Libertad, nel 2007.
ne degli anni ottanta e la meLondinese di nascita ma cresciuto a Los
tà degli anni novanta. L’arriAngeles, si è guadagnato il denaro per la
vo di Saul Hudson (questo il
sua prima chitarra partecipando e vincensuo vero nome) nei Guns N’
do numerose gare di bmx, ma c’è da diRoses passa attraverso una
re che ha bazzicato l’ambiente dello
breve permanenza nei Roshow business sin da piccolo: il paad Crew di Steven Adler,
dre era un grafico e aveva disegnato
con i quali aveva militacopertine di dischi per artisti come
to anche il bassista Duff
Neil Young e Joni Mitchell, mentre
McKagan. Come spesla madre era una delle stiliste preso accade in questi caferite da David Bowie. Casi, per una fortuita serie
pitava a volte che Pamela
di coincidenze nel giro
Courson, modella e
di pochi mesi si ritrovaamica della madre,
no a suonare con Izzy
facesse da babysitStradlin e Axl Roses,
ter al piccolo Saul.
il fondatore dei Guns
Pamela, Pam, era
N’ Roses. Messi sotla compagna di un
to contratto da una
certo di Jim Morricasa discografica e
son e fu proprio lei a
con un produttore
trovare il Re Lucerdi livello, nel 1987
tola morto nella vaviene alla luce Apsca da bagno del lopetite for Destrucro appartamento di
tion e inizia così la
Parigi il 3 luglio del
velocissima asce1971. Ma questa è
sa dei Guns N’ Roun’altra storia. ◼
ses nell’olimpo del
rock. Sono gli anSlash (slashonline.com).
Q
questo, a tutta la storia del jazz prima del bebop).
Con la svolta rock di Miles, anche Herbie si adegua, non solo formando band che portano spesso i nomi degli album incisi (Mwandishi e Head Hunters) per un jazz elettrico fundi Guido Michelone
keggiante, ma arrivando persino a scalare le classifiche del
pop con «Rockit», vera e propria hit contenuta nell’album
arà forse un’occasione irripetibile poter
Future Shock, dall’accattivante ritmo techno accompagnato
ascoltare, il 23 ottobre al Teatro Comunale Giusepda un fortunatissimo videoclip ipertecnologico. In Hancock
pe Verdi di Pordenone, il pianista Herla qualità maggiore resta però quella imprevedibie Hancock, in solo e dal vivo: il granbile di stupire ogni volta il pubblico, ragion per
dissimo jazzman, settantaduenne chicagoano,
cui mentre tutti si aspettano il bis nel pop, ecco
Pordenone
da annoverare nel Pantheon del sound afroamel’artista ribadire la vena di jazzista puro, peraltro
Teatro Comunale
ricano, è solito cimentarsi alla tastiera da circa
già anticipata dal progetto di The v.s.o.p. QuinGiuseppe Verdi
mezzo secolo in qua, passando dallo Steinway
tet, in pratica il gruppo modale di Davis senza
23 ottobre, ore 20.30
grancoda ai marchingegni elettronici, privileMiles, all’epoca gravemente malato.
giando soprattutto i piccoli ensembles, dal duo
Herbie insomma, allineandosi a giovani coal sestetto.
me Wynton Marsalis, riprende la bella forma del modernNegli ultimi tempi, poi, ogni concerto di Hancock è l’ocjazz, sia pur aggiornandola continuamente, ad esempio accasione per ascoltare quel jazz neomoderno (ma anche postcettando il «gioco», come ai tempi del ragtime, di una sfida
moderno, come egli stesso contribuisce a divulgarlo fin daa due, fra lui e Chick Corea, altro eccellente pianista davisiagli anni ottanta) che lo vede protagonista accanto ai più bei
no. E a proiettare ulteriormente Hancock nell’Olimpo munomi dello scenario artistisicale c’è anche il cinema:
co-musicale. A comprendela colonna sonora che firre il valore di Herbie compoma per il lungometraggio
sitore, a soli ventidue anni, è
Round Midnight di Beranzitutto il cubano Mongo
trand Tavernier è un affetSantamaria, che popolariztuoso omaggio al Blue Noza in tutto il mondo il brate Style e all’aureo mainno «Watermelon Man»,
stream che venti-trent’anun ballabile esempio di soulni prima mette d’accordo
jazz; altrettanto farà il regitutti, dal revival al pre-free.
sta Michelangelo AntonioEcco quindi la musica di
ni, che, un lustro dopo, gli
Hancock scorrere piaceaffida la colonna sonora (anvolmente tra sempre nuovi
cora soul-jazz) di Blow Up,
progetti – Village Life con
film-culto di un’intera gel’africano Foday Musa Sunerazione e simbolo della
so è world music in netto
swingin’ London.
anticipo – che mantengoMa a valorizzarne il genio
no una sorta di vivace diapianistico è il divino Miles
lettica tra passato e presenDavis, che lo vuole nel suo
te, attualità e futuro, riquintetto accanto a Wayne
cerca e tradizione, come si
Shorter, Ron Carter, Tony
evince dall’ascolto dei diWilliams, dal 1964 al 1969,
schi dell’ultimo ventenin quella che resta la formanio, The New Standards,
zione più compatta, prolifiGershwin World, Future 2
ca, inventiva non solo del geFuture e Directions in Muniale trombettista ma forse
sic, benché i più riusciti sidell’intera storia dei piccoli
ano da un lato 1+1, negli
gruppi. Negli anni di Davis,
intensi duetti con Shorter,
Hancock ha pure la chance
e dall’altro River: The Jodi firmare da solista album
ni Letters, un sincero trisopraffini come Mayden
buto alla cantautrice Joni
Voyage e Speak Like a Child,
Mitchell. Dice Hancock:
che lo consacrano jazzista as«È utopia pensare che un
sai originale, in grado di asproblema sparisca? No: è
similare e fondere il modautopia pensare che sparisca
le, il free e l’hard-bop con sisenza il nostro impegno.
cura padronanza ed eleganCi sono un sacco di cose
te sperimentalismo, che riche dobbiamo sviluppare:
marranno un po’ le due cola compassione, il coraggio,
stanti del suo linguaggio stila saggezza. E il senso di relistico, non senza però qualsponsabilità. Ma la parola
che strizzatina d’occhio alche racchiude tutto questo
lo show business (fedele, in
è: umanità. Bisogna essere
più umani. Più veri». ◼
S
Herbie Hancock.
l’altra musica
Herbie Hancock
in piano solo
49
l’altra musica
50
«E noi faremo
come la Russia…»
vuole sparir. / Scrive la traccia sicura / di un grido strozzato
che non sa morire. / Con mano ferma decisa / è scolpito da
anni padrone assassino, / la tua forza è l’inganno / la Breda ci
insegna che deve finir».
Nel 1954 l’occupazione della fabbrica Breda di Portomarghera diede vita a una serie di scontri che culminarono in una
manifestazione durante la quale la polizia sparò sul corteo degli operai ferendone uno in maniera molto grave. Gli operai si
riversarono in piazza San Marco, guidati dal sindaco comunista Gianquinto, che reggeva la camicia insanguinata del ferito, e dai principali dirigenti dei partiti della sinistra. Nella nostra città la memoria di quei fatti ha scavato un solco indelebile. Con i versi sopra riportati l’ho ricordata vent’anni dopo:
la scritta nera era ancora ben leggibile su un muro della Giudecca: l’hanno definitivamente cancellata i restauri di questi ultimi anni.
«Che cosa fa quel Mario Scelba / con la sua celere questura /
ma i comunisti non han paura / difenderanno la libertà /…».
Il ministro degli Interni Scelba fu il simbolo di questo periodo di violenza e repressione. Il battaglione Celere da lui istituito fu attore principale di numerosi scontri, ma la manovra
certamente più diretta e, dal suo punto di vista, più efficace fu
l’allontanamento degli iscritti alla cgil da tutti i luoghi che
potessero avere un qualche interesse strategico per quella che
fu denominata «guerra fredda». Sempre a Venezia duecento «arsenalotti» furono repentinamente licenziati; tra que-
La canzone comunista
di Gualtiero Bertelli
A
ffrontando l’ultimo dei grandi repertori
della canzone politica in Italia, quello comunista,
viene spontaneo chiedersi: «Ma quanto “fastidio”
potevano dare queste canzoni a un potere che di
fatto gestiva tutto con la selezione dell’elettorato, con il controllo di ogni fonte di produzione, con l’esercito sempre all’erta. Come potevano far breccia su un popolo tenuto nell’ignoranza da un sistema agrario e capitalistico tra i più arretrati
d’Europa e dalla connivenza della Chiesa?»
Nel 1963 Michele L. Straniero e Sergio Liberovici furono
denunciati assieme all’editore Einaudi per aver pubblicato un
libro di Canti della Nuova Resistenza Spagnola, cioè canti nati
in clandestinità durante il lungo periodo della dittatura franchista. L’accusa: offesa a capo di Stato straniero. Il feroce dittatore Franco! Nel 1964 poi lo stesso Straniero fu denunciato per aver cantato al festival di Spoleto una strofa «proibita» del canto «Gorizia» nato nelle trincee della prima guerra mondiale. Offesa alle forze armate! Entrambi i casi, dopo
1.
anni, si risolsero in altrettante assoluzioni, ma ci confermano che anche in un’Italia percorsa dal miracolo economico, ai
primi passi tra i Paesi democratici, la canzone politica, con il
suo linguaggio semplice e diretto, faceva paura. Eppure tutti
gli organi d’informazione, escluso qualche giornale, suonavano all’unisono il canto del potere.
«Ignoranti, senza scuole, / calpestati dai padron / eravam
la plebe della terra / in risaia come in una prigion. / … / Ma i nemici hanno armi / di menzogna e corruzion: / han giornali, cinema e la
radio / che difendono i profitti dei padron. /
Ma noi donne è un gran faro / che c’illumina
il cammin…»
Così cantavano le mondine all’inizio degli
anni cinquanta; la Repubblica Italiana, nata
dalle ceneri del fascismo, faceva fatica a rispettare la Costituzione che si era data, ricorrendo
spesso a metodi largamente sperimentati dal
vecchio regime per mettere a tacere il dissenso.
Sono di quegli anni le grandi lotte per il lavoro
e per la riforma agraria che insanguinarono le
piazze e le contrade del nostro Paese.
«Sul muro di casa mia / una pece nera non
2.
3.
4.
sti anche mio padre. Fu riconosciuta la persecuzione politica
vent’anni dopo.
Se tutto ciò accadeva nella Repubblica fondata sul lavoro, è
facile intuire quale fosse il clima nel momento in cui il fascismo stava prendendo il potere e nasceva il Partito Comunista d’Italia.
«Fascisti e comunisti giocavano a scopone / ma vinsero i fascisti con l’asso di bastone…».
«Sapete chi ha incendiato la camera del lavoro? / Chiedetelo ai fascisti ve lo diranno
loro…»
Non fa neanche tempo a nascere il Partito
Comunista che lo scontro con i fascisti diventa
diretto e totale, non solo nelle canzoni.
Il legame con il canto anarchico e socialista risulta subito evidente, ma il linguaggio è più diretto e la prospettiva rivoluzionaria sempre più
spesso evocata. Inoltre, man mano che il potere fascista si rafforza e il quadro internazionale si chiarisce, la scelta di campo filo-sovietica si
fa più esplicita e viene sempre più spesso invocata nei canti.
zando spesso più l’ironia che l’invettiva, poiché il fascismo ai tempi di Starace era sì feroce, ma nello stesso tempo ridicolo e grottesco.
«Quando bandiera rossa se cantava / co
trenta franchi al mese se magnava / adesso che se canta giovinessa / se va in leto co la
debolessa…».
«Quando vedrai Petacci in bicicletta / vuol
dire che Benito l’è in bolletta / … / quando
vedrai brillar la stella rossa / vuol dire che Benito è nella fossa».
«Benito, Benito, / ti n’à ciavà puito / ti n’à calà la paga / ti
n’à cressuo l’afito».
Canti come questi godevano anche di una notevole diffusione, almeno nelle regioni del nord, tant’è che ne esistono versioni analoghe in dialetti diversi.
Il primo bersaglio, dopo la liberazione e all’indomani della
7.
5.
sta propaganda. Nel ‘28 per esempio si attribuisce al bolscevismo ogni aspirazione delle donne alla loro emancipazione:
«Il bolscevismo la donna l’applica / ma vuol mangiar, vestir,
goder / e lavorar non ne vuol saper / Il bacio che ti dà ben caro fa pagar / tutto per essa e niente a te / questo è l’effetto che
fa il soviet».
Quando poi i nostri esuli politici incominceranno a riparare all’estero, in particolare in Francia, ancora la canzone di regime ne darà un’immagine fosca e terrorizzante:
«Lungi dal confini consacrati / fuori usciti e rinnegati /
stanno benon. / Parlano, complottano adunati, / con i piani preparati / d’insurrezion. / E s’addorme ognun come un
eroe / sopra il motto della Liberté. / Sogna / l’Italia messa
alla vergogna, /il Quirinale conquistato / col drappo rosso
inalberato...».
Dall’altra parte gli antifascisti che dopo le leggi speciali vengono incarcerati o condannati al confino, fanno sentire come
possono la loro voce:
«Mi avete incatenato e non fa niente / vostro mestiere è fare
gli aguzzin, / mi avete bastonato crudelmente / siete pagati a
fare gli assassin. / Son comunista e questo lo sapete / ed il mio
cuore è pien di ribellion / ma voi sbagliate se credete coi martìri di fiaccar / questa mia fede di rivoluzione».
Come il fascismo si consolida al potere, voci come questa diventano più flebili e clandestine, la protesta sotterranea, ricorrendo spesso alla parodia di canzoni in voga, come abbiamo visto parlando di Spartacus Picenus. È il modo attraverso
il quale si riesce a far circolare le idee, le parole d’ordine, utiliz1. Michele L. Straniero; 2. Pietro Nenni; 3. Palmiro Togliatti; 4.
Giobatta Gianquinto; 5. Alcide De Gasperi; 6. Benito Mussolini;
7. Mario Scelba (fondazionegiannipellicani.it).
6.
fine dei governi di unità nazionale, è il nuovo partito di potere, la Democrazia Cristiana, e i suoi principali rappresentanti:
«Con De Gasperi alla testa / non si mangia la minestra /
noi vogliamo un altro capo / che mantenga l’unità. / E con de
Gasperi non si va – e non si va / l’è contro noi lavorator – lavorator / vogliam Togliatti / Nenni i capi del lavor. / … / E De
Gasperi in pignata / e Stalin al ghi fa fuoco / e Togliatti tasta
il brodo / se l’è zevat o salà».
Dopo questo periodo eroico, che arriva fino ai primi anni
sessanta, la canzone politica prende un nuovo impulso grazie
al lavoro di ricercatori e autori che sono stati spesso argomento di altri articoli su questa rivista.
Nelle raccolte di canti che sono state realizzate da allora sino a oggi le nostre canzoni sono state spesso riportate come
«canti comunisti». Faccio fatica a inquadrare come tale, per
esempio, «Nina ti te ricordi», però è vero che la maggior parte di noi militava in gruppi e partiti della sinistra oppure se
ne sentiva parte ideologicamente. Ma le canzoni hanno incominciato a respirare un’aria di libertà ideale che ci ha permesso di percorrere itinerari diversi e diversificati, anche perché
ben diversa e diversificata è diventata negli anni la «sinistra»
a cui ci siamo riferiti.
La diffusione della canzone sociale avvenuta negli anni settanta ha prodotto decine di gruppi musicali e Canzonieri che
hanno ripreso e riproposto questi repertori, che hanno composto nuove canzoni, spesso legate a situazioni di lotta nelle
fabbriche, nei campi, nella scuola, nella società.
«Alle sbarre qui di Reggio / ogni giorno si sta peggio / i
bambini mezzi nudi / hanno un prato di rifiuti / l’immondizia per giocare / l’epatite per morire / qui la gente ha la rabbia /
di chi cresce in una gabbia» (Canzoniere delle Lame 1971) ◼
l’altra musica
Questo si verificò già all’indomani della vittoria dei Soviet.
Sempre le mondine, punta di diamante del
movimento bracciantile, nel 1921, a conclusione della lunga battaglia per le otto ore,
cantavano:
«Se otto ore vi sembran poche / provate voi
a lavorar / e proverete la differenza / di lavorare e di comandar. / E noi faremo come la Russia / chi non lavora non mangerà /e quei vigliacchi di quei signori / dovranno loro lavorar».
Speranze come quelle evocate dal canto compariranno per
molti anni nell’innodia comunista, almeno fino a quando il
pci non incomincerà a prendere le distanze da Mosca.
La minaccia bolscevica nelle mani della propaganda fascista diventa un’efficace arma di propaganda, e le canzoni, spesso tratte dall’avanspettacolo o dalle riviste, danno voce a que-
51
arte
52
Giuseppe Capogrossi
secondo
Luca Massimo Barbero
Scuola Romana, si arriva, attraverso un breve momento cosiddetto neocubista, alla produzione astratta degli anni cinquanta e sessanta, con le grandi tele dominate dalla formasegno che, coniugandosi in infinite composizioni, giunge a
costruire lo spazio del quadro, rappresentazione simbolica di
una interiore organizzazione spaziale. Le opere di Capogrossi sono dominate da quell’innovativo «alfabeto» che ha reso celebre l’artista, e in esse si fa sempre più chiara l’impora cura di Ilaria Pellanda
tanza del segno che caratterizza in modo assolutamente personale la sua ricerca.
a Collezione Peggy Guggenheim si prepaDi tutto questo, e di molto altro ancora, ci parla Luca Masra a rendere omaggio a Giuseppe Capogrossi (1900simo Barbero, che abbiamo incontrato in una torrida matti1972), uno dei protagonisti assoluti della scena arna di agosto.
tistica del secondo dopoguerra, il
«In questa esposizione è innanzitutcui segno inconfondibile, così come il geto ravvisabile una sorta di continuità con
sto di Lucio Fontana e la materia di Alberun certo tipo di “studio” che vado perseVenezia
to Burri, ha lasciato una traccia indelebile
guendo da un po’ di tempo e che si concenCollezione Peggy Guggenheim
nella storia dell’arte italiana del xx secolo.
tra, nel mio lavoro con la Collezione Pegdal 29 settembre 2012
Sarà Luca Massimo Barbero, curatore asgy Guggenheim, nella volontà di far scoprial 10 febbraio 2013
sociato della Collezione veneziana, ad avere
re al pubblico, non solo nazionale ma anpreziosa cura di una mostra che porta avanche internazionale, i protagonisti del noti la linea d’indagine perseguita attraverso le recenti persostro dopoguerra, forse uno degli aspetti che maggiormente
mi colpisce della storia dell’arte protocontemporanea. Do-
L
nali dedicate ad Adolph Gottlieb, Lucio Fontana, William
Baziotes, Jackson Pollock, Germaine Richier e Richard Pousette-Dart, e incentrata sull’emblematica generazione d’artisti internazionali il cui linguaggio pittorico nasce e matura
negli anni del collezionismo di Peggy.
Capogrossi. Una retrospettiva, realizzata in collaborazione
con la Fondazione Archivio Capogrossi di Roma, intende
ripercorrere l’iter artistico del maestro romano portando in
scena oltre settanta opere: partendo dagli esordi figurativi
degli anni trenta, contraddistinti da una pittura tonale densa di contenuti originali che si snoda durante il periodo della
po Fontana e insieme a Burri – anche se quest’ultimo non lo
abbiamo ancora celebrato con una vera e propria antologica
– Capogrossi è il terzo grande protagonista del dopoguerra
italiano; e se Fontana è il gesto e Burri la materia, Capogrossi è sicuramente il segno. Si tratta di un autore con il quale
tutti pensiamo d’avere grande confidenza, perché il suo simAlcune opere di Giuseppe Capogrossi.
A sinistra, Superficie 210 (1957, olio su tela, 206.4 x 160 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York).
A destra, Superficie 137 (1955, olio su tela, cm 195 x 160
collezione privata, courtesy Galleria Tega, Milano).
A sinistra, Il Temporale (1933, olio su tela, 108 x 90 cm
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna).
A destra, Sole di Mezzanotte (1952, olio e tempera su tela , 98,5 x
66 cm Collezione Maramotti, Reggio Emilia);
(tutte le immagini: © Giuseppe Capogrossi, by SIAE 2012).
elemento che lui considerava invece come qualcosa di sospeso, astratto e quasi metafisico. A mio parere si tratta di un elemento dotato di una forza originale e straordinaria che, in
un qualche modo, nelle composizioni di Capogrossi va a determinare lo spazio: un elemento quindi tutt’altro che grafico e decorativo ma, piuttosto, strutturale, dalla forza quasi morale. Capogrossi parlava addirittura del bisogno di realizzare, in un momento come quello del passaggio immediato dal secondo dopoguerra, qualcosa che fosse in grado di rimuovere l’idea di semplice realismo.
Che dialogo viene a instaurarsi tra le opere in mostra?
L’allestimento è molto semplice e avrà una parte iniziale
che dagli anni trenta arriverà alla metà dei quaranta: si tratta
di una sezione di galleggiamento, una zona particolarmente scura dove i quadri verranno illuminati in una sorta di sospensione buia del tempo. Poi esploderà il caso-Capogrossi
legato all’astrazione e tutto diverrà chiaro, bianco, contemporaneo, salvo ogni tanto incontrare delle pareti blu, quel-
lo stesso colore che nel ’54 la Biennale utilizzò per presentare le nuove opere nella prima sala che Capogrossi ebbe per i
suoi lavori astratti. La volontà è quella di provare a capire come l’artista già nel figurativo cercasse di lavorare a uno spazio molto ricco e però quasi bidimensionale, a un’idea di prospettiva diversa che non tralasciava un certo tipo di rapporto con la geometria. Verrà poi raccontato il viaggio a Vienna
degli anni quaranta, lo studio delle finestre, che in realtà sono delle persiane e che narreranno delle cose molto curiose.
Insomma, abbiamo costruito un filo rosso che permetterà di
scorgere in che modo quest’uomo leggesse la natura, la realtà.
Come dicevo, è da tantissimi anni che non si rivede «fisicamente» Capogrossi, un pittore molto raro e tuttavia forse il più noto all’estero, fra gli italiani, negli anni cinquanta
e sessanta. Essere riusciti a radunare così tante opere rende
quest’occasione davvero unica. ◼
arte
bolo è così famoso da essere immediatamente riconoscibile.
In realtà è un pensiero che si basa su fondamenta tutt’altro
che solide: non sono state realizzate molte esposizioni dedicate a questo artista romano, e una monografia come quella
che presenteremo in occasione dell’esposizione che si aprirà il 29 settembre – che, fra le altre cose, darà alla luce ben
undici saggi – non viene stampata da trenta o quarant’anni.
Una mostra anche di studio, dunque, che ben rappresenta
una delle peculiarità delle esposizioni da me curate.
Da dove provengono le opere? Ci saranno solo lavori su tela o
anche su carta?
La maggioranza delle opere scelte saranno su tela, ma ce ne
sarà anche qualcuna su carta. Sarà esposta la grandiosa tela
acquisita nel 1958 dalla Fondazione Solomon R. Guggenheim di New York, Superficie 210 (1957), avremo quadri che
vennero presentati durante le Biennali di Venezia e ci sarà un
lavoro del ’33 che non torna in Italia da quella data e che arriverà dal Centre Pompidou di Parigi; poi ancora dipinti da
Roma, da Rovereto e da quasi tutti i musei italiani più importanti. La mostra ha una peculiarità che sorprenderà molto, in quanto prenderà il via da alcune opere figurative degli
anni trenta: spesso dimentichiamo che, in quel periodo, Capogrossi fu uno dei fondatori – con Corrado Cagli, Emanuele Cavalli e pochi altri
– della Scuola Romana,
e proprio per
questo le prime stanze saranno dedicate alla ricerca svolta su
tela in quegli
anni. Vi sarà
poi una sezione ancora più
sorprendente
dal punto di
vista filologico, quella che
narrerà il passaggio, fra il
1946-’47 e il
’50, dal figurativo al cosiddetto non
figurativo. La
mostra, che esporrà anche il grande arazzo che il maestro eseguì per il transatlantico Michelangelo (si trovava nella parete
di prua del soggiorno di quello che fu l’ultimo transatlantico costruito per la Società Italiana. La nave rimase in servizio
per soli dieci anni, dal 1965 al 1975, prima di essere posta in
disarmo per via delle ormai insostenibili perdite economiche
del servizio passeggeri, ndr), sarà suggellata da un video inedito – realizzato con Zenit e della durata di quindici minuti
– che racconterà la storia del famoso segno di Capogrossi, di
questo «elemento», come lui lo chiamava.
In molti lo chiamano «la forchetta»…
In realtà Capogrossi ha sempre sostenuto che non significasse quasi nulla e soffriva molto dell’oggettivazione di un
53
IL RIDOTTO
d i Venezia
★ ★ ★ la prima rivista in rete ★ ★ ★
★ ★ ★ di attualità culturali ★ ★ ★
★ direttore editoriale - roberto bianchin ★
★ direttore responsabile - luca colferai ★
●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●
www.ilridotto.info
[email protected]
●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●◉●
quello che gli altri non scrivono lo scriviamo noi
Pubblicato da «I Antichi» Editori - Venezia
Registrazione presso il Tribunale di Venezia 172/10 n. 3 del 29 gennaio 2010
c.f. p.i. 03631220278
creatività, il suo carattere stravagante e anche la sua immensa erudizione. Questi lavori, di enorme attualità, rispecchiano le inquietudini dell’uomo del suo tempo, in un momento
nel quale l’Illuminismo e la ragione convivono con la stregoneria e la magia. Fu il figlio Giandomenico a pubblicare per
la prima volta l’opera incisoria del padre dopo la sua scomdi Eva Rico
parsa, e già nel titolarla ci diede la chiave di lettura: Giambattista, facendo uso della sua incredibile immaginazione,
on «Tiepolo Nero. Opera grafica e matrici inriunisce i bizzarri protagonisti delle sue incisioni in maniecise» arrivano in laguna, dopo essere state espora appunto capricciosa, scherzosa, fantasiosa. Osservando le
ste al m.a.x.museo di Chiasso e all’Istiopere in mostra emergono elementi ricorrenti come
tuto nazionale per la Grafica di Roma, le
il fascino dell’inesplicabile e del misterioso, un’inincisioni dei Tiepolo: i Capricci e gli Scherzi di fantatima riflessione sul declino, un continuo riferimenVenezia
sia di Giambattista e la serie della Fuga in Egitto del
to alla morte, e anche la volontà di esprimere al masCa’ Rezzonico
figlio Giandomenico. Ma soprattutto, per la prima
simo la propria creatività in opposizione all’accadefino al 14 ottobre
volta esposte al pubblico, alcune delle matrici in ramismo e lontano della retorica autocelebrativa della
me che le hanno generate, restaurate dalla massima
decorazione di palazzi, ville e chiese.
autorità italiana in materia: il citato Istituto nazionale per la
Nella deliziosa serie della Fuga in Egitto poi, se da un laGrafica di Roma.
to ancora una volta Giandomenico dimostra la sua bravura come disegnatore anche nella difficile arte dell’incisione,
dall’altro si distingue per la delicatezza con cui rappresenta
la Sacra Famiglia: una giovane Madonna che appare sempre
serena e addirittura sorridente, sostenendo amorosamente
il bambino fra le braccia ma dedicando anche teneri sguardi
C
L’interpretazione delle trentacinque acqueforti di Giambattista Tiepolo, divise nelle due celebri serie note come Capricci e Scherzi di fantasia, ha occupato diverse generazioni di
critici, eruditi e studiosi dell’arte: vi si ritrovano infatti maghi, satiri, soldati, astrologhi, filosofi, giovani uomini e donne e, immancabile, pulcinella, inseriti in paesaggi con piramidi e are decorate con mascheroni e bucrani, popolati da cani, asini, scimmie, capre, gufi e serpenti, teschi e ossa, e dove addirittura la morte in persona concede udienza. Giambattista, molto richiesto dai grandi dell’epoca per la decorazione delle loro sfarzose residenze con enormi e coloratissimi affreschi celebrativi della propria condizione e delle proprie gesta, realizza in privato queste incisioni, che non erano
destinate al mercato. In tali opere, di evidente perizia tecnica e stilistica, Tiepolo esprime al massimo la sua sconfinata
Uno Scherzo di Giambattista Tiepolo
e una scena della Fuga in Egitto del figlio Giandomenico.
allo sposo, metre Giuseppe fa strada girando continuamente gli occhi per assicurarsi di avere lasciato indietro il pericolo o che gli amati moglie e figlio lo seguano, aiutati e accuditi da solleciti angeli.
Ma l’incredibile maestria e inventiva dei Tiepolo si vede
soprattutto nelle matrici in rame da poco restaurate: sono
immagini spesso direttamente concepite e incise sulla lastra,
dove con grande abilità le figure vengono modulate con segni lievi e producono sorprendenti effetti di chiaroscuro e di
profondità, dosando saggiamente le morsure dell’acido o facendo più fitto il disegno per catturare maggiore quantità di
inchiostro. Oltre ad alcuni esempi delle lastre che danno origine alle Fantasie e agli Scherzi già menzionati, si possono
gustare la deliziosa Adorazione dei maghi di Tiepolo padre e
un’interessantissima serie di lastre con studi di teste portati
a termine dal figlio Giandomenico.
La possibilità di confrontare le matrici in rame con le acqueforti costituisce una rara e imperdibile occasione di approfondire lo studio della parte meno nota della produzione artistica dei Tiepolo. La mostra, nata dalla collaborazione
delle diverse istituzioni già ricordate in apertura, è stata curata da Lionello Puppi e Nicoletta Ossanna Cavadini, che firmano anche il catalogo edito da Mazzotta. ◼
arte
A Ca’ Rezzonico
l’opera grafica
dei Tiepolo
55
cinema
56
Un ritratto
di Francesco Rosi,
Leone d’oro
alla carriera 2012
l cinema di Francesco Rosi, Leone alla carriera
della Biennale alla lxix Mostra di Venezia quasi mezzo secolo esatto dopo il Leone d’oro vinto con Le mani sulla città, appartiene ad una stagione e ad un’epoca culturali e storiche che, benché ci appaiano oggi remotissime, quasi arcaiche, fanno invece parte della nostra contemporaneità: anzi, la sostanziano, la innervano e le conferiscono un valore altrimenti destinato a disperdersi nei volatili fluidi dell’effimero o nella volgare precarietà del nostro
presente.
ri, italiani e stranieri, da Rod Steiger a Frank Wolff, da Alberto Sordi a Josè Suarez da Lino Ventura a – soprattutto
– Gianmaria Volonté, che diventerà di fatto l’attore-feticcio delle «drammatizzazioni» di Rosi, metamorfizzandosi
da autentico, incredibile camaleonte in una serie di ruoli reali o immaginari (Enrico Mattei, Lucky Luciano, il tenente
Ottolenghi di Uomini contro, il Cristof Bedoya di Cronaca di
una morte annunciata) che divengono specchi e maschere di
altrettante narrazioni incise sanguinosamente nella storia.
Una formula, quella del film-inchiesta, con la quale Rosi anticipa di parecchio le pulsioni ribellistiche del cinema
militante postsessantottino dei Bellocchio, Faenza, Taviani, Samperi, Cavani, peraltro rimanendo costantemente fedele ad un rigore linguistico e narrativo che non esclude affatto, anzi, la chiarissima scelta di campo civile e ideologica del regista, ma nemmeno vuol rinunciare alle potenzialità drammaturgiche del racconto cinematografico, persuaso
al contrario che proprio in queste trovi ancora maggior linfa e forza la voce insopprimibile della denuncia e della battaglia delle idee.
In realtà nel cinema del regista partenopeo è costante una
Era quello che si chiamava «cinema di impegno civile»,
con una ridondanza che oggi muove al sorriso: quasi potesse esistere una forma di «impegno incivile» o una qualsiasi forma di civiltà fondata sul disimpegno. Sia chiaro: esiste
fortunatamente anche ai nostri giorni, trasmessa nelle forme più varie, una vena di cinema italiano diversamente «engagé», battagliero, di denuncia, di documentazione, di indignazione: o sub specie docu-satirica (Videocracy, Draquila) o di docudrama ben più duro (Diaz) o di fiction grottesca
(Il divo) o di ricostruzione storica non convenzionale (L’uomo che verrà), per non citare che alcuni titoli. Ma il cinema
di questo gentiluomo napoletano d’altri tempi, colto e raffinato, popolare senza mai essere populista, ha occupato l’intera seconda metà del Novecento con caratteristiche del tutto proprie e irripetibili: in testa a tutte, l’invenzione di quel
particolare genere chiamato «film-inchiesta», a cominciare da Salvatore Giuliano del 1962, che – lungi dal rifarsi a
cascami neorealisti – coniugava un approccio documentale,
cronachistico, investigativo su fatti e aspetti tra i più scabrosi e scottanti dell’Italia di quegli anni con una ricostruzione romanzesca, squisitamente narrativa e avvincente, fondata sull’utilizzo strepitoso ed efficacissimo di grandi atto-
meditazione analitica più vasta e profonda sulla Storia come
palcoscenico spesso crudele della condizione umana e delle sue contraddizioni, non solo sociali e politiche ma anche
psicologiche ed esistenziali, ravvisabile sin dalle prime esperienze come sceneggiatore per il maestro Luchino Visconti (La terra trema, Senso); essa permette a Rosi di espandere la propria ricerca narrativa anche in altre direzioni, oltre
a quella del film-inchiesta e del docu-drama, spesso e volentieri appoggiandosi a testi letterari fondativi del Novecento, ma in ogni caso essenziali alla riflessione storica del regista, come nel caso di La tregua di Primo Levi, progetto già
accarezzato nei primi anni ottanta ma poi sospeso per il suicidio dello scrittore e portato a termine solo nel ’97 (rimane il suo ultimo film), o di Cronaca di una morte annunciata (1987) di Gabriel García Marquez, o di Cadaveri eccellenti (1976) di Leonardo Sciascia, o ancora di Cristo si è fermato
a Eboli (1979) di Carlo Levi. Inoltre, l’irrefrenabile curiosità intellettuale dell’autore lo ha portato più di una volta verso digressioni stilistiche e di genere apparentemente di difficile decifrazione o in conflitto con l’anima più rigorosa e severa della sua opera, come nel caso della fiaba all-star C’era
una volta (1967), con Sofia Loren e Omar Sharif, girata qua-
I
di Roberto Pugliese
di guerra, film-opera) alla ricerca persistente di un contatto
quanto più possibile immediato con il pubblico.
Francesco Rosi è infatti un cineasta «popolare», quando la parola non equivaleva ancora ad un insulto, ed è nello stesso tempo un cineasta di élite, selettivo, dal linguaggio,
dal lessico non sempre facilmente accessibili, e dallo sguardo spesso profetico. Quasi mezzo secolo prima di Gomorra,
scende con il suo esordio da regista in proprio La sfida (1958)
nei vicoli della nativa Napoli per raccontare con durezza e
asciuttezza ma anche con immensa umanità, grazie alla penna della grande e spesso a lui vicina (così come Tonino Guerra) Suso Cecchi d’Amico, una storia di camorra, di amicizia
e di famiglia. E l’anno dopo, con I magliari, aspra tragicommedia su malavita e immigrazione, è tra i pochissimi a cercare con successo di sfruttare al massimo le (esilissime) doti di
Alberto Sordi come attore drammatico. Ma è con Salvatore
Giuliano e Le mani sulla città (1962 e ’63) che Rosi declina
perentoriamente le generalità del proprio cinema di denuncia e di ricerca, iniziando a chiamare con nome e cognome
alcune delle più inquietanti zone d’ombra della nostra storia
recente: il primo, con una geniale struttura a flashback, rievoca la vicenda del bandito separatista siciliano autore della
strage di lavoratori di Portella della Ginestra, della sua morte violenta nel 1950 e delle collusioni già vivissime fra mafia
e ambienti reazionari; il secondo, forte di una drammaturgia ferrigna, squadrata, semidocumentaristica, affonda il bisturi nello scandalo della speculazione edilizia e nell’abbraccio mortale tra malaffare, apparati dello Stato e malavita. Le
apparenti digressioni di Il momento della verità (1965), girato in Spagna e storia di un contadino che per sfuggire alla miseria affronta il destino dell’arena, e del già citato C’era una volta, prelude al trittico-Volonté Uomini contro,
Il caso Mattei (Palma d’oro a Cannes nel ’72) e Lucky
Luciano: sorta di Orizzonti di gloria italiano il primo,
da Un anno sull’Altipiano di
Emilio Lussu, straziante ancorché un po’ enfatico anatema pacifista, ritratti in piedi gli altri due di un antieroe
dell’imprenditoria italiana e
di un gangster sui generis, entrambi con fortissimo spirito d’indagine sui retroscena,
i misteri e le aree oscure dei
rapporti fra potere, finanza e
politica. Se Cadaveri eccellenti cala ancora una volta l’argomento mafioso in una tipica
atmosfera sciasciana da incubo insolubile e kafkiano, Cristo si è fermato a Eboli e il successivo Tre fratelli (1981) dimostrano una nuova fase creativa del regista, più intima e
personale, memorialistica e
lirica, letteraria e pacata ma,
come attesta la già ricordata
trasposizione marqueziana
dell’87, non meno intransigente. Dimenticare Palermo,
del ’90, robusto film di mafia
aggiornato ai tempi, con Jim
Belushi, Vittorio Gassman, è
una nuova imperiosa dimostrazione di vitalità così come, dopo Diario napoletano, amaro e disilluso ritorno documentaristico nella realtà napoletana a trent’anni da Le mani sulla città, lo è ancor di più La tregua (1997), in cui le pagine implacabili di Primo Levi si decantano in un racconto intriso di sfumature e sottigliezze,
dove l’atrocità dell’argomento non conosce né la retorica né
gli stereotipi di tanto coevo cinema sulla Shoah.
In tutto questo percorso, coerente e di straordinaria compattezza pur nella diversità dei risultati, il faro ispiratore di
Rosi è sempre rimasto quello dell’approfondimento, della
perlustrazione, dell’indagine pubblica e privata. Un maestro di cinema e di coscienza civile, in sintesi, per il quale «il
momento della verità» non è mai sterile esercizio memorialistico o passato da archiviare, ma irrinunciabile viatico per
un futuro migliore. ◼
cinema
si provocatoriamente proprio alla vigilia del rovente Sessantotto o, nell’84, di un colorito e ipernaturalistico adattamento della Carmen di Bizet, con Julia Migenes-Johnson, Placido Domingo e Ruggero Raimondi.
Si evincono bene da questi dati la complessità e la ricchezza della personalità di Francesco Rosi e il valore, la potenza rappresentativa del suo cinema e del suo modo di incidere nella realtà e nelle sue varie raffigurazioni, anche spettacolari. Non va infatti mai dimenticato che Rosi è anche, forse soprattutto, un formidabile uomo di spettacolo in senso il
più ampio possibile: dal teatro di prosa all’opera lirica, dalla fiction al documentario, ogni forma di messinscena lo attrae e lo stimola. Pertanto, l’efficacia documentale, sociale e
ideale del suo cinema non prescinde – al contrario – dall’impianto narrativo ma vi si integra, utilizzando stilemi di vari
generi (gangster movie, melodramma, commedia, noir, film
57
letteratura
58
«Se ti abbraccio
non aver paura»,
storia di un padre
e un figlio
S
di Mariano Beltrame
i dice che gli scrittori cerchino storie. Ogni
tanto le storie li scovano. In entrambi i casi bisogna
scriverle. Possibilmente bene.
Se ti abbraccio non aver paura racconta una storia
vera: il viaggio che un padre, Franco, compie nell’estate del
2010 con un figlio. Sbarcano a Miami, partendo da Treviso,
affittano una Harley Davidson e tagliano gli usa da costa a
costa. Poi saltano in Messico, attraversano il Centro America e finiscono ad Arraial d’Ajuda, in Brasile.
La solita vacanza? Sì, se Andrea, figlio di Franco, sedici anni, non fosse un ragazzo autistico. Allora è, come minimo,
una vacanza complicata. O forse non è una vacanza. Forse
c’è qualcosa di più.
L’autismo viene spesso descritto come mancanza di relazione con gli altri, comportamenti stereotipati, scarsa autonomia personale. Portare in viaggio un ragazzo autistico implica imprevedibilità, difficoltà di gestione, grandi sforzi di
comunicazione.
Una gran fatica, per decine e decine di migliaia di chilometri. Perché, allora, un simile sforzo? Per dimostrare che cosa?
Il romanzo ci racconta di un padre che, contro il parere di
medici e amici, decide di partire, di far vedere un po’ di mondo al figlio autistico, convinto che questo abbia un effetto
«curativo» superiore al tenerlo in qualche stanza, oppure
sulla spiaggia di Jesolo. E in questo «cibarsi del mondo»,
questo cambiare continuamente sfondo, si produce un’incredibile intimità tra padre e figlio, si rafforza un legame: affrontare assieme mille intoppi, e superarli, produce l’effetto
positivo di essere capaci di agire e non subire.
Ecco, il romanzo contiene il resoconto degli sforzi di adattamento a una situazione complessa, l’amore che il padre deve mettere in campo per stare, ogni giorno, a contatto con
la mente autistica. Nell’era della comunicazione, l’autismo
rappresenta una sfida: significa difficoltà di interpretare desideri, emozioni, le poche parole e confrontarsi con la ripetitività delle azioni, nella scelta del cibo, nei riti quotidiani.
È un mondo fatti di colori, un periodo rosso e poi uno verde; di suoni in sottofondo, musica sempre e ovunque, talvolta ad alto volume e altre volte appena sussurrata; di acqua
che scorre, come nei fiumi, o acqua in cui immergersi, come
nei laghi, o di onde oceaniche dove lasciarsi cullare, per ore
e ore. Senza sosta.
La storia arriva all’autore quasi per caso. Il padre, Franco,
tornato dal viaggio sente di dover raccontare l’esperienza e
cerca qualcuno che lo aiuti. Racconterà allo scrittore, per undici mesi, i suoi ricordi di viaggio, le emozioni, le riflessioni. L’autore raccoglie ogni dettaglio e per un altro anno lavora pazientemente alla composizione del romanzo. Scritto in prima persona, diventando il padre narrativo di Andrea. Perché questo romanzo è anche una storia di padri. Ce
n’è bisogno. ◼
Una conversazione
con Fulvio Ervas
Q
uali sono state le motivazioni del padre per questo
viaggio: raccontare un’avventura speciale, far conoscere di più l’autismo, dare una lezione di vita a tutti i genitori?
Franco potrebbe averlo fatto per tutte queste cose messe
assieme, perché sono connesse: per mettere nero su bianco
un’esperienza personale molto forte; perché voleva che suo figlio uscisse da quella «terra di nessuno», come dicono molti genitori di figli autistici; perché i genitori che non vivono
una relazione così complessa potessero vedere. O forse niente di tutto questo, perché potrebbero essere solo ipotesi razionali che facciamo noi. Forse solo un bisogno di libertà, istintivo, potente, che non si ferma nemmeno davanti all’autismo e, anzi, lo sfida. Ogni tanto, fuori dagli schemi, si respira.
È stato difficile misurarsi con una storia vera come questa? E
cosa pensa di aver detto, nel libro, ad Andrea?
Misurarsi con un pezzo di vita vera, diretta, vestirla con le
parole della narrazione è stata una grande esperienza. Ci sono stati molti momenti del viaggio che mi hanno colpito ed
emozionato, anche divertito, perché si sorride spesso nel racconto. Nonostante la malattia, il viaggio non è stato un salto
nel buio: piuttosto una sequenza di voli che puntavano verso
il cielo. Ed è stato un viaggio anche per me, fatto di tante tappe personali: la mia genitorialità, il mio lavoro di insegnante,
le esperienze con studenti complicati, anche autistici. Raccontare la storia di Franco e Andrea è stato mettersi in un incrocio dove confluivano strade provenienti da lontano. Andrea è pieno di sfumature, alle volte davvero sottili: quando
affiorano le emozioni è come assistere al cambiamento di forma delle nuvole. Quello che ho potuto dirgli, sta tutto nel libro: Andrea, la vita è «un po’ sì».
Qual è la chimica della sua vita e della sua scrittura?
Zucchero come preferenza alimentare, orto come sfondo visivo, niente fumo, molto movimento, ironia, guardare
avanti e vedere la vita come un flusso, un metrò dove si sale e
si scende, lasciando il posto a qualcuno senza averlo sporcato e la scrittura è una pagina bianca, nessun progetto, solo invenzione improvvisa, una mattina silenziosa, un paio di cani che gironzolano pigramente e poi la sensazione di un’onda che prende le singole parole e le trascina lontano. Ecco, la
scrittura è un’onda con la schiuma.
Sta già pensando al suo prossimo libro?
Se riesco a prendere fiato, un’avventura dell’ispettore Stucky in Dalmazia. Forse… (m.b.) ◼
Fulvio Ervas (caligola.it).
N
di Ilaria Pellanda
ella suggestiva cornice della Casa dei Tre
Oci – splendida testimonianza dell’architettura
veneziana di inizio Novecento che sorge sull’isola della Giudecca, al centro del bacino di San
Marco, in una zona di eccezionale interesse storico, artistico
e monumentale – si svolgerà in autunno la seconda serie di
alcuni workshop dedicati alla fotografia.
Il disegno fa parte di un progetto siglato tra la Fondazione
di Venezia, la sua società strumentale Polymnia (proprietaria della splendida Casa progettata nel 1910 dal pittore Mario De Maria), Civita Tre Venezie e la Fondazione Forma in
collaborazione con Veneto Banca.
Le proposte formative promosse ai Tre Oci sono da considerarsi parte integrante di un progetto culturale ed espositivo più ampio e fortemente legato allo stretto rapporto fra
arte e immagine, che immerge gli studenti che decidono di
prendere parte a queste iniziative in un vero e proprio laboratorio di idee.
«La Casa dei Tre Oci si candida a essere un punto di riferimento a Venezia e in Italia per quanto riguarda il tema
delle arti visive e della contemporaneità», sottolinea Denis
Curti, direttore scientifico della Casa veneziana. «Abbiamo
quindi deciso di realizzare un progetto che da una parte desse spazio alle esposizioni vere e proprie – l’inaugurazione è
avvenuta con la mostra di Elliott Erwitt Personal Best (cfr.
vmed n. 46, pp. 60-61) – e dall’altra a tutta una serie di attività di studio del linguaggio visivo esplorato secondo molteplici declinazioni. Nel caso dei due workshop realizzati prima dell’estate e di quelli che avranno luogo in autunno, ci si
è concentrati sul linguaggio fotografico».
Il primo laboratorio, intitolato «Nudo in Laguna» e volto alla scoperta della bellezza femminile, è stato condotto da
Settimio Benedusi, uno dei più importanti fotografi di moda, che ha guidato un gruppo di appassionati in un percorso
progettuale sul tema dell’estetica.
Il workshop «Storia della Fotografia» s’è invece svolto in
un ciclo di quattro incontri durante i quali Italo Zannier ha
tracciato un racconto per immagini sulla storia della fotografia, appunto, dall’Ottocento ai giorni nostri. La narrazione è stata integrata con l’analisi e l’illustrazione di alcuni volumi – che fanno parte della collezione della Fondazione di
Alcuni momenti del workshop «Nudo in laguna»
condotto ai Tre Oci da Settimio Benedusi
lo scorso marzo (foto di Silvia Pasquetto).
Venezia – in un dialogo costante che Zannier ha tenuto con
gli iscritti per far loro conoscere e comprendere gli sviluppi e
l’evoluzione dell’arte fotografica.
Dopo la pausa estiva, con l’arrivo dell’autunno ricomincerà anche l’attività laboratoriale. A cavallo tra i mesi di settembre e novembre, infatti, prenderanno il via altri tre workshop, il primo dei quali, intitolato a «Fotografia e Cinema», sarà condotto dalla regista Marina Spada e dal fotografo Cesare Cicardini, che si dedicheranno ai nuovi linguaggi
della tecnologia contemporanea, tra immagini still e motion.
«Mi sembrava molto interessante amalgamare il lavoro di
questa regista con quello di Cicardini» – continua Curti –
«senza dimenticare che nel suo penultimo film, Come l’ombra (2007, ndr), la Spada aveva chiesto la consulenza di Gabriele Basilico per realizzare i punti macchina, le inquadrature fisse, ancora una volta a ribadire il suo grande interesse
nei confronti della fotografia».
Sarà quindi la volta di Francesco Jodice e del suo «After
The West. Fotografie e urbanesimo sul finire dell’Occidente». Dagli scontri di Teheran a quelli siriani, passando per
le «rivolte dei gelsomini», il ruolo delle immagini sarà analizzato in relazione a nuovi e drammatici scenari, tra un paesaggio urbano-umano modificato e la rinascita del regime
del visibile.
«Figlio del grande maestro Mimmo Jodice, Francesco
svolgerà una riflessione sul tema della contemporaneità che
si declinerà attraverso un’indagine quasi poliziesca sul territorio: un ricercare che farà dello strumento fotografico non
un mero congegno visivo che cattura ciò che l’occhio vede,
ma piuttosto un mezzo che mette in scena la realtà cercando
di recuperare tutti i linguaggi e tutte le mediazioni possibili
con l’arte contemporanea».
L’ultimo appuntamento è quello con «L’oggetto fotografico» di Alberto Prandi per una due giorni che consentirà ai
partecipanti di acquisire confidenza con i metodi di identificazione dei procedimenti fotografici e la loro puntuale storicizzazione, interrogandosi sul consistente patrimonio di
scatti accumulato nel tempo e sulla necessità di far partecipare all’opera d’arte materiali evocativi per i loro riferimenti temporali.
«Il terzo workshop – conclude Curti – vuole ribadire il
rapporto con il territorio: la Casa dei Tre Oci viene a tessere
un rapporto con le Università veneziane cercandone la complicità e mettendo a disposizione i suoi spazi per svolgere alcuni corsi e per ospitare gli studenti. Questo è solo l’inizio di
un programma che si svolgerà con queste modalità anche nel
prossimo futuro: continueremo a realizzare mostre di fotografia ma anche workshop e incontri con i protagonisti della contemporaneità, che non è assolutamente detto apparterranno al mondo della fotografia in maniera esclusiva». ◼
fotografia
Nuovi workshop
ai Tre Oci
59
in vetrina
60
Venezia tra salvaguardia
e contemporaneità
Una conversazione
con Renata Codello
P
a cura di Leonardo Mello
ur nel caldo afoso di questo agosto Renata Codello, Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Venezia e Laguna, accetta gentilmente di rispondere a qualche domanda sulla nostra città,
dal punto di vista artistico e
culturale ma non solo.
Prima di tutto vorrei chiederle qual è lo stato generale
del patrimonio artistico veneziano, e quali sono, secondo lei, gli interventi prioritari da effettuare.
Direi buono. I colleghi
di Firenze e Roma ci fanno i complimenti soprattutto considerando l’altissimo numero di visitatori
della città dove tutto è storico. I turisti ormai arrivano ovunque e quindi anche
i problemi della tutela cambiano di scala. Con una
battuta: tutto è prioritario
a Venezia. Intendo dire che
l’approccio conservativo è
una modalità di pensare e
di agire: talvolta restaurare
un portone in legno è importante quasi quanto l’intera facciata di un palazzo.
Comunque, basta confrontare le campagne fotografiche degli anni settanta e ottanta per vedere quanto sia
migliorata la città. Per altro verso, non si fa mai abbastanza: la straordinaria
bellezza dei luoghi contrasta con tutto ciò che è sciatto e degradato.
Quali sono, a suo parere,
gli esempi più riusciti di architettura contemporanea
realizzati a Venezia in questi ultimi anni?
Tengo a sottolineare che a
Venezia ci sono molti esempi di architettura contemporanea: la città storica per
eccellenza è un luogo ideale per la nuova architettura. I progetti più riusciti sono quelli che dialogano con la storia, ma
non rinunciano a esprimere il pensiero progettuale di oggi:
l’ampliamento del cimitero monumentale di David Chipperfield, la biblioteca della Manica Lunga alla Fondazione
Cini di Michele De Lucchi, la punta della Dogana di Tadao
Ando, l’ampliamento delle Gallerie dell’Accademia di Tobia
Scarpa. Talvolta, le nuove architetture hanno bisogno di un
po’ di tempo per integrarsi ma, in generale, il livello è molto
più alto che in altre città.
Nello specifico, e sempre parlando di architettura contemporanea, come si è strutturato il progetto di ampliamento delle Gallerie dell’Accademia, e quali sono state le fasi più
importanti?
Il complesso della Carità, che ospita le Gallerie, riunisce
l’architettura tre-quattrocentesca della chiesa e della Scuola della Carità, uno straordinario edificio di Palladio, e una
lunga manica ottocentesca realizzata da Francesco Lazzari. Occorreva conservare le fabbriche esistenti, rigenerare gli
spazi deturpati dagli usi passati, realizzare sistemi impian-
tistici molto avanzati e, al contempo, mantenere l’aura dei
luoghi e offrirla ai nuovi visitatori. Un percorso lungo, minuzioso, in cui Tobia Scarpa ha disegnato migliaia di dettaAmpliamento delle Gallerie dell’Accademia: un disegno
di Tobia Scarpa e il rendering dello spazio espositivo nell’ala Selva
(soprintendenza.venezia.beniculturali.it).
In alto: la Punta della Dogana. Sopra: la Manica
Lunga della Fondazione Cini (cini.it).
A destra: la facciata delle Gallerie dell’Accademia.
metropoli «giornaliera» e, quindi, lavorare su modelli diversi di sostegno a tutti gli abitanti. Trovo giusto che il prezzo del biglietto turistico sia alto. Per tanta bellezza, dovrebbe esserlo ancora di più.
Data la situazione di crisi generalizzata, e la conseguente
scarsità di finanziamenti pubblici, qual è secondo lei il modo
migliore per attrarre fondi privati da destinare alla salvaguardia del nostro patrimonio?
La condivisione delle responsabilità. Lo Stato non può
pensare di mantenere questo sterminato patrimonio, deve
condividere con i privati l’impegno della sua conservazione
ma non solo a parole. Si dovrebbero sperimentare modalità diverse di collaborazione, valutandone poi i risultati e, alcuni, ci sono già. Un complesso sistema di norme allontana qualche buona intenzione dei privati, ma questi ultimi sono spesso improvvisati. L’attività di salvaguardia è un lavoro serio, culturale, scientifico e tecnico; soprattutto non è fatta dagli articoli dei giornali. Gli operatori delle soprintendenze restano
sempre i più competenti in questi settori. ◼
in vetrina
gli che, come le tessere di un mosaico, sono tutte uniche nel
concorrere alla qualità del progetto. Anche le soluzioni tecnologiche come la climatizzazione o il sistema di illuminazione degli ambienti e delle opere d’arte sono stati molto importanti. Alla fine il Museo avrà dodicimila metri quadrati
di superficie, poco più degli Uffizi, realizzati con grande perizia esecutiva.
In un’intervista di qualche tempo fa, lei diceva che a beneficiare dei flussi turistici sono soltanto alcune categorie, e continuava affermando che una
tassa d’ ingresso indistinta e per tutti non le sembrava una soluzione adeguata.
Come si dovrebbe affrontare dunque il problema della
sostenibilità di questi flussi?
L’art. 9 della Costituzione dice che la Repubblica
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutti i
cittadini ne fruiscono ma,
appunto, è un patrimonio,
un bene comune. Se alcuni lo usano come fonte di
guadagno, devono trovare
– più di altri – i modi per
contribuire a mantenerlo
disponibile per tutti. Troppo spesso si dimentica che
il patrimonio storico non
è una risorsa inesauribile,
che la città si usura, si deteriora e non si può restaurare all’infinito. Per quanto
riguarda i flussi turistici, il
problema è molto complicato, mi piacerebbe che venisse affrontato sul serio e
senza pregiudiziali.
Spesso si sente dire dai visitatori, non senza ragione,
che Venezia e i suoi abitanti non sono molto accoglienti
e ospitali (a cominciare dai
trasporti pubblici, sovraffollati e carissimi). D’altro
canto i residenti vivono talvolta situazioni di oggettivo disagio. Pensa che si possa
trovare un modo per coniugare le esigenze di chi viene a scoprire la città e quelle di chi la vive quotidianamente?
Penso di sì ma, anche in questo caso, andrebbero superati
molti luoghi comuni. Veneziani sono i cittadini che hanno scelto di abitare qui, che amano e rispettano la città. L’iscrizione o meno
all’anagrafe non è un parametro significativo.
Va introdotto il concetto di «abitante equivalente» che vive in città almeno cinque giorni alla settimana anche se non ha la residenza. Per altro verso, se il disagio degli abitanti, a fronte del gran numero di turisti è reale, dobbiamo pensare che Venezia è come una
61
in vetrina
62
Le «Voci
Fuori Campo»
della Fondazione
Pellicani
tori, giuristi, giornalisti e politologi per aiutarci a capire il
presente e a immaginare il futuro. Un concentrato di personalità di altissimo livello che non ha eguali in questo momento in Italia. Accanto a Massimo Cacciari, presidente della Fondazione Pellicani, che fin dall’inizio ha creduto fermamente in questo progetto, interverranno tra gli altri Gustavo Zagrebelsky, Dacia Maraini, Stefano Rodotà, Angelo Panebianco, Massimo Giannini, Corrado Augias, Massimo Donà, Ilvo Diamanti, Silvia Avallone e altri ancora. Un
significato particolare assume la presenza delle donne. Tutte le giornate del Festival saranno aperte da appuntamenti al
femminile. Come ha evidenziato Cacciari «il pensiero delle
di Nicola Pellicani*
donne, oggi poco presenti nella politica, permetterà di geta presenza del Presidente della Repubblitare uno sguardo disincantato sull’oggi offrendo suggestioca Giorgio Napolitano al Festival della Politica, in
ni importanti per costruire un futuro rinnovato». Particoprogramma a Mestre dal 5 all’8 settembre tra piazlarmente significativo è poi il laboratorio didattico rivolto
za Ferretto e piazzetta Pellicani, costituisce il moagli studenti delle scuole superiori, animato da alcuni docenmento più alto di una manifestazione concepita per riporti del liceo scientifico Giordano Bruno di Mestre, che sarà attare l’attenzione sul pensiero politico, sul ruolo e
tivo nel corso del Festival a villa Settembrini (sede
sull’importanza strategica della politica nella sodella Fondazione Pellicani). Gli studenti la matticietà contemporanea. In una fase così complessa
na avranno l’opportunità di prepararsi agli inconMestre
caratterizzata da un clima di preoccupante disaftri della giornata incontrando alcuni dei relatori.
vari luoghi
fezione per la politica e più in generale di sfiducia
La Fondazione ha fortemente voluto una sezione
5-8 settembre
nei confronti dei partiti e delle istituzioni, il Festidedicata ai ragazzi nella convinzione che è fondaval, alla sua seconda edizione, intende contribuimentale cercare di avvicinare i giovani alla politica.
re a ritrovare il bandolo della matassa della Buona Politica e
Solamente se i giovani iniziano a occuparsi di politica e a stuin questo senso la figura del Presidente, per il ruolo e il prediare la politica, avremo la possibilità di favorire un ricambio
stigio internazionale che ha saputo ritagliarsi in questi anni,
della classe dirigente, un tema non più rinviabile. Non a caso
rappresenta il punto di riferimento più significativo da cui
questo sarà uno degli argomenti affrontati durante il Festival. Proprio Cacciari, assieme a Emanuele Macaluso e al giovane studioso
Alessandro Aresu, parlerà di «Parricidio e Infanticidio».
«In politica», ha ricordato Cacciari, «i figli devono uccidere i padri
per prendere il loro posto, altrimenti non c’è vero ricambio di classe dirigente. In realtà continua a non avvenire, semmai in Italia abbiamo assistito a fratricidi». Seguendo la metafora
i figli dagli anni sessanta in poi si sono
eliminati tra di loro. Un tema particolarmente caldo in questo periodo, a
pochi mesi dalle elezioni politiche. La
carne al fuoco sul braciere della politica è molta, ma tutto ruoterà attorno
al discorso del Presidente della Repubblica dal titolo «Le nuove mappe della
politica in Italia e in Europa». È probabile che l’intervento del 6 settembre al Teatro Toniolo di fatto detterà
l’agenda politica d’autunno che si preannuncia alquanto complicata. Già in
un’altra occasione Napolitano, ospite
della Fondazione Pellicani, pronunciò
un discorso molto importante, in occasione della celebrazione del sessanripartire. L’intervento del Presidente sarà il filo conduttore
tesimo anniversario della Costituzione, organizzato a Palazdel Festival, la lezione permetterà di riordinare le parole delzo Ducale a Venezia. In quell’occasione lanciò un messaggio
la politica dando loro un senso e una gerarchia. Sarà un conmolto forte alle forze politiche per riformare in senso fedetributo determinante per riannodare i fili, partendo da conralista la seconda parte della Carta.
cetti fondamentali come giustizia, libertà, equità.
Con la visita del 6 settembre è la quarta volta che il PreTutti temi che saranno poi al centro degli incontri e dei diasidente Giorgio Napolitano partecipa a un’iniziativa della
loghi in programma durante il Festival che vuol essere un anFondazione Pellicani. Fu Napolitano a inaugurare la Fontidoto all’antipolitica dilagante.
dazione Pellicani il 27 marzo 2007, tornò il 18 settembre
Per una volta non saranno politici a parlare di politica: la
2008 per il convegno a Palazzo Ducale e venne poi il 2 setFondazione Pellicani ha chiamato a raccolta filosofi, scrittembre 2010 a inaugurare piazzetta Pellicani. Il 6 settembre
Giorgio Napolitano ospite d’onore
del Festival della Politica
L
zione culturale che dura dodici mesi all’anno e si focalizza su
tre filoni principali. «Idee per Mestre», che si concretizza in
convegni, studi, seminari e sono state date alle stampe diverse pubblicazioni. Qual è la struttura economica e sociale della città in cui viviamo? Chi sono i suoi residenti? Quali ruoli
svolgono Mestre e Venezia all’interno dell’area vasta? Quali le opportunità di sviluppo? Queste alcune delle domande
Sopra e a fronte: alcuni momenti
dell'edizione 2011 di Voci fuori campo.
In alto: Giorgio Napolitano ospite della Fondazione Pellicani.
alle quali «Idee per Mestre» cerca di rispondere, attraverso
ricerche mirate, ponendosi l’obiettivo di agire come catalizzatore delle forze intellettuali cittadine per portare riflessioni approfondite sulla città stessa. Un filone quindi dedicato
alle politiche urbane, agli intrecci e agli interventi rivolti al
perseguimento dell’efficienza e di misure ispirate a innalzare la qualità della vita dei cittadini.
Altro filone è la «Grande Politica e il Futuro dell’Italia»
che quest’anno arriva alla sesta edizione, una serie di incontri
che rappresentano un momento di riflessione, fuori da stere-
otipi e luoghi comuni, sui grandi temi della politica italiana e internazionale. Ad oggi sono intervenuti relatori quali Giuliano Amato, Lucio Caracciolo, Piero Ignazi, Renzo Guolo, Antonio Martino e Ilvo
Diamanti, Giorgio Ruffolo, Alberto Melloni, Guido Bodrato, Rino Formica, Rosy
Bindi, Claudio Petruccioli e molti altri.
Il terzo strumento è l’Atlante storico
politico veneziano pensato per orientarsi in cinquant’anni di storia politico-amministrativa ed econonica che hanno mutato profondamente il territorio veneziano, non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche nella sua composizione sociale, nelle popolazioni che lo abitano, nei
modi e nelle forme politiche che ha espresso. Il lavoro in corso è strutturato in diversi punti, si avvale sia di fonti archivistiche che orali e si svolge in collaborazione
con diversi enti ed istituzioni. Oltre a diverse pubblicazioni ha dato vita al progetto «Archivi della politica e dell’impresa
del Novecento veneziano», un’iniziativa
innovativa per la realtà veneziana, poiché per la prima volta vede impegnate entità istituzionalmente diverse a sostegno dell’amministrazione pubblica in un comune sforzo di
raccolta, conservazione e valorizzazione di fondi archivistici novecenteschi a rischio di dispersione. Ad oggi il materiale inventariato e consultabile dal sito «Archivi della politica
e dell’impresa del Novecento veneziano» è costituito da oltre 25.000 documenti inventariati tra foto, libri, lettere, lucidi e altro materiale inedito. ◼
* Segretario della Fondazione Gianni Pellicani
in vetrina
sarà di nuovo con noi. L’ennesima testimonianza dell’affetto, dell’amicizia e della stima che legava Napolitano a Gianni Pellicani, che sono sempre stati politicamente molto vicini, anche nei momenti più difficili.
Ma è merito della Fondazione se per la prima volta nella
storia della Repubblica un Presidente interviene a Mestre per
un convegno pubblico. Per la Fondazione Pellicani è motivo
di grande orgoglio riuscire a contribuire in modo così significativo alla crescita socio-culturale della città.
Troppe volte si è detto che Mestre è una città senza identità e priva di storia. Un dibattito che non ci ha mai appassionato, noi ci limitiamo a lavorare con l’obiettivo di far crescere Mestre, nella convinzione che momenti come questi aiutino a essere più città.
La Fondazione ha fortemente voluto quest’evento a Mestre, una città che in questi anni ha conosciuto una stagione di grandi trasformazioni. In passato, pur stravolta nella
sua forma e nella sua identità, si è trovata di colpo nel vivo
del Novecento diventando protagonista di una storia straordinaria fatta di industrializzazione, di urbanizzazione, di
migrazione e di conflitti sociali, in cui la politica ha svolto
un ruolo fondamentale. Oggi tra mille contraddizioni questa storia continua ed è particolarmente significativo che da
Mestre parta un’iniziativa per un confronto politico di ampio respiro basato sulle idee.
Fin dall’inizio delle nostre attività Mestre è stata al centro delle iniziative che abbiamo sviluppato con l’obiettivo di
portare l’attenzione su un’area urbana che svolge un ruolo
fondamentale all’interno di quella Città Metropolitana di
cui recentemente si è ripreso a parlare, anche sotto il profilo istituzionale. Il Festival è infatti parte di una programma-
63
in vetrina
64
«Musiche
Culture Identità»
Il congresso
della Società Internazionale
di Musicologia a Roma
L
di Emanuele Senici
a diciannovesima edizione del congresso della Società Internazionale di Musicologia, che si
svolge ogni cinque anni, ha avuto luogo dall’1 al 7
luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Organizzata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in
collaborazione con le tre università romane La Sapienza, Tor
Vergata e Roma Tre, ha visto la presenza di più di seicento relatori, che, oltre alle sedute del convegno, hanno preso parte
a varie altre attività, come concerti e visite guidate ai luoghi
musicalmente più rilevanti di Roma e dintorni.
La maggior parte dei congressi della sim svoltisi negli ultimi decenni ha avuto un tema generale: quello proposto dal
comitato scientifico dell’edizione romana, presieduto da Fabrizio Della Seta, è stato «Musiche Culture Identità» (come utile termine di confronto si pensi che il congresso precedente, svoltosi a Zurigo nel 2007, era stato intitolato «Passaggi»). Si tratta più che altro di un punto d’orientamento
utile a chi propone tavole rotonde e study sessions (ogni congresso ne prevede diverse di entrambe le tipologie), mentre
le sedute di relazioni libere, assemblate dal comitato scientifico stesso dopo la selezione delle proposte ricevute, sono
meno vincolate al tema generale. Al termine dei lavori l’impressione è stata però che l’identità sia una delle questioni al
contempo più interessanti e più calde tra quelle che animano il dibattito musicologico oggi (è bene chiarire che in questo contesto «musicologia» è termine che serve da ombrello per tutte le attività di ricerca sulla musica, dalla musicologia storica all’etnomusicologia, dalla filosofia della musica all’organologia, dall’iconografia musicale alla psicologia della musica, e così
via). In un certo senso sarebbe strano il contrario, dal momento che
la musicologia, come ogni attività intellettuale, riflette la cultura in cui essa si trova immersa, seppur spesso in modo indiretto; e mi pare fuor di dubbio che l’identità sia una delle
categorie fondanti della cultura, nonché della società, della
politica e dell’ideologia del mondo contemporaneo – una delle ragioni, immagino, per cui il comitato scientifico l’ha proposta come tema del congresso –.
Un’altra benemerita tradizione di questi convegni vuole
che al centro della giornata inaugurale si collochino due relazioni plenarie presentate da non-musicologi, che riflettono sul tema generale da punti di vista esterni alla disciplina.
Non sempre queste occasioni funzionano: ricordo per esempio una lezioncina superficiale del matematico Roger Penrose a Londra nel 1997, che sembrò ancora più striminzita per
essere appaiata a una profonda riflessione filosofica su opera ed esecuzione del compianto Bernard Williams. A Roma, invece, le conferenze della filosofa statunitense Martha
C. Nussbaum e dell’antropologo italiano Francesco Remotti hanno offerto spunti di riflessione molto stimolanti sulla
questione dell’identità. Nussbaum ha indagato il ruolo della musica e della danza nel progetto filosofico ed educativo
di Rabindranath Tagore, sottolineando la portata sovversiva di queste attività all’interno di una «religione dell’umanità» costituzionalmente anti-identitaria. Remotti ha invece offerto una critica articolata ed eloquentissima del concetto stesso di identità, seguita da un appassionato plaidoyer per
la categoria della somiglianza, secondo lui molto più adatta a
navigare il difficilissimo contesto sociale, politico e ideologico in cui ci troviamo a vivere.
Le parole di Nussbaum e Remotti hanno risuonato per tutta la settimana seguente, offrendo prospettive generali assai
stimolanti da cui contemplare sedute dedicate a temi apparentemente così diversi come le tavole rotonde su «Costruzione e decostruzione dell’identità nella musica dell’Asia
orientale dagli anni sessanta», «Sguardi dal di fuori sull’identità musicale italiana», «Modelli cognitivi nelle attività
musicali», «Musica e visualità», «Identità europea e condizione periferica nella musica iberica antica» e «Identità
musicale e cultura dell’identità in Italia nel Quattro-Cinquecento», oppure le study session su «Papi, cardinali e musica, 1450-1630», «La trasmissione della conoscenza musicale: costruire una cittadinanza europea», «Prospettive interdiciplinari sulla musica, la cultura e l’identità brasiliane», «Immagine-suono-struttura e l’esperienza audiovisiva», «Com’era veneziana l’opera veneziana nel Seicento?»
e «Questioni di identità stilistica e di disseminazione europea nella Scuola delle Nazioni di Tartini», per citare solo
Gioacchino Rossini
(dipinto anonimo
prima metà Ottocento).
Igor Stravinsky
n un disegno
di Pablo Picasso
(31 dicembre 1920).
linità, omosocialità e identità religiosa che stanno al centro
del film, aiutando a risolvere alcuni punti di tensione lasciati in parte aperti dalla componente visiva.
Più sopra ho detto come la musicologia rifletta la cultura in
cui essa si trova immersa, anche se indirettamente. Allo stesso tempo, però, la musicologia non sta al di fuori della cultura, ma ne fa parte come qualsiasi altra attività umana, e
quindi contribuisce a questa stessa cultura. In questo senso,
il congresso romano può aver dato un contributo al dibattito sempre più vivo sui significati e gli usi dell’identità all’interno della società contemporanea – significati e usi che, non
dimentichiamolo, si esplicano in molte questioni scottanti
del presente, dall’immigrazione al matrimonio tra coppie
dello stesso sesso, e dalla violenza domestica sulle donne alle
rivendicazioni territoriali da parte di vari stati contro altri –.
C’è però anche un altro modo in cui il convegno romano
può aver contribuito non solo alla discussione sulle identità,
ma anche alla pratica di esse, per così dire. Il congresso quinquennale della sim è di gran lunga il più autenticamente globale tra le occasioni di portata simile nel panorama musicologico internazionale (molto di più, per esempio, dei convegni annuali della American Musicological Society o della Society for Ethnomusicology, che gli si possono avvicinare per numero di partecipanti «passivi», anche se il numero delle relazioni è inferiore). Per moltissimi tra noi, questa
è l’unica occasione in cui incontrare colleghi di paesi lontani non solo geograficamente (notevole a Roma il numero di congressisti dall’America Latina e dall’Asia Orientale,
per esempio), ma anche per tradizioni intellettuali e orientamenti della ricerca. Ascoltare una relazione diversa per contenuto, forma e stile da quelle che sentiamo di solito ci invita a riflettere in modo nuovo sulle nostre identità intellettuali e disciplinari, che spesso riteniamo, imperialisticamente, la pietra del paragone. Può persino accadere di fermarsi
un attimo a pensare sull’uso troppo spesso irriflesso di aggettivi quali il «nostre» della frase precedente: «nostre»
di chi? Voglio dunque, in conclusione, sottolineare l’importanza di un’occasione che ci ha
portato ha ripensare la categoria dell’identità non solo nella musica che studiamo, ma anche nella nostra pratica intellettuale e quindi culturale e sociale. In questo senso mi pare assai significativo che il prossimo congresso si svolgerà, nel 2017, a Tokio, fuori dall’Europa per la prima volta dal
1977: sarà un’occasione preziosa per continuare da un
punto di vista anche geograficamente molto diverso la riflessione sull’identità e la musica
avviata quest’anno a Roma. ◼
Ludwig van Beethoven
ritratto da W. J. Mähler
nel 1804
Gaetano
Donizetti
(autocaricatura
del 1843).
in vetrina
alcuni esempi da entrambe le tipologie. I titoli delle sedute di relazioni libere erano spesso più tradizionali: si andava
da «Monodia medievale» a «Polifonia medievale e rinascimentale», da «Opera italiana nel Settecento» a «Rossini»,
da «Lo stile classico e Beethoven, ieri e oggi» a «Donizetti e Verdi», da «Musica tedesca dell’Ottocento” a «Wagner
e l’opera nazionale ottocentesca”, da «Stravinsky e la musica francese del Novecento» a «Musica nel periodo sovietico»; ma non sono mancate sedute più insolite, come «Colonialismo», «Esoticismi», «Diaspore», «Popular music»,
«Identità ebraica e musica dell’esilio», «Cantanti e canti»,
«Donne e uomini», nonché varie occasioni in cui le identità geografiche erano al centro dell’attenzione, come «Prospettive sull’Asia», «Tra Spagna e Nuova Spagna dal Cinque al Settecento», «L’Ungheria e i compositori ungheresi dell’Otto-Novecento», «America Latina» (tre sedute),
«La Turchia e la penisola balcanica», «Gli USA nei secoli xix e xx», e così via.
Lunghe discussioni con amici e colleghi durante le animatissime giornate del congresso hanno fatto emergere come
le proposte di Nussbaum e Remotti abbiano profeticamente anticipato gli atteggiamenti critici o comunque interlocutòri di molti tra i relatori verso la categoria dell’identità, di
cui al presente non pare si possa fare a meno, ma che oscura e confonde almeno tanto quanto illumina e chiarisce, soprattutto in un campo costituzionalmente fluido e cangiante come quello musicale. Come ha spiegato Benjamin Walton, per esempio, nella Calcutta della prima metà dell’Ottocento l’opera italiana era imbricata in una rete di somiglianze (per dirla con Remotti) che rimandano non solo all’Italia, ma anche a Londra e al teatro musicale in lingua inglese, nonché al rapporto tra genere femminile e rappresentazione scenico-musicale nel contesto della cultura bengalese
del tempo. In modo non dissimile, nella colonna sonora che
Miklos Rozsa scrisse per Ben Hur nel 1959 Stephan Prock ha
rintracciato una complicata negoziazione delle relazioni, potenzialmente pericolose per la cultura del tempo, tra masco-
65
in vetrina
66
Alla Cini un convegno
su Luigi Squarzina
D
al 4 al 6 ottobre 2012 nelle sale della Fondazione Giorgio Cini si svolge il convegno di studi
dedicato alla figura artistica e all’opera del regista e drammaturgo italiano Luigi Squarzina (18
febbraio 1922 – 8 ottobre 2010).
Inserito nell’ambito delle iniziative collegate alla donazione che Squarzina ha voluto fare della propria Biblioteca al
Centro Studi per la Ricerca documentale sul Teatro e il Melodramma europeo, il convegno, a cura di Maria Ida Biggi,
è organizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma e con l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica. Questa manifestazione vuole anche ricordare il maestro in occasione del secondo anniversario della scomparsa.
Le tre giornate sono articolate in sessioni, ognuna delle
quali contiene riflessioni e approfondimenti storico-critici,
interventi di giovani studiosi e testimonianze di artisti collaboratori del maestro, affrontando le tematiche legate al-
la sua attività di studioso e saggista, organizzatore culturale e direttore di teatri stabili, drammaturgo e regista teatrale di prosa e di lirica. L’importanza storica del personaggio è
testimoniata dalla partecipazione dei numerosi e autorevoli relatori quali Carmelo Alberti, Roberto Alonge, Giovanni
Agostinucci, Franca Angelini, Katia Angioletti, Anna Barsotti, Maria Ida Biggi, Francesca Bisutti, Lina Bolzoni, Paolo Bosisio, Eugenio Buonaccorsi, Roberto Cuppone, Masolino d’Amico, Guido Davico Bonino, Marco De Marinis, Siro
Ferrone, Ilaria Gariboldi, Maurizio Giammusso, Maria Grazia Gregori, Camilla Guaita, Gerardo Guccini, Ginette Herry, Isabella Innamorati, Giuseppe Liotta, Stefano Locatelli,
Claudio Longhi, Lorenzo Mango, Federica Mazzocchi, Nadia Palazzo, Matteo Paoletti, Giacomo Pedini, Franco Perrelli, Paolo Puppa, Alberto Quadrio Curzio, Elena Randi,
Renzo Tian, Alessandro Tinterri, Roberto Tessari, Franco
Vazzoler, Piermario Vescovo, Claudio Vicentini e Marianna Zannoni.
Al termine di ogni giornata, a partire dalle 17.30, sono previsti incontri aperti al grande pubblico. Giovedì 4 ottobre,
alle ore 17,30, si presenterà il volume degli Annali della Fondazione Istituto Gramsci di Roma intitolato Luigi Squarzi-
na. Il teatro e la storia dedicato ai suoi scritti. In questa occasione saranno presenti il presidente della Fondazione Istituto Gramsci Giuseppe Vacca e il curatore del volume Elio
Testoni. Nella stessa serata, l’attore Omero Antonutti leggerà un pezzo tratto dal dramma di Squarzina Cinque giorni al porto.
Venerdì 5 ottobre, dalle ore 17.30 alle 22, si svolgerà una serata con testimonianze e letture degli attori Giorgio Albertazzi, Erika Blanc, Benedetta Buccellato, Massimo Foschi,
Franco Graziosi, Gabriele Lavia, Lucilla Morlacchi e Tullio
Solenghi con brani tratti da testi drammaturgici e saggi di
Squarzina come L’esposizione universale, Siamo momentaneamente assenti, I cinque sensi, Tre quarti di luna, Il gioco dei
potenti, Rosa Luxenburg, 8 settembre. Inoltre è previsto l’ascolto di estratti inediti della registrazione audio dell’Amleto, interpretato da Vittorio Gassman e diretto con Squarzina
nel 1952, recentemente ritrovato negli archivi di Radio Rai.
Per questa occasione, Paola Gassman e Ugo Pagliai leggeranno alcune lettere che Vittorio Gassman e Luigi Squarzina si
sono scambiati durante la preparazione di questo spettacolo e brani dal carteggio Silvio d’Amico – Vittorio Gassman
a proposito della messinscena dell’Amleto.
Il convegno ha ottenuto la Media partnership di Rai Radio
3 e Rai Teche, permettendo così di offrire al pubblico una se-
lezione di registrazioni audio e video di cui Squarzina è stato
autore, traduttore, organizzatore, interprete e regista. Grazie
a ciò, è possibile ascoltare le registrazioni dei radiodrammi e
delle interviste da lui rilasciate alla radio e visionare i video
di alcuni suoi spettacoli in una sala appositamente allestita a
fianco del luogo in cui si terrà il convegno e aperta al pubblico da lunedì 1 ottobre 2012.
Sabato alle 17.30 è organizzata la tavola rotonda conclusiva
con le testimonianze di Paolo Baratta, Maricla Boggio, Cristiano Chiarot, Matteo d’Amico, Gianfranco Padovani, Ottavia Piccolo, Pier Luigi Pizzi, Carlo Quartucci, Luca Ronconi, Giuliano Scabia, Marco Sciaccaluga, Gianrico Tedeschi e Lamberto Trezzini. Gli attori Paola Cannoni e Giancarlo Zanetti leggeranno brani dalla Romagnola e dal Tartufo .
Il convegno ha il sostegno del Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali dell’Università di Ca’ Foscari, della Fondazione Teatro La Fenice, del Comune di Lugo e della Regione del Veneto. (l.m.) ◼
Luigi Squarzina.
La biblioteca del regista alla Fondazione Cini.
Mario Bortolotto
e le vie della musicologia (3)
un progetto a cura di Jacopo Pellegrini
I
l periplo attorno a «Capo Bortolotto» (passaggio irto di perigli, infido persino, se, quando credi di
aver finalmente afferrato il bandolo del discorso, una
svolta improvvisa, un cambio di rotta verso un’espressione sibillina bastano a rimettere tutto in discussione, a precipitare in nuovi labirinti di senso: si veda, e si ammiri, la nota 13 dello scritto di Alberto Caprioli, vero e proprio tour de
force ermeneutico, in virtù del quale anche un comune «lettore ingenuo» quale lo scrivente è alfine messo nella condizione di toccare con mano l’intricatissimo congegno di allusioni e citazioni, dirette e indirette, che può annidarsi in
un qualsiasi enunciato del nostro magmatico prosatore: l’esempio prescelto è l’explicit d’Introduzione al Lied romantico), questo
periplo giunge finalmente a lambire la produzione libraria accumulata, in cinquant’anni precisi di attività (1962-2012, ma suoi saggi e articoli erano cominciati ad apparire un
paio di anni avanti), da un insaziabile desiderio di conoscenza.
Caprioli, compositore ben noto e
forte studioso di letteratura comparata (in particolare esplora il rapporto poesia-musica), interroga per
l’appunto il testo d’esordio, apprezzato a suo tempo da Fedele d’Amico e da Giorgio Vigolo (che, non si
dimentichi, era anche poeta in proprio, e non dei trascurabili), e rileva
come esso sia costituito da «una serie di microstorie dei Lieder e dei loro autori», una collana di monografie (Bortolotto non è davvero un seguace di Croce, eppure il ritratto a
tutto tondo di singoli autori o opere è una sua «specialità»: si pensi a
Fase seconda, a Consacrazione della casa, a Dopo una battaglia, a Est dell’Oriente) all’apparenza indipendenti, ma concepite secondo un piano unitario, a partire cioè da un’idea
centrale, di solito racchiusa nel capitolo o nelle pagine iniziali e soggetta a sviluppo e dimostrazione. Libri di un musicista, quelli di Bortolotto, sostiene Caprioli: punto di vista
già espresso da Stefano Catucci nel saggio comparso sul numero scorso di «Venezia musica e dintorni», e che dalla veste professionale di chi ora lo riprende e lo fa suo, invoglia a
guardare sotto una luce diversa le rampogne, anche asperrime, e gli elogi indirizzati al Nostro da nomi illustri: Berio,
Nono, Vlad da un lato, Boulez, Clementi, Donatoni, Pablo
dall’altro. Insomma, schermaglie tra «consanguinei», gente fatta della stessa pasta.
Il contributo del musicista bolognese, che, secondo un tipico (e spavaldo) processo di rispecchiamento nella materia trattata, concede qualcosa allo stile per «illuminazioni»
di Bortolotto, individua nel Lied romantico una quantità
di presagi e anticipazioni critiche invero sorprendente, istiMario Bortolotto (foto di Francesco Maria Colombo).
tuendo confronti e paralleli con la più recente comparatistica e musicologia internazionale. Dal canto suo, invece, Gian
Paolo Minardi da Parma (90 km appena, ma è
un altro mondo) affronta
Wagner l’oscuro (2003)
in una prospettiva prettamente italiana. Criterio nient’affatto opinabile, trattandosi della prima monografia complessiva dedicata al compositore tedesco da un autore italiano dai tempi di
Torchi (1890: ovviamente non tengo conto dei lavori divulgativi – Celli,
Mila, Tedeschi – o dei tomi a firma Borrelli, Pannain, Rinaldi). In questo senso offre un inte-
resse specifico la lettura di Tristano, mio Tristano. Gli scrittori italiani e il caso Wagner (1988),
il sapientissimo studio di
Adriana Guarnieri, ricordato anche da Minardi. Il
nome di Bortolotto vi figura in rapporto ora ai
«“ritorni” antiwagneriani al quadrato» (p. 347)
della neoavanguardia (il
Gruppo ’63, Arbasino in
primis), dei quali condivide l’orrore per il «wagnerismo» idolatrico, per i
«bidelli del Walhalla»1,
ora all’«indirizzo formalistico o polemicamente pragmatico, volto a considerare la produzione wagneriana preliminarmente in quanto “musica”» (p. 356), impo-
Il provetto stregone
Il provetto stregone
67
Mario Bortolotto e le vie della musicologia
68
stosi negli anni settanta e ottanta: l’«affermazione della musica» su cui insiste molto anche Minardi.
Ma questo indirizzo
non è caratteristico del
solo scenario italiano,
lo si ritrova anche nella musicologia mitteleuropea, in particolare nei contributi epocali
di Carl Dahlhaus. È degno di nota il fatto che i
due, il tedesco e l’italiano, si accostino a Wagner quasi in contemporanea, questo con la traduzione e la cura del saggio di Adorno (uscito nel
1966 per i tipi di Einaudi), quello con le indagini che condurranno, nel
1971, alla fioritura pressoché simultanea della
Wagners Konzeption des
musikalischen Dramas
e dei Richard Wagners
Musikdramen2: entrambi partono da un retroterra filosofico-ideologico molto solido e specifico (l’interesse per la
Nuova musica che si riverbera anche in scelte lessicali riconoscibili; il riferimento costante ad Adorno, specie in
funzione antagonistica) 3 , entrambi nutrono un certo qual sospetto intorno alla solidità
dell’impalcatura teorica wagneriana, entrambi rimarcano che nel
Wort-Ton-Drama «il testo, il poema, non diversamente dalla musica,
è inteso da Wagner come un mezzo del dramma, non come la sua essenza» (Dahlhaus, Wagners Konzeption des
musikalischen Dramas,
p. 15: anche Bortolotto
affronta l’argomento nel
capitolo iniziale di Wagner l’oscuro, «Temperamento e teoresi», pp.
13-58), ma poi – come si
diceva – si concentrano
sulla dimensione musicale, privilegiando la microforma, singole componenti del discorso o
momenti delimitati, rispetto alla lunga gittata,
all’impianto globale di un atto o di un Drama4 .
Ora, si potrebbe pensare, date alla mano, che Bortolotto
sia in debito con Dahlhaus (il cui nome in Wagner l’oscu-
ro compare tre volte, a pari merito con Diether de la Motte ed Ernest Newman, una in meno di Robert Donington,
mentre Egon Voss e Jean-Jacques Nattiez5 si fermano a quota uno: più frequenti le citazioni degli ammirati Boulez,
Confalonieri e Lévi-Strauss); in realtà, la loro quête wagneriana procede parallela e indipendente. L’immagine di Wagner, essenzialmente desunta da Nietzsche, quale dissoluzione della Romantik e scaturigine del «negativo» novecentesco, in Bortolotto è già del tutto definita quando le monografie di Dahlhaus vedono la luce in italiano; anzi, è proprio in
quell’immagine ch’è dato distinguere il timbro inconfondibile della sua voce tra le mille e mille che formano il coro della critica wagneriana. (j.p.) ◼
1. Per ricorrere a un titolo ben noto di Beniamino Dal Fabbro (1954):
non a caso la Guarnieri per la letteratura degli anni sessanta parla di
«ritorni» antiwagneriani, giacché essi si ritrovano «a fianco della
tradizione letteraria antiwagneriana neoclassica tuttora operante» (il
rondismo di Montale), laddove le origini di questa ripulsa rimontano
indietro sino a D’Annunzio, al suo progetto di «mito mediterraneo»
alternativo a quello «nordico» di Wagner (Il fuoco, 1900).
2. Tradotti anche in italiano, l’uno da Maria Cristina Donnini Maccio
per Discanto, Fiesole (FI) 1983 («Contrappunti», 17), l’altro da Lo-
renzo Bianconi (anche curatore) per Marsilio, Venezia 1984 («Musica
critica»).
3. A partire dagli anni settanta, Bortolotto gli affiancherà il prediletto
Nietzsche: «Ben pochi casi conosce la storia della musica in cui un
manuale di estetica , o anzi una formulazione di poetica, sia di tanto
più brillante di quelle che già erano […] le composizioni da esso ispirate, o con esso simbiotiche. Pensiamo soltanto al Caso Wagner»: Mario
Bortolotto, Cocteau e il marinaio, in Id., Corrispondenze, Adelphi, Milano 2010 («Saggi. Nuova serie», 65), pp. 263-68: 263. Si veda anche
Friedrich Nietzsche, Scritti su Wagner, trad. it. di Sossio Giametta e
Ferruccio Masini, con un saggio di Mario Bortolotto, Adelphi, Milano 1979 («Piccola biblioteca», 80), la cui introduzione, Altra aurora,
graziosamente resa più accessibile ai comuni mortali da pochi ma capitali interventi, è poi confluita in Bortolotto, Wagner l’oscuro, Adelphi,
Milano 2003 («Saggi. Nuova serie», 42), pp. 140-196. Tutta sua anche
la propensione per il mito e il sapere iniziatico, verificabile nella parte
introduttiva dei capitoli sul Ring, su Tristan, e, in modo speciale, su
Parsifal.
4. Tema a cui ha invece prestato particolare attenzione la scuola angloamericana, da Anthony Newcomb e Carolyn Abbate in avanti. Per
Dahlhaus e Bortolotto la questione viene forse data per risolta (termine da intendersi anche e soprattutto in senso etimologico) nel flusso
continuo e onnicomprensivo della rete leitmotivica.
5. Con le ricerche del quale non mancano punti di tangenza, con ogni
probabilità del tutto casuali, ma non per questo meno sintomatici.
Sopra: Carl Dahlhaus.
I
di Gian Paolo Minardi
l mio primo incontro con Wagner l’oscuro
(Adelphi, Milano 2003) è avvenuto quasi in concomitanza con una bella proposta dei Meistersinger al Maggio musicale fiorentino 2004, il che mi ha naturalmente guidato a iniziare la lettura dal capitolo dedicato a quest’opera: a incorniciarlo, un titolo sottilmente allusivo, «La città, il profumo». Ed è stata subito coinvolgente occasione
per ritarare lo strumento che convenzionalmente, e non poco passivamente, viene spesso applicato
a quest’opera, nata a
fianco del Tristan, durante l’ampia interruzione apertasi lungo il
defatigante cammino creativo del Ring
– «un’opera tra parentesi», come scriveva l’autore a Cosima;
per modificare, dunque, quelle misure che
sembrano sovente costringerla entro una
proiezione retrospettiva, quella di un Wagner che si rifugia nel
passato, nel contrappunto, nella positività
operosa di personaggi
riconoscibili1, piuttosto che avventurarsi in altre ben più avvolgenti, non poco sibilline, spire.
Aggiustare il tiro rispetto alla semplificazione è per Bortolotto fin troppo scontato; gli basta ricordare (p. 347) il chiarimento di Nietzsche: «Chi rimane sorpreso dalla vicinanza del Tristan coi Meistersinger, non ha capito, in un punto
importantissimo, la vita e la natura di tutti i Tedeschi veramente grandi: non sa su quale terreno soltanto può crescere
quella gaiezza propriamente ed unicamente tedesca di Lutero, Beethoven e di Wagner». Per poi innescare tutte le sue
qualità introspettive nello sciogliere i nodi insiti nello stesso stacco del soggetto, non più innervato nel mitico o nel leggendario, ma arroccato alla storia ancora palpitante di una
città: ecco quindi rinsaldata l’unità che ricomprende l’intera vicenda wagneriana. Di questa, infatti, i Meistersinger sono solo un altro aspetto, avvinti da una segreta continuità,
oltre che dalla contiguità cronologica, con il Tristan, come a
ribadire la profonda unità di questa «paradossale dilogia»
(p. 353), dove la chiarezza dell’una, anche quella lunare della notte di San Giovanni, sembra fugare i più inquieti spiriti
della notte che attraversano la partitura gemella. L’acutezza
di Bortolotto è oltremodo penetrante nel leggere in filigrana i sottili intrichi di questo nodo: se, com’egli dice, i Meistersinger «enunciano la regola» (p. 341), nondimeno affiora insinuante «la volontà del nuovo», espressione che sembra attivare le segrete consonanze baudelairiane, e con esse
lo spettro della «distruzione della lingua», spettro che fin
dai suoi inizi critici ha accompagnato la sensibilità del Nostro. Centrale, in tale intreccio di tensioni opposte, è la figuA destra: Richard Wagner.
ra di Sachs, il cui profilo l’autore disegna con quella ricchezza e, pure, con quell’ambiguità di tocchi che smussa, confondendone le tensioni, certi tratti troppo netti, così da coglierne la complessità: «Lo sguardo di Sachs, – scrive Bortolotto – di lui solo, ha doppio orizzonte, l’eccezione e la regola, il
nuovo e il bello» (p. 343). Può sembrare quasi un autoritratto di Wagner, trascinato da quel «demone dalla vertiginosa
energia trascinatrice» (p. 344) che è il Wahn, il senso illusorio, sottile follia, che nella sua mobilità insinuante si apre alle più insospettate riverberazioni musicali: fino alla decantazione suprema del Quintetto, «musica assoluta: o almeno,
[…] quanto in Wagner più le si accosta» (p. 352).
Il Wahn come traccia sotterranea che delimita e insieme
unisce le due opere, Tristan e Meistersinger; irradiato attraverso vari poli, esso trasmette il senso più recondito di un
pensiero che nutre la musica, quasi sollecitando inafferrabili presentimenti. Bortolotto, con la sua sensibilità da rabdomante, sorretta dal dominio di letture sconfinate e dalla capacità di riattivarle entro prospettive attuali, segnala alcuni
indizi preziosi, luci penetranti, utili a orientarci, seppur come sprazzi fugaci dell’inconscio, entro la fascinosa, non di
rado disarmante, oscurità. È quanto, appunto,
va attraversando l’animo di Sachs, quel suo
modo di praticare il ruolo di «maestro»,
consapevole che il rispetto della regola non può non divenire proiezione
di nuove situazioni, di nuovi sentimenti. Motivo centrale dell’opera, questo, attestato dalla diversità delle reazioni: «Hanslick perse il controllo: “se i Meistersinger diventassero regola, sarebbe la fine di tutta la musica”;
Nietzsche non si entusiasmò. Ma
Brahms li predilesse, avendo vissuto quel dilemma come una spina
nella carne» (p. 346).
Allo stesso modo, proprio attraverso questo percorso sotterraneo, Bortolotto rivolge altrettanta attenzione
a Beckmesser, liberandolo dalle insistite ristrettezze di certi tratti grotteschi appartenenti a un consunto oleografismo, al quale pure sottrae gli altri Maestri, per ritrovare più profonde radici di quell’inclinazione comica che, non va dimenticato, aveva rappresentato l’originario,
benché tutto da decodificare, obiettivo di Wagner; di là dalla superficie, dunque, è l’humus diversamente fermentante
che opera, quella «gaiezza propriamente ed unicamente tedesca» colta da Nietzsche, il quale, pur non entusiasta, aveva compreso il tessuto più segreto entro cui le varie tematiche, come in un contrappunto arioso eppur necessario, vanno intersecandosi. Persino il tema, più perigliosamente esposto, dello spirito patrio: «queste cose – aveva detto il filosofo
– debbono venir intese artisticamente, non dogmaticamente. Anche il nazionalismo tedesco fa parte di ciò».
Il Wahn, dunque, come chiave per penetrare l’oscuro, nella
sofferta consapevolezza di Sachs (in questo davvero un doppio di Wagner) che carattere dominante della poesia è la dimensione onirica. Quella che, infine, troverà nell’estremo cimento poetico di Walter la forza fecondante dell’amore: non
più il «malvagio spettro della notte», chiarisce Bortolotto a
riscontro di Tristan, «ma illuminazione benigna» (p. 351).
«Illuminazione benigna» e «follia d’amore» sono i termini per rilevare le differenze tra le due opere contigue: diverse ma non contrastanti, sembra pensare Bortolotto, il
Il provetto stregone
Bortolotto l’oscuro
69
Mario Bortolotto e le vie della musicologia
70
quale, nel rimarcare l’«unità di stile», scorge in questa vicinanza un momento nodale di quella stretta tra stile e linguaggio che prefigura le strade della modernità: fino a quel
«punto di bruciante identità» realizzato da Anton von Webern (pp. 334-335).
Il mio approccio al libro, partendo dai Meistersinger, è stato un repentino precipitare in medias res, cosicché ancor
più sollecitante è risultato poi il risalire alle origini di questo straordinario viaggio entro l’«oscuro». Con una guida tanto avvincente quanto impegnativa: scherzosamente, si potrebbe parafrasare: «Bortolotto l’oscuro». Ma nel
senso ch’egli ci consente di entrare nell’oscurità wagneriana, svelandocene i tratti che da quelle tenebre vanno via via
definendosi, superando le contraddizioni più apparenti per
stabilire una nuova complicità. La stessa cosa, insomma,
che Bortolotto aveva fatto in Dopo una battaglia, ricreando
una prospettiva inattesa della Francia dopo Sédan, o in Est
dell’Oriente, dove ci aveva introdotto nei più riposti scenari
della musica russa. Con Wagner Bortolotto ci rende partecipi di quel mondo fatto, com’egli dice, di «quasi inafferrabili
fugacità, nebule intangibili, fibrillazioni tessutarie, collisioni cromatiche, microcosmi sfumanti in un magmatico habitat sinfonico» (pp. 183-184). Terreno oltremodo provocante per il Nostro, nel
contrasto tra questo avventuroso universo linguistico e immaginario e la
statura umana del mistificatore. Un
contrasto irrisolvibile: «Impossibile
affatto sarebbe procedere a districare
nell’amalgama psichico, e verbale, di
sincerità, mendacio, estetismo, egoismo, posa, generosità sconfinata» (p.
22). E tuttavia il gioco è avvincente, e
infiniti sono i labirinti attraverso cui
Bortolotto ci guida, con le sue imprevedibili vividezze, le scorciatoie inaspettate quanto rivelatrici.
Un viaggio, del resto, lungo il quale Bortolotto aveva già accompagnato il lettore nella prefazione
all’edizione italiana del saggio di
Adorno2 , laddove sospingeva lo
sguardo verso regioni più arcane, inesplorate – «il discorso su
Schönberg si deve di necessità inserire nella prospettiva del Versuch»3, – sul
filo di quella ambivalenza che troverà pure riverbero nel pensiero di Fedele d’Amico per giustificare come «tutto, dopo
Wagner, diventa problema» in quanto «eterna resta l’ambiguità fra la tensione nichilista dell’inestirpabile eresiarca
e la bronzea concretezza delle figure che ne son messe in moto»4. Bortolotto sembra andare ancora oltre nel creare aspettative di lunghissima gittata, conseguenza del «negativo»,
pur non celando la disillusione nella scettica chiusa: «Gli
orologi della musica senza aggettivazione, arrestatisi simpateticamente nel febbraio 1883, il giorno 13 (in obbedienza
al numero vitale del musicista) sul frammento Liebe-Tragik
di Palazzo Vendramin, segnano adesso, meccanici ossimori,
l’ora delle serenate»5.
Un Wagner diverso, appunto, non riportabile entro linee
definite, neppure rassicuranti, a considerare l’enorme sfrido
che dall’imponente impresa è andato determinandosi. Anche questo fa parte dell’effetto Wagner, di quel gorgo avvitato dalla sua concezione musicale e, più ancora, dal suo linguaggio votato alla dissoluzione: la musica, come intuito da
Schopenhauer e da Nietzsche, quale «arte del tramonto»,
a disegnare l’arcata discendente in fondo alla quale, «ulti-
ma tappa del sublime romantico» – scriveva Bortolotto nella prefazione al saggio di Adorno su Wagner – è «il Kitsch»6.
Aloni fumosi quelli emanati da questo termine; quel fumo
che costituiva la ragion d’essere degli adepti («Il wagnerismo […] un rituale asiatico, baudelairianamente “impregné
d’odeurs”»: p. 16), i Wagnerianer e, nella diramata idolatria francese, i Wagnerites, fino all’eccitazione di un Catulle
Mendès il quale esclamava «Christ, Berlioz et Wagner, divins!» (p. 15). Un terreno in cui Bortolotto brucia tutta la
sua sagacia, con una circolarità di movenze capace di mettere a frutto la banalità del gossip attraverso iperboli accecanti,
che partendo dalle situazioni del divenire quotidiano ci pongono di fronte a snodi essenziali, facendoci intendere il senso
ineludibile di un lascito. Lascito che va depurato, comprensibilmente, dalle incrostazioni sedimentate sul personaggio
Wagner, pur esse però significative, come pure dalle infinite complicazioni innescate dal suo rapporto coi contemporanei, e con Liszt in particolare. Al quale non esitava a confessare «come musicista mi sento tale da far pietà» – pendant al giudizio impregnato di sufficienza sul futuro suocero: «non è che un musicista!».
Una presenza, quella dell’ungherese, che nelle pagine di
Bortolotto rivive non tanto in termini di rivendicazione quanto piuttosto innestata nel
comune parametro dell’«inattualità». Molte, infatti, sono le situa zioni musicali di Liszt che possono considerarsi incunaboli di Wagner; la più
nota, la melodia dalle Campane del duomo di Strasburgo, che ritroviamo nel Parsifal quale motivo che accompagna il corteo funebre di Titurel
(e che poi, simbolicamente, Liszt
riprenderà nel tardo Am Grabe
Richard Wagners per pianoforte). Bortolotto è chiarissimo nello
sfatare la nebbia: «La distanza da
Liszt è radicale, nonostante l’affinità apparente: l’atteggiamento di Wagner punta sull’estensione del principio tonale, laddove Liszt indaga plaghe
ignote con attenzione meramente acustica, sperimentale
nettamente» (p. 428). Più che il bilancio dei crediti, in parte riconosciuti da Wagner, in particolare quelli verso i poemi
sinfonici, nonostante la sua iniziale sfiducia nella musica a
programma (mentre risulterà insensibile, se non disgustato,
dalle estreme pagine sperimentali, a tal punto ritenute frutto di uno squilibrio da chiamarne l’autore «re Lear»), emerge la comunanza di una particolare tensione formale nel gestire il rapporto con la parola. Tensione che per Wagner vede la sua naturale proiezione nel modo di concepire il tempo, miticamente, come uno scorrere circolare entro cui affiorano e agiscono, quali presenze riconoscibili, i temi, non organismi compiuti in sé, nella loro fisionomia grafica, avverte Bortolotto, bensì puro dato temporale, proprio come l’intermittence proustiana. Puntualissimo il rimbalzo attraverso
la figura del «barone di Charlus, perno della Recherche; ove
svolge insieme pratica di delucidazione e d’arbitraggio, e soffre passione sacrificale. Al pari di Wotan, non occupa tropA sinistra: Friedrich Wilhelm Nietzsche.
A destra: Arthur Schopenhauer.
A destra: Franz Liszt.
ferito un pensiero di Wagner, in quel periodo intento a correggere le bozze di Oper und Drama: «So quello che là dentro non conviene a Nietzsche, è ciò che è spiaciuto a Kossak,
e che solleva Schopenhauer contro di me: è quanto dico del
Verbo: in quel tempo non ero ancora capace di dire che era la
musica ad aver dato origine al dramma, e tuttavia, interiormente, lo sapevo». Ancora Cosima, sei anni dopo, nel 1878,
riferisce di un Wagner irato per una questione di «costumi
e trucco», che si sfogava dicendo, dopo «aver creato l’orchestra invisibile», di voler «inventare il teatro invisibile». La
questione, come ben si sa, è complessa e tanti sono gli aspetti contradditori su cui gli studiosi hanno dibattuto. Bortolotto la gestisce con la consueta sottigliezza; il che non gli
impedisce di far l’occhiolino all’amato Stravinskij: «Là dove può sembrare che l’assunto ideologico vacilli – scrive, –
interviene il “golfo mistico”: che mai come ora avanza pretese legittime per la tronfia designazione» (p. 282). Pretese
che il nostro amico, altrettanto puntiglioso nel frugare entro gli angoli più riposti del disordinato magazzino
da cui Wagner attinge i materiali per le sue ricreazioni poetiche, individua con acutezza
fulminante, osservando attraverso la lente del suo penetrante microscopio ogni
minimo passaggio, quasi che, nel chiudere quel cerchio da cui sono partite le
diramazioni più imprevedibili, si sentisse sospinto dalle parole del musicista ormai vecchio, che sentiva Bach
«come la radice delle parole. I rapporti di quest’opera con ogni altra musica
sono quelli del sanscrito con le altre
lingue». E quindi dar l’impressione
di accondiscendere all’idea che Wagner, terminato il Parsifal, sognasse di lasciare il teatro, «dimostrarsi un musicista vero, fuori dalle lusinghe dell’azione scenica». Ma subito se ne ritrae, consapevole che in questo modo si uscirebbe «dal continente Wagner» per addentrarsi «nello scialbo territorio delle supposizioni» (p. 36). Ossia per entrare in
un’altra dimensione di oscurità. ◼
note
1. Significativo il pensiero di Enrico De Angelis espresso nel saggio I
maestri cantori. Lettura di un’«opera» pubblicato nel Numero unico del
49° Maggio musicale fiorentino 1986, a cura di Mauro Conti, Alberto
Paloscia, Annalena Aranguren, Ente autonomo del Teatro Comunale di
Firenze, Firenze 1986, pp. 129-41, e così riassunto da Adriana Guarnieri
Corazzol in Tristano, mio Tristano. Gli scrittori italiani e il caso Wagner,
il Mulino, Bologna 1988 («Saggi», 347), p. 361: «ha […] suggerito quale dimensione wagneriana più autentica (più moderna, novecentista appunto) quella comico-“moderata” (liberatoria ma non eversiva) dei Maestri Cantori; proponendo quale cifra privilegiata di questo “dramma satiresco” la parodia dell’opera tradizionale e sottolineandone quindi significativamente i caratteri ‘neoclassici’ (prestiti, citazioni, inversioni di
senso, autocitazioni ironiche, effetti a sorpresa, ecc.)».
2. Mario Bortolotto, Prefazione (1966), in Theodor Wiesengrund
Adorno, Wagner (1952), prefazione e cura di Mario Bortolotto, Einaudi, Torino 2008 («Piccola biblioteca Einaudi», 414); prima ed. it. in Id.,
Wagner – Mahler. Due studi, Einaudi, Torino 1966 («Saggi», 376).
3. Ivi, p. XXIII.
4. Fedele d’Amico, Il dio Wagner (1983), in Id., Tutte le cronache musicali. «L’Espresso» 1967-1989, 3 voll., a cura di Luigi Bellingardi, con la
collaborazione di Suso Cecchi d’Amico e Caterina d’Amico de Carvalho, prefazione di Giorgio Pestelli, Bulzoni, Roma 2000, III (1979-1989),
pp. 1989-1993: 1993.
5. Bortolotto, Prefazione, in Adorno, Wagner cit., pp. XXIII-XXIV.
6. Ivi, pp. XXII-XXIII.
7. Scritto nel 1970, è ora confluito in Bortolotto, Corrispondenze,
Adelphi, Milano 2010 («Saggi. Nuova serie», 65), pp. 88-101.
8. Le due citazioni si leggono ivi, rispettivamente alle pp. 100 e 101.
Il provetto stregone
po spazio nella generale economia» (p. 278). Ma questa peculiarità dei temi wagneriani, elementi di un cosmo in divenire (e non albero genealogico), di quella melodia infinita
che lungi dall’essere isolata e ridefinita come forma chiusa –
secondo una consuetudine pratica cui aderì per convenienza lo stesso Wagner – trova una sua ragion d’essere proprio
nel suo vivere nel tempo, e quindi nel suo continuo trasformarsi, in quel suo cangiare quasi biologico che dalla nascita
giunge all’estinzione, questa peculiarità dei temi, dicevo, è
un tratto che, come suggerisce Bortolotto, può ritrovarsi anche «nella genesi della Comédie humaine e, in scala minore,
nei Rougon-Macquart o, fra gli scrittori moderni, nelle complesse parentele diramantesi nella saga di Yoknapatawpha,
in Faulkner» (p. 41).
E proprio il parametro della «inattualità», nel rendere più
segnatamente sensibile il rapporto di Liszt con Wagner, si allarga in maniera oltremodo significativa nel reclamare una
più incidente considerazione del musicista ungherese. Lo si
coglie nella sicura evidenza impressa al profilo del musicista
magiaro-franco-tedesco nel bellissimo saggio Liszt o la coscienza romantica7, dal quale la visione si allarga verso orizzonti inattesi. Indubbio, dice Bortolotto, il riconoscere la
grandezza di Liszt per la complessità ch’egli è andato diramando su vari fronti, dalla tecnica alla concezione formale, al gusto, ma ciò che più «allarma» è lo sperimentalismo
e l’eterofonia, quest’ultima in particolare, «un modo di modernità schiacciante, un’espressione radicale di décadence».
E proprio nel grembo indistinto in cui tali elementi si muovono, sovrapponendosi talora a più rassicuranti linee guida,
si cela il senso più occulto, più istigante anche, dell’eredità
lisztiana; fino a pensare che si stia «riscoprendo in lui la profezia di lontani approdi informali»8.
Anche per Liszt, come per Wagner, il cammino di Bortolotto si muove sempre seguendo le ragioni della musica,
esplorate nelle possibili declinazioni delle tante virtualità, a
garantire un’autenticità dai rischi di ogni possibile contaminazione letteraria o agiografica. In altre parole, egli si sottrae
ben consapevolmente alle insidie del wagnerismo, pur da lui
osservato con quella lunghezza di sguardo, non poco cinica
anche, che lo protegge da ogni «infezione». Una voce per
questo ben sbalzata sul fondale di una tradizione come la nostra, in cui il wagnerismo si è innervato come termine di confronto in un ben diversificato tessuto di cultura. Un quadro
che Adriana Guarnieri ha ampiamente ricomposto nel già citato Tristano, mio Tristano, prezioso gioco d’intarsi, ricchissimo variegato mosaico tra le cui tessere il «caso Wagner»
si insinua come sottile provocazione, specchio riflettente anche di più segreti disagi.
Wagner l’oscuro nasce da un confronto inesausto di Bortolotto con l’opera wagneriana, benché talora scandito in maniera occasionale: alcuni capitoli sono infatti ripresi da saggi
apparsi in varie occasioni, programmi di sala, presentazioni;
contingenze poi ricomposte attraverso la naturale progressione cronologica. Ma è soprattutto il filo che va snodandosi
da questo viaggio gremito e avventuroso ad assicurare l’organicità del percorso, un filo che affiora sempre più significativamente da un cammino a senso unico, indirizzato all’affermazione della musica; dopo aver preso le mosse dall’imperioso statuto teorico del Wort-Ton-Drama, Bortolotto mostra come le «azioni della musica» vadano facendosi sempre
più «visibili». La vistosa parentesi aperta da Wagner durante l’Atto II del Sig frido, con la composizione del Tristan e
dei Meistersinger, segna un trapasso sensibile. Tanti i segnali di questa presa di coscienza; sintomatica un’annotazione
di Cosima nel suo diario, l’11 febbraio 1872, in cui viene ri-
71
Mario Bortolotto e le vie della musicologia
72
L’anima del Lied
I
di Alberto Caprioli
libri di Mario Bortolotto non sono soltanto libri da leggere, sono anche libri da ascoltare, perché parlano. Come nel caso del magistrale trattato sul Lied romantico apparso in due edizioni e in varie ristampe tra
il 1962 e oggi, che il suo autore intitola con falsa modestia Introduzione, e che, al momento della sua riedizione nel 1984,
giudica, addirittura, «impolverato profilo»: Sternenstaub,
diremmo noi piuttosto, quella polvere di stelle che per gli
astrofisici indica il prodotto di novae e supernovae, che il Nostro ritrasforma da sostantivi di nuovo in aggettivi.
Essendo musicisti, ci si accorge che sono libri scritti da una
mente in continuo dialogo con il proprio orecchio di musicista; libri che parlano una lingua che alterna ai continui riferimenti filosofici, artistici, letterari, finanche antropologici,
una verifica incessante sul campo, sul tavolo talora spoglio,
talora straordinariamente adorno di un’anatomia dei pensieri e dei sentimenti oltre che delle forme, delle attitudini
superficiali e delle strutture profonde.
Chi fosse abituato a confrontarsi con i saggi della maggior
parte dei musicologi, dopo aver letto le prime due pagine di
Introduzione al Lied romantico, comincerebbe a sfogliare
questo, come tanti altri libri di Bortolotto, ricercandone i
capitoli, i paragrafi, l’indice dei nomi; dimenticando che
un’«introduzione» è appunto come un’ouverture, dove i
temi o i Leitmotive dei personaggi si presentano a raccontarli, a difenderli, talvolta a rimpiangerli, ancor prima dei personaggi stessi. Ma in questo caso non si tratta di un’ouverture
o di una sinfonia in stile italiano, bensì di una pièce sinfonica
per grande orchestra, una Symphonische Dichtung generatrice di idee, così come la potrebbe concepire in musica un
Richard Strauss (una lunga frase poematico-sinfonica accompagnata da una miriade iridescente e incessante di contrappunti intellettuali, di fermate reali, che fungono da perno per digressioni continue, ma segretamente e astutamente
organizzate), dove l’ossimoro
con il camerismo del Lied
è artificio volontario
e rende ragione della inimmaginabile
portata di quella
che si potrebbe
chiamare una
paginetta di
Schubert, di
Schumann
o di Wolf.
Di questa
appa rentemente
infinita
E rl ös u n g
d e l l a
forma rimane la
lu c i d it à
Novalis.
dei timbri, la riconoscibilità degli accenti, la pregnanza delle
dramatis personae, chiamate in causa nella loro chiara contestualità da manuale di alta geografia delle idee; la distillata
sapienza della citazione appropriata, che non è mai, neppure
nei casi e nei generi più intricati e sibillini, jeu de mots fine a se
stesso, ma diviene viva carne e sangue pulsante del corpo del
testo e dei suoi tessuti:
con trame e orditi talvolta paralleli o trasversali
che, se non esistono in
natura, vengono creati
da Bortolotto in preziosi
artifici di autentica ars
retorica: un invito al lettore a divenire l’interlocutore e l’artefice di uno
scambio continuo.
Bortolotto, da viennese (oltre che francese) di
origine, prima ancora
che di adozione, esordisce, inaspettatamente,
con una disamina degli
aspetti contraddittori di
quello che chiama «il
fondamento proibito»
della storiografia tedesca del Lied, partendo
dalle origini linguistiche
e musicali del termine,
dalla sua pretesa derivazione antica, germanica e
popolare, con le conseguenti interpretazioni storiografiche,
che oggi gli storici definirebbero sous surveillance.
E in questa introduzione all’introduzione, che si salda al
resto del trattato con l’accelerando proprio delle Einleitungen delle sinfonie schumanniane, già compaiono scaglie cristalline di metalli rari, di quelli che erano ancora da scoprire
al tempo dell’alchimia, nel quale certa musicologia italiana
giaceva allora wie eingeschlummert. Un esempio per tutti
(non credevo ai miei occhi quando ho visto, nell’edizione
del 1962, esattamente le stesse parole dell’edizione 1984: in
quel caso nulla era stato aggiunto): quando nella prima pagina l’autore parla di Stilkritik, in un contesto che, se all’inizio
degli anni sessanta poteva apparire connesso alle discipline
artistiche e all’archeologia, è oggi invece inderogabilmente legato al suo côté storico-antropologico, non fa altro che
anticipare di quarant’anni, con una fulminante intuizione,
uno dei temi à la page dell’odierna semiotica, tanto da essere
inserito tra i fili conduttori dell’XI Convegno internazionale della Deutsche Gesellschaft für Semiotik del 2005, intitolato per l’appunto Stil als Zeichen. Funktionen – Brüche
– Inszenierungen (Stile come segno. Funzioni – trasgressioni –
messinscene), ove un’intera sezione presenta una ricerca della
cattedra di letteratura comparata e comunicazioni (Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft und Medienforschung) dell’Università europea Viadrina di Francoforte
sull’Oder, intitolata per l’appunto Critica stilistica storica e
antropologia. E la sensazione che si tratti di un presagio, di
un’«illuminazione», si concretizza una trentina di pagine
più avanti (per l’esattezza alla p. 32 dell’edizione Piccola
biblioteca Adelphi, p. 31 della prima edizione nella Piccola
biblioteca Ricordi), dove tra gli autori menzionati, al seguito
di Theodor Wiesengrund Adorno, compare Claude LéviStrauss, sette anni prima che Luciano Berio ne utilizzasse i
testi in Sinfonia (1968-1969). Di Lévi-Strauss, oltre ai Tristes
tropiques del 1955 e all’Anthropologie structurale del ’58, si
Il popolo è inteso […], come ci dice un frammento di Novalis, come
un’idea, idea che riassume in sé una vicenda oscura di sofferenza: la miseria tedesca marxiana, che il Lukács ha preso a tema centrale del suo schizzo. Ma a questo punto Novalis interviene: «Si dovrebbe essere orgogliosi
del dolore. Ogni dolore è un ricordo del nostro alto rango. Le malattie
distinguono l’uomo dagli animali e dalle piante. L’uomo è nato a soffrire. Tanto più misero, tanto più sensibile alla morale e alla religione. [...]
Sempre più trionfanti diventeranno la religione e la moralità, queste basi
del nostro essere». E qui non solo si nega ogni possibilità di redenzione
sociale, ma si proscrive perfino la volontà di saltarne fuori. È necessario,
è doveroso accettare quello stato di cose, perché da esso nasce la salvezza
dell’esperienza basilare, concepita sempre più come unitaria: esteticoreligiosa. (p. 37; qui e più avanti si cita sempre dall’ed. 1984)
Novalis che teorizza quindi l’accettazione della condizione
umana, la celebrazione dell’amore (di quell’intesa sociale destinata a divenire la Christenheit-Europa [cristianità-Europa] del celebre saggio) «e anzitutto [del]la patria tedesca del
nuovo nazionalismo – séguita Bortolotto; – a costituirsi, si
vorrebbe dire, quasi come corpo mistico». Come nei migliori testi filosofici è qui esemplificato quel «profondo iato» tra
la nascente Romantik, erede degli Stürmer und Dränger, e
l’Illuminismo e la stessa Weimarer Klassik. Invano abbiamo
cercato qualcosa di più vicino all’anima di Schubert di quelle parole novalisiane citate da Bortolotto: «“Il Lessing vedeva troppo acutamente e perdeva per questo il sentimento
dell’oscura totalità, la visione magica degli oggetti, nel loro
insieme, nella molteplicità delle luci e delle ombre”. La storia
tedesca, presente tutta nell’istante poetico, nel sogno dell’anima bella, è una storia ideale eterna: onde nei più radicali
non si parlerà neppure di un ritorno all’evo medio, ma di una
presenza in atto» (p. 38).
Qui si vede la capacità di far germinare il pensiero: non possiamo non aggiungere oggi, con il conforto del fondamentale saggio su Wagner3, che qui sta tutto il problema della non
autenticità, o quanto meno del non romanticismo, del Lipsiense e del suo neogotico, opposto al romanticismo, a quella
sorta di grande Liederkreis con cori, più simile al Faust e
al Manfred, che è per esempio la Genoveva di Schumann,
criticata da Wagner, perché non compresa, né da parte sua
in alcun modo comprensibile. «In ogni caso, l’accettazione
dell’attualità “alienata” è il punto di partenza. Essa diviene,
in Beethoven e in Schubert, Wonne der Wehmut, Lob der
Thränen: voluttà della pena, elogio delle lacrime. Schiude
infatti l’unica salvezza: la “immaginazione” in cui consiste
“il più gran bene”» (Ibid.).
Un ulteriore elemento che emerge nel corso dell’analisi, anche
particolareggiata, di molti
Lieder, indagati dal punto
di vista melodico, armonico, formale, o da
quello del rapporto testo-musica,
è il confronto fra
le diverse versioni
musicali di uno stesso testo letterario: è il
caso della goethiana
Mignon («Kennst du
das Land»: Beethoven, 1810; Schubert,
1815; Schumann,
1849; Wolf, 1888).
Quasi venti pagine
(pp. 42-60), fitte di
concetti che anti-
Franz Schubert.
Il provetto stregone
intuisce che Bortolotto aveva in certo senso prefigurato non
solo alcune pagine del primo scritto appartenente alla tetralogia dei Mythologiques, Le cru et le cuit, apparso due anni
dopo il Lied romantico, nel 1964, ma anche quelle di Regarder écouter lire, pubblicato a trent’anni di distanza, nel 1993,
laddove Lévi-Strauss (a proposito di Wagner), dialogando
con un interlocutore d’eccezione quale Michel Leiris (dietro
cui sta in realtà la figura del comune amico René Leibowitz),
da un lato gli rimprovera di occuparsi del testo e non della
musica, dall’altro afferma provocatoriamente che la verità
della storia è nel mito e non viceversa. Ma quella che sembra
una provocazione, Mario Bortolotto lo intravedeva già negli
ormai lontani primi anni sessanta, perde la sua efficacia se la
si legge nel contesto della tradizione dialettica occidentale,
in particolar modo riguardo alle arti. Non solo nelle arti e
nella musica, ma persino nella critica letteraria è ormai un
dato acquisito quanto il mito influenzi in vario modo e a vari
livelli la storiografia. Se Le Goff e Foucault avessero recensito il libro di Bortolotto avrebbero visto in questo capitolo
introduttivo un parallelo con le allora vivissime polemiche
contro l’antropocentrismo e contro il concetto di storia globale. Seguendo questo pensiero apparentemente sghembo,
e utilizzando termini forse impropri, direi che Bortolotto,
con il suo trattato, offre una precisa testimonianza di come
fosse ormai risibile, all’epoca della nouvelle histoire, scrivere
una storia del Lied, ma fosse invece necessario affrontare i
problemi posti da una serie di microstorie dei Lieder e dei
loro autori.
E, cosa che rende il libro incredibilmente attuale, gli autori
del passato sono messi in costante dialogo con gli autori del
presente o del passato prossimo. Non vi è pagina dove non
si parta da Bach per giungere a Thomas Mann, da Pfitzner,
Claudel e Stockhausen indietro a Venanzio Fortunato e al
Medioevo tedesco, indagato questa volta per nulla en passant
da una mezza dozzina di pagine per poter leggere le quali
non basta passare un pomeriggio in biblioteca.
Cosa che altrove è richiesta più gradatamente, quando ci si
immerge nelle medias res degli autori a noi più noti, sempre
posti in relazione con l’oggi della musica, della letteratura,
della storia delle idee. Per esempio, quando si parte dalla coscienza che con la deutsche Romantik è «intervenuta di riflesso, anche nella musica tedesca, una reale frattura. Dopo i
nuovi ideali religiosi della Nona («Über Sternen»), parallelo
esatto alle Reden über die Religion di Schleiermacher e alla
Christenheit oder Europa di Novalis (per tacere di infiniti
altri apporti), è impensabile una ulteriore variazione»1. In
Italia bisognerà attendere gli stessi ventidue anni che separano la prima dalla seconda edizione dell’Introduzione al Lied
romantico, perché uno studioso quale Luigi Magnani riprenda il tema del Beethoven lettore di Omero e della Gräkomanie viennese2; un libro nel quale, peraltro inspiegabilmente,
Novalis non è nemmeno citato, e Schleiermacher una volta
soltanto, quale traduttore della Repubblica di Platone nell’edizione posseduta da Beethoven.
Novalis, invece, in Bortolotto ritorna puntualmente in
antitesi con le formulazioni di Lukács, introducendo così il
concetto di popolo cui il Lied si ispira, e occupando tre delle
trentaquattro pagine introduttive, sulle quasi duecento pagine del libro:
73
Mario Bortolotto e le vie della musicologia
74
cipano una nutrita serie di studi di musicologia comparata
da parte di più giovani leve della critica (pensiamo al saggio
schubertiano di Giuseppina La Face Bianconi)4. Ma di esse
non si può non citare quella che, se non ne è affatto la conclusione (in quanto invece di chiudere strade ne apre di nuove),
ne è, in certo modo, il paradigma critico:
Il confronto fra le quattro versioni del Lied, favorito dall’identità del
testo, conclude a una verificazione fondamentale: la tendenza al comportamento organico, unitario: alla canzone durchkomponierte. [...] Ove la
dissoluzione dello schema, della forma presupposta risulti impossibile,
come nel nostro caso, il compositore riforma dall’interno le strutture
accettate, arrivandosi con Wolf a mutarle integralmente: la variazione
annulla la ripetizione; e niente rimane dell’antica strofe unitaria, sotto la
quale si arrivò a segnare fino a sei testi sovrapposti5. Dopo questa rinnovata vocalità, affiancata dalle affini elaborazioni di Mahler, il Lied non
può che eliminare gli ultimi elementi della sussunzione popolare, e quella
sorta di musica al quadrato ante litteram rovesciarsi nelle depressioni morali e nelle assorte veggenze della Wienerschule. (pp. 59-60)
E qui, di nuovo, come non vedere un apoftegma patrum nella definizione che segue: «Le sillabazioni iniziatiche di Webern portano il Lied a schivare ogni ricerca di salvezza per
ascoltare la verità del suono-simbolo, nel silenzio dell’uomo
interiore». Questa volta è Hölderlin e con lui i suoi migliori
interpreti novecenteschi, da George a Heidegger. Ma eccolo
citato, Hölderlin, quarantasette pagine più avanti (p. 107),
con i Götter Griechenlands, insieme al Leopardi dell’Inno ai
Patriarchi, incomprensibile a chi non ne ricordi il sottotitolo
(De’ principii del genere umano).
Le settantacinque pagine (pp. 35-109) dedicate a Schubert
(che hanno per accompagnatori Mozart, Tomášek, Beethoven, Zelter, ma anche Schiller, Goethe, Lessing, Winckelmann, Novalis, Schlegel, Kierkegaard, e, quali paratesti,
tra gli altri Nietzsche, Marx, Lukács) si concludono con un
tramonto del compositore viennese dalle omeriche «dita
di rosa», che prelude all’alba di Schumann, forse mai così a
fondo, e così «germanicamente» compreso, se non da John
Daverio6:
della lirica amorosa, e le zuppe, le gelatine di tante graziose
raccolte tutt’oggi pubblicate» (p. 142).
Quasi nessuno – neppure conoscendo intimamente il
Brahms dell’opus 33, le quindici romanze composte tra il
1861 e il 1868 a Münster am Stein, dove il compositore aveva
steso i primi abbozzi, poi abbandonati, della Prima Sinfonia,
e dove si trovava in compagnia di Clara Schumann e dei figli
di lei: quell’opus 33 i cui testi erano stati tratti dal romanzo
della bella Magelone, in Italia quasi ignoto: Liebesgeschichte
der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence,
– quasi nessuno, dicevo, penserebbe di paragonare la prosa
brahmsiana a quella di Tieck (p. 148). E varrebbe la pena di
discutere con Mario Bortolotto se, oltre beninteso al celebre articolo di Schönberg (nel 1962 non ancora così celebre)
da lui citato, Brahms the Progressive8, avesse ragione anche
quel critico contemporaneo di Brahms oggi ingiustamente
dimenticato, che titolava all’inizio del Novecento uno dei
capitoli conclusivi della sua bella epitome sulla storia musicale (allora) contemporanea «Der Klassizismus. Johannes
Brahms»9. Come non pensare, oggi, alla rilettura «classica» che ne ha dato di recente l’ormai celebre raccolta saggistica di Giorgio Pestelli, che ridiscute, tra le altre, anche
le tesi contraddittorie di Walter Niemann?10 Nemmeno al
caustico Ladislao Mittner – che definiva la Rapsodia per
contralto, coro e orchestra di Brahms anziché il suo «Canto
di Fidanzamento», come il compositore aveva scritto a Clara
Schumann, «il canto della sua incapacità di fidanzarsi»,11 –
sarebbe venuto in mente di stabilire un’equivalenza tra il preteso paganesimo di Brahms e quello di Chesterton (le celebri
pagine sull’ateismo del Manalive vestito di verde). E a pochi, prima di leggere Bortolotto (mentre a posteriori appare
chiarissimo), risulta chiaro come questo preteso paganesimo
sia da identificare piuttosto con una religiosità à la Schleiermacher: quel «senso e gusto dell’infinito» (il celebre passo
del teologo di Breslavia citato da Thomas Mann nel Doktor
Faustus: «Sinn und Geschmack für das Unendliche»), che
è l’«essenza del fenomeno religioso» (p. 152).
Su Wagner, tre pristine rose: tante sono le pagine (154-
Il pensiero idealista, fermamente radicato sui temi dell’umanesimo,
chiarendo la responsabilità tutta umana della storia, parve determinare
in quegli anni, come è stato notato, una seconda perdita del Paradiso. Da
ogni parte d’Europa, Foscolo, Leopardi, Hölderlin, Blake, Keats, Coleridge, Platen, Nerval, e finanche, in termini di esulcerata ironia, l’amato
Heine, sembrano insegnare agli uomini, nella consolazione del canto, a
dischiudere nuove attualità edeniche. Il candidissimo Schubert, uomo di
poca filosofia, poco dovette saperne: ma intuì quella necessità di ritorno,
che riporta la favola umana a condizioni di primordio. (p. 108)
Chi ha letto lo Schumann delle prime pagine dei Tagebücher 7 lo sente già palpitare in queste parole. Bastano
infatti meno pagine (solo ventotto, contro le settantacinque
dedicate a Schubert) per giungere a un epilogo più da Eusebio che da Magister Rarus: «La conclusione di Schumann è
[...] uno stupito accecato fissare le ragioni che la ragione non
conosce: proprio attraverso il contatto immediato con la materiale tangibilità degli oggetti». Gli stessi echi schumanniani dell’infanzia sono qui accostati alla bella definizione di
Adorno riguardo al «sempre vano tentativo degli uomini di
nominare le cose stesse» (p. 136).
Il terzo capitolo, dedicato a Mendelssohn e a Löwe, consta di sole sei pagine (pp. 137-142), divertentissime, dove la
materia passa «dalla natura trascendentale del Gesang der
Geister schubertiano alle canzoni da Touring Club, per le
escursioni educative della media borghesia (la “malvagia”
borghesia di Adorno), tra la religiosità sublime o la tenerezza
Robert Schumann.
Richard Wagner.
1. Mario Bortolotto, Introduzione al Lied romantico, Adelphi, Milano 19842 («Piccola Biblioteca», 165), p. 13.
2. Luigi Magnani, Beethoven lettore di Omero, Einaudi, Torino 1984 («Saggi», 668).
3. Mario Bortolotto, Wagner l’oscuro, Adelphi,
Milano 2003 («Saggi. Nuova serie», 42).
4. Giuseppina La Face Bianconi, La casa del mugnaio. Ascolto e interpretazione della Schöne Müllerin, Olschki, Firenze 2003 («Historiae musicae
cultores», 102).
5. Si pensi a Mahler, Quarta Sinfonia, lo stupefacente Finale (Sehr behaglich «Das himmlische
Leben») su quell’algido testo del Wunderhorn:
nient’altro che una serie di variazioni.
6. John Daverio, Robert Schumann: Herald of a
“New Poetic Age”, Oxford University Press, Oxford-New York et al. 1997; Id., Crossing Paths:
Schubert, Schumann and Brahms, Oxford University Press, Oxford-New York et al. 2002.
7. Robert Schumann, Tagebücher, 3 voll., hrsg.
von Georg Eismann und Gerd Nauhaus, VEB,
Leipzig 1971-1087.
8. Arnold Schönberg, Brahms the Progressive
(1933-1947), in Id., Style and Idea, Philosophical Library, New York 1950; trad. it. di Maria
Giovanna Moretti e Luigi Pestalozza, Brahms il
progressivo, in Id., Stile e Idea, con un saggio introduttivo e a cura di Luigi Pestalozza, prefazione di
Luigi Rognoni, Rusconi e Paolazzi, Milano 1960
(«Le poetiche»); rist. Feltrinelli, Milano 1975
(«I fatti e le idee», 293).
9. «Der Klassizismus. Johannes Brahms und
seine Nachfolge» è il titolo dell’Erstes Buch nel
volume di Walter Niemann intitolato Die Musik der Gegenwart und der letzten Vergangenheit
bis zu den Romantikern, Klassizisten und Neudeutschen, Schuster & Loeffler, Berlin [1913]
192113-17, pp. 32-60.
acute definizioni che lo studioso friulano dà del Lied del secondo Ottocento, nel quale «la preoccupazione conoscitiva
finisce nella soddisfazione artigianale» destinata a «divenire indagine di se stesso, poesia della poesia, o analisi del
fare poetico» (p. 160), si celi un’ironica risposta agli strali di
Léon Daudet e del suo Le stupide XIXe siècle (1922).
La personalità di Hugo Wolf, non mi riferisco soltanto alla
puntuale analisi del suo Nachtzauber su testo di Eichendorff
(pp. 184-186), incontra per la prima volta in Italia un interprete degno di tal nome; e pure in ambito germanico, dove
al più si era fatto del facile biografismo legato alle sue amare
vicende umane, non molto era stato scritto che fosse realmente degno di essere conosciuto.12 E la meravigliosa scoperta, che non è mera trouvaille, dell’inaspettata considerazione
di Ravel per il grande viennese (p. 190), non appare poi così
insospettabile, se si pensa a cosa rappresenti per il Novecento
un capolavoro-enigma qual è La valse.
All’amato Strauss, sei pagine (198-203): ma bastano a far
cantare con nuovissimi accenti i Vier letzte Lieder, e non
soltanto; solo due a Pfitzner (pp. 204-205), morto nel 1949,
fedele «a un passato indimenticabile, sepolto ormai come
ricordo o sedimento nell’anima del provincialismo tedesco»: così si conclude la parabola del Lied romantico, con
un asintoto verso le zone dell’incognita negativa, quella del
feroce antagonista del preteso futurismo musicale teorizzato
da Ferruccio Busoni.
E quando, infine, nell’explicit, Liszt sembra passar la mano
a Sainte-Beuve13 («La nuova schiatta del Lied, la mutata,
è […] troppo vibrante di passione moderna per trovar luogo idoneo “dans cette étude du déclin”»), fieri delle parole
espresse su di noi da Mario Bortolotto, viviamo nella speranza che il futuro ci riserbi, magari fra un secolo, alla scuola ideale del suo pensiero inimitabile, un nuovo sublime interprete
dei nostri rinnovati canti. ◼
10. Giorgio Pestelli, Canti del destino. Studi su
Brahms, Einaudi, Torino 2000 («Saggi», 833),
in particolare il paragrafo 9 del cap. V, «Diritto
degli artisti agli anacronismi», pp. 174-177 (dove
si fa riferimento a Niemann, Brahms, Schuster &
Loeffler, Berlin 1920).
11. Ladislao Mittner, «Brahms ovvero un ultimo
saluto all’Ottocento», in Id., Storia della letteratura tedesca, vol. 3, Dal realismo alla sperimentazione (1820-1970), Einaudi, Torino [1968] 19712,
tomo I (Dal Biedermeier al fine secolo (18201890)), pp. 848-849.
12. A partire dalle prime biografie degli amici
(Ernst Décsey e Heinrich Werner) e dal moltiplicarsi di testimonianze ed epistolari inediti (più di
venti dal 1903, anno della morte di Wolf, al 1962,
anno di pubblicazione del libro di Bortolotto),
senza contare ben quattro studi di taglio psicopatologico, bisognerà attendere gli stessi anni
sessanta, perché veda la luce uno studio organico
sull’opera liederistica del compositore viennese
(Eric Sams, The Songs of Hugo Wolf, Foreword by
Gerald Moore, Methuen, London 1961, aggiornato nel 1983 per Eulemburg, London, e tradotto
in italiano da Erik Battaglia per Analogon, Asti
2011, quale numero 9 della collana «Le opere
di Eric Sams»). Dei circa cento titoli apparsi dal
1903 al 1962, quattordici sono biografie più e
meno romanzate, dieci sono tesi di laurea; mentre
solo una dozzina sono brevi studi critici sui Lieder, di cui pochi hanno lasciato traccia nei lavori
sopra citati di Eric Sams e in quelli più recenti e
approfonditi della maggiore studiosa di Wolf,
Susan Youens (Hugo Wolf. The Vocal Music, Princeton University Press, Princeton 1992, e Hugo
Wolf and His Mörike Songs, Cambridge University Press, Cambridge 2000, rist. 2006).
13. La metafora è giocata su un termine che a noi
non può non suonare lisztiano: «In Strauss po-
stremi titoli, che parlano di settembre, di sonno e
occaso, ci inducono, nella commozione dell’estinguersi, a considerare gli ultimi passi anche possibilità di consolation: così Liszt sembra passar la
mano a Sainte-Beuve» (p. 205). In realtà è Bortolotto che rilegge Sainte-Beuve facendogli «passar
la mano» da Strauss a Liszt e, ripercorrendo il passaggio riprodotto, ci si accorge che si tratta di una
citazione quanto mai ellittica: non è Bortolotto a
creare la lisztiana consolation, ch’è già presente in
Sainte-Beuve (in un brano da lui non riportato);
egli si limita solo a sottolinearla nel suo testo con
un lieve tratto di penna, che il tipografo non può
che tradurre in corsivo. Il passo è tratto dal Livre
sixième di Port-Royal, intitolato Le Port-Royal
finissant: «La fin de la vie est toujours triste. Estce une tristesse de plus, n’est-ce pas plutôt une
consolation [sottolineatura nostra], de sentir que
l’on s’en va avec tout un ordre de choses, et que ce
qu’on affectionnait le plus dans la vie, ce qui nous
y rattachait le plus étroitement, nous a précédé ou
nous accompagne dans la mort? Le fait est qu’en
tout genre Boileau [-Despréaux, Nicolas, 16361711] estimait son siècle fini et très-fini quand il
mourut. Ce n’était plus ce qui s’appelle le siècle
ni le temps qui l’occupait, il pensait à l’Éternité.
Véritable chrétien, honnête homme exemplaire,
il était trop essentiellement poëte [...] pour n’être
pas traité ici comme l’un des nôtres, pour n’avoir
pas une place exacte dans cette étude du déclin»
(C[harles].-A[ugustin]. [de] Sainte-Beuve, PortRoyal, Renduel-Hachette, Paris 1840-1859; la
citazione è stata controllata sul quinto dei sette
tomi che formano la troisième édition, Hachette,
Paris 1867, p. 520); le due versioni delle Consolations (Six penseés poétiques) lisztiane erano apparse per i tipi di Breitkopf & Härtel: nel 1844-1948
la prima, nel 1849–1850 la seconda...
Il provetto stregone
156) dedicate
a l l ’a u t o r e
del Tristano
nell’Introduzione
al Lied romantico.
Vol g endo
al contrario quell’aforisma di
Oscar Wilde secondo il
quale dietro
ogni cosa buffa va ricercata
una verità nascosta, pare
quasi che
dietro le
75
carta canta — libri
76
Le recensioni
D
di Giuseppina La Face Bianconi
i Ellen Rosand, che insegna storia della musica alla Yale, i cultori dell’opera veneziana del Seicento apprezzano l’imponente monografia Opera in 17th-Century Venice: the Creation of a Genre (1991; è in cantiere una traduzione italiana). In questi anni la studiosa statunitense ha continuato a dissodare il campo: ha promosso l’edizione critica delle opere di Francesco
Cavalli (Kassel, Bärenreiter, 2012); e nel 2007 ha pubblicato
una monografia su Le ultime opere di Monteverdi, uscita ora
da Ricordi in un’edizione italiana attentamente curata da Federico Lazzaro. Il sottotitolo dell’ampio lavoro (Trilogia veneziana) implica una tesi. Per quanto diversi, Il ritorno d’Ulisse in patria (1640), Le nozze d’Enea con Lavinia (1641) e
L’incoronazione di Poppea (1643) costituirebbero un trittico
su un «programma» implicito: glorificare le mitiche origini
di Venezia. Per gli intellettuali del Seicento la Serenissima discende idealmente dall’antica Troia. Ora, proprio ai poemi
omerici rimanda la vicenda del rimpatrio d’Ulisse nel dramma stilato da Giacomo Badoaro. Fuggito da Troia, Enea approda nel Lazio per fondarvi una nuova civiltà dai fulgidi destini, Roma: è questo il tema delle Nozze d’Enea (dramma di
cui rimane il libretto, attribuibile al lucchese Michelangelo
Torcigliani, non però la musica di Monteverdi). A sua volta
la Repubblica veneta si concepisce come erede legittima della Roma repubblicana, opposta al degrado morale e politico
della Roma imperiale: nell’èra
di Paolo Sarpi
e dell’Interdetto, attingere dagli Annali di Tacito lo spettacolo della tirannide neroniana
equivaleva a celebrare, per contrasto, la sovranità e la libertà di Venezia.
È il caso dell’acre, beffarda trama dell’Incoronazione di Poppea di Busenello, fondata sugli amori scellerati di Nerone, la criminale sete di vendetta
d’Ottavia e l’agguato omicida di Ottone ai danni dell’eroina. La tesi, affascinante, è argomentata da Rosand su molti piani – storia delle idee, critica delle fonti, analisi stilistica, drammaturgia – e va attentamente considerata. Certo,
l’ideologia «negativa» del terzo dramma stride con quella
«positiva» dei primi due: il che ha suscitato lo scetticismo di
qualche recensore. Ma nessun amante del teatro monteverdiano può fare a meno di confrontarsi con una monografia
così generosa di sapienza e acume critico.
Carlo Piccardi è uno dei musicologi e operatori
musicali di spicco nella Confederazione Elvetica. Autore di
numerosi saggi, in particolare sulla musica per la radio e il cinema, per decenni ha lavorato come direttore della rete culturale della Radiotelevisione Svizzera italiana. Ricordi e lim
pubblicano ora un corposo volume sui Maestri viennesi, che
Ellen Rosand,
Le ultime opere di Monteverdi. Trilogia veneziana,
edizione italiana a cura di Federico Lazzaro,
San Giuliano Milanese, Universal Music Publishing Ricordi,
2012, xix-440 pp., isbn 978-88-7592-905-3, euro 28,00.
Carlo Piccardi,
Maestri viennesi.
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Verso e oltre,
San Giuliano Milanese, Universal Music Publishing Ricordi –
Libreria Musicale Italiana, 2012 («Le Sfere», 53),
vii-744 pp., isbn 978-88-7592-895-7, euro 32,00.
Arnold Schönberg,
Il pensiero musicale,
a cura di Francesco Finocchiaro,
Roma, Casa editrice Astrolabio – Ubaldini, 2012 («Adagio»),
339 pp., isbn 978-88-340-1602-2, euro 32,00.
tratta i quattro sommi, Haydn Mozart Beethoven Schubert,
col contorno di parecchi «minori». Si narra qui la nascita e
lo sviluppo di una fulgida civiltà musicale nella Vienna tra fine Sette e fine Ottocento. La capitale asburgica metabolizza
le esperienze musicali del passato e ne crea di nuove: i quattro grandi compositori non sono riconducibili sic et simpliciter a un’astratta «viennesità» (solo Schubert era nativo), ma
tutti si alimentarono della cultura offerta dalla città sul Danubio, così ricca di incroci colti e popolari. Il saggio di Piccardi è seducente, accattivante alla lettura, utile al musicologo come allo studente: ottimo lavoro, da salutare con gaudio.
Si deve a un giovane studioso di Schönberg, Francesco Finocchiaro, un’impresa ragguardevole: l’edizione bilingue del trattato che, nelle intenzioni del capostipite della
Scuola di Vienna, avrebbe dovuto compendiare il senso del
«pensiero musicale» e della «logica, tecnica e arte» in cui
esso si manifesta. La stesura fu avviata nel 1923; ma il lavoro rimase incompiuto. Negli anni novanta ne fu fatta una discutibile edizione inglese; ora Finocchiaro, in collaborazione
con l’Istituto Schönberg di Vienna, offre integro l’originale tedesco e vi appone un’accuratissima traduzione italiana,
che è nel contempo un prezioso commento. Un documento
intellettuale e critico di primaria importanza. ◼
È
di Ilaria Pellanda
uscito lo scorso aprile, per i tipi di effequ,
il primo volume che relega all’Inferno, non lascia
certo deserto il Purgatorio e fa assurgere al Paradiso
ben cinquant’anni di cantautorato italiano.
Il coraggioso autore che s’è cimentato nell’impresa è Guido Michelone, che ha dato alla luce una sorta di commedia
alla Dante Alighieri, con tanto di palchi e gironi.
E proprio come l’Alighieri allora, accompagnato nella sua
Divina commedia
da Virgilio e Beatrice, così oggi un
nuovo e scanzonato – è proprio
il caso di dirlo –
scrittore, Lazslo
Kovacs (alter ego
dell’autore), accompagnato dal
poeta Cecco Angiolieri e dalla signorina Francis
Nudella, si inoltra in una surreale fiera composta
proprio da Inferno, Purgatorio e
Paradiso. La abitano i cantautori italiani, appunto, accomodati
guido michelone,
fra cerchi, gironi e
La commedia dei cantautori italiani.
cornici, a seconda
Inferno – Purgatorio – Paradiso,
del contributo dieffequ editore, Orbetello, 2012,
pp. 240, 14 euro.
scografico fornito alla storia della
canzone d’autore nel Belpaese della musica. Un gioco divertente dove Michelone racconta, tra fiction e saggistica, mezzo secolo di voci e volti, caratteri e pensieri, da Domenico
Modugno e Fred Buscaglione a Francesco Guccini e Fabrizio
De André (tutti e quattro in Paradiso), da Luigi Tenco (anche lui nel più celestiale dei cerchi) a Jovanotti, Vasco Rossi,
Claudio Baglioni (relegati all’Inferno) e molti altri ancora,
svelando pregi e difetti di novantanove personaggi tratteggiati con humor, ironia e teatralità.
«Questo libro è un gioco della memoria su pensieri e parole – si legge nella premessa di Andrea de Antonio –, su nomi
e cognomi, su canzoni e cantautori. È anche un gioco “sulla” memoria del passato e del presente, gioco esercitato attraverso i ricordi, le sensazioni, i ragionamenti, le idee che suscitano alcuni pezzi e i loro interpreti (sovente essi stessi autori). Non è un’altra storia della musica leggera nazionale, perché già molte ne esistono e si correrebbe il rischio di non dire nulla di speciale, al momento. Questo libro è piuttosto il
tentativo di coniugare Marcel Proust (che diceva che la canzone – e non solo la musica più “seria” come quella classica,
ad esempio – si ricorda e si ama di più grazie all’immediatezza del messaggio, ndr), Dante Alighieri e i giochi a premi che
sono andati assai di moda nell’Italietta televisiva di questi
ultimi cinquant’anni, forse non a caso in parallelo ai successi della cosiddetta “canzone d’autore”». ◼
Emma Dante
e la sua Biancaneve
P
alazzo reale. La regina è nella sua stanza da letto davanti allo specchio. Si spoglia. Si
toglie il rossetto facendo le smorfie. Si ammira. Si guarda di profilo, davanti, di dietro. Lo
specchio la imita in tutto e per tutto».
Comincia così la rilettura che la drammaturga e regista siciliana Emma Dante fa della favola di Biancaneve nel suo Gli
alti e bassi di Biancaneve, pubblicato la scorsa primavera per
i tipi della Tartaruga, illustrato ancora una volta da Maria
Cristina Costa, che già aveva lavorato con la Dante al libro
Anastasia, Genoveffa e Cenerentola (cfr. vmed n. 41, p. 86),
e divenuto anche uno spettacolo cupo e colorato, divertente
e profondo (presentato lo scorso 9 agosto all’interno del cartellone dell’Operaestate Festival).
Vi è poi subito il famoso scambio tra la regina – curiosa
di sapere chi sia la più bella del reame – e il suo specchio:
«Dimmìllo ora, forza!», dice la sovrana.
E lo specchio: «Sei bella, bellissima, favolosa, attraente, eccitante, sexy, meravigliosa, appetitosa, burrosa, voluttuosa,
con le mani lunghe e affusolate ca putissi suonare la settima
di Beethoven… coi capelli ricci e voluminosi, chilometri di
capelli… il culetto sodo, ‘u pigghiassi a muzzicuni stu culu!
La pancia piatta, ‘a
vita stritta, la bocca rossa, carnosa,
gli occhi grandi…!
E che muscoli che
hai? Miss Olimpia
2012, la forza della natura in persona! Sii ‘a megghiu
di tutto il reame!».
Em ma Da nte
continua dunque
il suo viaggio nel
mondo delle fiabe
con una nuova inEmma Dante,
terpretazione viGli alti e bassi di Biancaneve,
sionaria e crudele,
illustrazioni di Maria Cristina Costa,
dove l’alto si fa basMilano, La Tartaruga edizioni, 2012,
pp. 48, 18,00 euro.
so e il basso si fa alto. La regina rappresenta l’«alto», il pericolo di un’esaltazione del proprio io
che rende malvagi e chiusi. La sovrana interroga lo specchio,
Biancaneve il suo cuore, e l’invidia che tormenta la matrigna
è tale da farle desiderare di uccidere la rivale. Quando, con un
incantesimo, decide di trasformarsi in una vecchia per offrire alla giovane la mela avvelenata, eccola diventare altissima,
per poi ricevere però una punizione esemplare che le farà perdere la memoria e che non le permetterà di ricordare la formula dell’antidoto. Tutto è sproporzionato, come le cose che
vedono i bambini. C’è uno specchio che riflette sogni e paure, azioni malvagie e fughe verso la libertà. E un mondo dove
anche i mostri insegnano a crescere.
E se la matrigna rappresenta il rischio dell’esuberanza del
proprio sé, saranno invece i nanetti – «piccoli» minatori
che hanno perso le gambe durante un’esplosione – a costringere Biancaneve ad abbassare lo sguardo e a essere umile.
Il lieto fine comunque non manca: Biancaneve viene risvegliata dal suo sogno incantato da un bel principe. E tutti ballano dalla felicità. (i.p.) ◼
«
carta canta — libri
Palchi e gironi
per i cantautori italiani
77
carta canta — libri
78
«L’attore civile»
di Paola Bigatto
e Renata Molinari
L
di Leonardo Mello
a vita di un teatro e della sua scuola, ma anche della sua città, in un periodo cruciale della loro
esistenza: così si potrebbe definire, molto riduttivamente, L’attore civile. Una riflessione tra teatro e storia attraverso un secolo di eventi all’Accademia dei Filodrammatici di Milano di Paola Bigatto e Renata M. Molinari. Così, affrontando i diversi capitoli, sempre intitolati a un tipo di
attore («giacobino», «patriota», «professionista», «sensitivo» e «vate»), ecco che, nel 1796, si assiste alla nascita
dei Filodrammatici ad opera della Società Patriottica milanese, e in quel contesto si inserisce anche la recita della Virginia alfieriana alla presenza addirittura di Napoleone. Diversi anni dopo, nel 1862, a Unità appena conseguita, incontriamo Garibaldi in platea per vedere La sposa senza saperlo di
Giulio Genoino. In epoca postrisorgimentale poi si passa –
per citare solo alcune stazioni di questo articolato percorso –
dalla scoperta teatrale di Dante operata da Ernesto Rossi alle riflessioni sulla «suggestione
scenica» di Giuseppe Giacosa
all’arrivo, nel 1923, di Eleonora Duse a inaugurare la sede rinnovata per la seconda volta. Ma
il segreto che rende piacevolissima, anzi emozionante la lettura
sta nella forma in cui questo pregevole volume è stato concepito:
esso è infatti costruito con criteri eminentemente drammaturgici, come spiega con la consueta chiarezza Renata M. Molinari nel suo Prologo (pp. 7-8):
L’attore civile «si presenta strutturalmente come un’anomalia e
metodologicamente è un azzardo: non è un saggio storico, né
Paola Bigatto
teorico, e nemmeno la cronaca
e Renata M. Molinari,
di un evento o di un’istituzione
L’attore civile.
teatrale; è pensato come un tracUna riflessione tra teatro e storia
ciato drammaturgico. […] Il liattraverso un secolo di eventi
all’Accademia dei Filodrammatici bro racconta possibili spettacoli
o eventi spettacolari che potrebdi Milano,
bero prendere vita a partire dalTitivillus, Corazzano (pi),
pp. 200, euro 16.
le cronache e dalle fasi di crescita
di una comunità teatrale impegnata nella costante definizione e indagine del suo fare. Questa comunità teatrale è l’Accademia dei Filodrammatici, vista soprattutto in alcuni particolari momenti di incontro con
le vicende civili, politiche e artistiche della sua città: Milano.
Una Milano raccontata attraverso i suoi teatri – attraverso alcune serate in un suo teatro: una città osservata nell’intreccio fra vicende civili e diverse forme dell’arte drammatica e
delle riflessioni ad essa legate. Il tutto con un’attenzione sempre vigile al fare dell’attore, a quella particolare responsabilità del dire che egli declina sulle diverse scene della vita artistica e civile. Nell’avvicinarci e nel presentare momenti particolari di quella relazione attiva fra un’accademia e la sua città, gli accadimenti storici diventano tappe di un possibile itinerario nella pedagogia teatrale». ◼
«Scritto dentro»,
un libro bellissimo
B
agno il prato dove è più alto, perché
cresce sul mio cane sotterrato, la macchia di
trifoglio implosa nella conca, l’edera nella
spelonca celeste della civetta, le mille costellazioni di gramigna. Ma anche dove è rado, arido, secco, dove non c’è speranza eppure aspetto, bagno ancora, e il geroglifico da sciogliere è solo lo strato delle orme e delle anatre. E anche la terra nuda rinfresco, i sassi del
viale, le traversine che
diventano scure come
l’odore dei treni passati. E allora lavo anche
questo corpo estraneo,
la testa che sprigiona
un vapore di pensieri, i piedi quadrati nel
fango, gli occhi lasciati cadere, la gamba più
lunga del passo. Quella
matta che sente il tempo, che butta in parte,
sghemba asta a matita.
Quella che è buona soltanto a tremare. Eppure un tempo, insieme
all’altra e a un pugno
di idee, teneva su un
uomo»: queste le paFernando Marchiori,
role che concludono il
Scritto dentro,
primo tempo di Scritto
Poiesis, Alberobello (Ba) 2012,
pp. 110, euro 15.
dentro, il bellissimo libro di Fernando Marchiori, scrittore oltre che critico teatrale e studioso tra i più
seri e illuminati. Edito dalla pugliese Poiesis nella pregevole
collana «Le rive dei narratori», il volume descrive attraverso molte stazioni l’isolamento in cui Saetta, un Filottete dei
nostri tempi, si è rinchiuso dopo un tragico avvenimento dei
difficili anni settanta, in cui resta ucciso un suo compagno
di lotta. Neottolemo assume in questo caso i panni di una ragazza, Moira, figlia del grande amore di Saetta, che lo induce
con l’inganno e poi – presa dal rimorso – con la forza della
persuasione a testimoniare al processo per scagionare amici
d’un tempo chiamati in causa da uno dei molti pentiti, amici
che l’hanno abbandonato alla solitudine della sua esistenza,
in cui gli unici dialoghi il protagonista li instaura con piante e animali del suo giardino. Il frammento prescelto, nella sua ovvia parzialità, offre comunque già un saggio potente dell’universo in cui si muove questo uomo stanco e malato, che come lo sfortunato eroe sofocleo si ritira in un mondo
«altro», dove dimenticare le tracce dolorose del proprio passato. Ma al di là del tema, che riprende in modo inedito e affascinante un argomento scottante della nostra storia recente, quello che incanta è la scrittura, magmatica eppure controllata, impetuosa e discreta, poetica e teatrale (credo si potrebbe con facilità trarne un tesissimo e appassionante monologo, dato che alcune parti sembrano naturali didascalie
a un testo sempre perfetto): una lingua di «dentro», che associa vissuto individuale e vicende patrie, dove però si incontrano elementi universali, che ciascun lettore di oggi può facilmente fare e sentire propri. Un libro da leggere assolutamente, e tutto d’un fiato. (l.m.) ◼
«
L
di Leonardo Mello
a creatività giovanile, nelle sue molte sfaccettature, era uno dei pensieri ricorrenti di Giovanni Morelli, il quale più volte, anche con noi di VeneziaMusica, aveva ribadito l’importanza di monitorare le realtà sommerse, la «musica fatta in casa», come l’aveva definita lui stesso. E un interessante esempio di questa
tendenza lo offre un originale duo, Rockit & Gugly, nato un
paio di anni fa e composto, come suggerisce il nome stesso,
da Guglielmo Manfrin e Rocco Camatti, rispettivamente di
diciotto e ventun
anni. Questi due
ragazzi mescolano, in un assemblaggio ritmico
assai intrigante,
sonorità pop melodiche e cadenze
rap. Il loro sodalizio, nato dalla frequentazione dello
stesso liceo, ha dato luogo a un cd
autoprodotto, Reset, che mette insieme due modalità espressive differenti, appunto
il pop e il rap, trovando però un ottimo punto d’incontro tra le parole cadenzate dei testi (scritti da Rocco) e le linee dolci dei ritornelli (composti invece da
Guglielmo). Le canzoni parlano un po’ di tutto, ma sono tra
loro legate da una sorta di filo rosso che diventa anche, in un
certo senso, un flusso narrativo. Così – per citare solo alcune
tracce – si passa da «This Is Italy», dove viene descritto, nelle sue usanze e costumi, il Belpaese, a «Sideshow», in cui invece vengono messe in evidenza criticamente le disfunzioni
e le magagne tipicamente nostrane. Ma c’è spazio anche per i
sogni, con la bella «Dreams», e per una concezione più semplice e umana della vita, invocata in «Reset», che dà il nome
al disco, senza dimenticare il poetico e impegnativo affondo
sulla tragedia dell’Olocausto, evocata in «Fateless», di cui è
stato anche costruito un video utilizzando spezzoni dei più
importanti lungometraggi che hanno trattato l’argomento.
Il processo compositivo dei brani vede prima l’invenzione
delle basi musicali – opera di Guglielmo e creati al computer
grazie al programma Logic Pro 9 – cui poi vengono aggiunte
da Rocco le parole, sempre in lingua inglese. Se spesso si parte da un giro di chitarra, come ci racconta lo stesso Manfrin,
poi tutto passa per il supporto elettronico: si tratta di musica di buon livello, costruita e registrata in casa con strumentazioni professionali, che varrebbe la pena fosse valorizzata e
resa pubblica, tralasciando – com’è invece costume tutto italico – la diffidenza verso generi considerati, a torto, «minori». In realtà, attraverso le atmosfere sonore e le parole, ci si
addentra con crescente entusiasmo all’interno del pensiero,
per forza di cose contemporaneo, di due giovanissimi e promettenti musicisti. ◼
Il «Sunrise» del
Masabumi Kikuchi trio
U
di Giovanni Greto
carta canta — dischi
Il pop-rap
dei giovanissimi
Rockit & Gugly
79
n disco delizioso, tenero, malinconico, pieno
di vitalità. Eppure, nell’ascoltarlo, non c’è modo
di togliersi di dosso un velo di tristezza, pensando che non si potrà più sentire il fraseggio melodico, ritmico, ineguagliabilmente fantasioso e inventivo di Paul
Motian, il quale, a due anni dalla registrazione se ne sarebbe andato all’improvviso – aveva suonato dal vivo fino a due
mesi prima – lasciando artisti come Kikuchi dolorosamente sbigottiti. È dunque un disco postumo Sunrise, «il sorgere del sole», del settantatreenne pianista giapponese, che già
aveva suonato con Motian fin dal 1990. Dapprima in un trio,
«Tethered Moon», completato da Gary Peacock
– cinque dischi, a partire
da quello di esordio First
Meeting. Poi nel Paul Motian trio 2000 + Two con
Chris Potter, Greg Osby e
Mat Manieri, un organico che licenziò due dischi
dal vivo nel 2007 e 2008,
fino a quest’ultimo trio
formatosi nel 2009 e che
avrebbe potuto indubbiamente continuare a scrivere pagine significatiMasabumi Kikuchi trio,
ve nel segno dell’improvSunrise,
visazione. Sunrise, uscito
ecm Records, 2012
quest’anno, è il terzo alMasabumi Kikuchi, piano;
bum registrato da Motian
Thomas Morgan, contrabbasso;
nel 2009 per l’etichetta tePaul Motian, batteria.
desca ecm Records, preceduto da Lost in a Dream del Paul Motian trio, registrato dal
vivo al Village Vanguard e uscito nel 2010 e Live at Birdland,
con Lee Konitz, Charlie Haden e Brad Mehldau, uscito nel
2011. Un anno fecondo, dunque, il 2009, per un musicista che
a settantott’anni (era nato il 25 marzo del 1931) continuava
a suonare con un timbro cristallino e caldo, in maniera raffinata, lucida e stimolante, che lo caratterizza sin dal momento
della sua apparizione, breve purtroppo (dal 1959 al 1961), nel
forse, più bel trio «piano-basso-batteria» della storia del jazz:
quello con Bill Evans (piano) e Scott LaFaro (contrabbasso),
scomparso in un incidente d’auto il 6 luglio 1961.
Anche se è suddiviso in dieci tracce, Sunrise, di fatto, è una
lunga suite che si sviluppa secondo nuove possibilità improvvisative per un ensemble, come afferma il pianista nelle note di
presentazione. Il disco è registrato magnificamente, una consuetudine che ha reso celebre per la qualità del suono l’etichetta bavarese. Fin dal primo frammento, «Ballad I», avvertiamo nel fraseggio del trio la grande importanza data al silenzio, evitando cascate di note che possano appesantire. Si crea
in tal modo un’attesa, un’aspettativa per un qualcosa che si realizza nella maniera più appropriata. Kikuchi inizia a sondare
il terreno con piccoli tocchi, Morgan lo asseconda con estrema attenzione, Motian interviene come per commentare e lo
fa sapientemente, sia con le spazzole, sia con le bacchette, dando molta importanza ai piatti sospesi (una traccia è stata intitolata proprio «Sticks and Cymbals», «bacchette e piatti»).
Il tocco e il modo di percuotere lo rendono immediatamente
riconoscibile al primo ascolto, come soltanto avviene quando
a suonare è un maestro dello strumento. ◼
VeneziaMusica e dintorni
80
Bimestrale di musica e spettacolo
Come abbonarsi:
tramite versamento sul conto corrente postale n. 62330287
oppure
con bonifico bancario anche via internet iban IT 44 J 07601 02000 000062330287
indicando la causale del versamento
Prezzo unitario: 5 euro
Abbonamento ordinario a sei numeri: 25 euro
Abbonamento sostenitori a sei numeri: 40 euro
Per informazioni:
tel.
041 2201932
fax
041 2201939
e-mail
[email protected]
web
www.euterpevenezia.it
la «lou salomé»
di giuseppe sinopoli
Anno VIII - novembre / dicembre 2011 - n. 43 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241
Anno IX - gennaio / febbraio 2012 - n. 44 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241
gli artisti
e la critica
la
(p cr
ar it
te ic
se a
co o
nd g
a) gi
Eresia della felicità a Venezia
Anno IX - marzo / aprile 2012 - n. 45 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241
La «Carmen» di Bizet torna alla Fenice
la
c
(p rit
ar
te ic
te a o
rz g
a) g
i
Anno IX - maggio / giugno 2012 - n. 46 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241
la
c
(p r
ar it
te ic
qu a
ar og
ta g
) i
Anno IX - luglio / agosto 2012 - n. 47 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241
Anno IX - settembre / ottobre 2012 - n. 48 - bimestrale - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB PD - ISSN 1971-8241
VeneziaMusica e dintorni è acquistabile presso la redazione (Dorsoduro 3488/u, Venezia) e nei seguenti punti distributivi:
Libreria Al Capitello, Cannaregio 3762, Venezia; Libreria Cafoscarina, Dorsoduro 3259, Venezia; Libreria Goldoni, San Marco
4742, Venezia; Bookshop del Teatro La Fenice, San Marco 1965, Venezia; Bookshop della Scuola Grande di San Rocco, San
Polo, Venezia; Libreria Ub!k, Corso del Popolo 40, Treviso; Bookshop del Teatro Olimpico, Stradella del Teatro 8, Vicenza.
Le collaborazioni di questo numero
• Giò Alajmo (p. 43)
Critico musicale
• Giuliano Gargano (p. 27)
Giornalista
• Jacopo Pellegrini (p. 68)
Critico musicale
• Matteo Antonaci (pp. 10-11)
Critico teatrale (arttribune.com;
teatroecritica.net)
• Tommaso Gastaldi (p. 45 e p. 48)
Giornalista freelance
• Nicola Pellicani (pp. 62-63)
Segretario
della Fondazione Gianni Pellicani
• Gualtiero Bertelli (pp. 50-51)
Cantautore
• Giovanni Greto (p. 79)
Critico musicale – Musicista
• Federico Capitoni (pp. 28-29)
Critico musicale
• Filippo Juvarra (p. 42)
Direttore artistico
degli Amici della Musica di Padova
• Alberto Caprioli (pp. 72-75)
Compositore
• Giuseppina La Face Bianconi (p. 76)
Università di Bologna
• Alberto Castelli (p. 34 e p. 35)
Musicologo
• Andrea Oddone Martin (p. 39)
Critico musicale
• Paolo Cattelan (p. 40-41)
Musicologo
Presidente degli Amici
della Musica di Venezia
• Rossella Menna (pp. 9-10)
Critico teatrale (rumor(s)cena.com)
• Elena Conti (pp.12-13)
Critico teatrale
(iltamburodikattrin.com)
• Vitale Fano (p. 36)
Musicologo (Università di Padova)
• Roberta Ferraresi (pp. 13-15)
Critico teatrale
(iltamburodikattrin.com;
doppiozero.com)
• Mario Messinis (pp. 26-27 e p. 31)
Critico musicale
• Guido Michelone (p. 49)
Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano –
Conservatorio di Musica
«Antonio Vivaldi» di Alessandria –
Critico musicale
• Gian Paolo Minardi (pp. 69-71)
Critico musicale
• Paolo Petazzi (pp. 22-25)
Critico musicale – Docente di Storia
della Musica al Conservatorio
«Giuseppe Verdi» di Milano
• Andrea Pocosgnich (p. 15)
Critico teatrale (teatroecritica.net)
• Oliviero Ponte di Pino (pp. 16-19)
Critico teatrale
• Andrea Porcheddu (p. 8)
Critico teatrale
• Roberto Pugliese (pp. 56-57)
Critico cinematografico
• Eva Rico (p. 55)
Storica dell’arte
• Giada Russo (pp. 11-12)
Critico teatrale (ateatro.it)
• Emanuele Senici (pp. 64-65)
Università «La Sapienza» di Roma
• Arianna Silvestrini (p. 30)
Giornalista freelance