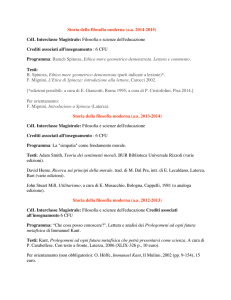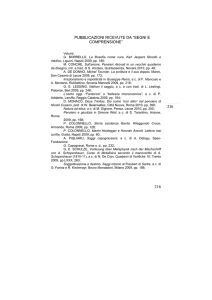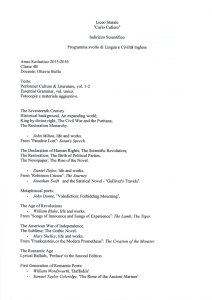RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XIX
NUOVA SERIE - N. 55 - MAGGIO-AGOSTO 2005
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia e
Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del
“Centro Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce,
e dello stesso Dipartimento.
2
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce),
Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno),
Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De Leo,
Lucia De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia
e Scienze sociali, Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel.
(0832) 294627/8; fax (0832) 294626. E-mail: [email protected]
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto
I, 51 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/205577 - 0832/200373. Iscritto al
n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento
annuo: Italia € 25,00, Estero € 35,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero
Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da
gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo € 10,00, degli anni precedenti il doppio.
Stampato presso Tiemme - Manduria
nell’aprile 2005 - per conto di Piero Manni s.r.l.
SOMMARIO
5
a c. di Michel Rybalka
UNA VITA PER LA FILOSOFIA
conversazione con Jean-Paul Sartre
21
a c. di A. Astruc, M. Contat, S. de Beauvoir
J.-L. Bost, A. Gorz, J. Pouillon
HUSSERL, LE COSE, L’INTENZIONALITÀ
Conversazione con Jean-Paul Sartre
25
Pierre Taminiaux
SARTRE E IL NOME DEL MALE
40
Pierpaolo De Giorgi
IL RITORNO DI DIONISO
A proposito di un libro di P. Pellegrino
47
Delfo Cecchi
DELEUZE LETTORE DI SPINOZA
70
Angela Ales Bello
PSICOPATOLOGIA FILOSOFIA POESIA
IN LUDWIG BINSWANGER
73
Bruno Callieri
LA CATTEDRALE SOMMERSA
Bianca Maria D’Ippolito legge Binswanger
76
Franca Mazzei Maisetti
L’ORIZZONTE SIMBOLICO E LA PSICOANALISI DELL’ARTE
SECONDO IL PENSIERO DI FRANCO FORNARI
92
Pietro Birtolo
IL TERRORISMO RELIGIOSO
119
Antimo Negri
L’ONTOLOGIA ELEGIACA DI MAURO FABI
3
124
Antonio Tursi
E-GOVERNMENT:
RETORICHE ED OPPORTUNITÀ
140
Marianna Pankiewicz
IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE
L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO
161
Recensioni
175
Libri ricevuti
4
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento di Filosofia e scienze sociali – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I
testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta
su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà
essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà
restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione
dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
UNA VITA PER LA FILOSOFIA
conversazione con Jean-Paul Sartre
DOSSIER SARTRE
Questa intervista era apparsa nel “Magazine Littéraire”, n. 384, février 2000, a cura
di Michel Rybalka e con il titolo Une vie pour la philosophie, un entretien avec Jean-Paul
Sartre. La traduzione di Lucia Angelino riporta i volumi sartriani con il titolo della edizione italiana. Tutte le note sono della traduttrice.
“Segni e comprensione” ringrazia Michel Rybalka e “Magazine Littéraire” che hanno
concesso i diritti per la traduzione italiana.
di Michel Rybalka
Intorno al 1972 Paul A. Schilpp, che dirigeva negli Stati Uniti la collezione
The Library of Living Philosophers, ebbe l’idea di fare un libro su Sartre, ottenendo da questi la promessa di una breve autobiografia e riunì una trentina di
testi critici che trattavano i molteplici aspetti della sua filosofia. In seguito Sartre, essendo diventato cieco, non poté mantenere la promessa, e decise allora di sostituire l’autobiografia con delle conversazioni. Queste, della durata di
circa sette ore, si svolsero il 12 e il 19 maggio 1975, in compagnia di Oreste
Pucciani, professore alla U.C.L.A., Susan Gruenheck, professoressa al Collège Americain di Parigi, e Michel Rybalka che aveva curato con Michel Contat
gli Ecrits di Sartre e l’edizione dei suoi romanzi nella collana La Pléiade. Sartre rifiutò di accettare la partecipazione di un filosofo dell’università francese.
Il testo integrale di queste conversazioni, trascritto e poi tradotto da S.
Gruenheck, riveduto da Michel Rybalka, è uscito nell’ottobre 1981 nel volume:
Schilpp, Paul A., ed. The Philosophy of Jean-Paul Sartre, The Library of Living
Philosophers, vol. XVI. Open Court Pub.Co.
Pubblicati per la prima volta in francese sul Magazine littéraire nº 182 del
marzo 1982, i brani che seguono sono stati estratti dal testo francese originale, con qualche modifica secondaria, e sono stati scelti da M. Rybalka. Essi si
propongono soprattutto di ripercorrere la biografia filosofica di Sartre e tralasciano gli aspetti più tecnici delle conversazioni, dal punto di vista filosofico.
Sono stati raccolti e pubblicati alcuni passaggi sul marxismo, sul maoismo e
sulla coscienza degli animali, inediti nella versione francese.
– Michel Rybalka1. Il suo progetto iniziale era di scrivere, di fare della letteratura; come è arrivato alla filosofia?
– Jean-Paul Sartre. Non mi sono appassionato alla filosofia quando seguivo le lezioni di filosofia. Avevo un professore che si chiamava Chabrier e che
era soprannominato «Cucu-Filo»2; non mi ha mai trasmesso la voglia di fare
filosofia. Questo desiderio non mi è venuto nemmeno durante l’hypokhâgne 3;
il mio professore –che si chiamava Bernes– si esprimeva in modo particolarmente difficile e non capivo quello che diceva.
5
6
È stato durante la khâgne4 che mi sono deciso, grazie ad un altro professore, Colonna d’Istria, un uomo invalido, piccolo, molto piccolo, che era stato ferito. In khâgne si raccontava che fosse stato investito da un taxi e che la folla gli
si fosse avvicinata dicendo: «Che orrore!». In realtà era così da sempre.
Il primo argomento che ci ha proposto per il tema, suggerendoci di leggere
Bergson è stato: «Che cosa significa durare?». Così ho letto Il saggio sui dati
immediati della coscienza ed è senza dubbio questa lettura che all’improvviso
mi ha dato la voglia di interessarmi alla filosofia. In quel libro ho trovato la
descrizione di quello che mi pareva fosse la mia vita psichica. Ne sono stato
catturato, quello è diventato per me un tema di riflessione. Mi sono detto che
mi sarei dedicato alla filosofia, allora la consideravo semplicemente come una
descrizione metodica degli eventi mentali dell’uomo, della sua vita psichica,
tutto questo doveva costituire un metodo e uno strumento per le mie opere letterarie. Desideravo ancora scrivere romanzi e a volte desideravo scrivere
saggi, ma pensavo che passare l’agrégation 5 di filosofia, diventare insegnante
di filosofia, mi avrebbe aiutato a sviluppare i miei temi letterari.
– R. In quel periodo, lei era già incline a vedere la filosofia come una base
per l’opera letteraria. Ma non provava anche questo bisogno d’inventare una
filosofia per rendere conto del suo vissuto?
– Entrambe le cose. Desideravo interpretare il mio vissuto –la mia vita interiore, come la chiamavo allora– e questo doveva servire come base ad opere
che avrebbero trattato non so bene di cosa, ma sicuramente temi strettamente letterari.
– R. Nel 1924, quando lei entra alla Ecole Normale 6, la decisione è quindi
già presa.
– Proprio così: avrei fatto della filosofia una materia di insegnamento. Consideravo la filosofia come uno strumento, ma non la vedevo come un campo in
cui avrei potuto creare un’opera personale. Probabilmente, pensavo, ne avrei
ricavato delle verità nuove, ma queste verità non mi sarebbero servite a comunicare con gli altri.
– R. Si tratta insomma di una conversione?
– No, ma era qualcosa di nuovo, che mi spingeva a studiare seriamente la
filosofia. Punto di partenza e fondamento di ciò che avrei scritto, la filosofia non
mi sembrava qualcosa che dovesse essere scritta da se stessa e per se stessa, ne conservavo delle annotazioni eccetera. Prima di leggere Bergson, provavo interesse per quello che leggevo e scrivevo dei pensieri che mi sembravano filosofici. Avevo anche un taccuino da medico, diviso alfabeticamente,
che avevo trovato in metropolitana e nel quale scrivevo questi pensieri.
– R. Torniamo indietro. C’era una tradizione filosofica nella sua famiglia?
– No, assolutamente. Mio nonno, che era professore di tedesco, non capiva niente di filosofia e la ridicolizzava. Per il mio patrigno, che era ingegnere
uscito dal Politecnico, la filosofia non era, in un certo senso, altro che filosofia
della scienza.
– R. Nel prendere la sua decisione, è stato influenzato da qualche amico
come Nizan?
– No, anche se non saprei spiegare perché Nizan si sia dedicato alla filo-
DOSSIER SARTRE
sofia nello stesso periodo in cui mi ci dedicai io e sia diventato anche «agrégé»8 in filosofia qualche anno dopo di me. Lui compì questa trasformazione
nello stesso momento e la filosofia giocò per lui più o meno lo stesso ruolo che
svolse per me.
– R. Voi non vi eravate consultati?
– Sì, certamente.
– P. Che cosa ad una prima lettura di Bergson ha suscitato il suo interesse
per la filosofia?
– Sono stati i dati immediati della coscienza a sorprendermi. Già in terza
superiore9 avevo un insegnante molto bravo che mi aveva un po’ guidato
verso lo studio dell’io; da allora mi sono interessato ai dati immediati della
coscienza, allo studio di quello che passa per la testa, alla maniera con cui
si formano le idee, al modo con cui i sentimenti appaiono, scompaiono eccetera. In Bergson ho trovato delle riflessioni sulla durata, sulla coscienza, su
che cosa sia uno stato di coscienza, eccetera, e questo mi ha certamente
influenzato molto. Ciononostante mi sono staccato da Bergson molto presto
perché l’ho abbandonato l’anno stesso in cui frequentavo ancora la khâgne.
– R. E nell’Immaginazione d’altra parte lei lo attacca abbastanza duramente, tanto che Merleau-Ponty glielo rimprovera.
– Non sono mai stato bergsoniano, ma il mio primo incontro con Bergson
mi ha rivelato una maniera di studiare la coscienza che mi ha convinto a fare
filosofia.
– R. Il suo primo lavoro filosofico importante, il diploma di studi superiori che
ha presentato nel 1927, verte sull’immagine. Perché questo interesse piuttosto
che un altro?
– Perché, in definitiva, per me la filosofia era psicologia. Mi sono liberato di
questa concezione più tardi. C’è la filosofia, e quindi non c’è la psicologia. Quest’ultima non esiste; è una chiacchiera oppure è uno sforzo per cercare di stabilire che cos’è l’uomo a partire da nozioni filosofiche.
– R. Quali sono i filosofi che, dopo Bergson, l’hanno interessata?
– Be’, sono i filosofi classici: Kant, molto Platone, Cartesio in modo particolare. Mi considero un filosofo cartesiano, almeno nell’Essere e il Nulla.
– R. Ha studiato questi autori in modo sistematico?
– In modo assolutamente sistematico, perché dovevo seguire i programmi
della licence10 e quelli dell’agrégation. I filosofi a cui mi sono appassionato,
Cartesio o Platone, per esempio, mi sono stati insegnati all’università della
Sorbonne. In altre parole, la formazione filosofica che ho ricevuto durante quegli anni è una formazione scolastica. Del resto questo è naturale perché si finisce di studiare con l’agrégation. Una volta che si è «agregé»11, si diventa
immediatamente insegnanti di filosofia e tutto finisce lì.
– R. C’è stata un’influenza di Nietzsche?
– Mi ricordo di aver preparato una relazione su di lui per il professor Brunschvicg al terzo anno della Ecole Normale. Mi interessava, come molti altri, ma
per me non ha mai rappresentato niente di importante.
– R. Questo mi sembra un po’ contraddittorio. Da un lato, si sente che lei
subisce una certa attrazione perché nell’Empédocle, Une défaite identifica in
7
8
Nietzsche il personaggio del «patetico Federico». Tuttavia, nello stesso periodo, lancia delle bombe ad acqua sui nietzschiani della Scuola gridando: «Così
pisciava Zarathustra!».
– Credo che in tutto questo non sia contraddizione. Nell’Empédocle, ho
voluto riprendere in chiave romantica la storia Nietzsche-Wagner-CosimaWagner, dandole un carattere molto più forte. Non ho voluto rappresentare la
filosofia di Nietzsche, ma semplicemente la sua vita d’uomo: egli è stato innamorato di Cosima nello stesso momento in cui era amico di Wagner. Friedrich
è diventato uno studente della Ecole Normale e finalmente mi ci sono identificato; avevo dei referenti anche per gli altri personaggi. Non ho mai terminato
questo romanzo breve.
– R. E Marx?
– L’ho letto, ma in quel preciso momento non ha giocato nessun ruolo.
– P. Lesse anche Hegel?
– No. Lo conoscevo da alcune opere e dai corsi, ma non l’ho studiato che
molto più tardi, intorno al 1945.
– R. Ci stavamo proprio domandando a che data risale la sua scoperta della
dialettica.
– Tardi. Dopo L’Essere e il Nulla.
– P. (con un’aria meravigliata). Dopo L’Essere e il Nulla?
– Sì. Conoscevo il concetto di dialettica dalla Ecole Normale, ma non lo utilizzavo. C’è qualche passaggio ne L’Essere e il Nulla che richiama un po’ la
dialettica, ma la maniera di procedere non era specificamente dialettica e pensavo che non ce ne fosse una. Invece, a partire dal 1945…
– R. Ci sono molti critici che ritengono che lei sia stato dialettico sin dall’inizio…
– È affar loro. Da parte mia non vedevo le cose in questo modo.
– P. Ma c’è comunque ne L’Essere e il Nulla una dialettica dell’in-sé e del
per-sé?
– Sì, ma in quel senso, c’è una dialettica in tutti gli autori; si trovano ovunque delle contraddizioni che si oppongono, che si trasformano in qualcos’altro,
eccetera.
– R. Le si è spesso rimproverato di non dedicarsi al pensiero scientifico e
all’epistemologia. Queste discipline hanno avuto un’importanza nella sua formazione?
– Sì, sono stato costretto a studiarle al liceo e alla Ecole Normale (ci si
occupava molto delle scienze), e successivamente sono stato costretto, per la
preparazione dei miei corsi, a leggere dei testi particolari. Ma questo non mi ha
mai appassionato, in una parola.
– P. E Kierkegaard, quando l’ha scoperto?
– Intorno al 1939-40. Prima di allora, sapevo che esisteva, ma per me non
era che un nome e questo nome, non so perché, non mi piaceva. A causa delle
due a, penso… Questo mi toglieva la voglia di leggerlo. Per continuare questa
biografia filosofica, vorrei dire che quello che è stato molto importante per me,
è stato il realismo, vale a dire l’idea che il mondo quale io lo vedo esiste e che
gli oggetti che percepisco sono reali. Questo realismo non aveva trovato
un’espressione valida perché, per essere realista, era necessario avere allo
DOSSIER SARTRE
stesso tempo un’idea del mondo e un’idea della coscienza –ed era precisamente quello il mio problema.
Ho creduto di trovare una soluzione, o qualcosa come una soluzione, in
Husserl, o piuttosto in un piccolo libro uscito in francese sulle idee di Husserl.
– R. Il libro di Lévinas?
– Sì, ho letto Lévinas un anno prima di andare a Berlino. Nello stesso periodo, Raymond Aron, che ritornava dalla Germania, mi diceva che secondo lui
era una filosofia realista. Non era affatto così, ma ero assolutamente desideroso di conoscere quella filosofia e nel 1933 sono partito per la Germania. Là ho
letto le Idee nella versione originale e ho davvero scoperto la fenomenologia.
– R. Taluni distinguono un Sartre fenomenologo e un Sartre esistenzialista.
Le sembra che questa distinzione sia fondata?
– No, non vedo la differenza. Husserl faceva dell’«io», dell’«ego» un dato
interno alla coscienza, invece, già nel 1934, ho scritto un articolo, La Trascendenza dell’ego, nel quale ritengo che l’ego sia una specie di quasi-oggetto
della coscienza e che, di conseguenza, esso si trovi escluso dalla coscienza.
Ho mantenuto questo punto di vista fino a L’Essere e il Nulla, e lo manterrei
ancora oggi, ma non è più il tema delle mie riflessioni, in questo preciso
momento.
– P. Questa questione dell’ego costituisce una difficoltà per molti dei suoi
critici.
– Sono critici che si limitano alla tradizione. Perché l’ego apparterebbe al
mondo interiore? Se è un oggetto della coscienza, allora esiste all’esterno; se
esiste nella coscienza, questa cessa di essere straordinariamente lucida, di
essere coscienza di se stessa, per ripiegarsi su un oggetto all’interno di se
stessa. La coscienza è all’esterno, non c’è interno della coscienza.
– P. La difficoltà dipende dal fatto che non è una cosa…
– No, ma nemmeno lei lo è, lei non è una cosa e nello stesso tempo è
anche un oggetto della mia coscienza. La soggettività non è nella coscienza,
essa è la coscienza; è attraverso questa via che si può trovare un senso della
coscienza che corrisponda nel soggetto ad una oggettività. L’ego è un oggetto
vicino alla soggettività, ma non è interno alla soggettività. Non può esserci
niente nella soggettività.
– P. Simone de Beauvoir scrive che questa rimane una delle sue convinzioni più solide. È una convinzione o un fatto?
– Ritengo che sia un fatto. In un pensiero non riflessivo, non incontro mai
l’ego, il mio, incontro quello degli altri. La coscienza non riflessiva è completamente alleggerita dell’ego che appare soltanto in una coscienza riflessiva, o
meglio in una coscienza riflessa, perché la coscienza riflessa è già un quasioggetto per la coscienza riflessiva. Alle spalle della coscienza riflessa, come
una specie di identità comune a tutti gli stati che sono subentrati a una coscienza riflessa, c’è un oggetto che si chiamerà ego.
– R. Nei suoi primi scritti filosofici, quando scriveva, per esempio, L’Immaginazione o Immagine e coscienza, aveva delle ambizioni di stile?
– Non ho mai avuto ambizioni di stile per la filosofia. Mai. Ho tentato di scrivere chiaramente e nient’altro. Mi si è detto che c’erano passaggi ben scritti. È
9
10
possibile; quando ci si sforza di scrivere chiaramente, tutto sommato si scrive
bene, in un certo qual modo. Non sono nemmeno orgoglioso di quei passaggi, se ce ne sono. Ho voluto scrivere in un francese il più semplice possibile;
non l’ho sempre fatto, per esempio, ne La Critica della ragione dialettica (in cui
questo è dovuto alle compresse di corydrane12 che ingerivo).
– R. Quale sarebbe la sua definizione di stile?
– Ho già parlato di stile altrove, nelle interviste. Lo stile è in primo luogo
l’economia: si tratta di costruire delle frasi in cui coesistano molteplici significati e in cui le parole siano prese come allusioni, come oggetti piuttosto che come
concetti. In filosofia una parola deve esprimere un concetto, e solo quello. Lo
stile è un certo rapporto tra le parole, e rinvia a un senso che non si può ottenere per semplice addizione di parole.
– R. Ci si pone spesso la questione di sapere se nel suo pensiero ci sia continuità o rottura.
– C’è un’evoluzione, ma non penso che ci sia stata rottura. Il grande cambiamento nel mio pensiero è la guerra: 1939-40, l’occupazione, la resistenza,
la liberazione di Parigi. Tutto questo mi ha fatto passare da un pensiero filosofico in senso classico a dei pensieri in cui la filosofia e l’azione, o il teorico e il
pratico sono legati: il pensiero di Marx, quello di Kierkegaard, quello di Nietzsche, quello dei filosofi a partire dai quali si potrebbe comprendere il pensiero
del XX secolo.
– P. E Freud in quale momento è intervenuto?
– L’ho conosciuto dopo il mio corso di filosofia. Poi ho letto qualche suo
libro: ricordo di aver letto Psicopatologia della vita quotidiana al primo anno
della Ecole Normale, poi finalmente L’Interpretazione dei sogni prima di finire
l’Ecole. Ma mi urtava perché gli esempi che fa nella Psicopatologia della vita
quotidiana sono troppo distanti da un pensiero razionale e cartesiano. Ho parlato di questo in un’intervista che ho rilasciato alla New Left Review.
Poi durante i miei anni d’insegnamento ho approfondito la dottrina di Freud,
sempre mantenendomi separato dalla sua idea dell’inconscio. Intorno al 1958,
sono stato interpellato da John Huston che voleva fare un film su Freud; cadeva male perché non si sceglie qualcuno che non crede all’inconscio per fare un
film in onore di Freud13.
– R. Cumming dice che lei ha la tendenza ad esagerare la discontinuità
del suo pensiero: annuncia ogni cinque o dieci anni che ha cambiato, che
non farà più quello che ha fatto. Se si prende l’esempio che lei faceva un
momento fa –quello del piccolo diario che teneva quand’era studente e che
diventa ne La Nausea il diario dell’Autodidatta– è evidente che lei pensa contro se stesso.
– Ma non è così: pensavo contro di me nello stesso momento e il pensiero
che ne risultava era un pensiero contro il primo, contro quello che avevo pensato spontaneamente.
Non ho mai detto che cambiavo idea ogni cinque anni. Al contrario, penso
di avere seguito uno sviluppo continuo a partire da La Nausea e fino alla Critica della ragione dialettica. La mia grande scoperta, è il sociale durante la guerra, perché essere soldato al fronte è veramente essere vittima di una società
DOSSIER SARTRE
che ti tiene là dove non vuoi stare e che ti impone delle leggi che tu non condividi. Ne La Nausea non c’è il sociale, ma lo si intravede.
– R. E sotto questo aspetto, L’Essere e il Nulla, ha rappresentato per lei la
fine di un’epoca?
– Certamente. Ne L’Essere e il Nulla la cosa più brutta sono i capitoli propriamente sociali, su il «noi», a differenza dei capitoli sul «tu» e gli altri.
– R. Maurice Natanson si chiede, per l’appunto, qual è per lei la relazione
tra l’ontologia e la sociologia.
– Questa relazione non è in L’Essere e il Nulla, infatti, si trova nella Critica
della ragione dialettica…
– R. A questo proposito, lei considera la nozione di penuria [rareté] come
ontologica?
– No. Non è nemmeno antropologica; se preferisce, appare dal momento in
cui c’è una vita animale.
– R. Natanson pone la domanda: «Il per-sé ha un plurale o un genere?»
– No, evidentemente. Esiste solo il per-sé, il vostro, il mio, ma questo non
costituisce dei per-sé.
– P. La forza del suo sistema, è di essere fondato su un’ontologia. Come è
arrivato a questa nozione di ontologia?
– Volevo che il mio pensiero avesse un senso in rapporto all’essere. Penso
che l’idea di ontologia fosse nella mia testa a causa della mia formazione filosofica, delle lezioni che avevo seguito. La filosofia si interroga sull’essere o
sugli esseri… Ogni pensiero che non arriva a interrogarsi sull’essere non è un
pensiero valido.
– P. Sono assolutamente d’accordo, ma vorrei ricordarle che un certo pensiero scientifico (i filosofi del circolo di Vienna per esempio) rifiuta totalmente,
come una specie di fantasticheria, ogni nozione dell’essere.
– Lo so, ma io penso proprio che, quando si parte da questo, si fa noi stessi della filosofia. In altri termini, non credo che il pensiero dei filosofi di Vienna
(e quello delle persone a loro vicine) sia un pensiero valido e che abbia dato
sucessivamente dei risultati validi. Bisogna partire dall’essere o ritornarvi,
come fa Heidegger. Bisogna ad ogni modo che l’essere sia in questione; questo conduce a dei pensieri più precisi sui problemi della filosofia attuale.
– R. Come domanda Natanson, si deve assumere un punto di vista retrospettivo e si può discutere oggi de L’Essere e il Nulla senza entrare in una dialettica?
– Questo pone un problema difficile, quello di sapere come fare per interpretare un filosofo morto, che ha avuto tante filosofie. Come si può parlare,
poniamo, di Schelling, che importanza dare alla sua prima filosofia e come
comprenderla in rapporto alla successiva? Saper esattamente quali sono le
fonti di una prima filosofia, proprio in quanto originaria e quali le fonti della
seconda, sapere in che misura la prima interviene nella seconda, è una questione molto difficile alla quale non ho ancora risposto, non completamente.
– P. Ma senza l’ontologia fondamentale, mi chiedo se avrebbe potuto porre
il problema sociale come lo ha posto nella Critica.
– Penso che non avrei potuto. È davvero in questo mi distinguo da un mar-
11
12
xista; quello che precisamente rappresenta per me una superiorità sui marxisti, è il fatto di porre la questione di classe, la questione sociale, a partire dall’essere che esce dai confini della classe, perché questo riguarda sia gli animali, sia gli oggetti inanimati. È a partire da questo che si possono iniziare a
porre i problemi di classe, di questo sono certo.
– R. Ci si chiede spesso qual è il posto dell’estetica nella sua filosofia. Ha
un’estetica, una filosofia delle arti?
– Se ne ho una (e ce l’ho a malapena), è completamente in quello che ho
scritto e la si può trovare là. Non ho creduto che valesse la pena di creare
un’estetica come Hegel ne ha creata una.
– G. Ha pensato di fare una filosofia del linguaggio?
– No. Il linguaggio deve essere studiato all’interno di una filosofia, ma non
può essere la base di una filosofia. Penso che dalla mia filosofia si possa ricavare una filosofia del linguaggio, ma non c’è una filosofia del linguaggio che le
si possa imporre.
– G. Per ritornare al problema letteratura/filosofia, considera ancora la letteratura come una maniera di comunicare?
– Sì, non vedo proprio cos’altro potrebbe essere. Non si scrive mai, o
meglio non si pubblica mai qualcosa che non sia destinato agli altri.
– R. Pensa che il filosofo, simile in questo allo scrittore, abbia un’esperienza particolare da trasmettere?
– No. Anzi, forse. La sua funzione è di mostrare un metodo, un modo di concepire il mondo a partire dall’ontologico.
– G. Cumming cerca di dimostrare che questo metodo è sempre stato per
lei una dialettica.
– In un primo tempo sono stato non-dialettico e solo intorno al 1945 ho
cominciato a occuparmi veramente del problema. Mi sono inoltrato nella dialettica a partire da Sant Genet e penso che la Critica sia davvero un’opera dialettica. Adesso, ci si può divertire a dimostrare che prima ero dialettico senza
saperlo; si può dimostrare allo stesso modo che Bergson era bergsoniano
anche a sei anni, quando mangiava pane e marmellata.
– G. Crede che esistano delle sintesi?
– Sì, delle sintesi parziali, in ogni caso; l’ho dimostrato nella Critica della
ragione dialettica.
– G. Suppongo che rifiuti una sintesi assoluta, o mi sbaglio?
– Sì, assoluta. Ma una sintesi dell’epoca, per esempio, no. La nostra epoca
è di per se stessa la propria sintesi, e lo spiegherò nel secondo volume della
Critica. È certo che bisogna superare il tipo di sintesi di cui dispongo nel primo
volume per arrivare a delle sintesi riguardanti noi stessi e gli altri. Ognuno di
noi può, in ogni momento, fare delle sintesi. Per esempio, posso fare la sintesi di voi tre e in un certo modo, immedesimarmi in questa situazione, e voi,
potete fare la stessa cosa. Ma queste sintesi non sono a livello di una sintesi
globale, e non esiste nessuno che la possa fare. Se si era in sei, si potrebbe
ricominciare, ma se si era mille, questo non avrebbe più molto senso. Bisogna
quindi cercare un altro modo di concepire quelle sintesi.
– P. Eppure, ne L’Essere e il Nulla, lei dice che la coscienza è sintesi.
DOSSIER SARTRE
– Sì, è vero. Ma è la coscienza di ciascuno che costituisce la sintesi di quello che vedo. Io sono sintesi in rapporto a tutto quello che vedo, in rapporto a
voi tre, ma a voi tre che siete in rapporto con me. Ma non sono sintesi di quello che accade per la strada e che non vedo. (In quell’istante, un rumore di sirene nella strada). Dato che credo solo a delle coscienze individuali e non ad una
coscienza collettiva, mi è impossibile dare dunque una coscienza collettiva
come sintesi storica.
– R. Ha definito la Critica della ragione dialettica un’opera contro i comunisti e che si considera marxista.
– Contro i comunisti, certamente. Ma marxista è una parola che in quel
momento usavo con un po’ di leggerezza.
All’epoca, consideravo la Critica un’opera marxista, ne ero convinto. Ma su
questo punto mi sono ricreduto: oggi penso che la Critica si avvicini al marxismo sotto alcuni punti di vista, ma non è un’opera marxista.
– R. Nelle Questioni di metodo, sottolinea una differenza tra l’ideologia e la
filosofia, ed è una differenza che imbarazza i critici.
– È perché pretendono di essere tutti filosofi! Mantengo la differenza ma il
problema è molto complicato. L’ideologia non è una filosofia costituita, meditata e riflessiva, è un’insieme di idee che sta alla base di atti alienati e che li riflette, che non è mai completamente espressa e formulata, ma che appare nelle
idee correnti di una data epoca o di una data società. Le ideologie rappresentano dei poteri e agiscono. Le filosofie si costituiscono contro le ideologie,
anche se in una certa misura le riflettono, proprio nel criticarle e nel superarle.
Notiamo che attualmente l’ideologia esiste tra coloro che dichiarano che bisogna mettere fine alle ideologie.
– P. Anch’io ho provato imbarazzo davanti a questa differenza: consideravo l’esistenzialismo della Critica come un tentativo di sintesi del marxismo e
come un superamento, invece lei direbbe che l’esistenzialismo non era che un
‘enclave’, del marxismo.
– Sì, ma era questo l’errore. L’esistenzialismo non può essere un ‘enclave’
a causa della mia idea della libertà ed è quindi in definitiva una filosofia a parte.
Non penso affatto che questa filosofia sia marxista. Non può ignorare il marxismo, è legata a questo come certe filosofie sono legate ad altre senza tuttavia entrarvi, ma adesso non la considero affatto come una filosofia marxista.
– R. Allora quali sono gli elementi del marxismo che lei accetta?
– La nozione di plus-valore, la nozione di classe, tutto rielaborato, del resto,
perché la classe operaia non è mai stata definita da Marx e dai marxisti. Bisognerà rivedere queste nozioni, ma per me restano valide in ogni caso come
elementi di ricerca.
– R. E oggi non si riconoscerebbe più come marxista?
– No. Penso del resto che assistiamo alla fine del marxismo e che, nei prossimi cent’anni, il marxismo non avrà più la forma che si conosce…
– R. Il marxismo teorico o il marxismo come è stato applicato?
– Il marxismo come è stato applicato, ma è stato applicato anche come
marxismo teorico. Dopo Marx, il marxismo ha vissuto una certa vita e, nello
stesso tempo, è invecchiato. Ora noi siamo nel periodo in cui l’invecchiamen-
13
14
to va verso la morte. Il che non significa che le nozioni principali del marxismo
scompariranno; al contrario, saranno riprese… Ma per conservare il marxismo
oggi ci sono troppe difficoltà.
– R. E quali sono queste difficoltà?
– In sintesi, dirò semplicemente che l’analisi del capitalismo nazionale e
internazionale nel 1848 non ha nulla a che fare con il capitalismo contemporaneo. Non si può spiegare una società multinazionale nei termini marxisti del
1848. Bisogna introdurre una nozione nuova che Marx non ha previsto e che,
quindi, non è marxista nel senso puro del termine.
– P. La Critica è quindi già un superamento del marxismo?
– In ogni caso, non è sul piano in cui si è situata, quello di una semplice
interpretazione del marxismo, con qualche modificazione a destra e a sinistra.
Non è contro il marxismo, è veramente non-marxista.
– P. È stato superato dall’idea di serialità, di pratico-inerte, grazie a delle
idee nuove che non avevamo mai sfruttato.
– Ci sono delle nozioni che mi sembravano venute dal marxismo, ma che
sono differenti.
– R. E con chi si sente in sintonia in questa contestazione del marxismo?
– Con quelli che si chiamano maoisti, i militanti della sinistra proletaria con
i quali ho guidato La Cause du peuple . Inizialmente erano marxisti, ma hanno
fatto come me: non lo sono più, o lo sono molto meno. Pierre Victor14, per
esempio, con il quale lavoro nelle trasmissioni televisive, non è più marxista o,
almeno, vede la fine del marxismo.
– R. Alcuni critici cercano di vedere in lei un filosofo maoista.
– È assurdo, io non sono maoista; del resto, questo non significa nulla. Si
parlava un po’ di Mao quando scrivevo L’Essere e il Nulla.
Per alcuni gruppi, questo aveva un senso, molto vago: si immaginavano
forme di vita socialista come quelle che avevano visto o creduto di vedere in
Cina e le volevano applicare qui. Questi gruppi sono stati maoisti quando la
testa di Mao non compariva su La Cause du peuple ; hanno smesso di esserlo quando la testa di Mao ha fatto la sua apparizione.
– R. Mi è sempre sembrato che nei maoisti francesi ci fosse un 10% di
maoismo e un 90% d’altro genere, non molto facile da definire.
– Difficile da definire, ma interessante. È quello che noi abbiamo cercato di
fare in On a raison de se révolter.
– R. E cosa diventerà questa filosofia della libertà che sta per nascere oggi?
– È una filosofia che sarebbe sullo stesso piano, mescolando la teoria e la pratica, del marxismo, una filosofia in cui la teoria serve alla pratica, ma che assumerà come punto di partenza la libertà che mi sembra manchi al pensiero marxista.
– R. In alcune conversazioni recenti, utilizza il termine socialismo «libertario».
– È un termine anarchico e lo conservo, perché mi piace ricordare le origini un po’ anarchiche del mio pensiero. Sono sempre stato d’accordo con gli
anarchici che sono i soli ad aver concepito un uomo completo, da costituire per
mezzo dell’azione sociale, e la cui caratteristica principale è la libertà. Detto
ciò, evidentemente, in politica, gli anarchici sono un po’ semplici.
DOSSIER SARTRE
– R. Forse anche sul piano della teoria?
– Sì, a condizione che non si consideri solo la teoria e che non si lascino
da parte intenzionalmente intuizioni che sono molto buone, e cioè quelle
riguardanti la libertà e l’uomo completo. Queste intuizioni qualche volta si sono
realizzate: gli anarchici hanno vissuto insieme, hanno formato delle società
comunitarie, per esempio in Corsica intorno al 1910.
– R. Se oggi dovesse scegliere tra due etichette, quella di marxista e quella di esistenzialista, quale preferirebbe?
– Quella di esistenzialista. Gliel’ho appena spiegato.
– R. Non preferirebbe un altro termine che esprima meglio la sua posizione?
– No, perché non l’ho mai cercato. Mi hanno chiamato esistenzialista, ho
accettato la definizione, ma non sono stato io a darla.
– R. Robert Champigny, che ha dedicato un libro intero a questo tema, la
accusa di razzismo umano, di antropomania. Quello che lo infastidisce nella
sua frase famosa di I Comunisti e la pace, «Un anti-comunista è un cane», non
è l’espressione di un’idea politica…
– …È il cane?
– R. È il cane. (Risate)
– Veramente, non credo che se ne possa concludere che ce l’ho con i cani.
È una formula molto banale che ho usato in quel momento. […] So bene che
gli animali hanno una coscienza, perché non comprendo il loro comportamento se non ammettendo una coscienza. Di che tipo è la loro coscienza, che
cos’è una coscienza non dotata di linguaggio? Non saprei. Forse arriveremo a
decifrarlo più avanti, ma dovremmo sapere molto di più sulla coscienza.
– P. I miei studenti mi chiedono continuamente: dove sono gli animali ne
L’Essere e il Nulla?
– Non ci sono. Perché ritengo che quello che si dice degli animali nella psicologia animale è in generale stupido, in ogni caso completamente slegato
dalle nostre esperienze coscienti. La psicologia animale è da rifare. Ma è difficile dire su quali basi.
– P. Attualmente negli Stati Uniti si fanno delle ricerche molto interessanti
con delle scimmie alle quali si insegna a battere a macchina; esse possono
pensare secondo simboli, ma non possono passare alla parola.
– R. C’è una coscienza vegetale?
– Non ne so assolutamente nulla. Non penso che vita e coscienza siano
sinonimi. No, per me, la coscienza, è là dove la si nota, ed esistono degli animali che non ce l’hanno, i protozoi, per esempio. La coscienza appare nel
mondo animale a un dato momento, negli uomini, sicuramente anche nelle
scimmie. Ma come appare e che cos’è?
– R. Pierre Verstrueten è rimasto colpito dallo statuto che lei ha dato nel III
volume di «Flaubert» alla nevrosi storica del XIX secolo. Per lui, è una scoperta e si chiede a ragione quale sia lo statuto di questa potenza inventiva. In
quale momento si produce questa scoperta? Quando, per esempio, ha scoperto l’idea di programmazione o quella di nevrosi storica?
– Non lo so. Emerge nel corso delle mie riflessioni, ma non posso dire in
che momento appare. Un’idea viene in questo modo: inizialmente si ha un’idea
15
16
vaga completamente non-affermata, e in seguito si cerca di determinarla, di
creare delle funzioni; in quel momento si arriva ad una coscienza che non è più
la pura coscienza-sentimento che c’era all’inizio. Dapprima si ha qualcosa che
non chiamo conoscenza ma intuizione, e la conoscenza in un certo senso è
radicalmente differente da ciò che è dato da questa prima intuizione. Questa
determina delle cose che non erano determinate, ne sviluppa delle altre, ne
sfuma altre che erano più evidenti inizialmente. Conserva un certo legame con
la prima intuizione, ma è un’altra cosa e differente.
– R. Per gli americani, lei è spesso il filosofo dell’anti-natura.
– Sono un filosofo anti-natura, ma su alcuni piani solamente. So che all’inizio c’è stata una natura che indirettamente ha influenzato l’uomo. È certo che
gli uomini primitivi intrattenevano dei rapporti reali con la natura, come gli orango o le formiche. Questo rapporto, in questo momento, esiste ancora, ma è
superato da altri rapporti che non sono più rapporti materiali, o almeno rapporti in cui la natura non gioca più lo stesso ruolo.
– R. La penuria, questa nozione che lei sviluppa nella Critica, è legata al
desiderio o al bisogno?
– Talvolta al bisogno, talvolta al desiderio. Data una causa qualsiasi che fa sì
che si abbia bisogno di una certa sostanza o di un certo oggetto, questo oggetto non è dato nella proporzione in cui se ne ha bisogno; questa è la penuria.
– R. Così, la penuria non ha tendenza a diventare una categoria ontologica piuttosto che storica? Oscar Wilde diceva, per esempio: “Dove c’è domanda, non c’è offerta”.
– Non è una nozione ontologica, ma non è nemmeno una nozione semplicemente umana o una constatazione empirica. Tende verso l’ontologia, ma
non è ontologica, perché gli uomini che noi prendiamo in considerazione nel
mondo non sono da studiare solo secondo una prospettiva ontologica o su un
piano di idee astratte particolari, come fanno le filosofie o le ontologie particolari. Bisogna studiarli empiricamente, come sono. E su questo piano, si constata che un uomo è circondato di penuria, che si tratti del gioco che il bambino
non ha a sua disposizione quando lo vorrebbe o dei prodotti alimentari che un
gruppo umano reclama e di cui non ha a disposizione che una sola parte. Ad
ogni modo, c’è una differenza tra la domanda e l’offerta, che deriva dalla
maniera in cui è fatto l’uomo, che deriva da quello che l’uomo domanda ancora quando l’offerta è limitata.
– R. Oggi si vede chiaramente che l’idea di abbondanza che si è potuta
avere negli Stati Uniti è una mistificazione.
– Certamente. Completamente. Viviamo in un mondo di penuria e di quando in quando possiamo immaginarci di trovare l’abbondanza cambiando il
nostro desiderio di natura. Non avendo quel che ci occorre in un campo, trasferiamo il desiderio in un altro campo. Ma è ugualmente la penuria che è
all’origine di questa concezione.
– P. Ciononostante ho sempre inteso la penuria nella Critica della dialettica
come il risultato di una oppressione sociale.
– Può essere, è sempre un fatto di oppressione sociale. Ma ci sono delle
penuria che provengono semplicemente dal rapporto di domanda dell’uomo
DOSSIER SARTRE
–una domanda libera, per niente assoggettata a un’altra– con la quantità
offerta.
– P. Ma se c’è una mancanza oggettiva, è anche una penuria?
– Certamente. In origine, la penuria era proprio questo. Il desiderio, la
volontà, la necessità di utilizzare il tale oggetto come mezzo per creare una
domanda che può essere qualche volta illimitata, mentre l’oggetto domandato
è disponibile su un territorio o sul globo in quantità limitata. Quindi, per me, la
penuria è un fenomeno di esistenza, un fenomeno umano, e naturalmente, la
più grande penuria è sempre quella fondata sull’oppressione sociale. Ma
all’origine c’è la penuria; noi creiamo circondati da un campo di penuria.
– P. Per passare a un altro problema, il professor Frondizi ritiene che la sua
riflessione morale sia stata soprattutto negativa e che si finisca per cadere in
una morale dell’indifferenza.
– Non ho mai avuto una morale dell’indifferenza. Quello che rende le morali difficili, non è questo, sono i problemi concreti e politici, per esempio, che
bisogna risolvere. Come ho già sottolineato in Sant Genet, penso che attualmente non siamo in un tale stato, la società e le conoscenze non sono tali da
permetterci di ricostruire una morale che abbia lo stesso tipo di valore di quella che abbiamo superato. Non si può, per esempio, fare una morale su un
piano kantiano che abbia lo stesso valore della morale kantiana. Perché le
categorie morali dipendono fondamentalmente dalle strutture della società
nella quale noi viviamo e dal fatto che queste strutture non sono né abbastanza semplici, né abbastanza complesse perché noi possiamo creare dei concetti morali. Siamo in un periodo senza morale o, se si vuole, ci sono delle morali, ma queste sono superate o molto particolari.
– R. La morale è impossibile?
– Sì. Non lo è sempre stata, ma lo è oggi. Non lo sarà sempre, lo è attualmente. Detto questo, penso che all’uomo sia necessaria una morale.
– P. C’è compatibilità tra la sua filosofia e quella di Merleau-Ponty, in particolare quando sviluppa la nozione d’«intramondo»?
– Credo che ci sia un’incompatibilità fondamentale, perché dietro alle analisi di Merleau-Ponty c’è sempre il riferimento a un tipo di essere per il quale
evoca Heidegger e che non è assolutamente qualcosa che io consideri valido.
Tutta l’ontologia che si sviluppa dalla filosofia di Merleau-Ponty è distinta dalla
mia: si tratta piuttosto di continuismo. Io non sono tanto un continuista: l’in-sé,
il per-sé e le forme intermedie di cui si parlava poco fa, questo mi basta. In
Merleau-Ponty c’è un rapporto con l’essere che è molto differente, un rapporto nel fondo di se stesso. Ho parlato di questo in Merleau-Ponty vivant.
– R. L’esempio di oggi lo conferma, credo che in generale lei impari molto
poco dagli altri sulla sua opera.
– Fino ad ora molto poco. Mi hanno sempre detto, quando avevo diciassette o diciotto anni, che si impara molto dai critici. Quindi sono cresciuto con delle
buone idee su questo, delle idee disciplinate, sagge. Leggevo i critici e pensavo: «Che cosa mi insegnano?», ma non mi insegnavano nulla.
– R. Non c’è un confronto con altri pensieri che la spinge a rivedere certe
sue idee?
17
18
– Non mi sono mai sentito spinto a rivedere le mie idee. Forse sono un filosofo ostinato! Ho letto, ho visto effettivamente che c’erano delle cose da dire,
e poi ho continuato a fare quello che facevo.
– R. Il suo pensiero si sviluppa così su un piano relativamente autonomo?
– In rapporto al pensiero dei critici scrittori, sì. Se degli amici mi fanno notare qualche cosa, questo sì che può essere più importante. Tra i critici, i migliori che abbia incontrato sono quelli che dicevano quello che avevo voluto dire.
– R. La irrita vedere spesso il suo pensiero semplificato?
– No. Lo scrivono, tutto qui.
– R. Lei stesso ha detto che servirebbero dei mediatori per il «Flaubert».
Come prevede una critica possibile della sua opera?
– Per cominciare bisognerebbe leggerla. Molti commentatori si fermano a
metà strada.
– R. Leggere l’insieme?
– Be’, insomma, sì. Non lo chiedo al lettore in generale, ma ai critici specializzati: che si prendano il tempo. Bisogna poi esporre l’opera, vedere se un
punto di vista si prolunga per tutta la vita o cambia a metà, cercare di spiegare gli sviluppi, le rotture, tentare di ritrovare la mia scelta originale, che è la
cosa più difficile: che cosa ho deciso di essere scrivendo la tal opera, perché
ho deciso di scrivere?
– R. Il critico rischia di non immedesimarsi in lei tanto quanto lei vorrebbe
e, così, di non renderle totalmente giustizia.
– Nonostante tutto, che faccia un po’ quello che faccio io su Flaubert; non
pretendo di avergli reso giustizia, completamente, ma spero di aver trovato
certe direzioni, certi temi.
– R. Le farebbe piacere quindi che si facesse su di lei un lavoro come quello che ha fatto su Flaubert?
– Sì, proprio così. Il senso della critica mi sembra proprio questo. Ecco dei
libri, un uomo li ha scritti. Che cosa significa? Chi è quest’uomo, che cosa sono
questi libri? Il punto di vista estetico mi sembra talmente variabile che è proprio questo aspetto che trovo interessante.
– R. Attribuisce una grande importanza alla documentazione?
– Sì. Lo posso dire, perché so quello che c’è voluto per Flaubert.
– P. Ciononostante, non c’è molta documentazione su di lei. Se si confronta quello che ha messo ne Le Parole con quello che si conosce dell’infanzia di
Flaubert, c’è una grande differenza.
– Questo è dovuto anche al periodo attuale. Oggi si danno molti meno dettagli
sulle persone, si sa molto meno su di loro che nel secolo scorso, proprio perché i
problemi della sessualità, i problemi della vita, diventano individuali e scompaiono.
Per esempio, quello che si sa di Solženicyn, sono cose che in fondo riguardano
tutta la Russia. Si sa che è stato esiliato in un campo; subito si riflette sui campi,
ci si ricorda che cosa significa questo, eccetera. Ma quanto a sapere se amava il
caffè, e quale fosse la sua sessualità, mistero. Si potranno forse individuare certi
elementi a partire dai suoi libri, ma bisognerebbe che qualcuno lo facesse.
Tutto questo non è nascosto, in effetti. Penso che il mio amore per il caffè
e la mia sessualità siano nei miei libri. Non c’è da fare altro che ritrovarli e que-
(traduzione dal francese di Lucia Angelino)
DOSSIER SARTRE
sto è compito dei critici. Detto altrimenti, questi dovrebbero, a partire dai libri,
e nient’altro che secondo i libri, aggiungendo la corrispondenza, capire la persona che li ha scritti, ricostruire le correnti, vedere a quali dottrine si collega…
– R. Nel suo caso c’è molta corrispondenza?
– No, o molto poca.
– Quello che vuole quindi, è una biografia?
– Sì, una specie di biografia che si può fare soltanto con dei documenti. Una
biografia letteraria, vale a dire l’uomo con i suoi gusti, i suoi principi, la sua
estetica letteraria… e ritrovare tutto questo in lui, a partire dai suoi libri e in lui.
Ecco, mi sembra che sia questo il lavoro che deve fare la critica.
– R. Stranamente, nessuno degli articoli che abbiamo davanti ci parla dell’insegnamento della filosofia, della maniera in cui potremmo insegnare il suo
pensiero. Come insegnava la filosofia?
– Tenevo un corso professorale, un corso ex cathedra, come si dice, ma mi
interrompevo in continuazione per fare delle domande o per rispondere alle
domande che mi venivano poste. Penso che l’insegnamento non consista nel
far parlare un signore davanti a delle persone giovani, ma nel discutere con
loro a partire da problemi concreti. Se dicessero: «Quel tipo è un idiota. Dice
questo, ma io da parte mia ho vissuto un’altra cosa», bisognerebbe spiegargli
che si può pensare la cosa diversamente.
– R. Riusciva a stabilire un inizio di reciprocità, perché non si ha mai una
reciprocità completa?
– Era una reciprocità molto forte. Bisogna dire che facevo anche altre cose
con i miei allievi, anche della boxe, e questo, questo aiuta. Passavo anche
molto tempo a estirpare le idee che avevano nella testa.
– R. Questo modo di insegnare non è stato considerato un po’ scandaloso,
all’epoca?
– Sì. Ho scatenato le reazioni dei colleghi, di un censore, di tutte le persone di quel tipo. Inoltre, permettevo ai miei allievi di fumare in classe, cosa che
era considerata molto male.
– R. Come vedrebbe l’insegnamento della filosofia oggi?
– Come sapete, nel progetto di riforma che deve essere votato, la filosofia
è eliminata dall’insegnamento secondario.
– R. Lei sa che negli Stati Uniti non si insegna la filosofia nelle scuole superiori, ma soltanto all’università.
– Ma, a mio modo di vedere, bisognerebbe fare il contrario. Penso, come
ha proposto qualcuno, che la filosofia potrebbe essere insegnata fin dalla terza
superiore, un po’, per permettere di capire gli autori insegnati; tre ore alla settimana, per esempio.
Per me, la filosofia è tutto. È come si vive. Si vive in modo filosofico. Io vivo
da filosofo; questo non significa che vivo da buon filosofo, ma le mie percezioni sono percezioni filosofiche, anche quando guardo questa lampada o quando guardo voi. Di conseguenza, è un modo di vivere e ritengo che lo si dovrebbe insegnare il più presto possibile, senza paroloni.
19
20
1 Nel seguito della conversazione, G. indica Gruenheck (Susan), P. Pucciani (Oreste), R.
Rybalka (Michel).
2 Questa parola, si compone di due termini, «Cucu», che vuol dire «stupido, sciocco» e «Filo»
che è vuol dire, in forma abbreviata, filosofo.
3 Questo termine dell’argot scolastico designa il primo anno del corso preparatorio alla Ecole
Normale Supérieure.
4 Con questo termine gli studenti chiamano scherzosamente gli anni di preparazione al concorso d’ammissione alla Ecole Normale. A Parigi funzionano quattro khâgnes: le due più importanti sono collocate l’una presso il Liceo Louis-le-Grand, l’altra presso il Liceo Henry IV, le altre due,
di minore importanza, si trovano presso il liceo Condorcet sulla riva destra della Senna, e presso
il Liceo Lakanal a Sceaux, in periferia.
5 L’agrégation è un esame di concorso per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Una volta
superato, esso dà il diritto e la possibilità d’insegnare nelle scuole medie e superiori.
6 La Ecole Normale Supérieure è una prestigiosa istituzione, creata il 9 brumaio dell’anno III
(30 ottobre 1794) dalla Convenzione, per iniziativa del Comitato di salute pubblica, e sistemata, a
partire dal 1847, nei locali appositamente costruiti nella rue d’Ulm a Parigi. Da questa «grande
scuola» (o università a numero chiuso) è uscita la maggiore e la migliore parte della élite intellettuale e del personale politico francesi. Per ulteriori approfondimenti e precisazioni sulla storia di
questa istituzione, rinviamo al libro celebrativo del 150º anniversario, realizzato da Alain Peyrefitte, raccogliendo testimonianze e scritti dei più famosi «normalisti», introdotto da Georges Pompidou: Rue d’Ulm. Chronique de la vie normalienne, Flammarion, Parigi, 1963.
7 “Ho parlato per la prima volta della contingenza in un quaderno raccolto in una metropolitana. Era un quaderno nuovo con su scritto ‘Supposte Midy’, era evidentemente un carnet distribuito ai medici, fatto come una rubrica con A-B-C-D ecc.”; J.-P. SARTRE, La mia autobiografia in un
film. Una confessione, ed. it. a c. di G. Invitto, Marinotti, Milano 2004, p. 44.
8 L’agregé è un professore di ruolo nelle scuole medie inferiori e superiori o un docente ordinario in alcune facoltà universitarie.
9 Nell’ordinamento scolastico francese la classe de première corrisponde alla terza superiore,
o terzo anno di liceo.
10 La licence è il diploma universitario che si consegue dopo tre anni di studi.
11 È questo il titolo che si attribuisce a chi ha conseguito l’agrégation.
12 Si tratta di una droga, ottenuta mescolando anfetamina e aspirina.
13 Sulla sceneggiatura freudiana di Sartre, mai diventata film, vedi Sartre, il cinema, la psicoanalisi, in G. INVITTO, L’occhio tecnologico. I filosofi e il cinema, Mimesis, Milano 2005, pp. 49-78.
14 Alain Geismar, leader dell’opposizione proletaria al potere politico, propose a Sartre nel 1973
Pierre Victor, giovane maoista, come segretario per parare le restrizioni che la polizia imponeva
al giovane. Pierre Victor era lo pseudonimo di Benny Lévy, che fu l’ultimo segretario del movimento Sinistra Proletaria.
DOSSIER SARTRE
Queste pagine sono riprese da J.-P. SARTRE, La mia autobiografia in un film. Una confessione,
trad. it. a c. di G. Invitto, apparso nella collana “Sartriana” dell’editore Marinotti di Milano (2004, pp.
160). Il testo è la trascrizione della sceneggiatura del documentario Sartre par lui-même, costituito da una serie di conversazioni di Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir e con gli intellettuali che più erano stati vicini alle imprese culturali e politiche del filosofo francese. Girato per la maggior parte nel 1972, il documentario fu interrotto per motivi finanziari e fu completato tra il 1975 e
il 1976. In quello stesso anno fu presentato in anteprima al Festival di Cannes, ottenendo unanimi consensi di critica e di pubblico. L’edizione francese della sceneggiatura fu pubblicata nel 1977
a Parigi da Gallimard, a c. di A. Astruc e M. Contat.
“Segni e comprensione” ringrazia le Edizioni Marinotti che hanno permesso la pubblicazione
di questo breve stralcio della traduzione italiana. Qui non sono riportate le note che sono, invece,
nella traduzione integrale.
HUSSERL, LE COSE, L’INTENZIONALITÀ
Conversazione con Jean-Paul Sartre
di A. Astruc, M. Contat, S. de Beauvoir
J.-L. Bost, A. Gorz, J. Pouillon
POUILLON – […] Lei ci ha detto che era tramite Nizan che ha scoperto la
letteratura moderna. E il surrealismo?
SARTRE – Io seppi cos’era, ma non mi ha sfiorato, no. So per esempio che
questo ha avuto una importanza ma un’importanza ridotta, perché noi lo tenevamo a distanza.
POUILLON – Husserl è stato molto più una scoperta?
SARTRE – Sì, ma molto più tardi. Io sono entrato all’École nel ‘24, siamo
stati ammessi all’agreg nel ‘29, ed è verso il ‘33…
POUILLON – Non prima?
SARTRE – Non prima. Io non sapevo chi fosse Husserl, egli non rientrava
nella cultura francese…
SIMONE DE BEAUVOIR – Si ignorava Hegel!
SARTRE – Si ignorava Hegel. Era Lachelier che diceva: “Niente Hegel finché vivrò”. E Brunschvicg, in La Conscience occidentale, ha dedicato, in un
capitolo, qualche pagina a Hegel, e nessuna a Marx.
Il risultato, l’ho spesso detto, è che ero in ritardo rispetto ai miei compagni
per i quali Freud e il surrealismo erano esperienze che essi potevano forse contestare su un certo piano, ma che in parte condividevano e che appartenevano
al loro tempo. C’era anche un po’ di Claude Farrère nella mia preparazione.
CONTAT – Per quale ragione lei scrive una tesi per un diploma di studi
superiori sull’immaginazione?
SARTRE – Suppongo di aver avuto in quel momento qualche idea sull’immagine –quindi in khâgne– e, dopo, di aver avuto l’impressione che era la
prima cosa che dovevo fare; l’idea che la sensazione non fosse la stessa cosa
dell’immagine, e l’idea che l’immagine non fosse una sensazione rinnovata.
Tutto ciò l’ho sentito dentro di me. È legato alla libertà della coscienza poiché,
21
22
quando la coscienza immagina, essa si stacca dal reale per cercare qualche
cosa che non è là o che non esiste. Questo passaggio all’immaginario è stato
anche uno degli elementi per farmi comprendere cosa sia la libertà. Una persona è là, gli si dice: “Dove è il vostro amico Pietro?”, egli è a Berlino, per
esempio, e lei immagina dove sia. C’è uno sganciarsi del pensiero che non può
spiegarsi col determinismo. Il determinismo non può passare all’immaginario.
Se è un fatto, creerà un fatto.
POUILLON – Si ha, insomma, un po’ implicitamente la risposta alla domanda che si poneva poco fa: il motivo per cui non fossero né Freud né Marx né
Breton ad attirarla, è perché lei aveva il suo problema dentro di sé ed essi non
erano di aiuto.
SIMONE DE BEAUVOIR – Certo, credo che sia molto giusto.
SARTRE – Era l’epoca del realismo, c’era l’idea di fare una filosofia nella
quale si sarebbe stati realisti. E realista non era né materialista né idealista.
POUILLON – Era già Husserl, “le cose stesse”…
SARTRE – È vero, era Husserl. È per questo che quando Aron m’ha detto
“Ma si può ragionare su questo bicchiere di birra”…
SIMONE DE BEAUVOIR – No, non era un bicchiere di birra, era un cocktail all’albicocca. [Risate]
SARTRE – Ebbene, ciò mi ha stupefatto, mi sono detto: “Ecco finalmente
la filosofia”. Noi pensavamo molto a una cosa: il concreto. C’era un libro di
Wahl che s’intitolava Vers le concret, che ci aveva fatto tutti sognare, perché il
concreto, sebbene non quello di Wahl (si trattava piuttosto di pluralismo nel
caso di Wahl), si pensava che esistesse… Tutti volevamo sapere cosa era un
tavolo, parlando filosoficamente, cioè tentare di astrarne un’essenza che non
è quella che le scienze potranno darci, vale a dire le scienze sociologiche per
studiare il lavoro ecc., e poi le scienze fisiche per spiegare la materia. C’era
qualcos’altro da imparare.
CONTAT – E perché si orientò verso la filosofia piuttosto che verso la letteratura?
SARTRE – Ah, questo, è a Bergson che lo devo. Quando sono entrato in
khâgne, avevamo un professore che era invalido e che si chiamava Colonna
d’Istria. Ci ha dato come prima dissertazione “la sensazione di durare”. Dico
“durare” e non “durata”. Allora io avevo letto il libro di Bergson l’Essai sur les
données immédiates de la conscience. E là ero stato catturato. Mi ero detto:
“Ma, la filosofia è formidabile, vi si apprende la verità”. Notate che è un libro
che ha una tendenza concreta, malgrado tutto, poiché tenta di descrivere concretamente ciò che accade in un coscienza. Penso che sia stato questo che
m’ha orientato verso l’idea di coscienza, così come l’ho presentata. Naturalmente, anche Husserl, che è venuto dopo. Ma, infine, la coscienza di durare è
stato uno degli elementi. Ricordo che ho fatto una dissertazione in cui trascrivevo Bergson. Non era mia abitudine trascrivere altri, ma mi dicevo: “Visto che
egli ha detto la verità, perché io dovrei dire cose diverse?”. Allora ho elaborato una dissertazione che era un riassunto, se vuole…
SIMONE DE BEAUVOIR – Quale giudizio ha avuto?
SARTRE – Mediocre. E in quel momento, ciò ha prodotto qualche cosa. Era
DOSSIER SARTRE
la prima volta. Non amavo quel professore, ma, davanti alla verità scesa dal
cielo, come questa in un libro, mi sono detto: “Bisogna farne discendere delle
altre!”. La filosofia è divenuta una cosa che mi interessava profondamente. Tra
l’altro io non ero neanche un buon allievo di Colonna d’Istria, dovevo essere
settimo o ottavo. Ma, infine, ho sentito che era quello che dovevo fare. L’anno
precedente, al contrario, o piuttosto due anni prima, nella classe di filo, non
comprendevo neppure come si potesse essere filosofi. Sono sempre stato
prima scrittore, e poi filosofo, è accaduto così. D’altra parte c’è stata tutta
un’epoca in cui lei [Simone de Beauvoir] mi sconsigliava di passare molto
tempo con la filosofia, dicendo: “Se non è dotato, non se ne occupi!”. È molto
semplice, è divenuta una vocazione a partire da Bergson, vale a dire che ho
sentito il bisogno di far questo, pur non sapendo molto bene quale fosse il rapporto tra filosofia e letteratura. È certo che soprattutto La Légende de la vérité
è stata una specie di tentativo di trovare un rapporto tra letteratura e filosofia.
In quel momento, la filosofia aveva qualcosa di letterario, nei miei libri, o perlomeno credevo, che fosse espressa letterariamente, cosa che ho cambiato
del tutto. Non penso che la filosofia possa esprimersi letterariamente. Essa
deve parlare del concreto, ch’è altra cosa. Ma ha un linguaggio tecnico che
occorre impiegare.
Considero ugualmente la filosofia oggi come l’unità di tutto ciò che faccio,
cioè, se volete, la sola unità che può esserci tra i differenti libri che ho fatto in
un’epoca data, è l’unità filosofica. Sono tutti orientati verso un medesimo centro, o, se preferite, sono tutti ricoperti da un medesimo guscio: è la mia filosofia dell’epoca. In modo che, così, scopro anche un altro genere di unità tra le
varie cose che scrivo; come, per esempio, si potrebbe trovare unità scrivendo
un romanzo che fosse interamente fatto sulla vita di provincia o di Parigi, oppure dei romanzi come quelli di Zola su una famiglia sotto il Secondo Impero. No,
l’unità, è la filosofia.
GORZ – Da dove le è venuta l’idea di andare a Berlino per studiare Husserl?
SARTRE – Perché Aron mi aveva facilitato le cose. Mi aveva presentata la
teoria di Husserl, in grandi linee però. Ho letto in quel momento un’opera di
Gurvitch1 sull’intuizione delle essenze in Husserl, e ho visto che era molto
importante. Ed egli [Aron] mi ha nello stesso tempo facilitato il cammino, poiché lui era stato all’Istituto di Berlino. Lì, a Berlino, leggevo Husserl prendendo
degli appunti. Dunque sono arrivato senza sapere niente, neanche l’intenzionalità, sapevo alcune piccole cose attraverso Gurvitch, ma occorreva leggere
Ideen.
POUILLON – E ha preso, cronologicamente, prima Ideen, oppure prima le
Logische Untersuchungen?
SARTRE – Le Ideen, niente altro che le Ideen, per me che sono lento un
anno è stato sufficiente per leggere le Ideen. La Transcendance de l’Ego l’ho
scritta in Germania quando ero alla Maison Française, e l’ho scritta direttamente sotto l’influenza di Husserl; per quanto io sia ancora contro Husserl in quell’opera, ma perché, in una certa maniera, non ho mai accettato niente senza
contestare. Il che vuol dire che non sono intelligente, allora il risultato è che ci
23
vuole molto tempo perché io comprenda le cose, occorre che siano completamente dentro di me e disossate. Mi occorre più tempo, per esempio, che al
Castoro [Simone de Beauvoir]. Il Castoro procede molto più svelta. Ma a me
occorrono tempi lunghi. Quando ciò avviene, c’è sempre uno strascico di contestazioni, poiché la cosa è stata smembrata, disossata ecc. Quindi, per questo ero assolutamente per Husserl su certi piani, vale a dire sul piano della
coscienza intenzionale, là lui mi aveva fatto scoprire qualcosa; questo è stato
il momento della scoperta.
1 Si tratta in realtà di un’opera di Emmanuel Lévinas, apparsa nel 1930: La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl (Alcan, Paris).
24
di Pierre Taminiaux
“Une Victoire”1: questo è il nome che Jean-Paul Sartre dava, nel marzo del
1958, al suo commentario su La Question d’Henri Alleg2. Rileggendo oggi questi due testi che costituiscono un insieme indivisibile, mi ritrovo non solo di fronte alla storia della Guerra d’Algeria (la guerra coloniale che si dispiegherà dal
1954 al 1962, fino agli accordi di Evian), ma anche di fronte alla contemporanea vicenda di una guerra, quella post-coloniale, che travaglia un altro paese
a maggioranza araba e musulmana, ovvero l’Iraq. La cruda violenza che attraversa il racconto di Alleg ci riporta, in effetti, a certe forme di violenza perpetrate verso il popolo iracheno, verso la sua esistenza sia politica che strettamente fisica. Le recenti rivelazioni sui soprusi commessi da soldati americani,
membri delle forze d’occupazione, contro i prigionieri iracheni nella prigione di
Abou Ghraib sembrano ripercuotere come un’eco lo stesso contenuto del racconto d’Alleg e del saggio di Sartre che l’accompagna.
La Question chiama in causa, dunque, delle nuove vittorie, quelle d’uomini
e donne pronti a resistere all’intimidazione dell’occupante e all’umiliazione collettiva che questa inevitabilmente genera. Come scrive Sartre: “Alleg ci risparmia dalla disperazione e dalla vergogna perché è una vittima che ha vinto la
tortura”3. L’ ottimismo deciso di questi due testi risiede, così, malgrado tutto,
nell’affermazione dell’uomo (dell’umano) esattamente verso chi lo nega in
modo radicale. Colui che si sforza, con i suoi propri mezzi di sopravvivere alla
tortura non fa che ripetere la seguente affermazione: “L’uomo esiste, l’ho
incontrato, sono un uomo nient’altro che questo”. Purtroppo, però, come Sartre mette ben in evidenza, non tutti possono essere uomini allo stesso tempo
né in modo simile. “Nella tortura, questo insolito scontro, la posta in gioco sembra radicale: è per la qualifica di uomo che il torturatore si misura col torturato
e tutto avviene come se entrambi non potevano, entrambi, appartenere alla
specie umana”4. In questo senso, paradossalmente, la questione non è inumana: uomini appartenenti alla medesima specie si competono il diritto di ribadire la propria identità sia singolare che comune.
Alleg e Sartre, quindi, condividono il rifiuto di un’apparente fatalità: quella
dell’inumanità dell’uomo. Poiché il sentimento della inumanità, così come spiega Sartre, non ha altro scopo che quello di convincerci della nostra impotenza
di fronte al male. “L’inumano non esiste da nessuna parte, tranne che negli
incubi che genera la paura”, sottolinea ancora Sartre5. Non si può considerare
la questione come un semplice sogno cattivo da dimenticare il prima possibile. Una tale prospettiva sarebbe troppo facile: permetterebbe, infatti, di liberarsi del male, della sua troppo insistente presenza, del suo nome troppo inquie-
DOSSIER SARTRE
SARTRE E IL NOME DEL MALE
25
26
tante, della sua inadeguatezza al reale, del suo non appartenere al mondo
concreto e vero. La Question, dunque, non è un racconto kafkiano: tutta l’entità della sua risonanza etica proviene precisamente dalla mancanza di qualsiasi pretesa metafisica. L’oppressione politica del soggetto non si dà a vedere
che nella materia più tangibile. Inoltre, essa non può che sfociare nel potere
della paura, nella misura in cui questo consacrerebbe proprio la legge dei carnefici e trasformerebbe, dunque, la vittoria in sconfitta. Non c’è alcun impressionismo, in questo senso, nel racconto d’Alleg: la rappresentazione della violenza nata dalla tortura consacra l’oggettività invalicabile e necessaria dei fatti
senza la minima costruzione metaforica né il minimo eccesso d’emozione.
Questi apparterrebbero ancora, in effetti, all’ambito della seduzione. Essi implicherebbero una sorta d’indebolimento del suo proposito ed un allontanamento, in qualche modo, del soggetto e della sua somiglianza a noi stessi.
Pertanto la paura è proprio qui. Ma è allo stesso tempo tanto quella del carnefice che quella della vittima. Il carnefice interroga, così, perché ha paura dell’inumanità dell’altro, perché rabbrividisce all’idea che ci sia troppo dell’uomo
nell’uomo. Non c’è spazio sufficiente su questa terra per tutto l’umano, pensa,
ed è questo che suscita l’estrema brutalità dei suoi atti. La sua vittima non ha,
del resto, davvero il tempo d’aver paura: non può che tentare di sopravvivere,
al di là di ogni sentimento, nel semplice vissuto psichico d’ogni istante che lo
pregiudica. Ma la paura, allora, è anche quella del popolo francese e dei politici che lo governano, la paura congiunta della moltitudine disarmata e dei
potenti che non osano guardare in faccia la verità. All’inizio del suo testo Sartre evoca, così, brevemente, l’atteggiamento di una parte del popolo francese
sotto l’occupazione, di questa Francia già ammutolita che guardava con noncuranza la polizia di Pétain compiere il suo preteso dovere e fingeva di non
comprendere ciò che succedeva al Vel d’Hiv o altrove. Egli impiega, a giusto
titolo, la parola stupore tentando, in questo senso, di cercare una spiegazione
psicologica, e non solamente politica, a questa passività collettiva. Un tale processo di generale stupefazione si compie nell’incomprensione della realtà. Ma,
come ben scrive a proposito di questo contesto storico particolare, “tutto è
accaduto insensibilmente attraverso impercettibili trascuratezze, e poi, alzando la testa, abbiamo visto nello specchio un viso straniero, detestabile: il
nostro”6. Lo stupore della massa riflette la paura dell’altro ma soprattutto di sé
stessi. In queste circostanze, in effetti, “vittima e carnefice non formano che
una sola immagine: la nostra”7.
Un tale stupore fu, allo stesso modo, all’origine della profonda rimozione
della guerra d’Algeria e della sua immagine negativa all’interno della cultura
francese, rimozione che eserciterà la sua influenza ancora per molto tempo
dopo l’anno ufficiale dell’indipendenza. In questo senso, la situazione congiunturale della guerra stessa non è la sola causa di questa intolleranza collettiva:
questa si perpetuerà fino alla pace, all’interno di un mondo che tuttavia in teoria avrebbe dovuto favorire la libera espressione di tutto il discorso politico (un
tale fenomeno si genererà, allo stesso modo, per l’affermazione della colpevolezza francese sotto Vichy). Si sa che l’opera di Henri Alleg fu sequestrata dal
governo francese qualche settimana dopo la sua pubblicazione, esattamente
DOSSIER SARTRE
il 27 marzo del 1958, quando si apprestava a conoscere un considerevole successo a livello di vendite. Questo suscitò, in particolare, la risposta d’intellettuali e scrittori, come André Malraux, Roger Martin du Gard, François Mauriac
e naturalmente Sartre, in una petizione indirizzata al Presidente della Repubblica. L’autore del libro era stato per più anni il redattore principale de L’Alger
Républicain (il solo quotidiano del paese ad essere autenticamente democratico data la sua apertura a tutte le tendenze politiche), dal 1950 al 1955 fino
alla sua ufficiale interdizione nel settembre del 1955. Membro, peraltro, del
Partito Comunista Algerino, egli fu in seguito ricercato ed infine arrestato il 12
giugno 1957. Il suo esempio sarà accompagnato da molti altri: non solo perché altre donne e altri uomini, sconosciuti e meno, dovranno subire delle sedute di tortura ripetute e sistematiche, da Maurice Audin, sostenuto da Pierre
Vidal-Naquetin L’Affaire Audin, a donne algerine quali Djamila Boupacha, difesa da Simone de Beauvoir e Giséle Halimi, ma anche e forse soprattutto perché i poteri successivi gollisti e post-gollisti manterranno deliberatamente il
segreto sui metodi più che dubbi dell’esercito francese in Algeria. I titoli di
opere letterarie censurate, interdette o semplicemente intralciate nella diffusione pubblica per i riferimenti troppo critici alla guerra abbonderanno: da Petit
Soldat di Godard al film francese senza dubbio più direttamente impegnato
contro questa guerra, Avoir vingt ans dans les Aurès di René Vautier8, la cui
fruizione fu per lungo tempo ridotta al circuito dei ciné-club, passando attraverso il film del cineasta italiano Gillo Pontecorvo, La Battaglia d’Algeri9 e naturalmente attraverso La Question.
Gli effetti culturali del fenomeno dapprima psichico dello stupore, dunque,
si faranno sentire per un troppo lungo numero di anni: daranno come esito un
soffocamento della rappresentazione critica accessibile alla maggioranza. Un
tale soffocamento, certamente, sarà stato determinato dai differenti poteri in
atto, ma ci si può legittimamente interrogare se taluni mezzi francesi non ne
abbiano approfittato, tollerandolo per meglio incoraggiarlo. Lo stupore, in un
certo senso, sarà certo stato ordinario: avrà permesso di confondere sotto
molti aspetti gli interessi dei politici e quelli dell’uomo della strada. È in questo
senso che il destino commerciale e giudiziale del racconto di Alleg ci interpella: non rivela solamente il ruolo politico della censura che viene dall’alto, ma
anche quello dell’autocensura che viene dal basso. In entrambi i casi si tratterà di far regnare la legge del silenzio10.
A tal riguardo, è interessante notare che nell’autunno del 2000 il primo ministro del governo francese dell’epoca, Lionel Jospin, espresse formalmente il
suo sostegno ad una dichiarazione fatta da un gruppo di intellettuali che condannavano le violazioni dei diritti dell’uomo commesse durante la guerra d’Algeria. “L’appello dei dodici” fu, così, pubblicato nel quotidiano L’Humanité il 31
ottobre del 2000. Tuttavia, egli rifiutò ostinatamente di impegnarsi in una reale
discussione dei fatti. In questo modo, egli rifletteva la posizione della maggior
parte dei membri dell’élite politica francese, ad eccezione dei comunisti. Inoltre dichiarò che da parte sua non si sarebbe pentito ed aggiunse che non
amava per niente la parola pentirsi. Queste sconcertanti affermazioni sottolineano inconsapevolmente l’importanza del problema della nominazione per il
27
28
riconoscimento del male, dal momento che non può esserci il pentimento
senza una confessione preliminare della propria colpevolezza.
Questo preciso problema è essenziale per la mia riflessione: in questo contesto, in effetti, eliminare una particolare parola significa cancellare la memoria d’una realtà storica specifica allo scopo di privarla del suo significato contemporaneo per la comunità. Più concretamente, la possibile filiazione politica
tra la passata democrazia coloniale francese e la contemporanea democrazia
post-coloniale è confutata in modo da evitare l’intera e profonda questione dell’eredità repubblicana. Nel tentativo di giustificare il silenzio dell’élite politica,
Jospin fece notare in questo caso che le violazioni dei diritti dell’uomo in Algeria costituivano un problema strettamente storico e giuridico e non soltanto un
problema politico. Da allora, una tale dicotomia tra il dominio storico e quello
politico implicava una negazione della capacità del linguaggio d’esprimere una
verità del passato nei termini linguistici del presente.
Il processo di nominazione del male opera sia nel testo di Sartre che in
quello d’Alleg; è precisamente grazie a questo processo che il male non solo
è manifesto qui ed adesso ma anche, e più profondamente, è iscritto nella sua
realtà storica. Il nominare il male torna, così, a definire prima di tutto il fatto politico come una realtà storica e a sottolineare in questo senso la necessità di
una coscienza storica come fonte dell’intero discorso politico legittimo. Si può
menzionare, di conseguenza, un’etica specifica associata a questa coscienza.
La storia non si accontenta del silenzio: essa costituisce una voce che non
cessa di parlare e che continuamente richiede al potere politico d’assumere la
sua responsabilità morale nei confronti della comunità e della sua memoria collettiva.
Il tema della censura affrontato attraverso La Question e la sua storia ben
definisce uno spazio politico e culturale della rappresentazione. La democrazia ha, dunque, il potere di far tacere, in certe circostanze, chiunque essa non
voglia ascoltare. Tutta la crudele ironia de La Question (il suo doppio senso
filosofico) viene, così, chiarita. Il carnefice obbliga la sua vittima a parlare, ma
peraltro egli agisce in nome d’un potere ufficiale e legittimo che la forza stessa mette a tacere.
Perfetto Doppio legame11, questo: una stessa fonte dell’autorità (ma diversamente incarnata) esige simultaneamente il silenzio e la parola della sua vittima. L’autorità gli notifica che le sue parole devono essere ben evidenti, poi
devono definitivamente svanire: la parola ed il silenzio sono qui, entrambi,
d’oro.
Di tutti i testi che Sartre consacra, a caldo, alla crisi algerina, Une Victoire
si dimostra essere, senza dubbio, il più sottile e complesso; giacché oltrepassa la semplice denuncia unilaterale del colonialismo come modello storico
d’oppressione dei popoli del terzo mondo (denuncia che si ritroverà certamente nell’introduzione ai Damnés de la terre, di Franz Fanon12), per interrogarsi,
in modo più ampio, al di là degli avvenimenti, sul male e sulla sua identità nel
suo relazionarsi alla natura umana. Qui il tono del testo di Sartre è quasi ovattato: l’autore non cerca né di accusare né di additare i responsabili dell’orrore.
Non implica né un’invettiva né un attacco personale. Le sue parole non inten-
DOSSIER SARTRE
dono amplificare a grossi tratti l’impatto della realtà: finiscono, al contrario, per
relativizzarlo. Infatti La Question è prima di tutto il racconto di un’esperienza
singolare: una voce unica si è imposta nel mezzo delle tenebre, ed è risalita in
superficie malgrado l’influenza di coloro che volevano ridurla a niente. I fatti
raccontati da Alleg sono già sufficientemente sorprendenti per sé stessi: non
necessitano di un’eco altisonante, piuttosto di una parola come un mormorio
che nella sua riservatezza e modestia faccia meglio intendere l’appello alla
dignità contenuto in questo racconto.
È evidente che “lo strip-tease del nostro umanesimo”, per riprendere la
celebre formula di Sartre nel suo testo su Fanon, è qui completo. Se l’inumanità non esiste, dunque, il simulacro d’umanesimo, che per lungo tempo ha
legittimato l’avventura coloniale a partire da Jules Ferry, è ben messo a nudo,
è il caso di dire, attraverso La Question. Con la tortura Alleg affronta non solamente i suoi carnefici, ma anche la pura illusione del discorso dell’(e sull’)
uomo incluso nell’ideale della Repubblica francese. In tal senso è proprio l’uomo universale che scompare in questa esperienza: non c’è che un solo uomo
che si oppone ad altri uomini particolari, escluso, dunque, dal sogno crudele di
tutti gli uomini (sogno che aveva definito, in partenza, l’idea coloniale), un
uomo che non ha più neanche il diritto alla consolazione d’una comunità astratta, divenuta inaccessibile.
In tale misura il racconto d’Alleg non appartiene che a lui: è l’occasione, per
l’autore, di rimpossessarsi di se stesso, in un mondo glaciale seguito all’uomo
universale. Questo Sartre l’ha perfettamente compreso: non opera mai generalizzazioni o conclusioni globali, ma riflette sui dubbi e sulle contraddizioni nati
dal carattere particolare degli avvenimenti. È per questa ragione che il discorso propriamente ideologico qui non ha luogo. Alleg stesso vi oppone resistenza, se ne allontana per far posto al resoconto di ciò che è avvenuto. Sartre
risponde fedelmente a questa domanda: non insiste né sulla retorica anticolonialista, per quanto quasi inevitabile, né sull’identità politica di sinistra di Henri
Alleg. In altri termini, non è un membro del Partito Comunista Algerino che è
stato torturato da alcuni francesi, è un uomo che è stato torturato da alcuni
francesi, e questo è sufficiente. Nei limiti in cui la tortura è assolutamente
imperdonabile ed indifendibile, dovunque avvenga e qualsiasi siano le sue
motivazioni politiche, essa interroga l’umano nella sua concretezza e la sua
autentica esistenza. Essa non rinvia né a dei valori né a dei principi puramente politici che permetterebbero ancora di giustificarla, ma al fatto stesso d’essere un uomo, malgrado e contro tutto.
È proprio ciò che costituisce la singolarità di questo testo nel fitto complesso degli scritti politici di Sartre. La crisi algerina non è qui per lui l’occasione per
un discorso sul colonialismo come espressione privilegiata della lotta di classe
nel terzo mondo. Una tale identificazione sarà, del resto, denunciata, nello
stesso periodo, da Jean-François Lyotard nei suoi diversi articoli di “Socialisme
ou Barbarie”, consacrati al problema algerino13, articoli che costituiscono, per
molti aspetti, una risposta a Sartre sulla questione del colonialismo. Ciò che
Lyotard mostrerà molto bene, in particolare, è, secondo le sue stesse parole,
“l’affossamento degli antagonismi di classe nella società coloniale”14, nel senso
29
30
che, da una parte l’F.L.N. si definirà un movimento di raggruppamento nazionale (quello della classe contadina, degli impiegati, della piccola borghesia e
della borghesia illuminata che assicurerà, in realtà, la direzione del movimento), e dall’altra parte la borghesia francese e i partiti di sinistra (particolarmente i comunisti) manifesteranno un’identica condiscendenza nei confronti dello
sviluppo del conflitto. Più in particolare Lyotard insisterà sulla diffusa rinuncia
della classe operaia francese: “la classe operaia non ha lottato energicamente contro la guerra”15, sotto l’influenza negativa di un P.C. che ufficialmente
dichiara il suo sostegno all’indipendenza, ma, concretamente, è molto più preoccupato dall’idea di un’Algeria americana in caso di ritiro delle truppe e dell’amministrazione francese, e che si sforza, dunque, di frenare il processo di
decolonizzazione. La guerra d’Algeria, in questo senso, consacrerà la collusione degli interessi della sinistra francese e della borghesia e la loro comune
strategia16. Ma è proprio questo paradosso che permetterà, allora, di contestare la validità delle proposizioni sartriane incluse nel suo testo su Fanon, quelle di un divenire politico radicalmente rivoluzionario dell’Algeria fondato sul
nuovo potere del piccolo popolo per troppo tempo oppresso dalla borghesia
colonialista sottomessa alle leggi del capitale.
In Une Victoire l’idea politica, tuttavia, è praticamente assente, perché il suo
stesso soggetto ne esige il superamento in nome della ricerca d’un’etica del
soggetto. Ma quest’etica non implica, nella sua urgenza, una forma d’ontologia, sebbene, evidentemente, tale parola non faccia parte del discorso sartriano? Si tratta d’affermare il trionfo dell’essere e della sua vita sulla morte, e della
parola sul silenzio, prima che questa vita si possa trasformare in un’architettura teorica. Soltanto Henri Alleg ha ragione, qui, e nessun altro, neanche il filosofo. Solo quest’uomo è in grado di custodire una ragione profonda del politico, ammesso che esista ancora una ragione, dopo “la question”. Ma è precisamente la ragione per cui Une Victoire sembra più attuale e più prossimo a
noi sotto molti aspetti che, per esempio, Les Communistes et la paix17 o lo
stesso testo su Fanon. Sartre non cerca di proiettare sul terzo mondo
un’astratta e superata verità occidentale, come ha fatto altrove, quella della
rivoluzione marxista adattata alle realtà culturali, politiche, economiche e
sociali dei paesi colonizzati. “Bisogna farla finita con un certo marxismo di
patronato”18, scriveva così Lyotard nel 1957 nelle sue cronache algerine, sottolineando l’abisso che separava certi intellettuali francesi di sinistra dalla realtà quotidiana di un paese dove egli stesso aveva vissuto.
Infatti questo “adattamento” si trasformerà presto in un disadattamento,
come proveranno i fallimenti storici successivi del modello marxista applicato al
terzo mondo, da Cuba al Nicaragua passando attraverso l’Angola, l’Etiopia, il
Vietnam e la Cambogia. La lucidità di Sartre consiste, allora, nel non raffigurare l’Europeo, cioè il colono, come il solo colpevole del fenomeno della tortura:
Ed io non pretendo, ben inteso, che gli Europei d’Algeri abbiano inventato la tortura, né che abbiano incitato le autorità civili e militari a praticarla; al contrario la
tortura s’è imposta di per sé, essa era divenuta una routine prima che se ne prendesse consapevolezza.
[…] Così, di queste due coppie indissolubili, il colono ed il colonizzato, il carnefice
Il proposito sartriano, così, evita ogni manicheismo. Il male arriva surrettiziamente, quasi all’insaputa di ciascuno. Esso si radica come una fatalità:
l’odio è più forte dell’uomo, può dominare qualsiasi cosa. Non detiene alcun
particolare bersaglio. All’interno di questo cerchio infernale, ci sono spesso
degli uomini venuti dalla Francia ma che non hanno mai avuto, nel passato, il
progetto dell’odio. Essi sono stati semplicemente travolti in un turbine che
avrebbe potuto travolgerne altri. Il male che costituisce la tortura, in questo
senso, è proprio meccanico, perché il suo esercizio non corrisponde ad un’idea
preconcetta del politico, ma ad un sentimento distruttivo costituzionale all’uomo. È nella natura di questo, in lui ed intorno a lui, al di là di ogni verità e ragioni collettive, al di là di ogni pensiero preliminare della comunità e dell’alterità20.
È questo che lega, a dispetto dell’ineguaglianza del loro rapporto di forza,
il carnefice alla sua vittima e la vittima al suo carnefice. L’uomo ha paura e dunque odia e fa soffrire, ma ogni uomo può aver paura e quindi odiare e far soffrire. Uno dei grandi meriti di Une Victoire è precisamente quello di rifiutare la
facilità di una dimostrazione alla lavagna e di un ragionamento che assegnerebbe ad una fonte particolare il monopolio della verità politica. Alleg stesso
non si lascia mai andare a questo genere d’esercizio: diffida, da buon giornalista, dei concetti troppo ben elaborati, e preferisce appoggiarsi a ciò che è qui,
ad una inconfutabile presenza dell’esistenza immediata. Il metodo de “la question” smaschera precisamente uno dei miti fondatori dell’eredità filosofica
della Rivoluzione Francese: quello d’una coscienza universalizzante del politico la cui legittimità sarebbe quella propria di un solo popolo e d’una sola nazione (ma precisamente nella misura in cui tale popolo e nazione si fondono in
un’unica origine). In La Question, dunque, non è la Francia che ha torto, come
avrebbe potuto avere ragione in altre circostanze, né i francesi, ma alcuni francesi. Come Alleg stesso precisa nelle ultime righe del suo racconto, alcuni
uomini agiscono “nel nome della Francia”. Sono questi i principali responsabili del razzismo e dell’odio. Le nozioni fondamentali del bene e del male sono
più che mai determinanti, così in La Question: esse generano necessariamente il discorso critico che le accompagna. Ma non possono in alcun caso sfociare nell’identificazione indiscutibile di un’unica origine del bene o del male. L’articolo di Sartre ed il racconto d’Alleg rendono conto insieme di una tale confusione ed incertezza. L’autore de La Question non è un buon comunista secondo l’ideale proletario che affronta i cattivi parà fascistoidi nutriti dalla borghesia
e dal grande capitale francese. Alleg non parla in nome di una classe né, allo
stesso tempo, in nome di un popolo (così fanno i carnefici): egli parla in nome
di ogni uomo (e, quindi, non solamente algerino) vittima della tortura nel mondo
coloniale ma anche in gran parte non coloniale, in nome di tutti coloro che sono
oggetto d’un odio cieco a causa delle loro idee o della loro razza e che non ne
possono parlare. L’intelligenza di Sartre consiste, allora, nel sottolineare che i
DOSSIER SARTRE
e la sua vittima, il secondo qui non è che un’emanazione del primo. E, senza alcun
dubbio, i carnefici non sono dei coloni, né i coloni dei carnefici. Questi sono in
genere giovani persone che vengono dalla Francia e che hanno vissuto vent’anni
della loro vita senza essersi mai preoccupati del problema algerino. Ma l’odio era
lì un campo di forze magnetiche: esso le ha attraversate, corrotte, dominate. 19
31
carnefici costituiscono un gruppo d’individui intercambiabili ed anonimi senza
una propria identità:
Nessuno di questi uomini esiste per se stesso, nessuno resterà ciò che è: essi rappresentano i momenti di un’inesorabile trasformazione. Tra i migliori ed i peggiori,
una sola differenza: questi sono matricole, quelli anziani. Ognuno finirà per andarsene e, se la guerra continua, altri li rimpiazzeranno, dei biondini del Nord o dei
piccoli bruni del Centro, che riceveranno la stessa formazione e ritroveranno la
medesima violenza e l’identico nervosismo.
In questo affare gli individui non contano più: una sorta di odio errabondo, anonimo, un odio radicale dell’uomo s’impossessa contemporaneamente dei carnefici e
delle vittime per degradarli insieme gli uni contro degli altri, creandosi i suoi propri
strumenti21.
32
Qui il politico ed il suo potere prendono la forma neutra. Il carnefice non ha
né nome né viso, egli è l’anonimo che ordina alla sua vittima di nominare. È
proprio una fonte del male indifferente, poiché senza differenza. Egli è chiunque possa svolgere un preciso compito. Ma in questo processo di spersonalizzazione del luogo d’origine del male, la vittima stessa è implicata suo malgrado. Poiché se il male è senza forma né figura, chi parla, allora, chi pone le
domande? O piuttosto chi fa parlare? L’etica della responsabilità umana di
fronte all’opera di morte del politico si trova proprio contraddetta dalla modernità e più particolarmente dall’organizzazione segreta del potere che essa produce in democrazia così come nel totalitarismo. Nel primo caso, senza dubbio,
si tratta di un’eccezione, dal momento che nel secondo si tratta molto più di
una regola. Ma poco importa: l’effetto di quest’organizzazione è lo stesso sotto
molti aspetti. Il male si ritrova ad essere “sradicato dalla realtà” o è reso più fittizio dal fatto stesso che non risponde più ad alcun’esigenza d’identità individuale. Questa perdita di realtà implica, si sa, secondo un movimento paradossale, un “in più di realtà” del potere nella sua opera di morte. Un tale fenomeno si ritrova oggi negli Stati Uniti nel processo giudiziario che mira a perseguire e a condannare i presunti responsabili degli abusi di violenza nella prigione
d’Abou Ghraib. Questi uomini sono, nella maggior parte dei casi, soldati o ufficiali subalterni che non hanno fatto altro che obbedire agli ordini provenienti
dall’alto e che non hanno agito, a dire il vero, di loro propria iniziativa. Ma l’opacità del funzionamento dell’esercito americano in Iraq è tale che l’autorità che
dà gli ordini non è mai chiaramente identificata né ancor meno punita.
Il destino della vittima, in La Question, spinge in un certo senso questa logica fino al suo termine: essa è, così, intimata a scomparire, eclissare la stessa
traccia del proprio viso e del suo corpo e diventa, così, il perfetto simbolo dell’assenza del nome nel male, assenza che rinvia, pertanto, ad un imperativo
della nominazione dell’altro (degli altri). Questo processo di scomparsa fu ben
messo in luce dai vari documenti fotografici pubblicati per la stampa internazionale in occasione del recente scandalo di Abou Ghraib. Una delle caratteristiche più sorprendenti di queste immagini prese dai carnefici, in effetti, era nella
generale assenza del viso delle vittime. Queste non erano altro che un mucchio di corpi nudi ridotti alla più brutale animalità e completamente fusi in questa stessa animalità. In questo senso le vittime erano non solamente private
Questa chiama gli uomini a fare qualcosa. Ma se vuol essere ancora letteratura
autentica, gli rappresenta questo qualcosa da fare, questo scopo determinato e
concreto a partire da un mondo dove una simile azione rinvia all’irrealtà di un valore astratto e assoluto. Il “qualcosa da fare” così come può essere espresso in
un’opera di letteratura non è che un “tutto si deve fare”, sia che esso s’affermi
come questo tutto, cioè valore assoluto, sia che per giustificarsi e raccomandarsi
DOSSIER SARTRE
del proprio viso ma anche del proprio corpo divenuto non identificabile. La crudele ironia della posa fotografica forzata dai carnefici, veniva dal fatto che essa
rappresentava in modo paradossale la radicale cancellazione dell’intera identità (e non solamente sessuale), come nel famoso esempio del detenuto
messo sopra una cassa e collegato a dei fili elettrici, il cui viso, totalmente
nascosto, era incappucciato.
Nella tortura, in effetti, il soggetto che la subisce è soltanto un corpo senza
nome né viso che contiene dei nomi. Non è un caso che le ultime righe del racconto di Henri Alleg terminino con parole che si rivolgono a tutti i francesi che le
leggeranno: “essi devono conoscere ciò che è fatto nel loro nome”. Il male è,
dopo tutto, usurpare il nome, il suo autentico senso politico e morale, negarlo, da
quel momento in poi, proclamandolo. Il nome è qui il luogo essenziale di questo
male, la sua posta più dolorosa e decisiva. Il corpo senza nome che deve nominare non può che reiterare la seguente affermazione: il nome di Francese è stato
sequestrato per fini inaccettabili. Di conseguenza il carnefice è l’uomo che si è
impossessato di questo in modo illegittimo: è, dunque, ugualmente l’anonimo
perché pretende di possedere un nome che non può più essere il suo.
Che vuol dire impegnarsi, allora, nel contesto de La Question? Qual è il significato dell’azione politica del soggetto che sembra, tuttavia, condannato a subire
e a rimanere passivo? Qui l’impegno è quello di un corpo assoluto, totalmente
dominato da una prova puramente fisica. Ma in questo rapporto, che non è che
uno, quello del carnefice con la sua vittima, la trascendenza dell’Ego, qualunque
cosa sia ferocemente negata dall’altro, è ancora possibile. Essa è persino, in un
certo senso, più che mai possibile. Così la vittima esiste (non può sopravvivere)
solo se dimentica proprio di esistere. Il soggetto deve negare persino la presenza materiale del suo proprio corpo per poter ancora e sempre vivere. È cosi, e
così solamente, che egli può negare i molteplici assalti di cui è l’oggetto. Il corpo
si impegna, in questo senso, perché si nega lui stesso come singolarità (come
presenza di un soggetto singolare), pur essendo negato dall’altro. Il soggetto si
dice: “io non esisto” per poter propriamente esistere ed essere, malgrado tutto,
nel mondo22. Ma questo “io non esisto” impone la confessione di un “io non faccio niente”, confessione di non-reazione che costituisce la garanzia della sua
resistenza al nemico e del suo mutismo. L’impegno è generato proprio da una
doppia negazione. Ma in questo processo lo spirito del soggetto politico s’afferma irresistibilmente: il corpo puro si ricongiunge alla coscienza pura di un soggetto che ormai vive della sua sola forza mentale e della sua unica volontà interiore, a partire da un movimento radicale di superamento di sé. La letteratura
impegnata, qui, non è una letteratura stricto sensu d’azione. Poiché questa implica un imperativo del “fare” nel linguaggio, come ha ben mostrato Blanchot in un
importante testo consacrato ai rapporti della scrittura col Terrore:
33
abbia bisogno di questo tutto nel quale scompare. Il linguaggio dello scrittore, persino rivoluzionario, non è il linguaggio di un comandamento. Esso non comanda,
esso presenta, e non presenta rendendo presente ciò che mostra, ma mostrandolo, dietro tutto, come il senso e l’assenza di questo tutto23.
34
Al di là, dunque, del sogno della totalità dell’azione e del suo comandamento nella rappresentazione del politico (ma questa, in Alleg, non è mai solo una
presentazione, nel senso blanchottiano della parola), l’impegno qui risponde
ad una logica specifica del dovere dell’indifferenza. La vittima deve, in effetti,
restare indifferente alla sua pena (al suo corpo che lo scongiura di chiamare,
di parlare), ma anche alla presenza dell’altro, ovvero del carnefice. Questo,
peraltro, ha il dovere di essere indifferente alle grida di tale uomo. La legge dell’indifferenza rinvia, dunque, a quella dell’anonimo: “Io resto insensibile alla tua
esistenza e perciò non ti darò nessun nome”, dice il torturato.
Secondo una tale prospettiva si può affermare, allora, che ne La Question
l’inferno non sono gli altri, ma al contrario lo stesso e doppiamente lo stesso,
se così si può dire. Da una parte, in effetti, i visi dei carnefici non formano altro
che un insieme indistinto. Essi si somigliano tutti ed è precisamente da questo
carattere intercambiabile che essi ricavano il proprio potere, da questa generale oscurità nata dal loro essere indefiniti. Ma d’altra parte, come mostra bene
Sartre, i carnefici appartengono allo stesso mondo delle loro vittime. Prima di
tutto sono dei francesi a torturare un altro francese. Ciò non impedisce a Sartre, peraltro, di tracciare le linee essenziali tra l’odio e il razzismo nello sviluppo della guerra d’Algeria. Alcuni membri d’un esercito rappresentativo di uno
stato democratico se la prendono con un altro democratico, un uomo di massmedia guidato nella sua professione dall’intoccabile principio della libertà di
parola generato dal credo repubblicano. Un altro buon numero di ufficiali paracadutisti che dirigono queste sedute di tortura o ordinano di compierle sono
essi stessi degli ex resistenti o soldati, talora esemplari ed eroici, che hanno
combattuto il nazismo durante la seconda guerra mondiale. Degli ex-antifascisti, dunque, si battono contro un comunista di natura antifascista. È certamente questo che disturba la coscienza del lettore. Gli eroi di ieri (ma questi eroi
allora avevano scelto il partito delle vittime e lottavano al loro fianco) sono divenuti i torturatori ed i vigliacchi di oggi. (È sufficiente pensare all’itinerario politico più che strano di un Massu o di un Gorge Bidault, dalla seconda guerra
mondiale a quella d’Algeria, per rendersene conto). Questo rovesciamento dell’identità si produce all’interno di un contesto repubblicano: non lo oltrepassa
ma vi si colloca in maniera quasi perfetta. Qui l’abiezione consiste nella confusione dei ruoli e dei valori. Il tempo precipitoso della storia ha fatto il suo corso:
ha permesso una simile trasformazione sotto la pressione dell’ideologia colonialista. “Noi siamo tutti gli stessi”, così dice il carnefice verso e contro tutti. Ed
è proprio per questo che può compiere il suo ingrato lavoro. Una simile affermazione giustifica la sua azione e lo rafforza nella sua buona coscienza. Il carnefice de La Question, come lo descrive Sartre, è ancora a modo suo un umanista. È in questo senso che bisogna comprendere l’idea sartriana, a prima
vista strana, di una impossibilità dell’inumano nel racconto di Alleg. Qui non c’è
più posto, in effetti, per un’alternativa all’umano, per qualcun altro diverso dal-
DOSSIER SARTRE
l’uomo, perché questo fondamentale rovesciamento ha già avuto luogo, essendo la condizione preliminare, necessaria e sufficiente della tortura.
L’attualità del racconto di Alleg e di Une Victoire risiede in questa constatazione essenziale: il male può fondarsi su un movimento che va dallo stesso al
medesimo, non c’è sempre bisogno di una rappresentazione fantasmatica dell’altro per esistere (mentre il contesto storico e culturale della guerra d’Algeria
darebbe da pensare precisamente al contrario). La “victoire” della vittima, in
questo senso, al di là della sua sopravvivenza puramente fisica, è quella di un
uomo che giunge a preservarsi uno spazio sia esistenziale che politico della
differenza, lo spazio di un’altra politica coloniale, d’un altro rapporto tra le
razze, d’un’altra concezione dell’uomo –dell’umano– e della sua libertà. Nondimeno, Alleg non pretende di essere né un eroe né un superuomo. In lui non
c’è una visione epica della sua avventura personale e politica, come in Malraux, per esempio, né l’afflato nietzschiano di natura profetica. Il suo coraggio
è a malapena amplificato dalle parole: è quello d’un appassionato. Al contrario, coloro che un giorno sono stati degli eroi lo affrontano. L’eroismo è qui per
lui una nozione più che dubbia, poiché ha troppo spesso fornito il mito al nemico nel suo progetto di espansione coloniale, concepito in origine dalla Francia
come lo specchio di una “grandezza umanistica” della nazione (l’eroismo, allora, dell’uomo che porta volontariamente la civilizzazione e la cultura ai “selvaggi” che sono nel mezzo dell’ignoranza e della barbarie). Il suo racconto evita
tanto il pathos di una forza indomabile che vince la sofferenza dell’essere,
quanto il sensazionalismo d’una rappresentazione spettacolare della violenza
estrema. Egli semplicemente scopre una perfetta geometria del terrore la sua
trasparenza ancora pudica malgrado la schiacciante evidenza dei fatti. La
Question, in questa misura, non si situa oltre il bene e il male ma proprio al di
qua di questi due: essa rivela, così, lo stoicismo non di circostanza ma essenziale dello scrittore.
L’appassionato è l’uomo che senza dubbio può meglio scrivere questo tipo
d’esperienza. Da Primo Levi a Platonov, in effetti, abbondano gli esempi che
provano la vanità d’una scrittura detta professionale quando s’applica a rappresentare la dimensione irrappresentabile del politico. Lo scrittore nasce dall’esperienza stessa (dalla sua intera esperienza narrativa) e da nient’altro. In
un certo senso non può esserci un testo anteriore a questo: le prime parole
sono sempre le più decisive e le più eloquenti. Il giornalista, qui, diventa scrittore, come altrove il chimico o il membro del Partito, poiché egli è, in un certo
modo, senza passato, perché il suo linguaggio non esiste se non nel cuore
della sua presente condizione. Il dovere della scrittura è certo senza antecedenti. Spesso ho pensato, a tal riguardo, che i testi più intensi consacrati
all’esperienza del totalitarismo venissero da queste voci, queste voci originali,
più viventi, senza dubbio, perché nate con l’evento. Si tratta certamente di
un’esigenza morale di sincerità e di onestà di cui lo scrittore già pubblico, troppo cosciente della sua identità e di quella dei lettori, troppo abituato all’uso
abile delle parole, non è più sempre capace quando deve raccontare una simile realtà. Lo si sarà compreso, La Question è in questo senso il libro di un innocente disperso tra i colpevoli. Ma questa innocenza è prima di tutto quella del
35
36
linguaggio, del nuovo linguaggio di un uomo che non ha niente da dimostrare
e che si accontenta di far conoscere ciò che resta di più umano, malgrado
tutto, nel confronto col male (e quindi nel suo riconoscimento), ciò che rimane
dopo questo e che sopravvive a qualsiasi cosa arrivi, vale a dire le parole.
Il turbamento dell’identità, di cui lui è testimone, appare in particolare nella
conclusione. Alleg sente, dalla sua cella, le grida di un detenuto algerino nella
corte della prigione. Quest’uomo è stato condannato a morte nello stesso
momento in cui due dei suoi compagni e dei suoi guardiani lo conducono al
patibolo. Allora egli grida, proprio prima di morire: “Viva l’Algeria!”. La sconcertante e cupa ironia di questo momento scaturisce dalla stessa natura del
mezzo utilizzato per la sua esecuzione. Il simbolo storico della giustizia rivoluzionaria francese diviene, circa due secoli dopo, quello della giustizia colonialista. Non si potrebbe trovare una confusione simbolica più eclatante: il terrore
si appoggia su uno stesso oggetto che permette la rappresentazione del bene
e del male e dei termini distorti dal potere politico. Questo simbolo permanente allontana, così, l’immagine reale dell’emancipazione dei popoli e d’un divenire storico orientato nel senso dell’equità e della fraternità umana, e dunque
la concreta attualità dei valori rivoluzionari per colui che Albert Memmi definiva
“l’uomo dominato”. I giusti di ieri, che agivano nel nome della Francia e del suo
popolo, ritrovano nei militari della fine della IV Repubblica, sempre al nome
degli stessi, uno degli emblemi privilegiati della loro legge. Il carnefice si crede
ancora puro e soprattutto umano. Non ha cessato d’esserlo, malgrado le tribolazioni della storia. È proprio così, nell’utilizzazione propriamente politica dei
riferimenti simbolici, che si perpetua il sogno oscuro d’un uomo universale
divenuto assoluto nel suo rifiuto del particolare, a partire da una filosofia morale che si è creduto essere condivisa da tutti. Il ritorno del terrore (“della più fredda e più piatta morte”, come Hegel diceva, della morte senza nome) corrisponde, dunque, prima di tutto al ritorno forzato dei segni più forti di questo.
Si può vedere, quindi, in cosa Une Victoire e La Question interrogano la
nostra verità democratica contemporanea. Giacché questo mondo del rovesciamento dei ruoli politici, questo mondo senza nome, stabilisce dove la vittima di ieri (quella della barbarie nazista o del fanatismo islamico) può divenire,
a nostra insaputa, il carnefice di oggi e, viceversa, è quello che ci offre il Nuovo
Ordine Mondiale nato dal crollo del comunismo dell’Est, da circa quindici anni.
Il male non proviene più, adesso, da una sola fonte, o da un solo impero,
Sovietico o Americano, com’era per molti, sia a destra che a sinistra, nel corso
della Guerra Fredda. Ora si è disseminato, per meglio ingannarci. Ciò significa che, in effetti, le fonti del male sono sempre meno chiare (ma non le fonti
del bene, poiché ufficialmente ne esiste solo una: quella della democrazia liberale e dell’economia di mercato che l’accompagna). È proprio ciò che s’afferma come il maggior pericolo, filosoficamente ed eticamente parlando, della
nostra epoca, nella misura in cui le stesse nozioni di colpevolezza e responsabilità (individuali e collettive) si perdono spesso in un universo informe dove il
nemico resta nascosto e a volte difficile da definire24. La Guerra Fredda, questa, poteva, all’opposto, offrire più rapide consolazioni alla sofferenza dei popoli e procurare facilmente una buona coscienza poiché le colpe erano per lo più
DOSSIER SARTRE
quelle di un nemico che si costituiva come un altro politico radicale. Ma all’alba di questo nuovo millennio, dove s’arresta il regno della ragione e dove
comincia quello dell’irragionevolezza? E chi custodisce davvero le chiavi della
verità, quando l’altro sembra perdere la sua totale figura? I Serbi responsabili
dei massacri di Srebrenica non erano, dopotutto, i figli degli eroi della lotta contro il nazismo dell’ex Jugoslavia? Non è, così, a causa del ricordo dei partigiani di Tito (ma ugualmente di conseguenza a quello di Hitler e degli “oustachis”
di Pavelic) che noi abbiamo per troppo lungo tempo chiuso gli occhi, noi europei, sulle loro estorsioni ed abbiamo potuto giustificare in gran parte la nostra
inerzia collettiva? Il sentimento di un’ambiguità del male generato dal racconto di Alleg e dall’articolo di Sartre non deve cessare, quindi, di interessarci ed
interpellarci25. Perché l’ufficiale dei parà che, nel giugno 1957 ad Algeri, “s’occupava” di Henri Alleg e di molti altri, uomini e donne, francesi ed algerini, non
avrebbe potuto anche lui, malgrado le sue azioni, essere ignorato o persino
discolpato, secondo questi termini? L’appello all’identificazione ed alla nominazione che questi due testi invocano deve farci riflettere, noi soggetti democratici conquistati da questo nuovo ordine che non osa pronunciare il suo vero
nome (che non sempre utilizza il nome che occorrerebbe). In effetti, a volte, i
torti sono condivisi, tuttavia non sono mai anonimi. Non li si nomina mai abbastanza: è ciò di cui Alleg e Sartre ci persuadono, poiché tutti i nomi possono
finire per somigliarsi nel turbine della storia. Democrazia e totalitarismo non si
escludono: a volte si completano, s’alimentano l’un l’altro fino alla presunta
agonia dell’altro, fino al luogo comune di una libertà immediata e globale divenuta oggi il peggio degli alibi post-ideologici, quello dell’indifferenza. Le immagini vergognose dei corpi nudi ed ammucchiati gli uni sugli altri dei prigionieri
iracheni d’Abou Ghraib ci ricordano, così, che nella moderna storia occidentale le peggiori azioni sono state spesso commesse nel nome della libertà dei
popoli e del progresso dell’umanità. La presunta lotta contro il male (contro
“l’asse del male”, più precisamente, se si considera la fraseologia del potere
americano attuale) può essa stessa generare ciò contro il quale sostiene d’opporsi. Questo perverso rovesciamento delle cose non costituisce un semplice
caso o una mera peripezia della storia: al contrario si inscrive nella logica di
ogni potere a pretese universaliste per il quale l’Altro (con un’A maiuscola) non
è che una figura neutra suscettibile d’esser ridotta in questo stato per un’apparente ragione sia pratica che simbolica. In questo senso dare un nome al male
implica ugualmente dare un nome e far luce sullo spazio della sua apparente
contraddizione politica.
Non lo si nomina mai abbastanza, poiché si ha troppo spesso paura di
nominarlo. In ciò sta il significato, per esempio, dei grandi processi che mirano
a condannare i crimini di guerra e quelli commessi contro l’umanità. Tale significato non è nella punizione propriamente detta, ma nella nominazione dei colpevoli e delle loro colpe, ancora e sempre. Così l’obbligo di perseguire uomini
come Karadzic e Mladic dinnanzi al tribunale de La Hayne non è legato al
sogno di una qualsiasi riparazione dei loro crimini. Il male è fatto, non si può
che pronunciarlo ed intenderlo, al di là di ogni sentenza. Se la comunità internazionale ha, fino al presente, mancato al suo compito e se questi due uomi-
37
ni restano liberi, è precisamente perché essa preferisce soprassedere a questo imperativo etico del nome e rifugiarsi nel silenzio, malgrado le belle intenzioni tradotte in parole (ma non in atti) e le promesse. “Parlate e tacete”, dicevano i parà francesi davanti ad Henri Alleg, nel 1957 ad Algeri. “Parlate e tacete”, dicevano due nostri uomini ai musulmani bosniaci, in una calda giornata
d’estate, nel 1995 a Srebrenica. “Parlate e tacete”, dicevano ancora i soldati
americani ai loro prigionieri iracheni nel 2003 e 2004. Sembrerebbe che oggi,
allora, non siano le vittime, ma i giudici ad aver obbedito al loro ordine. La Question e Une Victoire ci invitano, così, a rompere il silenzio ovunque venga e
qualunque sia la sua apparente ragione. Il nome che risuona e che si fa sentire da lontano è quello nato dal tribunale della storia. Tutti gli uomini sono membri di questo tribunale, e non solamente qualche eletto, scelto per le sue competenze giuridiche. Poiché il male più diffuso è senza dubbio il più lancinante
e tenace. L’esigenza di un nome è, dunque, anche quella di un centro: essa
rinvia ad un origine di questo silenzio, ad un punto di partenza definito e differenziato da dove necessariamente nasce l’immagine del carnefice e della sua
vittima, in quel momento preciso dove l’uno non s’era ancora confuso con l’altra per rendersi indicibile.
(traduzione di Donatella Morea)
38
1 In Situations V, Colonialisme et Néo-Colonialisme, Gallimard, Paris 1964, pp. 72-88. Pubblicato precedentemente nell’Express, n. 350, il 6 marzo 1958.
2 Editions de Minuit, Paris 1958.
3 J.-P. SARTRE, op. cit., p. 76.
4 Ivi, p. 84.
5 Ivi, pp. 76-77.
6 Ivi, p. 73.
7 Ivi, pp. 73-74.
8 Il film di René Vautier fu girato nel 1971. Il cineasta francese non ha mai abbandonato la sua
ricerca della verità storica sulla tortura durante la guerra d’Algeria. Per lo stesso scopo ha realizzato un gran numero di interviste a vittime, tra gli anni sessanta ed ottanta. Egli ha potuto, così,
mettere insieme più di sessanta ore di pellicole basate su resoconti personali dei fatti. Alcune di
queste interviste sono state proiettate nella cineteca di Parigi la scorsa estate del 2003.
9 L’uscita di questo film in Francia, per la prima volta in versione integrale e non censurata,
nella primavera del 2004, ha coinciso, del resto, con le rivelazioni sulla stampa delle azioni di tortura commesse dall’esercito americano in Iraq. La sua cocente attualità fu sottolineata ancora
meglio. Del resto, bisogna aggiungere che una speciale proiezione di questo film fu organizzata
contemporaneamente a Washington per i più alti responsabili del Pentagono. Lo scopo riconosciuto di questa proiezione era quello di mostrare alle autorità della difesa i metodi utilizzati dall’esercito francese nella sua lotta contro il terrorismo in terra araba e di discutere in seguito la loro possibile utilità per l’esercito americano in risposta ai numerosi attentati terroristi perpetrati dagli insorti in Iraq.
10 A tal riguardo, è necessario sottolineare che la diffusione delle immagini d’Abou Ghraib nell’attuale America è molto più rapida. Questa più grande trasparenza è legata essenzialmente
all’enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione a tempo reale di questa cultura di massa, e non
ad una qualsiasi superiorità etica del potere politico americano o persino dell’uomo della strada nel
suo rapportarsi alla verità dei fatti. A confronto, la Francia degli anni cinquanta non conosceva evidentemente né la televisione via cavo, né Internet.
12
DOSSIER SARTRE
Double Bind: in inglese nel testo. N. d. T.
In Situations V, cit., pp. 167-193, prima pubblicato insieme al testo di Fanon per la Maspero Editions nel 1961.
13 Tali articoli sono stati riuniti sotto il titolo La Guerre des Algérien, Galilée, Coll. “Debats”, Paris
1989, con una presentazione di Mohammed Ramdani.
14 Ivi, p. 90.
15 Ivi, p. 85.
16 Questa collusione s’è particolarmente affermata nella Francia degli anni cinquanta, sotto l’influenza di un politico moderato come Guy Mollet alla testa della S.F.I.O., ma anche sotto quella
d’un Partito Comunista che accentuava la sua deriva piccolo-borghese in nome della ricerca prioritaria del benessere materiale della classe operaia francese all’interno di una società di consumo
allora in pieno sviluppo.
17 In Situations VI, Gallimard, Paris 1964, pp. 80-394, pubblicato in origine da “Les Temps
Modernes”, n. 81, luglio 1952, n. 84-85, ottobre-novembre 1952, n. 101, aprile 1954.
18 J.-F. LYOTARD, op. cit., pp. 86-87.
19 J.-P. SARTRE, op. cit., pp. 86-87.
20 Bisogna del resto riconoscere, per rispettare l’oggettività storica, che sfortunatamente certi
membri del F.L.N. ricorsero alla tortura durante la guerra allo scopo di ottenere delle informazioni
sulle attività del nemico.
21 J.-P. SARTRE, op. cit., p. 79
22 Sui rapporti, in Sartre, tra trascendenza dell’ego e teoria dell’impegno, si veda in particolare
Denis Hollier, “Actes sans parole”, p. 51-53 e “Mimesi et castration 1937”, pp. 63-64, in Les Dépossédés, Minuit, Paris 1933, dove l’autore mostra bene il processo di spersonalizzazione e messa
da parte della coscienza soggettiva provocato paradossalmente dall’implicazione totale del soggetto nel mondo.
23 M. BLANCHOT, “La Littérature et le droit à la mort”, in De Kafka à Kafka, Gallimard, Paris 1970,
p. 30.
24 Cosa rappresenta il terrorismo islamico, a tal riguardo, se non un movimento i cui artefici
rimangono spesso senza viso né nome preciso per poter precisamente meglio colpire il popolo che
attaccano? L’esigenza politica e militare della dissimulazione dell’identità all’interno della stessa
violenza rinvia proprio, qui, alla strategia e al simbolismo compiuto di un combattente che rifiuta
ogni rivelazione e la propria intera figura.
25 Una simile prospettiva filosofica costituisce una profonda contraddizione del manicheismo
apparso agli Stati Uniti nel discorso politico ufficiale dopo gli attentati dell’11 Settembre. Questo, in
effetti, conduce ad una negazione da parte dell’America della sua responsabilità nella crescita globale del terrorismo islamico, soprattutto se si considera la storia delle relazioni tra il governo americano ed il mondo arabo, e più precisamente la storia dei rapporti dell’America nei confronti del
problema palestinese e della rispettiva politica di Israele. In questo specifico caso l’ostinato rifiuto
a considerare le ambiguità politiche di questa situazione non può che portare a dei conflitti ancora più micidiali e ad un incremento della distanza psicologica che separa oggi l’America dalle
masse arabe e musulmane.
11
39
IL RITORNO DI DIONISO
A proposito di un libro di P. Pellegrino
di Pierpaolo De Giorgi
40
La sorprendente fortuna della figura di Dioniso nella storia della civiltà occidentale, impensabile nelle sue proporzioni e caratteristiche per altre divinità
pagane, si trova a costituire un problema culturale di notevole spessore e interesse, comune a molte discipline. Nella storia delle idee, quando le indagini
sulle origini del nostro attuale modo di essere e di pensare lasciano l’epidermide per scavare in profondità, non di rado la vertiginosa figura del dio dell’ebbrezza dapprima balugina, poi s’afferma con decisione. Un parfum entetant di
alterità sembra insinuarsi proprio là dove la ragione causale e ordinatrice ha
appena finito di tracciare le sue sobrie e geometriche linee ermeneutiche. Allo
stesso modo la trance, come stato modificato di coscienza, erompe da quei
luoghi fisici e mentali dove si è maggiormente diffusa una calma improduttiva
e terrificante: un tumultuoso mondo della vita, che in parte ricorda quello di
Husserl, e che Dioniso da sempre incarna sic et simpliciter, preme per uscire.
A compiere un’ampia e aggiornata ricognizione entro questo fertile terreno
di ricerca, a fornire risposte ben ponderate e a porre nuovi quesiti, è l’estetologo Paolo Pellegrino, cui non sfugge la pregnanza tutta contemporanea di Dioniso. Tanto che il suo recente e agile volume Il ritorno di Dioniso: il dio dell’ebbrezza nella storia della civiltà occidentale1 si pone già come una pietra miliare sull’argomento. Con un excursus filologico e filosofico ineccepibile, Pellegrino utilizza un approccio storico, di ben estesa portata, che si avvale delle
nuove prospettive di riflessione sul mito, soffermandosi in particolare sulla
Mythosdebatte europea guidata da H. Blumenberg, del quale occorre qui ricordare almeno il volume Elaborazione del mito, tradotto in Italia nel 19912. L’estetologo prende le mosse dalle proprie precedenti ricerche sulle varie interpretazioni, sulle funzioni e sul lavoro del mito, culminate nella raccolta di saggi da
lui stesso curata Mito e tarantismo 3. Egli ritiene urgente e necessario mettere
a nudo le radici mitiche e mitologiche del mondo in cui viviamo, che si mescolano continuamente con i tentativi di decodifica della realtà elaborati dalla
ragione argomentativa e strumentale. Nel viluppo di tali radici si fa notare, riaffiorando soprattutto nei momenti di crisi della ragione, il mitologema di Dioniso, cioè un’insieme di tradizioni mitiche in grado di creare e di alimentare la
celeberrima tragedia greca, di riapparire nel Rinascimento, di essere presenti
in forma palese o sotterranea in numerosi periodi storici, e quasi di dilagare in
epoca romantica. Fino a riaffacciarsi decisamente nel nostro tempo, facendosi protagonista di un tentativo di vero e proprio reincanto dell’ormai troppo
secolarizzato e disincantato mondo contemporaneo. Ripercorrendo le tracce
del quasi periodico riaffacciarsi di questo mito mediterraneo legato all’ebbrez-
NOTE
za, al vino e alle sue tradizioni, e tastando il polso al rinnovato interesse degli
studiosi, Pellegrino elabora una storia coerente e organica, sanando una vera
e propria carenza del settore.
Perché Dioniso? Va rimarcato che questa figura divina è una metafora della
natura e delle sue caratteristiche estreme. La risorgenza di un mito siffatto deriva dal bisogno umano, quasi primario, di esprimere le qualità onnicomprensive
e paradossali della natura stessa. Più di altre divinità, Dioniso “totipotente” penetra in rerum natura inglobando e metabolizzando la morte e la vita, il negativo e
il positivo, cioè la doppiezza o meglio la dualità del cosmo. Più esattamente, egli
accoglie in sé l’armonica compresenza unitaria di tale dualità opposta e complementare, per poter poi riaffermare con decisione il valore della vita. Non a caso,
Pellegrino mette in rilievo che Dioniso, dio considerato «il dominatore del
mondo», è in grado di «incarnare e far valere –là dove altri culti e altri miti separavano e condannavano– la geniale intuizione che traspare in un aforisma di Eraclito», l’armonia tra opposte tensioni, ritenuta fondamento del mondo 4.
Per ciò che concerne il mito in generale, l’autore ricorda che quest’ultimo,
sostenuto da un’esigenza cosciente, torna a svettare già nell’età di Goethe
come supporto teorico di una neue Mythologie e, attorno al 1797, nel cosiddetto Systemprogramm di Hegel, Hölderlin e Shelling5. Il Systemprogramm, in
dettaglio, si configura come il proclama etico, influenzato dalla rivoluzione francese, di una nuova “religione sensibile” e di una nuova politica, e come un progetto orientato da un idealismo nel quale la bellezza e la ragione riescano ad
incontrarsi nell’estetica e nella poesia6. In questo denso periodo storico, ci
ricorda Pellegrino, è la cultura tedesca a veicolare, exceptis excipiendis, sia il
mito in generale che la ricomparsa epocale della figura di Dioniso, evento che
nei versi del sommo poeta Hölderlin riveste un’“eccezionale importanza” per il
nostro discorso7.
Nel romanticismo, in aggiunta, se Schlegel nei primissimi anni dell’Ottocento, allo scopo di conciliare intelletto e sensibilità, postula deliberatamente la
necessità ontologica della poesia (del «bel disordine della fantasia») e della
mitologia come «reagente utopico del Moderno»8, ecco farsi strada entro queste posizioni la consapevolezza che gli antichi dèi possiedono una natura puramente metaforica. Utilmente Pellegrino mette l’accento sull’idea di Schlegel
che una nuova mitologia possa e debba sorgere, allora, con tali valenze metaforiche, come un’operazione trascendentale, come un «pensare sé»9. La struttura semantica del discorso romantico si pone, pertanto, come un fatto estetico, ricco di poesia, di pensiero trascendentale metaforico e di mitologia. E
l’estetica viene riconosciuta come la sede del mito, anche perché quest’ultimo
appare «intimamente connesso alla produzione letteraria e infinitamente riproducibile anche nel Moderno»10. Come si può dedurre, si compie in questo
periodo un notevolissimo passo in avanti nella rivalutazione del mito.
È in questo clima che Hölderlin fa sì che l’antico trovi una via di penetrazione nell’attuale, teorizzando con forza il primato della mitologia. All’interno di
tale primato culturale spunta la rilevanza gnoseologica del tragico e di figure
come quelle di Dioniso e di Cristo, che al tragico appartengono totalmente.
Puntualmente Pellegrino ricorda che, per Hölderlin, Dioniso e Cristo condivido-
41
42
no un destino di morte e resurrezione e, per questo, si pongono come straordinari paradigmi della condizione umana11. È lo stato di natura, incarnato sia
da Dioniso che da Cristo, che, nella poesia di Hölderlin si mostra nella sua
nuda verità. La saggezza tragica consiste nel fatto che l’Uno-tutto, pur essendo forte e totale, si manifesta nella debolezza, nel particolare, nella morte dell’individuo. Gli eroi tragici esprimono così la natura annientandosi. Hölderlin
usa il topos, di ascendenza schilleriana, del mondo ormai abbandonato dagli
dei e considera la modernità come una lunga e difficile notte cui, però, dovrà
succedere un nuovo giorno12. Gli dei, infatti, nonostante siano fuggiti hanno
lasciato all’uomo l’arte, il pane e il vino a garanzia del loro ritorno. Nella celebre lirica Pane e vino, il poeta tedesco canta qualche simbolico spiraglio di
luce: il pane, frutto della terra, e il vino, dispensatore di gioia13. Ma, nel suo delirio doloroso e visionario, egli ritiene che Cristo, come Dioniso, debba morire
per redimere gli oppressi e alla fine tornare al Padre, lasciando il cielo vuoto.
Il dio che verrà è, invece, Dioniso. È forse anche questa assenza, ritenuta
insopportabile, ad accompagnare il destino personale del poeta verso la follia.
Nonostante tutto, Hölderlin aderisce ad una concezione ciclica della storia, ed
è comunque certo che, al tempo giusto, gli dèi torneranno, finendo con l’influenzare fortemente filosofi del calibro di Heidegger.
Orbene, sulla scorta del pensiero degli autori che precedono l’epoca in cui
viviamo, dopo la novecentesca crisi della ragione, e per il fatto di avvertire l’inesausto meccanismo ciclico di avvicendamento della natura, anche oggi ci
accorgiamo sempre più che il pensiero mitico, con le sue metamorfosi e con le
sue oscillazioni, è una risposta per nulla trascurabile alle domande che la vita
ci pone dinanzi. Siamo in presenza di una elaborazione culturale certamente
simbolica e immaginifica, e lontana dalla forma euclidea e argomentativa della
razionalità, ma ugualmente dotata di una capacità gnoseologica importante e
funzionale. Tanto che, nel conflitto delle interpretazioni contemporanee sull’argomento, sottolinea Pellegrino, esemplare è la posizione di Horkheimer e
Adorno, per i quali non si può negare che il sapere umano sia un «intrico di
mito e illuminismo»14. È molto utile, poi, riconoscere che «tra il passato mitico
e il presente razionale non interviene un salto drastico, ma si compie una specie di Aufhebung hegeliana di superamento e di integrazione, di contaminazione e di libera convivenza, sicché diventa arduo precisare le idee di antico e di
moderno»15, sostiene Pellegrino. Pertanto, non solo possiamo considerare il
mito come una forma di razionalità, ma possiamo giungere a comprendere il
logos stesso come una forma eterna che traspare, così di sovente, dalle remote e dinamiche raffigurazioni del mito. Non meraviglia, allora, che i miti greci
siano un patrimonio inestimabile, costantemente presente nella letteratura
occidentale e dotato di funzioni destinate a perdurare nel tempo.
È in quest’ottica che la serrata riflessione di taglio storico, filosofico ed estetico di Paolo Pellegrino giunge a rimarcare la presenza ineliminabile di Dioniso in
vasti strati della nostra cultura, e a spiegare l’apologia che di questo dio costruisce Nietzsche. L’exploit ottocentesco de La nascita della tragedia di Nietzsche si
basa sulla ripresa di un pensiero mitico e oracolare, all’interno del quale Dioniso,
assieme ad Apollo, è figura centrale16. La nascita della tragedia, com’è noto, ruota
NOTE
interamente intorno all’idea che l’arte e il pensiero dell’Ellade siano imperniati su
una radice duplice e complementare: lo spirito apollineo e quello dionisiaco,
entrambi compresenti e in continua alternanza nelle diverse manifestazioni storiche. Senza dimenticare che la vita, per Nietzsche, che subisce l’influenza di Schopenhauer, è volontà di potenza, è desiderio di manifestare e aumentare tale
potenza e, per questo, rimette in discussione ogni posizione dominante. Siffatta
volontà di potenza, nota infatti Pellegrino, si incarna «in una figura del desiderio
affermativo e traboccante, quella di Dioniso»17, producendo incontinenza delle
passioni, trasgressione, estasi ed ebbrezza. Apollo interviene a ristabilire il sogno
dopo le estreme sensazioni dell’ebbrezza, ma è soprattutto Dioniso ad esprimere
l’eterno ritorno ciclico della vita, ossia della volontà di potenza. Per Nietzsche, Dioniso è il dio sempre rinascente che, mediante la consapevolezza del ritorno ciclico, toglie all’uomo la paura della morte e restituisce all’istante la dimensione dell’eternità18. Per contro, la speculazione del filosofo tedesco giunge, com’è risaputo, a teorizzare la morte di Dio, negando in sostanza valore di verità a Cristo.
Eppure, secondo Pellegrino, proprio la sostituzione dialettica e la rivalutazione del
dio dell’ebbrezza, cioè di un altro dio che muore e che ugualmente porta sulle
spalle il destino dell’umanità, palesa, nell’opposizione, la prossimità analogica tra
le due divinità, come già per Hölderlin e per Schelling19.
Con il volume Il ritorno di Dioniso, la vicenda sempre risorgente di questo
mito nella storia della civiltà occidentale trova un compendio sistematico, che
rende conto non solo del lato culto della riproposizione, ma anche della sua
presenza all’interno della tradizione popolare. Se la vicenda culta si specchia
nel modello intellettuale offerto da Nietzsche e dal romanticismo, quella tradizionale e popolare trova il suo cardine nel fenomeno del tarantismo. Così lo
studio di Pellegrino, mirato a svelare la figura di Dioniso nella sua molteplicità
di significati, possiede quel coraggio raro che consente uno sguardo d’insieme
davvero completo e soddisfacente. Nella rete di nessi e di significati che balzano evidenti dal volume, diviene più chiaro come il dionisismo, nelle sue
diverse forme storiche e soprattutto come orfismo-dionisismo, abbia potuto
manifestarsi anche nelle tradizioni popolari meridionali.
Le analisi più recenti condotte sulla cultura del tarantismo correggono per
molti versi la rotta già tracciata dall’illustre etnologo Ernesto De Martino ne La
terra del rimorso 20, ugualmente diretta verso il dionisismo magnogreco ma
incapace di comprenderne proprio la continuità storica di cui trattiamo e i simboli nella loro valenza estetica, mimetica e analogica. Le ricerche di Pellegrino, accanto a quelle di chi scrive compendiate nel volume Tarantismo e rinascita21, scoprono la pregnanza e la presenza sotterranea ma ininterrotta del dio
dell’ebbrezza e della trance anche in questa cultura tradizionale fondata sulla
iatromusica e sulla rinascita. Per entrambi gli autori il veicolo principale è rappresentato dalla religiosità orfica della Magna Grecia, e dei territori sottoposti
alla sua influenza culturale, che nei riti musicali e nella vastissima ceramografia manifesta evidenti significati di rinascita.
Non a caso Il ritorno di Dioniso nasce all’interno del progetto di ricerca “La
memoria del tarantismo”, portato avanti dal Centro servizi educativi e culturali
della Regione Puglia di Copertino e dal Centro interdipartimentale di studi di
43
44
estetica Eidos dell’Università degli Studi di Lecce. Paolo Pellegrino da anni condivide con lo scrivente non solo la ricerca sul tarantismo, ma anche la successiva operazione di spostamento dell’indagine sul fenomeno da una prospettiva
etnologica ad una più corretta prospettiva estetica. I principali eventi rituali e terapeutici del tarantismo avvengono, infatti, all’interno, per mezzo e durante la musica e la danza. La cosiddetta pizzica pizzica, arcaica tarantella utilizzata come
terapia musicale e coreutica, è un’opera d’arte tradizionale e funzionale che contempla atteggiamenti mimetici e analogici utili a portare all’inversione i ritmi psicologici degli adepti, favorendo la guarigione. Alla fine il mito della taranta e della
musica che guarisce produce effetti reali, proprio come accadeva nelle danze e
nelle musiche dionisiache. All’interno dello stesso progetto di ricerca poc’anzi
menzionato, l’analisi dell’arte del tarantismo è argomento del recente volume
dello scrivente L’estetica della tarantella: pizzica, mito e ritmo 22, che con Il ritorno di Dioniso si trova a costituire un’endiadi.
L’analisi di Pellegrino, in particolare, mette allo scoperto alcune contraddizioni di De Martino, il quale, se per un verso delinea con forza la presenza dei culti
orgiastici e dionisiaci nel tarantismo, per altro verso ne limita la portata collocando in epoca medioevale l’origine del fenomeno, considerandolo un frutto della
miseria contadina, e isolandolo in una originale ma troppo angusta e superstiziosa “religione minore”. Secondo Pellegrino c’è una sorta di weberismo alla rovescia nella posizione di De Martino, il quale ultimo, così come Weber mette in luce
i rapporti tra capitalismo ed etica del lavoro nel protestantesimo, tende a ridurre
ingenuamente la questione meridionale alle superstizioni religiose e ai “relitti” dei
sistemi mitico-rituali che fenomeni come il tarantismo portano con sé 23. Tra le più
interessanti valutazioni critiche di Pellegrino vi è quella sul noto rapporto tra San
Paolo e l’animale-totem detto taranta, che per De Martino è un innesto forzato,
mentre per il nostro ha una sua logica storica incentrata sulla stessa figura culturale dell’Apostolo. A confortare l’inesistenza di soluzioni di continuità tra quest’ultimo e il fenomeno del tarantismo, Pellegrino analizza l’intrigante questione
delle influenze orfiche, e quindi dionisiache, sul paolinismo studiata proprio dall’ex-suocero di De Martino, Vittorio Macchioro. I saggi di Macchioro, tra i quali gli
ormai noti Zagreus: studi intorno all’orfismo e Orfismo e paolinismo, stranamente ignorati da De Martino, forniscono al contrario tutta una serie di giustificazioni
teoriche e archeologiche alla questione24. Il Cristo di Paolo, che muore e risorge,
possiede caratteri misteriosofici inconfondibilmente appartenenti all’orfismo e al
dionisismo, filosofie di rinascita che l’Apostolo ha quasi certamente conosciuto
durante la prima parte della sua vita, votata al paganesimo. D’altra parte l’archeologia contemporanea, va rilevato, e la ricerca di Macchioro, incalza l’estetologo, sempre più gettano luce sulla «presenza massiccia di religiosità misterica,
e di pratiche rituali e riti funerari, in tutto l’ambito della Magna Grecia, segnatamente in Puglia»25, e in particolare proprio qui nel Salento, dove più forti sono le
sopravvivenze della religione della taranta.
Da non sottovalutare, infine, la rilevanza che per Pellegrino possiede il
poeta egiziano Nonno di Panopoli e del suo capolavoro, il poema Dionisiache,
noto a molti ma solo di recente parzialmente tradotto in Italia26. In questo travolgente “ritorno del dio”, Nonno tratteggia elementi rituali della passione di
NOTE
Dioniso e delle sue epifanie, quali la presenza della musica che guarisce eseguita con timpani, cembali, danze notturne, spade e specchi, elementi che
incontriamo anche nel tarantismo. Ultimo grande poeta della letteratura greca,
l’egiziano Nonno testimonia la sopravvivenza fino al V secolo d.C. di un sistema soteriologico analogo a quello cristiano. L’intreccio tra dionisismo e cristianesimo è più che mai evidente in Nonno, nota Pellegrino, ed è rafforzato dalla
sua enigmatica successiva conversione alla nuova religione della salvezza27.
Orbene, come abbiamo visto, la presenza di Dioniso non è un fatto meramente intellettuale né un frutto esclusivo della grande immaginazione poetica o teoretica di Nonno, Hölderlin, di Schelling e di Nietzsche, ma un bisogno dell’animo
umano di esprimere la natura nella sua interezza ciclica e la speranza che attraverso tale ciclo, del tutto naturale, di morte e vita, malattia e salute, buio e luce,
si possa pervenire alla rinascita continua. Se tutto avviene in modo duplice e
complementare al tramonto dovrà sostituirsi necessariamente una nuova alba. A
mio parere una simile vittoria sistematica della positività, un simile trionfo della
vita, sul quale si basa la terapia musicale e coreutica del tarantismo, introduce la
speranza, perché fa sì che, attraverso la stessa via ciclica della natura, l’uomo
possa opporsi alla malattia devastante e all’annientamento definitivo.
Il lavoro Il ritorno di Dioniso: il dio dell’ebbrezza nella storia della civiltà occidentale, dettagliato e in pari tempo efficacemente sintetico, giunge opportunamente a colmare un vuoto, in un periodo in cui anche in Francia le ricerche del
sociologo e filosofo Michel Maffesoli teorizzano, già da qualche anno, il ritorno
di questo mito, palpabile in quel reincanto del mondo, oggi sotto i nostri occhi
con il riaffermarsi del mondo delle immagini, delle emozioni, degli atteggiamenti religiosi e del recupero della fantasia28. A ben guardare, nella letteratura filosofica del nostro passato più recente, ci dice Pellegrino, questo ritorno è stato
presagito anche da Giorgio Colli che, nella sua Nota introduttiva a La nascita
della tragedia di Nietzsche, già nel 1972 ha scritto che il fuoco acceso da Nietzsche, racchiuso nella duplice esaltazione dell’ebbrezza di Dioniso e del sogno
di Apollo, è pronto a divampare in un incendio29. Anche i sommovimenti socioculturali e artistici, che intorno al Sessantotto e negli anni successivi hanno interessato la civiltà occidentale, non sono estranei ad un nuovo bisogno di natura,
di mito, di emozioni, di apertura della sensibilità e di soddisfazione estetica.
Possiamo compiendiarli nell’affermazione che fa Marcuse in un Frammento
dagli appunti su À la recherche du temps perdu di Proust inserito nel saggio
Che l’intollerabile esploda: inediti di Herbet Marcuse su arte e rivoluzione:
«Quando la conoscenza viene posseduta dal piacere, essa si trasforma in una
critica della normalità»30. L’estetica può offrire chiavi e strumenti davvero efficaci al pensiero contemporaneo. Una nuova sensibilità, ci ricorda Pellegrino, è
proprio ciò che porta alla riscoperta e alla valorizzazione del mondo di Dioniso,
e della forza vitale che questi reca con sé 31. Per altro verso, le tante forme di
stravolgimento, anche irrazionale, della sobrietà quotidiana e del principium
individuationis, come accade ad esempio nel triste fenomeno della droga, vengono esaminate come aspetti del nostro tempo da Elémire Zolla nella sua antologia dei moderni dionisiaci Il dio dell’ebbrezza 32. C’è, in definitiva, un bisogno
di Dioniso nella postmodernità, quello stesso che Michel Maffesoli descrive nel
45
saggio L’ombre de Dionysos: contribution á une sociologie de l’orgie 33. Vengono così recuperati, in una sempre più diffusa ibridazione di passato e presente,
l’aspetto incantato della realtà e la necessità di affrontare coraggiosamente
l’ineliminabile presenza del tragico nella nostra vita.
46
1 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso. Il dio dell’ebbrezza nella storia della civiltà occidentale,
Congedo, Galatina 2003.
2 H. BLUMENBERG, Elaborazione del mito, trad. it. di B. Argenton, Il Mulino, Bologna 1991.
3 AA.VV., Mito e tarantismo, a cura di P. Pellegrino, Pensa MultiMedia, Lecce 2001.
4 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 55.
5 Il più antico programma sistematico dell’idealismo tedesco, in F. HÖLDERLIN, Scritti di estetica, a cura di R. Ruschi, Mondadori, Milano 1996.
6 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 64.
7 Ivi, p. 68.
8 Ivi, p. 66.
9 Ivi, p. 67.
10 Ivi, p. 68.
11 Ivi, p. 69.
12 Ivi, p. 74.
13 F. HÖLDERLIN, Pane e vino, in ID., Poesie, saggio intr. e cura di G. Vigolo, Einaudi, Torino
1963, p. 146.
14 Cfr. J. HABERMAS, L’intrico di mito e illuminismo. Osservazioni sulla Dialettica dell’illuminismo
–dopo una rilettura, trad. it. di G. Pirola e A. Ponsetto, in ID., Dialettica della razionalizzazione, a
cura di E. Agazzi, Unicopli, Milano 1983.
15 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 47.
16 F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia, trad. it. di S. Giametta, Adelphi, Milano 1972, p. XI.
17 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 98.
18 Ivi, p. 103.
19 Ivi, p. 105.
20 E. DE MARTINO, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore,
Milano 1961.
21 P. DE GIORGI, Tarantismo e rinascita, saggio intr. di P. Pellegrino, Argo, Lecce 1999.
22 P. DE GIORGI, L’estetica della tarantella: pizzica, mito e ritmo, Congedo, Galatina 2004.
23 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 113; M. WEBER, L’etica protestante e lo spirito del
capitalismo (1904), trad. it. di A.M. Marietti, Introd. di G. Galli, Rizzoli, Milano 1991.
24 V. MACCHIORO, Zagreus. Studi intorno all’orfismo, Laterza, Bari 1920; V. MACCHIORO, Orfismo
e paolinismo. Studi e polemiche, Casa editrice cultura moderna, Montevarchi 1922.
25 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 148.
26 NONNO, Dionisiache, a cura di D. Del Corno, trad. it. di M. Maletta, note di F. Tissoni, voll. I
e II, Adelphi 1999.
27 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 150.
28 M. MAFFESOLI, L’ombre de Dionysos: contribution à une sociologie de l’orgie, Le Livre de
Poche, Paris 1991 (I ed. 1982), trad. it. di E. Scarpellini, L’ombra di Dioniso, presentazione di F.
Alberoni, Garzanti, Milano 1990.
29 G. COLLI, Nota introduttiva a F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia, cit., p. XI.
30 H. MARCUSE, Frammento dagli appunti su À la recherche du temps perdu di Proust (1950),
in Che l’intollerabile esploda. Inediti di Herbert Marcuse su arte e rivoluzione (1945-1979), a cura
di G. Baratta e R. Casale, ne “L’Indice”, a. XVI (1999), n. 11, p. III.
31 P. PELLEGRINO, Il ritorno di Dioniso, cit., p. 98.
32 E. ZOLLA, Il dio dell’ebbrezza. Antologia dei moderni dionisici, Einaudi, Torino 1998.
33 M. MAFFESOLI, l’ombra di Dionisio, cit.
DELEUZE LETTORE DI SPINOZA
«Spinoza: è il filosofo assoluto, e l’Etica è il grande libro del concetto. Ma il
filosofo più puro è al tempo stesso quello che s’indirizza rigorosamente a tutti:
chiunque può leggere l’Etica, se si lascia trasportare a sufficienza da quel
vento, quel fuoco»1. Con queste parole, nel 1988, Gilles Deleuze ritornava su
uno dei suoi autori prediletti2. Il richiamo alla destinazione non filosofica della
filosofia, contro l’opposta consuetudine di una non filosofia per filosofi, è un
grande tema deleuziano, che trova nel pensatore olandese un precursore illustre. Spinoza, il razionalista più puro della storia del pensiero, l’autore di uno
degli edifici concettuali più imponenti della modernità, è anche il filosofo dei
non filosofi, il catalizzatore di aspettative e desideri che superano ogni confine
disciplinare.
Il fatto è che l’argomento e il fuoco dello spinozismo sono la vita stessa.
Deleuze trova in Spinoza, nei pensieri del filosofo come nel corpo magro e sofferente dell’uomo, addirittura «una potenza identica alla Vita»3. Minato dalla
malattia, esposto alla fortuna, Spinoza non nega certo la morte: nega piuttosto
il culto o la passione della morte, l’idea che sia lei a dare senso alla vita e argomento al pensiero. La morte non è interessante: è quest’autentica eresia filosofica che nutre sia Spinoza che il suo interprete francese. Entrambi tentano
l’impresa, impopolare e desueta, di togliere alla morte ogni fascino e ogni significato, per fare della vita l’oggetto esclusivo della filosofia.
Non si parlerà, con ciò, di «vitalismo». Per Deleuze, la vita non è un principio o una sostanza, e ancor meno lo è per Spinoza. L’etica spinoziana, anzi,
neppure riconosce al vivente uno statuto ontologico peculiare4. Il concetto di
vita che Deleuze isola in Spinoza non è e non può essere biologico; come
caratterizzarlo allora? Se non è una causa, in quanto non le compete una categoria propria, la vita è almeno un effetto. A partire da un’ontologia pura, concernente Dio e gli attributi, Spinoza approda senza soluzione di continuità a
quel campo di effetti che è la vita del modo finito, intesa come ambito in cui si
delineano le relazioni e si producono gli incontri tra gli individui.
Ci si potrebbe domandare perché parlare qui di vita, anziché –ciò che eluderebbe in anticipo ogni possibile equivoco– semplicemente di «esistenza». Il
punto è che Deleuze riferisce all’idea di vita una connotazione intensiva che
nel concetto di esistenza manca. Vita è quel che, nell’esistente, si manifesta
della sua propria essenza; è qualcosa come la faccia espressiva o la qualità
pura dell’esistenza. «Vita» è un’espressione immediata dell’essenza. Il tema
della vita, in Deleuze, costituisce quindi il filo conduttore per una lettura propriamente ontologica dello spinozismo5.
NOTE
di Delfo Cecchi
47
Deleuze è fortemente interessato all’ontologia, e appunto un’ontologia pura
è ciò che trova in Spinoza. Per questa ragione, sebbene non priva di originalità, la lettura deleuziana non presenta alcuna esplicita finalità ermeneutica6: è
nel cristallo perfetto della dottrina, piuttosto che nel significato culturale dell’opera, che essa ricerca il senso dello spinozismo. Per Deleuze, il valore di un filosofo si trova d’altronde nei suoi concetti e non altrove. In quanto segue, cercheremo dunque di non essere infedeli al compito di un’esposizione concettuale.
«Espressione»
48
Parola-chiave del confronto di Deleuze con Spinoza, quest’idea rinvia, oltre
che all’autore dell’Etica, alla filosofia di Leibniz. A parere di Deleuze, Spinoza
e Leibniz sono i creatori di un vero e proprio «espressionismo in filosofia»7, il
quale, oltre ad attestarsi come reazione critica al cartesianismo, pone le basi
per un nuovo naturalismo filosofico. L’idea di espressione implica infatti che i
vari aspetti della realtà costituiscano le manifestazioni di una natura comune,
declinata in forme espressive omogenee. «Espressione» è quindi la forma in
cui tutto ciò che è, a monte di ogni distinzione ulteriore, immediatamente si
manifesta.
Come Deleuze ci ricorda, quando Spinoza afferma che gli attributi sono ciò
che l’intelletto coglie come costituente l’essenza della sostanza8 egli non intende dire che l’attributo «medi» la conoscenza della sostanza che appartiene
all’intelletto, bensì, tutt’al contrario, che l’attributo è la forma in cui la sostanza
si manifesta e l’intelletto immediatamente la intende così come essa è in se
stessa. Dal punto di vista dell’espressione, l’intelletto e l’intelligibile hanno la
stessa forma: la struttura di una cosa e il suo profilo in rapporto alla conoscenza sono identici. Soggetto e oggetto ricevono le loro determinazioni dal sistema comune dell’espressione, dal quale non possono essere separati.
Sviluppandosi da questi presupposti, che implicano l’identità tra il piano dell’essere e il piano dell’espressione, l’«espressionismo filosofico» si presenta
indubbiamente come una conoscenza di stampo metafisico; nel contesto spinoziano in cui Deleuze si muove, non avrebbe d’altronde alcun senso andare
alla ricerca di atteggiamenti antimetafisici. Nella breve ricostruzione della storia del concetto di espressione che ci propone9, Deleuze mira piuttosto a indicare dei percorsi incompleti verso l’espressionismo (e dunque verso un saldo
razionalismo). L’analisi di alcuni momenti cardinali della filosofia occidentale
mostra come quest’ultima abbia prodotto, prima di Spinoza, un razionalismo
solo parziale10, finalizzato all’edificazione di un ideale trascendente della razionalità piuttosto che all’elaborazione delle strutture di una ragione immanente.
In questa prospettiva, il sistema della ragione si presenta inoltre come corredato di un prospetto assiologico e finalistico che, nello spinozismo, è del tutto
assente.
L’espressionismo filosofico è dunque una metafisica, ma una metafisica
dell’immanenza. Ciò impone che la ragione sia un vero e proprio occhio interno all’essere, e che viceversa la realtà sia intelligibile fin nei suoi più intimi
NOTE
recessi. Spinoza non pretende certo di conoscere le cause di ogni evento11:
suo interesse è semmai mostrare che le condizioni della produzione di qualcosa devono coincidere con le relative condizioni di conoscibilità; pensiero e produzione sono, in natura, omogenei e paralleli. In breve, l’espressionismo filosofico è possibile solo in quanto il pensiero sia un aspetto della natura, e in
quanto l’ordine della natura sia l’oggetto immediato del pensiero12. La maniera
più radicale di intendere ciò consiste nel pensare che le forme sotto cui le cose
sono concepite siano le stesse forme entro cui sono prodotte. Perché l’espressionismo filosofico sia possibile, concetto, essenza, posizione e causalità
devono dunque uniformarsi13: la ragione per cui una cosa è, ciò per cui essa è
quel che è e la sua suscettibilità all’ordine della causazione devono cadere
sotto una stessa idea.
Questi passaggi hanno la loro radice ontologica nell’idea di una sostanza
assolutamente infinita, le cui forme essenziali costituiscono in pari tempo le
condizioni della conoscibilità delle cose e le condizioni ultime della loro produzione. Nello spinozismo, l’attributo svolge questo doppio ruolo: esso è ciò sotto
cui qualcosa è concepito, ed è anche una struttura ultima della realtà. Lo spinozismo è la filosofia che, in modo del tutto originale, riallaccia il cordone arcaico della physis: «natura» nel senso di essenza o concetto e «natura» nel
senso di pro-duzione sono un’unica cosa, natura rerum. Tale unità di significato si fonda sull’uguaglianza tra quelle che Deleuze chiama le due «metà» dell’assoluto14, la potenza del pensare e la potenza dell’esistere o agire15. È perché la sostanza soddisfa univocamente sia alla condizione della concepibilità
per sé sia alla condizione dell’autocausazione che espressione e produzione
si riflettono l’una nell’altra.
Ogni metafisica è una filosofia dell’espressione, ma non ogni metafisica è
un esempio di espressionismo filosofico, perché non ogni metafisica unifica le
potenze di pensare e di agire, l’espressione e la produzione. In Platone, come
Deleuze mostra, l’espressione compare come partecipazione o imitazione dell’Idea, ma l’Idea, il «partecipato», raggiunge il «partecipante» solo per intervento del Demiurgo, cioè in virtù di una causa esterna16. Questo significa che nella
produzione è dato qualcosa che non è contemplato nell’espressione: la potenza di agire non coincide con la potenza di pensare. Per parte sua, il neoplatonismo fonda la metoché «nel partecipato come tale»17, che diviene però un
principio: anziché causa prossima e idea matrice, l’Uno di Plotino è causa
prima e origine ineffabile.
Il concetto di espressione ha una lunga storia, ma questa storia è anche un
travisamento, che impedisce la fondazione dell’espressionismo in filosofia.
Esso rimane un ideale in seno alla tradizione platonica, e diviene addirittura
un’icona18 nel creazionismo giudaico-cristiano, ove la «cultura dell’inesprimibile» rappresentata dalla Rivelazione e la «conoscenza confusa e relativa» offerta dalla profezia19 si sostituiscono alla chiarezza delle ragioni. La nuova veste
della filosofia dell’espressione dev’essere dunque quella di un razionalismo
conseguente.
Resta il problema di come articolare questo razionalismo. Quello che si
potrebbe ormai chiamare il principio dell’espressione richiede che la ragione di
49
una cosa e il suo essere siano tutt’uno. Sappiamo quindi che l’espressione
deve poter assegnare tutte e sole le ragioni per cui qualcosa è, ma non sappiamo ancora come determinare queste ragioni: non conosciamo cioè la sintassi dell’espressione.
Logica dell’assoluto
50
Deleuze osserva che il razionalismo di Spinoza sostituisce al tema dell’infinito il punto di vista dell’assoluto20. Questo mutamento di prospettiva implica un
nuovo concetto di Dio e un argomento inedito a dimostrazione della sua esistenza21. A parere di Deleuze, tale argomento è solo formalmente debitore
verso le prove ontologiche tradizionali. La prospettiva dell’Etica (a differenza di
quella del Breve trattato22) è espressionistica: non si tratta di prendere le
mosse da ciò che noi concepiamo (o crediamo di concepire) sotto il concetto
di Dio, per dimostrare che quel qualcosa esiste; si tratta bensì di costruire il
contenuto dell’idea di Dio secondo strutture comuni al pensiero esprimente e
all’oggetto espresso, in maniera tale che l’esistenza di quest’ultimo risulti innegabile. L’idea di Dio nella mente dimostra l’esistenza di Dio solo se ciò che la
mente pensa quando concepisce Dio è l’essenza reale di Dio, e non un insieme di proprietà come l’infinità o la perfezione, le quali potrebbero anche non
costituire i predicati di alcun ente. Si tratta di mostrare che ciò che noi pensiamo sotto il concetto di Dio è un’essenza reale, la quale designa dunque la
struttura di un ente esistente e non solo i propria di un ente postulato23.
La prima dimostrazione spinoziana dell’esistenza di Dio consiste in sintesi
nel mostrare che, l’essenza di Dio non potendo essere espressa se non da infiniti attributi24, e costituendo questi ultimi l’essenza della sostanza (alla quale
appartiene di esistere25), Dio ha l’essere della sostanza, e dunque necessariamente esiste26. L’esistenza di Dio non è desunta dal fatto che esso è l’ente perfettissimo, ma viceversa dal fatto che le perfezioni riferite a Dio costituiscono
non soltanto le proprietà di un ente assolutamente infinito, ma anche le strutture stesse della realtà27. In assenza di questo passaggio, resta del tutto impredicato se un ente infinito sia possibile, perché definire Dio in funzione di una
natura perfetta o infinita non dimostra affatto che una tale natura non sia contraddittoria28.
È interessante osservare, sulla scorta di Deleuze, il procedimento di Spinoza. L’identità tra i termini «Deus», «ens absolute infinitum» e «substantia constans infinitis attributis» è, in partenza, perfettamente nominale; a partire da
questa convenzione terminologica si giunge tuttavia a dimostrare che la definizione di Dio è reale. Gli infiniti attributi che (da tutta prima e in maniera perfettamente teologica) eravamo disposti ad accordare a Dio si rivelano essere i
costituenti reali di una sostanza attualmente esistente. Dietro l’apparenza di
una concezione teologica, scopriamo un’ontologia pura, in cui si fa questione
delle strutture comuni all’intera realtà e non delle proprietà di un ente superessenziale. Dio non è un oggetto trascendente, bensì è l’unità immanente delle
nature esistenti: Dio è la totalità delle forme dell’essere.
NOTE
Qual è il rapporto tra assoluto e infinito in questa nuova logica? Il punto di
vista dell’assoluto richiede di pensare che ogni forma della natura sia infinita,
cioè che l’infinito sia la proprietà espressa dall’assoluto. L’infinito è il modo in
cui l’assoluto si esprime, cioè è l’elemento ultimo dell’espressione. «Una certa
essenza eterna ed infinita, un’essenza corrispondente al genere dell’attributo»29 è quanto è espresso da una forma della natura. Ciò che l’intelletto intende come costituente l’essenza della sostanza è una «qualità illimitata»30. Si
tratta del terzo asserto della prima «triade della sostanza», secondo la dicitura impiegata da Deleuze nel suo libro spinoziano più importante: «La sostanza si esprime, gli attributi sono espressioni, l’essenza è espressa»31. La condizione prima dell’espressione è l’infinito, perché l’infinito è la qualità elementare della natura. Nulla che sia meno che infinito è necessariamente espresso,
ovvero nulla che non sia infinito deve essere colto dall’intelletto come costituente la sostanza. L’infinità è la quantità propria della pura qualità, ossia la
quantità che deve essere attribuita a tutto ciò che si presenta come forma ultima della natura.
L’infinito è l’elemento dell’assoluto. Esso è la forma sotto cui un’essenza è
conoscibile: nel caso di una cosa qualunque, qualche natura infinita è ciò attraverso cui essa è conosciuta; nel caso della conoscenza di Dio, la totalità delle
nature infinite è anche ciò che costituisce l’essenza dell’oggetto conosciuto.
Una cosa finita non ha per essenza una natura infinita, ma anch’essa si esplica
attraverso qualche natura infinita. L’essenza di un ente qualunque non è costituita di attributi, ma gli attributi sono ciò senza di cui la sua essenza non potrebbe essere costituita. «Essere» vale espressione tanto per Dio quanto per una
cosa finita, perché essere significa: implicazione di qualche natura infinita. Nel
linguaggio di Deleuze: «essere, significa esprimersi, o esprimere, o essere
espressi»32; l’espressione si chiarisce ora come implicazione dell’infinito.
La differenza tra Dio e l’ente finito consiste in ciò, che quest’ultimo non ha
quale essenza la natura che implica, mentre Dio sì. Tra Dio e i modi si tratta di
una distinzione concernente non le nature, dal momento che le nature sono
univoche, ma ciò che l’essenza significa in rapporto alle nature implicate. Questa più sofisticata distinzione conduce lo Spinoza di Deleuze più lontano che
mai dalla teologia, senza però condannarlo a un monismo indifferenziato. Gli
attributi costituiscono le «forme comuni» della realtà, le «forme di essere
comuni alle creature e a Dio, comuni ai modi e alla sostanza»33, cioè le nature
attraverso le quali ogni cosa, finita o infinita, si esplica34. Per Deleuze, laddove
la tradizione giudaico-cristiana tende spontaneamente all’analogia entis, Spinoza tiene ben ferma l’univocità dell’ente35.
La prospettiva dell’assoluto implica dunque, in sintesi, che l’infinito sia il carattere delle nature che costituiscono l’essenza della sostanza: Dio non è solo infinito, ma assolutamente infinito. Tuttavia, in quanto ogni attributo costituisce una
natura di sostanza e una sostanza non è se non ciò che è conosciuto attraverso
la sua natura, di ogni natura sembra doversi dare una sostanza, cioè sembra
necessario che esistano tante sostanze quanti attributi. Si tratta della dottrina
delle prime proposizioni de Deo. Esse definiscono, secondo Deleuze, una nuova
logica della distinzione reale, che è il caso di ricostruire in dettaglio.
51
Espressione e distinzione
52
Cartesio afferma che la distinzione reale, la quale si dà «soltanto fra due o
più sostanze», è riconoscibile «da ciò solo, che possiamo intendere chiaramente e distintamente l’una senza l’altra»36, cioè cogliere i loro «attributi principali» come reciprocamente escludentisi. La distinzione reale nonpertanto è
una distinzione formale, la quale «basta per fare che una cosa sia concepita
separatamente e distintamente da un’altra, per mezzo di un’astrazione dello
spirito che concepisca la cosa imperfettamente, ma non per fare che due cose
siano concepite talmente distinte e separate l’una dall’altra, che noi intendiamo che ognuna è un essere completo e differente da ogni altro»37.
A tal fine, occorre una distinzione numerica: per Cartesio, «esistono distinzioni numeriche che sono allo stesso tempo reali o sostanziali»38, cioè la distinzione reale è «accompagnata da una divisione delle cose»39. Questa concezione salva i fenomeni, ma non ci consente di determinare a priori una sostanza, e quindi non dà ragione della molteplicità numerica degli esemplari. Che la
sostanza non sia integralmente determinata in ragione della propria natura
costituisce, in prospettiva spinoziana, una patente contraddizione al principio
dell’espressione.
Non a caso, Spinoza nega che la distinzione numerica sia reale. Due sono,
al riguardo, gli argomenti dell’Etica isolati da Deleuze. Il primo40 mostra che la
distinzione numerica non è reale perché è impossibile una distinzione reale
che sia sottodeterminata rispetto alla natura di una cosa, in quanto si tratterebbe di una distinzione inintelligibile. Poiché due cose possono distinguersi o per
differenza di attributi o per differenza di affezioni41, e poiché le sostanze devono distinguersi secondo ciò che costituisce la loro natura ossia secondo gli
attributi, esse non possono essere distinte che così, cioè in particolare non può
darsene più d’una per attributo42. Una distinzione reale è quindi di necessità
(contro Cartesio) una distinzione formale; non sappiamo però ancora se una
distinzione formale sia una distinzione reale. Per saperlo, dovremmo anche
sapere che alla natura della sostanza appartiene di esistere.
Il secondo argomento43 presuppone come nota questa conoscenza. Si sa
che a essere espressa in una vera definizione è la sola natura della cosa, per
cui nessuna definizione autentica dà a concepire «un certo numero di individui»: il numero non rientra mai nel concetto. Se una cosa che sia concepita
per sé anche esiste per sé, essa esiste in virtù del proprio concetto, cioè non
soltanto nulla che sia estraneo a questo compete alla sua natura, ma in più
nulla di estraneo al concetto potrà essere affermato della cosa. Poiché una
sostanza esiste per sé, essa esiste in ragione del proprio concetto; quindi,
nessuna sostanza esiste in un certo numero, ma ve n’è soltanto una per ogni
natura. La distinzione formale è una distinzione reale: esistono attualmente
tante sostanze quante forme, cioè di ogni attributo vi è una e una sola
sostanza.
«Ora, a partire dalla proposizione 9, sembra che Spinoza cambi prospettiva. Non si tratta più di dimostrare che esiste una sola sostanza per attributo,
ma che esiste una sola sostanza per tutti gli attributi»44. Il principio è che, se la
NOTE
distinzione numerica non è mai reale, «reciprocamente, la distinzione reale
non è mai numerica»45. Poiché nessuna distinzione numerica è reale, una
distinzione reale può solo essere formale. Viceversa, la distinzione formale è
reale, perché, la sostanza esistendo per natura, le diverse forme sostanziali
danno realmente luogo a una pluralità di sostanze. Allora, però, al di sotto delle
nature sostanziali c’è una moltitudine di sostanze quanto a sé inconoscibili: se
ciascuna è tale in virtù di una natura (e quindi di una ragione) diversa, il termine «sostanza» è equivoco, cioè le cose distinte dalle nature sostanziali sono
solo gli esemplari di un genere comune46.
Perché così non sia, la distinzione formale deve, pur restando reale, implicare l’unicità della sostanza. Posto che la distinzione reale non può essere che
formale, la distinzione formale deve assumere il valore, che Deleuze trae da
Duns Scoto47, di una «apprensione di quiddità distinte appartenenti però ad
uno stesso soggetto»48. La distinzione reale distingue ancora le sostanze, ma,
essendo formale, non può distinguerle altrimenti che distinguendo le forme
della sostanza, le nature-di-sostanza o qualità sostanziali49. La distinzione
reale distingue le sostanze nel senso che distingue tra ciò che è dell’ordine
della sostanza (l’attributo) e ciò che non lo è (il modo). Deleuze interpreta l’oggetto della distinzione reale, l’attributo, non come esistente da sé, ma soltanto
come ciò che «si concepisce per sé e in sé»50. Esiste dunque «una sostanza
per attributo dal punto di vista della qualità, ma esiste un’unica sostanza per
tutti gli attributi dal punto di vista della quantità»51. Esistono infinite nature
sostanziali realmente distinte, le quali costituirebbero altrettante sostanze se
ciò non implicasse la costitutiva indeterminazione imposta dalla diversificazione numerica. L’unica interpretazione possibile della distinzione reale-formale è
pertanto quella che impone l’unicità della sostanza.
Il carattere formale della distinzione reale mostra la profondità del razionalismo spinoziano. Spinoza intende perfettamente che, se la sostanza dev’essere integralmente conoscibile, è impossibile che le appartengano sia un
aspetto numerico, sia la forma classica del sostrato. Le due evenienze sono
connesse: se la sostanza fosse un sostrato, l’essenza non la costituirebbe
realmente; ossia, il concetto di espressione non la esaurirebbe. Il principio dell’espressione impone al contrario la completa identità tra la ragione e l’essere:
nessuna determinazione di una cosa può sfuggire alla ragione per cui essa è
una cosa.
La sostanza non è dunque un subiectum, e gli attributi non sono le sue differenze specifiche. L’attributo è un «attributore» piuttosto che un «attribuito»52:
è ciò che attribuisce un’essenza, dice Deleuze, «a qualcos’altro»53. I primi due
asserti della prima triade della sostanza sono dunque i seguenti: la sostanza
si esprime, gli attributi sono espressioni. L’ordine degli asserti, così come
Deleuze lo propone, considera la sostanza non dal punto di vista genetico della
sua costruzione, ma dal punto di vista ontologico della sua composizione. Il
terzo asserto, da noi già esaminato, ci mostra in che debba consistere un’essenza sostanziale; con la dimostrazione dell’esistenza di Dio, tutti gli attributi si
qualificano come espressioni dell’unica sostanza esistente. Poiché la distinzione numerica non è reale, l’essenza è una forma distinta, ossia è un’espressio-
53
ne autonoma; poiché la distinzione reale non è numerica, ogni espressione è
autonomamente riferita a un solo oggetto. Porre l’attributo come espressione
significa in ultimo affermare che l’espressione non è un segno, cioè che l’essenza non è un proprio. In questa duplice affermazione si riassume la distanza di Spinoza dalla teologia54.
La prima triade della sostanza contiene tutti gli elementi per intendere la
triade successiva55, che ne costituisce un approfondimento dal punto di vista
della quantità. Come Deleuze osserva, «l’espressione non concerne la sostanza o l’attributo in generale in condizioni indeterminate; quando la sostanza è
assolutamente infinita, quando possiede infiniti attributi, allora, e solo allora, gli
attributi esprimono l’essenza, perché, allora, anche la sostanza si esprime
negli attributi»56. Gli attributi sono espressioni della sostanza solo perché questa è assoluta, cioè solo in quanto esistono in numero infinito: nell’assoluto,
l’unica divisione possibile è quella che dà luogo a un’infinità attuale di infiniti.
Non si tratta solo di una infinità qualitativa, ma dell’infinito come quantità correlata all’assoluto. «L’infinitamente perfetto è la modalità di ogni attributo, ovvero il “proprio” di Dio. Ma la natura di Dio consta di infiniti attributi, cioè dell’assolutamente infinito»57. L’espressione culmina così in un nuovo aspetto dell’assoluto, che dobbiamo ora esaminare.
54
La potenza
Il tema non nasce certo con Spinoza, ma Spinoza è tra i filosofi che rinnovano maggiormente il concetto di potenza. Deleuze riconosce nello spinozismo
due potenze essenziali: il pensare e l’agire. È necessario non confondere la
potenza di pensare di Dio con l’attributo pensiero, e la potenza dell’esistere o
agire con l’attributo estensione58. La potenza dell’esistere-agire, secondo
Deleuze, è infatti costituita dalla totalità degli attributi (pensiero compreso)59.
Mentre il parallelismo tra pensiero ed estensione riguarda la relazione tra idee
e corpi, il rapporto tra le potenze concerne la partecipazione di tutti gli attributi
nella costituzione di cose. Una singola cosa è, in tal senso, una modificazione
della potenza di agire che è propria di Dio, rifratta attraverso tutti gli attributi60.
Le cose sono dunque veri e propri frammenti della potenza divina. A differenza di altre filosofie dell’immanenza, lo spinozismo radica la potenza dell’essere su un fondamento reale: l’essere è potenza non per una misteriosa autopoiesi, ma perché la realtà è sostanza, e per conseguenza ogni cosa è una
parte della potenza di agire che appartiene a Dio. Altrimenti detto, l’ente è
potenza proprio perché il modello della causalità è la causa sui 61.
Dio è causa immediata di tutto ciò che è62: lungi dal negare la potenza delle
cose, proprio questa tesi la avalla63. La realtà di una cosa è in se stessa potenza,
sia nel senso che una cosa, esistendo, rivela la sua possibilità reale di essere, sia
nel senso (ontologicamente speculare) che ogni cosa manifesta una intrinseca
capacità di sussistenza e permanenza64. L’essenza non causa l’esistenza, ma
afferma la realtà della cosa, cioè implica la potenza comportata dalla sua realtà.
Le essenze delle cose esprimono la potenza in virtù di cui queste sono reali.
NOTE
L’essenza non è dunque una mera possibilità logica, ma una possibilità
reale: la sola pertinente allo spinozismo65. Essa è indifferente all’esistenza, ma
non alla realtà di una cosa, cioè alle condizioni a priori della sua esistenza. Si
danno essenze di modi attualmente inesistenti66, le quali sono nondimeno perfettamente attuali o reali. Nell’interpretazione deleuziana, le essenze non esprimono in nessun senso una contingenza67: sebbene non implichi l’esistenza,
l’essenza costituisce la configurazione espressiva o il «diagramma» di quella.
L’essenza è il lato intensivo dell’esistenza. La sua astrattezza in rapporto
all’esistenza fisica non è quella del possibile in rapporto al reale, ma quella dell’intenso in rapporto all’esteso, o dell’«implicato» in rapporto all’«esplicato».
L’essenza è la vera vita dell’ente.
A tal proposito, Deleuze focalizza una nozione spinoziana apparentemente
marginale, ma essenziale all’espressionismo: quella della «capacità affettiva»
di una cosa68. Esistere significa avere una qualche capacità di affezione, la
quale esprime immediatamente la potenza che costituisce l’essenza della cosa
esistente. La capacità affettiva è il «medio» tra essenza ed esistenza. Essa
non esprime la vita affettiva del modo nella sua dimensione estensiva, cioè
l’appartenenza dell’individuo a un mondo, bensì esprime questa stessa vita
affettiva nel suo puro lato intensivo. La potenza del modo si «schematizza» in
un certo grado di capacità affettiva, la quale costituisce dunque il risvolto implicato o espressivo di ciò che si esplica in forma estensiva nell’ambito dell’esistenza spaziotemporale.
A ogni grado di capacità affettiva corrisponde una potenza perfettamente
attuata, e in tal senso assoluta. Finita o infinita che sia, ogni cosa è perfetta,
cioè capace di tutto ciò che è in suo potere. La formulazione deleuziana di questo principio è la seguente: «Ogni potenza reca con sé una capacità [pouvoir]
di essere affetti che le corrisponde e che ne è inseparabile […] sempre e
necessariamente colmata»69. La potenza è identica alla realtà ossia alla perfezione, in un senso che, dal punto di vista di Deleuze, sembra escludere una
nozione proporzionale dell’ente: non tutte le potenze sono eguali, ma ciascuna potenza costituisce quanto a sé un valore assoluto70.
Grazie all’eguaglianza delle due potenze (l’esistere-agire e il pensare) di
Dio, la divisione dell’essere secondo la verità dell’idea e la divisione dell’essere secondo la realtà dell’essenza sono la stessa cosa. Ciò che si concepisce
per sé e ciò che è causa di sé sono unum et idem, per cui l’espressione è sempre reale e la realtà è sempre espressa. Dio, esprimendosi, non può fare a
meno di esprimere qualcosa di reale, ossia non può fare a meno di produrre,
e non può produrre se non esprimendo ciò che produce. Come vedremo, il
tema della potenza del pensare conduce a un’importante questione gnoseologica, perché, fatta salva l’uguaglianza delle potenze, Dio deve conoscere la
propria espressione per produrre, ancorché l’intelletto non appartenga alla sua
essenza71.
Entrambe le potenze sono in Dio infinite. In particolare, che la potenza divina di agire sia infinita implica che infinita sia la capacità di essere affetto che è
propria di Dio; e poiché ogni capacità d’affezione è sempre colmata, Dio è
necessariamente affetto in un numero infinito di modi. Ma, dal momento che le
55
56
sue affezioni sono solo attive, ciò significa che «Dio produce necessariamente
e attivamente infinite cose che l’affettano in un numero infinito di modi
[façons]»72. Dio è producente perché infinite affezioni devono colmare la sua
potenza infinita, e perché infinite affezioni implicano cose in numero infinito. La
ragione per cui l’universo è costituito d’infinite cose o modi è che devono darsi
in esso infinite modificazioni; e queste devono darsi affinché la potenza infinita di Dio sia assolutamente colmata73.
Di qui deriva, secondo Deleuze, un nuovo argomento a sostegno della
quantità infinita degli attributi. Se pensiero ed estensione, cioè le nature a noi
note, «non bastano ad esaurire o a colmare una potenza assoluta di esistere»74, è perché due soli attributi non sono sufficienti a dare conto dell’infinita
capacità di essere affetta che è propria della sostanza. Poiché «il modo è
un’affezione di un attributo, la modificazione, un’affezione della sostanza»75, e
poiché «i modi che differiscono secondo l’attributo formano una sola ed unica
modificazione», un numero finito di attributi implicherebbe un numero finito di
modi; ma da finiti modi non può derivare neppure una modificazione, e ancor
meno l’infinità di modificazioni che è richiesta per colmare la potenza di esistere della sostanza.
Deleuze così enuncia l’ultima triade della sostanza: «L’essenza della
sostanza come potenza assolutamente infinita di esistere; la sostanza come
ens realissimum esistente per sé; la capacità di essere affetti in infiniti modi,
corrispondente a tale potenza, necessariamente colmata da affezioni di cui la
sostanza è la causa attiva»76. La prima triade esponeva la struttura della
sostanza, a partire dall’elaborazione della teoria dell’espressione. La seconda
triade affermava l’assoluto come ragione dell’infinito, confermando ontologicamente i fondamenti dell’espressione. La terza triade determina l’identità di
potenza e natura, deducendo la produzione dall’espressione. Questa deduzione segna il compimento del ciclo della sostanza e introduce all’universo dei
modi77. Prima di volgerci a esso, è necessario sviluppare il precedente accenno al rapporto tra espressione e gnoseologia.
L’idea espressiva
La teoria spinoziana dell’idea prende le mosse da Cartesio, ma si discosta
ben presto dal suo modello. Secondo lo Spinoza di Deleuze, Cartesio non si
avvede che la natura dell’idea può essere intesa solo cogliendo la vera potenza del pensare. Ciò che fa difetto alla ratio cartesiana non è molto diverso da
ciò che manca alla ragione classica: entrambe ignorano la nozione del pensiero come potenza, perché a entrambe rimane estraneo l’espressionismo
filosofico.
Cartesio e Spinoza sono accomunati da una concezione non intellettualistica dell’idea: idee non sono i soli concetti. La riduzione cartesiana dello spirito
a pensiero, che segna l’ingresso della filosofia nella modernità, è pienamente
approvata da Spinoza; non c’è una differenza di natura tra un concetto astratto, un affetto e una sensazione. Un’idea è, prima facie, semplicemente uno
NOTE
stato mentale. Le nostre rappresentazioni, nelle condizioni cui siamo esposti
dal comune ordine della natura, sono idee confuse o inadeguate: conseguenze senza premessa, come dice Spinoza, oppure impressioni, tracce, segni che
sono delle vere e proprie «grida», come dice Deleuze78.
Che le nostre idee siano perlopiù inadeguate non implica però che esse
siano come dei segni arbitrari79, perché un’idea non è mai disgiunta dall’affermazione (implicita o esplicita) di una causa reale per la presenza del suo
oggetto80. Che l’ordine delle idee sia identico all’ordine delle cose deriva innanzi tutto dal fatto che l’ordine delle idee è identico all’ordine delle cause. Nulla
di positivo è dunque dato in un’idea, perché essa sia falsa81: un’idea falsa significherebbe l’affermazione di una causa fittizia; ma una causa fittizia è in contraddizione con l’ordine della natura, e dunque o è oggetto di una finzione, o è
riconducibile a un’idea inadeguata. Il falso è inefficace; non esiste una potenza del falso. Se esistesse un genio maligno, sarebbe il più impotente dei sovrani. Il falso non sta in piedi.
Nulla che sia affermato in un’idea è dovuto al falso; sappiamo quindi che
l’eventualità di un inganno trascendentale è illusoria, ma non sappiamo ancora se la scienza certa sia espressa dal pensiero. La nostra gnoseologia è sicura, ma la nostra epistemologia è ancor tutta da costruire. Intendiamo che l’intelletto possiede la facoltà di riconoscere il vero; ignoriamo però se e come
possa produrre idee vere.
Deleuze attribuisce a Spinoza il merito d’aver concepito un vero e proprio
metodo di generazione delle idee, fondato sul concetto di idea adeguata. Quest’ultima non è semplicemente l’idea chiara e distinta, bensì è l’idea scientifica
o «espressiva»82. L’esistenza di Dio non assicura la verità delle nostre idee, ma
la possibilità dell’adeguatezza, ovvero della scienza83. L’esistenza di Dio fonda
la completezza della nostra conoscenza. Il problema non è più gnoseologico,
come in Cartesio, ma epistemologico: posta l’esistenza di Dio, l’intera realtà è
deducibile attraverso una sequenza di idee necessariamente vere. Dio non è
il garante della verità delle nostre rappresentazioni, ma il punto archimedeo
dell’adeguatezza dei nostri concetti.
Lo spinozismo implica un evidente primato del pensiero sulla coscienza,
che secondo Deleuze significa un primato dell’adeguato sul chiaro-e-distinto. Il
criterio cartesiano del chiaro e distinto consente di riconoscere il vero ma non
di costruirlo, e per questo resta al di qua della potenza del pensiero84. La stessa idea di Dio, finché resta una mera traccia nella coscienza, non ci consente
di fare illazioni sull’esistenza del suo oggetto. Viceversa, è solo perché la definizione di Dio è reale che noi possediamo l’idea di Dio nella mente. È il pensiero nel suo aspetto oggettivo a fondare le credenze contenute nella coscienza, le quali resterebbero altrimenti del tutto prive di significato. È l’adeguatezza dei nostri concetti a fondare la loro chiarezza e distinzione, e non viceversa. In tal senso, come il significato generale della lettura di Deleuze suggerisce, lo spinozismo non esprime alcun facile accesso a Dio.
Spinoza non si limita a rinnovare profondamente la gnoseologia cartesiana,
bensì imposta in modo del tutto originale il problema del rapporto tra idea e
intelletto. L’idea di Dio è la prima espressione del pensiero: in quanto idea
57
58
matrice d’ogni altra idea, essa si esprime immediatamente nella forma del
modo infinito dell’intendimento, ossia come intelletto infinito. Resta vero che
all’essenza di Dio non appartiene l’intelligenza, ma la forma della potenza divina di pensare (l’idea di Dio) si esprime nell’attributo del pensiero come il modo
che è proprio di questo (l’intelletto infinito).
Dio, conoscendosi in un’idea, conosce tutte le proprie modificazioni, perché
la conoscenza dell’idea implica la conoscenza di tutto ciò che accade nell’oggetto85. Dio conosce tutte le cose non per onniscienza, ma perché la forma
intellettuale che dà accesso alla facies totius universi risulta attualmente costituita nell’attributo del pensiero. Con ciò, il mondo prodotto è raggiunto nel solo
modo consono all’espressionismo filosofico: attraverso la dimostrazione della
accessibilità della produzione dall’espressione. Si trattava di verificare se,
assumendo l’antecedente (l’idea di Dio), il conseguente (l’universo empirico)
potesse essere dedotto; il che è dimostrato dal fatto che ciò che sussume tutte
le condizioni di produzione della realtà (l’intelletto infinito) è anche ciò che è
necessariamente implicato da ciò cui l’idea di Dio inerisce (l’attributo del pensiero). Dio produce in quanto conosce, ma non produce perché conosce, bensì
per una conseguenza correlata al conoscere; oppure si può anche dire che Dio
produce «perché» conosce, con la postilla che ciò è vero unicamente in quanto la sua potenza di pensare, come Deleuze scrive, è di fatto condizionata dal
solo attributo del pensiero86.
Il nesso tra intelletto divino e produzione delle cose perde così ogni valenza teologica per acquistare il suo vero significato espressionista: Dio produce tutto ciò che dipende da una certa articolazione di sé semplicemente
esprimendo tale articolazione. Esprimendosi in quanto sostanza infinita
(prima articolazione), Dio si rappresenta in un’idea che è la matrice di tutte
le idee (seconda articolazione); ma l’idea matrice è anche modo immediato
del pensiero, cioè è intelletto infinito (terza articolazione), il quale sussume
gli infiniti modi che compongono l’«aspetto dell’intero universo» (quarta articolazione)87.
L’espressionismo di Spinoza è una teoria della accessibilità degli strati che
compongono la realtà. Se uno strato è raggiungibile mediante una sequenza
deduttiva, ciò cui esso apre è contemporaneamente prodotto e conosciuto. Si
mostra la necessità del mondo prodotto semplicemente dimostrando che si
può guadagnare, a partire dall’idea di Dio, l’accesso alla sfera della produzione. La conoscenza del prodotto –il fatto che si dia un’idea a partire dalla quale
il prodotto è attinto– ci assicura che l’espressione è produzione, senza bisogno
di mediazione alcuna. L’espressionismo filosofico è la negazione del concetto
di mediazione. Se tutte le condizioni per la produzione del fenomeno sono
date, la dimostrazione dell’attualità dell’idea che implica tali condizioni è quanto basta perché il fenomeno sia anche prodotto: nessuna causa ulteriore è
richiesta. A questo titolo, la metafisica può essere ciò che aspira a essere:
un’autentica filosofia della realtà.
L’accesso dall’espressione alla produzione segna la deduzione del finito. Poiché Dio è causa immanente delle cose88 e in quanto ogni singola determinazione di una cosa dipende da Dio89, il finito cade completamente sotto l’espressione. Questo non è però tutto ciò che possiamo conoscere circa la finitezza. Spinoza non si limita a dimostrare che il finito cade sotto l’espressione, ma elabora
i fondamenti dell’espressione nel finito. Il principio dell’espressione si specifica in
forme distinte, senza perdere nulla della propria univocità. Resta vero che niente in natura sfugge all’espressione, ma da ciò non segue che tutto ciò che accade in natura sia direttamente e invariabilmente riferibile all’espressione. Le cose
esprimono Dio, ma ciò non va sans dire. Le cose esprimono comunque Dio, e
tuttavia solo sotto una certa condizione: è questo il principio dell’etica.
L’etica si distingue dall’ontologia pura, se è lecito dire così, per il fatto che
in essa le condizioni espressive non sono già date, ma devono essere raggiunte. Se le cose, esistendo, fossero nella condizione naturale contemplata dalla
loro espressione, non ci sarebbe bisogno di alcuna etica. Per esempio, posto
che il modo finito è sforzo costante verso il proprio potenziamento, e posto che
questo potenziamento comporta la costituzione di un individuo il più possibile
potente e razionale90, l’espressione imporrebbe, a partire dall’essenza modale, la creazione immediata della perfetta democrazia, la quale, secondo tutte le
evidenze empiriche, è invero ancor di là da venire91. Il modo non «nasce» nelle
sue condizioni espressive di base: la vita del modo non è da parte a parte
espressiva.
Nell’interpretazione deleuziana, la sfera dell’etica sembra rappresentare
anzitutto il raggiungimento del primo livello ontologico che possa essere detto
espressivo. Tutto ciò che è è determinato, ma non ogni determinazione è
espressiva. Esiste una determinazione propriamente etica, ed è quella che
concerne il raggiungimento, da parte degli individui, delle condizioni richieste
per l’espressione. Il «comune ordine della natura»92 è un piano della realtà, ma
non è un piano dell’espressione: nulla in esso è chiaro, nulla è esplicato. L’etica è lo sforzo di portare ordine in questa dimensione, in modo da ottenere il
maggior numero di determinazioni espressive. Per questo, pur ritrosa alla
meditatio mortis, l’etica spinoziana comprende una teoria assolutamente originale della morte: la nostra parte di eternità è la nostra parte espressiva. Con la
morte, scrive icasticamente Deleuze, «siamo diventati totalmente espressivi»93, perché abbiamo perduto tutte le nostre note esistenziali, quelle che confondono od ostacolano la nostra espressione.
La condizione della espressività del modo è l’attività. Per il modo, essere
passivo significa implicare affezioni che non si esplicano attraverso la sua sola
natura94, cioè non la esprimono: essere separato dalla propria potenza e quindi non libero. In breve, il modo finito ci fa scoprire che, seppure tutta l’espressione è determinazione e tutta la potenza è efficiente, esiste un ambito del
determinato inespressivo o del potere «inefficace». Pur essendo tutto determinato, il modo non è tutto espressivo: ciò che non contraddice al principio
d’espressione, il quale richiede soltanto che la natura di una cosa esprima
NOTE
Teoria del modo finito
59
60
necessariamente ogni possibile determinazione di questa, e non che, per converso, ogni determinazione di una cosa esprima necessariamente la natura di
questa; qualche determinazione del modo può quindi, senza contraddizione,
non esprimere ciò che appartiene alla natura dello stesso95.
Anche il modo finito possiede dunque triadi nell’espressione96. Le essenze
dei modi sono parti della potenza divina97, cioè quanta di intensità in cui si
ripartiscono le qualità illimitate rappresentate dagli attributi98. A ciascun grado
di potenza è associato un rapporto caratteristico99, che realizza nell’estensione una capacità determinata di affezione. Quando un’essenza viene sussunta
da un rapporto, il modo a essa corrispondente si costituisce come individuo
esistente: Deleuze ricorda che è il rapporto, e non l’essenza, a determinare
l’esistenza del modo, perché le leggi di composizione dei rapporti non sono
deducibili dalle essenze. Tuttavia, poiché un modo esistente non avrebbe potuto costruirsi secondo un rapporto diverso da quello in cui si costruisce, la relazione tra essenza e rapporto non è contingente. L’essenza non implica il rapporto, ragion per cui l’essenza del modo non involge l’esistenza; nondimeno,
stante il determinismo universale, un certo rapporto è anche l’unico possibile
per una certa essenza. La trasformazione del rapporto comporta infatti il passaggio a un nuovo individuo, o viceversa lo smembramento del vecchio100.
Esterno all’espressione del modo è solo l’ordine degli incontri, cioè il «comune ordine della natura» entro cui hanno luogo le sue determinazioni fortuite. La
casualità degli incontri fa sì che l’ordine in cui i corpi si relazionano possa non
essere quello in cui i loro rapporti si compongono101: altrimenti, ogni incontro
sarebbe un incontro felice, una simbiosi, un motivo di potenziamento vitale. Poiché, invece, non tutti gli incontri esprimono una composizione di rapporti, esistono determinazioni inespressive o spurie, le quali producono tra gli individui alchimie nocive o nefaste. In prospettiva deleuziana, l’etica è in ultima analisi la scienza generale della costruzione dei rapporti, finalizzata a rendere il maggior numero di determinazioni isomorfo all’ordine espressivo delle ragioni102.
L’assenza di isomorfismo tra ragioni e determinazioni impone al modo una
ininterrotta sperimentazione affettiva. La vita del modo è in tal senso una
«prova», non però morale, bensì «fisico-chimica»103. Esistere significa selezionare affetti, discernere tra i buoni e i cattivi incontri, tra le occasioni di potenziamento e le congiunture dannose, fermo restando che il Bene e il Male sono
soltanto nomi vuoti, contrassegni della peggiore ignoranza104. Lo Spinoza di
Deleuze è apertamente materialista, immoralista, ateo105: la coscienza è l’illusione di una causa finale delle determinazioni materiali106; l’essere sta al di là
del bene e del male107; Dio non trascende il mondo. La vera eredità dello spinozismo è l’immoralismo nietzscheano108, altra grande filosofia della selezione
e della sperimentazione.
Da che cosa si riconosce lo spinozismo?
Gilles Deleuze non era un pensatore poetante postmoderno, ma uno strano tipo di filosofo «classico», amante dei princìpi e dei concetti. Le monografie
NOTE
deleuziane sono scritte con una nettezza quasi barbarica: pochi autori hanno
saputo trasmettere, attraverso le loro opere, un così grande amore per la vita
interna del concetto e per la sua scabra oggettività. Anche per questo, le riflessioni fin qui condotte possono essere ora riordinate, senza alcuna pretesa di
completezza, a partire dalla categoria dello «spinozismo», per come essa
occupa il discorso e le intenzioni di Deleuze.
Lo spinozismo ci insegna anzitutto che un’ontologia pura è una filosofia dell’immanenza assoluta. Il problema non è di scegliere tra un’ontologia immanentista, ancorata al sensibile e al finito, e un’ontologia che riconosca l’esistenza di oggetti trascendenti: né l’una né l’altra opzione è spinoziana. Il problema
è semmai che, dal punto di vista dell’immanenza, la realtà è un concetto assoluto, rispetto al quale ogni mediazione è una falsa espressione.
L’immanenza è una critica all’idea di mediazione, un attacco anticipato alla
dialettica: lo Spinoza di Deleuze è il filosofo dell’immediatezza, della genesi
statica, del movimento sul posto. Da questo punto di vista, niente sembra
meno spinoziano dell’incipit della Logica hegeliana, che defrauda l’ente a nulla
per riscattarlo solo nel divenire. Lo spinozismo è una delle più conseguenti filosofie dell’immanenza anche perché ignora il tema, tanto platonico quanto cristiano quanto hegeliano (in breve: occidentale), del «parricidio» ontologico.
Per nessun pensatore meno che per Spinoza vale l’idea –che ha in sé tutti i
germi della dialettica, della secolarizzazione, dello storicismo– di un’origine
abbagliante e ineffabile oppure astratta e vuota, precocemente tradita o inesorabilmente mediata. Di qui l’eccezionalità di Spinoza nella cultura, o, per il suoi
detrattori, il suo irenismo.
Ciò conduce a una seconda nozione, quella di potenza. Secondo Deleuze,
lo spinozismo indica l’esistenza di una potenza propriamente ontologica: l’essere è potenza. Per dimostrarlo, occorre però far vedere che la causa sui è il
modello di ogni causalità, ossia che Dio è causa immanente e non transitiva
delle cose e che Dio causa così com’è. Senza di ciò, la potenza sarebbe solo
l’intuizione indimostrata di una physis abissale. Come parlare di una genesi
intrinseca alla realtà al di fuori del fondamento dato da una sostanza attualmente sussistente? In mancanza della dimostrazione dell’esistenza di Dio
–che non significa se non questo, che la Natura è l’Assoluto– l’autopoiesi dell’essere resta un mito metafisico tra gli altri.
Lo spinozismo sembra consistere, in terzo luogo, in un realismo estremo.
Ciò significa che debbono valere due princìpi: quello della realtà intrinseca
della causa e quello della verità intrinseca dell’idea. Una causa fittizia non può
essere realmente affermata; ossia, una tale affermazione sarebbe contraddittoria rispetto alla necessità che ogni effetto dipenda da una causa. Se l’idea
potesse esprimere il falso, saremmo in presenza nientemeno che di una naturae eversio109. Pertanto, il falso è improduttivo; è impossibile essere certi del
falso, perché ciò significherebbe che in natura si dà qualche falsità. La possibilità di una rappresentazione positivamente scorretta della natura è negata
dalla struttura stessa di questa.
In quarto luogo, lo spinozismo rappresenta un essenzialismo radicalmente
antiplatonico110. L’essenza non è un modello ideale, bensì un nocciolo di real-
61
62
tà costituito in seno alla potenza di Dio. Le essenze dei modi sono le forme ritagliate entro la potenza divina di agire. L’implicazione della realtà è quindi immediata, anche se tale non è l’implicazione dell’esistenza temporale111, la quale
comporta, scrive Deleuze, una «posizione estrinseca» (ma non per questo
esterna) rispetto agli attributi112.
Un quinto aspetto è il carattere pratico dello spinozismo. Nella misura in cui
l’esistenza del modo implica determinazioni inespressive, essa non può non
assumere un carattere sperimentale. Il modo non è tutto espressivo non perché trascenda l’espressione, ma perché la sua appartenenza all’espressione è
sottoposta a condizioni peculiari; altrimenti, la virtù del modo (la vita secondo
ragione) sarebbe una conseguenza immediata della sua essenza. Così non è
non perché il modo fuoriesca dall’ordo geometricus, ma perché la sua esistenza conosce l’ordine estrinseco dei rapporti. L’esistenza del modo è simile al
destino di una figura geometrica tracciata sulla carta: la storia del suo supporto cartaceo, esposto all’usura del tempo, non la riguarda meno dei teoremi ai
quali essa deve il proprio essere. L’etica è la consapevolezza di questa «doppia vita» del modo finito, divisa tra l’ordine esplicito delle ragioni espressive e
l’ordine muto dei segni inespressivi.
L’ultimo aspetto dello spinozismo potrebbe essere definito il suo carattere
semiotico. Deleuze legge in Spinoza una semiotica originale della realtà: «se
siamo spinozisti», egli scrive, «non definiremo alcunché né secondo la sua
forma, né in base ai suoi organi e alle sue funzioni, né in quanto sostanza o
soggetto»113. Tracceremo invece una sorta di mappa affettiva: ponendo su un
asse gli specifici rapporti di moto e quiete dell’oggetto e, sull’altro asse, gli
affetti corrispondenti. Deleuze ha sviluppato in proprio questo metodo, interessandosi alla possibilità di costruire un «piano di immanenza» dell’essere sia
sfruttando alcune acquisizioni dello strutturalismo114, sia rinnovando profondamente le ragioni del naturalismo. La Natura come individuo115 e la filosofia
come espressione di un «Grande Vivente»116 sono state le premesse ideali del
suo lavoro, perfettamente individuabili anche nel suo grande predecessore
olandese.
G. DELEUZE, Pourparlers, Minuit, Paris 1990, p. 191.
Il più importante libro spinoziano di Deleuze è Spinoza et le problème de l’expression, Minuit,
Paris 1968; tr. it. di S. Ansaldi: Spinoza e il problema dell’espressione, Quodlibet, Macerata 1999
(d’ora in poi indicato come SPE), già tesi di dottorato complementare dell’Autore. L’altra monografia deleuziana dedicata al filosofo dell’Etica è Spinoza. Philosophie pratique, Minuit, Paris 1981; tr.
it. di M. Senaldi: Spinoza. Filosofia pratica, Guerini, Milano 1991 (di qui in avanti: SPhP). I numeri dopo le sigle indicano le pagine dei testi originali di Deleuze; i numeri in parentesi indicano le
pagine delle traduzioni italiane. Le opere di Spinoza sono citate dagli Opera, a cura di Carl
Gebhardt (contrassegnati nel testo dalla sigla G, seguita da una cifra romana che indica il numero del volume e da una cifra araba che indica la pagina). Le versioni italiane delle opere di Spinoza vengono citate in parentesi, secondo i contrassegni seguenti: CM = Pensieri metafisici (Cogitata metaphysica), a cura di E. Scribano, Laterza, Roma-Bari 1990; E = Etica dimostrata secondo
l’ordine geometrico (Ethica ordine geometrico demonstrata), a cura di S. Giametta, Bollati Boringhieri, Torino 1992; Ep. = Epistolario, a cura di A. Droetto, Einaudi, Torino 1951; KV = Breve trat1
2
NOTE
tato su Dio, l’uomo e il suo bene (Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand),
a cura di F. Mignini, Japadre, L’Aquila 1986; PPhC = Principi della filosofia di Cartesio (Principia
philosophiae cartesianae), cura e luogo come CM; TIE = Trattato sull’emendazione dell’intelletto
(Tractatus de intellectus emendatione), a cura di E. de Angelis, Boringhieri, Torino 1962; TP = Trattato politico (Tractatus politicus), a cura di L. Pezzillo, Laterza, Roma-Bari 1995?; TTP = Trattato
teologico-politico (Tractatus theologico-politicus), a cura di A. Dini, Rusconi, Milano 1999. I numeri arabi che compaiono dopo le sigle delle traduzioni citate indicano le pagine; nel caso della versione italiana dell’Etica, anziché il numero di pagina viene indicato il luogo di riferimento, secondo
le seguenti convenzioni: a = assioma; c = corollario; d = definizione; dim = dimostrazione; p = proposizione; ps = postulato; sc = scolio. Un esempio di citazione è: E 1 p 8 sc 2 = secondo scolio
della proposizione 8 della prima parte.
3 La descrizione di Deleuze merita d’essere letta per intero: «Questa vita frugale e senza proprietà, minacciata dalla malattia, questo corpo magro, debole, questo viso ovale e bruno con due
sorprendenti occhi neri –come spiegare l’impressione che danno di essere percorsi dalla Vita stessa, di avere una potenza identica alla Vita? In tutto il suo modo di vivere come di pensare Spinoza eleva un’immagine di vita positiva, affermativa, contro i simulacri di cui gli uomini si accontentano. Non solo se ne contentano: ma l’uomo che ha in odio la vita, che se ne vergogna, l’uomo
dell’autodistruzione che moltiplica i culti della morte, che fonda la sacra unione del tiranno con lo
schiavo, il prete, il giudice e il guerriero, sono sempre impegnati a perseguitare la vita, a mutilarla, a farla morire a fuoco rapido o lento, a mascherarla o a soffocarla con leggi, proprietà, doveri,
autorità: ecco ciò che Spinoza diagnostica nel mondo, questo tradimento dell’universo e dell’uomo»: SPhP, 20-21 (21-22).
4 Un’articolata discussione del tema è svolta da R. BOUVERESSE, Spinoza et Leibniz. L’idée
d’animisme universel, Vrin, Paris 1992.
5 In Spinoza, scrive Deleuze, «la Vita, ossia l’espressività, è portata nell’assoluto»: SPE, 70
(60). Cfr. anche SPE 87 (77): «L’espressione è, in Dio, la vita stessa di Dio».
6 Osserva M. SENALDI, Scholium, SPhP (165): «Si eviterà di parlare di un’interpretazione particolarmente “forte” del testo, di un’ermeneutica deleuziana di Spinoza. Mentre potremmo parlare di
uno Spinoza hegeliano, o gentiliano, non esiste un’immagine deleuziana di Spinoza […]. Il problema resta quello di creare libri spinozisti, o leibniziani, o nietzscheani, o anche cinematografici, anziché libri su questo o quel pensatore o argomento».
7 Il problema dei rapporti tra Spinoza e Leibniz esula dagli obiettivi del presente scritto. Basti
qui citare la seguente affermazione di Deleuze: quali che siano «le differenze fra Leibniz e Spinoza, in particolare nell’interpretazione dell’espressione, è un dato di fatto che entrambi utilizzano
questo concetto per superare quel che considerano l’insufficienza o la facilità del cartesianesimo
e per restaurare l’esigenza di una ragion sufficiente che operi nell’assoluto. Questo non significa
che ritornino al di qua di Cartesio: vi sono risultati del cartesianesimo che non possono più essere messi in discussione: ad esempio, le proprietà dell’infinitamente perfetto, della quantità di realtà, del chiaro e del distinto, del meccanicismo ecc. Spinoza e Leibniz sono postcartesiani nello
stesso senso in cui Fichte, Schelling e Hegel sono postkantiani: devono raggiungere il fondamento da cui derivano tutte le proprietà precedentemente enumerate, riscoprire un assoluto che sia
all’altezza del “relativismo” cartesiano»: SPE, 302 (255-256).
8 Cfr. G II, 45 (E 1 d 4). L’interpretazione deleuziana dell’attributo è, sin dall’inizio, radicalmente oggettivista: cfr. SPE, 14 (13).
9 SPE, 153-169 (133-146).
10 Osserva M. MESSERI, L’epistemologia di Spinoza. Saggio sui corpi e le menti, il Saggiatore,
Milano 1990, pp. 45-46: «La scienza naturale degli antichi è […], secondo Spinoza, ingiustificatamente poco ambiziosa. Questa scienza si propone spiegazioni dimostrative per alcuni generi di
fatti, ma lascia altri fatti nella situazione logica di una mera necessità condizionale: essa si costituisce sulla base del presupposto che non tutto possa essere dimostrato. Spiegazione causale e
spiegazione dimostrativa restano al suo interno separate. La scienza di Spinoza si costituisce,
invece, muovendo dalla certezza della completa dimostrabilità di ogni fatto».
11 Cfr. G IV, 166 (Ep. XXX, 164).
12 Cfr. G IV, 173-174 (Ep. XXXII, 170).
13 Cfr. in proposito G I, 237-238 (CM, 118-119).
14 SPE, 103 (92).
63
Cfr. G II, 89 (E 2 p 7 c).
SPE, 153 (133).
17 SPE, 154 (133).
18 Deleuze sottolinea il carattere icastico (ossia non espressivo) del segno: «La Scrittura è sì
la parola di Dio, ma una parola che è comandamento: essendo imperativa, non esprime nulla, perché non permette di conoscere nessun attributo divino»: SPE, 48 (42). Sul nesso tra profezia,
segno e immaginazione cfr. segnatamente G III, 28 (TTP, 97).
19 SPE, 165 (143).
20 In SPE, 69 (60) si parla esplicitamente di «logica dell’assoluto».
21 Deleuze distingue talora tra assoluto e infinito, talaltra (in maniera equivalente) tra l’assolutamente infinito e l’infinitamente perfetto. Secondo Deleuze, gli argomenti di Spinoza a dimostrazione dell’esistenza di Dio sono in parte ascrivibili al tema tradizionale dell’«infinitamente perfetto», che resta tuttavia subordinato «alla posizione preliminare dell’assolutamente infinito»: cfr.
SPE, 66 (57).
22 Scrive recisamente Deleuze in SPE, 66 (57): «La prova ontologica, così come si trova all’inizio del Breve Trattato, non serve assolutamente a nulla».
23 «Finché non si pone una definizione reale, che poggi sull’essenza di una cosa e non su propri (propria), si resta nell’ambito arbitrario di ciò che è semplicemente concepito ed è privo di qualsiasi relazione con la realtà della cosa quale è fuori dell’intelletto»: SPE, 63 (55).
24 G II, 52 (E 1 p 10 sc).
25 G II, 49 (E 1 p 7).
26 G II, 52 (E 1 p 11).
27 Cfr. M. GUEROULT, Spinoza, I, Dieu (Ethique, I), Aubier-Montaigne, Paris 1968, p. 160: «È
impossibile conferire come attributi a una sostanza realtà che non siano concepite esse stesse
come sostanze. Altrimenti detto, gli attributi che dobbiamo riconoscere alla sostanza infinitamente
infinita non possono essere altri da quelli che sono stati fino a qui dedotti come sostanze a un solo
attributo».
28 «Riguardo all’ente che ha la proprietà razionale di essere infinitamente perfetto, la domanda rimane sempre la stessa: è possibile?» (SPE, 62 (54)). Cartesio ritiene erroneamente «che la
concezione chiara e distinta del proprio [la perfezione di Dio] sia sufficiente per garantire la possibilità della natura corrispondente» (SPE, 62 (53)). Viceversa, per Spinoza, «l’infinitamente perfetto è solo un proprio. Tale proprietà non ci fa conoscere nulla della natura dell’ente al quale appartiene, e non è sufficiente a dimostrare che questo ente non implichi contraddizione».
29 SPE, 9 (9).
30 SPE, 37 (32). «Vi sono due modi per riconoscere un attributo: o si ricercano a priori le qualità che si concepiscono come illimitate, oppure, partendo da ciò che è limitato, si ricercano a
posteriori le qualità che possono essere portate all’infinito, cioè le qualità “implicate” nei limiti del
finito. Così, da questo o quel pensiero, arriviamo fino al pensiero come attributo infinito di Dio; da
questo o quel corpo, all’estensione come attributo infinito». Per i due metodi, Deleuze rinvia rispettivamente a E 2 p 1 sc e a E 2 p 1 dim.
31 SPE, 21 (19).
32 SPE, 232 (198).
33 SPE, 37 (33).
34 «Gli attributi sono per Spinoza forme di essere univoche, che non cambiano natura cambiando “soggetto”, vale a dire predicandoli dell’ente infinito o degli enti finiti, della sostanza e dei modi,
di Dio e delle creature»: SPE, 40 (35).
35 Il lavoro di P. DI VONA, Studi sull’ontologia di Spinoza, 2 voll., La Nuova Italia, Firenze 1960
e 1969, esprime (in maniera completamente autonoma) posizioni teoriche opposte a quelle
deleuziane, sulle quali anche per questo è interessante soffermarsi. Secondo Di Vona, «in Spinoza non c’è un concetto dell’ente comune a Dio e alle sue conseguenze» (I, p. 252). Il genere
di analogia che si dà tra l’ente in quanto predicato di Dio e in quanto predicato delle «creature»
è per Di Vona in primo luogo di attribuzione estrinseca. In questo tipo di attribuzione, la stessa
entità deriva alle creature, «senza nulla presupporre», dall’essenza divina (cfr. II, p. 19). Di Vona
ritiene infatti che sia Spinoza che Cartesio (I, p. 254) –quest’ultimo, in particolare, in ragione dell’idea della creazione continua– si oppongano alla dottrina suareziana dell’ente analogo per
attribuzione intrinseca (I, p. 224).
15
16
64
NOTE
36 RENÉ DESCARTES, I princìpi della filosofia, a cura di P. Cristofolini, Bollati Boringhieri, Torino
1992, p. 101.
37 ID., Meditazioni metafisiche. Obbiezioni e risposte, a cura di A. Tilgher, Laterza, Bari 1954,
pp. 123-124. Il brano fa parte delle Prime Risposte, indirizzate a Caterus.
38 SPE, 24 (21).
39 SPE, 25 (22).
40 G II, 48 (E 1 p 5).
41 G II, 47 (E 1 p 4).
42 Cfr. GUEROULT, Spinoza, I, Dieu, cit., p. 119.
43 G II, 49 sgg. (E 1 p 8 sc 2).
44 SPE, 27 (24).
45 «Il problema diventa più chiaro se consideriamo che, per passare da una tematica all’altra,
basta effettuare quello che in logica si chiama la conversione di una universale negativa»: SPE,
27 (25). La conversione è un’inferenza che si ottiene scambiando tra loro il soggetto e il predicato di una proposizione; nel caso della conversione di un’universale negativa, da «nessun S è P»
deriva quindi che «nessun P è S» (cfr. I. M. COPI, Introduction to Logic, 1961?; tr. it. di M. Stringa:
Introduzione alla logica, il Mulino, Bologna 1964, pp. 172-174).
46 «Se dividessimo la sostanza conformemente agli attributi, bisognerebbe considerare la
sostanza come un genere, e gli attributi come differenze specifiche. La sostanza sarebbe un genere che non ci permetterebbe di conoscere nulla di particolare; sarebbe allora distinta dai suoi attributi, come il genere dalle sue differenze, e gli attributi sarebbero distinti dalle sostanze corrispondenti, come le differenze specifiche e le specie. Facendo della distinzione reale fra attributi una
distinzione numerica fra sostanze, introduciamo nella realtà sostanziale semplici distinzioni di
ragione»: SPE, 29 (26).
47 Non nascondendo l’azzardo del richiamo: cfr. SPE, 57, nota (49, nota).
48 SPE, 54 (47).
49 Secondo S. SPORTELLI, Potenza e desiderio nella filosofia di Spinoza, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 1995, p. 43, «un’interpretazione di questo tipo riduce però la sostanza –potendo
conoscerne solo le qualità– a qualcosa che in se stesso è inconoscibile».
50 SPE, 33 (29). Cfr. G IV, 7 (Ep. II, 39); G I, 24 e nota (KV, 147 e nota) e G I, 29 (KV, 157). F.
ALQUIÉ, Le rationalisme de Spinoza, 1981; tr. it. di M. Ravera: Il razionalismo di Spinoza, Mursia, Milano 1987, p. 76 contesta a Deleuze questa lettura, richiamando G I, 116 (KV, 353): «All’essenza di
ogni sostanza l’esistenza appartiene per natura». «È vero che Spinoza», scrive Alquié, «nell’appendice del Breve Trattato usa il termine sostanza per designare ciò che altrove chiama attributo; ma
l’equivalenza dei due termini è totale, e proprio agli attributi Spinoza conferisce l’esistenza per sé».
51 SPE, 30 (27).
52 SPE, 36 (32).
53 SPE, 34 (30).
54 Cfr. SPE, 48 (41): «Mai si è andati così a fondo nella distinzione di due ambiti: la rivelazione e l’espressione. Come anche nella distinzione di due relazioni eterogenee: quella del segno e
del significato, dell’espressione e di ciò che è espresso. Il segno si riferisce sempre ad un proprio;
significa sempre un comandamento e fonda la nostra obbedienza. L’espressione concerne sempre un attributo; esprime un’essenza, vale a dire una natura all’infinito, e ce la fa conoscere».
55 Questa la sua formulazione per esteso: «1) Tutte le forme dell’ente sono uguali e ugualmente perfette, non c’è ineguaglianza di perfezione tra gli attributi; 2) ogni forma è dunque illimitata,
ogni attributo esprime un’essenza infinita; 3) tutte le forme appartengono ad una sola ed unica
sostanza, tutti gli attributi si dicono, senza limitazione alcuna, di una sostanza assolutamente infinita»: SPE, 70-71 (61).
56 SPE, 15-16 (14).
57 SPE, 60 (52).
58 «Come l’attributo dell’estensione non si confonde con la potenza di esistere, così l’attributo
del pensiero non si confonde di diritto con la potenza di pensare»: SPE, 106 (94).
59 «L’attributo del pensiero sta alla potenza di pensare come tutti gli attributi (compreso il pensiero) stanno alla potenza di esistere e di agire»: SPE, 107 (95).
60 «I modi di attributi diversi non solo hanno lo stesso ordine e la stessa connessione, ma
anche lo stesso essere; si tratta delle stesse cose che si distinguono solo attraverso l’attributo di
65
66
cui esse implicano il concetto. I modi di attributi diversi costituiscono una sola e unica modificazione che si differenzia solo secondo l’attributo»: SPE, 96 (85).
61 Cfr. SPhP, 78 (73): «Spinoza rovescia doppiamente la tradizione: poiché causa efficiente
non è più il senso primario di causa, e poiché non è più causa di sé quella che si predica in un
senso differente da quello di causa efficiente, ma è la causa efficiente che si predica nel medesimo senso della causa di sé».
62 «Una cosa esistente rinvia a un’altra cosa finita come causa. Ma si eviterà di dire che una
cosa finita è sottoposta a una doppia causalità, l’una orizzontale costituita dalla serie indefinita
delle altre cose, l’altra verticale costituita da Dio. Infatti in ogni termine della serie si è rinviati a
Dio come a colui che determina la causa ad avere il suo effetto. Così Dio non è mai causa remota, ma è dedotto dal primo termine della regressione. E non vi è che Dio che sia causa, non vi
è che un solo senso e una sola modalità per tutte le figure della causalità, benché queste stesse figure siano diverse […]. Presa nel suo senso unico e nella sua sola modalità, la causa è
essenzialmente immanente: vale a dire, dimora in sé per produrre (in opposizione alla causa
transitiva), e l’effetto non esce minimamente da essa (in opposizione alla causa emanativa)»:
SPhP, 78-79 (73).
63 Deleuze ricorda il testo di G III, 276-277 (TP, 8-9): le cose naturali «hanno bisogno, per
cominciare ad esistere, della stessa potenza che per continuare ad esistere. Dalla qual cosa segue
che la potenza delle cose naturali, per la quale esse esistono e di conseguenza agiscono, non può
essere altra che la stessa potenza eterna di Dio. […] Poiché Dio ha diritto su tutte le cose, e il diritto di Dio altro non è che la stessa potenza di Dio, in quanto venga considerata assolutamente libera, da ciò segue che ciascuna cosa naturale ha dalla natura tanto diritto quanta potenza ha di vivere e agire: poiché la potenza di ciascuna cosa naturale, per la quale esiste e agisce, non è altro
che la stessa potenza di Dio che è assolutamente libera». «Per un certo verso», scrive Deleuze,
«si potrebbe pensare che il testo intenda togliere ogni potenza che spetta alle creature. Così non
è. Lo spinozismo nel suo insieme è concorde nel riconoscere agli enti finiti una potenza di esistere, di agire e di perseverare; e il contesto del Trattato politico sottolinea che le cose hanno una loro
potenza, identica alla loro essenza e costitutiva del loro “diritto”. Spinoza non intende sostenere
che un ente che non esiste per sé non ha potenza; vuol dire invece che ha una sua potenza solo
se è parte di un tutto, ossia parte della potenza di un ente che esiste per sé»: SPE, 80 (70). Cfr.
anche G I, 157 (PPhC, 29) e G I, 266 (CM, 160).
64 G II, 146 (E 3 p 7).
65 Cfr. SPE, 78 (68): «L’esistenza possibile (nell’essenza) è altro dalla “possibilità”, proprio perché l’essenza è potenza».
66 G II, 90 (E 2 p 8).
67 DI VONA, Studi sull’ontologia di Spinoza, cit., II, p. 131 ritiene invece «innegabile che, quando sia veduta dal lato dell’essenza, anche per Spinoza la contingenza è reale». L’Autore interpreta «il contingente spinoziano» come «il concetto obbiettivo di qualcosa, il quale astrae dall’esistenza in atto e dalla sua negazione, ed i cui predicati non implicano contraddizione» (II, p. 187).
68 I testi che Deleuze richiama a proposito di questa nozione sono quelli in cui Spinoza definisce il corpo come «atto» a qualcosa: cfr. G II, 97 (E 2 p 13 sc); G II, 139-140 (E 3 pss 1-2); G II,
304 (E 5 p 39).
69 SPE, 82 (72).
70 Di segno opposto è, di nuovo, l’interpretazione di DI VONA, Studi sull’ontologia di Spinoza,
cit., I, p. 205, secondo cui la dottrina spinoziana della identità tra realtà e perfezione implica una
teoria della analogia di proporzionalità della res. «Il concetto di “res” non è identico in Dio e negli
altri esseri in modo assoluto, né in modo assoluto è uno. Ma è identico ed è uno “proportionaliter”.
Pertanto, esso è un concetto analogo. L’analogia di proporzionalità esprime la verità fondamentale del concetto di “res”, in Spinoza, perché Dio e ogni altro ente ha la realtà, l’esse e l’esistenza
che competono alla sua essenza».
71 G II, 63 (E 1 p 17 sc).
72 SPE, 90 (80).
73 «La sostanza […] non può essere una potenza assolutamente infinita di esistere senza che
sia colmata, da infinite cose in infiniti modi [modes], la capacità di essere affetta che corrisponde
a tale potenza»: SPE, 84 (73).
74 SPE, 104 (92). Cfr. G I, 17, nota (KV, 135, nota 8).
SPE, 98 (86).
SPE, 84 (73).
77 Deleuze ricava dall’ultima triade della sostanza una triade modale introduttiva («attributomodo-modificazione»): SPE, 98 (87).
78 Cfr. G. DELEUZE, Critique et clinique, 1993; tr. it. di A. Panaro: Critica e clinica, Cortina, Milano 1996, p. 185: «I segni o affetti sono delle idee inadeguate e delle passioni […]. Il genere di
conoscenza da essi costituito è a malapena una conoscenza; è piuttosto un’esperienza in cui si
ritrovano in maniera casuale delle idee confuse di mescolamenti fra corpi, degli imperativi bruti di
evitare la tale commistione e di cercarne un’altra, e delle interpretazioni più o meno deliranti di queste situazioni. È un linguaggio materiale affettivo piuttosto che una forma d’espressione, che assomiglia alle grida più che al discorso del concetto».
79 MESSERI, L’epistemologia di Spinoza, cit., pp. 15 e 195, interpreta la gnoseologia spinoziana
in funzione del paradigma, direttamente anticartesiano, della semiotica naturale.
80 G II, 89 (E 2 p 7 dim).
81 G II, 116 (E 2 p 33).
82 Cfr. SPE, 118 (104) e SPE, 136 (119): «L’idea adeguata è l’idea che esprime la propria causa
e che si spiega attraverso la nostra potenza. L’idea inadeguata è invece l’idea inespressiva e non
spiegata: l’impressione che non è ancora un’espressione, l’indicazione che non è ancora una spiegazione».
83 Cfr. in particolare G II, 36 (TIE, 83): Dio è causa non della verità, ma piuttosto della sistematicità delle nostre conoscenze. Conoscendo Dio, «la nostra mente […] riprodurrà la natura nella
misura massima: infatti ne avrà oggettivamente l’essenza, l’ordine e l’unione». Cfr. inoltre G I, 148149 (PPhC, 20): «Noi non possiamo essere certi di alcuna cosa non –per essere precisi– fintantoché ignoriamo l’esistenza di Dio […], ma fintantoché non abbiamo di Dio un’idea chiara e distinta».
84 «La dottrina della verità di Spinoza è inseparabile dalla polemica, diretta o indiretta che sia,
contro la teoria cartesiana. Considerati in sé, il chiaro e il distinto ci consentono al massimo di riconoscere un’idea vera che abbiamo, vale a dire quel che di positivo c’è in un’idea ancora inadeguata. Formare un’idea adeguata ci porta però al di là del chiaro e del distinto. In sé, l’idea chiara e
distinta non costituisce una vera e propria conoscenza, così come non contiene la propria ragione: il chiaro e il distinto hanno la loro ragion sufficiente solo nell’adeguato, l’idea chiara e distinta
forma una conoscenza vera solo se deriva da un’idea in se stessa adeguata»: SPE, 137 (120).
85 G II, 92 (E 2 p 9 c).
86 «Non pare esserci, qui, nessuna contraddizione, ma soltanto un fatto estremo. […] “Il fatto
è” che nessun attributo è sufficiente per colmare la potenza di esistere: qualcosa può esistere e
agire, senza essere né esteso né pensante. Al contrario, tranne attraverso il pensiero, niente può
essere conosciuto; la potenza di pensare e di conoscere è effettivamente colmata dall’attributo del
pensiero»: SPE, 107 (94).
87 Non è raro che Deleuze, dopo l’incontro con Félix Guattari, paragoni Spinoza a Louis Hjelmslev. In che modo il filosofo dell’Etica e il padre della glossematica possano essere confrontati ci
sembra poter essere chiarito nel modo seguente. Deleuze e Guattari mettono in relazione la struttura della sostanza di Spinoza con la concezione biplanare del segno, che prevede una bipartizione tra espressione e contenuto, a propria volta distinti secondo la forma e secondo la sostanza. Ci
pare che alle quattro articolazioni della sostanza di Spinoza elencate nel testo potrebbero corrispondere questi concetti di Hjelmslev: alla prima (l’attributo e, quindi, la substantia constans infinitis attributis) corrisponderebbe la forma dell’espressione, alla seconda (l’idea di Dio) la sostanza
dell’espressione, alla terza (il modo infinito immediato) la forma del contenuto e alla quarta (la
facies totius universi) la sostanza del contenuto.
88 G II, 63 (E 1 p 18).
89 G II, 68 (E 1 p 26).
90 Cfr. G II, 233 (E 4 p 35 c 2).
91 M. HARDT, Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy, 1993; tr. it. di E. De Medio:
Gilles Deleuze. Un apprendistato in filosofia, a-change, Milano 2000, p. 161 mostra che il problema politico non soltanto appartiene alla filosofia di Spinoza, come è immediatamente ovvio,
ma soprattutto possiede in essa un’espressione ontologica, alla quale si associano specifiche
forme modali: «Se accettiamo l’interpretazione deleuziana del parallelismo, dobbiamo scoprire
una nozione comune corporea che serve a organizzare gli incontri casuali, inadeguati e per lo
75
NOTE
76
67
68
più tristi dei corpi sociali in incontri coerenti, adeguati e gioiosi, proprio come la nozione comune intellettuale costituisce le idee adeguate (ragione) sulla base delle idee inadeguate (immaginazione). Spinto ai suoi limiti concettuali, il parallelismo ontologico significa che la costituzione
della conoscenza, la costituzione intellettuale della comunità, deve essere uguagliata e integrata da una sua costituzione corporea. Alla nozione comune corporea, al corpo sociale adeguato,
è data forma materiale nella moltitudine». Il riferimento esplicito è ad A. NEGRI, L’anomalia selvaggia, 1981; ora in ID., Spinoza, DeriveApprodi, Roma 1998. Scrive l’Autore: «Alcuni interpreti colgono la centralità del lavoro politico di Spinoza: ma è la sua centralità ontologica, dico ontologica, che va fatta risaltare» (p. 123). Negri coglie in Spinoza una «fenomenologia della prassi
costitutiva» il cui orizzonte è la collettività, la multitudo (p. 48). Proprio perché immediatamente
ontologiche, le nozioni di multitudo e di costituzione sottraggono Spinoza all’idealismo della tradizione della filosofia politica: «In ciò è il carattere rivoluzionario del suo pensiero: nell’esprimere assolutamente nella costituzione un rapporto sociale produttivo, la produttività dei bisogni
naturali, e tutto ciò come egemone rispetto al politico, –nel sussumere assolutamente qualunque astratta funzione di dominio sotto la positività dell’espressione del bisogno di felicità e di
libertà. La distruzione di ogni autonomia del politico e l’affermazione dell’egemonia e dell’autonomia dei bisogni collettivi delle masse: in questo consiste la straordinaria modernità della spinoziana costituzione politica del reale» (p. 253).
92 Cfr. G II, 114 (E 2 p 29 c).
93 SPE, 294 (248). «In noi non vi è più nulla di “implicato” o di “indicato”».
94 G II, 139 (E 3 d 2).
95 È il tema della corrispondenza con Guglielmo di Blyenberg. Cfr. in particolare G IV, 147 (Ep.
XXIII, 148): «Affermo dunque […] che Dio è assolutamente la causa di tutte le cose che hanno
un’essenza, qualunque esse siano. E se voi potete dimostrarmi che, per esempio, il male, l’errore, il delitto, ecc., sono alcunché che esprime un’essenza, io vi ammetto interamente che Dio è la
causa del delitto, del male, dell’errore, ecc. Mi pare di avervi sufficientemente mostrato che ciò che
costituisce la forma del male, dell’errore e del delitto non consiste in alcunché che esprima un’essenza, e che non si può dire, per conseguenza, che Dio ne è la causa».
96 Deleuze ne individua due: la prima (SPE, 191 (163)) comprende l’essenza, il rapporto caratteristico e le parti estensive; la seconda (SPE, 197 (169)) concerne essenza, capacità di affezione, affezione.
97 G II, 213 (E 4 p 4 dim).
98 «Gli attributi sono qualità eterne ed infinite, dunque indivisibili. L’estensione è indivisibile,
come qualità sostanziale o attributo. Ogni attributo, come qualità, è indivisibile. Ma ogni attributoqualità possiede una quantità infinita, che è anch’essa, a certe condizioni, divisibile [qui, elle, est
divisible sous certaines conditiones]. Tale quantità infinita di un attributo forma una materia, ma
una materia che è soltanto modale. Un attributo si divide quindi modalmente e non realmente. Possiede parti che si distinguono modalmente: parti che sono modali e che non sono sostanziali. […]
Abbiamo a che fare con parti di potenza, ossia con parti intrinseche ed intensive, veri e propri gradi
di potenza o di intensità. Le essenze dei modi si definiscono infatti come gradi di potenza»: SPE,
173 (149).
99 «Ogni corpo ha delle parti, “un gran numero di parti”; ma queste parti non gli appartengono
che sotto un certo rapporto (di moto o di quiete) che lo caratterizza. La situazione è assai complessa, poiché i corpi composti hanno delle parti di ordine differente che entrano sotto dei rapporti essi stessi variati; questi rapporti variati si compongono fra loro per costituire il rapporto caratteristico o dominante dell’individuo considerato a questo o a quel certo livello»: SPhP, 46-47 (45).
100 Cfr. SPhP, 47 (46): «Ciò accade quando questo rapporto, che è esso stesso una verità eterna,
non si trova più effettuato da parti attuali. Ciò che è scomparso non è affatto il rapporto, eternamente
vero, sono le parti fra le quali esso si era stabilito, e che hanno assunto ora un altro rapporto».
101 Cfr. SPhP, 48 (47).
102 Il problema del male è, eminentemente, un problema di anisomorfismo rispetto all’espressione: «Dal punto di vista della natura o di Dio, vi sono sempre dei rapporti che si compongono, e
non vi è nient’altro che rapporti che si compongono secondo delle leggi eterne. Ogni volta che
un’idea è adeguata, essa coglie almeno due corpi, il mio e un altro, sotto quell’aspetto secondo cui
essi compongono i loro rapporti (“nozione comune”). Al contrario, non vi è alcuna idea adeguata
dei corpi discordanti, del corpo che discorda con il mio, in quanto discordante. È in questo senso
NOTE
che il male, o piuttosto il malvagio, non esiste che nell’idea inadeguata e nelle affezioni di tristezza che ne derivano (odio, collera, ecc.)»: SPhP, 52-53 (50-51). Cfr. G II, 259 (E 4 p 64).
103 SPhP, 58 (55).
104 Non esistono il Bene e il Male, ma solo il buono e il cattivo: «Sarà detto buono ogni oggetto il cui rapporto si componga con il mio (concordanza); sarà detto cattivo ogni oggetto il cui rapporto decomponga il mio, salvo poi comporsi con altri (discordanza)»: SPhP, 48 (47). Cfr. G II, 239
(E 4 p 39).
105 SPhP, 28, 33, 37 (28, 33, 36).
106 «La coscienza è naturalmente il luogo di un’illusione. La sua natura è tale che essa raccoglie degli effetti, ignorando le cause. […] Siamo in una situazione tale che afferriamo solamente
“ciò che accade” al nostro corpo, “ciò che accade” alla nostra anima, cioè l’effetto di un corpo sul
nostro, l’effetto di un’idea sulla nostra. Ma ciò che è il nostro corpo sotto il suo proprio rapporto, e
la nostra anima sotto il suo proprio rapporto, e gli altri corpi e le altre anime o idee sotto i loro rispettivi rapporti, e le regole secondo le quali tutti questi rapporti si compongono o si decompongono
–di tutto questo noi non sappiamo nulla all’interno dell’ordine dato della nostra conoscenza e della
nostra coscienza. […] La coscienza è soltanto un sogno ad occhi aperti»: SPhP, 29-31 (29-31).
107 SPhP, 45 (44).
108 Cfr. SPhP, 27 e 33 (27 e 32).
109 Sul tema, declinato in altra prospettiva, cfr. R. BORDOLI, Baruch Spinoza: etica e ontologia. Note
sulle nozioni di sostanza, di essenza e di esistenza nell’Ethica, Guerini, Milano 1996, pp. 93-110.
110 Ci sembra che questa dicitura possa definire anche la filosofia originale di Deleuze, per
come essa emerge soprattutto in Differenza e ripetizione (1969). Il termine «essenzialismo» può
creare qualche perplessità solo rispetto a una linea di pensiero dalla quale Deleuze si è sempre
tenuto piuttosto distante, quella esistenzialista, finitista ed ermeneutica. Uno degli sforzi teoretici di
Deleuze sembra invece consistere proprio nel conferire un nuovo significato alla nozione di essenza: la sua è, per intero, una filosofia dell’intrinseco contro l’estrinseco, dell’immediato contro il
mediato, dell’oggetto contro il soggetto, dell’intensivo contro l’estensivo. Da un capo all’altro della
storia del pensiero, dagli Stoici a Leibniz, da Spinoza a Bergson a Proust, Deleuze ha cercato le
ragioni di un naturalismo assoluto, indifferente verso ogni mediazione, sia essa la storia, la morale, il soggetto, la cultura; in tal senso parliamo qui di essenzialismo, seppure di suo genere.
111 Cfr. G II, 91 (E 2 p 8 c).
112 Cfr. SPhP, 103 (83): «L’esistenza del modo è dunque la sua stessa essenza, in quanto essa
non è più solamente contenuta nell’attributo, ma dato che essa dura e possiede un’infinità di parti
estensive, posizione modale estrinseca».
113 SPhP, 171 (157).
114 Il testo di riferimento è a tal proposito anzitutto l’articolo di Deleuze compreso in AA.VV.,
Histoire de la philosophie. Idées, Doctrines, vol. 8 – Le XX siècle, a cura di F. Châtelet, 1973; tr. it.
di L. Sosio: Da che cosa si riconosce lo strutturalismo?, in AA.VV., Storia della filosofia, vol. VIII. La
filosofia del XX secolo, Rizzoli, Milano 1976, pp. 194-217.
115 Cfr. SPhP, 164 (151).
116 SPhP, 10 (12).
69
I due testi che sono seguono, di Angela Ales Bello e di Bruno Callieri, costituiscono
due relazioni svolte presso il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche, a Roma, sul
libro di Bianca Maria d’Ippolito.
PSICOPATOLOGIA FILOSOFIA POESIA
IN LUDWIG BINSWANGER
di Angela Ales Bello
70
Non è mai esauribile il compito di ripensare il rapporto fra malattia mentale,
pensiero razionale ed espressione poetica. Bianca Maria d’Ippolito ha affrontato di nuovo questa tematica con risultati veramente convincenti, sollecitandoci a ripercorrere, da un punto di vista storico e teoretico, gran parte della cultura del Novecento e lo fa anche con uno stile personale ed affascinante.
Il suo libro La cattedrale sommersa – Fenomenologia e psicopatologia in
Ludwig Binswanger, Franco Angeli, Milano 2004. si presenta ricco d’immagini
e raffinato nel linguaggio che spesso assume un andamento lirico, nonostante
l’estremo rigore concettuale. Già sulla copertina un particolare del quadro di
Claude Monet, Scogliera ad Etretat, 1883, propone drammaticamente il contenuto del testo la cui chiave d’accesso è rappresentata dall’indagine sulla malattia mentale.
Vorrei aggiungere un’altra immagine alle molte che si trovano nel corso
della scrittura per tentare di rendere la complessità della ricerca dell’Autrice
–anche traduttrice dell’opera di Binswanger La psichiatria come scienza dell’uomo (1992)– sul contributo offerto dallo psichiatra svizzero alla descrizione
e comprensione delle patologie psichiche. Si tratta di un fascio di cerchi concentrici che, mobili, si toccano e si intersecano raffigurando i pensatori che di
volta in volta hanno attraversato più o meno direttamente il cammino speculativo dello psichiatra, ma si potrebbe dire anche del filosofo, Binswanger. E su
questi cerchi sono iscritti i nomi più illustri della cultura austriaca e tedesca dei
primi decenni del Novecento, da Freud, a Husserl e a Heidegger, ma anche
Dilthey e Buber, Hofmannsthal e Rilke, quindi psicoanalisti, filosofi e poeti che
gli consentirono di intessere una trama teorica capace di “catturare” il senso
dei disturbi mentali.
D’altra parte, l’immagine del cerchio può essere anche usata per illustrare
il tipo ricerca condotta dall’Autrice, la quale procede, a sua volta, per cerchi
concettuali che si allargano, quasi che fossero provocati da un sasso gettato
nell’acqua; essi scendono in profondità e costituiscono nel loro insieme, visti in
superficie, ad un occhio attento che sappia porli relazione, una mappa in cui,
alla fine, ognuno di essi trova il suo posto: il tempo, lo spazio, il mondo, la poesia, il delirio, temi affrontati e ripresi con successivi approfondimenti nel corso
del libro che rende ragione di ciascuno di essi.
NOTE
Desidero fermarmi su questi due aspetti dell’indagine di Bianca Maria d’Ippolito che sono, a loro volta, interconnessi. Il primo cerchio, relativo ai pensatori, è rappresentato dall’incontro con Freud, maestro di Binswanger e collega
di Husserl alla scuola di Franz Brentano. Certamente da Freud il giovane psicopatologo impara la teoria e la tecnica necessaria per capire e curare la
malattia mentale e dal filosofo Husserl impara ad esplorare le pieghe più riposte della dimensione psichica dell’essere umano.
Brentano, Freud e Husserl costituiscono il terreno sul quale si fonda l’interpretazione biswangeriana della malattia mentale, ma ci si potrebbe chiedere
come mai non gli basti la tecnica freudiana. In realtà la prima parte del libro di
Bianca Maria d’Ippolito è dedicata ad un’analisi approfondita proprio della posizione di Freud, non riducibile, secondo l’Autrice, all’interpretazione superficiale che di lui è data correntemente, essa in realtà è ricca di spunti largamente
antropologici, quelli che aprirono a Binswanger la via verso l’indagine sulla
struttura dell’essere umano. Scrive d’Ippolito: “Come medico, Freud incontra
una domanda che è quella della malattia. Ma Freud si chiede che cosa significa la malattia, e in ciò si attesta la natura filosofia della sua indagine. Al di là di
ciò che è stato considerato come il ‘naturalismo’ di Freud, la malattia è stata
per lui una via –o la via– per esplorare il territorio umano” (p. 19).
Proprio per rispondere a tale domanda Binswanger si rivolge prima a Husserl e poi a Heidegger. Tra le righe, ma non tanto, d’Ippolito propone, da filosofa, la sua lettura acuta e pertinente dei due fenomenologi, lettura che ella
mette in relazione con la ricezione che lo psicopatologo Binswanger fa delle
loro analisi. Si tratta sempre del terreno già individuato da Freud, terreno antico, ma analizzato con occhi nuovi, il terreno dell’“anima”: “A Vienna, Freud e
Husserl furono allievi di Brentano. Per quanto la visione eidetica e l’analisi della
coscienza appaiano rivolti ad una dimensione polarmente opposta all’inconscio freudiano, la comune radice aristotelica nella comprensione dell’‘anima’
riveste un’importanza decisiva in entrambe le dottrine. A sua volta Heidegger
non si sottrae al confronto con Aristotele, e la sua concezione del tempo deve
all’antico filosofo il proprio abbrivio nel concetto di ekstatikon” (p. 53).
Il comune denominatore è, quindi, l’attività dell’anima ed è qui che si incontrano e si scontrano i pensatori citati; ognuno pone in evidenza un aspetto, tutti
collaborano al chiarimento. E Binswanger utilizza questi risultati per una duplice finalità, quella di spiegare la malattia e quella di comprendere l’essere
umano, in cui la malattia si manifesta, sia nella sua singolarità sia nell’universalità delle sue strutture, in ciò consistono la “prima” e “seconda” lettura: “La
vicenda di Irma, nella presentazione di Binswanger, lascia vedere in filigrana,
sotto l’ortodossa versione psicoanalitica una seconda scrittura che più tardi
porterà a chiarezza teorica” (p. 52). Il cammino, ci dice l’Autrice, si delinea
attraverso l’idea husserliana dei nuclei eidetici operanti nella costituzione di
corpo e psiche, ed il concetto heideggeriano di “esistenza”, tutto questo per
delineare il mondo del malato e per porlo in relazione agli altri mondi Il senso
dell’umano emerge proprio attraverso questi confronti.
Le alterazioni patologiche presenti nei mondi dei malati –e così entriamo
nella descrizione della seconda immagine dei cerchi– rimandano alla costitu-
71
72
zione del “mondo” inteso, in senso husserliano, come quell’ampio territorio
interiore in cui si riflette tutta la realtà quoad nos, quasi monade leibniziana,
alla quale non a caso Husserl si riferisce. È il reciproco scambio fra i mondi che
rende possibile la comprensione reciproca e in particolare l’incontro fra il terapeuta e il paziente. Ed è proprio il tema dell’incontro che, nonostante il debito
di Binswanger nei confronti di Freud e di Heidegger, lo allontana da costoro:
“In Freud e in Heidegger l’angoscia resta il ‘fondo’ dell’uomo –benché in senso
diverso. Per Freud, la costituzione antropologica resta vincolata alla sostanza
indomabile del desiderio; Heidegger svela la ‘nullità dell’essere’ che parla nel
Gewissen”. Ciò che Binswanger in realtà cerca è “il potere o il dono di oltrepassarsi verso l’Altro” (p. 71). Ecco, allora, il suo riferirsi a Martin Buber, perché nel pensatore ebreo egli trova quella consonanza di vedute che lo conduce all’apertura in un duplice senso, orizzontale e verticale. La sfera più alta è,
in senso hegeliano il noi, la noità dell’esserci nell’amore (p. 196) di ciò Binswanger trova conferma in Rilke, e non si tratta di una conferma estrinseca,
ma di una conferma che viene dall’apporto decisivo che la poesia può dare,
come grande fonte disvelativa dell’interiorità umana.
A Delirio e poesia è dedicato forse il capitolo più avvincente del libro della
d’Ippolito. Qui è il ruolo dell’immaginazione che lega i due momenti, i quali
«Pure si allontanano l’una dall’altro come galassie nei silenzi cosmici» (p. 174).
L’immaginazione svincolata li accomuna come segno di libertà, ma nel delirio
avviene il terribile, nell’attimo che supera e blocca il possibile, che è invece
l’apertura poetica, e il terribile “spezza l’unità linguistica del mondo e dell’esserci” (p. 178). In tal modo si consuma, secondo Binswanger, il dramma della
malattia mentale. E il terribile corrisponde –per rimanere sempre nell’ambito
dell’espressione poetica– a ciò che Hofmannstahl chiama l’oppressione; in lui
“non ci si può fermare al ‘familiare’ semplicemente: il mondo è umano soltanto
nella polarità esistenziale tra il ‘familiare’ e l’oppressione. […] L’oppressione è
in questo senso vera passione, poiché in essa il dolore è intimamente legato
al demoniaco che ne è la cifra” (p. 86). Ed è questo che consente l’autentico
insorgere dello spirito, come slancio verso la libertà.
Non si tratta, pertanto, di qualche cosa di estraneo all’umano, ma di una
modalità, come mette bene in evidenza Bianca Maria d’Ippolito, terribile, sconvolgente l’eticità della conoscenza, la visione giusta e comune, modalità che
con la sua potenza può distruggere, mentre nella poesia tale potenza si manifesta nel suo aspetto creativo e liberatorio.
Siamo di fronte a livelli diversi ai quali può vivere l’essere umano; l’aver indicato tali livelli è stato storicamente il grande merito di Ludwig Binswanger dal
quale è nata una scuola chiamata dallo psicopatologo Danilo Cargnello, il suo
primo discepolo italiano, di “antropoanalisi” oppure, come è poi detta da Lorenzo Calvi e da Bruno Callieri, di “psicopatologia fenomenologica”. Il merito di
Bianca Maria d’Ippolito è quello di aver ricordato il grande maestro, ma al dilà
della sua figura, di aver posto in discussione attraverso di lui, le tematiche esistenziali più avvincenti al confine fra psichiatria, filosofia e poesia.
LA CATTEDRALE SOMMERSA.
Bianca Maria D’Ippolito legge Binswanger
Il volume di Bianca Maria D’Ippolito, “La cattedra sommersa”. Fenomenologia e psicopatologia in Ludwig Binswanger (Angeli, Milano 2004, pp. 240)
viene delineando una vera e propria fenomenologia binswangeriana con caratteristiche peculiari, emergenti tra Husserl e Heidegger; ma soprattutto con
l’evidente intenzione di delineare quella prospettiva che, con Max Scheler, si
potrebbe indicare come la “posizione dell’uomo nel cosmo”.
Emerge in primo piano la debita presa di distanza dal richiamo alla nosografia e ad ogni tentazione riduzionistica nosologizzante. Segue poi, a caratteri ben marcati, la prospettiva molto invitante del rapporto tra “visione d’essenza” (la nota Wesensschau) e immaginazione (Phantasie).
È noto, e l’Autrice ce lo ricorda energicamente, che Binswanger propose
con fermezza la possibilità di cogliere l’esperienza della follia come quella
peculiare modalità che comporta nella sua stranezza la possibilità e anzi la
realtà di un Altro (altrui) con il proprio diritto, a seconda della formazione dell’individuo o dell’ambiente culturale (p. 57).
Una notevole esplicitazione del concetto biswangeriano di spazio deve
essere riconosciuta alla D’Ippolito (p. 65) con il suo interessante richiamo al
termine Gemüt; parleri qui di spazio timico, ricordando quanto dice Binswanger nel capitolo sul problema dello spazio in psicopatologia (1955) in Per una
antropologia fenomenologica.
Va anche aggiunto che sono state preziose le pagine puntuali e chiarificanti sul non-sentirsi a casa-propria: quel che in Heidegger viene proposto come
il fenomeno più originario, e che Bianca Maria ritrova in Binswanger come
fenomeno dello spaesamento o dell’oppressione. Vorrei qui aggiungere che
l’unità della dimensione spaziale, come si coglie in Traum und Existenz e come
è stata ripresa da me nel mio Quando vince l’ombra (1982-2002), è un principio di “conformazione vivente” (la lebendiger Gelstaltung, a p. 95).
È per questo tramite che l’esperienza delirante viene sottratta alla sua categorizzata insensatezza, che ormai da tre decenni, con altri occhi, incontro sempre più raramente. Se il segno è aperto al senso (come dice Borgna in I conflitti del conoscere), allora il segno spezza il silenzio estraniato dalla biologizzazione ad oltranza, e si apre (non certamente per magia) alla trascendenza
mondana (si pensi all’Eraclito di Binswanger); e si apre anche al sogno (si
pensi a Traum un Existenz).
Il sogno, sottratto alla riduzioni fisiologiche e alla composizione freudiana
delle pulsioni, si sogno (dico) viene fatto accedere alla dignità della significazione (p. 161), anche se bisogna stare attenti all’eccedenza dell’interpretazio-
NOTE
di Bruno Callieri
73
74
ne, il che non vuol dire affatto tipizzare! Nel sogno risuonano più chiaramente
i segnali più lontani, le parole del sottosuolo, dell’implicito.
La legittimazione di diversi modi di “abitare” dell’uomo: è questo che viene
chiaramente ad esprimersi nelle pagine di Bianca Maria D’Ippolito, ove anche
ben si colga il limite delle ontologie husserliane per la poesia e per il delirio.
A tal proposito Bianca Maria riprende bene Dilthey (p. 174) e lo spessore,
in lui, della temporalità, ancor prima che in Binswanger. Temporalità che può
esplodere nell’attimo, nell’Augenblick di Kierkegaard, nell’ha!-Erlebnis di
Hagen: l’illuminazione improvvisa, il nascere al delirio (Grivois e Grosso), dove
il mondo è sempre al limite e dove “la naturalità della natura si rivela come uno
strato all’interno del mondo culturale” (p. 160) e dove, aggiungerei io, la coappartenenza al mondo slitta rapidamente nella distanza, con il rischio della
indifferenza e, per dirla con Filippo Costa, della circuitazione infinita di me con
me stesso.
Molto illuminante risulta (nella quarta parte del volume) il fatto dell’ordinamento dei dati, da intendere qui non più come sintomi di malattia ma come
aspetti fenomenologici. Il ritorno binswangeriano all’Esserci è il denso passaggio che egli compie dal 1922 al 1942, cui si collega, non proprio sottinteso, il
riconoscimento che “in Essere e Tempo non si trova l’antropologia” e che il
Dasein va inteso come presenza (Danilo Cargnello!) anziché come esserci.
È proprio qui che si pone, inequivoca e precisa, la critica che l’Autrice di
queste penetranti pagine muove sia a Binswanger che a Heidegger (cfr. p.
184). Ella mostra che, se la fenomenologia di Husserl tende a svelare, al di qua
della costruzione logico-teoretica, il mondo dei significati precategoriali, in Heidegger il mondo della quotidianità, familiare e noto, dissimula con azione
costante una zona di fondo dove sono indovati i problemi ultimi, dove c’è l’implesso dell’esistenza. E sotto questo profilo, sostiene la D’Ippolito, i due Filosofi sono più vicini di quanto entrambi credano. Debbo riconoscere che tanto
Danilo Cargnello quanto Ferruccio Giacanelli non avevano ben sottolineato
questo rilievo, che dobbiamo –è bene dirlo– a Bianca Maria. Costei invero (p.
189) riconosce a Binswanger un intuito preciso: il cogliere nel concetto di
esserci la sola possibilità di porre il problema dell’uomo nella psichiatria, cioè
di poter scorgere, ad un tempo, le strutture trascendentali (gli esistenziali) e la
storia dei singoli: il destino comune di ciò che è proprio mio.
Ontologia e antropologia, dice la D’Ippolito, si raggiungono e si toccano sul
sentiero dell’enigma, del nascosto, del coperto e della metafora. Il suo confronto di Binswanger con Heidegger attraversa la poesia di Rilke, la sua concezione dell’amore come mutuo, come ontologia del due.
Mi preme sottolineare che da queste pagine emerge in modo chiaro e persuasivo la prospettiva del mondo che ci si disvela fenomenologicamente non
come uno star-di-fronte oggettivo ma proprio all’interno dell’esser-nel-mondo
come situazione affettiva (la Befindlichkeit), come totalità affettiva (la Stimmung), come stato patico dell’umore (la Gestimmtheit). Qui appare essenziale
il patico, proprio nel senso di Aldo Masullo (il παϑη, Aristotele, libro II, Retorica), e lo spazio personale della Wirheit, il faktisch zwischen Ihnen, di Buber
–che è poi la polarità cuore-amore– e che quindi ripropone, in tutta la sua
NOTE
ambiguità, il rapporto di Buber con Heidegger, così come emerge dal suo scritto sul delirio (1941) e in Ilse (1945). Dove si apprezza sempre la l’ontologia di
Heidegger nel suo significato puramente filosofico, e si riconosce il sempre
maggior rilievo della dottrina della coscienza trascendentale di Husserl: l’insistere binswangeriano sulla necessità di leggere e rileggere le Ricerche logiche
e Le meditazioni cartesiane.
A ben rifletterci, dalla lettura attenta de La “cattedrale sommersa” ho tratto
due chiarimenti per me di gran pregio, anzi ne ho tratti tre: 1) l’epochè non è
né una sospensione di giudizio né un pregiudizio. Essa indica la necessità di
stare radicalmente aderenti ai vissuti concreti, rinunciando ai filtri dell’ideologia
e della scienza, filtri dai quali spesso è molto difficile separarsi. 2) L’esperienza dell’altro (come si sta facendo adesso nel programma del C.I.P.A. di Roma,
per i prossimi corsi) ci toglie gli occhiali specifici di ogni disciplina; mette in luce
evidente l’estraneità, il rischio, la scommessa esistenziale, e procede sempre
nella direzione che sottrae garanzie ma offre orizzonti. Ci dobbiamo liberare
dalla zavorra della volontà di potenza, dell’abuso dei saperi e strumenti convenzionali. 3) L’incontro terapeutico è una continua interazione.
Binswanger, in una nota lettera del novembre 1962 a Heidegger, riconosce
come Husserl gli tolse dagli occhi la cataratta naturalistica così egli, Heidegger, è riuscito a togliergli la cataratta idealistica. Ecco: mi pare che questo sia
stato pienamente inteso da Bianca Maria D’Ippolito. La sue pagine, come tante
altre sue, non finiscono di arricchirmi, di colmare quei vuoti di donazione di
senso (la Sinngebung) che, comunque intesi, illuminano di luce sempre nuova
la nostra quotidiana attività di psichiatri clinici.
Con un ardito salto teoretico, vorrei dire che il messaggio implicito in questa cattedrale ci sollecita ad accostarci al delirio e al sogno come ad autentici
organizzatori narrativi del non-senso o, meglio, organizzatori narratologici di
sensi altri, tra “profondità notturne” e “cime a picco sul mare” (Ibsen di Binswanger).
75
L’ORIZZONTE SIMBOLICO
E LA PSICOANALISI DELL’ARTE
SECONDO IL PENSIERO DI FRANCO FORNARI
di Franca Mazzei Maisetti
L’orizzonte simbolico
76
Il fenomeno della percezione e la conoscenza, in campo filosofico e psicoanalitico, non sono riferibili a cose “reali”. La conoscenza (anche scientifica) è
una delle prospettive create dall’uomo per costruirsi un universo col quale
instaurare un dialogo significante.
È per questo motivo che nasce il simbolo come organo del desiderio e del
pensiero e presupposto per cui si crea e si determina un contenuto rispetto ad
un conte- nitore.
Già con Leibniz (1948) e via via col procedere del pensiero contemporaneo
la realtà (oggetto) si struttura come risultato di un lavoro simbolico e i linguaggi umani “si rivelano altrettante modalità della umana intelligenza del mondo,
specificamente determinate e differenziate”(Cassirer, 1968, p.12).
Il linguaggio quindi è dentro l’individuo come “disposizionalità”. Nel sogno il
linguaggio notturno è una “messa in forma” del desiderio; esso attraverso i simboli onirici risolve la “rappresentazione di cose” in presenza confusiva e precostituisce gli elementi primari naturali da significare, con altri simboli (linguistici
ad es.) attraverso cioè significanti delle lingue storiche.
Scrive E. Cassirer:
Soltanto ciò che si dimostra essenziale per l’insieme del nostro vivere e del nostro
agire viene scelto e osservato.
Qualunque cosa appaia importante per il nostro desiderare e il nostro volere, per
le nostre esperienze e angosce, per agire e per fare, quello e soltanto quello riceve il timbro del significato verbale. Possiamo ritrovare la matrice unitaria dei processi di costruzione della realtà, in quanto l’itinerario maturativo di ordine cognitivo non viene disgiunto dall’itinerario psicoaffettivo
(Cassirer, 1968, p.38).
In alcuni tipi di linguaggio (amoroso, infantile, erotico…) che definiamo primari, la funzione linguistica si confonde con la funzione affettiva, in quanto
non c’è più una distinzione tra parole e cose (secondo le regole convenzionali del linguaggio); i due ordini di rappresentazione si confondono in quanto
“significazione” e “fruizione” coincidono. Di solito comunque per il linguaggio
intendiamo quell’insieme di simboli che costituiscono lo strumento più idoneo
ad una più libera e completa costituzione e definizione della realtà e alla comprensione del mondo interno dell’uomo e della specie. Parlando di realtà o di
mondo proprio ed altrui, non pensiamo naturalmente ad una realtà dogmaticamente affermata, ma a delle realtà così come ciascuno di noi riesce a con-
NOTE
quistarsele in base al travaglio simbolico della personale consapevolezza, e
alla capacità individuale di superare quella resistenza cognitiva determinata
dalla difficoltà di esteriorizzare il mondo interno ed interiorizzare il mondo
esterno. Stabilire cioè un armonico alternarsi circadiano dell’“ordine del giorno” e dell’“ordine della notte”.
Se da un verso quindi la lingua (come linguaggio primario, convenzionale o trasgressivo) è il luogo dell’inconscio e il terreno in cui opera la psicoanalisi, dall’altro la lingua (come linguaggio convenzionale “ostensivo”) è il
contenitore di una visione del mondo ed insieme un fattore che trasforma il
mondo.
La lingua è energia non rigidamente strutturata ma dinamica; lo studio della
funzione simbolica è alla base di qualsivoglia attività umana.
Simbolo linguistico e simbolo psicoanalitico
Nello sviluppo del pensiero occidentale, ad un certo punto ci si è posto l’interrogativo se l’impianto metafisico e quindi normativo della logica e dell’etica
potessero funzionare come criteri oggettivi di valutazione, oppure se era
necessario sganciare l’esperienza, la creatività e il linguaggio da norme precostituite.
L’insorgenza di una pluralità di modelli linguistici ed espressivi è insieme
causa ed effetto di una diversa configurazione di rapporto tra l’uomo e la realtà.
Cassirer dice:
Se la definizione, la determinazione dell’oggetto del conoscere può avvenire solo
attraverso la mediazione di una particolare struttura logico-concettuale, bisogna
accettare la conclusione che ad una diversità di questi mezzi debba corrispondere necessariamente anche una diversa disposizione dell’oggetto, un diverso significato di nessi oggettivi
(Cassirer, 1976).
Questo concetto fa pensare che l’uomo non può mettersi in comunicazione
con l’ambiente che lo circonda, se non attraverso degli strumenti, grazie ai
quali istituisce la sua realtà.
Emerge quindi la considerazione che la vita dell’uomo è modellata, in ogni
sua espressione, dai vari strumenti e dal loro uso, così come la psiche dell’individuo è condizionata anche dalle necessità imposte dall’ambiente. Il linguaggio diventa allora l’espressione viva di questa evoluzione e di questo disagio,
in quanto, per un verso si è progrediti verso un certo tipo di autonomia, dall’altro ci si è creata una rete di condizionamenti che hanno preso il posto di ciò
che prima costituiva la normativa (etica o estetica).
Analizzare il linguaggio allora non può esaurirsi in un lavoro grammaticale
od estetico quanto piuttosto esplicarsi in un esame approfondito dello stesso
nelle sue più intime connessioni con la vita, nella speranza di poter comprendere veramente il contenuto dello spirito umano.
77
Il contenuto dello spirito si dischiude solo nella sua estrinsecazione; la forma ideale si riconosce solo dal complesso e nel complesso dei simboli sensibili di cui essa
si serve per la sua espressione. Se si riuscisse a raggiungere una sistematica
visione d’insieme delle differenti tendenze di questo genere di espressioni, se si
riuscisse ad indicarne i tratti tipici generali, così come le particolari gradazioni e le
intrinseche differenze, sarebbe realizzato in tal maniera, per il complesso della
creazione spirituale, l’ideale della “caratteristica universale” che Leibniz proponeva per la conoscenza
(Cassirer, 1976, p.7).
78
Lasciando come compito specifico della filosofia, le risposte a questo desiderio, noi possiamo solo concentrare l’attenzione su quella caratteristica universale insita in ciascun linguaggio, cioè sulla funzione generativa del linguaggio, quindi sulla sua funzione simbolica a livello di elementi primari che sono
alla base di qualunque tipo di rapporto oggettuale.
La generatività, secondo N. Chomsky (1970), è un atto creativo che emerge nel passaggio dalla competenza alla performanza.
Ogni forma di creatività comunque, qualunque sia il terreno nel quale si
esplica, presuppone una serie di regole precostituite; e soltanto grazie alla prescrittività di un codice di regole precostituite, si può valutare il grado effettivo
della creatività.
La necessità di un codice-regola è insito filogeneticamente in ciascun essere vivente; nella vita dell’uomo il riconoscimento delle regole assume caratteristiche di importanza inconfutabile in quanto, essendo la vita stessa basata su
un principio dialettico di forze contrapposte, la mancanza di regole equivale
alla confusione e alla morte.
La creatività senza regole dunque è sinonimo di illusione, così come è illusione il concetto di vittoria senza quello di sconfitta o la possibilità di definire
una cosa senza il suo opposto.
Fondamentale è allora porre una prima distinzione tra simbolo onirico privato immaginario e confusivo (simbolizzazione onnipotente) e simbolo pubblico consensuale e distintivo, che appoggiandosi al reale, trova accesso ai codici simbolici.
La definizione di codice simbolico degli affetti nell’interno della comunicazione tra gli uomini, ha la funzione di scoprire e chiarificare i contenuti affettivi
dei propri ed altrui atti; mettere in luce cioè i segni che nella vita quotidiana,
l’uomo usa per mandare e ricevere messaggi tesi a soddisfare il comune bisogno di affetto1.
Con questa impostazione di lettura simbolica, si trasforma sostanzialmente
la concezione dello psicoanalista, come specialista della psiche “deviata” per
farne un “lettore” interprete della realtà e dell’umanità in tutte le sue manifestazioni.
L’immagine dello psicoanalista, specchio neutrale, poco credibile, di proiezioni immaginarie, che ha la funzione di scoprire la verità inconscia (o preconscia) lascia il posto allo psicoanalista che può, grazie alla sua preparazione specifica, porsi come “l’altro” dal paziente per permettergli di vivere e comprendere, nel gioco delle “identificazioni introiettive e proiettive” quale costruzione confusa e complessa abbia messo in piedi per difendersi da se stesso e dagli altri.
NOTE
Al momento in cui il vissuto emotivo ha libertà di esprimersi nel suo linguaggio confuso, segue il momento del passaggio, attraverso la decodificazione del
simbolo onirico e del coinema, dall’immaginario al reale, dall’ordine della notte
all’ordine del giorno.
La psicoanalisi acquisisce con ciò una “funzione semaforica” la quale “precostituisce all’interno dell’equiprobabilità anomica e confusiva del simbolo,
quali sono i codici simbolici che guidano il senso della comunicazione” (Fornari, 1976, p.16).
La funzione semaforica dice ancora Fornari, è una funzione dell’Io che
deve, col suo codice dirigere il traffico nella massa delle comunicazioni e nell’incontro-scontro tra il proprio desiderio e il desiderio degli altri, per evitare il
caos degli affetti e il sadomasochismo.
Nella “Pragmatica della comunicazione” Watzlawick (1971) definisce numerico il linguaggio verbale ed analogici i linguaggi non verbali. F. Fornari attribuisce ad ogni parola sia una componente numerica sia una componente analogica (che corrisponde al simbolo immaginario elaborato da Freud) dando per
assurda una arbitrarietà simbolica legata al linguaggio inteso come manifestazione di affetti.
Se è possibile accettare una arbitrarietà fonemica (e tale affermazione non
è sufficientemente dimostrata), non è possibile accettare una arbitrarietà di
simbolizzazione affettiva. Ogni organizzazione linguistica presuppone una
capacità di giudizio, ogni capacità di giudizio presuppone una capacità di
distinguere l’opposizionalità, il “buono” dal “cattivo”, il positivo dal negativo. Alla
base di questa capacità c’è l’esperienza vissuta di “presenza” e “assenza” e la
preconcezione di vita e di morte (Fornari F., Fornari B., 1974).
I linguaggi, espressione simbolica di contenuti affettivi, hanno da sempre
avuto la funzione di mettere in relazione topologica due mondi: uno interno e
uno esterno (propri od altrui) con l’intento di mettere dentro un altro o ricevere
dentro di sé qualcosa di buono oppure mettere dentro un altro o ricevere dentro di sé qualcosa di cattivo (i termini buono e cattivo non sono naturalmente
intesi in senso morale ma funzionale alla sopravvivenza).
Conoscere quale tipo di comunicazione abbiamo messo in atto, equivale a
conoscere la nostra parte più vera e profonda nella quale nascono e prosperano confusamente sogni, desideri, residui infantili, invidie, gelosie, aggressività. ecc.
Compito della psicoanalisi è “individuare la struttura genitale sinergica o la
struttura pregenitale antergica della comunicazione stessa” (Fornari, 1976). Essa
opera sia a livello di simbolizzazione privata, sia di simbolizzazione pubblica.
In questo senso la psicoanalisi oltre ad essere strumento di indagine e cura
del singolo, diventa chiave di lettura della cultura in genere, nell’interno della
quale si pone, e di se stessa.
Per “simbolo psicoanalitico” si intende generalmente “simbolo onirico”. Esso
viene definito universale, innato, preesistente a Freud che lo teorizzò come la
base affettiva immaginaria di ogni codice simbolico operativo. Il simbolo onirico,
scoperto attraverso il sogno, porta alla definizione del “processo primario” che
sta alla base di ogni “processo secondario” quindi di ogni linguaggio.
79
Attraverso la confusività dei simboli onirici, depositari anche delle verità
inconsce di ciascuno, si arriva alla chiarezza definitoria dei simboli operativi2.
80
Sono quindi i simboli affettivi analogici a permettere la formazione dei simboli operativi numerici (La chiusura totale al mondo degli affetti degli psicotici,
impedisce la formazione del linguaggio sintattico, basato su simboli convenzionali operativi).
I codici simbolici si fondano su stati del mondo già strutturati affettivamente
e qualunque conoscenza scientifica affonda le sue radici nel simbolo immaginario. La conflittualità tra la conoscenza scientifica e la psicoanalisi consiste
nel non aver mai potuto inserire in categorie logiche il simbolo onirico, in quanto esso è un modo di simbolizzare non a livello cognitivo ma a livello affettivo.
Il simbolo onirico è la radice sotterranea sulla quale cresce l’albero della
conoscenza, attraverso il processo secondario.
Il linguaggio notturno delle immagini oniriche, le cui caratteristiche di condensazione e spostamento rendono confusivo, contiene in sé la matrice naturale dei segni distintivi del linguaggio diurno come “simbolo presimbolico”.
Si definisce abitualmente discorso adulto e maturo sia il discorso sintatticamente esatto, sia contenutisticamente ricco, sia formalmente accettabile. Al di
là di questi inconfutabili requisiti che fanno capo a codici simbolici resi validi da
un consenso istituzionalizzato, una lingua intesa come mezzo di interrelazione
deve, per comunicare, fondarsi sulla consensualità intersoggettiva o reciprocità simmetrica. Cioè è necessario che due esseri umani si pongano come due
soggetti con proprie paritetiche capacità decisionali perché il codice simbolico
usato sia lo stesso.
Definiamo tale codice: Codice dell’Io o Codice Genitale (contrapposto a
pregenitale) (es. comunicazione scientifica).
Quando la comunicazione tende a soddisfare un bisogno (affettivo) proprio
o altrui, accade che il rapporto tra le parti non è più paritetico, a livello di codice simbolico, cambiano i ruoli, in quanto la parola oltre ad essere intesa nella
sua funzione di significazione, può esser vista a livello confusivo di simbolo coinemico, espressione di un codice affettivo (genitore-figlio, maestro-discepolo,
analista-paziente). Nel discorso quotidiano alternativamente ciascuno di noi
vive questa realtà del bisogno inconscio.
Il discorso quotidiano umano è polimorfo, la semiologia legata alla comunicazione interessa indifferentemente qualunque tipo di espressione l’uomo
abbia scelto per mettere dentro gli altri qualcosa di sé, e dentro di sé qualcosa degli altri (Fornari, 1979b).
Psicoanalisi dell’arte
Nella sua proposta di psicoanalisi dell’arte F. Fornari parte da un modello
semiotico e pone un problema anzitutto di ordine linguistico. Ridefinisce
appunto il rapporto significante-significato e allarga i confini delle teorie lingui-
Ogni discorso umano, dice Fornari, qualunque sia la modalità espressiva,
presenta un duplice statuto: lessicale-operativo e affettivo-coinemico. Il primo
si basa sull’arbitrarietà del segno, il secondo si rifà alla struttura dell’inconscio
ed è soggetto al codice affettivo.
Relativamente all’arbitrarietà del segno, Fornari rifacendosi a Jakobson
afferma che il rapporto tra significante e significato che Saussure chiamava
“arbitrario” dipende da una “continguità abitudinaria appresa, che è obbligata
per tutti i membri della comunità linguistica data” (Jakobson, 1978).
In questa prospettiva il coinema diventa un codice di organizzazione e struttura di funzionamento di ogni testo.
Il linguaggio come ogni altra istituzione sociale, presuppone delle funzioni mentali operanti a livello inconscio
(Lévi Strauss, 1978)
Fornari riprendendo la scoperta freudiana della tendenza umana a riprodurre nel sogno esperienze penose (coazione a ripetere), sgancia tale meccanismo dall’istinto di morte ipotizzato da Freud e ne fa una “tendenza primaria a
rappresentare qualcosa per mezzo di segni […] riprodurre sotto forma di rappresentazione tutto ciò che è presente è poi diventato assente” (Fornari,
1979a).
Il linguaggio artistico trasforma la presenza in rappresentazione attraverso
un processo singolarissimo collocabile in una zona intermedia tra immaginario
e reale, “a metà strada tra il principio del piacere e il principio della realtà in
quanto l’esame di realtà (che permetterebbe di collocare l’esperienza nell’uno
o nell’altro dei due principi) non è negato (come avviene ad esempio nell’allucinazione) ma semplicemente lasciato sospeso” (Fornari, 1970).
NOTE
stiche moderne grazie al concetto di arbitrarietà del segno. Fornari si occupa
di psicoanalisi dell’arte prima ancora di formalizzare concettualmente l’analisi
coinemica3.
Scrive nel 1974 “Psicoanalisi e ricerca letteraria” insieme alla moglie Bianca (Fornari F., Fornari B., 1974). Propone nel 1978 con “Strutture affettive del
significato” (Fornari, 1978) un modello di critica e un’applicazione a “Agostino”
di Moravia.
Nel 1979 con “Coinema e Icona” (Fornari, 1979a) formalizza una nuova
proposta di psicoanalisi dell’arte figurativa, mentre nel 1984, già in ambito della
teoria dei codici affettivi, scrive “Psicoanalisi della musica” (Fornari, 1984). Nei
primi scritti di analisi letteraria, il modello risente ancora molto dei concetti freudiani classici. L’“Agostino” di Moravia e, ancor meglio il saggio sulla “Monarchia” di Dante sono influenzati dal pensiero kleiniano, ma metodologicamente
risentono dei concetti freudiani come l’edipo e la scena primaria. Finalmente
nel “Miracolo delle noci” è applicata la teoria coinemica che “parte dal presupposto di costituire la verità a partire dalla consonanza o dalla dissonanza
semantica che il confronto tra la simbolizzazione affettiva e la simbolizzazione
operativa di un enunciato mette in grado di rivelare” (Fornari, 1978).
81
Nell’ambito di approccio e interpretazione al testo letterario o iconografico,
Fornari individua uno spazio tridimensionale comprendente un “referente figurale” (il testo in sé) un “referente coinemico” e un “referente storico”. Senza il
referente coinemico non sembra possibile scendere nelle profondità dei significati; gli altri referenti si prestano ad una lettura bidimensionale pur essendo
fondamentali contenitori e denotatori di senso per i referenti coinemici confusi
e indeterminati […]. Il testo letterario o iconografico viene esaminato secondo
unità significanti: le formule, le sequenze, gli elementi figurali, le figure plastiche, i soggetti, gli argomenti.
Dai significanti della scena manifesta che queste unità denotano, si ha una
possibile traduzione in significati coinemici, in una struttura affettiva di significati, “metastorica” e “invariante” (Biotti, 1987).
L’arte per Fornari è quell’attività che:
si muove nella notte ed entra nella luce del giorno per ritornare alla notte, in una marcia a delfino tra mondo interno e mondo esterno, che fa del linguaggio notturno e del
linguaggio diurno non due facce di una stessa medaglia, ma un continuo succedersi di un gioco “a testa e croce” in cui una faccia si presenta quando l’altra si nasconde, diventando ognuna delle due alternativamente significante e significata
(Fornari, 1979a)
82
Il passaggio da un mondo ad un altro mondo è dato da quell’equilibrio dinamico che in altri termini può essere espresso come armonia tra forma e contenuto oppure tra discorso manifesto e significato latente tra inconscio e conscio
tra principio del piacere e principio di realtà, linguaggio ed anti-linguaggio”
secondo uno statuto doppio: “metonimico e metaforico”.
Il linguaggio della notte e il linguaggio del giorno trovano nell’espressione
artistica una traduzione; in essa l’uno e l’altro sono compresi in una interazione perfetta che “consente il processo di simbolizzazione, trasformando la presenza in rappresentazione”, in questo senso l’opera d’arte è a metà tra immaginario e reale in quello che Winnicot chiama campo o “area transizionale”.
L’opera d’arte allora è un oggetto concreto vestito con abiti fantastici, è una
cosa reale che contiene in sé anche l’irreale ed è in quest’alternarsi che la
struttura linguistica si rivela come fattore determinante.
Tale area transizionale che si presenta come “il terreno favorevole” perché
l’arte alberghi, accoglie in sé qualunque forma d’arte, dalla pittura alla letteratura, al teatro, al cinema, alla musica.
Lotman in Semiotica e Cultura dice relativamente all’opera d’arte: “So che
questo non è ciò che rappresenta ma nello stesso tempo vedo chiaramente
che questo è proprio ciò che essa rappresenta” (Lotman, Uspensky, 1975).
Fornari ha detto dell’arte “essa è sospesa tra lo Scilla del bisogno di sapere e il Cariddi della proibizione di sapere”.
È dunque nel bisogno-desiderio di sapere e nella proibizione del sapere che
si struttura quell’ambiguità che caratterizza la modalità espressiva dell’artista.
In chiave psicoanalitica diremmo che ‘la simbolizzazione secondaria (il
significante) deve insieme rivelare e tenere nascosto ciò che viene rivelato cioè
la simbolizzazione primaria (significato).
Io mi sono sempre trattenuto al pianterreno dell’edificio: Lei afferma che se si cambia punto di vista, si riesce a vedere anche il piano superiore, nel quale abitano
ospiti così distinti come la religione, l’arte e altri ancora […] In questo Lei è conservatore, io rivoluzionario. Se avessi ancora una vita di lavoro davanti a me, oserei indicare a queste “illustrissime” un posticino nella mia bassa casetta
(Lombardo, Fiorelli, 1985).
Binswanger tentava di far entrare la psicoanalisi nella sfera della spiritualità in una visione esistenzialistica. Ma nella realtà Freud non aveva mai disdegnato l’arte, e nella sua cultura di notevole vastità, le scienze “dello spirito” avevano avuto una larga parte.
Nel discorso in occasione del conferimento del premio Göethe, egli dice:
NOTE
S. Freud non ha indagato a lungo su questo problema. Nel 1936 scriveva a
L. Binswanger:
I poeti sono i pochi cui sia concesso, quasi senza sforzo, di salvare dal gorgo delle
loro emozioni le più profonde verità verso cui noi altri dobbiamo dirigerci con fatica, annaspando incessantemente in mezzo a incertezze torturanti
(Freud, 1930).
E in Delirio e sogni nella Gradiva di W. Jensen ancora:
Probabilmente, noi e lui (Freud e il poeta) attingiamo alle stesse fonti, lavoriamo
sopra lo stesso oggetto, ciascuno di noi con metodo diverso; e la coincidenza dei
risultati sembra costituire una garanzia che abbiamo entrambi lavorato in modo
corretto. Così egli (il poeta) esperimenta in sé quanto noi abbiamo appreso da altri,
e cioè le leggi a cui deve sottostare l’attività di questo inconscio
(Freud, 1906)
L’aver strutturato all’interno di schemi e modelli di comportamento ogni processo della mente, può considerarsi come un tentativo di fondere le scienze
dello spirito con le sue caratteristiche di inconoscibilità, inclassificabilità e
mistero, con le scienze della natura, solide, misurabili e scientifiche, salvando
comunque la singolarità di ogni espressione artistica e la creatività individuale.
Nell’Introduzione alla Psicoanalisi (Freud, 1915) in un parallelismo tra psicoanalisi e marxismo egli dice che così come il pensiero di Marx ha messo in
luce l’esistenza di forze economiche che sono “alle spalle degli uomini” e li condizionano, così la psicoanalisi ha messo in luce l’esistenza di forze psichiche
che agiscono al di fuori di ogni consapevole volontà.
Quanto la conoscenza dell’universo dell’Arte abbia influito sul suo processo di pensiero emerge in diversi suoi accenni: “I poeti e i filosofi hanno scoperto l’inconscio prima di me; quel che ho scoperto io è il metodo scientifico che
consente lo studio dell’inconscio” egli scrive nel “Discorso in occasione del suo
70° compleanno”(Freud, 1926) ed è evidente che concetti come: complesso di
Edipo, sadismo, masochismo, narcisismo, nascono in area letteraria e mitologica prima che in psicoanalisi.
Proprio questa psicoanalisi tra “romanzo” e “scienza” è alla base di quella
dicotomia e conflittualità che, partendo dall’epoca di Freud, si trascina fino ai
nostri giorni.
83
Nel 1900 con la Traumdeutung, Freud ci introduce nel fantastico mondo
dell’inconscio. Il linguaggio cifrato del sogno diventa il risultato della “deprivatizzazione del linguaggio pubblico”.
Stabilisce con ciò una netta differenziazione tra il linguaggio dell’inconscio
e il linguaggio della poesia. Mentre quest’ultima tende a rivelare quanto è
inconscio attraverso la parola-simbolo (anche se ermetica), il sogno tende a
nascondere, attraverso la parola quanto è inconscio. Nella verbalizzazione del
sogno la parola privatizza il linguaggio pubblico, nella poesia pubblicizza il linguaggio privato. Ogni sogno racchiude in sé tutto l’universo del sognatore e,
l’interpretazione analitica può solo esaurire una faccia del poliedro, lasciando
la possibilità ad altre molteplici interpretazioni.
Anche l’opera d’arte è contenitore di tutto un mondo, quello dell’artista, conscio e inconscio. Davanti a tanta “vastità” Freud si blocca e in Dostoevskij e il
parricidio (Freud, 1927) si dichiara impotente a penetrare nel nucleo della creazione artistica.
Affronta comunque gli aspetti psicologici, storici, sociali che stanno alla base
di ogni produzione artistica e definisce l’Arte come “un ritorno del rimosso” istituzionalizzato e socialmente accettato. Egli attribuisce una funzione benefica
all’opera d’arte, strumento di catarsi e veicolo positivo di desideri e pulsioni che
altrimenti potrebbero manifestarsi in forma disgregante e distruttiva.
84
Se la civiltà impone continue rinunce alla soddisfazione delle pulsioni
secondo un “principio di realtà”, l’arte fornisce un’area di rivincita della fantasia, secondo il “principio del piacere”.
L’arte allora come contrapposta alla vita, Arte come frutto del recupero delle
forze inconsce e rimosse, e, attraverso la “sublimazione” espresse in comunicazione formale.
Il piacere derivato dalla fruizione dell’Arte per Freud è una “promessa di felicità” ma non è chiaro quanto appartenga al mondo delle illusioni piuttosto che
a quello della realtà.
Soltanto in un campo si è conservata l’onnipotenza del pensiero fino ai nostri giorni: in quello dell’arte. Nell’arte soltanto avviene ancora che un uomo ignorato dai
desideri, elabori un’azione che assomigli all’appagamento e che questo gioco, in
grazia dell’illusione artistica, provochi delle risonanze affettive come se si trattasse di cosa reale. A ragione si parla dell’incantesimo dell’arte e si confronta l’artista
con l’incantatore.
Tale confronto è forse più importante di quanto esso vorrebbe essere. L’arte, che
certamente non è cominciata quale arte per arte, stava originariamente al servizio
di tendenze che oggi sono in gran parte cessate. Tra queste è lecito ammettere
che vi si trovino parecchie intensioni magiche
(Freud, 1917)
Donde venga all’artista la sua capacità creativa non è problema della psicologia –ma dice anche– la psicoanalisi riconosce anche all’esercizio dell’arte
una attività che si propone di temperare desideri irrisolti, e precisamente in
primo luogo nello stesso artista creatore e in seguito nell’ascoltatore e nello
spettatore (Freud, 1969).
una volta entrato nel contesto del quadro, acquista senso in base al fatto che non
parla più in funzione di se stesso, ma viene parlato dalla sintassi dei significante,
cioè dalla relazione tra le figure del quadro.
Se al posto di natura mettiamo il linguaggio coinemico come linguaggio naturale e
al posto di humanitas mettiamo i linguaggi culturali, siano essi verbali o iconici, si
può dire che la “poesia” cioè la comunicazione estetica, nasce da una elaborazione profonda e vitale, di un dramma che si colloca all’interno di questi linguaggi. Le
emozioni sono un fatto naturale. Il trasformare le emozioni umane in emozioni
estetiche richiede un particolare tipo di relazione tra linguaggio coinemico naturale e linguaggi artistici culturali
(Fornari, 1979a).
Il teatro e il mito
La funzione attribuita allo spettacolo del teatro presso gli antichi greci è indicativa di come naturalmente le antiche civiltà ricorressero a quanto era in loro
potere per mantenere un equilibrio psicologico nella polis. La tragedia greca è
da intendersi come fenomeno collettivo. religioso e catartico, quasi un prototipo di gruppo terapeutico.
Gli spettatori riuniti nel recinto sacro di Dioniso, sulle pendici dell’Acropoli
partecipavano ad un rito e di questa funzione ne erano consapevoli quanto gli
attori e gli autori.
Levi Strauss dice che la materia della tragedia è sempre costituita da un
mito, il quale si pone come presa di coscienza di certe opposizioni e tende alla
loro progressiva mediazione.
NOTE
Il collegamento che Freud fa tra Arte e Desiderio è alla base della elaborazione del discorso sull’arte che fa Fornari; da questa impostazione data al
fenomeno artistico come funzione degli accoppiamenti (nella fruizione dell’oggetto artistico) dei desideri, l’un l’altro ricercantesi, del creatore e del fruitore di
arte, nascerebbe pertanto una metodologia di ricerca sincronica e diacronica
(Fornari, 1966).
La psicoanalisi può diventare uno strumento di indagine estetica se viene
utilizzata come chiave di lettura della interrelazione degli elementi linguistici
(consci e inconsci) e della trasformazione che essi subiscono.
L’artista dal “mare magnum” della significatività indistinta delle relazioni coinemiche, dove alberga il desiderio informe, emerge in un gioco a delfino, nel
mondo esterno, dando forma al desiderio e denotandolo. Il fatto che la sintassi dei coinemi non sia legata alla esperienza storica, ma decisa dall’ordine
significante creato dall’artista (sintassi dei significanti iconici) porta ad una
organizzazione della vita emotiva.
Per cui se le emozioni incontrollate portano l’uomo alla sofferenza e alla
percezione dolorosa della “mancanza”, l’esperienza artistica permette che le
emozioni trovino spazio per esprimersi grazie al controllo dato sia dall’ordine
del processo culturale estetico, sia dalla possibilità di “mettere a confronto” i
significati primari con i significati storici.
Il coinema (rappresentazione psichica della pulsione)
85
86
È molto importante che la tragedia abbia come materia un mito.
Erodoto racconta che il tragico Frinico fu punito e multato perché, mettendo in scena un fatto di vita contemporanea, la battaglia di Mileto, aveva prodotto il panico e la disperazione nel pubblico.
Fatti ben più gravi propongono tragedie come la trilogia dell’Edipo e dell’Orestea o altre ancora, ma il popolo anche se fortemente coinvolto, non ne
era destrutturato. Perché? Perché il teatro per il greco era vita dell’umanità,
non biografia e l’uomo antico come il bambino non attua una distinzione tra
questi due piani.
Quindi la posizione dei greci verso lo spettacolo tragico non era mai critica.
La tragedia è un’esperienza insita nella storia dell’umanità, la gente riunita partecipa ad un’esperienza concreta. Nella stessa maniera in cui in uno psicodramma, la gente riunita in gruppo, ripropone nella specificità del problema
personale, l’universalità di temi esistenziali, comuni all’umanità.
All’origine della tragedia c’era la musica, il coro dei Satiri. Nella melodia
l’uomo si fonde con gli altri. Il divino entrava nel mondo dell’uomo con aspetti
e caratteristiche terrene, e gli permetteva di proiettarsi in lui, identificarsi con
lui, aspirare alla stessa eternità in una fusione con la natura non più intesa
come madre castrante e crudele ma accettante e benevola. Nel suo interno
l’individuo singolo andava alla ricerca di una individualità unica nella quale
potersi rispecchiare, perseguendo, singolarmente, una legge uguale per tutti:
“conosci te stesso”.
Se indichiamo nella natura il dionisiaco e nell’individuo l’apollineo possiamo
capire come nella fusione dionisiaca (pulsione naturale, ritorno regressivo
all’Eden originario o all’utero materno) l’uomo soffra la paura della disintegrazione data dall’indefinito ma ne abbia anche estremamente bisogno perché
solo da essa può trarre la spinta per l’individuazione.
Si è stabilita nel 534 l’origine della tragedia per opera di Tespi, nella realtà
la prima tragedia si ebbe quando un uomo rivestì l’identità di un personaggio
del passato e trascinò dietro di sé un coro proponendosi come protagonista di
una nuova realtà.
Questo importante momento costituisce la fase di passaggio da una dimensione fantastica ad una dimensione simbolica oltre che segnare il passaggio
dalla danza e la musica alla parola ed all’azione. Alla musica diamo il significato di impulso, energia, libido. Alla parola il significato di simbolo, immagine, illusione. La musica quindi rappresenta il desiderio (universale), alla parola diamo
il significato di volontà (particolare).
Dalla musica quindi il mito che parla per simboli della conoscenza dionisiaca.
È importante quindi la funzione della parola nella tragedia come importante è la
differenza tra la tragedia ed i vari rituali mimici di identificazione che da sempre
l’umanità ha messo in atto e sono ancora presenti in alcuni popoli primitivi.
Altrettanto importante il passaggio tra il raccontato ed il recitato, in quanto
abbiamo una fusione temporale tra passato (raccontato) e presente (agito).
Gli attori nella tragedia greca recitavano, il coro cantava accompagnandosi
con passi di danza. La funzione del coro era quella di costituire “un muro vivo
contro l’assalto della realtà” (Schiller). Quale realtà? Quella profonda arcaica
NOTE
che le gesta e le parole dell’attore e la realtà scenica presentavano o la loro di
spettatori-attori? Analizziamo per un attimo la forma del Teatro, circolare, e
pensiamo all’associazione che tale forma suggerisce. Seduti sui gradini gli
spettatori riempivano lo spazio intorno all’orchestra che in quel momento costituiva l’ombelico del mondo e osmoticamente vivevano le emozioni relative alle
azioni che venivano rappresentate, quasi uniti da un cordone ombelicale. Nel
coro dell’orchestra il pubblico proiettivamente ritrovava se stesso; nel coro
c’era lo spettatore ideale, l’unico spettatore, ognuno, dominando dall’alto del
suo posto, contemplava se stesso come coreuta.
Per questo il coro è più antico dell’azione teatrale vera e propria. Perché
esso rappresenta l’uomo e la massa, la forza dionisiaca che nel mondo apollineo delle immagini, scarica le sue tensioni e pian piano si evolve. Se lo spettatore si identificasse nell’attore, potrebbe avere la liberazione nell’illusione,
mentre spezzandosi come individuo ed unificandosi con l’essere originario,
attuava una catarsi vera, molto più profonda, in quanto entrava in contatto con
le sue parti più arcaiche.
È come se il coro, unica realtà, producesse fuori di sé la visione e parlasse
di essa e su di essa con tutto il simbolismo della danza, del suono e della parola (Nietsche, 1977).
È una sorta di incantesimo; lo spettatore diventava Satiro e guardava fuori di
sé quella visione che era il compimento apollineo del proprio stato dionisiaco.
Attraverso l’azione dell’attore, l’uomo cominciava il lungo percorso della sua
individuazione, in maniera naturale, semplice e piana, anche se sofferta. Il linguaggio in Eschilo e Sofocle ha parole chiare i periodi sono semplici. Il lamento è quello di un bambino che direttamente si rivolge a dio-padre o invoca l’aiuto della madre.
L’immagine del coro greco riporta alla situazione terapeutica dei “gruppi” di
lavoro. Il gruppo, e come luogo d’incontro, e come entità a se stante, ripropone un alveo di protezione, un grembo materno nell’interno del quale è possibile sia ritrovare tracce di vissuto arcaico, sia vivere o rivivere simbolicamente
momenti nodali dell’esistenza. La sofferenza dell’umanità affonda le sue radici
in situazioni sempre uguali e sempre nuove: la separazione dalla madre, la
paura della morte, il problema edipico, il porsi come individuo nei confronti di
se stesso e dell’altro.
Da quando l’uomo visse il cataclisma della nascita, uscendo dal ventre della
madre, la morte connessa con la vita, divenne una situazione insieme desiderata e paventata. Da una parte la madre ha desiderato trattenere il figlio nel
suo ventre (per paura di uccidere o di morire) dall’altra, l’atto dell’inevitabile
espulsione è stata per tutti, sofferenza, squarcio, rottura, pericolo di morte.
Sempre rimarrà nella madre il desiderio del proprio figlio, sempre nel figlio
rimarrà la nostalgia del paradiso perduto.
Ogni esperienza di vita porterà in sé un “ricordo” e una nostalgia.
Noi ben sappiamo come in ogni innamoramento, si riproponga a livello
inconscio una situazione già vissuta di onnipotenza e di dipendenza, come
conflittuale e sofferta sia sempre questa rinnovellata simbiosi e come ci sia
bisogno che definitivamente venga risolta. Il cordone ombelicale non si taglia
87
88
mai una sola volta; continuerà a rinascere fino a che non avviene la fusione
interiore tra le due immagini di donna e di madre e non verrà accettata la figura del padre.
Il momento terapeutico è un momento esperenziale importantissimo,
durante il quale l’uomo si incontra, si riconosce e nella metafora del gesto e
della parola, si riappropria di quanto, dentro di lui, a lui stesso era nascosto.
Nella tragedia di Edipo, Colono rappresenta il ritorno dalla vecchiaia all’infanzia, la rielaborazione, attraverso la ricostruzione, il ritorno verso il ventre
della madre, ventre più accogliente che rappresenta sia la morte che la nascita di Edipo. La morte di Edipo, secondo la leggenda, avverrà per spalancamento della terra; è la reinfetazione in un grembo universale. Per potersi liberare
Edipo ha ripercorso la sua strada fino alla nascita ed è solo a Colono, nel
bosco delle Eumenidi che la tragedia si definisce. Edipo ha spezzato le leggi
morali, ha infranto l’ordine del presente e del futuro, ha sperimentato la dissoluzione della natura anche su se stesso e proprio grazie a questa trasgressione è emerso individuo.
È la legge dell’individuazione, il vero incantesimo della natura, come dice
Nietsche (op. cit.), già verificata in precedenza come causa.
Ritornando nel mito, incontriamo l’uomo che sfida i Titani, si conquista da sé
la propria identità perché tutta l’esistenza ed i limiti di essa li ha dentro di sé.
Prometeo, nel perseguire la giustizia contro gli stessi dei, misere proiezioni
questa volta di invidie e gelosie, emerge come individuo sconfinatamente dolorante ma creatore di uomini. E se il mito con Edipo ci dà l’ineluttabilità della sofferenza, con Prometeo ci dà la potenza, la speranza, il fuoco del desiderio ma
anche della purificazione. In esso c’è la presenza dell’elemento divino e dell’elemento umano fusi insieme (il fuoco viene rubato agli dei).
Il desiderio dell’uomo di vincere la morte, di travalicare l’umano, essere
l’unica essenza del mondo, provoca in lui sofferenza e contraddizione, ma non
può farne a meno perché proprio questo fa di lui un uomo.
Göethe dice che ogni tragicità è fondata su un conflitto inconciliabile e che
se interviene o diventa possibile una conciliazione, il tragico scompare. Per
l’uomo inconciliabile è il conflitto tra libertà e necessità, tra l’azione in vista di
un fine e le forze che ne impediscono il raggiungimento (siano esse metafisiche, storiche o psicologiche).
La tragedia è un esempio di come si può prendere coscienza di tale conflitto e di come, attraverso la forma artistica si possa esorcizzare il sentimento
della frustrazione. Oggettivare, proiettare fuori di sé l’arcano, rende più accettabile l’impotenza, che diventa non più l’impotenza dell’uomo ma caratteristica
del vivere umano.
L’eroe tragico assumeva su di sé la responsabilità della propria condizione.
Edipo si è misurato col proprio destino. La legge suprema imposta dagli dei era
ed è il libero arbitrio. Nell’“Edipo a Colono” alla fine trionfa l’uomo, dopo aver
sperimentato la propria impotenza, aver messo a repentaglio la propria volontà, aver sofferto il disagio enorme della sua fragilità di fronte all’ignoto. Se il
dolore e l’angoscia avviliscono, la catarsi risana.
La morte per il greco non aveva il significato che noi le attribuiamo. La peste
Il teatro e l’elaborazione della morte (da Fornari, 1979a)
Il teatro è mimesi simultanea del sonno, del sogno e della veglia. Le relazioni che legano attori e spettatori sono funzioni motorie e produttrici di sogni
per gli attori e funzioni percettive e ricettive di segni per gli spettatori. Insieme
costituiscono una coppia oppositiva e complementare che ha la “funzione di
significare la dissociazione tra motilità e sensorialità specifica del sonno”.
La scena teatrica è come la scena di un sogno rappresentato dagli attori che
agiscono i fantasmi degli spettatori metaforicamente addormentati. In tal sonno
il teatro è “un’istituzione circadiana” che racchiude in sé il sonno (la notte) e la
veglia (il giorno) ed è insieme presenza e sua rappresentazione; si può perciò
paragonare al sogno nel quale l’onnipotenza del desiderio porta il segno onirico
a coincidere confusivamente con la presenza di ciò che significa.
L’elemento che contraddistingue il teatro dal sogno è che nel teatro si può rappresentare l’angoscia o qualunque altro “affetto” senza esserne mai catturati.
“Instaurando la specificità di una produzione segnica che implica la simultaneità della presenza e della rappresentazione” il teatro rende possibile la fruizione del sogno e del risveglio contemporaneamente, trasformando a volontà
la rappresentazione in presenza e viceversa.
NOTE
non è la morte che rimuoviamo per vederla nostro malgrado ritornare; la peste
era qualcosa di sempre presente per il greco sia nella struttura simbolica che
nella struttura reale. Questa morte che compare nella relazione analitica reificata nel silenzio come luogo dell’altro è testimonianza di verità delle due sole
relazioni che l’inconscio contiene: la nascita e la morte.
Nell’esperienza analitica è possibile la reinfetazione simbolica, il ritorno alla
fase preedipica, il ricupero narcisistico dell’onnipotenza. Solo nello sporgersi
pericoloso dell’analista nei confronti del paziente, nel suo reinvestirsi, nel suo
coinvolgersi affettivamente, nel suo accettare di nuovo il disastro, la catastrofe
della nascita che vi è la possibilità che l’Io distrutto, l’Io annichilito, l’Io preedipico del paziente superi l’annichilimento di una perduta onnipotenza. È nella
stanza dell’analisi in quella posizione regredita e spesso fetale sul lettino o
sulla poltrona che il paziente sofferente incontrerà l’Io dell’analista che con la
sua maieutica tenderà una mano al nascituro per introdurlo al mondo degli
uomini.
È solo da questa tragedia analitica (Bion) nasce l’Io; da una parte il paziente rischia l’afanisi, l’annichilimento, il suicidio; dall’altra la persona dell’analista,
coinvolto affettivamente ed emotivamente con l’Io del paziente, restituisce la
gioiosa voglia di ritornare alla vita. È in un rapporto sano con la madre e nel
riconoscimento del desiderio del padre che avviene l’identità; il codice materno si è fuso col codice paterno, c’è la pace fra l’Io e il suo ideale. Può l’uomo
finalmente consentirsi quei rapporti affettivi che gli garantiscono e gli consentono di essere in ogni situazione padre e madre nei confronti di se stesso e
degli altri e di comunicare affettivamente ciò che del padre e della madre ha
introiettato.
89
Nel teatro l’attore è una persona che rappresenta un personaggio, lo presentifica ma contemporaneamente ne nega la presenza. Ciò che viene rappresentato diventa sogno collettivo e pertanto pubblico e come tale serve a scongiurare gli incubi privati.
Da quando Freud ha scoperto che la vicenda di Edipo non è un misfatto ma
una regolarità “notturna” delle vicende affettive umane, il teatro mostra che le
società umane si sono preoccupate di rappresentare attraverso incubi collettivi, funzionalmente ed esteticamente controllati, il terrore degli incubi privati.
Parallelamente alla relazione tra presenza e rappresentazione, il teatro porta il
discorso sulla relazione tra l’essere e l’apparire, tra persona cioè e personaggio, tra rappresentante e rappresentato. L’apparire senza essere nel teatro
come nell’incubo svolge la funzione di elaborazione del lutto attraverso la possibilità per entrambi di produrre segni capaci di evocare la morte e contemporaneamente farla evolvere dalla presenza alla rappresentazione.
90
1 Comprendiamo nella sfera degli affetti anche l’odio, l’aggressività e ogni manifestazione relativa alla sfera dell’intersoggettività.
2 Cfr. il Cratilo di Platone, relativamente al problema dell’origine della lingua “culturale” o
“naturale”.
3 Teoria Coinemica = Teoria psicoanalitica del linguaggio, basata sulla semiosi affettiva.
Analisi Coinemica = Analisi del linguaggio basata sulla semiosi affettiva. Nata come analisi del
testo scritto, è stata in seguito utilizzata come analisi di qualunque forma di linguaggio verbale e
non verbale.
Coinema (dal greco Κοινοσ = comune) = neologismo coniato da F. Fornari per indicare l’unità elementare di base del significato affettivo. I coinemi, come significati comuni di svariati significanti, sono invarianti e innati; corrispondono a pre-oggetti elementari della vita affettiva e sono alla
base di ogni linguaggio umano. Corrispondono ai denotati simbolici del sogno e cioè: madre,
padre, bambino, fratello (relazioni di parentela) organi sessuali (corpo erotico) nascita e morte. (S.
Freud ha considerato precostituiti filogeneticamente il simbolismo onirico, le fantasie primarie e gli
affetti. “Introduzione alla psicoanalisi”, vol. 8, p. 368; “L’uomo Mosé”, vol. 11, p. 448; “Analisi terminabile e interminabile”, vol. 11, p. 523, ed. Boringhieri).
I coinemi si distinguono in “parentemi” ed “erotemi” (parallelamente nel linguaggio, i primi sono
resi da sostantivi e aggettivi, i secondi dai verbi).
I coinemi della nascita e della morte combinandosi oppositivamente con tutti gli altri coinemi
“significano” l’istinto di conservazione della specie (erotemi) e di conservazione della cultura
(parentemi).
Essi presiedono alla forma più primitiva di “combinazione coinemica” cioè, grazie a loro, si
struttura la connotazione oppositiva: buono-cattivo, positivo-negativo, amico-nemico ed inoltre
danno origine alla struttura elementare della significazione affettiva:
• coinonie diadiche – relazione madre-bambino;
• coinonie triadiche – complesso edipico-scena primaria;
• coinonie tetradiche – due maschi - due femmine;
• coinonie collettive – collettivo buono - collettivo cattivo.
BION W.R., 1971, Esperienze nei gruppi, Armando, Roma.
BIOTTI V., 1987, Teoria coinemica e linguaggio cinematografico, in “Psicoanalisi-ArtePersona”, a cura di F. Maisetti, Franco Angeli, Milano.
CASSIRER E., 1968, Linguaggio e Mito, Saggiatore, Milano.
CASSIRER E., 1976, Filosofia delle forme simboliche – Il linguaggio, La Nuova Italia,
Firenze.
CHOMSKY N., 1970, Saggi linguistici, Boringhieri, Torino.
F. SCHILLER, 1981, Sulla poesia ingenua e sentimentale, tr. R. Precht a cura di Berardinelli, Abete, Roma.
FORNARI F., 1966, Nuovi orientamenti nella psicoanalisi, Feltrinelli, Milano.
FORNARI F., 1970, Psicoanalisi della situazione atomica, Rizzoli, Milano.
FORNARI F., 1976, Simbolo e codice, Feltrinelli, Milano.
FORNARI F., 1978, Strutture affettive del significato, Cortina, Milano.
FORNARI F., 1979a, Coinema e icona, Il Saggiatore, Milano.
FORNARI F., 1979b, I fondamenti di una teoria psicoanalitica del linguaggio, Boringhieri,
Torino.
FORNARI F., 1984, Psicoanalisi della musica, Longanesi, Milano.
FORNARI F., Fornari B., 1974, Psicoanalisi e ricerca letteraria, Principato, Milano.
FREUD S., 1906, Sulla Gradiva di W. Jensen, Opere, Vol. 5, Boringhieri, Torino.
FREUD S., 1915, Introduzione alla Psicoanalisi, Opere, Vol. 8, Boringhieri, Torino.
FREUD S., 1917, Totem e tabù, Opere, Vol. 7, Boringhieri, Torino.
FREUD S., 1926, Discorso per il 70° compleanno, Opere, Vol. 10, Boringhieri, Torino.
FREUD S., 1927, Dostoevskij e il parricidio, Opere, Vol. 10, Boringhieri, Torino.
FREUD S., 1930, Scritto in occasione del conferimento del premio Göethe, Opere, Vol.
11, Boringhieri, Torino.
FREUD S., 1969, Saggi sull’arte, la letteratura, il linguaggio, Opere, Vol. 2., Boringhieri,
Torino.
GOETHE J., 1969, Opere, a cura di L. Mazzucchetti, Sansoni, Firenze.
GRAVES R., 1963, I miti greci, Longanesi, Milano.
JAKOBSON R., 1978, Segno e sistema del linguaggio – Lo sviluppo della semiotica, Bompiani, Milano.
LEIBNIZ G.G., 1948, La monadologia, di G. De Ruggero, Laterza, Bari.
LÉVI STRAUSS C., 1978, La linguistica e le scienze dell’uomo, Il Saggiatore, Milano.
Lombardo e Fiorelli (a cura di), 1985, Biswanger e Freud, Boringhieri, Torino.
LOTMAN J., USPENSKY B.A., 1975, Semiotica e cultura, Ricciardi, Milano.
NIETSCHE F., 1977, Origine della tragedia, Adelphi, Milano.
SCHILLER F., 1973, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, a cura di A. Sbisà, Nuova
Italia, Firenze.
WATZLAWICK P., 1971, Pragmatica della comunicazione, Astrolabio, Roma.
NOTE
Bibliografia
91
IL TERRORISMO RELIGIOSO
di Pietro Birtolo
“Io manderò innanzi a te il mio terrore;
metterò in rotta ogni popolo” (Esodo 23,27).
“Non temerai pericolo notturno né saetta
volante di giorno”(Salmo 91,5).
“Ascoltate la parola del Signore,
voi che tremate ai suoi detti” (Isaia 66,5).
Introduzione
92
Il legame tra religione e violenza è presente in tutte le più importanti tradizioni religiose: cristianesimo, giudaismo, islam, induismo, sikhismo e buddismo. Nel tentativo di comprendere, ecco le domande che non possiamo evitare di porci. Perché così tanti credenti uccidono in nome del loro Dio? La maggior parte dei terroristi pretende di avere le proprie motivazioni nella religione.
Può la religione avallare atti di terrore contro esseri umani? La religione deve
fornire pace e tranquillità, non terrore. Può essere giustificato l’ossimoro “guerra santa”? Può una battaglia essere una crociata religiosa? Può la violenza
diventare un dovere sacro? Si può ritenere santa l’eliminazione fisica dei
“nemici di Dio” nei modi più spietati? Dio può volere la morte dei suoi “nemici”?
La difesa della fede richiede l’uso della forza, esercitato da un potere militare
o statale costituito? È giusta l’espressione soldati di Cristo?
Diciamo subito che Dio non può volere la morte, vuole la vita. Come è scritto nella Bibbia, Dio non vuole la morte del peccatore, per estensione diciamo
del suo nemico, ma che si converta e viva (Ezechiele 18,23; 33,11; Seconda
Lettera di San Pietro 3,9). Il Dio-Padre della Bibbia è completamente estraneo
a qualsiasi violenza, indifferente allo spirito di vendetta. Dio è agape (1Gv
4,8.16) e non può che volere l’agape e ama chi crede nell’agape (1Gv 4,16) e
pratica l’agape (Mt 25, 31-46; 1Cor 13,1-13). Neppure l’Apocalisse allude ad
una divinità violenta. La violenza apocalittica non è divina ma umana; la crisi
apocalittica che i Vangeli prefigurano non viene presentata come la vendetta di
Dio, ma come l’esito cui l’umanità andrà incontro se non sarà in grado di rifiutare la violenza. Gesù predica di “amare i nostri nemici e di pregare per coloro che
ci perseguitano”(Mt 5,44). Per amore muore in croce per tutti, anche per i suoi
nemici. “È lui la vittima espiatrice per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo” (Prima lettera di San Giovanni 2,2).
Anche altre religioni, il buddhismo e lo stesso islam, sono sulla stessa lunghezza d’onda del cristianesimo. Scrive Juergensmeyer: “Curiosamente, poi,
lo scopo di tutta questa violenza religiosa è la pace”1. Ruthven osserva che
“l’immagine di un islam militante non si addice a una fede considerata dalla
maggior parte dei suoi seguaci –circa un miliardo nel mondo– non meno paci-
NOTE
fica del buddhismo o del cristianesimo. La parola islam in arabo significa ‘sottomissione volontaria’, ed è etimologicamente legata a salam, che vuol dire
‘pace’; inoltre, l’espressione con cui i musulmani di tutto il mondo si salutano,
e salutano gli stranieri, è as-salam alaykum: ‘Che la pace sia con te’”2. Osserva inoltre che “le versioni quietiste dell’islam stanno rapidamente guadagnando terreno”3 e che la Tablighi Gama’at, nata in India e diffusa in un centinaio di
paesi, dalla Malaysia al Canada, fino a una completa internazionalizzazione,
pur essendo attiva nel promuovere la fede, è dichiaratamente apolitica. “I
decenni avvenire –egli afferma– vedranno probabilmente l’abbandono dell’azione politica diretta e un rinnovato accento sugli aspetti personali e privati
della fede”4. Secondo Pace, “l’islam è una religione che in linea di principio predica la pace (si tratta in realtà di intendersi storicamente cosa significhi questa
affermazione) e perciò i movimenti dell’islam politico si collocano su un piano
diverso che nulla hanno a che vedere con la fede e così via”5. E soggiunge: “Si
tratta, a ben guardare, di ipotesi di letture del fenomeno che appaiono speculari a tutte quelle interpretazioni del fondamentalismo quale espressione di
intolleranza e di fanatismo o di giacobinismo in ‘salsa religiosa’, indice complessivo di una strutturale incapacità delle religioni soprattutto monoteistiche di
accettare il principio moderno del pluralismo e della democrazia. Ci troviamo di
fronte, allora, da un lato, al ricorso ad argomenti apologetici per esorcizzare un
fenomeno che nasce all’interno di una determinata religione, dall’altro al tentativo di ricondurre il fondamentalismo ad una forma esasperata di intendere il
primato della verità religiosa su tutte le sfere dell’agire umano, dal foro interno
alla vita sociale”6.
La religione, dal latino religare, mira a ricongiungere l’uomo con Dio, Jahveh, Allah, Coscienza universale, Siva, Visnu e Kali (diversità di parole per
definire la Realtà Ultima, l’Assolutamente Altro, dovuta alla differenziazione
culturale). Questo legame verticale con l’Altro non esclude quello orizzontale
con l’altro, anzi, lo privilegia dal momento che nell’altro è l’Altro. Nella relazione con Dio il prossimo è un momento indispensabile, primario. Addirittura Dio
dice: “Se dunque tu stai presentando la tua offerta all’altare ed ivi ti ricordi che
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta lì dinanzi all’altare, e va’prima a riconciliarti col tuo fratello; poi allora torna e presenta la tua
offerta” (Mt 5, 23-24). E ancora Dio dice: “ogni volta che voi avete fatto queste
cose a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete fatta a me” (Mt 25, 3940). Nel passo biblico vengono precisate quelle che sono le cose fatte a uno
dei più piccoli: aver dato da mangiare all’affamato, aver dato da bere all’assetato, aver dato ospitalità al pellegrino, aver rivestito l’ignudo, aver visitato l’infermo, il carcerato.
Se così è, non è forse più giusto ammettere che si è di fronte ad uno scenario, quello attuale, complesso, nel quale la religione è usata a pretesto della
lotta politica, è ridotta a religione politicizzata? È proprio vero che la religione
fornisce agli autori degli attentati la motivazione? È ammissibile una giustificazione religiosa degli atti terroristici? Si tratta della religione veramente o di
un’ideologia religiosa? Si può trovare nella religione un rimedio per la violenza
più che una sua causa? La religione deve avere legami con la politica? Qual è
93
94
il rapporto dell’islam come religione con l’islam politico? Nelle teorie islamiche
la jihad è usata per la salvezza personale e la redenzione politica, è impegno
civile e religioso. “La vita è fede e lotta”, ha detto l’ayatollah Khomeini, intendendo che il concetto del combattere è fondamentale per l’esistenza umana ed
è allo stesso livello dell’impegno religioso.
L’attuale terrorismo, che ha in Osama Bin Laden il suo leader, possiede
un’ideologia religiosa in grado di costituirsi come strumento di interpretazione
e rinnovamento della realtà. Bin Laden ha sferrato l’attacco contro il potere
imperialistico americano, concepito come il nemico da combattere, “satana”,
perché incarna lo spirito di una “crociata”cattolico-ebraica contro i paesi musulmani. Infatti, i terroristi non si ritengono aggressori, ma vittime. Si apre, così, lo
scenario da essi auspicato: l’immagine di un mondo in guerra tra forze laiche
e religiose. Il fondamentalismo islamico si è fatto naturale interprete del timore
diffuso tra i musulmani che l’Occidente, attraverso la globalizzazione economica e culturale e la sua potenza militare, minacci l’esistenza dell’islam. La percezione di un Occidente arrogante, repressivo è diventata così una vera e propria forma di rappresentazione identitaria della civiltà islamica.
Ad una ricognizione sociologica, la città di New York risulta essere una città
multietnica che ospita persone provenienti da tutto il mondo senza che esse
abbiano alcun problema con gli uffici addetti all’immigrazione. L’attacco ha fatto
emergere una dissidenza all’interno dello stesso territorio americano costringendo a comprendere le ragioni degli altri e a riflettere che è stato un attacco
contro i valori rappresentati dall’intero Occidente. Di qui la condanna verso tutti
quegli Stati che con il fenomeno terroristico presentano una connivenza e il
mutamento degli equilibri mondiali: schieramenti, fino a pochi decenni fa inimmaginabili, hanno dato vita ad intese politiche fra U.S.A., Cina e Russia contro
il terrorismo. L’attacco ha deteriorato i rapporti tra Oriente e Occidente. Noi
siamo convinti che la religione, meglio, le religioni svolgono un ruolo fondamentale nel rapporto Oriente-Occidente, soprattutto le tre grandi religioni
monoteistiche e abramitiche, per la costruzione concreta della pace, e sono
rimedio per la violenza.
Con l’aiuto di Mark Juergensmeyer, il più grande studioso mondiale del
terrorismo religioso, e di altri, cerchiamo di rispondere alle domande che ci
siamo poste, partendo dagli attentati terroristici dei nostri giorni. Gli attentati
aerei al World Trade Center e al Pentagono dell’11 settembre 2001 sono stati
“la manifestazione più spettacolare di una serie di sanguinosi eventi religiosi”7. Prima gli americani erano stati il bersaglio di attacchi terroristici: gli scontri a fuoco etnici in California e nell’Illinois nel 1999, l’attacco alle ambasciate americane in Africa nel 1998, gli attentati alle cliniche per aborti in Alabama e in Georgia nel 1997, lo scoppio di una bomba alle Olimpiadi di Atlanta
e la distruzione di un edificio di alloggi per militari a Dahahran in Arabia Saudita nel 1996, la tragica distruzione dell’edificio federale di Oklahoma City nel
1995, l’esplosione al World Trade Center a New York nel 1993. Quello dell’11
settembre è “il più grande attacco terrorristico mai realizzato sul suolo americano”8. In questi casi la religione associata al terrorismo era il cristianesimo. Gli autori di questi eventi e altri episodi violenti, infatti, erano estremisti
NOTE
religiosi americani (tra cui le milizie cristiane, la Christian Identity e i militanti antiabortisti cristiani).
Gli americani non sono i soli a dover fare i conti con la violenza religiosa. I
francesi hanno avuto a che fare con le bombe nella metropolitana collocate da
attivisti dell’islamismo algerino, i britannici con camion e autobus imbottiti di
esplosivo innescati da nazionalisti cattolici irlandesi e i giapponesi con il gas
nervino introdotto nella metropolitana dai membri di una setta indo-buddista. In
India gli abitanti di Delhi hanno subito attentati con autobombe da parte dei
separatisti sikh e di quelli del Kashmir. Gli algerini hanno subito selvaggi attacchi dai sostenitori del FIS (Fronte Islamico di Salvezza). Israeliani e palestinesi hanno dovuto affrontare le azioni mortali di estremisti ebrei e palestinesi.
Questi eventi sono violenti e motivati dalla religione.
Un’ascesa della violenza religiosa si registra in tutto il mondo negli ultimi
decenni del ventesimo secolo. Negli ultimi anni, infatti, è esplosa la violenza
religiosa tra i cristiani di destra negli Stati Uniti, tra musulmani ed ebrei in
Medio Oriente, tra induisti e musulmani nell’Asia meridionale e tra comunità
religiose indigene in Africa e in Indonesia. Il legame tra religione e violenza
coinvolge le più diverse confessioni: cristianesimo, ebraismo, islam, induismo,
sikhismo e buddismo e sembra diffuso praticamente ovunque. Si tratta di uno
scenario complesso nel quale non c’è religione che non venga usata a pretesto della lotta politica.
I seguaci di Osama bin Laden “hanno tratto dalla religione la propria identità politica e la legittimità per ideologie vendicative”9. La religione è nel background di Osama bin Laden come è in quello di così tanti e diversi autori di
catastrofici atti terroristici, perché “tutte le religioni sono intrinsecamente rivoluzionarie. Possono fornire le risorse ideologiche per una visione alternativa
dell’ordine pubblico”10.
La globalizzazione può essere la causa della violenza religiosa, “una ragione del perché tutti questi casi di violenza religiosa nel mondo si verificano in
questo momento storico”11. D’altra parte, la percezione di una cospirazione
politica internazionale e di un “nuovo ordine economico mondiale”oppressivo è
stata esplicitata da Osama bin Laden, dall’Aum Shinrikyo e dai gruppi miliziani cristiani. “Attivisti come bin Laden potrebbero essere considerati come guerriglieri antiglobalizzazione”12. Ronald Robertson vede nel fondamentalismo
una formidabile rivendicazione di identità e di località da parte di attori sociali
che rifiutano l’idea di un mondo unico13. Più che un clash of civilizations, scontro tra civiltà, tra l’Occidente e l’islam, teorizzato da Samuel Huntington14, si
profilerebbe così un clash of localities, scontro di località. Robertson preferisce
al concetto di globalizzazione, che non dà conto delle resistenze locali, quello
di glocalizzazione, che fonde globalizzazione e localizzazione.
Certamente Osama bin Laden e quelli come lui “si sono appropriati della religione per metterla al servizio della loro macabra visione del mondo”15. La religione, in questo caso, è usata a pretesto della lotta politica. Perché la religione,
che dovrebbe fornire pace e tranquillità, non terrore, è legata ad atti di violenza
pubblica, ad atti di terrorismo? Perché questi atti hanno la loro giustificazione
religiosa? Perché la religione ha un ruolo fondamentale? Perché “offre giustifi-
95
96
cazioni morali per uccidere e mette a disposizione immagini di guerra universale che permettono agli attivisti di credere che la pièce che stanno interpretando
sia di natura spirituale”16. La religione “spesso mette a disposizione usanze e
simboli che rendono possibile lo spargimento di sangue, e anche catastrofici atti
terroristici”17. Agli autori degli attentati fornisce “non solo l’ideologia, ma anche
la motivazione e la struttura organizzativa”18. La violenza religiosa non è esclusiva di una religione in particolare: “praticamente tutte le più importanti tradizioni religiose (cristianesimo, giudaismo, islamismo, induismo, sikhismo e buddhismo) sono servite da risorsa per soggetti violenti”19. Ma la religione, che fornisce le motivazioni ad atti terroristici, è al tempo stesso “un rimedio per la violenza”20, è “in grado di sanare le ferite, ricostruire e ridare la speranza”21.
Terrorismo, dal latino terrere, far tremare, è più frequentemente associato
alla violenza commessa da gruppi emarginati che cercano di ottenere un brandello di potere e che, grazie all’alto grado di dedizione alla causa e alla loro
pericolosa imprevedibilità, sono in grado di esercitare un’influenza notevole. La
loro lotta è alimentata da ideologie di sinistra o da un desiderio di separatismo
etnico o regionale. “Ma è stata più spesso la religione, talvolta in combinazione con questi altri fattori, talvolta come motivazione primaria, a incitare gli atti
terroristici”22. Negli ultimi decenni del ventesimo secolo c’è stata un’ascesa
della violenza religiosa. Nel 1980, nell’elenco dei gruppi terroristici internazionali, stilato dal Dipartimento di Stato americano, figurava soltanto un’organizzazione religiosa. Vent’anni dopo, nell’elenco dei trenta gruppi più pericolosi a
livello mondiale più della metà erano religiosi. Si trattava di gruppi ebraici,
musulmani, buddisti. Per questo il terrorismo perpetrato in nome della religione e dell’identità etnica è –come dice Warren Christopher– “una delle sfide più
importanti, in materia di sicurezza, tra quelle che ci troviamo di fronte nel
mondo post-Guerra Fredda”23.
Il legame religione e violenza è rintracciabile nell’immaginario religioso.
“All’interno delle storie delle tradizioni religiose, dalle guerre bibliche alle crociate e ai grandi atti di martirio, la violenza aleggia come un’oscura presenza.
I simboli più oscuri e misteriosi della religione ne sono pervasi. Il potere che ha
la religione di stimolare l’immaginazione ha sempre avuto a che fare con immagini di morte”24. L’immaginario religioso possiede un potere sulla vita pubblica.
Agli atti di violenza del nostro tempo la religione “ha fornito la motivazione, la
giustificazione, l’organizzazione e la visione del mondo”25; ma alla base di questi atti stanno anche idee e comunità di supporto, contesti culturali, culture
della violenza. Nelle culture della violenza che hanno portato al terrorismo religioso, le angosce dei giovani (le preoccupazioni per la carriera, la collocazione sociale, le relazioni sessuali, la marginalità, la moralità pubblica deficitaria,
la laicizzazione della società) sono esarcebate. Di qui i loro tentativi di creare
regimi basati sulla legge religiosa, di ricostruire le loro società su basi religiose, di rivendicare alla religione un ruolo nella vita pubblica. “Le esperienze di
umiliazione in questi ambiti li hanno resi vulnerabili al richiamo di leader carismatici e alle immagini di gloria di una guerra universale”26. Ai fini del legame
religione e violenza è importante il contesto, cioè, le situazioni storiche, le localizzazioni sociali e le visioni del mondo legate agli eventi violenti.
Religione e violenza nel cristianesimo
Innanzitutto c’è da chiedersi: il cristianesimo, dal momento che si presenta
espressamente, e in modo marcatamente originale, come religione dell’amore
e della non-violenza, si rapporta con la violenza? Purtroppo sì. Nietzsche definisce il cristianesimo “l’unico grande istinto della vendetta”28, perché, i deboli,
di cui prende le parti, dietro l’apparenza dell’amore, sono in realtà mossi da
una profonda brama di vendetta nei confronti dei forti; per essi, la possibilità di
liberarsi dalla sofferenza sta sempre soltanto nella vendetta.
Il cristianesimo –come la maggior parte delle tradizioni religiose– ha sempre
avuto il suo aspetto violento, nonostante la centralità del messaggio evangelico
di amore e pace. Cristo stesso ha detto: “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada” (Mt 10, 34;
cfr. anche Lc 12, 51-52). “La sanguinosa storia della tradizione cristiana ha fornito immagini altrettanto inquietanti di quelle fornite dall’islamismo o dalla religione sikh, e, sia nel Vecchio sia nel Nuovo Testamento, il conflitto violento viene
rappresentato a tinte vivide. Questa storia e queste immagini bibliche hanno fornito la materia prima per giustificare dal punto di vista teologico la violenza dei
gruppi cristiani contemporanei”29, come gli attentati alle cliniche per aborti, negli
Stati Uniti, e gli attacchi terroristici di cattolici e protestanti nell’Irlanda del Nord.
NOTE
La religione, “comunemente, non conduce alla violenza. Questo succede
solo quando una determinata serie di circostanze (politiche, sociali e ideologiche) si saldano insieme, quando la religione diventa tutt’uno con manifestazioni violente di aspirazioni sociali, orgoglio personale e movimenti per il cambiamento politico”27. Il terrorismo, perciò, non è un atto isolato; nella maggioranza
dei casi, è il risultato di decisioni collettive, come la cospirazione, cui parteciparono buddisti giapponesi, che ha portato allo spargimento di gas nervino
nella metropolitana di Tokyo. Quando Mohammad Atta e altri membri di al
Qaida, a Boston e a Newark, salirono a bordo degli aerei che poco dopo si
sarebbero schiantati sulle torri gemelle del World Trade Center provocando- ne
il crollo, agivano all’interno di un piano in cui erano coinvolti diversi cospiratori
e tanti simpatizzanti negli Stati Uniti, in Europa, in Afghanistan, in Arabia Saudita e in altre parti del mondo. L’attentato del 1993 al World Trade Center inizialmente fu ritenuto opera di un piccolo gruppo, in seguito si scoprì che esso
aveva legami con la rete mondiale di attivismo islamico al Qaida, legata ad
Osama bin Laden. Dietro l’assassinio di Yitzhak Rabin per mano di Yigal Amir
c’era un grande movimento di sionismo messianico in Israele e all’estero. Dunque, anche quelle azioni che appaiono avventate imprese solitarie compiute da
schegge impazzite hanno alle spalle reti di supporto e ideologie che le convalidano, sebbene ciò non risulti immediatamente evidente. La percezione che la
propria comunità sia violata e che le proprie azioni siano una risposta alle violenze che stanno subendo è la caratteristica significativa delle culture della violenza. Vediamo brevemente il legame tra violenza e religione nelle diverse tradizioni religiose.
97
98
Nella tradizione cristiana ci sono altri esempi di violenza religiosa, tra cui le
Inquisizioni, con la tortura e il rogo, e le Crociate. Le Inquisizioni del tredicesimo secolo costituivano il tentativo della Chiesa medievale di sradicare l’eresia,
che comprendeva la tortura dell’accusato e la condanna al rogo tra le possibili sentenze. L’Inquisizione spagnola nel quindicesimo secolo era rivolta in gran
parte contro gli ebrei e i musulmani convertiti al cristianesimo, indagati perché
sospettati di conversioni non sincere: anche in questo caso torture e condanne a morte erano caratteristiche comuni di questi processi illegittimi. Le Crociate si combatterono al suono del grido di battaglia cristiano “Dio lo vuole”, con
la croce e la spada. A Clermont, nel 1095, il papa Urbano II esorta i cristiani ad
armarsi per liberare i luoghi santi in mano ai musulmani. Nella prima crociata
ci furono massacri di ebrei, giustificati dall’affermazione che bisognava innanzitutto distruggere gli infedeli più vicini, prima di mettersi in marcia per sconfiggere i più lontani. Da parte ebraica fu elaborata l’idea di martirio per la “Santificazione del Nome”. La morte o il suicidio collettivo vennero preferiti al battesimo coatto. A York avvenne uno dei casi più noti di accettazione collettiva della
morte per la “Santificazione del Nome”. I massacri di ebrei compiuti dai crociati furono i funesti presagi di ciò che sarebbe accaduto nella storia successiva
ad Auschwitz.
Diciannove secoli di antigiudaismo cristiano sono culminati nella Shoà,
“distruzione”, “catastrofe”, nella quale sei milioni di ebrei sono stati sterminati
nel cuore dell’Europa cristiana (protestante e cattolica). Secondo il teologo
Martin Cunz, Auschwitz è la “bancarotta del cristianesimo”: i cristiani hanno
perseguitato e fatto morire i fratelli di colui che essi veneravano (Cristo era
ebreo).
Maria Zambrano, pensatrice spagnola, di fronte ad un’Europa assediata dai
totalitarismi, scossa dalle guerre civili, annichilita dalla violenza, s’interroga
sulle ragioni dell’orrore e scopre che l’Europa è violenza, perché è cristiana.
Ricollega, infatti, questa violenza originaria dell’Europa alla violenza del Dio
cristiano, il Dio creatore che trae il mondo dal nulla. L’uomo, che è immagine
sua, è anch’egli creatore e quindi violento. Scrive: “Non v’è un Dio più attivo,
più violento. Dal nulla estrae il mondo, la splendida realtà che è l’azione più
grande di tutte, l’azione più attiva, azione assoluta. E la creatura umana è fatta
a sua immagine e somiglianza. Presto comincerà quella frenesia della creazione che si chiama Europa”30. La violenza europea ha dunque un’origine religiosa-cristiana. La capacità creatrice dell’uomo doveva essere motivo di intimità
con Dio, così pensava Agostino, quindi prosecuzione dell’attività creatrice divina, invece si è sviluppata nella più completa distanza da essa, pretendendo di
sostituirsi ad essa e cioè di creare anch’essa dal nulla, divenendone così una
variante perversa. È la tentazione luciferica dell’eritis sicut Deus, che porta
l’uomo ad attribuire a se stesso poteri assoluti e totalizzanti, falsando così le
sue relazioni con Dio, con gli altri e con il mondo. L’uomo, preso da un satanismo, suscitato dall’orgoglio teoretico e pratico, pretende di poter spiegare tutto
da sé. Questa pretesa è il demoniaco in atto, ovvero l’assoluta solitudine. La
cupiditas scientiae, infatti, “non lascia scorgere gli altri (l’umanità degli altri),
insinuando nell’animo l’orgoglio di potersi eguagliare a Dio, di essere il divino
NOTE
(l’illusione della ragione)”31. Scrive Strummiello: “l’uomo europeo ha trasformato il suo sogno in un ostinato delirio, ha fatto della propria grandezza creatrice
il suo inferno, ha ceduto alla furia della passione di assolutezza, stanco di
vestire i panni di un’epoca immagine […]. La frenesia della creazione giunge
ad un punto in cui non può essere più tollerata dall’uomo stesso, stanco di
vedere ogni volta rinviato il soddisfacimento del suo desiderio di assoluto: l’uomo creatore, fattosi impaziente, vuole giungere a toccare con mano i risultati
del suo potere, per potersi finalmente definire compiuto e superare l’orrore di
un continuo rinascere”32. Illusione! Come sottolinea la Zambrano, non si tratta
di negare la propria nascita –conia i termini di desnacer, desnacimiento–,bensì
di affermarla costantemente, tornando ogni volta a nascere. Ciò significa che
l’uomo deve riconoscere la propria strutturale incompiutezza: deve trascendersi continuamente, tornando ogni volta a nascere, perché non è nato una volta
per tutte completo; deve rinunciare alla tentazione di desnacer; consapevole di
“vivere nel fallimento”; deve rinunciare alle proprie pretese di purezza. Torniamo all’antigiudaismo cristiano.
“Se non vi fosse stato il bimillenario ‘insegnamento del disprezzo’ cristiano
verso gli ebrei ‘carnali e deicidi’ i nazisti avrebbero tentato e parzialmente realizzato il loro progetto di estirpamento del popolo ebraico dal mondo? L’antigiudaismo cristiano ha pavimentato l’impresa”33. L’antigiudaismo religioso è
“un’indiscussa condizione”34 dell’antisemitismo razziale e culturale. Sotto la
spinta della secolarizzazione, “l’antigiudaismo religioso del lontano passato si
è trasformato divenendo ora antisemitismo biologico-razziale, ora avversione
economico-politica, cioè antisionismo”35. E così “l’avversione religiosa di un
tempo è divenuta la più “scientifica”giustificazione della politica della razza
pura”36. Duemila anni di conflitto antigiudaico dovuti a motivi religiosi, teologici
sono, dunque, culminati nella Shoah.
Perché tanto odio da parte dei cristiani contro gli ebrei? Qual è la matrice
della conflittualità teologica tra ebrei e cristiani? “Esiste un parallelo, […] una
sovrapposizione di tipo ermeneutico-soteriologico tra Israele e il Cristo dei cristiani “37. Quel parallelo, quella sovrapposizione tra Israele e Cristo costituisce
la matrice della conflittualità teologica tra popolo ebraico e chiesa. La questione intriga. A chi spetta la missione salvifica, il compito messianico: ad Israele,
il “popolo eletto”, o alla chiesa, cioè a coloro che –secondo il racconto degli Atti
degli Apostoli– credettero in Gesù come messia e perciò convocati a svolgere
la stessa opera salvifica di Cristo? Da una parte c’è Israele, il “popolo eletto”da
Dio a una speciale missione nel mondo, a un compito messianico per eccellenza, ne è rivelativa l’alleanza sinaitica; dall’altra c’è Cristo, l’Agnus Dei, quindi, la chiesa come ecclesia, comunità di convocati a svolgere la stessa opera
di redenzione nel mondo attraverso la fede in quello stesso Gesù “che Dio ha
costituito Cristo” (At 2,36). Per gli ebrei, Cristo non è il messia, perciò lo hanno
crocifisso. Per i cristiani, invece, Cristo è filius Dei. Gli ebrei, dunque, sono deicidi. Da qui l’antisemitismo cristiano e le affermazioni antiebraiche: ebrei carnali, ebrei maledetti da Dio per aver ucciso suo figlio. L’accusa di deicida
abbassa l’ebreo al livello più basso della condizione umana. Ciò ha costituito,
fin dalle origini della storia cristiana, la base per la demonizzazione dell’ebreo
99
100
qua talis e per l’attribuzione di una colpa universale. Questa colpa avrebbe le
sue radici “nella presunzione del popolo ebraico di sentirsi un popolo eletto, e
quindi portatore di una verità e di un progetto che cerca di imporsi alla storia
dei popoli e di mutarne il libero corso. Gli ebrei sono quindi perpetuamente
agenti e colpevoli di un complotto”38. Innanzitutto complotto contro Dio, perché
negano la divinità di Cristo e arrestano la diffusione del messaggio cristiano
nell’umanità, e poi complotto contro la società, perché vogliono imporre il principio dell’economia capitalistica, il freddo dominio del denaro, a tutta la società, costruendo così nuove forme di schiavitù economiche, coloniali e imperiali.
Nell’uno e nell’altro caso gli ebrei sono visti come “causa di tutti i mali della
società e la risoluzione di questi mali s’identifica con il loro sacrificio come
capro espiatorio”39.
Nonostante tutto, il popolo ebraico non è stato annientato, come prevedeva il progetto nazista. La Shoah, dunque, è “nuova rivelazione dell’esistenza di
Israele accanto alla chiesa” e “solleva nella chiesa l’istanza nuova della relatività soteriologica, dei limiti cioè della propria pretesa di salvezza sul mondo,
ponendo così un limite teologico alla redenzione di Cristo”40. La Shoah, quindi,
è un problema cristologico perché riapre al cuore della teologia cristiana il problema della redenzione, “facendo riscoprire ai cristiani il peccato originario
della loro ermeneutica sostituzionista e la sostanziale relatività soteriologica
del simbolo cristiano per antonomasia: la croce di Cristo”41.
La Shoah mette in discussione l’assolutizzazione del senso salvifico del
sacrificio di Cristo e il suo elitismo sostituzionista, mette in dubbio la salvezza
del mondo operata da Cristo, sovrapposto e sostituito a Israele, cioè mette in
dubbio che Cristo sia veramente Redemptor mundi e insinua un’istanza di relatività soteriologica nella cristologia tradizionale della chiesa. Mette in crisi
l’esclusività soteriologica della croce di Cristo, dal momento che proprio la
croce è stata per gli ebrei simbolo di intolleranza, di condanna, di oppressione
e di odio. In nome di essa i crociati hanno combattuto gli ebrei. La croce era
brandita dai giudici dell’Inquisizione e dagli aguzzini dei pogroms. Per gli ebrei
esiste un parallelo tra la croce e la svastica. Allora: si può includere Auschwitz
nella croce di Cristo? È Auschwitz una “stella dell’irredenzione”? “Il dubbio che
la croce di Cristo sia rimedio per tutti i mali e per tutti i peccati, tranne quelli
compiuti in nome della croce stessa, fa tremare l’intero edificio della redenzione cristiana […]; incrina la serafica certezza dell’universalità e della compiutezza della soteriologia”42. La redenzione, allora, “ridiviene dramma […]. Ridiventa il biblico Chaoskampf, dove Dio è ancora in lotta contro il male e dove nessun redentore può dire ‘tutto è compiuto’”43.
L’implicazione più urgente e radicale della Shoah per la teologia cristiana
è ripensare il ruolo d’Israele nell’economia cristiana della salvezza. La Shoah
pone le chiese e le teologie cristiane di fronte alla realtà storico-teologica di
Israele, come popolo di un’alleanza mai revocata –l’alleanza sinaitica è eterna– e come radice santa della propria fede, le pone anche di fronte al proprio
peccato: “il peccato di non-credere che le promesse di Dio sono irrevocabili e
di negare l’unigenitura di Israele. In una parola, il peccato di antigiudaismo”44.
Un peccato, dunque, verso Dio e verso Israele, nella forma della dottrina sosti-
NOTE
tuzionista, in virtù della quale la chiesa sostituisce Israele nel piano di salvezza, della sostituzione teologica, cioè, di Israele con un altro “popolo eletto”, la
chiesa, cioè il popolo cristiano, “nuovo Israele”. La sovrapposizione cristiana di
Cristo a Israele è il nodo teologico che è alla base del conflitto ebraico-cristiano. La Shoah riscopre l’irrevocabilità delle promesse di Dio e la permanenza
del valore teologico di Israele nella storia della salvezza. “Infatti se Israele
venisse meno, cadrebbero le promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza per sempre”45. E ancora: “il principale attributo del Dio biblico, cioè la sua
credibilità, verrebbe meno a sua volta”46.
La rivelazione di Dio in Cristo non è negazione della rivelazione di Dio a
Israele. Il peccato originale del cristianesimo nascente è l’aver occultato l’origine ebraica, l’hebraica veritas, della cosiddetta nuova alleanza: l’alleanza tra
Dio e Israele è confermata e rinnovata in Cristo. Per il teologo Martin Cunz,
infatti, il patto in Gesù Cristo e il patto tra Dio e Isarele costituiscono un’unica
realtà. L’ “Eletto” di Dio, allora, è Israele, o meglio il popolo ebraico, nella sua
dimensione di servo sofferente, di cui parla Isaia al capitolo 53, che i cristiani
interpretrano come una figura del Cristo. Israele è servo sofferente prima di
Cristo, in quanto popolo eletto da Dio a una speciale missione nel mondo. Per
la Scrittura il “servo di Dio” è colui che il Signore coinvolge, sceglie, nel suo
progetto d’amore nei confronti del suo popolo. Questa espressione emerge nei
quattro poemi del “Servo di Jahveh” e trova la sua realizzazione piena in Gesù
“il quale pur essendo di natura divina […] spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo” (Lettera ai Filippesi 2,6.7). Le due religioni, perciò, hanno
motivo di essere l’una accanto all’altra e non l’una contro l’altra. D’altra parte,
“Dio ha creato il mondo, non le religioni. E neppure le chiese e le sinagoghe”47.
Ed Egli stesso non è né ebreo né cristiano, né musulmano né hindu. “Forse
Dio è soltanto Iddio dei Giudei? –scrive l’apostolo Paolo– o non lo è pure dei
Gentili? Sì, anche dei Gentili. Or, dato che vi è un solo Dio, egli come giustificherà per mezzo della fede il Giudeo, così per mezzo della fede giustificherà i
Gentili” (Lettera ai Romani 3, 29-30). L’uomo, quindi, “è giustificato dalla fede”
(Ibid.). E nella Lettera agli Efesini (4, 5-6) scrive: “Non c’è che un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Non esiste che un solo Dio e Padre di
tutti, il quale è al di sopra di tutti, opera in tutti ed è in tutti”. La comune fede in
un solo Dio deve spingere tutti gli uomini a riconoscersi fratelli al di là di ogni
discriminazione di razza o di nazionalità, “poiché davanti a Dio non vi è preferenza di persone”(Lettera ai Romani 2,11). “Non c’è infatti nessuna differenza
fra il giudeo e il greco, poiché Gesù è lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti
coloro che l’invocano” (Op.cit. 10,12). “Non c’è dunque più né giudeo né greco,
né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti siete un sol uomo in Cristo Gesù” (Lettera ai Galati 3, 28). Perciò non ha senso dire: “Io sono di Paolo”,
“Io di Apollo”, “Io di Pietro”, “E io di Cristo”. È stato tagliato a pezzi il Cristo?”
(Prima Lettera ai Corinti 1,12-13). E “quando infatti uno dice: “Io sono di Paolo”;
e un altro: “Io sono di Apollo”, non siete forse uomini?” (Op. cit. 3, 4). L’essere
uomini è l’elemento che dovrebbe far riflettere per favorire la pace.
Tornando al legame religione e violenza nel cristianesimo, osserviamo che
i primi cristiani erano fondamentalmente pacifisti. Per la Chiesa primitiva il
101
102
pacifismo era una componente essenziale della dottrina cristiana. I primi padri
della Chiesa, tra cui Tertulliano e Origene, asserivano che ai cristiani era fatto
divieto di togliere la vita ad altri uomini, un principio che impediva ai cristiani di
servire nell’esercito romano. Tertulliano scriveva: “È proprio del diritto umano e
della facoltà naturale che ciascuno veneri ciò che vuole; la religione di un uomo
non nuoce né giova ad un altro. E non è proprio della religione imporre la religione, che dev’essere accettata spontaneamente e non con la forza, perché i
sacrifici sono richiesti solo dalla libera volontà”48. Lattanzio aveva scritto: “Si
deve difendere la religione non uccidendo ma morendo, non con la crudeltà ma
con la pazienza, non col delitto ma con la fede: quelli infatti sono tra i mali, questi tra i beni, e nella religione è necessario impiegare il bene, non il male. Perché se vuoi difendere col sangue, con la violenza e con la malvagità la religione, questa non sarà difesa, ma inquinata e offesa. Nulla è più volontario della
religione: se l’animo di chi compie il sacrificio è avverso, essa rimane soppressa, annullata”49.
Nel quarto secolo d. C. si affermò l’idea della guerra giusta, sostenuta per
primo da Cicerone e poi da Ambrogio e da Agostino. Già con Costantino, e l’alleanza tra Chiesa e Impero, era stata riconosciuta ai cristiani la licenza di uccidere al servizio dello Stato, contro “barbari” e pagani. Agostino aveva giustificato il bellum justum come guerra difensiva, non come guerra di aggressione.
Dopo il 1050, con l’integrazione della sfera temporale in quella spirituale progettata da Gregorio VII nel suo sogno ierocratico di una società organicamente cristiana, il papato romano sviluppò la tendenza alle gestione totalitaria della
società e all’eliminazione violenta del dissenso e delle diversità di fede e di
pensiero. “S’involgariva la grandezza e la bellezza del messaggio evangelico
dimenticandone la vocazione irenica e mutandone l’etica della compassione e
della vita in teologia della guerra apportatrice di morte. Gregorio VII, adottando lo jus gladii della cavalleria, aveva cancellato le inibizioni che avevano trattenuto la Chiesa dal predicare la guerra e dal commissionarla e guidarla”50.
Urbano II s’impegnò a realizzare quel programma, che poi Innocenzo III allargò. Questi, in una strategia teocratica di apostolato armato, trasformando la
persuasio in coercitio, darà mandato di sterminare i “diversi”. A dispetto del
messaggio evangelico, la crociata contro gli infedeli diventerà la guerra contro
tutti i presunti nemici della Chiesa, gli “altri”: politici, scismatici o eretici, ebrei e
musulmani (“popoli del Libro” come i cristiani), “nemici di Cristo”e come tali
dovevano essere convertititi con la violenza o eliminati. Innocenzo III trasformò i cristiani “devianti” in criminali, giustificando inquisizione e persecuzione,
che tre secoli dopo troveranno conferma nel concilio di Trento: la diversità di
fede, la libertà di coscienza, sarà punita con la tortura ed il rogo. Certamente
atrocità simili ci sono stati e ci sono. “Ma i crociati erano cristiani di obbedienza romana, ed erano stati messi in cammino da un papa che, pur non avendo
abrogato il Discorso della Montagna, sosteneva di parlare in nome di Dio. “Dio
lo vuole!”era il grido terribile che spinse gli uomini a prendere le armi”51. L’impresa delle crociate, ricca di ossimori (guerra santa, pellegrinaggio armato,
combattimento penitenziale) è l’origine della rottura dei musulmani nei confronti dell’Occidente. “Il mondo arabo non può decidersi a considerare le crociate
Religione e violenza nell’ebraismo
La stessa violenza religiosa si riscontra nell’ebraismo, che giustifica la violenza, quantomeno nei casi di guerra giusta. Yigal Amir, Baruch Goldstein e
Meir Kahane si rifanno a questa tradizione.
Il primo, un giovane ebreo di 25 anni, studente dell’Università conservatrice Bar-Ilan di Tel Aviv, in nome della “violenza del sacro”, assassinò il primo
ministro israeliano Yitzhak Rabin la sera del 4 novembre 1995 nella piazza Re
di Israele a Tel Aviv, dopo aver parlato davanti ad una folla di 100.000 persone. Avrebbe detto di non avere “alcun rimorso” per quello che aveva fatto, che
aveva “agito da solo e su ordine di Dio”54 e che si richiamava alla tradizione
ebraica che, in taluni casi, legittima l’assassinio del rodef e mosser, traditore e
persecutore, che mette in pericolo la vita (pikuah nefesh) di altri ebrei. Yigal è
NOTE
come un semplice episodio di un passato ormai compiuto. Si è spesso sorpresi nello scoprire a che punto l’atteggiamento degli Arabi e dei Musulmani in
generale nei confronti dell’Occidente sia influenzato ancora oggi da avvenimenti che si presume conclusi sette secoli or sono. […]. E non si può dubitare
che la rottura avvenuta tra i due mondi abbia la propria radice nelle crociate, a
tutt’oggi considerate dagli Arabi come un vero atto di violenza”52.
Tommaso d’Aquino sostenne che la guerra era sempre immorale, anche se
intrapresa per una giusta causa. Ha scritto di recente il cardinale Martini: “Noi
siamo del parere che non basta una nobile causa per giustificare una guerra condotta per ordine di Dio […]. Del resto, non ci si è forse appellati, lungo i secoli
della storia della Chiesa, al giudizio implacabile di Dio per ritenersi autorizzati ad
anticiparlo in qualche modo nella tortura, nelle crociate, nelle forme di eliminazione degli avversari della fede?”53. Una lenta trasformazione ideologica (avvenuta
soprattutto nel X e XI secolo) porta il pensiero cristiano dall’originaria non violenza alla crociata. Attraverso la difesa armata dei possedimenti della Chiesa, la
guerra viene a poco a poco sacralizzata, poi prende corpo la demonizzazione dei
musulmani e infine nasce la “guerra santa”contro gli infedeli.
Alcuni teologi cristiani moderni sostengono che la Chiesa possa abbracciare la causa di una rivoluzione giusta. Reinhold Niebuhr, uno dei più grandi teologi protestanti del ventesimo secolo, nel saggio Why the Christian Church is
not Pacifist (perché la Chiesa cristiana non è pacifista), legittima l’uso della violenza per estirpare l’ingiustizia, ma con parsimonia e con la rapidità e la precisione con cui un chirurgo adopera il bisturi. Anche il teologo e pastore luterano tedesco Dietrich Bonhoeffer legittima l’uso della violenza per scongiurare
grandi atti di violenza e di ingiustizia. Egli stesso abbandonò la sua privilegiata posizione di ricercatore alla Union Theological Seminary di New York per
ritornare in Germania e aderire clandestinamente a un piano per assassinare
Hitler. Il piano fu scoperto ed egli fu impiccato dai nazisti. È citato dai filosofi
morali come esempio del modo in cui i cristiani dovrebbero intraprendere azioni violente per una giusta causa e di come siano costretti occasionalmente a
infrangere la legge per uno scopo più alto.
103
104
stato educato in una famiglia ultraortodossa: suo padre aveva militato in una
delle principali formazioni fondamentaliste in Israele. Ha frequentato la scuola
vicina agli ideali più duri e puri del movimento nazional-religioso, Tshal, che
prescrive per i suoi aderenti una milizia regolare. La lettura della Torah nutre la
sua fede e allo stesso tempo gli suggerisce le linee di azione da seguire. Legge
il passo della Bibbia (Numeri 25), nel quale si ricorda la vicenda di Pinhas, che
uccide un ebreo –Zimri– che aveva stretto una relazione con una donna
–Cozbi– appartenente ad un popolo adoratore di dei, empio e peccaminoso.
Per questo gesto il Signore mostra riconoscenza a Pinhas, stipulando con lui
un’alleanza di pace e di sacerdozio perpetuo con tutta la sua discendenza.
“L’idea di trasferire l’immagine del “nemico”su Rabin e di assumere da parte di
Amir le vesti del grande punitore –Pinhas– non solo diventerà una fantasia
mentale, ma si concretizzerà in un atto insano quella sera del novembre
1995”55. Questo percorso mentale di Amir è simile a quello che conduce giovani palestinesi a diventare martiri della fede: “si assume alla lettera il dato rivelato di fede e lo si tramuta in un potente dispositivo di mobilitazione politica. Il
nesso diretto fra Libro sacro e azione politica è la sostanza del fenomeno fondamentalista”56.
Baruch Goldstein uccise una trentina di musulmani e ne ferì altri mentre
pregavano nel santuario della Tomba dei Patriarchi di Hebron, luogo di culto
sia per gli ebrei sia per i musulmani, con sale riservate agli uni e agli altri. La
strage fu compiuta il giorno di Purim, una festa sacra per gli ebrei che ricorda
lo scampato pericolo da parte del popolo ebraico di essere sterminato dal “cattivo Aman”. Il 24 febbraio 1994, la sera prima della celebrazione del Purim,
Goldstein andò al santuario, dove gli ebrei erano radunati per ascoltare la lettura di Ester (9,5), com’è tradizione il giorno della vigilia del Purim: “gli ebrei
colpirono i loro nemici, passandoli a fil di spada, sterminandoli, facendo dei loro
nemici quello che vollero”. La sua meditazione fu interrotta da voci e schiamazzi di giovani arabi provenienti da fuori che dicevano “sterminate gli ebrei”. Goldstein vide che le guardie armate mandate dal governo israeliano a sorvegliare non intervenivano. Ne rimase indignato e umiliato. La mattina dopo, entrò
nella moschea e sparò sulla folla che pregava. La strage “assumerà il significato rievocativo del passo biblico citato”57.
Il passo dei Numeri recentemente è stato ripreso dai militanti dei movimenti nazional-religiosi e quello di Ester dal gruppo di estremisti religiosi, il Kach,
“Così”, fondato dall’estremista di destra Meir Kahane.
Al centro della ideologia di Kahane c’era il “messianismo catastrofico”,
come l’ha chiamato Ehud Sprinzak58: il messia giungerà in un grande conflitto
dove gli ebrei trionferanno e glorificheranno Dio attraverso i loro successi.
Durante il raduno all’Hotel Sheraton per proclamare lo stato di Giudea, Meir
Kahane chiamò il popolo di Israele a sollevarsi e a rivendicare la Cisgiordania
come un atto di guerra giusta. Kahane fu assassinato da Nosair, mentre il complice, il musulmano Mahmud Abouhalima riuscì a fuggire; lo stesso svolse un
ruolo nell’attentato al World Trade Center del 1993, mosso dalla visione di una
società islamica ideale, più potente e duratura dei modelli concorrenti di ordine politico, ebraismo militante o laicismo aggressivo.
Anche l’India è flagellata dalla violenza religiosa fin dal principio della
sua esistenza come Stato indipendente. Nel 1992 fu distrutta la storica
moschea di Ayodhya da parte di una folla inferocita di indù e nel 2002 ci
furono uccisioni di massa nello Stato del Gujarat. Per molti anni il movimento Khalistan dei combattenti sikh è stato il principale esempio di attivismo
religioso violento. Il 31 agosto 1995, alle cinque del pomeriggio, il terrorismo
legato al movimento separatista sikh causò un’imponente esplosione
davanti al modernistico palazzo governativo di Chandigarh, che uccise il
governatore statale, Beant Singh, e anche altre quindici persone. L’omicidio
di Beant Singh è stato una replica dell’assassinio del primo ministro indiano
Indira Gandhi avvenuto il 31 ottobre del 1984. Un esempio di separatismo
religioso in India è la lotta per l’indipendenza in Kashmir. Nel maggio 1989,
i separatisti cominciarono a chiamarsi mujahedeen (guerrieri sacri) e diedero al loro conflitto la caratteristica di una guerra santa. La giustificazione
della violenza ha un forte radicamento nelle tradizioni religiose indiane. Nell’antica epoca vedica i guerrieri invocavano gli dèi perché prendessero parte
alle loro battaglie. Nel 1699 il guru Govind Singh istituì il khalsa, la comunità dei puri, un ordine di monaci-guerrieri, una milizia scelta pronta a combattere e a morire per difendere la propria fede contro gli attacchi dell’Islam
e in generale dei nemici che volessero distruggere la comunità sikh. Il martirio era il massimo onore concesso a coloro che davano la propria vita per
la causa. Tra i simboli offerti dal guru ai suoi seguaci figurano emblemi di
guerra come una spada e uno scudo a forma di braccialetto portato sul
polso. Questa comunità è operante anche oggi. Nel 1982 militanti sikh, sotto
la guida di Saint Jarnail Singh, proclamano la guerra santa in vista dell’ottenimento della piena autonomia politica del Panjab. Anche nel sikhismo,
quindi, è presente l’associazione di religione e politica. Il simbolo oggi più
diffuso della religione sikh è una spada a doppio taglio circondata da un cerchio e da due spade curve incrociate. Jarnail Singh sosteneva che la tradizione sikh, come quasi tutte le tradizioni religiose, normalmente esalta la
non violenza, proibisce di togliere la vita a un altro uomo e che tuttavia l’atto violento occasionale è giustificato. Simranjit Singh Mann distingueva tra
“omicidi indiscriminati” e “omicidi mirati” e diceva che l’assassinio del capo
di governo del Punjab Beant Singh era un esempio di omicidio mirato, poiché quell’uomo simboleggiava la tirannia dello Stato.
Il buddhismo, con la dottrina dell’ahimsa (non violenza), della liberazione
dal dolore attra- verso l’annullamento del proprio io, fonte di attaccamento alle
cose di questo mondo, radice di ogni sofferenza, e attraverso il “nobile ottuplice sentiero”, il cammino salvifico, è meno incline al terrorismo religioso, ad
offrire giustificazioni religiose ad atti di terrore. La svolta nella storia del buddhismo si ha con Asoka, grande sovrano indiano della dinastia Maurya, che
governò dal 268 al 233 a. C. Egli aprì una fase di politica religiosa per imporre in tutto il suo vasto impero (dall’India all’Afghanistan e al Bengala) la fede
buddhista e incoraggiò i monaci ad esportarla al di fuori dell’impero. Una terra
NOTE
Religione e violenza nell’induismo e nel buddhismo
105
106
di missione importante fu proprio l’antica Ceylon (oggi Sri Lanka). Il re locale
accolse la nuova religione e fece costruire nella capitale dell’isola il Grande
Monastero, che per molti secoli fu il principale centro monastico di tutta l’isola. “L’associazione di religione e politica, dunque, nel caso di Sri Lanka appartiene alle origini stesse della diffusione del buddhismo. È a Ceylon, infatti, che
il Canone Pali verrà fissato definitivamente verso il 35 a. C. L’identificazione
fra buddhismo e monarchia politica si venne rafforzando nel corso dei secoli
quando l’isola subì ricorrenti invasioni e successive colonizzazioni di altri
popoli. Così accadde con le popolazioni hindù di cultura Tamil, così come con
le popolazioni conquistate alla fede musulmana e, infine, con le minoranze
cristiane (anglicane e cattoliche), importate dal colonialismo europeo, in particolare inglese”59.
Il buddhismo è forse la tradizione religiosa dove meno ci si aspetta di trovare violenza e il Giappone il luogo dove meno si potrebbe pensare a un atto
violento di terrorismo religioso. Eppure, una branca del buddhismo giapponese, l’Aum Shinrikyo, è responsabile dell’attentato alla metropolitana di Tokyo
del 20 marzo 1995, con il velenoso gas sarin, in cui rimasero uccisi molti viaggiatori pendolari e feriti migliaia d’altri. “Fu uno dei pochi casi di attivismo religioso al mondo in cui si utilizzò un’arma di distruzione di massa per un atto terroristico”60. Fu un nuovo tipo di terrorismo: “un terrorismo che creava un evento colossale in nome di una visione catastrofica della storia del mondo”61. Lo
scopo era dimostrare la veracità delle profezie del leader, Shoko Asahara, su
un’imminente guerra apocalittica, la Terza Guerra Mondiale, più catastrofica
della Seconda. “Armageddon” era il termine da lui scelto per questo cataclisma, per questa immane catastrofe, catastrofe globale. È un termine che si
trova nell’Apocalisse (16, 16-21) e si riferisce al luogo dove avverrà la battaglia
tra il bene e il male. Nel racconto biblico, un terremoto squarcia la grande città
dell’Anticristo e, nella catastrofe che segue, tutte le nazioni periscono. Asahara aveva preso le profezie dell’Apocalisse e le aveva mescolate con visioni del
Vecchio Testamento e affermazioni dell’astrologo francese del sedicesimo
secolo Nostradamus (Michel de Nostredame). Tra le varie predizioni sulla
grande conflagrazione alla fine del ventesimo secolo ce n’era una che diceva
che sarebbe stato usato il gas nervino, precisamente il sarin, contro la popolazione.
La dottrina dell’ahimsa (non violenza) non offre giustificazioni religiose ad
atti di terrore. Eppure, nello Sri Lanka gli atti di violenza perpetrati da combattenti cingalesi negli ultimi decenni del ventesimo secolo sono stati sostenuti da monaci buddhisti. Proprio un monaco buddhista nel 1959 uccise il
primo ministro dello Sri Lanka, S.W.R.D. Bandaranaike. Quest’uccisione è la
prova che i buddhisti giustificano la violenza su basi morali. I monaci vengono a svolgere così un ruolo sempre più attivo in campo sociale e politico, promuovendo le virtù predicate dal Buddha come virtù civiche e favorendo la diffusione dell’idea che si possa effettivamente costruire uno Stato buddhista,
riflesso dell’identità culturale e religiosa del popolo cingalese, un caso di
etno-fondamentalismo.
“La particolarità del terrorismo religioso sta nel fatto che è quasi esclusivamente simbolico, messo in atto con metodi altamente drammatici”62. Gli spettacolari attacchi aerei al World Trade Center e al Pentagono dell’11 settembre
2001 ne sono drammatici esempi. Il World Trade Center simbolizzava la portata globale dell’economia americana, il suo ruolo nel commercio trasnazionale globale. Il World Trade Center e il Pentagono erano icone-simbolo del potere politico ed economico laico. Gli atti terroristici sono simbolici nel senso che
essi hanno lo scopo di illustrare o alludere a qualcosa che va oltre il loro bersaglio immediato; sono “eventi drammatici” “concepiti per rimanere impressi in
virtù della loro importanza simbolica”63. L’attentato con il gas nervino dell’Aum
Shinrikyo è più simbolico che stragetico. In alcuni casi il simbolismo del luogo
era specifico: le cliniche per aborti negli Stati Uniti, colpite dagli attivisti religiosi del movimento per la vita. In altri era più generico: il Pentagono, il World
Trade Center e l’edificio federale di Oklahoma City. Si tratta di luoghi centrali,
simboli di potere, e gli atti terroristici li rivendicano in modo simbolico: “esprimono il potere dei gruppi terroristici di controllare, almeno per un momento, i
luoghi centrali del potere, danneggiandoli, terrorizzandoli e assaltandoli, anche
quando in realtà, per la maggior parte del tempo, non li controllano affatto”64.
Gli atti terrostici, quindi, “possono essere al tempo stesso “eventi di performance”, in quanto operano un’affermazione simbolica, e “atti performativi”, nella
misura in cui cercano di cambiare le cose”65.
Questi atti sono accompagnati da forti rivendicazioni di giustificazione
morale e da un tenace assolutismo, “caratterizzato dall’intensità dell’impegno
degli attivisti religiosi e dalla portata ultrastorica dei loro obiettivi”66. La ricerca
intensa di un livello più profondo di spiritualità di quello offerto dai valori superficiali del mondo moderno caratterizza gli attivisti religiosi. Abouhalima, uno
degli attentatori al World Trade Center del 1993, diceva che il punto più basso
della sua vita lo aveva toccato durante il soggiorno in Germania, in cui i conforti superficiali del sesso e degli inebrianti mascheravano un vuoto e una
disperazione interiori e voleva una religione dura, l’islam tradizionale, e non
quello dei musulmani moderni e progressisti, contro i comfort della modernità
laica e contro lo Stato laico, che, per sua stessa natura, si oppone all’idea che
la religione debba avere un ruolo nella vita pubblica. Gli attivisti religiosi contrastano il modernismo e il laicismo, criticano la vacuità della moderna vita
laica e auspicano cambiamenti rivoluzionari che instaurino un ordine sociale
religioso. La sfida da essi lanciata è profonda, “perché contiene una critica
sostanziale alla politica e alla cultura laica e postilluminista mondiale”67.
L’altra particolarità del terrorismo religioso contemporaneo è la globalità,
per l’impatto, in gran parte dovuto alla copertura mondiale e istantanea fornita
dai mezzi d’informazione, e per la natura transnazionale della scelta degli
obiettivi e delle reti cospiratorie. Tra le vittime degli attacchi dell’11 settembre
c’erano cittadini di ottantasei diverse nazioni. I membri della rete di al Qaida,
autori di questi attentati, sono multinazionali e i loro piani sono organizzati in
luoghi tra i più diversi: Germania, Spagna, Sudan, Marocco e Stati Uniti.
NOTE
Particolarità del terrorismo religioso
107
Un’altra particolarità è che il terrorismo religioso considera il conflitto in termini essenzialmente escatologici come battaglia tra il bene e il male e, per un
processo di satanizzazione, trasforma la lotta terrena in una sfida tra martiri e
demoni. L’America, più di ogni altra nazione, è il nemico, perché è laica, è satana, capitale del demonio, incarnazione delle forze del male, per tre motivi. Il
primo è che gli Stati Uniti difendono e sostengono governi laici considerati dai
loro avversari religiosi come nemici primari. Il secondo è il loro sostegno alla
cultura moderna. Il terzo è economico, la globalizzazione. Satana, negli anni
venti, erano i bolscevichi e i prussiani. Nella pubblicistica fondamentalista l’impero prussiano veniva evocato come la “Bestia” dell’Apocalisse, mentre il bolscevismo identificato con l’Anti-Cristo. Ad essi veniva contrapposta la forza di
resistenza della Nazione benedetta da Dio, gli Stati Uniti, sovente chiamata la
Nuova Gerusalemme in terra.
I fondamentalismi
108
La tensione utopica verso una società governata dalla legge di Dio, la tendenza a tornare ai fondamenti, la pretesa “di creare un regime di verità”68, il
modo di pensare “altrimenti” rispetto agli stili di vita e ai valori della modernità
accomuna i diversi fondamentalismi, da quello islamico a quello ebraico, da
quello cristiano a quello delle religioni orientali.
Il fondamentalismo mette in evidenza l’infondatezza dei legami sociali nelle
moderne società di massa non più annodati a Dio e propone la rifondazione di
essi sulla legge religiosa, sulle regole contenute nel Libro sacro. Per i fondamentalisti, il ricorso alla violenza sacra appare una scelta obbligata. Essi lottano contro il pluralismo democratico, il secolarismo, il comunismo, l’Occidente
capitalistico, lo Stato moderno eticamente neutrale, il Nemico che tende a far
perdere le loro radici, smarrire la loro identità collettiva, un popolo che ha un
patto di alleanza con una legge sacra. L’inerranza del Testo sacro e il richiamo
alla lotta armata per abbattere il Nemico, il Male, che impedisce il trionfo del
Bene, sono i due elementi di base del fondamentalismo. Il fondamentalismo
protestante americano vuole riconquistare al messaggio di salvezza biblico la
società secolare e scristianizzata, rifondare la società su basi religiose, restituendola ai valori originari contenuti nella Bibbia.
Analogamente il fondamentalismo islamico cerca di ristabilire l’ordine ideale della Città islamica, che è alla base dell’islam e della sua espansione nei
secoli d’oro, in cui religione, società e politica erano strettamente legate tra loro
secondo una precisa gerarchia ordinativa, avente come strumento di regolazione sociale la shari’a. Centrale è il concetto di “combattimento sulla via di
Dio” o jihad: un vero e proprio nuovo pilastro dell’Islam, che viene ad aggiungersi ai cinque tradizionali (professione di fede, preghiera cinque volte al giorno, elemosina rituale, il pellegrinaggio alla Mecca e la pratica del digiuno
durante il mese sacro di Ramadhan).
Il ricorso alla violenza sacra è praticato soprattutto dallo jiadismo, dal FIS
(Fronte islamico di salvezza), dall’AIS (Armata islamica di salvezza), dal GIA
NOTE
(Gruppi islamici armati) e dai gruppi come Hamas (Movimento per la resistenza islamica, il cui acronimo in lingua significa “fervore”) e la Jiad islamica palestinese. Questi gruppi, a partire dagli anni Novanta, hanno praticato la jiad
nella forma del martirio, facendosi saltare in aria insieme alle loro vittime, “con
il duplice obiettivo di gettare terrore […], da un lato, e di fornire un esempio di
militanza per fede ad altre centinaia di potenziali martiri, dall’altro”69.
Nei giorni nostri assistiamo ai martiri suicidi, ad attentati suicidi, ad atti di
automartirio, fondati su principi religiosi. Il suicidio è proibito nell’Islam ma gli
islamisti radicali interpretano l’essere “uccisi sulla via di Dio” (Corano,II,154)
come forma di martirio. Il Corano vieta di uccidere; nonostante ciò, esistono
altri principi islamici che giustificano l’omicidio. Del resto, una storia di guerre
e battaglie caratterizza l’islam fin dall’inizio. Lo scrittore contemporaneo egiziano Abd al-Salam Faraj nel suo pamphlet Al-Faridah al-Gha’ibah (Il dovere trascurato) dà una giustificazione religiosa alle azioni di islamismo radicale. Intende la jihad, lotta, letteralmente; sostiene che il dovere trascurato è quello della
jihad come guerra santa e incita perciò al combattimento. Secondo alcuni
mistici islamici, la vera jihad è quella che avviene nell’animo di ogni individuo:
sostituiscono il significato originario di jihad come azione di guerra, considerandolo, invece, in senso spirituale, una lotta contro l’anima, come per esempio in Cor. 22: 78: “E lottare nella via di Dio come è degno che si lotti. Egli vi
ha prescelti, e non vi ha imposto nella religione pesi gravosi”.
Anche i Talebani, gli “studenti di teologia”, in Afghanistan, hanno fatto ricorso alla lotta armata, instaurando nel 1996 un regime shariatico ancora più rigido di quello wahhabita saudita.
“Con Bin Laden lo jihadismo diventa davvero globale”70. Il manifesto ideologico del Fronte islamico, al quale aderisce Bin Laden, si apre con il versetto
coranico che incita all’uccisione dei “pagani” ovunque si trovino e attraverso
ogni “stratagemma”. A conferma della tesi sullo jihad globale e sull’uso del terrorismo come mezzo lecito.
Nel 1996 Bin Laden diffonde un proclama in cui invoca apertamente lo
jihad contro l’America, il “Grande Satana”. Nella “Dichiarazione di guerra contro gli americani” definisce la presenza americana in Arabia Saudita come “la
più grave delle aggressioni” contro l’Islam e fa appello allo jihad totale per liberare i Luoghi Santi dall’occupante americano. Nel 1998 le ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania sono distrutte; nell’ottobre 2000 la nave americana
“Cole”è attaccata nello Yemen da un commando suicida: muiono diciassette
marinai. L’11 settembre 2001 gli uomini che portano gli aerei dirottati, usati
“come spada dell’Islam”, a decapitare le Twin Towers e a cadere sul Pentagono, simboli del potere finanziario e militare, sono, per Bin Laden, “martiri per la
causa di Allah”. Lo stesso Bin Laden, in una delle sue prime videocassette trasmesse dalla televisione al Jazira dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001,
lodava Dio dicendo che le torri gemelle del World Trade Center erano crollate
per il suo volere. L’America è definita “il simbolo del paganesimo nel mondo
moderno (jahiliyya)”. Gli uomini che l’hanno colpita si sono guadagnati un
posto in paradiso. I giovani suicidi musulmani, compiendo la mortale missione,
dicevano d’incontrarsi con il Signore dell’universo. Un attentatore suicida dice-
109
110
va che quando sarebbe saltato in aria e sarebbe diventato un santo martire di
Dio, avrebbe avuto un posto in paradiso per lui e la sua famiglia, settandue vergini e un pagamento in contanti, per la sua famiglia, di seimila dollari 71. “Il potere di quest’idea è stato enorme. Ha superato tutte le normali rivendicazioni di
autorità politica e ha elevato le ideologie religiose fino ad altezze soprannaturali”72. La conclusione è: “perfino all’alba di un nuovo millennio, la religione continua a rivendicare un ruolo nella vita pubblica”73.
Con la grande coalizione anti-terrorismo, l’islamismo radicale subisce una
sconfitta molto dura, “ma il suo carattere di movimento diffuso e transnazionale, toccato relativamente dalla guerra, fa sì che esso possa ancora riorganizzarsi sotto forma di jihadismo globale. Unica forma che, nell’era della globalizzazione, consente la pratica della guerra asimmetrica anche di matrice
religiosa”74.
Il fondamentalismo ebraico, gli ultraortodossi o haredim (letteralmente
“coloro che tremano davanti alla Parola di Dio”, secondo il versetto biblico Isaia
66,5), accanto agli elementi tipici di ogni fondamentalismom, come l’inerranza
del Testo sacro e la superiorità della Legge religiosa su quella mondana, vi
aggiunge una dimensione etnica e un messianismo salvifico legato ad una precisa dimensione territoriale. Gli haredim sono contro il sionismo. Con la Shoah,
il genocidio degli ebrei ad opera del nazifascismo in Europa, cambiano atteggiamento e si convincono che l’immigrazione, prima nello Yishuv, l’insediamento ebraico in Palestina, poi nello Stato d’Israele, sia inevitabile. Molte
comunità scelgono gli Stati Uniti. Quelle emigrate in Israele mantengono il loro
rifiuto verso uno Stato non retto dalla Torah.
Germi di fondamentalismo si trovano nell’induismo e nel sikhismo, più nel
sikhismo contemporaneo rispetto al neo-hinduismo moderno. Queste due religioni difendono l’identità etno-religiosa, minacciata dalle classi dirigenti secolariste, dall’islam e dall’Occidente, e reclamano il ritorno alla purezza delle fonti
religiose per rifondare l’identità stessa.
Anche il buddhismo, dottrina dell’ahimsa (non violenza), che privilegia la
meditazione, l’elevazione spirituale, l’attingimento dello stadio ineffabile del
Nirvana, non sfugge alla tentazione fondamentalista. In Sri Lanka (l’antica
Ceylon), infatti, si realizza l’associazione di religione e politica: i monaci sono
impegnati socialmente e politicamente, sono “soldati di Buddha”, così li definisce Dharmapala, fondatore del modernismo buddhista. Legittimano il ceto politico, la monarchia (il principe, il re), che si mostra favorevole alla costruzione
di un regime buddhista di Stato. Questo è fondamentalismo. Che cosa è, infatti, il fondamentalismo? Esso è “l’involucro che cela le moderne forme del conflitto politico sotto specie religiosa”75.
Nel cattolicesimo il fondamentalismo non attecchisce, grazie all’autorità del
magistero della Chiesa, che si interpone tra il credente e la Parola contenuta
nel Libro sacro. Tentativi fondamentalisti comunque non mancano, come l’integrismo nell’Ottocento, che si sforza di rifondare la società su fondamenti cattolici, e lo scisma di Lefebvre, che esalta la tradizione come un deposito di fede
sempre inerrante e irreformabile. Il Concilio Vaticano II (1963-1965), restituendo centralità alla Bibbia, ha favorito l’approccio diretto al Testo e l’appello
Conclusione
Di fronte al terrorismo religioso che fare? Ci sono cinque possibilità, risposte, soluzioni, scenari: distruggere la violenza, terrorizzare i terroristi, rassegnarsi alla vittoria della violenza, separare la religione dalla politica, riconciliare politica e religione.
L’America, all’indomani dell’11 settembre, ha reagito con attacchi militari
contro i Talebani e gli accampamenti di al Qaida. In seguito a questi attacchi,
la simpatia mondiale per l’America come vittima si è rapidamente trasformata
in sdegno per la sua aggressività. Non solo. Con la rappresaglia americana è
aumentato il numero di volontari disposti a sostenere al Qaida. Così la spirale
di violenza è cresciuta. “Le rappresaglie di solito non distruggono completamente l’obbiettivo su cui sono dirette, creano le condizioni per ulteriori atti terroristici e si inseriscono all’interno degli scenari di guerra dei terroristi in cui è
difficile trovare un compromesso”76. Anche il terrorizzare i terroristi ha un effetto deterrente scarso. In effetti “una risposta dura da parte del governo può in
realtà incoraggiare gli attivisti, perché contribuisce a confermare la loro percezione di un mondo in guerra tra forze laiche e forze sacre”77.
Questo significa che l’idea di guerra, così come finora l’abbiamo conosciuta,
guerra convenzionale, è improponibile in uno scenario come quello attuale. L’attacco dell’esercito americano in Afghanistan è stato percepito, nel mondo
musulmano, come un uso della forza eccessivo e ingiustificato. Oggi il conflitto
contro il terrorismo deve avere un assetto mirato, “chirurgico”, dal momento che
i terroristi sono presenti ovunque. Il terrorismo si presenta come un’entità sovranazionale che trova protezione in molti stati del Medio Oriente e non solo. Que-
NOTE
all’autorità della parola rivelata in esso contenuta da parte di gruppi laicali e di
comunità spontanee che si diffondono tra il 1965 e il 1976 in molti paesi cattolici, dove fiorisce la cosiddetta “teologia della liberazione”. Ciò ha favorito
anche la radicalità delle scelte evangeliche di alcuni gruppi e di alcuni preti, che
hanno osato contestare la Chiesa, accusata di arroccamento tradizionalista e
di compromesso con i regimi politici, e intraprendere la strada della guerriglia,
come don Camillo Torres in Colombia.
Una lettura di tipo fondamentalista della Bibbia è rintracciabile nel movimento dei neo-catecumenali. Nato a Madrid, nel 1964, per opera di Kiko
Arguelo, coadiuvato da una giovane donna, Carmen Hérnandez, conosce un
forte impulso subito dopo il Concilio. Questo movimento non impegna i cattolici in politica, ma tende a ricostruire dal basso una micro-società permeata dai
valori religiosi, a fronte della società costituita percepita alla deriva, a causa del
consumismo, della secolarizzazione e dell’indifferenza religiosa. Un impegno
in politica richiede invece Comunione e Liberazione, un movimento fondato da
don Giussani negli anni Sessanta e che ha conosciuto la sua fase aurea tra la
fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Suo obiettivo era riconvertire la
Democrazia Cristiana a una più netta identità cattolica per arginare la deriva
secolarista della società italiana.
111
112
sto significa anche che la guerra al terrorismo non è facile e non breve: tutti
siamo potenziali vittime di un nemico-ombra, un nemico non facilmente identificato e, cosa forse più importante, limitato a una regione specifica. Gli avversari di al Qaida dell’America come i nemici palestinesi di Israele, infatti, sono mobili e quindi i tentativi di schiacciarli non sortiscono l’effetto desiderato.
C’è un caso in cui il terrorismo vince ed è quello in cui la violenza viene
usata come elemento condizionante per accordi negoziati, per compromessi,
per trattative politiche e gli obiettivi che stanno dietro alla lotta vengono raggiunti. Nei confronti dei terroristi religiosi, abbiamo detto, ci sono cinque possibilità: vincerli, intimidirli per indurli ad arrendersi, accordarsi con loro, separare
la religione dalla politica, riconciliare la religione con la politica.
Separare la religione dalla politica e confinarla nelle chiese, nelle moschee,
nei templi e nelle sinagoghe non soddisfa la maggior parte degli attivisti religiosi, i quali considerano che la manifestazione sociale della lotta universale (così
considerano la lotta) sia l’essenza stessa della loro fede. Eppure, a cavallo del
ventunesimo secolo, in molti paesi islamici c’è stata una certa reazione contro
la religione politicizzata. Nel 1999, gli studenti iraniani hanno manifestato a
sostegno del teologo moderato Abdol Karim Soroush, che distingue tra ideologia e religione e sostiene che il clero musulmano non debba immischiarsi nella
politica. La jihad, per lui, consiste in una battaglia spirituale o in una sfida tra
posizioni morali, in una contesa di idee, piuttosto che tra nemici armati.
Soroush propone una religiosità musulmana simbolicamente ricca per fare
quello che secondo Girard la religione dovrebbe saper fare: deviare la violenza tramite la sua legge rituale.
Secondo Girard, l’uomo è desiderio mimetico, cioè desiderio di essere
secondo l’altro, il modello. Ne scaturisce violenza, conflittualità, rivalità: il modello si sentirà in pericolo d’essere superato e tenderà a rafforzare la propria presunta superiorità. Il rimedio ad uno stato di violenza generalizzata è il meccanismo o processo vittimario, cioè la violenza di tutti contro uno, il capro espiatorio, la vittima, che perciò viene sacralizzata. Cristo non si lascia ridurre ad un
semplice capro espiatorio, non assume su di sé la violenza collettiva, si oppone alla logica della mimesi, si dichiara innocente e così facendo contrasta e
svela il processo vittimario e chiede una riconciliazione senza più vittime sacrificali, senza più violenza. Il cristianesimo, per Girard, smaschera il meccanismo
sacrificale e scommette sull’uomo, il quale, senza intermediari sacrificali, assumendosi in pieno le proprie responsabilità, imbocca la strada della rinuncia alla
violenza, la sola in grado di assicurare un avvenire. Scrive Girard: “Ormai non
si tratta più di propendere educatamente ma in modo distratto per un vago ‘ideale di non violenza’. […]. Ormai si tratterà sempre più di una necessità implacabile. La rinuncia alla violenza definitiva e senza riserve si imporrà a noi come
condizione sine qua non di sopravvivenza per l’umanità stessa e per ciascuno
di noi. […]. L’irruzione di una vera scienza dell’uomo ci introduce in un clima
radicalmente diverso; prepara un universo di responsabilità assoluta”78. Gli unici
responsabili della violenza sono sempre e solo gli uomini. “L’idea di un istinto –o
se si vuole di una pulsione– che porterebbe l’uomo verso la violenza o verso la
morte –il famoso istinto di morte, o pulsione, in Freud– non è che una posizio-
NOTE
ne mitica di ripiego, un combattimento di retroguardia dell’illusione ancestrale
che spinge gli uomini a porre la loro violenza fuori di se stessi, a farne un dio,
un destino, o un istinto di cui essi non sono più responsabili, che li governa dal
di fuori. Si tratta ancora una volta di non guardare in faccia la violenza, di trovare una nuova scappatoia, di procurarsi, in certe circostanze sempre più aleatorie, una soluzione sacrificale di ricambio”79. L’uomo, dunque, deve assumere in
pieno le proprie responsabilità e deve scegliere la strada della rinuncia alla violenza, la sola in grado di assicurare un avvenire. Il tono apocalittico qui non
vuole affatto contribuire alle isterie da “fine del mondo”, ma vuole rendere evidente “l’unica via che ormai ci resta aperta, quella di una riconciliazione che non
escluderà nessuno e non dovrà più nulla alla violenza”80.
La quinta risposta al terrorismo religioso è la scelta del governo di attenersi a valori morali e spirituali. Questo rende difficile agli attivisti religiosi raffigurare il governo come un nemico satanico. La mancanza di morale e obiettivi
spirituali, o peggio ancora, la corruzione morale, l’insignificanza spirituale, il laicismo è il motivo per il quale gli attivisti religiosi attaccano il governo. D’altra
parte, Rousseau, per definire quelli che considerava i fondamenti morali e spirituali essenziali per qualsiasi società moderna che volesse mantenere un ordine politico duraturo, aveva coniato il termine “religione civile”, non basata sui
“dogmi della religione”, ma sulla “santità del contratto sociale”81.
La domanda allora è: c’è un terreno neutrale per incontrarsi e riconciliarsi?
L’arte, l’istruzione, lo sport? Ad un giovane sostenitore di Hamas scelto per un
attentato suicida fu chiesto se era disposto ad eseguire la sua missione suicida in uno stadio di calcio, pieno di suoi nemici, sionisti e infedeli. Il giovane
rispose “no”. Per lui il calcio era al di sopra del vortice del terrorismo, rappresentava un terreno neutrale, al pari dell’istruzione e dell’arte. Ad un membro di
Hamas fu chiesto su quale terreno la futura generazione di palestinesi e israeliani avrebbe potuto incontrarsi e riconciliarsi. Rispose: “in un’università”. La
religione può essere un terreno neutrale per incontrarsi e riconciliarsi allo stesso modo dell’arte, dell’istruzione e dello sport? Sì, anzi, più dell’arte, dell’istruzione e dello sport, anche se i fatti non lo confermano. Sì, perché si è figli dell’unico Dio, almeno per le religioni monoteistiche.
Ai fini del rapporto Oriente-Occidente, va detto che la civiltà arabo-islamica
ha avuto un ruolo rilevante nella cultura europea, soprattutto per quanto riguarda le scienze fisico-matematiche, filosofiche, naturali e artistiche. C’è un intreccio di destini che nascono da un luogo, il Mediterraneo. Le tre grandi religioni
monoteiste, infatti, condividono territori molto vicini e, in parte, si specchiano
nelle stesse acque, integrandosi e interagendo nella parabola della storia. Non
solo, fanno parte tutte e tre del ceppo semitico e hanno in comune la radice
abramitica: riconoscono Abramo come loro capostipite.
Abramo è l’“ospitale” per antonomasia, animato da uno spirito di convivialità e questa sua qualità connette strettamente la sua figura al problema dell’accoglienza dell’altro. Nelle icone russe i tre Angeli che Abramo ospita, prefiguranti la Trinità, vengono sempre rappresentati a tavola. Il tema dell’ospitalità è
centrale nella vicenda di Abramo, visitato più volte dagli Angeli, come nel dipinto di Gaudenzio Ferrari (1471-1546), in cui egli stesso serve a tavola.
113
114
Nello spirito di Abramo, i rapporti tra gli uomini e le nazioni dovranno essere animati, secondo un termine caro a Giovanni Paolo II e a Carlo Maria Martini, appunto, “da uno spirito di convivialità”. In quanto discendenti di Abramo,
dobbiamo anche noi essere ospitali, cioè pronti ad accogliere l’altro e non a
demonizzarlo, accentuando, così, i rischi di reciproca esclusione.
Abramo, dunque, figura classica del dialogo interreligioso, è quel terreno
neutrale per incontrarsi e riconciliarsi, è lo “spazio” per l’incontro ebreo-cristiano-arabo. Dalle due prime consonanti che formano il nome di Abraham, Ibrahim, potrebbero derivare sia il termine “Arabi” sia quello “Ebrei” ad indicare
che, proprio su questo legame, si dovrà innescare un duraturo processo di
pace fra queste due nazioni da troppo tempo in guerra.
Abramo è esempio perfetto dell’uomo credente che si affida totalmente a
Dio, fino ad essere disposto a sacrificare suo figlio Isacco. L’Antico Testamento parla di Abramo come il padre di una moltitudine di popoli (Genesi 17, 4-7).
Il tema è espresso da vari autori del Nuovo Testamento, soprattutto da Paolo,
in particolare nella Lettera ai Romani e nella Lettera ai Galati. Anche il Corano
riprende l’immagine di Abramo come guida spirituale dell’umanità (cfr.Sura
della Vacca); contesta, però, sia agli ebrei sia ai cristiani la pretesa di monopolizzare la figura di Abramo e rovescia questa pretesa a favore dell’Islam (cfr.
Ivi, II, 135 e III, 65-68). Nell’Islam Abramo è il testimone del monoteismo più
radicale e, come le altre figure bibliche, è il modello della sottomissione perfetta a Dio. Invece la nozione di promessa o alleanza fatta ad Abramo, così come
quella di “storia della salvezza”, che è comune all’ebraismo e al cristianesimo,
sono praticamente assenti dall’Islam. Perciò il Concilio Vaticano II, nella costituzione dogmatica Lumen gentium, afferma: “Il disegno della salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in primo luogo i
musulmani, i quali, professando di tenere la fede di Abramo, adorano con noi
un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale” (n.16).
La prima redazione di questo testo diceva: “I figli d’Ismaele che, professando
Abramo per padre, credono anche nel Dio di Abramo”. La redazione definitiva
non si pronuncia sulla relazione tra i musulmani e Abramo, ma afferma solo
che i musulmani professano di “tenere la fede di Abramo”.
Nella memoria di Abramo, dopo tante “guerre sante”, inseguiamo la promessa di una pace santa, “accettando la sfida del confronto e della competizione nella pace, praticando la diciplina della ricerca ed esaltando la pazienza
del dialogo, anche quello, anzi soprattutto quello con le religioni del mondo”82,
convinti che le condizioni di una pace perpetua “non saranno prodotte dall’illusione di abolire i conflitti, ma dalla decisione di incanarli e guidarli per le vie di
una competizione dialogante, nella quale nessuno rinunci alla propria identità,
ma ciascuno la persegua permettendo ed anzi promuovendo l’identità dell’altro come altro”83. Questo promuovere l’identità dell’altro come altro non pare
possa avere un nome diverso da quello che il cristiano designa con il termine
agape. Abramo è la figura classica del dialogo interreligioso.
Assistiamo, oggi, ad una reviviscenza delle religioni. Si tratta di incanalare
l’esplosione incontrollata della loro aggressività verso una concordia senza violenza. Perché, infatti, prima che sia troppo tardi, non gettare le basi di un’intesa
NOTE
universale? Perché non avviare il progetto di un consenso di fondo, che veda
promotrici le religioni? Riprendendo per qualche aspetto l’antico sogno illuministico, potrebbe sembrare opportuno appellarsi a un ragionevole denominatore
comune allo scopo di trovare un vincolo da tutti condivisibile, che riesca a frenare e ammansire l’aggressività esclusivista di alcune religioni. “Occorrerebbe perciò non esaltare, ma appianare le differenze tra le religioni, contenendole e anzi
relativizzandole drasticamente, se si vuole davvero far germogliare nel deserto
del mondo il fiore della pace perpetua”84. Nel mondo, infatti, “non ci sarà pace fra
gli uomini finché non si stabilirà la pace fra le stesse religioni”85. I rappresentanti
delle religioni mondiali hanno cominciato a incontrarsi fra di loro e a pregare
insieme, molti si adoperano per delle pratiche comuni di solidarietà per i deboli e
di liberazione per gli oppressi. Ciò indubbiamente favorisce la pace.
Nel cammino verso un’armoniosa unità delle religioni e dei popoli non è
Gesù Cristo un intralcio imbarazzante con la sua smodata rivendicazione di
assolutezza, col suo farsi Dio? In qual modo si potrà chiamarlo Dio, oggi, non
solo dinanzi a Israele, ma anche dinanzi all’islam, all’induismo, al buddismo?
“Certo Gesù Cristo fa ostacolo. Ma non potrebbe egli costituire pure una risorsa per l’accoglienza reciproca, che a ogni costo bisogna pur promuovere fra
tutte le religioni e anzi fra tutti gli uomini? Egli inevitabilmente è un problema.
Ma non potrebbe egli diventare anche una soluzione? D’altra parte, accantonare semplicemente la pietra d’inciampo potrebbe anche equivalere a costruire senza pietra angolare. Ma in qual modo Gesù Cristo potrebbe costituire non
la rovina, bensì la salvezza della stessa verità, che rivendicano, ciascuna per
sé, le diverse religioni, strette come sono fra antagonismi e irrilevanza nel
mondo nuovo in gestazione?”86.
Nel rapporto fra le religioni è in gioco la questione stessa dell’essenza della
verità. Le soluzioni del rapporto delle religioni con la verità possono essere:
l’esclusivismo (la verità solo da una parte), l’inclusivismo (la verità parzialmente dappertutto, ma in pienezza solo in una parte), il pluralismo (verità molteplice e particolare).
Nel Vangelo di Giovanni si trova la perentoria identificazione della verità con
la persona di Cristo (persona veritatis): “Io sono la verità (Egò eimi e alétheia)
(Gv 14,6) si autoproclama Cristo. Egli solo è verità esclusiva, inclusiva e pluralista. È verità esclusiva “perché respinge qualsiasi omologazione e tanto più qualsiasi assimilazione a eventuali altre figure di rivelazione e di salvezza”87. È verità inclusiva, “perché si pone come centro al quale convergono e dal quale si
dipartono tutti i cammini di verità intrapresi dagli uomini nella storia del mondo”88.
È verità pluralista “perché egli è persona veritatis nel modo dell’enigma, e ciò
strutturalmente, in corrispondenza certo alle caratteristiche della storicità dell’uomo e della mondanità del mondo, ma anche e prima ancora in corrispondenza
al suo stesso “divenire carne”“89. Per attestare la verità che egli stesso è, si fa
appunto obbediente fino alla morte e alla morte di croce (Kénosi).
Il cristianesimo viene a possedere una chance distintiva e vincente proprio
in Cristo, che sembrerebbe costituire l’ostacolo supremo alla concordia tra le
religioni. La sua pretesa di essere rivelazione e salvezza l’avanza e la fa valere nella forma dell’agape, cioè dell’amore che si dona per tutti fino all’estremo
115
116
sacrificio di sé. Cristo è l’a-létheia di Dio perché è l’a-létheia dell’agape. Qui sta
l’excessus del concetto cristiano di salvezza, rispetto, per esempio, al concetto buddhista di liberazione attraverso la concentrazione e il distacco, e al concetto del conseguimento del Brahman sostenuto dalla mistica advaita indù.
L’unicità e l’assolutezza della verità cristiana non fomenta la violenza, perché
la sua ricerca “è un’urgenza che scaturisce da quella stessa agape che alla verità sempre si accompagna e a cui la verità si finalizza”90. Diversamente da una
umanistica tolleranza o da un cosmopolitico ecumenismo, “l’agape neotestamentaria impone l’esigenza non solo di riconoscere l’altro in quanto altro da sé
simile a sé, ma perfino di donarsi incondizionatamente a lui fino al sacrificio di sé,
affinché questi sia se stesso nella sua propria identità”91. L’agape, la quale “si
compiace della verità” (1 Cor 13,6), “è la risorsa radicale e distintiva che può far
valere il cristianesimo. È in forza di questo amore che Gesù Cristo è, infatti,
morto per tutti gli uomini e anche per tutte le religioni del mondo, perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”92. Cristo, “segno di contraddizione” (Lc
2,34), “scandalo”per i giudei e “follia”per i pagani (1Cor 1, 22-23), “pietra d’inciampo”e “testata d’angolo”(At 4,11;1Pt 2,8), “costituisce la risorsa e non soltanto l’ostacolo che il cristianesimo può e deve far valere nell’inevitabile e già avviato incontro delle religioni mondiali. È a partire da lui che ci si può e deve muovere all’altro nel modo più schietto e generoso, e questo, paradossalmente, proprio
facendo leva sulla sua pretesa di verità incondizionata”93.
M. JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, Editori Laterza, Roma-Bari 2003, p.268.
M. RUTHVEN, Islam, Giulio Einaudi editore, Torino 1999, p.3.
3 Ivi., p.140.
4 Ibid.
5 E. PACE, Il regime della verità, il Mulino, Bologna 1998, p.160.
6 Ibid.
7 M. JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit., p. IX.
8 Ivi, p. 253.
9 Ibid.
10 Ivi, p. X.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Cfr. R. ROBERTSON, Globalization, politcs and religion, in J. A. BECKFORD, T. LUCKMANN (a cura
di), The Changing Face of Religion, Sage, London 1989; A new perspective on religion and secularization in the global context, in J. K. HADDEN, A. SHUPE (a cura di), Secularization and Fundametalism Reconsidered, Paragon House, New York 1989; Globalization:Social Theory and Global
Culture, Sage, London 1992.
14 Cfr. S. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations, in “Foreign Affairs”, 1993, n.39, ora rifuso e
arricchito nel libro Lo scontro delle civiltà, Garzanti, Milano 1998.
15 M. JUERGENSMAYER, Terroristi in nome di Dio, cit., p. XI.
16 Ivi, p. IX.
17 Ivi, p. X.
18 Ivi, p. 5.
19 Ibid.
20 Ivi, p. XI.
21 Ivi, p. XVII.
1
2
Ivi, p. 6.
W. CHRISTOPHER, Fighting Terrorism: Challenges for Peacemakers, discorso al Washington
Institute for Near East Policy, 21 maggio 1996. Ristampato in Id., In the Stream of History: Shaping Foreign Policy for a New Era, Stanford University Press, Stanford (CA) 1998, p. 446.
24 M. JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit., p. 7.
25 Ibid.
26 Ivi, p. 209.
27 Ivi, p. 11.
28 F. NIETZSCHE, Der Antichrist. Fluch auf das Christentum, in Werke,VI, 3, Walter de Gruyter,
Berlin-New-York 1969; ed. it.: L’anticristo. Maledizione del cristianesimo,in Opere,VI, 3, trad. di F.
Masini, Adelphi, Milano 1970, § 62, p. 260.
29 M. JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit., p. 19.
30 M. ZAMBRANO, La agonìa de Europa, Madrid, Mondadori 1988; ed.it., L’agonia dell’Europa,
trad.di C. Razza, Marsilio, Venezia 1999, p. 52.
31 E. CASTELLI, Esistenzialismo teologico, Abete, Roma 1966 II ed., pp. 31-32.
32 G. STRUMMIELLO, Il logos violato. La violenza nella filosofia, Dedalo, Bari 2001, p. 259.
33 M. GIULIANI, Cristianesimo e Shoà, Morcelliana, Brescia 2000, p. 108.
34 Ibid.
35 Ivi, p. 19.
36 Ibid.
37 Ivi, pp. 105-106.
38 G. ISRAEL, La questione ebraica oggi, il Mulino, Bologna 2002, pp. 98-99.
39 Ivi, p. 99.
40 M. GIULIANI, Cristianesimo e shoà, cit., p. 110.
41 Ivi, p. 115.
42 Ivi, p. 114.
43 Ivi, p. 115.
44 Ivi, p. 31.
45 Ivi, p. 23.
46 Ibid.
47 Ivi, pp. 147-148.
48 TERTULLIANUS, Ad Scapulam, ed. E. Dekkers [Corpus Christianorum, s. l. 2], Turnhout 1954,
p. 1127.
49 LACTANTIUS, Divinae institutiones [C.S.E.L.19],Wien 1890, v. 19, p. 465.
50 G.MUSCA, Il vangelo e la torah, Edizioni Dedalo, Bari 1999, p. 92.
51 Ivi, p. 98.
52 A. MAALUF, Le Crociate viste dagli Arabi, Torino 1989, pp. 287-288.
53 C. M. MARTINI, Violenza e “parola di Dio”, in Fedi e violenze, a c. di C. M. Martini, Torino 1997,
pp. 119-120.
54 Y. AMIR, cit. in J. GREENBERG, Rabin’s Assassin, in “New York Times”, 5 novembre 1995, p. A1.
55 E. PACE, Il regime della verità, cit., pp. 104-105.
56 Ivi, p.105.
57 Ibid.
58 EHUD SPRINZAK, Violence and Catastrophe in the Theology of Rabbi Meir Kahane: The ideologization of Mimetic Desire, in Violence and the Sacreed in the Modern World, a cura di M. Juergensmeyer, Frank Cass, London 1991, pp. 48-70.
59 E. PACE, R.GUOLO, I fondamentalismi, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 105-106.
60 M. JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit., p. 109.
61 Ivi, p. 111.
62 Ivi, p. 238.
63 Ivi, p. 134.
64 Ivi, p. 144.
65 Ivi, p. 135.
66 Ivi, p. 238.
67 Ivi, p. 251.
68 E. PACE, Il regime della verità, cit., p. 12.
22
NOTE
23
117
Ivi, p. 95.
E. PACE, R. GUOLO, I fondamentalismi, cit., p. 56.
71 Rashid Sakher, un attentatore suicida della Jad islamica, intervistato da Dan Setton nel
documentario Shaheed; l’intervista è stata trascritta e pubblicata con il titolo As Terrorist Moves the
Goalposts, in “Harper’s”, agosto 1997, pp. 19-22.
72 M. JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit., p. 237.
73 Ibid.
74 Ivi, p. 61.
75 E. PACE R. GUOLO, I fondamentalismi, cit., p. 90.
76 M. JUEGERNSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit., p. 262.
77 Ivi, p. 256.
78 R. GIRARD La violence et le sacré, Grasset, Paris 1972; ed. it: La violenza e il sacro, trad. di
O. Fatica-E. Czerkl, Adelphi, Milano 1980 e successive ristampe (utilizziamo qui l’edizione del
1997), pp. 185-186.
79 Ivi, p. 204.
80 R. GIRARD, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, Paris 1978; ed.
it.:Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, trad. di R. Damiani, Adelphi, Milano 1996,
p. 325.
81 J. J. ROUSSEAU, Il contratto sociale (1945), trad. it. di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1994, libro
IV, cap. 8, Della religione civile, p. 181.
82 A. MILANO, Quale verità, Edizioni Dehoniane, Bologna 1999, p. 45.
83 Ivi, p. 64.
84 Ivi, p. 372.
85 Ivi, p. 377.
86 Ibid.
87 Ivi, p.387.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 Ivi, p. 160.
91 Ibid.
92 Ivi, p. 389.
69
70
118
L’ONTOLOGIA ELEGIACA DI MAURO FABI
Sì, d’accordo, Mauro Fabi, in questa sua straordinaria fatica lirica (Il motore di vetro, Palomar, Bari 2004), cade anche nella solitudine in cui non c’è “più
nessuno ostacolo” tra lui e la “moltiplicazione del silenzio” (p.37), ricorda anche
il consigliato “silenzio di Wittgenstein” (p. 79), ma non ci si aspetti da lui la rassegnazione a tacere su ciò che non si può esprimere chiaramente. Del resto,
che cosa potrebbe significare per un poeta come Fabi, unterwegs zur Sprache,
“in un cammino verso il linguaggio” (Heidegger), la resa al silenzio di fronte a
ciò che si ritiene “inesprimibile” o, certamente, non è “esprimibile” con una
parola che non ha potenza tanto allusiva che porti oltre ogni scontata determinazione concettuale? Senza dubbio, ci sono, per citare il titolo di un saggio di
H. Uihely dedicato a Georg Trakl (“Der Monat”, H. 7, 1954), i Grenzen des Sagbaren, i “limiti del dicibile” ma è pur vero che lo stesso “dicibile” non necessariamente bisogna “dirlo” in maniera concettualmente determinata. Il poeta –il
vero, il grande poeta– anche il “dicibile” lo “dice” a suo modo, cioè in modo irripetibile, in un modo che sembra l’unico, insostituibile modo di “dirlo”. E a me
pare che sia “detto” in questo modo, da Fabi, il “formidabile impegno nel non
lasciarsi morire” (p. 108), quel suo aver “sognato la bellezza / prima di morire
/ accartocciato sopra una lettiga / l’oro delle sue urine a colmar un pitale”
(p.141). Restare in silenzio di fronte a questa “bellezza”, accantonandola
nell’“inesprimibile”? Non è possibile, anche o soprattutto per un poeta che, persino di un ospedale, più che sentire l’odore, vede il colore. Non è possibile per
un poeta che, fin dall’inizio di questo suo libro liricamente mosso e abissalmente pensoso, tende ad “esprimere” e riesce ad “esprimere” ciò che è più “inesprimibile”, nientemeno una morte che non è morte, una vita che non è vita,
almeno se né l’una né l’altra è stretta in una assoluta identità con se stessa:
“La morte / che sempre abitiamo, / la morte che riduce il / corpo / non lo può
annientare / tu sai che / non si annienta nulla che / tutto rimane immobile” (pg.
7-8). Solo un lettore un po’ rude culturalmente può meravigliarsi se io, qui,
comincio ad “odorare” –dico ad “odorare”– cifre presocratiche. Magari mediate attraverso la lettura di Heidegger o, anche, di Cioran Già, perché Fabi è,
come si cominciato a vedere, lettore non poco accorto di filosofi e scrittori che
hanno grande dimestichezza con le idee, dei quali ascolta il “lungo silenzioso
declino” (Cioran), il “silenzio claudicante” (il piccolo Maurice Merleau-Ponty) il
“silenzio aurorale” (Maria Zambrano) l’“invisibile silenzio” (Maurice Blanchot)
(p.79) il “tragico silenzio” (Primo Levi) (p.79).
Né bisogna chiedersi –e, se ce lo si chiede, significa che non si può “capire” Fabi– se il silenzio è qualcosa che non si possa ascoltare. E, di fatto Fabi
NOTE
di Antimo Negri
119
120
lo ascolta, soprattutto perché esso, “invisibile”, non può venire in oculos. Estremamente suggestiva, intanto, l’immagine dell’“invisibile silenzio”. Non “si vede”
il “silenzio”; eppure è calato in un’immagine e fatto, esso stesso, “invisibile”,
quando lo ”vedi” come “silenzioso declino / in una stanza d’ospedale” o “claudicante nelle gambe di un fanciullo o “tenersi in disparte” come se fosse una
creatura vivente o spuntare con i colori dell’aurora ecc.
Chiedo venia del fatto di aver ceduto un po’ alla provocazione ermeneutica
di un’immagine come “invisibile silenzio”. Qualcosa che “ascolti” e, da ultimo
vedi anche, ma che non cogli, non afferri, non tieni nel pugno, proprio come
l’“invisibile alito di zolfo” che viene “soffiato” sotto una “bolla di sapone”, un
giuoco di bimbi ripetuto dal poeta quando è ormai “un povero diavolo dalle tempie fumanti” (p.15). Un’immagine, comunque che, accanto ad altre immagini,
cade nella prima parte di questo libro di versi risolubile (dico: la parte), più che
in una “cronaca”, come si legge nel risvolto di copertina bellamente curato da
Carlo Bordini, in una “storia” densa e complessa nella quale “si vede” –ancora una volta, “si vede”; e, sì che, istorein è “vedere” il mondo, il piccolo e grande mondo– o il “piccolo mondo antico” –degli affetti familiari, accarezzati con
una malinconia crepuscolare non scalfito dalla sapienza tecnica del poeta:
bambini che “non dobbiamo ferire” (p.13), i “figli che dormono nella / sua stanza stanza sopra il suo letto” (p.20), il padre che “aveva una / voce come se
facesse fatica a parlare” (p.25), “i nostri poveri vecchi che ad uno ad uno / se
ne andranno lasciandoci in cambio / una consolazione d’argilla” (p.29), Anna
che “avrà questa vita che la occupa pienamente” e “qualche amica del momento con la quale / potrà lamentarsi forse di lui”, ma alla quale, ora, chiede, continua a chiedere “com’è andato Federico a scuola, / se la bambina ha mangiato, / come sta suo padre” (p.40) ecc.
Più che una “cronaca”, dicevo, una “storia”. Anche se Fabi tende, quasi non
credendoci, a scriverla in una miriade di “storie” ed anzi di “storie finte” (p.43).
Fatto è che, queste “storie”, Fabi le racconta; e può raccontarle perché la “storia” continua. Non dategli retta quando –in versi che fanno pensare più a Vittorio Betteloni che a Guido Gozzano– egli dice: “Fra poco smetterò del tutto di
parlare, / quelle parole che non sono servite / a nulla, / meno che mai a comprenderci e a farci sentire un poco più vicini” (p.45). Dove, con enjambements
volutamente prosastici, direi, a Fabi capita di raccontare la “storia” di un tormentato amore coniugale, in fondo alla quale, presumo, è solo immaginato
l’epilogo della rottura definitiva e la solitudine: “Me ne andrò a camminare /
guardando il mare come facevo / quando ero giovane, il mare di quando ero
giovane” (p.45).
Già, ma il mare di quand’era giovane Fabi è lo stesso mare. È come se non
si muovesse, è come se non si fosse mosso…O nella coscienza di Fabi, nella
quale, come avvertivo, insorgono cifre presocratiche, non prevale più quella
dell’essere parmenideo che del divenire eracliteo? Gli abbiamo sentito dire:
“tutto rimane immobile / proprio come / cadavere che giace” (pp.7-8). E questo
“tutto” fa pensare, senza dubbio, più alla sfera di Parmenide che al fiume di
Eraclito. Pure, Fabi ha detto anche: “Non si annienta nulla” (p.7). Si tratta di
una sentenza antica: “Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”,
NOTE
e, anche, “tutto si ripete”. Tra Parmenide ed Eraclito Empedocle: l’Empedocle
più caro a Nietzsche, il filosofo dell’“eterno ritorno dell’eguale”. Ricordate: Fröhliche Wissenschaft, IV, 341: “Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un
demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse:
“Questa vita, così come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una
volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà mai niente di nuovo…”.
Sì, l’idea dell’ewige Wiederkunft des Gleichen, l’idea dell’eterno ritorno dell’eguale”. Per la specie e per l’individuo. E come si fa a dire che non si tratta
dell’idea che costituisce das Schwerste Gewicht del “fardello più pesante”? È
lo stesso Nietzsche a sostenerlo; e, nel suo mirabile romanzo L’insostenibile
leggerezza dell’essere (1984, cap. I), Kundera ci assicura che “quanto più il
fardello è pesante, tanto più la nostra vita è vicina alla terra, tanto più è reale
e autentica”.
E Fabi? Fabi, che ha sulla propria pelle le stimmati del dichterisches Denken, del “pensiero poetante” (Heidegger), anche lui ha la sua idea –concetto e
immagine– dell’“eterno ritorno dell’eguale”. Un’idea fatta valere con riferimento alla “grande” storia, quella che il Manzoni considerava come la storia dei
grandi potentati o degli “illustri Campioni che in tale Arringo fanno messe di
Palme e d’Allori” (Promessi Sposi, Introduzione)? Assolutamente no.
C’è anche la storia piccola propria della “gente meccaniche, e di piccolo
affare” (Promessi Sposi, Introduzione), di “anime” che non “son, di fama, note”
(Dante, Paradiso, XVII, 138). O ci sono anche storie di personaggi che non
sono tragici, come Robespierre, poniamo, o Hitler, ai quali Kundera, nel ricordo del nietzscheano “eterno ritorno dell’eguale”, lega gli eventi terribili, ripetibili e per ciò stesso “pesanti”, della Rivoluzione francese e della seconda guerra mondiale. Ci sono anche storie di personaggi “comici”, per dir così, quotidiani, semplici, “senza storia”, quelli a nome dei quali, quasi mettendo a portata di
mano la terribile nozione empedocleo –nietzscheana e per ciò stesso “alleggerendoli”, Fabi può parlare e di fatto parla: “La prossima vita sarà come quella /
che abbiamo vissuto. / Attraverseremo gli stessi mattini / di sole vulnerabili e
freddi / come un sedile di plastica grigio / dentro un autobus vuoto” (p.92).
La vertigine teoretica –ed anche theorein significa “vedere”!– fa decollare il
poeta verso gli orizzonti alti, mitici, fascinosi del pensiero antico in cui sono
incollate come stelle fisse le nozioni dello spazio, del tempo, dell’essere, del
divenire (lo ha notato bene Carlo Bordini).
Pure, è vero che, tra queste nozioni, speculativamente impervie e categorialmente “totalitarie”, prende il sopravvento, nella poesia di Fabi, quella dell’Essere (sì, da scrivere con l’iniziale maiuscola) o del “tutto”, appunto, che “rimane
immobile” (p.8). l’“immobile” evoca, ripete, traduce –non c’è niente da fare–
l’akinèton che è uno dei sèmata, dei “segni indicatori” dell’Essere parmenideo
che, allora, sì, “proprio come / un cadavere giace” (p.8). Ed è un fatto, intanto
che, quando la poesia di Fabi più concretamente si esprime come ontologia elegiaca, il senso dell’Essere si identifica con quello stesso della morte, eguagliata al silenzio, all’assenza del “nominare”: “Non avremo più nulla da insegnare o
da / sbagliare, a nessuno più / sapremo dire una parola e quante / parole abbiamo cancellato come / volti ai quali non si riesce più a dare / (un nome) / i nomi,
121
122
nominare” (p.142). L’Essere parmenideo nella sua interezza, come il Dio paleotestamentario; e (Es., 20, 7) non vuole essere “nominato”. Né io posso togliere
a Fabi la consapevolezza che “nominare” significa “determinare”, “dividere”,
“scindere”: onoma = nomen, da nemò = divido. Dove non si danno “nomi”, dove
non ci sono “determinazioni” ecc., lì c’è l’Essere, Dio, la morte. Siamo nell’aspazialità pura, nella pura intemporalità, nell’assoluto “presente” –e quella di Fabi
vuole essere un’“ontologia del presente” elegiacamente espressa– senza passato e senza futuro, e per ciò stesso, senza divenire: e, anche in questo caso,
si capisce, non posso togliere a Fabi la consapevolezza che “tempo”, da temnò
= divido, implica, esso stesso, l’idea della “determinazione” o delle “determinazioni” –degli stessi “nomi”– senza le quali l’Essere rimane puro Essere e, rimanendo tale, equivale, come voleva Hegel (Enciclopedia, 87).
Ma può –ecco il punto più importante– può il linguaggio della poesia, –o in
particolare questo– ospitare l’Essere così inteso? Ho già chiamato in causa
Unterwegs zur Sprache di Heidegger. E, certo, Fabi ha potuto leggere in esso:
“Il linguaggio è stato detto la ‘dimora dell’Essere’”. Si autocita, qui, Heidegger,
rinviando al suo Brief über den Humanismus (1947). E, intanto, Fabi appronta
una dimora all’Essere quando “canta” / “Essere, puro Essere, / ritornato alla
mezzanotte / dell’aurora, / ritornato al suo destino / primordiale” (p.120). Vero
è, però, che il “destino primordiale” dell’Essere è, almeno per Parmenide –o,
per il Parmenide più vicino ad Anassimandro– quello di restar fermo all’“aurora” della sua “mezzanotte” al di qua di tutte le determinazioni, di tutte le manifestazioni, di tutti i fenomeni, spazio-temporali: allora soltanto l’Essere è la
“verità della pietra”, “ontologicamnete più forte / di ogni fede” (p.97). E a Fabi
dal quale senti dire del “tradimento dell’Essere che ha / violato il patto”, accennando ad un crimine che dà luogo agli enti, ad un crimine che si può riparare
solo passando dalla molteplicità degli enti all’unità dell’Essere, viene spontaneo ricordare il celebre “detto di Anassimandro” che fa del luogo e del tempo
dei fenomeni il luogo e il tempo del peccato (di nascere) e della sua espiazione. Allora, Fabi: “Per questo l’esserci deve morire / e l’Essere è il nulla” (p.132).
Dove l’“esserci” è il Dasein di Heidegger, l’esistenza, il Sein-in-der Welt, l’Essere caduto nel mondo e sparpagliato negli enti, nei fenomeni ecc.
Se è così, mi vien da leggere non tanto “la morte dell’esserci è la colpa /
più grande” (p.132) quanto piuttosto: “la nascita dell’essere è la colpa (più
grande)” o, anche: “la morte dell’Essere è la colpa / più grande”. Nell’“ontologia elegiaca”, si accampa, da ultimo, “il nulla dell’essere” (p.132). La nullificazione dell’essere avvertita come una “caduta” della quale l’uomo sconta la
pena come per un peccato commesso: “È questa la colpa, / questa colpa tremenda / non è forse la colpa della caduta, / l’orizzonte entro il quale da sempre / come in un chiostro nel deserto / preghiamo” (p.131). E, qui, senti, non
solo Anassimandro e Parmenide, ma anche Michelstaedter e Cioran. Il “chiostro nel deserto”, intanto? Vi trovi dentro “l’essere delle cose disgregate” nel
“breve sangue del sapere”, “l’esserci slegato dall’essere”, un “esserci” (l’esistenza, il mondo dei fenomeni o degli enti), che, in quanto è “all’oscuro di
tutto”, “non ha valore per sé ma solo per altro” (p.124).
Non è assolutamente difficile leggere in questo “esserci” che “ha valore solo
NOTE
per altro” una sorta di vivere morendo o di morire vivendo. Ma il sentimento
profondo dall’esistere umano in quanto tale vivere o tale morire non induce ad
un gesto coerentemente e tragicamente nichilistico: quello di un Mainländer,
poniamo, o di un Weininger o, anche, di un Michelstaedter o di un Cioran,
appunto. D’accordo, frantumato l’Essere, vista la morte primordiale, sperimentiamo la “tentazione di esistere”, avvertiamo una inevitabile “decomposizione”,
giacché, una volta “caduti nel tempo”, sempre per dirla con Cioran, non ci rimane che “cadere dal tempo”, ritornare all’Essere dal quale siamo transfughi. Ma,
ecco, nell’ontologia elegiaca di Fabi, c’è lo spazio per la possibilità di un morire insieme, come in un amplesso solidale di fronte al “destino primordiale” in
forza del quale apparteniamo all’Essere, a Dio o alla morte: “Perché domani si
deve morire / e siamo malati per tutto / e invecchiamo abbracciati / sanguinanti per anni / a un tradimento” (p.128). Il morire come il vivere, intanto, sono sottratti ad ogni altra dimensione che non sia quella del “presente”. Cade l’idea del
passato e quella del futuro e, con essa, quella del nascere e del morire. Nasce
il fiore dell’idea dell’instabilità: “tutto è presente il presente / è tutto il tempo /
non esiste più e noi / non moriremo mai” (p.143). E, del resto, “nessuno conosce / la propria morte / nessuno la può raccontare” (p.132).
“Perché tu mi dici poeta?” (Sergio Corazzini). Ed io dico poeta Mauro Fabi.
Un poeta che vorrei continuare a leggere: perché parla dell’Essere e mi fa
aggrappare all’esistere, parla di Dio e mi fa amare l’uomo, parla della morte e
mi fa aggrappare alla vita. D’altra parte, non è un caso che, dopo aver letto e
riletto il Motore di vetro di Mauro Fabi, dopo averne gradita la più forte sollecitazione ad immaginare e a pensare, ritorno ad un mio poeta “greco” prediletto,
Hölderlin e, magari, butto gli occhi e la mente nell’antologia poetica luziana La
ferita nell’essere.
Continuo ad avere a che fare con l’essere o con l’Essere e do per certo che
anche Fabi ha contribuito poeticamente a dargli una dimora nella parola, con
la consapevolezza che la “ferita nell’Essere” è l’esserci, il Dasein, l’esistenza,
l’“essere nel mondo”, il fenomeno come frammento del noumeno, ecc.
123
E-GOVERNMENT:
RETORICHE ED OPPORTUNITÀ
di Antonio Tursi*
La retorica in-comprensione. Confusione tra e-democracy ed e-government
124
Come ogni medium in passato, la rete condiziona le forme politiche, in particolare il concezione e la pratica della democrazia. Naturalmente la comprensione del condizionamento dei media sulla politica non è affatto scontata. Ciò
in duplice direzione: o si sottovaluta il ruolo dei media oppure si sopravvaluta
la loro capacità di determinare le forme della politica. Questo secondo modo
dell’incomprensione a sua volta determina allarmismi o ottimismi eccessivi.
Perché queste direzioni nella (in)comprensione del rapporto media-politica?
Perché nel primo caso non si riconosce il ruolo strutturante che i media hanno
sempre giocato rispetto all’evoluzione dei sistemi politici. Chi sottovaluta il
ruolo dei media dovrebbe rileggere con attenzione le pagine di Harold Innis, in
particolare quelle di Impero e comunicazioni1. A onor del vero, bisogna aggiungere che attualmente è la sopravvalutazione che va per la maggiore. Evidentemente la presenza pervasiva della televisione e ora della rete, ha buon gioco
nel orientare gli sguardi sugli scenari mediali, dentro i quali giocano le forme
politiche. Sguardi orientati, perché disorientati. Il disorientamento di cui si fa
questione è quello relativo alla Politica. Con la fine delle grandi narrazioni2, la
liquidità dei legami sociali3, l’avanzata delle politiche della vita, si è creduto –lo
si crede ancora– che la Politica abbia terminato la sua funzione storica4, e perciò occorre ricercare e trovare dei suoi surrogati ovvero occorre sbarrazzarsi
dei suoi ultimi residui ovvero rimpiangerla additando le responsabilità, per
esempio, dei media. Ed ecco come i mezzi di comunicazione attirino su di sé
l’attenzione di studiosi e politici. Un’attenzione mal riposta, a causa di quello
sguardo disorientato e che disorienta, in quanto evita un reale confronto con le
tecnologie mediali. È questo lo scenario che alimenta discorsi retorici, i più vari,
sulle capacità taumaturgiche ovvero mortifere dei media. Viceversa, un saggio
di uno degli sguardi più lucidi sui nuovi media si conclude affermando: “comunque, abbiamo ancora bisogno delle istituzioni, abbiamo ancora bisogno della
rappresentanza politica, della democrazia partecipata, delle procedure di
costruzione del consenso e di un’efficace politica pubblica. Tutto ciò comincia
con governi responsabili, sinceramente democratici. [L’assenza della politica]
è l’anello debole della società in rete”5.
Tuttavia, soprattutto nella fase di esplosione della rete, a prevalere sono
stati gli sguardi disorientati che hanno alimentato vere e proprie ideologie. Uno
degli stilemi retorici di cui queste ideologie si sono valse, e che in parte occupa tuttora un posto di rilievo, richiama la necessità di forme di democrazia diret-
Una democrazia diretta richiede la presenza reale del sovrano. La volonté générale come corpus mysticum è legata al corpus physicum del popolo unanimemente radunato. L’idea di un plebiscito permanente si presenta a Rousseau nel modello della polis greca dove il popolo era radunato in piazza pressoché‚ ininterrottamente; così agli occhi di Rousseau la place publique appare come il fondamento
della costituzione. E’ da qui, cioè dai cittadini raccolti per acclamare, che l’opinion
publique deriva il suo attributo, e non dal pubblico dibattito di un public éclairé 8.
Infine, tale retorica cade in contraddizione da sé poiché se da un lato si
richiama alla democrazia diretta ateniese, dall’altro già annuncia all’orizzonte
una nuova forma di governo, «la demodinamica» nell’espressione di Pierre
Lévy9. Che senso ha evocare il cittadino della polis greca, quando si profila un
nuovo soggetto politico, il netizen? Non è senza motivo che lo stesso Lévy, nel
NORME e SEGNI
ta, tese a ricreare l’agorà propria della democrazia degli antichi. Naturalmente,
tali forme sono rese possibili solo grazie ad Internet e perciò l’agorà della
nostra epoca dovrà definirsi elettronica. Corrollario definitivo della retorica dell’e-democracy è l’oscuramento delle questioni specifiche riguardanti l’e-government, le quali sono dissolte nell’afflato ad una partecipazione senza mediazioni.
Pur essendo il corollario di questa retorica ciò che interessa stressare in
questo lavoro, può essere utile accennare alcuni elementi critici legati al concetto di e-democracy.
In particolare, per quel che riguarda il richiamo alla democrazia diretta
vanno fatte alcune osservazioni. In primis, ciò a cui ci si richiama è il modello
ideale enunciato da Pericle, ma assai lontano dalla realtà anche delle stesse
polis greche: il coinvolgimento diretto dei cittadini risultava fortemente condizionato da una serie d’istanze di mediazione e di controllo, l’isonomia e l’isegoria erano dappertutto ostacolate e snaturate, solo il quindici per cento della
popolazione era a pieno titolo riconosciuto tra i ‘cittadini’. Habermas parla a
proposito di «paradigma ideologico»6 che si forma dall’autointendimento che i
greci hanno avuto della loro sfera pubblica.
Inoltre, il richiamo attuale alla democrazia diretta si lega alle difficoltà che la
sua realizzazione avrebbe incontrato prima dell’avvento delle nuove tecnologie. John Thompson spegne queste rinnovate speranze, spiegando che “le difficoltà non riguardano semplicemente l’applicazione, come se in se stesso il
modello fosse eccellente ma la sua messa in pratica incontrasse certi ostacoli. La difficoltà è di fondo: il modello a democrazia diretta presuppone il verificarsi di particolari condizioni che, data le stessa scala e la complessità delle
società moderne, e la crescente interconnessione del mondo contemporaneo,
sono sempre più lontane dalle circostanze in cui oggi si devono prendere molte
decisioni”7.
Anche qualora l’ideale fosse stato realizzato nell’antica Grecia e fosse realizzabile nel nostro tempo, dovremmo riconoscerlo come auspicabile? Lo stesso Habermas, molte volte ripreso dai fautori della democrazia diretta, in un
luogo un po’ trascurato del suo Storia e critica dell’opinione pubblica, leggendo Rousseau, risponde a questo interrogativo:
125
126
suo ultimo lavoro sul tema del rapporto rete-politica10, non usi affatto quell’espressione, così come non ponga più un accenno forte sul superamento dei
meccanismi della delega.
Da parte nostra, non condividiamo affatto posizioni del tipo “siccome le
agorà virtuali potrebbero aprire spazi di comunicazione, negoziazione, apparizione di una parola collettiva e di decisioni in tempo reale, ci sono sempre
meno ragioni «tecniche» per perpetuare il dispotismo frammentato costituito
dal sistema della delega”11, ma neanche affermazioni del tipo “allorquando la
compresenza viene a mancare, o a indebolirsi, come nel caso nell’interazione
telematica, la democrazia appare fortemente minacciata”12; siamo invece portati a riconoscere che “pur senza modificare nel profondo il rapporto tra cittadini e istituzioni politiche, la rete consente a quegli individui o gruppi portatori di
un interesse o di un progetto politico di impostare una presenza e un’attività di
difficile realizzazione all’interno dei consueti circuiti della politica”13. Il che porta
alla conclusione che: “la rete […] si è dimostrata essere né uno strumento che
agevola la democrazia, né uno strumento che la ostacola fino ad annullarla.
Essa può contribuire allo sviluppo democratico di un paese così come può contribuire all’affermazione di forme di dominio interagendo con altri fattori di mutamento –siano essi di segno positivo o negativo– provenienti dall’ambito sociale, economico e culturale”14. Si pone quindi un problema di comprensione degli
“altri fattori di mutamento”, in particolare di quella crisi della Politica di cui
abbiamo detto. Si pone altresì un problema di comprensione delle caratteristiche proprie della rete.
Un passo di Franco Berardi aiuta a fare distinzione tra le varie problematiche che la retorica dell’e-democracy confonde.
La rete non è uno strumento di democrazia (può anche esserlo, ma del tutto marginalmente). La rete è piuttosto il paradigma di un modello di democrazia nuova,
una democrazia senza riferimenti al centro, non più riducibile alla forma dello Stato
nazione, e non più riducibile alla forma globale della decisione. Il ripensamento
della nozione di democrazia può derivare da un’invenzione paradigmatica che a
sua volta deriva dal modello della rete, ma non sarà la meccanica conseguenza di
una diffusione quantitativa delle reti15.
Tre risultano essere le questioni da indagare: la rete come «strumento di
democrazia», «un modello di democrazia», il «modello della rete».
La comprensione del modello della rete è l’elemento necessario che spesso manca nelle analisi del rapporto media-politica.
Le altre due questioni delineano quello scenario sul quale molto si dibatte
e che si potrebbe chiamare, utilizzando il sintagma di Lawrence Grossman,
«repubblica elettronica»16.
Per repubblica elettronica s’intende uno scenario che prevede un’informatizzazione delle procedure e dei comportamenti operativi tramite i quali i cittadini esercitano i loro diritti in una democrazia. […] Ritengo che il tema della comunicazione
politica occupi un luogo centrale nel programma (o nei programmi) della repubblica elettronica. Vi è nondimeno un altro tema, quello dell’informatizzazione degli
apparati burocratici dello stato, che non va minimamente sottovalutato. “Reinven-
Il “modello di democrazia”, utile per “reinventare la politica”, è il punto più
acceso del dibattito. Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa: quale
forma politica deve essere perseguita all’inizio del XXI secolo?
Chiaramente tale dibattito avente come posta in gioco la “reinvenzione della
politica”, trascura come si sta “reinventando il governo”. Mentre Berardi parla
di “strumento di democrazia”, noi suggeriamo di parlare di strumento della
democrazia, nelle mani, cioè, delle istituzioni democratiche. Siamo consapevoli che ciò comporta un qualche spostamento del focus d’attenzione, ma anche
il vantaggio di non presentare un’immagine quasi antropomorfizzata della tecnologia: Internet come portatore di chissà quali benefici o sciagure –dipende
poi dal grado d’integrazione di ciascuno–, evitando determinismi d’ogni sorta
che non tengono conto o delle potenzialità o dei limiti del ciberspazio.
L’e-government: una vasta gamma di strumenti
Reiventare il governo per mezzo della rete-strumento della democrazia è
l’obiettivo da perseguire, consapevoli però che si tratta di un obiettivo parziale, necessario ma non sufficiente a reinventare la politica. “Se l’e-government
deve essere solo un po’ di cosmetico sul cadavere della democrazia o uno
schermo per coprire la necessità di risolvere alcune questioni fondamentali,
allora tanto vale cessar di rimettere in ordine le sedie sul ponte del Titanic e
avviarsi alle scialuppe di salvataggio! Ma dove altro andare, e chi ci salverà?”18. Detto questo, si può tentare di descrivere in cosa consista l’e-government. Esso porta ad affrontare un ventaglio ampio ed eterogeneo di tematiche. La rete, più in generale le tecnologie informatiche, offrono una gamma di
strumenti da usare per avvicinare la pubblica amministrazione, centrale e
periferica, ai cittadini. Questi strumenti sono sfruttati, non sfruttati o mal sfruttati in Italia. Su ognuno di essi i governi degli ultimi anni si sono soffermati
(oppure non lo hanno fatto), definendo politiche e cercando una loro implementazione.
Forniamo un quadro riassuntivo delle tematiche da affrontare nell’ambito
dell’e-government. Proprio questo quadro è la migliore descrizione che si
possa dare di che cosa si intende parlando di e-government.
Prima di tutto, va fatto cenno all’inquadramento duplice di tali tematiche19:
gli obiettivi generali legati all’e-government sono definiti nei documenti sulla
“società dell’informazione”, emanati sia dall’Unione europea sia dal governo
italiano. Le iniziative europee del 1999, 2001 e 2002 costituiscono il quadro di
riferimento in cui si sono mossi i governi italiani sia di centro-sinistra, sia di cen-
NORME e SEGNI
tare il governo” è l’efficace slogan che D. Osborne e T. Gaebler hanno coniato per
promuovere questo ambizioso progetto. […] Nell’ottica della repubblica elettronica
“reinventare il governo” è inseparabile dalla volontà di “reinventare la politica”. […]
Se così fosse, non vi sarebbe nulla da eccepire. Ma c’è un punto che non convince. Mentre sul programma finalizzato a “reinventare il governo” è possibile trovare linee di convergenza e di accordo, non si può dire lo stesso sul programma che
si prefigge di “reinventare la politica17.
127
tro-destra con i rispettivi piani per la società dell’informazione. L’altro tipo di
inquadramento è dato dalle leggi sulla comunicazione della pa.
Le tematiche più rilevanti che definiscono il campo dell’e-government sono
riportate nella tabella 1.
Tabella 1: principali aspetti dell’e-government.
tematica
sicurezza delle transazioni
transazioni on
line
portali
e-commerce
e-procurement #
servizi on line #
pagamenti on line #
bandi di gara online #
portale nazionale
www.italia.gov.it;
portali per l'erogazione di
servizi
sistema pubblico di connettività
privacy
128
carta di identità elettronica e
carta nazionale dei servizi #
firma digitale #
voto elettronico
accessibilità e usabilità dei siti web
uso software open source
uso del dominio .gov.it
grandi sistemi dichiarazioni fiscali;
carta sanitaria;
pubblici
in rete
e-learning # / un pc per aula
alfabetizzazione dei dipendenti #
descrizione
le transazioni on line sono la dimensione attualmente
predominante nell'implementazione delle piattaforme d'egovernment. L'offerta di servizi attraverso il web costituisce
il valore aggiunto dell'uso di Internet in luogo dei tradizionali
sportelli fisici
la tendenza all'uso dei portali è in aumento, perché permette
ai siti delle pal di sopperire all'assenza di fondi adeguati per
mezzo di partnership con soggetti privati che operano sul
territorio
sistema nervoso della pa che integra la rete della pac con le
reti della pal. Utilizzo della banda larga
il concetto di privacy è strettamente connesso a quello di
governo on line e, in maniera contingente, alla sicurezza dei
dati gestiti in maniera elettronica – si veda il caso del voto
online
sono due priorità assolute in materia di progettazione di siti
web, perché permettono l'accesso ad un numero vasto di
utenti potenziali e una fruizione facile e soddisfacente
l'open source sta erodendo il monopolio di fatto della
Microsoft in materia di software e server, permettendo così
alle pa di risparmiare fondi, senza andare a danno della
qualità finale
è stata recepita in Italia, l'istanza che chiede una
riconoscibilità istituzionale assoluta ai siti delle pa fin dal
dominio. L'ottenimento dell'estensione .gov è subordinata ad
alcuni prerequisiti
i vantaggi dell'uso delle nuove tecnologie nella gestione dei
sistemi pubblici sono consistenti, in ordine alla flessibilità e
alla facilità di utilizzo
la formazione del personale costituisce un prerequisito
fondamentale
Fonte: nostra elaborazione su fonti varie 20.
Affrontando alcune di queste tematiche, il governo ha proposto come modello
di riferimento per l’e-government il modello riportato nella tabella 2.
beneficiari erogazione servizi
riconoscimento digitale
canali d’accesso
enti eroganti
interoperabilità e cooperazione
infrastruttura di comunicazione
- cittadini;
- imprese
- carta nazionale servizi;
- carta identità elettronica
web (portali pa); call center; sportello unico; cellulare,
palmare; reti terze (portali generalisti, banche, poste, …)
- comuni;
- regioni;
- pac
[procedure integrate di interfacciamento]
[uffici di back–office]
NORME e SEGNI
Tabella 2: il modello di e-government.
applicativi di notifica eventi
sistema pubblico di connettività
Fonte: Ministero per l’innovazione e le tecnologie, Linee guida del Governo per lo sviluppo della
Società dell’Informazione, Roma: giugno 2002, p. 28.
Come abbiamo accennato, esiste una frattura abbastanza profonda tra la
formulazione di politiche e la relativa codifica legislativa da un lato e la loro
implementazione dall’altro. Un’esempio particolarmente evidente viene offerto
dalla firma digitale.
Per dare forza agli investimenti sulla rete, incentivandone l’utilizzo, la legge
n° 59 del 15 marzo 1997 riconosce validi e rilevanti a tutti gli effetti, gli atti, i
dati, i documenti, i contratti della pa e dei privati formati, archiviati e trasmessi
con strumenti informatici a prescindere dall’esistenza di un corrispondente atto
o registro cartaceo: è questa una vera “rivoluzione copernicana” per l’amministrazione, basti pensare che se ne descrive la nascita in correlazione all’invenzione della scrittura. Per apprezzare gli effetti positivi di tale rivoluzione ed evitare eventuali rischi occorre affrontare il problema della crittografia che presenta due aspetti complementari: a) occorre garantire la segretezza del documento e la connessa integrità (l’impossibilità di alterarlo); b) l’autenticità dello stesso ovvero la certezza della provenienza. A ciò provvede la firma digitale, prevista dalla stessa legge, che si concretizza in Italia nel sistema della doppie
chiavi asimmetriche, una privata e una pubblica, che servono a codificare e
decodificare gli algoritmi matematici a cui vengono ridotti i documenti o i “riassunti” di questi (hash). La procedura di attuazione prevede tre passaggi: 1) la
certificazione della persona che deve formare il documento ad opera di un soggetto certificatore, la c.d. Autorità di Certificazione; 2) la sottoscrizione digitale
dell’atto, che si effettua cifrando l’hash o impronta tramite la chiave primaria del
firmatario; 3) la verifica della firma, che l’interessato effettua decifrando con la
sua chiave pubblica la propria firma.
Gli effetti dell’adozione della firma digitale si sentiranno in tutti gli ambiti in
cui si sviluppa il rapporto tra Stato e cittadino: dalla scuola alla sanità, dalla giustizia alle finanze. Per l’amministrazione oltre gli effetti generali nel processo di
innovazione, ne segnaliamo due in particolare. Il primo di ordine materiale:
meno carte, meno archivi e quindi più risparmio; il secondo di ordine progettuale, infatti con l’informatizzazione dei documenti saranno immediatamente verifi-
129
cabili gli uffici presso i quali un documento vedrà rallentato il suo cammino e
così si potrà intervenire a rimuovere gli impedimenti. Purtroppo, come ammoniva Franco Carlini21, a due anni dalla legge, varata nel marzo del 1997, nonostante siano stati approvati anche tutti i necessari regolamenti d’attuazione, non
esisteva neppure un contratto stipulato in questo modo. La situazione è migliorata in seguito, anche se ancora resta problematica la definizione dei certificatori e della relativa Autorità. Il miglioramento della situazione deve molto al ruolo
particolarmente propulsivo svolto in tale materia dal Ministero delle Finanze con
il suo progetto di fisco telematico, progetto che prevede la possibilità di rendere la dichiarazione dei redditi attraverso i canali telematici22.
La retorica in-azione. Un impegno concreto: smantellare lo Stato
130
Le tematiche dell’e-government sono state affrontate negli ultimi anni in Italia sia dai governi di centro-sinistra, sia da quelli di centro-destra. Entrambi si
sono confrontati con due peculiarità che descrivono un caso-Italia. La prima
peculiarità è costituita dall’intreccio stretto tra apparati burocratici e poteri politici, essendo i primi compresi come componente decisiva dei secondi. La
seconda peculiarità è data dall’attenzione esclusiva, o comunque preminente,
che nel nostro Paese si dà ai vecchi media, in particolare alla televisione, la
quale assorbe gran parte del dibattito politico ed accademico. Entrambe le
peculiarità influenzano negativamente le politiche sulle nuove tecnologie,
verso le quali molto spesso non è dato ritrovare la sensibilità che sarebbe
necessaria ad innovare il Sistema Paese, portandolo al livello dei Paesi tecnologicamente più avanzati. Salvo poi ritrovare, invece, un’eccesso di sensibilità
ogni qualvolta si rendano note ricerche che attestano il nostro divario digitale.
L’Italia, infatti, si colloca in 23ª posizione nel IDC’s Information Society Index
2002, e nelle ultime posizioni in Europa su tutta una serie di indicatori, come
evidenziato nella tabella 3.
Tabella 3: posizionamento dell’Italia in Europa nel 2001
indicatore
% della popolazione che usa Internet
% di famiglie che usa Internet
% diffusione larga banda
numero di PC collegati a Internet per 100 studenti
% di insegnanti che usano Internet nella didattica
% di lavoratori con alfabetizzazione ICT
% di lavoratori che usano il telelavoro
% spesa eCommerce
% di strutture sanitarie che hanno accesso a Internet
posizionamento
13
11
12
13
10
9
13
9
10
Fonte: Analisi Roland Berger Strategy Consultants su dati Eurobarometer, OCSE, CIA, Istat.
L’attuale responsabile del dicastero dell’Innovazione, Lucio Stanca, ha
posto tra i suoi principali obiettivi la realizzazione del governo elettronico. Sulla
NORME e SEGNI
sua azione gioca favorevolmente il lavoro compiuto negli anni precedenti dall’ex ministro della Funzione pubblica, Franco Bassanini, in particolare il lascito
del Piano d’azione per la società dell’informazione, varato nel giugno del 2000.
Infatti, nonostante l’attuale governo abbia prontamente provveduto a varare
nuove Linee guida del Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione
nella legislatura (giugno 2002), sostanzialmente esse riprendono i materiali del
precedente piano.
Sono sufficienti la sensibilità di Stanca e la ripresa dei documenti elaborati dai governi del centro-sinistra, per valutare positivamente le politiche
attualmente in corso? Certo che no. L’elemento chiave per tale valutazione è
un altro, purtroppo negativo. Esso trova manifestazione in tutta l’ideologia
espressa dall’attuale presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, sin dalla sua
discesa in campo. Si tratta di un’avversione dichiarata nei confronti della politica e delle sue istituzioni. E tra l’altro, Berlusconi non è solo: anche altri ministri, tra cui merita menzione Umberto Bossi, giocano la loro parte nell’elaborazione degli stilemi retorici dell’antipolitica. L’ideologia in questione si declina nella richiesta di uno Stato minimo, che significa marginalizzazione dell’amministrazione e privatizzazione della procedure. L’e-government, o almeno la sua pubblicizzazione, diviene un’arma per scardinare l’ossatura dello
Stato.
Naturalmente, questa azione decisa e premeditata viene resa invisibile
attraverso un’operazione sistematica di confabulazione retorica. Il culmine è in
una delle tre “i”, quella di Internet; ma significativo è il propagandare come
svolte decisive tutte le minime iniziative, con un uso continuativo di “effettoannuncio”. Lo stesso Stanca ha ammesso che alcune misure adottate hanno
solo uno scopo propagandistico –almeno per ora, nelle sue intenzioni23.
Nel concreto, i fondi, destinati a finanziare progetti utili per innovare la pa a
partire dalle nuove tecnologie, sono stati ridotti. La legge finanziaria per il 2003
ha smentito quanto annunciato nelle Linee guida del Governo per lo sviluppo
della Società dell’Informazione nella legislatura, presentate nel giugno del
2002. In questo documento era annunciata l’istituzione di due fondi per l’egovernment: il “Fondo per il sostegno dei progetti strategici” e il “Fondo nazionale per il cofinanziamento delle iniziative locali”. Invece di quanto annunciato,
è stato istituito un “Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel paese”, finanziato solo con riduzioni di spesa, non con stanziamenti aggiuntivi. Inoltre, nelle Linee guida si stimava la spesa complessiva per l’e-government tra il 2003 e il 2005 in 1000
milioni di euro e si annunciava una spesa di 1200 milioni di euro per implementare la banda larga, ma nella legge finanziaria non vi è alcun cenno a stanziamenti del genere.
È stato scritto che quella che governa attualmente l’Italia, impregnata di pseudo-liberismo, è una destra “politicamente e culturalmente antitetica all’e-government, visto come una contraddizione rispetto allo spirito autoritario che ne anima
l’azione”24. Non è questa la sede per indagare se l’azione del governo in carica sia
animata da uno spirito autoritario, sicuramente però è animata da un dichiarato
spirito antipolitico e sicuramente l’antipolitica è antitetica all’e-government.
131
Vantaggi e qualche svantaggio
132
Il governo elettronico si crea sfruttando in modo coordinato le numerose
opportunità che le tecnologie informatiche offrono. La sua realizzazione comporta cambiamenti importanti nella relazione amministrazione-cittadini, ciò a
patto che le nuove tecnologie siano utilizzate in maniera proficua. Come tutti i
cambiamenti, anche questo porta vantaggi –ciò che si guadagna dal cambiamento– e svantaggi –ciò che si perde, e in ogni cambiamento qualcosa inevitabilmente si perde. Affermiamo subito che i vantaggi, per l’amministrazione
così come per i cittadini, paiono tali da auspicare un’azione decisa nella direzione del cambiamento.
Consideriamo gli obiettivi finali a cui potrà portare questo processo di innovazione. Iniziamo dai cittadini, perché l’amministrazione, se non traspone i suoi
scopi, è ad essi finalizzata, ma anche perché riteniamo che delineando nuove
possibilità per i cittadini si possono intravedere le linee di un mutamento organizzativo della pa.
Il cittadino che le amministrazioni si trovano di fronte (per ora come controparte, ma presto come collaboratore) è un cittadino nuovo, che interroga, che
interviene, che si organizza, ed è quindi il maggior responsabile del processo
di cambiamento in atto: crediamo si possa affermare che le nuove normative
sulla pa siano dovute innanzitutto ad una spinta dal basso. Ciò che questo cittadino chiede e può ottenere grazie alle reti è in primo luogo ciò che Stefano
Rodotà chiama “liberazione del sovrano”: “grazie alle nuove tecnologie della
comunicazione è stato certamente avviato un processo di ‘liberazione’ del
sovrano da una serie di vincoli di spazio e di tempo che ha avuto (e potrà
avere) l’effetto di realizzare condizioni di indipendenza da apparati, da quelli
burocratici in primo luogo”25.
In effetti, proprio il superamento dei vincoli spazio-temporali tradizionali è
segnalato come una delle conseguenze principali dei media elettronici. Joshua
Meyrowitz, indagando questo aspetto, afferma: “se molte informazioni sociali
sono ancora accessibili solo recandosi in determinati luoghi o interagendo con
gli individui in incontri faccia a faccia, i recenti cambiamenti nei mezzi di comunicazione hanno parecchio indebolito il rapporto, un tempo armonioso, tra l’accesso all’informazione e l’accesso ai luoghi”26.
Tutta una serie di altri elementi propri di uno Stato democratico trovano
attuazione grazie a ciò che le reti offrono: redistribuzione del potere, riduzione
della discrezionalità amministrativa, trasparenza dei processi di decisione,
eguaglianza tra i cittadini, una forma diffusa di controllo, accrescimento della
partecipazione politica. Ecco come Rodotà descrive questi elementi:
La possibilità di accesso remoto a banche dati pubbliche e private, e di effettuare
tale accesso nel momento scelto dall’interessato, non è soltanto un fatto tecnico:
rappresenta una forma di redistribuzione del potere che indebolisce la funzione di
filtro e di intermediazione tipica delle burocrazie. […] Il trasferimento di potere
appare in modo ancora più netto, dal momento che il cittadino svolge integralmente attività prima affidate all’amministrazione. La riduzione della discrezionalità
amministrativa, e quindi anche del rischio dell’arbitrio e della gestione clientelare,
La perdita del senso del luogo, cioè, nel nostro discorso, la perdita della
necessità di recarsi negli uffici, porta con sé una forma di controllo diffuso sull’amministrazione che di conseguenza è costretta a perdere quell’aura di autorità che la caratterizza: “i nuovi modelli di flusso informativo influiscono innanzitutto sui ruoli sociali di tipo gerarchico. La perdita di controllo informativo
compromette l’esistenza delle tradizionali figure autoritarie”28.
Questa perdità di autorità può essere, per l’amministrazione, l’occasione
per mutare completamente la sua fisionomia, ottenendone in cambio una
nuova legittimazione presso la società civile.
L’utilizzo avanzato di Internet segna il passaggio della vecchia amministrazione
cartacea alla nuova amministrazione digitale, in cui gli scambi di informazioni sono
più celeri e diffusi; dalla amministrazione autoritaria, organizzata su base piramidale, il cui lavoro è scandito dai tempi della burocrazia e dalle regole formali dell’atto amministrativo, alla nuova amministrazione aperta al dialogo, orientata la
servizio e al risultato, in linea con i tempi della telematica29.
Franco Morganti avverte che “l’area del governo elettronico comprende sia
quella più tipica dei servizi al cittadino, quanto quella dell’innovazione interna
alla Pubblica amministrazione”30.
Anche se la pa si servisse dei sistemi informatici al solo scopo di razionalizzare ed accelerare il funzionamento della macchina burocratica, abbandonerebbe comunque “la gestione classica –lenta e rigida– della scrittura statica”.
Se poi Internet servisse “per sperimentare forme di organizzazione o trattamento dell’informazione innovative, decentralizzate, più duttili e interattive”,
anche “lo stato e le strutture attuali di governo potrebbero essere conservati, a
condizione di ridefinirne le sue funzioni: diventerebbero i guardiani, i garanti, gli
amministratori e gli esecutori dell’intelligenza collettiva”31. Naturalmente quella
che per la Lévy è concessione, per noi è necessità impellente: solo la presenza e l’azione dell’ente pubblico possono permettere quelle forme innovative,
decentralizzate, duttili e interattive di cui si auspica la realizzazione, possono
garantire l’utilizzo di tali forme comunicative per fini socialmente rilevanti e condivisi. Inoltre, traspare dal passo di Lévy una concezione residuale dello Stato
che noi certamente non condividiamo.
L’innovazione interna è necessaria perché “non è possibile fare della buona
comunicazione all’esterno se non si riorganizzano anche i processi interni”32.
Tale riorganizzazione può prendere spunto dal Business Process Reingeneering
NORME e SEGNI
si collega anche alla adozione di procedure automatizzate in casi come quelli della
liquidazione di pensioni, dell’assegnazione di abitazioni, e via dicendo. Qui assume rilevanza non tanto la trasparenza dei processi di decisione, quanto piuttosto
il momento dell’eguaglianza tra cittadini, le cui posizioni vengono liberate dall’eventualità di comportamenti discriminatori derivanti da scelte compiute dagli
apparati dell’amministrazione.
[…] La possibilità di informarsi senza mediazioni sulla persona che gestisce la procedura, e sullo stato di questa, non realizza soltanto un diritto di sapere dell’individuo, ma avvia una forma di controllo diffuso sulle modalità di funzionamento dell’amministrazione. Le possibilità di intervento e di controllo si fanno più incisive
quando i cittadini vengono consultati o associati a talune decisioni27.
133
134
(BPR) ed deve avere come centro il cittadino. La telematica gioca un ruolo decisivo nel reingegnerizzare i processi nella pa, in particolare nel consentire il controllo di tali processi (il protocollo elettronico va in questa direzione) e nel permettere una piena comunicazione interfunzionale tra i vari enti.
Una delle conseguenze più immediate dell’applicazione del BPR alla pa
potrebbe essere un importante decentramento amministrativo, sul quale si
discute molto in chiave politica e poco in riferimento al ruolo che le tecnologie
possono svolgere. Come evidenzia Nicholas Negroponte: “non occorre che
ogni comunicazione o decisione passi attraverso un’autorità centrale: questo
sarebbe un modo balordo di gestire un sistema per la prenotazione dei voli, ma
è considerato sempre più essenziale per la gestione delle organizzazioni e della
pubblica amministrazione. Una struttura decentralizzata con un alto livello di
interconnessione presenta una elasticità e possibilità di sopravvivenza molto
maggiori. È certamente più organizzata e capace di evolvere nel tempo. Il
decentramento è stato a lungo un approccio plausibile concettualmente, ma
non realizzabile praticamente”33. A proposito del decentramento –federalismo–
che si sta cercando di realizzare in Italia, bisogna guardare positivamente al
ruolo che Stanca prevede per le tecnologie informatiche. Infatti, al di là della
valutazione del progetto complessivo sul federalismo, ci sembra interessante
che le tecnologie di rete siano riconosciute come “la risorsa strategica per porre
in modo nuovo il rapporto fra autonomia delle amministrazioni locali con quelle
centrali e la necessità di integrità, armonizzazione, coerenza in un’ottica di sistema pubblico nazionale”34. Naturalmente, ciò non può significare che il rapporto
tra amministrazioni centrali a periferiche trovi la propria soluzione grazie alle
nuove tecnologie. È impensabile, cioè, che bastino nuove reti di comunicazione per dirimere una questione del tutto attinente la sfera politica.
Nel cambiamento qualcosa si perde: le strutture burocratiche affrontano ciò
che Anthony Giddens ha chiamato “la spersonalizzazione della fiducia”. Così la
descrive Maldonado, esaminandola proprio in riferimento alle nuove tecnologie:
“gli impegni delle persone nei confronti delle istituzioni sono «senza faccia»
(faceless), ossia impersonali. Impegni che si basano sostanzialmente sulla «fiducia» (trust) che le persone hanno nell’idoneità dei «sistemi esperti». [Ci] si riferisce, nella fattispecie, a quei sistemi astratti a cui, nella modernità, le persone affidano il compito di proteggerle dai rischi, di garantire, in fin dei conti, la loro sicurezza. […] Ma se questo è l’innegabile (e irrinunciabile) vantaggio di tale fiducia,
lo svantaggio, secondo Giddens, è la spersonalizzazione della fiducia. Il prezzo
che si paga per questa «sicurezza ontologica» è una sempre maggiore «vulnerabilità psicologica», perché, dopotutto, la «fiducia nei sistemi astratti non offre la
stessa gratificazione psicologica della fiducia nelle persone»”35.
Come può l’amministrazione pubblica sfuggire a ciò? “La comunicazione
pubblica in rete permette di dare vita ad un vero e proprio «customer service»
discreto e completo, capace di volta in volta di erogare informazioni e suggerimenti oppure di raccogliere o richiedere feedback e informazioni individuali,
nonché‚ una «customer intimacy», cioè la capacità di comprendere gli orientamenti del consumatore e di assecondare e stimolarne il comportamento”36.
Customer service e customer intimacy sono due conseguenze della adozione
NORME e SEGNI
da parte della pa di tecniche proprie del marketing interattivo di tipo relazionale (si veda la tabella 4), adozione resa possibile dall’uso della rete e da una
conseguente svolta culturale. “Gli amministrati sono diventati culturalmente cittadini-utenti e, in parte, cittadini-clienti. Cittadini-clienti non nel senso che comprano servizi in modo generalizzato, ma nel senso che lo Stato e gli enti pubblici rivendono ogni volta l’amministrazione al cittadini come se la dovesse
comprare: come se dovesse scegliere ogni volta i suoi servizi, come se dovesse confermare ogni volta il proprio contratto con la PA”37. Ciò con lo scopo di
completare la cittadinanza politica cone quella amministrativa e senza la pretesa di sostituire la seconda alla prima, il che significa che il BPR e la customer service non devo intendersi come surrogati dell’azione politica. Perciò
niente sconfinamenti indebiti della logica mercantile nell’ambito propriamente
politico: il marketing interattivo deve intendersi semplicemente come strumento utile ad un preciso e limitato scopo, quale può essere il miglioramento del
rapporto tra burocrazia e cittadino.
Tabella 4: il marketing interattivo
obiettivi
definire i benefici dell'utente e gli
obiettivi istituzionali
sviluppare un solido piano per
attrarre utenti potenziali
stimolare un forte coinvolgimento
dell'utente nei siti istituzionali
prevedere investimenti di
fidelizzazione
acquisire le informazioni
significative sul cliente
attivare una relazione continua
strumenti
- focalizzare su vantaggi istituzionali
- benefici effettivi, obiettivi espliciti
- leadership nel marketing
- campagne su stampa / TV
- cartelloni "on line"
- link con siti trafficati
- informazione e intrattenimento (servizio)
- coinvolgimento (chat)
- identificazione
- aggiornamento
- nuovi servizi
- coerenza marketing
- identificazione dei visitatori
- feedback degli utenti
- comunicazione “one to one”
- interazione / transazione customizzata
- servizi ad hoc
Fonte: Alberto Cattani, Internet e la comunicazione pubblica, Reggio Calabria, Scuola superiore
della pubblica amministrazione, 1998, p. 62.
L’elemento centrale della “cura della relazione”, l’elemento che ripersonalizza la fiducia è l’ascolto, diretta conseguenza del modello comunicativo della
rete, imperniato sulla interattività.
L’ultima osservazione riguarda i destinatari a cui si rivolge l’amministrazione digitalizzata. L’utilizzo della rete da parte delle istituzioni democratiche, è
realmente democratico, ossia rivolto a tutti i cittadini? Certamente no, e né può
esservi altra risposta osservando l’attuale diffusione delle tecnologie informatiche nel nostro, come anche negli altri Paesi. Questo, però, è un modo non
apprezzabile di porre la questione giacché è legato alla contingenza dell’oggi
e non ad una visione di lungo periodo: ogni discorso sulle tecnologie informa-
135
tiche se vuole evitare ogni tentazione retorica, deve dichiarare la propria conditio sine qua non: la capillare diffusione di personal computer e una alta alfabetizzazione informatica. Sebbene questa sia solo una condizione di partenza,
non bisogna dimenticare che ad oggi sia i dati del Pew Internet & American Life
Project38, negli Stati Uniti, sia quelli dell’Osservatorio Alchera39, in Italia, confermano l’ipotesi che le nuove tecnologie riescono ad ampliare il ventaglio di
opportunità solo per soggetti che hanno già un forte interesse per la politica nel
suo complesso, mentre non riescono ad attrarre l’attenzione dei cittadini da
essa più distanti. Al contrario, il target più importante al quale deve mirare la
pubblica amministrazione in rete è formato da quella vasta fascia di cittadini
poco propensi ed abituati a cercare il dialogo e il confronto con le istituzioni e
con gli altri soggetti che costituiscono la sfera pubblica. Purtroppo, questi sono
coloro che meno navigano nel ciberspazio.
136
* Dottorando di ricerca in “Teoria dell’informazione e della comunicazione” presso l’Università
degli Studi di Macerata e Senior McLuhan Fellow presso il McLuhan Program in Culture and
Technology dell’Università di Toronto.
I materiali qui presentati riprendono, in parte, e aggiornano i lavori della ricerca “I ministeri in
rete”, condotta nel settembre 2001 insieme a Danilo Vaccari e Matteo Domenico Recine per la cattedra di Teoria e tecniche della comunicazione pubblica, tenuta da Franca Faccioli presso la Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. A loro il mio ringraziamento per il continuo confronto.
1 A cura di Matteo Domenico Recine. Laureato in Scienze della comunicazione presso l’Università “La Sapienza” di Roma con tesi: L’e-government in Italia. Ha collaborato al rapporto Le città
digitali 2003 realizzato da Rur-Censis.
2 HAROLD A. INNIS, Impero e comunicazioni, Roma: Meltemi, 2001. Si veda anche Beniger,
James R., Le origini della società dell’informazione, Torino: Utet, 1995.
3 JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, La condizione postmoderna, Milano: Feltrinelli, 1979.
4 ZYGMUNT BAUMAN, Modernità liquida, Roma-Bari: Laterza, 2002.
5 FRANCIS FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano: Rizzoli, 1992, rappresenta
solo la punta di un iceberg ben più ampio.
6 MANUEL CASTELLS, Galassia Internet, Milano: Feltrinelli, 2002, p. 262.
7 JÜRGEN HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari: Laterza, 1971, p. 14.
8 JOHN B. THOMPSON, Mezzi di comunicazione e modernità, Bologna: Il Mulino, 1998, pp. 352-353.
9 JÜRGEN HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., p.122.
10 PIERRE LÉVY, L’intelligenza collettiva, Milano: Feltrinelli, 1999, p. 98.
11 PIERRE LÉVY, Cyberdémocratie, Paris (Fra): Odile Jacob, 2002.
12 PIERRE LÉVY, L’intelligenza collettiva, cit., p. 90.
13 TOMÀS MALDONADO, Critica della ragione informatica, Milano: Feltrinelli, 1999, p. 58.
14 SARA BENTIVEGNA, La politica in rete, Roma: Meltemi, 1995, p. 148.
15 BENTIVEGNA, op. cit., p. 14.
16 FRANCO BERARDI (a cura di), Cibernauti, Roma: Castelvecchi, 1996, p. 116; è bene dichiarare che il “modello di democrazia” delineato da Berardi non è da noi condiviso.
17 LAWRENCE K. GROSSMAN, La repubblica elettronica, Roma: Editori Riuniti, 1997.
18 TOMÀS MALDONADO, Critica della ragione informatica, cit., pp. 43-45.
19 LISS JEFFREY, “Tempo e democrazia on line. Riflessioni sul processo politico nell’era dei network globali”, in de Kerckhove, Derrick, La conquista del tempo, Roma: Editori Riuniti, 2003, p. 85.
20 Per tali documenti-quadro, nonché per le singoli disposizioni normative riguardanti le speci-
NORME e SEGNI
fiche tematiche, abbiamo ritenuto utile inserire l’appendice “Fonti normative e documenti istituzionali”, alla quale si rimanda.
21 Il documento sui 10 obiettivi di legislatura, che il Governo ha elaborato per la digitalizzazione dell’amministrazione, considera alcuni (quelli contrassegnati con il simbolo #) degli aspetti inseriti nella tabella 1, nella quale manca la qualità, che però è un metaobiettivo.
22 FRANCO CARLINI, “Non bastano leggi d’avanguardia, il problema è riuscire ad applicarle”, in
Telèma Burocrazia elettronica società più civile, 19, inverno 1999/2000.
23 Si veda GIANCARLO FORNARI, “Le nuove prospettive del fisco telematico”, Rivista italiana di
comunicazione pubblica, 4, 2000.
24 Ci riferiamo, in particolare, alle agevolazioni per la banda larga concesse alle famiglie.
25 VINCENZO VITA, “Il tempo nel governo in rete e nella pratica democratica”, in DE KERCKHOVE,
DERRICK, La conquista del tempo, Roma: Editori Riuniti, 2003, p. 108.
26 STEFANO RODOTÀ, Tecnopolitica, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 65.
27 JOSHUA MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo, Bologna: Baskerville, 1993, p. 192.
28 STEFANO RODOTÀ, Tecnopolitica, cit., p. 65 e p. 36.
29 JOSHUA MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo, cit., p. 270.
30 GIANCARLO FORNARI e MICHELE DIODATI, Internet per le pubbliche amministrazioni, Roma, Buffetti, 2000, p. 5.
31 FRANCO MORGANTI, “Nel nostro futuro c’è il modello di un nuovo governo. Elettronico”, Telèma. Burocrazia elettronica società più civile, 19, inverno 1999/2000.
32 PIERRE LÉVY, L’intelligenza collettiva, cit., p. 85.
33 PAOLA M. MANACORDA, “Tecnologie della comunicazione: strumenti strategici per la democrazia locale e l’amministrazione «amichevole»”, in Catanzaro, Raimondo e Ceri, Paolo (a cura di),
Comunicare nella metropoli, Torino: Utet-libreria, 1995, p. 140.
34 NICHOLAS NEGROPONTE, Essere digitali, Milano, Sperling & Kupfer, 1999, p. 164.
35 LUCIO STANCA, “e-Gov, la via breve del cambiamento”, il corriere delle Telecomunicazioni,
5/11 maggio 2003.
36 TOMAS MALDONADO, Critica della ragione informatica, cit., p. 66. Si veda, per le conseguenze
sugli impiegati dell’amministrazione, Carotenuto, Aldo, “Burocrazia, un mostro stupido che l’informatica potrà domare”, Telèma. Burocrazia elettronica società più civile, 19, inverno 1999/2000.
37 ALBERTO CATTANI, Internet e la comunicazione pubblica, Reggio Calabria, Scuola superiore
della pubblica amministrazione, 1998, p. 50.
38 PAOLO CERI, “Verso l’amministrazione pubblica dei cittadini-utenti”, in Catanzaro, Raimondo
e Ceri, Paolo (a cura di), Comunicare nella metropoli, cit., p. 75.
39 http://www.pewinternet.org.
40 www.alchera.it.
137
Bibliografia
138
BAUMAN, 2000 Bauman, Zygmunt, Modernità liquida, Roma-Bari: Laterza, 2002.
BENIGER, 1986 Beniger, James R, Le origini della società dell’informazione. La rivoluzione del controllo, Torino: Utet, 1995.
BENTIVEGNA, 1999 Bentivegna, Sara, La politica in rete, Roma: Meltemi, 1999.
BERARDI, 1996 Berardi, “Bifo” Franco (a cura di), Cibernauti. Tecnologia, comunicazione, democrazia, Roma: Castelvecchi, 1996.
CARLINI, 1999 Carlini, Franco, “Non bastano leggi d’avanguardia, il problema è riuscirle
ad applicare”, Telèma. Burocrazia elettronica società più civile, 19, inverno
1999/2000.
CASTELLS, 2001 Castells, Manuel, Galassia Internet, Milano: Feltrinelli, 2002.
CERI, 1995 Ceri, Paolo, “Verso l’amministrazione pubblica dei cittadini-utenti”, in Catanzaro-Ceri, 1995.
CATANZARO-CERI, 1995 Catanzaro, Raimondo e Ceri, Paolo (a cura di), Comunicare
nella metropoli. Tecnologie della comunicazione, democrazia, amministrazione,
Torino: Utet, 1995.
CAROTENUTO, 1999 Carotenuto, Aldo, “Burocrazia, un mostro stupido che l’informatica
potrà domare”, Telèma. Burocrazia elettronica società più civile, 19, inverno
1999/2000.
CATTANI, 1998 Cattani, Alberto, Internet e la comunicazione pubblica, Reggio Calabria:
Scuola superiore della pa, 1998.
DE KERCKHOVE, 2003 de Kerckhove, Derrick (a cura di), La conquista del tempo. Società e democrazia nell’età della rete, Roma: Editori Riuniti, 2003.
FORNARI, 2000 Fornari, Giancarlo, “Le nuove prospettive del fisco telematico”, Rivista
italiana di comunicazione pubblica, 4, 2000.
FORNARI-DIODATI, 2000 Fornari, Giancarlo e Diodati, Michele, Internet per le pubbliche
amministrazioni. Come utilizzare al meglio le opportunità della rete per avvicinare le istituzioni ai cittadini, Roma: Buffetti, 2000.
FUKUYAMA, 1992 Fukuyama, Francis, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano: Rizzoli, 1992.
GROSSMAN, 1995 Grossman, Lawrence K., La repubblica elettronica, Roma: Editori Riuniti, 1997.
HABERMAS, 1962 Habermas, Jurgen, Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari:
Laterza, 1971, ed. 1995.
INNIS, 1950 Innis, Harold A., Impero e comunicazioni, Roma: Meltemi, 2001.
JEFFREY, 2003 Jeffrey, Liss, “Tempo e democrazia on line. Riflessioni sul processo politico nell’era dei network globali”, in de Kerckhove, 2003.
LÉVY, 1994 Lévy, Pierre, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio,
Milano: Feltrinelli, 1996, 4. ed, 1999.
LÉVY, 2002 Lévy, Pierre, Cyberdémocratie, Paris (Fra): Editions Odile Jacob, 2002.
LYOTARD, 1979 Lyotard Jean-François, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano: Feltrinelli, 1979.
MALDONADO, 1997 Maldonado, Tomas, Critica della ragione informatica, Milano: Feltrinelli, 1997, 3 ed. 1999.
MANACORDA, 1995 Manacorda, Paola M., “Tecnologie della comunicazione: strumenti
strategici per la democrazia locale e l’amministrazione «amichevole»”, in Catanzaro-Ceri, 1995.
MEYROWITZ, 1985 Meyrowitz, Joshua, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici
NORME e SEGNI
influenzano il comportamento sociale, Bologna: Baskerville, 1993.
MORGANTI, 1999 Morganti, Franco, “Nel nostro futuro c’è il modello di un nuovo governo. Elettronico”, Telèma. Burocrazia elettronica società più civile, 19, inverno
1999/2000.
NEGROPONTE, 1995 Negroponte, Nicholas, Essere digitali, Milano: Sperling&Kupfer,
1995.
RODOTÀ, 1995 Rodotà, Stefano, “La cittadinanza elettronica”, Telèma. Politica, telematica, democrazia, 1, estate 1995.
RODOTÀ, 1997 Rodotà, Stefano, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie
della comunicazione, Roma-Bari: Laterza, 1997.
SMAURICERCHE, 2003 smauRicerche, Italia.ICT. Innovazione e competitività del Sistema
Paese, Roma: 2003.
THOMPSON, 1995 Thompson John B., Mezzi di comunicazione e modernità. Per una teoria sociale dei media, Bologna: Il Mulino, 1998.
VITA, 2003 Vita, Vincenzo, “Il tempo nel governo in rete e nella pratica democratica”, in
de Kerckhove, 2003.
139
IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE
L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE EUROPEO
di Marianna Pankiewicz
1. Le diverse attività
140
Il Trattato di Maastricht del 1992 prevede l’istituzione di un Mediatore europeo. Ai sensi dell’articolo 195 del Trattato CE, qualsiasi cittadino dell’Unione o
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro può presentare una denuncia al Mediatore in presenza di un
caso di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzione e degli organi
comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado
nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
L’Ombudsman europeo, pertanto, tutelando i cittadini dalla cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi comunitari, risulta uno strumento di
tutela non giurisdizionale. Il diritto di denuncia al Mediatore europeo è un diritto tipico della cittadinanza dell’Unione, è uno dei mezzi per rafforzare la tutela
dei diritti e degli interessi dei cittadini.
La funzione del Mediatore europeo è sia di protezione dei diritti dei singoli,
ma anche di stimolo per le istituzioni. Rendendo trasparente l’azione amministrativa e assicurando una buona amministrazione è possibile rinsaldare il rapporto tra istituzioni e cittadini. In questo modo l’ombudsman europeo contribuisce da un lato alla creazione di una Comunità vicina ai singoli e dall’altro
migliora l’efficacia dell’amministrazione.
Molte delle prerogative e delle caratteristiche peculiari del Mediatore europeo sono simili e talvolta identiche a quelle dei mediatori o difensori civici operanti negli Stati membri dell’Unione europea.
Il Mediatore europeo ha la funzione di risolvere i casi di cattiva amministrazione posti in essere dalle istituzioni comunitarie, al fine di garantire una buona
amministrazione.
La prima difficoltà incontrata riguardava proprio ciò che doveva costituire il
suo parametro di riferimento. Non era chiaro, infatti, in quali casi si potesse
parlare di cattiva amministrazione.
La prima definizione che il Mediatore dà della cattiva amministrazione è rinvenibile nella sua prima Relazione annuale, quella del 1995:
“Chiaramente si è in presenza di un caso di cattiva amministrazione quando un’istituzione o un organo comunitario non opera conformemente ai trattati
ed agli atti comunitari che sono vincolanti in materia o se non osserva le norme
e i principi giuridici stabiliti dalla Corte di giustizia o dal Tribunale di primo
grado.
La cattiva amministrazione può comprendere molti altri aspetti, fra cui: irre-
NORME e SEGNI
golarità amministrative, omissioni amministrative, abuso di potere, negligenza,
procedure illecite, iniquità, disfunzioni o incompetenza, discriminazione, ritardo
evitabile, assenza o rifiuto d’informazioni.
Questo elenco non vuole essere esaustivo. L’esperienza dei Difensori Civici
Nazionali dimostra che è meglio non tentare di definire con rigore ciò che può
costituire cattiva amministrazione, dato che il carattere aperto di questo termine
è uno degli elementi che permettono di distinguere il ruolo del Mediatore da
quello del giudice”. Tale definizione si è poi, col tempo, ulteriormente precisata.
La finalità della sua azione è di garantire una buona amministrazione, sia
come diritto che come principio. È proprio in virtù di tale obiettivo che il Mediatore agisce in modi diversi.
Come si vedrà nei paragrafi successivi, l’attività principale consiste nella
risoluzione dei casi che sono sottoposti alla sua attenzione. L’Ombudsman (letteralmente: “uomo che funge da tramite”, così si chiamava il difensore civico
istituito in Svezia con la costituzione del 1809) europeo apre un procedimento,
a seguito di una denuncia o di sua spontanea iniziativa, le cui caratteristiche
sono la celerità, l’economicità e l’informalità. Tenta sempre una conciliazione
tra le parti, assicura il contraddittorio e talvolta esercita poteri investigativi.
L’unico problema è che non gli è riconosciuto alcun potere di tipo coercitivo o
sanzionatorio per far valere le sue decisioni. Si tratta di un forte limite che
rischia di rendere inefficace la sua azione.
In seguito ad un numero cospicuo di ricorsi, il Mediatore europeo ha avuto
la possibilità di agire al fine di assicurare il diritto d’accesso. È anche grazie al
suo interessamento che vi sono stati frequenti interventi da parte del legislatore comunitario.
Al fine di garantire una buona amministrazione, l’azione dell’Ombudsman si
articola in più direzioni.
Il Mediatore espleta un’attività di prevenzione, che consiste nello specificare e chiarire quali comportamenti devono essere tenuti da un’amministrazione.
È stato grazie all’intervento del Mediatore europeo, che il diritto ad una
buona amministrazione non solo ha trovato riconoscimento nella Carta dei
diritti fondamentali e nel Codice di buona condotta amministrativa, ma anche
nel testo della Costituzione europea.
La prevenzione, inoltre, ha portato il Mediatore ad instaurare un rapporto di
cooperazione con le altre istituzioni comunitarie, che pure mirano ad assicurare il diritto ad una buona amministrazione.
Nel riportare all’interno della relazione annuale i casi risolti, è possibile leggere una finalità preventiva. L’Ombudsman, infatti, ritiene che le altre istituzioni o gli altri organi sia comunitari che nazionali possano guardare alle sue decisioni come ad un precedente.
Sulla base di queste considerazioni è possibile concludere che la prevenzione è una delle attività principali, ma quella che lo vede impegnato maggiormente è proprio quella di risoluzione dei casi di cattiva amministrazione.
141
2. La normativa di riferimento
142
Il Mediatore europeo espleta le proprie funzioni ai sensi dell’articolo 195 del
Trattato comunitario, così come modificato dal Trattato di Maastricht del 1992.
Prima di allora, si era discusso molto sull’esigenza di istituire un ombudsman
comunitario, ma fino a quel momento non vi era stato alcun intervento normativo.1 Con il Trattato di Maastricht ne viene sancita l’istituzione e vengono dettate le regole generali per l’esercizio delle funzioni.Vi è stata, poi, la Decisione
del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per
l’esercizio delle funzioni, entrata in vigore nel 1994. In questo atto parlamentare è contenuta la disciplina concernente l’organizzazione dell’ufficio del Mediatore e ne viene disciplinata in linea generale l’attività. Nell’articolo 14 si dice
che il Mediatore deve adottare le disposizioni d’esecuzione, che furono poi
approvate il 16 ottobre 1997 e successivamente abrogate da quelle entrate in
vigore il 1° gennaio 2003. In tale atto il Mediatore disciplina la sua attività, indicando i presupposti per il ricevimento delle denunce, per l’avvio delle indagini
e per la emissione di valutazioni critiche, raccomandazioni e relazioni speciali
al Parlamento. Disciplina inoltre la sua attività di cooperazione con i difensori
civici e organi corrispondenti degli Stati membri e regola l’accesso pubblico ai
documenti.
Vi è, poi, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a
Nizza nel dicembre 2000, in cui viene riconosciuto tra i diritti fondamentali il
ricorso al Mediatore europeo. Si è discusso a lungo sul valore giuridico vincolante di tale atto, considerato un vero e proprio Bill of rights.2 La conclusione a
cui sono giunte la dottrina e la giurisprudenza è che pur non essendo vincolante, ha comunque rilevanza giuridica.
Nel 2001, invece, è stato approvato il codice di buona condotta amministrativa nel quale si spiega quale sia il significato del diritto ad una buona amministrazione. Tale codice è indirizzato alle istituzioni comunitarie e ai suoi funzionari, ma anche ai cittadini, nel senso che a questi ultimi viene spiegato cosa
hanno il diritto di aspettarsi. Anche sul valore giuridico di tale documento si è
discusso a lungo, concludendo che, come la Carta dei diritti fondamentali, pur
avendo rilevanza giuridica, non è vincolante.
Inoltre, il Mediatore europeo è tenuto al rispetto del Regolamento CE
n°45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente sia la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di
organi e istituzioni comunitarie, sia la libera circolazione di tali dati.
L’articolo 14 delle disposizioni d’esecuzione disciplina proprio l’accesso
pubblico ai documenti custoditi dal Mediatore.
Nel testo della Costituzione europea, nel titolo relativo ai diritti fondamentali e alla cittadinanza dell’Unione, è inserito il diritto di denuncia al Mediatore
europeo, così che oggi è elevato al rango di diritto costituzionale.
3.1 La denuncia
La funzione del Mediatore europeo è di risolvere i casi di cattiva amministrazione posti in essere dalle istituzioni e dagli organi comunitari, al fine di
garantire la buona amministrazione.
L’attività del Mediatore si avvia sulla base di una denuncia o di propria iniziativa.3
La denuncia può essere presentata da un qualsiasi cittadino europeo o da
una qualsiasi persona residente in uno Stato membro. Nell’articolo 2 dello statuto del Mediatore si precisa che si può trattare sia di una persona fisica che
di una persona giuridica. Quando si parla di persona giuridica si fa riferimento
a tutte le imprese, associazioni o altri organismi che hanno la sede sociale nell’Unione.
La denuncia può essere presentata personalmente o attraverso un membro
del Parlamento europeo, ma anche da chi sia terzo e nonostante l’opposizione della parte interessata.4 Si riconosce anche ad una persona terza la possibilità di sporgere denuncia perché la funzione del Mediatore è di risolvere i casi
di cattiva amministrazione, garantire la buona amministrazione e pertanto
migliorare i rapporti con i cittadini.
Per quanto riguarda la forma delle denunce, è preferibile quella per lettera,
ma sono accettate anche quelle orali o telefoniche. Questo vuol dire che non
è richiesto il rispetto di determinati requisiti formali. Infatti, per questo tipo di
denuncia non è neppure richiesto il patrocinio di un legale. È comunque consentita l’assistenza legale, ma soltanto se il denunciante ne avverte la necessità. L’assenza del patrocinio legale e la mancanza di requisiti formali per la
presentazione della denuncia sono sintomatiche del fatto che il ricorso al
Mediatore europeo non è di tipo giurisdizionale.
Pertanto l’attività del Mediatore va distinta da quella degli organi giurisdizionali.
L’oggetto della denuncia deve riguardare un caso di cattiva amministrazione. Che cosa s’intenda per cattiva amministrazione è stato precisato dallo
stesso Mediatore.
La denuncia, inoltre, può riguardare un rapporto di lavoro tra l’istituzione o
organo comunitario e un suo funzionario o agente, purché siano state esperite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo e siano scaduti i
termini fissati per la risposta da parte dell’autorità interessata.5
I soggetti contro i quali è possibile presentare la denuncia sono le istituzioni elencate nell’articolo 7 del Trattato comunitario e in più le agenzie ed altri
organismi.6 Per quanto riguarda la Banca centrale europea, essendo un’autorità indipendente, per una parte della dottrina non può essere sottoposta alle
indagini del Mediatore, proprio al fine di assicurarne la massima autonomia.
Nel Trattato e nello Statuto della BCE, si fa riferimento al controllo di natura
giurisdizionale, ma non si menziona quello espletato dall’Ombudsman europeo
e per tale ragione se ne esclude l’esperibilità.7 Si auspica, comunque, un chiarimento di natura normativa.
NORME e SEGNI
3. La procedura d’indagine
143
144
La denuncia, inoltre, non può essere presentata contro un’autorità che non
sia indicata esplicitamente né contro una persona fisica.
Per quanto riguarda il profilo procedurale, la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono
portati a conoscenza del ricorrente.8 È quindi fissato un termine di prescrizione entro il quale far valere il proprio diritto.
Nella denuncia devono risultare chiaramente l’oggetto della stessa e l’identità della persona che la presenta.9
La presentazione di una denuncia al Mediatore europeo non interrompe i
termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi. Questo
vuol dire che il ricorso al Mediatore non impedisce il ricorso giurisdizionale.
La denuncia va presentata soltanto dopo aver fatto passi amministrativi
appropriati presso le istituzioni e gli organi interessati dalla cattiva amministrazione. Nel senso che si deve cercare una soluzione in accordo con l’organo o
l’istituzione, prima di rivolgersi al Mediatore.
Nel momento in cui le denunce vengono ricevute, sono classificate, registrate e numerate e al reclamante viene inviata una conferma scritta nella
quale sono indicati la procedura che verrà seguita e il nome del funzionario che
se ne occupa.10 Sono denominati giuristi i funzionari dell’ufficio responsabili del
trattamento delle denunce.
È possibile chiedere al Mediatore che la denuncia sia esaminata confidenzialmente, nel senso che sia classificata come riservata, infatti la regola generale è che sia trattata pubblicamente.11 È importante che il Mediatore operi nel
modo più aperto e trasparente possibile, sia per consentire ai cittadini europei
di seguirne e comprenderne il lavoro, sia per fornire il buon esempio alle altre
istituzioni.
Una denuncia può essere trasferita al Parlamento europeo perché la tratti come una petizione oppure ad un’altra autorità competente a condizione
che il Mediatore lo ritenga opportuno e che il denunciante acconsenta.12
Anche una petizione trasmessa al Mediatore dal Parlamento europeo può
essere trattata come una denuncia, previo consenso del firmatario. Questo
elemento è uno dei tanti sintomatici del rapporto stretto esistente tra le due
istituzioni.
La denuncia al Mediatore europeo non richiede il rispetto di particolari formalità, questo soprattutto al fine di semplificare il ricorso e assicurare una tutela effettiva. Questo non vuol dire che non esistano delle condizioni che devono essere soddisfatte per presentare la denuncia, anzi queste, desumendole
dagli articoli 2 e 3 dello statuto, possono essere così riassunte:
– la denuncia può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica
che ha sede sociale in uno dei paesi dell’Unione;
– la denuncia deve riguardare un caso di cattiva amministrazione;
– la cattiva amministrazione deve riguardare una delle istituzioni o degli
organi comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo
grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;
– nella denuncia occorre precisare l’oggetto della stessa e l’identità della
persona che la presenta;
3.2 La ricevibilità e l’irricevibilità della denuncia e l’apertura delle indagini
Una volta presentata una denuncia, il Mediatore europeo valuta se questa
rientra nel suo mandato e quindi sia ricevibile oppure esula dal suo mandato e
dunque archivia il caso.13
Una denuncia risulta ricevibile quando il Mediatore ritiene che questa rientra effettivamente nel suo mandato, questo però non vuol dire che sia anche
ricevibile. Tale valutazione avviene sulla base dei criteri definiti tanto nel Trattato di Maastricht nell’articolo 195 quanto nello statuto. È una valutazione che
non ha carattere discrezionale, ma si fonda su condizioni ben precise.
Una denuncia rientra nel mandato del Mediatore europeo quando:
– riguarda un caso di cattiva amministrazione;
– la cattiva amministrazione è posta in essere da un organo o da una delle
istituzioni comunitarie ad eccezione della Corte di giustizia o del Tribunale di
primo grado.
Se una denuncia non rientra nel mandato del Mediatore europeo, questo
archivia il caso.14 Se la denuncia invece rientra occorrerà accertarsi che sia
ricevibile.
Una denuncia è ricevibile se:
– l’autore e l’oggetto della stessa sono identificabili;
– è presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente;
– deve essere preceduta da un contatto diretto tra l’istituzione e gli organi
interessati;
– non è stato avviato un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale e non si è messa in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria;
– essendo inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni o organi comunitari e
i loro dipendenti, sono state esaurite le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo.
Ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni d’esecuzione del Mediatore, se la
denuncia è ricevibile il Mediatore decide se avviare le indagini o archiviare il
caso. Si tratta ancora una volta di una valutazione non di natura discrezionale, che il Mediatore effettua sulla base di elementi oggettivi. Prima di prendere
una decisione il Mediatore europeo può chiedere al denunciante ulteriori informazioni o documenti.15 Pertanto se ritiene che vi siano motivi sufficienti, avvia
le indagini. Una volta aperte le indagini ne informa sia il denunciante sia l’istituzione interessata.16 In particolare invia all’organo comunitario investito dal
caso di cattiva amministrazione una copia della denuncia e lo invita a formulare un parere entro tre mesi. Tale parere viene poi inviato al denunciante perché formuli a sua volta delle osservazioni. Nel momento in cui apre le indagini
NORME e SEGNI
– la denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data
entro cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente;
– la denuncia deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati
presso le istituzioni e gli organi interessati.
145
146
tenta una prima conciliazione tra le parti. In base ai risultati del contraddittorio
decide se proseguire le indagini o archiviare il caso.
Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto, se una denuncia esula dal mandato del
Mediatore o vi rientra, è comunque irricevibile:
– quando non riguarda un caso di cattiva amministrazione;
– quando non si tratta di un’istituzione o di un organo comunitario oppure si
tratta della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado nell’esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali;
– quando non è presentata entro due anni;
– quando non s’indica l’identità del denunciante e l’oggetto della denuncia;
– quando è stato già avviato un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale o vi è stata una decisione giudiziaria di siffatto organo;
– quando non è stata preceduta da un contatto diretto con l’istituzione o l’organo interessato al fine di trovare una soluzione;
– quando essendo inerente ad un rapporto di lavoro tra istituzioni o organi
comunitari e i loro funzionari, l’interessato non ha esperito le possibilità interne
di domanda o ricorso e non sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte
dell’autorità interessata.
Il Mediatore europeo quando una denuncia è irricevibile può anche consigliare di rivolgersi ad un’altra autorità comunitaria o nazionale oppure trasferire la denuncia direttamente all’organismo competente.17 In queste ipotesi è
necessario comunque un assenso da parte del Mediatore e il consenso del
denunciante.
Il Mediatore europeo soltanto se ritiene che vi siano motivi sufficienti apre
le indagini. Nel caso però di piccole irregolarità, come una mancata risposta o
lievi ritardi, non apre un’indagine ma piuttosto cerca di stimolare l’istituzione
attraverso contatti informali. Infatti già nelle sue relazioni il Mediatore ha stabilito degli standard che devono essere garantiti per la fase dell’iniziativa, della
decisione e della conclusione della procedura.18
Si può dunque notare come nella fase precedente le indagini il Mediatore
decida in modo non discrezionale ma del tutto oggettivo se una denuncia è
effettivamente fondata. La sua valutazione si basa sul riscontro di condizioni
stabilite nello statuto e non su un suo mero giudizio. Le sue scelte inoltre sono
sempre motivate, soprattutto nel caso in cui ritenga che una denuncia esuli dal
suo mandato e pertanto sia irricevibile.
In base ai dati statistici concernenti l’attività del Mediatore europeo dal
01.01.2000 al 31.12.2003, 19 su 8419 denunce ricevute soltanto il 30% circa
rientrava nel mandato del Mediatore, in 909 casi sono state avviate delle
indagini. Dalla relazione annuale del 2003 è emerso che la maggior parte
delle denunce non rientrano nel mandato del Mediatore europeo o perché
non riguardano un’istituzione o un organo comunitario o perché non si tratta di un caso di cattiva amministrazione o perché il denunciante non è autorizzato. Inoltre le denunce risultano irricevibili o perché non sono precedute
da passi amministrativi appropriati, o perché autore e oggetto non sono individuabili, o perché sono scaduti i termini, o perché non sono state esaurite
le possibilità interne di ricorso nei casi relativi al personale delle istituzioni,
NORME e SEGNI
o perché i fatti sono oggetto di un procedimento giurisdizionale in corso o
concluso.
Da tali dati, quindi, è possibile dedurre che il motivo per cui le denunce non
rientrano nel mandato del Mediatore o vi rientrano ma sono irricevibili è la poca
informazione. Proprio al fine di evitare tutto ciò, il Mediatore ha sempre cercato di attuare una politica d’informazione, impegnandosi nel far conoscere sempre di più l’ufficio. Come emerge dalla relazione annuale del 2003, in quei dodici mesi sono stati fatto sempre più affidamento sulla possibilità di diffondere le
informazioni tramite Internet.
3.3 I poteri istruttori del mediatore e la conclusione delle indagini
La fase successiva all’accertamento della ricevibilità della denuncia si può
considerare d’indagine.
Nel corso di tale fase sono attribuiti al Mediatore europeo poteri istruttori,
che sono stati ulteriormente rafforzati con le Disposizioni d’esecuzione entrate
in vigore nel 2003. Con le nuove disposizioni si sono riconosciuti al Mediatore
nuovi poteri di natura istruttoria per consentirgli di stabilire con maggiore semplicità la presenza o meno di un caso di cattiva amministrazione.
Quando il Mediatore decide di avviare un’indagine, invia una copia della
denuncia all’istituzione interessata perché formuli un parere entro tre mesi, tale
parere viene poi trasmesso al cittadino perché esprima le sue osservazioni.20
Nella relazione del 1998 il Mediatore europeo ha detto chiaramente che le informazioni fornite da uno dei soggetti non possono essere considerate se non
viene acquisito il parere della controparte.21 Il Mediatore europeo dunque considera una condizione necessaria della sua attività il rispetto del contraddittorio.
Durante questa fase, in cui il Mediatore esercita dei poteri di mediazione,
l’istituzione comunitaria interessata può decidere di venire incontro alle richieste del reclamante oppure è questo a decidere di desistere. In caso contrario
il Mediatore deve o procedere all’accertamento dei fatti e verificare che effettivamente vi sia un caso di cattiva amministrazione oppure archiviare il caso.
Nell’ipotesi in cui deve procedere all’accertamento dei fatti, ai sensi dell’articolo 5 delle Disposizioni d’esecuzione, gli sono attribuiti:
– il potere di richiesta di informazioni o documenti alle istituzioni o agli organi comunitari o alle autorità degli Stati membri
– il potere d’esaminare il fascicolo dell’istituzione comunitaria interessata e
il potere di estrarne copia
– il potere di richiesta di testimonianza nei confronti di funzionari o agenti di
istituzioni od organi comunitari
– il potere di accedere in loco
– il potere di commissionare studi o relazioni di esperti.
Si tratta di poteri d’indagine piuttosto estesi, in passato infatti non gli era
consentito l’accesso a tutti i tipi di documento e non poteva acquisire testimonianze. Oggi invece può prendere visione di qualsiasi documento sia pubblico
che riservato, sia comunitario sia di uno Stato membro. In caso di resistenza
147
148
può rivolgersi al Parlamento europeo perché prenda le iniziative del caso.22 I
poteri d’indagine trovano un limite nel segreto professionale, in base al quale
le amministrazioni e i funzionari possono rifiutarsi di rispondere, purché diano
un’adeguata motivazione.23 Nella relazione del 1998 il Mediatore ha sottolineato la necessità di distinguere tra i limiti all’accesso del pubblico ai documenti e
i limiti all’accesso consentito al Mediatore.24 Sicuramente il Mediatore opera
osservando il principio del contraddittorio e oggi può accedere anche a quasi
tutti i documenti, per verificare le risposte e le giustificazioni che le istituzioni
comunitarie forniscono a seguito della denuncia.
Quando l’esercizio di questi poteri non pone in luce un caso di cattiva amministrazione, l’istituzione e il denunciante ne sono informati e il caso viene archiviato con una decisione motivata.25
Qualora il Mediatore riscontri un caso di cattiva amministrazione deve tentare la via della conciliazione amichevole. Se non è possibile trovare una soluzione amichevole, soltanto allora il Mediatore potrà o formulare un’osservazione critica oppure nei casi più gravi redigere una relazione corredata da un progetto di raccomandazione.
Ai sensi dell’articolo 7 delle Disposizioni d’esecuzione il Mediatore può formulare un’osservazione critica a due condizioni: quando non è più possibile eliminare il caso di cattiva amministrazione e quando la cattiva amministrazione
non ha implicazioni generali. Il Mediatore ha comunque l’obbligo di informarne
il denunciante.
Ai sensi dell’articolo 8 delle Disposizioni d’esecuzione, il Mediatore redige
una relazione munita di un progetto di raccomandazione quando l’istituzione
può ancora eliminare il caso di cattiva amministrazione e quando il caso di cattiva amministrazione ha delle implicazioni generali. Il Mediatore deve trasmettere tali atti all’istituzione e al denunciante. L’istituzione in questa ipotesi è tenuta a trasmettere entro tre mesi un parere circostanziato. Con il parere circostanziato è possibile che l’istituzione accetti la decisione del Mediatore e adotti apposite misure. Ma nell’ipotesi in cui il Mediatore non reputi il parere soddisfacente, allora elabora una relazione speciale destinata al Parlamento europeo. La relazione può contenere una raccomandazione.26
Il progetto di raccomandazione è solitamente redatto nei casi più gravi,
quando cioè l’inerzia dell’istituzione interessata può aggravare la situazione
che risulta invece risolvibile.
Il Mediatore dunque dispone di ampi poteri istruttori, che si caratterizzano
per un bassissimo tasso di discrezionalità e per l’attuazione del contraddittorio,
ma non dispone di poteri decisori. Le indagini gli consentono di constatare se
si è in presenza di un caso di cattiva amministrazione, ma non ha il potere di
imporre la sua volontà all’istituzione interessata. Pertanto può non essere in
grado di risolvere il caso di cattiva amministrazione. Le osservazioni, le raccomandazioni e le relazioni infatti non sono atti che hanno efficacia vincolante.
Di qui anche la tesi della loro non impugnabilità al fine di ottenere l’annullamento.27 Il Mediatore infatti ritiene che dal momento che le sue decisioni non
sono vincolanti non possono essere lesive. L’unico caso fino ad oggi di ricorso
agli organi giurisdizionali comunitari contro il Mediatore ha riguardato una
3.4 Difesa
Durante il procedimento volto ad accertare il caso di cattiva amministrazione il Mediatore esercita dei poteri d’indagine, a seguito della denuncia di un
soggetto che ritiene che sia stato leso un suo diritto.
L’autore della denuncia sembra essere gravato dello stesso onere probatorio che si rinviene nel processo civile o penale. Egli deve indicare tutti gli elementi che dimostrano la lesione del suo diritto. Se non vi riesce rischia che le
indagini non siano approfondite e la lesione permanga.
Spetta poi al Mediatore accertare la fondatezza della denuncia.
L’Ombudsman europeo opera sempre nel pieno rispetto del contraddittorio,
nel senso che non decide mai avendo consultato soltanto una parte.
Infatti, una volta che ritenga che vi siano sufficienti motivi per avviare un’indagine ne informa immediatamente l’istituzione o l’organismo interessato perché gli faccia pervenire un suo parere.30 Pertanto si garantisce alla parte interessata il diritto di difendersi adducendo le proprie motivazioni. Inoltre, il diritto
di difesa può trovare attuazione nel momento in cui il Mediatore dovesse richiedere la testimonianza di un funzionario o agente dell’istituzione interessata.31
Le dichiarazioni, infatti, sono rese a nome dell’amministrazione che rappresenta e in base alle istruzioni date da questa.
Successivamente il Mediatore invia il parere dell’istituzione interessata al
denunciante. Entro un mese poi il denunciante deve far pervenire le sue osservazioni.32 Dopo aver esaminato il parere e le osservazioni, se il Mediatore ritiene che non si è in presenza di un caso di cattiva amministrazione, archivia il
caso e il denunciante non può nulla, nel senso che non può né fare ricorso né
tanto meno impugnare la decisione.
Se invece l’Ombudsman europeo accerta la sussistenza di un caso di cattiva amministrazione, formulerà una osservazione critica o un raccomandazione a seconda del caso. Ma se l’istituzione interessata non intende rimuovere
la situazione di cattiva amministrazione a cui ha dato vita, il denunciante non
avrà alcuno strumento di tutela per far valere la sua posizione, dovrà piuttosto
fare ricorso ad altri mezzi.
Nel corso del procedimento istruttorio, pertanto, è sempre garantito il contraddittorio, il Mediatore infatti decide dopo aver ascoltato entrambe le parti.
Questo vuol dire che il Mediatore garantisce all’istituzione investita della
denuncia il diritto di difendersi. L’istituzione però non ha a sua disposizione gli
strumenti probatori tipici di un processo.
NORME e SEGNI
richiesta di risarcimento dei danni che sarebbero derivati dal fatto che egli non
aveva informato un denunciante della possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso una decisione della Commissione.28
Infine, nel corso delle indagini svolte su iniziativa autonoma del Mediatore,
questo può esercitare gli stessi poteri che gli sono riconosciuti quando le indagini si avviano in seguito ad una denuncia. Il procedimento, inoltre, si può concludere nello stesso modo. 29
149
È sulla base degli elementi riportati nella denuncia e nell’atto di difesa dell’istituzione che il Mediatore decide. La sua comunque non è una decisione discrezionale dal momento che l’accertamento del caso di cattiva amministrazione
avviene sulla base di elementi oggettivi e non di una sua mera valutazione.
3.5 Conciliazioni amichevoli
150
La conciliazione amichevole o tentativo di conciliazione è disciplinato dall’articolo 6 delle disposizioni d’esecuzione e dall’articolo 2 dello statuto del
Mediatore, in cui si dice che uno dei presupposti per la validità della denuncia
è che questa sia preceduta da passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi comunitari interessati.
Questo vuol dire che ancora prima di presentare una denuncia la persona
che reputa leso un suo diritto dovrà tentare di trovare un accordo o una soluzione con l’istituzione o l’organismo che lo ha danneggiato.
Ai sensi dell’articolo 4 delle Disposizioni d’esecuzione, anche quando il
Mediatore europeo decide di aprire le indagini trasmette la denuncia all’istituzione interessata perché esprima un parere, che a sua volta è comunicato al
denunciante perché formuli un’osservazione. Lo scopo di queste comunicazioni è proprio quello di trovare una soluzione amichevole, nel senso che o l’istituzione riconosce di non aver agito correttamente e rimuove o annulla ciò che
ha provocato la cattiva amministrazione oppure il denunciante decide di desistere.
Infine vi è l’articolo 6 sempre delle disposizioni d’esecuzione che disciplina
il tentativo di conciliazione esperibile quando il Mediatore ritiene che sussista
un caso di cattiva amministrazione. In questa ipotesi però il tentativo è finalizzato ad eliminare la cattiva amministrazione ed a soddisfare il denunciante. La
conciliazione riesce non se le parti, cioè il denunciante e l’istituzione, trovano
un accordo ma se il Mediatore le aiuta a trovarlo. È pertanto l’Ombudsman
europeo che coopera con l’organismo o istituzione al fine di risolvere il caso di
cattiva amministrazione. In questa ipotesi chiude il caso con una decisione
motivata e ne informa il denunciante.
Nell’ipotesi in cui ritenga che la conciliazione non sia possibile o che il tentativo fallisce, il Mediatore termina il procedimento con una decisione motivata
contenente una valutazione critica oppure elabora un relazione accompagnata da un progetto di raccomandazione. 33
Dunque. la conciliazione amichevole a cui si fa riferimento all’articolo 6 nelle
Disposizioni d’esecuzione va distinto dall’arbitrato perché il Mediatore non
funge da arbitro tra le parti, ma è esso stesso una delle parti.
Mediazione e arbitrato hanno scopi diversi e non fungibili tra loro, il mediatore non decide la controversia ma concilia le diverse posizioni cercando di
favorire il raggiungimento di un risultato. La mediazione, infatti, è un processo
volontario durante il quale le parti di un conflitto si incontrano alla presenza di
un terzo indipendente avente funzioni di moderatore. Questi ha il compito di
condurre la procedura in modo da sviluppare fra i partecipanti una collabora-
NORME e SEGNI
zione che consenta a loro stessi di trovare una soluzione al problema. L’arbitro, al contrario, giudica i comportamenti a lui sottoposti in relazione alla conformità o meno di una norma, determinando gli effetti dannosi e le conseguenze che ne derivano.
Pertanto, il procedimento che si svolge dinanzi al Mediatore europeo ha
tutte le caratteristiche della mediazione, mentre non ha nulla in comune con
l’arbitrato.
Si può osservare, inoltre, come il Mediatore tenti più volte nel corso del procedimento la conciliazione, anche prima di avviare le indagini.
La conciliazione amichevole, dunque, può essere uno strumento idoneo a
realizzare l’obiettivo di risolvere i casi di cattiva amministrazione.
3.6 Conclusione delle indagini e assenza di poteri sanzionatori
La procedura d’indagine si avvia con una denuncia oppure a seguito dell’iniziativa del Mediatore. Prima di avviare le indagini, questo deve accertarsi
che la denuncia rientri nel suo mandato e se vi rientra deve assicurarsi che sia
ricevibile. Se la denuncia risulta ricevibile, viene aperta l’indagine al fine di stabilire se sussista o meno il caso di cattiva amministrazione. Prima di procedere il Mediatore cerca di conciliare le parti, se il tentativo non riesce si avviano
le indagini. I poteri istruttori risultano alquanto estesi soprattutto a seguito dell’entrata in vigore nel 2003 delle nuove disposizioni d’esecuzione. Per quanto
riguarda la durata del procedimento non è previsto alcun termine preciso. Il
Mediatore nella relazione annuale del 1997 ha dichiarato che: “l’obiettivo
dovrebbe essere quello di svolgere le indagini necessarie a seguito di una
denuncia e di informare il cittadino dell’esito entro un anno, salvo situazioni
speciali che richiedono indagini più lunghe”. Questo è però un termine indicativo e non perentorio, non può comunque protrarsi oltre un certo termine altrimenti risulterebbe violato il principio di buona amministrazione.
Per quanto riguarda la conclusione delle indagini, in base ai risultati statistici il Mediatore europeo ha trattato 1101 denunce dal 01.01.2000 al 31.12.2003,
917 indagini sono state concluse entro il 31.12.2003. 34 Le indagini si sono concluse per i seguenti motivi: 270 casi sono stati risolti dall’istituzione dopo l’avvio delle indagini, in 18 casi il denunciante ha ritirato la denuncia, 441 denunce sono risultate infondate, 13 casi sono stati conclusi con un accordo, 121
indagini si sono concluse con un’osservazione critica all’istituzione interessata, 46 indagini si sono concluse con l’invio di progetti di raccomandazione.
In base a tali dati è possibile dedurre che nella maggior parte dei casi le
denunce sono infondate, molte altre sono risolvibili positivamente e alcune si
sono concluse con delle osservazioni critiche. Soltanto in pochi casi la conciliazione amichevole ha avuto un esito positivo.
Osservando i dati statistici è possibile notare l’elevato numero di denunce
irricevibili, come anche di denunce infondate. Tali elementi sono probabilmente sintomatici della poca informazione, nonostante la campagna di sensibilizzazione attuata dal Mediatore europeo.
151
152
Se l’Ombudsman europeo dispone di poteri istruttori piuttosto marcati, al
contrario non ha alcun potere decisorio, questo porta a interrogarsi sul suo
potere, che rischia di essere vuoto. Infatti, nell’ipotesi in cui il Mediatore riscontra un caso di cattiva amministrazione e l’istituzione non si adopera al fine di
risolvere la questione, potrà soltanto formulare una raccomandazione corredata da una relazione speciale. Se nonostante tale atto l’istituzione persiste nella
sua condotta, il Mediatore invierà una relazione speciale al Parlamento. L’Ombudsman europeo, pertanto, non ha alcuno strumento sanzionatorio o coercitivo per far valere la sua decisione.
Il Mediatore, infatti, potrà riscontrare un caso di cattiva amministrazione ma
non essere in grado di risolverlo, infatti, può non assicurare al denunciante
alcuna tutela o alcun soddisfacimento. La tutela non è certa o perché il soddisfacimento dell’interesse è divenuto impossibile o perché è impossibile eliminare la situazione. Il denunciante, pertanto, può non vedere tutelato o soddisfatto il suo diritto.
Secondo Cadeddu, il Mediatore europeo è un organismo privo di poteri
decisori e di discrezionalità in senso tecnico, in quanto svolge indagini che possono portare solo a stabilire se sussiste o meno un caso di cattiva amministrazione.35 Pertanto se i poteri decisori non hanno carattere discrezionale, allora
sono volti alla manifestazione di opinioni e non di volontà.
Il pensiero di Cadeddu è condivisibile, anche se occorre tenere conto del
fatto che il Mediatore europeo rimane uno strumento di tutela in tutte quelle
situazioni in cui l’amministrazione ha posto in essere dei comportamenti contro i quali il cittadino rinuncia a protestare e a chiedere giustizia, poiché la loro
entità non giustifica il ricorso ad una procedura giudiziaria. Anche se è comunque in grado d’incidere sui rapporti tra individuo e poteri pubblici.
L’impugnabilità delle decisioni
Il Mediatore europeo in quanto autorità indipendente ha sempre negato
l’esperibilità da parte dei cittadini di una qualsiasi azione nei suoi confronti.36
Temeva, infatti, che attraverso un controllo di natura giurisdizionale, il giudice
comunitario potesse mettere in discussione le sue decisioni finendo così con il
sindacare il suo operato. L’indipendenza sarebbe compromessa e l’articolo
195 del Trattato violato.
Riteneva, inoltre, che, dal momento che le sue decisioni non hanno effetti
giuridici diretti per i cittadini e non risultano giuridicamente vincolanti per l’istituzione interessata, non possano mai essere fonte di danno. Inoltre, in nessuna disposizione del Trattato CE o di diritto derivato è prevista una possibilità di
ricorso avverso le sue decisioni.
L’assenza, però, di una qualsiasi forma di tutela nei confronti del cittadino
andrebbe considerata come denegata giustizia. Il principio dell’effettività della
tutela giurisdizionale risulterebbe violato.37 Senza tenere conto che il conferimento di poteri ad un organo presuppone che detto organo assuma la responsabilità in caso di illeciti nell’esercizio di siffatti poteri o in caso di mancato
4. Il diritto d’accesso e la trasparenza nell’attività del mediatore
La trasparenza è una componente essenziale della democrazia. Il cittadino
ha il diritto di sapere come e perché le decisioni sono prese. Nel momento in
cui si hanno tali informazioni si è in grado di valutare il lavoro dei rappresentanti politici e di assicurarsi che il potere pubblico è responsabile. Una buona
informazione garantisce infatti una partecipazione effettiva.
Come affermato dallo stesso Mediatore, l’Unione europea è legata alla
NORME e SEGNI
adempimento dei suoi compiti. È proprio la mancanza di un rimedio amministrativo che rende necessaria un’alternativa nei confronti dell’individuo leso
che altrimenti resterebbe privo di tutela.
L’azione di annullamento e quella per carenza non possono essere esperite dal momento che riguardano l’illegittimità di un atto giuridicamente vincolante o la sua mancata adozione. L’azione risarcitoria, invece, risulterebbe l’unica
possibile. La stessa Corte di giustizia ha statuito la fondatezza del ricorso per
risarcimento dei danni nei confronti del Mediatore europeo, anche se autorità
indipendente.38
Già nel luglio 2003, la Corte si era pronunciata sull’indipendenza della BCE
e della BEI.39 In queste due pronunce aveva statuito che l’indipendenza di
un’istituzione non ha la conseguenza di distaccarla completamente dalla
Comunità europea e di sottrarla a qualsiasi norma di diritto comunitario. Ogni
istituzione, infatti, è destinata a contribuire alla realizzazione degli obiettivi
della Comunità ed è soggetta alle condizioni previste dai Trattati.
Il controllo del giudice comunitario sulle autorità indipendenti e quindi sul
Mediatore europeo è, però, limitato per via delle caratteristiche peculiari di tali
organi. Di conseguenza la responsabilità extracontrattuale dell’ombudsman
europeo può sorgere solo in caso di violazione grave e manifesta degli obblighi che gli incombono.
Secondo una giurisprudenza costante, valida anche nei confronti del
Mediatore la responsabilità extracontrattuale della Comunità e il diritto al
risarcimento del danno si configurano solo se sussistono determinati presupposti.40 Vi deve essere una violazione grave di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, devono sussistere un danno reale e un nesso
causale diretto tra siffatta violazione e il danno subito dai soggetti lesi. Il
danno, poi, può derivare tanto da un atto giuridicamente vincolante o meno,
quanto da un comportamento imputabile ad un’istituzione o ad un organo
comunitario.
Pertanto l’azione per risarcimento danni è l’unica esperibile dal cittadino
avverso le decisioni del Mediatore ed è anche l’unica che assicura l’effettività
della tutela giurisdizionale. L’avvocato generale Geelhoed ha giustamente
osservato che lasciare il cittadino sprovvisto di tutela in caso di cattiva amministrazione è incompatibile con l’essenza stessa del Mediatore.41 Questo vale
a maggior ragione quando il danno deriva da un’azione o un’omissione dello
stesso ombudsman europeo.
153
154
democrazia e riconosce la cittadinanza.42 Le istituzioni europee sono pertanto
tenute a difendere e promuovere il principio della trasparenza.
Nell’articolo 1 del Trattato sull’Unione europea si dice: “il presente Trattato
segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’Unione sempre più
stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”.
Questo dovere non è sempre stato pienamente adempiuto. Molte delle
denunce trattate dal Mediatore riguardano proprio la mancanza di trasparenza
da parte delle istituzioni comunitarie. In questi casi l’Ombudsman europeo
deve stabilire se il rifiuto di accesso costituisca o meno un caso di cattiva
amministrazione. Si tratta di accertare se l’istituzione interessata abbia applicato in modo corretto le proprie norme sull’accesso del pubblico o se abbia
agito al di fuori dei limiti della propria autorità giuridica.43
Il Mediatore europeo in una lettera ha esposto le sue preoccupazioni per
l’uso improprio delle norme sulla protezione dei dati non conforme al loro
scopo di aiutare a garantire il rispetto del diritto individuale alla vita privata. Al
contrario queste norme si stanno utilizzando per limitare la trasparenza nelle
attività pubbliche.44 In particolare nella lettera risaltano due casi in cui le norme
sulla protezione dei dati sono state invocate per limitare la trasparenza. Il primo
ha riguardato il Parlamento europeo che ha messo in discussione la pubblicazione del registro contenete i nomi degli assistenti degli euro-deputati che vengono pagati con fondi comunitari. La materia è ora all’esame della commissione responsabile del Parlamento europeo.
Un altro caso ha interessato la raccomandazione che il Mediatore ha fatto
al Parlamento perché nei futuri concorsi d’assunzione i candidati siano informati che i nomi dei vincitori saranno resi pubblici. Il Parlamento non ha accolto la proposta argomentando che i vincitori godono del diritto all’anonimato. Tali
esempi mostrano l’uso improprio delle norme sulla protezione dei dati, quasi
come esistesse un diritto a partecipare anonimamente ad attività pubbliche. La
tutela dei dati personali è finalizzata a proteggere la vita privata e le informazioni personali. Pertanto non si deve fare riferimento a tale tutela quando gli
individui agiscono nell’espletamento di funzioni pubbliche o quando partecipano alla definizione di decisioni pubbliche di propria iniziativa. Fornire informazioni fa parte dei compiti dell’amministrazione in particolare di una buona
amministrazione.45 Inoltre, la trasparenza è una delle migliori difese contro la
corruzione, pertanto non può essere circoscritta alle procedure legislative, ma
deve investire l’intero processo politico europeo.
A partire dagli anni novanta, il diritto d’accesso è stato considerato anche
come un diritto procedurale autonomo. L’accesso ai documenti costituisce una
delle garanzie procedurali finalizzate alla tutela dei diritti alla difesa, ma soprattutto come effettivo esercizio del diritto ad essere ascoltato, previsto dai regolamenti n.17 e n.99 del 1963.
Il Mediatore si è sempre impegnato perché le istituzioni europee assicurassero l’accesso ai dati, indipendentemente dalla sua qualificazione teorica. Ha
sempre cercato di evitare di esprimersi sulla natura del diritto d’accesso, limitandosi ad assicurare il rispetto delle norme da parte delle istituzioni. Ha con-
NORME e SEGNI
tribuito, praticamente e a seguito delle denunce, a dissuadere gli organi comunitari dall’agire in modo ostruzionistico.
Nel 1993 la Commissione e il Consiglio hanno adottato un Codice comune
di condotta sull’accesso ai loro documenti. Il Codice riconosce che “il pubblico
avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio”. Tale documento ha un’elevata rilevanza giuridica poiché
sancisce i principi generali che regolano l’accesso, ma prevede anche alcune
eccezioni.
Nel 1996 a seguito di un’indagine effettuata su iniziativa del Mediatore, altre
istituzioni e organi comunitari hanno adottato norme sull’accesso del pubblico.46 Oggi la quasi totalità delle istituzioni ha adottato e pubblicato delle regole in tale materia. Nel maggio 2001 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato
delle nuove regole in materia d’accesso pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.
Il Mediatore europeo ha sempre sostenuto che se le istituzioni si fossero
conformate al principio di trasparenza nell’applicazione delle regole, i cittadini
sarebbero stati in grado di comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni. La trasparenza è riconosciuta come “uno strumento cruciale per portare la
Comunità più vicina ai suoi cittadini e per aumentare la loro fiducia nel suo funzionamento, essendo tale fiducia un elemento chiave in ogni democrazia”.47
Per quanto riguarda l’attività che il Mediatore espleta, nell’articolo 13 delle
disposizioni d’esecuzione esso riconosce al denunciante il diritto di prendere
visione del fascicolo concernente la sua denuncia. Non solo, infatti, ha il diritto di prendere visione dei documenti ma anche quello di estrarne copia. L’accesso è negato soltanto rispetto ai documenti o alle informazioni confidenziali
ottenuti a seguito dell’esame o dell’escussione.
Nell’articolo 14 sempre delle disposizioni d’esecuzione è disciplinato l’accesso pubblico ai documenti custoditi dal Mediatore. È garantito l’accesso ai
documenti non pubblicati ma in possesso del Mediatore, applicando il regolamento CE n°1049/2001. L’accesso pubblico è negato rispetto a documenti
confidenziali o alle informazioni riservate. È garantito tanto il diritto di accesso
quanto quello di estrarne copia. L’accesso è consentito rapidamente quando si
tratta del registro generale delle denunce, delle denunce e dei documenti allegati dal cittadino, dei pareri circostanziati delle istituzioni interessate ed eventuali osservazioni formulate dal cittadino, delle decisioni del Mediatore di chiudere il caso e infine delle relazioni e dei progetti di raccomandazioni.
Così come è garantito il diritto d’accesso pubblico ai documenti del Mediatore così anche a quest’ultimo deve essere riconosciuto il diritto di accedere ai
documenti delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri al fine di espletare
le sue indagini. L’accesso può essere negato per ragioni di segreto professionale, purché debitamente motivate.
Il diritto d’accesso è d’altra parte compensato da un dovere di riservatezza.
Nell’articolo 4 dello statuto del Mediatore si dice chiaramente che, quando questi e il suo personale ispezionano i documenti, sono vincolati dallo stesso obbligo di riservatezza dell’amministrazione. Pertanto, l’ispezione non si traduce
nella divulgazione dei documenti.
155
Si può quindi dire che è importante garantire l’accesso ai documenti e la trasparenza nella propria attività, perché questo aiuta i cittadini a comprendere il
lavoro delle istituzioni, li avvicina sempre di più ad esse e garantisce pertanto
il diritto ad una buona amministrazione. Per tali ragioni il Mediatore si è sempre impegnato in una campagna di sensibilizzazione delle istituzioni perché
attuino e assicurino la trasparenza e l’accesso ai dati e documenti. Purtroppo
molte delle denunce ancora oggi presentate al Mediatore riguardano proprio la
mancanza di trasparenza nell’attività delle istituzioni comunitarie.
5. La relazione annuale al Parlamento europeo
156
Ai sensi dell’articolo 195 del Trattato della Comunità europea: “il Mediatore
presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini”.
Nell’articolo 11 delle disposizioni d’esecuzione si dice: “Il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulla sua attività in generale,
che include i risultati delle sue indagini… La relazione annuale può includere
le raccomandazioni che egli ritiene opportune ai fini dell’assolvimento dei propri compiti conformemente ai Trattati e allo statuto”.
Il Mediatore europeo annualmente effettua una relazione sull’attività svolta
e su quelli che sono stati i risultati delle sue indagini.
La relazione annuale va distinta sicuramente dalla relazione speciale che
invece viene elaborata in casi del tutto eccezionali, quando cioè, nonostante la
raccomandazione del Mediatore, l’istituzione ha continuato a perseverare nella
sua condotta scorretta.
Fino ad oggi il Mediatore ha elaborato soltanto nove relazioni annuali, dal
1995 al 2003. Confrontando i diversi testi è impossibile non cogliere delle differenze. Originariamente la relazione risultava breve e sintetica. Nella prima il
Mediatore ha spiegato le origini dell’istituto e le funzioni, in quelle successive
ha invece cominciato a classificare le denunce il cui numero risultava esiguo.
Con il passare del tempo la relazione è sicuramente divenuta un atto importante nell’attività svolta dal Mediatore.
Oggi la relazione annuale non soltanto è un documento esauriente e completo, ma risponde ad uno schema ben preciso.
La relazione è un atto che non si può non reputare importante perché costituisce un precedente di cui non solo il Mediatore ma anche le altre istituzioni
non possono non tenere conto. Nella relazione infatti il Mediatore riporta i vari
casi affrontati nell’anno e come sono stati risolti. Effettua una classificazione,
distinguendo i casi risolti con una conciliazione amichevole, i casi in cui la
denuncia non rientrava nel mandato o era irricevibile, i casi in cui non aveva
riscontrato cattiva amministrazione e i casi in cui l’aveva riscontrata ed era
stato necessario emettere un’osservazione critica o piuttosto una raccomandazione. Le ipotesi in cui una raccomandazione è seguita da una relazione speciale sono veramente rare. In casi del tutto eccezionali la relazione può contenere anche una raccomandazione.
La relazione costituisce un precedente e un esempio che può aiutare a
NORME e SEGNI
capire cosa s’intenda effettivamente per cattiva amministrazione. La cosa più
importante è che tale relazione viene pubblicata. È, infatti, proprio attraverso
la pubblicazione che chiunque può prenderne visione e osservare come il
Mediatore ha agito e che cosa intendeva effettivamente per cattiva amministrazione. È uno strumento molto utile per la comprensione e la diffusione del
concetto di buona e cattiva amministrazione. Tale relazione è in grado di raggiungere non solo le istituzioni comunitarie, ma anche le autorità nazionali e i
cittadini. Senza dimenticare che questo documento viene tradotto in tutte le
lingue dell’Unione.
La relazione annuale è uno strumento d’informazione e prevenzione veramente importante e utile perché in tal modo si potrebbe ridurre il numero delle
denunce irricevibili, alleggerendo in parte il carico di lavoro del Mediatore.
6. La cooperazione con le istituzioni comunitarie
Il rapporto esistente tra il Mediatore europeo e le istituzioni comunitarie è di
cooperazione ed ha una duplice valenza. Da una parte, infatti, l’Ombudsman
europeo agisce nei confronti degli organi comunitari che hanno posto in essere il caso di cattiva amministrazione. Dall’altra, invece, collabora con essi al
fine di garantire il diritto ad una buona amministrazione.
Tale rapporto è pertanto fondamentale sia per l’attività di risoluzione delle
controversie che per quella di prevenzione.
Nell’articolo 2 dello statuto del Mediatore si dice che: “Alle condizioni e nei
limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il Mediatore contribuisce a individuare
i casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni e degli organi
comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado
nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazione
per porvi rimedio”.
La funzione dell’Ombudsman europeo è dunque di risolvere il caso di cattiva amministrazione posto in essere da un’istituzione o un organo comunitario.
L’ambito “di istituzioni e organi comunitari” ha subito un estensione notevole, giungendo a comprendere, oltre quelle elencate nell’articolo 7 del Trattato
comunitario, anche la Banca centrale europea, le agenzie e altri organismi. Il
merito del Mediatore, come già visto, è stato quello di aver elaborato dei veri e
propri indici di riconoscibilità.48
La funzione del Mediatore farebbe pensare subito ad un rapporto di sovraordinazione. L’Ombudsman europeo, infatti, interviene a seguito di una denuncia oppure di sua iniziativa, effettuando tutte le indagini che ritiene necessarie.49 La sua posizione sembrerebbe quasi identica a quella di un giudice, ma
il Mediatore europeo non espleta una funzione giurisdizionale, ma conciliativa.
Anche nel caso in cui le indagini si dovessero concludere con l’accertamento
di un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore avrebbe soltanto un potere
di raccomandazione o di relazione, ma mai di decisione.50
Il rapporto con le istituzioni è stato chiarito dallo stesso Ombudsman europeo nella relazione annuale del 1995. Nella prima parte relativa alle origini del-
157
158
l’organo, nel paragrafo I.2.1 intitolato “la missione del Mediatore”, si dice che
“il Mediatore deve ugualmente contribuire a proteggere la situazione dei cittadini incoraggiando le buone pratiche amministrative. Questo presuppone di
cooperare con le autorità amministrative per cercare le soluzioni che gli consentiranno di migliorare le relazioni con i cittadini”.
Da questo è possibile dedurre che la cooperazione con le atre istituzioni
consente al Mediatore di garantire una buona amministrazione. Tale rapporto
pertanto è fondamentale ai fini dell’espletamento della sua attività.51
Il fatto che vi sia questo tipo di rapporto emerge anche dal contenuto delle
norme dello statuto e delle disposizioni d’esecuzione.
Nell’articolo 3 dello statuto si dice che nel momento in cui l’Ombudsman
europeo espleta le sue indagini, ne informa l’istituzione o l’organo interessato,
che a sua volta potrà fargli pervenire qualsiasi informazione utile. Inoltre al 2°
comma si dice: “le istituzioni e gli organi comunitari hanno l’obbligo di fornire al
Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarsi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati ”, da questo si deduce come le altre istituzioni siano tenute a collaborare con il Mediatore.
Ai sensi dell’articolo 3 dello statuto si dice ancora che l’Ombudsman europeo nel tentativo di risolvere il caso di cattiva amministrazione non agisce in
modo autoritario, ma ricerca con l’istituzione interessata la soluzione migliore.
La ricerca di una risoluzione, attraverso la cooperazione con le altre istituzioni,
avviene per quanto possibile, nel senso che le istituzioni non sempre riconoscono la loro responsabilità e non sempre accettano di buon grado l’intervento del Mediatore.
La cooperazione pertanto dipende dal buon senso delle istituzioni, non esiste una norma che lo sancisca come obbligo o come dovere. Nel caso in cui
le istituzioni rifiutassero la collaborazione con il Mediatore europeo, questo non
potrebbe nulla.
Il rapporto cooperativo con le istituzioni comunitarie non solo può facilitare
la risoluzione dei casi sottoposti all’attenzione del Mediatore, ma può persino
agevolare l’applicazione uniforme del diritto ad una buona amministrazione.
Particolarmente significativo è il rapporto con la commissione per le petizioni del Parlamento europeo. La cooperazione tra questi due organi è molto
importante. Ai sensi dell’articolo 21 del Trattato della Comunità europea, i cittadini dell’Unione hanno diritto di petizione davanti al Parlamento europeo e il
diritto di rivolgersi al Mediatore europeo.
Nella relazione annuale del 1996, nel paragrafo 4 intitolato “Relazione con
il Parlamento europeo e la Commissione per le petizioni” il Mediatore precisa
che fin dalla creazione dell’ufficio si è instaurata una stretta cooperazione e
che i due segretariati intrattengono contatti regolari. Tra essi esiste un accordo in merito al deferimento reciproco di denunce e petizioni in casi specifici e
con il consenso del denunciante o dell’autore della petizione. Le denunce che
esulano dal mandato del Mediatore ma che potrebbero essere trattate come
petizioni dal Parlamento europeo vengono trasferite direttamente per essere
trattate come petizioni, purché ne sia dato il consenso, e viceversa.52
1 E. Vinci, “Unione europea,cittadino, ombudsman, brevi riflessioni su un nuovo istituto civico
europeo”, in Rivista Internazionale dei diritti dell’uomo n.3, settembre 1992, p.887, G. Tesauro, “Il
mediatore europeo”, in Rivista Internazionale dei diritti dell’uomo n.3, settembre 1992, p.894.
2 Cfr., A. Pace,”A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea? Appunti preliminari”, in Giurisprudenza Costituzionale-2001, p.194.
3 Art. 3 della Decisione 94/262.
4 Art. 2, 2º comma della Decisione 94/262.
5 Art. 2, 8° comma della Decisione 94/262.
6 Art. 2, 2° comma della Decisione 94/262.
7 M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè,1999, p.312.
8 Art. 2, 3° comma della Decisione 94/262.
9 Art. 2, 3° comma della Decisione 94/262.
10 Art. 2 della Decisione 94/262.
11 Art.10 della Decisione 94/262.
12 Art. 2 della Decisione 94/262.
13 Art. 13 della Decisione 94/262.
14 Art. 3, 2° comma della Decisione 94/262.
15 Art. 3, 1° comma della Decisione 94/262.
16 Art. 4, 3° comma della Decisione 94/262.
17 Art. 2 della Decisione 94/262.
18 Relazione annuale 2001, Prefazione.
19 www.euro-ombudsman.eu.int, STATISTICHE.
20 Art.4, 3° comma della Decisione 94/262.
21 Relazione annuale 1998, 2.8 “Decisione a seguito di una indagine del Mediatore”.
22 Articolo 3, 4° comma della Decisione 94/262.
23 Articolo 3, 2° comma della Decisione 94/262.
24 Relazione annuale 1998, 2 “Denunce”.
25 Art. 4, 5° comma della Decisione 94/262.
26 Art. 8 della Decisione 94/262.
27 S. Cadeddu, op. cit., p.10.
28 Causa T-209/00, Racc. II-2203.
29 Art. 9 della Decisione 94/262.
30 Art. 4, 3° comma della Decisione 94/262.
31 Art. 3, 2° comma della Decisione 94/262.
32 Art. 4, 4° comma della Decisione 94/262.
33 Art. 6 della Decisione 94/262.
34 www.euro-ombudsman.eu.int, STATISTICHE.
35 Cfr., S. Cadeddu, “Le denunce al mediatore europeo”, Relazione al Convegno di Roma sul
tema:”La disciplina europea del procedimento amministrativo”, 8 aprile 2003, p.12.
36 Cfr., E. Chiti e C. Franchini, “L’integrazione amministrativa europea”, Bologna, Il Mulino,
2003, p.78; C. Franchini, “I principi dell’organizzazione amministrativa comunitaria”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico n.3, 2002.
37 Cfr., E. Chiti, “Il ricorso per annullamento e l’effettività della tutela giurisdizionale”, in Giornale di diritto amministrativo n.11, 2002; C. Franchini, “Nuovi modelli di azione comunitaria e tutela
giurisdizionale”, in Diritto amministrativo, 2000, p.81-9.
NORME e SEGNI
È il cittadino a scegliere se rivolgersi al Mediatore o alla Commissione, ma
a volte risulta difficile determinare la via più conveniente, per questo è utile tale
procedura cooperativa.
Il rapporto che dunque esiste tra le due istituzioni comunitarie consente ad
entrambe le istituzioni di esercitare in modo efficace e proficuo la loro attività.
159
Sentenza del 23 marzo 2004, causa C- 234/02, Racc. pag. I-0000.
Sentenza del 10 luglio 2003, causa C-11/00, Racc. pag. I-7147; sentenza del 10 luglio 2003,
causa C-15/00, Racc., pag. I-7281.
40 Sentenza del 28 aprile 1971, causa 4/69, Racc. pag. 325 e ordinanza 21 giugno 1993, causa
C-257/93, Racc. pag. I-335.
41 Punto 110 delle Conclusioni dell’Avvocato generale Geelhoed del 3 luglio 2003, causa C234/02.
42 Mediatore europeo, Guida per i cittadini, p.15, sul sito www.euro-ombudsman.eu.int
43 Söderman, “Le citoyen, l’administration et le droit communautaire”, in Revue du marché inique européeen, 1998, p.16-97; C. Morviducci, “Diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni e
Trattato di Amsterdam”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2000, pp.665-718.
44Mediatore europeo, Lettere e note: “Uso improprio delle norme sulla protezione dei dati nell’Unione europea”, 25/09/2002, sul sito www.euro-ombudsman.eu.int
45 Cfr., A. Zito, “Il diritto ad una buona amministrazione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordinamento interno”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n.23, 2002, pp.425-444; si veda anche l’interessante studio del Consiglio d’Europa, che ha individuato i principi della giurisprudenza e delle legislazioni nazionali, Council of Europe, “The administration and you”, Strasburgo, Council of Europe Publishing, 1996.
46 Relazione annuale 1998, 2.10 “Alcune questioni riguardanti l’accesso ai documenti”.
47 Cfr., D. Curtin e H. Meiers, “The principle of Open Government in Schengen and the European Union: Democratic Retrogression?”, in Common Market Law Review, 1994, pp.390-442; nonché degli stessi autori, “Access to European Union Information: an element of citizenship and a
Neglected Constitutional Right”, in The European Union and Human Rights, a cura di N.A. Neuwahl e A. Rosas, 1995, den Haag-London-Boston, Martinus Nihoff, pp.77-104.
48 Cfr., S. Cadeddu, op.cit., p.5.
49 Art. 3, 1º comma della Decisione 94/262 del Parlamento europeo.
50 Art. 8 della Decisione 94/262 del Parlamento europeo.
51 G. Bosco, “L’Europa dei cittadini”, in Bulletin européeen n.616, settembre 2001.
52 Art. 2 della Decisione con cui il Mediatore europeo adotta le disposizioni d’esecuzione.
38
39
160
Questa traduzione esce nella Collana “Testi a fronte” diretta da Giovanni
Reale, e il testo latino riprodotto è quello dell’edizione di L.M. De Rijk: Peter of
Spain, Tractatus, Assen, Van Gorcum, 1972.
Pietro di Giuliano, detto Pietro Ispano (Petrus Hispanus Portugalensis),
nasce a Lisbona intorno al 1205. Studia a Parigi, Siena e Montpellier. Tra il
1260 e il 1261 svolge il ruolo di consigliere scientifico alla Curia di Papa Gregorio X. Il 5 giugno 1273 è nominato cardinale arcivescovo di Tuscolo (Frascati) e il 15 settembre 1276 viene eletto Papa col nome di Giovanni XXI. Muore
il 20 maggio 1277. Scrive il Trattato intorno al 1230, durante un soggiorno nel
nord della Spagna, forse a Leon, sul modello dei compendi conosciuti a Parigi. Si tratta di un testo di logica nel senso in cui la intendevano gli antichi, che
è molto più ampio di quello odierno. Logica come facoltà di ragionamento, abilità posseduta dalla specie Homo, l’unica dotata di quella capacità sintattica o
di modellazione primaria che Thomas A. Sebeok chiama linguaggio e che è la
condizione delle teorie, dei mondi possibili, dei progetti, della società. “Logica,
nel suo senso generale –dice Peirce (v. Opere, Milano, Bompiani, 2003, p.
147; 2.227)–, è […] solo un altro nome per semiotica”. In questo senso il Trattato è un libro di semiotica.
Si pone in tal modo la questione del rapporto tra la semiotica e la sua storia, ossia il rapporto con la sua fase pre-paradigmatica fatta di idee, intuizioni,
riflessioni, di quelli che chiamiamo sintomi del suo odierno paradigma scientifico, e che solo nell’epoca contemporanea sono stati interpretati come portatori di nuove pertinenze teoriche
Gli studi di approfondimento storico in semiotica sono relativamente recenti, e se ne può far risalire l’inizio a un dibattito dedicato a questo tema durante
il 2° Congresso dell’Associazione internazionale di Studi Semiotici nel 1979 a
Vienna.
Studiare la storia di una scienza e studiare e praticare quella scienza non
sono momenti che si elidono reciprocamente. La ricostruzione storica di una
scienza è animata da un intento teorico e non (o non soltanto) da un proposito filologico. La ricognizione storica è connessa alla ricognizione teorica. Si
tratta di un processo dialogico per cui se da un lato l’indagine storica può cambiare l’assetto teorico in atto, dall’altro lato quest’ultimo influenza il senso della
ricerca storica.
La prospettiva storiografica di Sebeok, per fare un esempio, che cerca i
“criptosemiotici” (ricercatori che fanno semiotica senza saperlo) e che sul
piano teorico collega la semiotica alla semeiotica medica dell’antica Grecia,
oltre che un ampliamento della materialità storica pone una questione di senso
della disciplina e una ristrutturazione teorica.
La semiotica assume una diversa configurazione a seconda che la si faccia iniziare con Ippocrate anziché, poniamo, con Locke o con Saussure. Se si
collega la scienza dei segni con la medicina o con la biologia, se ne cambia,
perché si amplia, l’oggetto di indagine e i suoi modelli, per primo il modello del
R ECENSIONI
PIETRO ISPANO, Trattato di logica. “Summule logicales”, introduzione, traduzione, note e apparati di Augusto Ponzio, Milano, Bompiani, 2004, pp. XLIV + 674.
161
162
segno. Si allarga il campo della ricerca storica includendovi autori le cui riflessioni sono tutt’altro che estranee a un pensiero del segno, pur non menzionandone il concetto, o negandolo, oppure mettendolo in dubbio. Trovano così
posto, accanto alle teorie semiotiche esplicite, le teorie ostracizzate, cancellate, represse o semplicemente implicite.
Ma torniamo a Pietro Ispano per sottolineare che quella delle Summule è
una semiotica del linguaggio verbale.
Il primo trattato, Concetti introduttivi, è dedicato alla definizione di concetti
come quello di dialettica, di suono, voce, verbo, frase, proposizione, proposizione categorica, ipotetica e modale.
Il secondo trattato è l’esposizione dei predicabili (genere, specie, differenza, proprio, accidente) secondo l’Isagoge di Porfirio. Il terzo e il quarto sono
dedicati, rispettivamente, alle categorie aristoteliche e ai sillogismi, mentre il
quinto è dedicato alla teoria dei luoghi, secondo l’impostazione di Boezio.
Il sesto trattato ha per oggetto le supposizioni, il settimo le fallacie, l’ottavo
i relativi, il nono gli ampliamenti, mentre i trattati X, XI e XII hanno per oggetto,
rispettivamente, le appellazioni, le restrizioni e le distribuzioni.
I trattati dal primo al quinto e il settimo ricalcano la logica antiquorum. Il
sesto e i trattati dall’ottavo al dodicesimo sono dedicati alle proprietà dei termini, secondo la logica modernorum. In questo secondo gruppo sono presenti
elementi di novità che saranno approfonditi nel pensiero medievale successivo: nei Modisti, in Duns Scoto, Ockham, ma che non sono scomparsi ancora
oggi dalla logica, dalla filosofia del linguaggio e dalla semiotica.
Un ruolo particolare fra le proprietà dei termini è svolto dalla teoria della
supposizione (suppositio), poiché le altre proprietà (come l’appellatio, la copulatio, l’ampliatio, la restrictio) vengono assorbite nel suo ambito.
Dalla supposizione va però tenuta distinta la significazione di un termine,
ossia “la rappresentazione di una cosa tramite voce secundum placitum”
(VI.2). Il segno risulta, a questo livello, formato da un significante verbale, il cui
valore è stabilito per convenzione, e da un significato (la res significata o representata) che non è qualcosa di esterno ad esso, anzi ne è parte costitutiva. Nel
Trattato, allora, non solo è colta la differenza fra significato e referente, ma è
colto anche il carattere mediato del rapporto fra segno e referente.
Ancora Pietro Ispano dice che “La supposizione è l’assunzione di un termine sostantivo per qualcosa” (VI.3). La teoria della supposizione descrive i vari
modi in cui un termine può supporre, o stare per, stare al posto di, o fungere
da sostituto di qualcos’altro.
Nella semiotica del verbale del Trattato significare è parlare, e solo successivamente alla definizione verbale dei significati si può procedere alle varie
forme di supposizione. Si avverte l’influenza dei vari strati della riflessione logico-linguistica dell’antichità.
Appare chiara la presenza della connessione aristotelica tra logos e corpo,
che pone quest’ultimo come condizione strutturale del parlare e che consente
l’uscita dell’umano dal tacere del resto del mondo vivente. Nella prospettiva di
Aristotele il parlare non solo è un’attività biocognitiva unica e specie-specifica,
ma è soprattutto un’attività che rende specifiche tutte le attività cognitive
R ECENSIONI
umane, comprese quelle che l’uomo mostra di avere in comune con gli altri animali: percezione, memoria, desiderio, immaginazione.
In questa prospettiva si muovono le riflessioni di P. Ispano a proposito del
suono (“tutto ciò che è percepito propriamente dall’udito”) e della voce (“suono
prodotto dalla bocca di un animale e formato con strumenti naturali […]: labbra, denti, lingua, palato, gola, polmoni”). Dei suoni, poi, alcuni sono voce, altri
non-voce, ovvero suoni generati “dall’urto di corpi inanimati, come lo stormire
degli alberi, il calpestìo dei piedi” (I.2). Le voci, a loro volta, si distinguono in
significative (quelle che all’udito rappresentano qualcosa, come ‘uomo’) e nonsignificative (quelle che all’udito non rappresentano nulla, come ‘buba’). E
ancora: le voci significative si distinguono in voci significative ad placitum, verbalizzate (quelle che, a discrezione di chi le istituisce, rappresentano qualcosa, come ‘uomo’ [v. I.3], quindi i nomi, ma anche i verbi, le frasi [v. I.4-6]), e voci
significative per natura (quelle che per tutti rappresentano la stessa cosa,
come il gemito degli infermi e il latrato dei cani). Ciò vuol dire che la comunicazione acustica può essere vocale o non-vocale, a seconda della corporeità
da cui è prodotta, ossia, rispettivamente, da corpi animati e corpi inanimati, e
la comunicazione vocale non è necessariamente parola.
Già Aristotele, cui abbiamo accennato, nella sua zoo-antroposemiotica,
metteva in rilievo che la voce è una materia predisposta per sua natura a
diventare segno verbale, ponendosi a un livello diverso e più complesso rispetto al suono. Nell’umano la parola è la destinazione naturale della voce. Tale
destinazione distingue gli animali umani dagli animali non umani. Quella particolare forma somatica che costituisce l’umano è organizzata per parlare-pensare. Condizione della voce è che un corpo sia dotato di polmoni, trachea-laringe, organi in possesso anche dei delfini, per esempio. La voce umana, però, è
una voce unitaria e internamente articolata in unità vocali chiamate grammata,
il che richiede lo sviluppo dell’udito e un certo movimento della lingua e delle
labbra (cfr. F. Lo Piparo, Aristotele e il linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2003).
Nelle Summule logicales l’espressione ad placitum, a conferma –diremmo–
della loro funzione di sistemazione del sapere logico-linguistico ad uso scolastico, viene riportata (e utilizzata) con una doppia valenza. Una, risalente al
neoplatonico Ammonio e che passa attraverso Boezio, che può tradursi in italiano (ma con molta approssimazione) con ‘a piacimento’, ‘ad arbitrio’, o ‘a
discrezione’”; l’altra valenza è quella di ‘composizione’, ‘combinazione’, ‘mettere insieme’ per produrre qualcosa di nuovo, in una parola ‘sintassi’ (v. VII.53).
Questioni molto vive ancora oggi in semiotica, delle quali si discute nei termini dell’arbitrarietà debole e dell’arbitrarietà forte. Allo stesso modo, approfondendo la problematica della supposizione il Trattato prelude alla distinzione fra linguaggio oggetto e metalinguaggio nella filosofia del linguaggio contemporanea.
La semiotica di Pietro Ispano può essere collocata nel modello della semiosi, dovuto a Peirce e poi ripreso da Morris. Questo modello procede oltre la
concezione all’aliquid stat pro aliquo, ovvero oltre la diadicità del segno come
costituito da un significante e da un significato (distinto dal referente). La
semiosi è un processo triadico in cui qualcosa funziona come segno di qualcos’altro per un terzo qualcosa.
163
164
Il ‘primo qualcosa’ (aliquid), che nel Trattato è un segno verbale, è un
oggetto cui è riferita l’operazione dell’acceptio nelle sue due forme della suppositio e della copulatio, ossia della sua assunzione per qualcos’altro. Questo
‘secondo qualcosa’ è il riferimento (res significata), che non è la cosa “tout
court”. L’operazione del rinviare avviene per mezzo della significazione (significatio) avviata da un interpretante (il ‘terzo qualcosa’) e riguarda “tanto una
cosa esistente quanto una cosa non esistente. Così, ‘Anticristo’ significa Anticristo e sta per l’Anticristo, ma non appella nulla [“L’appellazione è l’assunzione di un termine comune per una cosa esistente”]; ‘uomo’, invece, significa
uomo e per sua natura sta tanto per quelli esistenti quanto per quelli non esistenti e appella soltanto gli uomini esistenti” (X.1).
Un conto, allora, è il denotatum, un altro conto è il designatum. ‘Anticristo’
è un “designatum” senza “denotatum” (non appella infatti nessuna cosa esistente), mentre ‘uomo’ è un “designatum” con “denotatum”, poiché sta tanto
per gli uomini esistenti quanto per quelli non esistenti.
Abbiamo qui adoperato termini della semiotica di Charles Morris che ben
s’attagliano alla questione posta da Pietro Ispano. Il referente non viene identificato con l’oggetto fisico, ovvero, come si è detto, la res significata non è la
‘cosa’ “tout court”, ma si definisce volta per volta all’interno della semiosi.
Si tratta di sintomi teorici colti e interpretati dagli sviluppi successivi della
ricerca semiotica e filosofica del linguaggio.
Cosimo Caputo
D. VERDUCCI, Il segmento mancante. Percorsi di filosofia del lavoro, ed. Carocci, Roma 2003.
Ogni “lettura” è sempre, in fondo, una “interpretazione”, in conformità con la
“preparazione” o la “pre-formazione” dello stesso lettore. Tale è stata la mia lettura del libro di Daniela Verducci sul lavoro; lettura nella quale ho fatto emergere appunto alcune idee particolarmente consonanti con le mie, senza tradire, tuttavia –così spero–, il senso complessivo della ricca trattazione offerta
dall’Autrice sul tema del lavoro nelle sue ragioni ultime e in particolare sul rapporto con la filosofia, anche se le mie rilevazioni non si limiteranno a registrare gli elementi, pur già così pregnanti del saggio, ma si apriranno a qualche
loro ulteriore applicazione e svolgimento, in consonanza con la “lettura” cui ho
appena accennato.
Proprio al rapporto del lavoro con la filosofia si riferisce una mia prima rilevazione. A p. 2 l’Autrice, “interprete”, già lei, del pensiero di Max Scheler (da
cui il saggio ha preso l’avvio e con il quale è rimasto in costante dialogo), scrive che la filosofia in relazione al suo ruolo di direzione dei “processi psico-fisici, umani e naturali”, deve mettere a tema anche il lavoro, correggendo la tendenza di tanta cultura contemporanea a chiudersi in un “esclusivismo teoreticistico”. Orbene, a me pare che questa reazione all’“esclusivismo teoreticistico” in rapporto al lavoro faccia parte di una reazione anche più ampia a tale
R ECENSIONI
esclusivismo, reazione che si esplica, in modo credo ancora più diffuso e pressoché generalizzato, nell’attenzione di tanta filosofia contemporanea al tema
del rapporto con l’altro; tema dell’alterità che è appunto una delle caratteristiche della filosofia contemporanea rispetto a quella tradizionale, soprattutto
“moderna”, condizionata dal principio del cogito e, con esso, da quello della
“astratta”interiorità (dico “astratta”, non l’“interiorità” in se stessa). Non è,
credo, senza una sua profonda ragione che proprio Max Scheler sia stato, oltre
che filosofo del lavoro, anche e più ancora filosofo della simpatia e dell’amore.
Se l’attenzione al lavoro, come al rapporto alteritativo, rientra nell’ordine
“storico” –di storia della filosofia– è invece di natura strettamente “ontologica”
l’idea che trovo a p. 10 del libro di Verducci, dove si legge che è proprio del
lavoro il “far essere”. Anche qui, anzi soprattutto qui, la mia “lettura” rileva un
principio fondamentale, ontologico appunto, che ha una sua applicazione nel
campo del lavoro, ma che trascende –a mio avviso– lo stesso ambito del lavoro, in quanto riguarda l’essere come tale, nel senso che l’essere è precisamente, per se stesso, un “far essere”. Un’applicazione concreta di questo principio
la si può osservare, in particolare, nel mondo della vita (tema della “vita” che
la stessa Verducci tratta ampiamente in un altro suo saggio, dal titolo, appunto, “Pensare la vita”, ed. Il Calamo, Roma 2003); mondo della vita, dove “vivere” è appunto “far vivere”: la vita è produttrice di vita; la vita esiste producendo
vita (e la vita è espressione quanto mai significativa dell’essere –anche di questa mia idea trovo, in certo modo, una conferma nel libro di Verducci cui ho
appena accennato e, per esso, mi pare, nella filosofia di Anna Teresa Tymieniecka, con la serie dei suoi libri intorno a Logos and Life, a cui si riferisce Verducci nel cap. V del medesimo saggio–).
A sua volta, in un’ulteriore approfondimento del discorso, è dato trovare –io
ritengo, una ragione radicale di questo principio ontologico: e ciò nella concezione dell’essere come libertà. Non è questo il luogo per aprire un altro fondamentale capitolo della problematica filosofica: mi limito a rilevare che l’idea dell’essere come libertà è venuta facendosi luce in certi settori del pensiero contemporaneo con l’emergere sempre più chiaro del tema della libertà: intendo la
libertà come “iniziativa” come “creatività”, ben più radicale della “libertà di scelta” ed evidentemente della libertà a livello sociale e politico.
Pur già così pregnante a livello ontologico del “far essere”, il tema della
libertà può ottenere un ulteriore sviluppo, in questa “lettura” del saggio di Verducci, quando si legge, a p. 35, che l’amore è “movimento creatore”. Ora,
“amare” è appunto “far essere”.Se è l’amore, in ultima analisi, a creare (e di
questa “creatività” dell’amore può essere espressione e simbolo la creatività
dell’amore a livello biologico, fisiologico), bisogna dire –secondo una certa
riflessione filosofica, affermatasi soprattutto in tempi recenti– che la libertà è
veramente, concretamente “creatrice”, è “far essere”, se e nella misura in cui
è “maturata”, come io dico, nell’amore. Prima di essere maturata nell’amore, la
libertà è “possibilità” di creatività, non creatività in atto.
Sul tema dell’amore trovo ancora, nel saggio di Verducci, un’idea da rilevare con particolare attenzione, anche se meno radicale della precedente: cioè
l’idea –ripresa da Scheler– che “non si ama qualcuno perché vale” (p. 35).
165
166
Orbene, su questa linea io direi, con qualche altro filosofo –come Gabriel Madinier– che qualcuno “vale” proprio perché e in quanto lo si ama. E ciò non solo
e non tanto per ragioni “psicologiche”, ma, oserei dire, per ragioni “ontologiche”, nel senso che il “valore” dell’amore è “risultato”, cioè risultato della “relazione” fra gli “amanti”. È la “relazione” a creare il valore dell’amore. E qui entra
in gioco un altro principio fondamentale, su cui non è il momento di soffermarci più a lungo: voglio dire, appunto, il principio ontologico della relazione. Mi
limito a richiamare –a titolo simbolico, in questa sede– il Mistero Trinitario, per
il quale la realtà dello Spirito (Santo) è tutto nella o “per” la“relazione” (del
Padre col Figlio).
La mia lettura privilegia, devo dire, il tema dell’amore, intorno al quale trovo
un altro principio, a p. 36 del saggio, dove si dice, con Scheler, che “il sapere
non è fine a se stesso”, e che il “sapere per sapere non sta da nessuna parte”
(p.37). Veramente, io aggiungo, il sapere non ha ragione di “fine”, poiché questo è proprio dell’amore, il quale è appunto causa e fine di se stesso: secondo
l’efficace espressione di S.Bernardo, “amo quia amo, amo ut amem” (Super
Cantica canticorum).
Ancora sul tema del rapporto conoscenza-amore leggo, alle pp. 35-36, che
Scheler definisce l’amore come quello che “risveglia alla conoscenza”. Andando oltre, io direi che il conoscere, il vero conoscere, si realizza all’interno dell’amore. In conformità a questa tesi –così io ritengo– è stato rilevato che noi
conosciamo veramente soltanto le persone che amiamo.
Sempre in rapporto all’amore (e ancora in relazione all’essere), leggo a p.
155 del saggio che secondo Scheler la “gioia” e l’“amore” sono “l’autentica
fonte” dell’essere, non “il falso eroismo del dovere e del lavoro”. Senza ritornare qui a quanto ho rilevato più sopra intorno all’amore come fonte dell’essere
(cioè dell’essere come “dato”, bisogna precisare, poiché l’amore è lui stesso
essere, io dico, anzi è l’essere, in quanto “atto”), voglio sottolineare l’idea della
gioia quale “fonte dell’essere” (accanto all’amore). Effettivamente la gioia
accompagna inscindibilmente l’amore: l’amore è la stessa “gioia”, la vera gioia
(di cui quelle sensitive, fisiologiche, legate all’amore, non ne sono se non
un’espressione, una “traduzione”). È in relazione a questo essenziale abbinamento di amore e gioia che le creature più pregne di potenzialità di amore (e,
per esso, di “vita”), quali le giovani donne, sono le creature in cui vibra più
intensamente la gioia.
Ritornando, infine, direttamente, al tema del lavoro, mi pare di trovare nel
libro di Verducci, quella che si potrebbe ritenere la radice ultima del significato
da attribuire al lavoro: di essere cioè,il lavoro, in sintonia, in certo senso, con
la concezione scheleriana dell’Assoluto: voglio dire con l’idea della “Sostanza
eterna” come “già in divenire, indipendentemente dal mondo” (p.179). Io ritengo che questa concezione dell’Assoluto come, in certo senso, diveniente,
possa essere ricondotta all’idea dell’Assoluto come Libertà (in coerenza con il
concetto dell’essere come appunto libertà). In relazione a ciò, bisognerebbe
rivedere –se il mio discorso non fosse troppo presuntuoso– il concetto dell’Assoluto come Infinitezza in atto, e sostituire tale Infinitezza in atto con la Infinitezza di Possibilità (nel senso di Potenzialità, conformemente, d’altra parte, al
Santino Cavaciuti
A. ALES BELLO, L’universo nella coscienza. Introduzione alla fenomenologia di
Edmund Husserl, Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, ETS, Pisa 2003, pp. 242.
Con la finalità di porre in evidenza il valore fondamentale della ricerca e,
in generale, la “situazione di ricerca” in cui l’umanità esprime la propria
richiesta di senso, questa introduzione alla fenomenologia muove innanzitutto dal nucleo problematico, da cui deve partire la ricerca stessa. In primo
luogo, dunque, dalla esplicitazione della coscienza come “ciò che è a noi più
vicino” e, in secondo luogo, dalla considerazione che un simile lavoro non
possa essere svolto da un solo filosofo, bensì necessiti di una scuola di ricer-
R ECENSIONI
tradizionale concetto di Dio come Onnipotente (messo in ombra –mi pare– dal
concetto più comune in tanta filosofia, di Dio come Essere Infinito o come puro
Pensiero).
Ora, il lavoro può trovare –dico– il suo ultimo e supremo significato, ontologico e teologico, in una “partecipazione” al realizzarsi, nel tempo, della Potenzialità infinita, che è Dio, il Quale, in correzione di eventuali cadute panteistiche, in quanto “Potenzialità infinita” va concepito sempre come “trascendente”
a tutte le realizzazioni temporali, sempre “finite” (anche qui si aprirebbe tutto
un nuovo Capitolo che, evidentemente, non ha posto in questa sede, ma che
potrebbe avere forse un suo svolgimento di primissimo interesse filosofico, e
non solo).
A parte, comunque, questo possibile svolgimento “metafisico” e “teologico”,
la stessa Verducci, ancora alla p. 179, nel contesto dell’idea scheleriana della
“Sostanza eterna come già in divenire”, scrive che “proprio in questa vicenda
temporale degli attributi a noi noti del fondamento del mondo si apre lo spazio
metafisico del lavoro”. Veramente –da parte mia confermo– sta proprio qui lo
“spazio” metafisico del lavoro, ed è pertanto qui il “cuore” dell’intero saggio. Il
lavoro –bisogna dire– ha uno spazio metafisico (e con esso la sua ultima dignità) in quanto si inserisce, se pur parzialmente, nella realizzazione della Possibilità infinita che è l’Assoluto. Il lavoro partecipa, a livello di “natura”, con la
“natura”, alla realizzazione, in certo senso, della Possibilità infinita, come vi
partecipa, a livello “ideale”, il pensiero umano, e a livello di “essere concreto”,
di essere alla sua sorgente, la libertà umana, e vi partecipa nella misura in cui
essa, la libertà, aderendo alla sua “vocazione”, alla sua “chiamata”, si realizza
e “matura” nell’amore.
Sono questi alcuni degli spunti che ho colto, fra i tanti possibili, nel ricco e
profondo saggio di Verducci. Si è trattato di una “lettura” che ha privilegiato il
livello “ontologico” e, in esso, quello della libertà e dell’amore (oltre che della
vita); una lettura che, più che chiudere un cerchio, ne ha aperti di nuovi, in connessione, d’altra parte, con la tesi di fondo, in questo mio breve scritto: la tesi
della “novità” perenne dell’essere, di cui è espressione e simbolo quanto mai
eloquente la “novità” perenne della “vita”.
167
168
catori (la husserliana “comunità dei filosofi”) che lo affrontino da tutte le sue
angolazioni.
Per questo motivo, si sottolinea fin dalle prime battute, la fenomenologia
non può essere intesa come la filosofia di un autore isolato che l’ha concepita
in un sistema definitivo; ma appunto essa va intesa come l’apertura verso una
ricerca dei fondamenti prima di ogni loro categorizzazione. Inoltre, per l’infinità
del suo oggetto, una tale finalità non può essere risolta da una sola esistenza,
bensì deve essere “sempre di nuovo” riattualizzata nel “presente vivente” dei
filosofi che la realizzano. È l’obiettivo husserliano di una scuola fenomenologica, realizzato in parte nel periodo di Gottinga, che, in questo prestigioso lavoro, Ales Bello prende in considerazione nelle sue fondamentali espressioni,
muovendo dal suo fondatore, Edmund Husserl, per proseguire nelle analisi
delle sue due celebri allieve Edith Stein e Hedwig Conrad-Martius.
L’analisi della fenomenologia husserliana, concepita come prima parte del
testo, attraversa ogni singolo fondamentale aspetto della sua filosofia. A partire dal cuore dell’indagine fenomenologica, ossia dalla riduzione, Ales Bello
entra in merito al senso “archeologico” di questa ricerca ed individua il trascendentale come luogo autentico e primo, del senso del mondo. La riflessione su
questa fondamentale “novità” apportata dalla fenomenologia husserliana, conduce conseguentemente all’evidenziazione della dimensione trascendentale
del mondo-della-vita, come luogo di originarietà primordiale e come regno
delle evidenze prima dell’attività teoretica. A sua volta, l’esplicitazione di un tale
universo trascendentale, evidenzia il suo contrapporsi al mondo delle scienze,
cresciuto ed impostosi nella tradizione del pensiero occidentale, nell’oblio di
queste sue origini “naturali”. Per questa “dimenticanza” tutta la tradizione filosofica ha scartato la dimensione pre-categoriale come ingenua e foriera di
generalità e a-logicità. Al contrario Husserl, formulando un’estetica trascendentale rivolta proprio al recupero di queste strutture profonde appartenenti all’atteggiamento ingenuo, esamina nell’ingenuità di questa posizione, le strutture
invarianti (l’eidos) che permangono nella realtà, come elementi costitutivi della
coscienza. Da tale indagine, parallelamente alla variazione eidetica, emerge
anche il carattere teleologico di questo “a-priori”, che si manifesta nella dimensione temporale e, più concretamente, nella fatticità (la dimensione hyletica),
nelle vesti di una tensione dell’umanità al raggiungimento di un fine. Allo stesso tempo, proprio in questa “unità” dell’umanità verso uno stesso fine, l’analisi
della dimensione oggettiva lascia emergere un’apertura verso l’alterità. La
«coscienza dell’altro, che sostiene l’autrice, consente la comunicazione con
l’altro» (p. 75), ossia l’entropatia (tema essenziale dell’antropologia fenomenologica), esprime sia l’individualità della coscienza che la sua insopprimibile
coappartenenza ad un “universo di monadi” (la comunità eticamente fondata),
in cui si rispecchia la realtà umana. E proprio in questo rispecchiamento della
realtà esterna nell’interiorità, si inserisce la dimensione teologica. L’Erlebnis di
Dio, a differenza degli altri Erlebnisse, è la scoperta razionale di un assoluto in
sé, che si rivela fattualmente nella coscienza. L’idea di Dio che teologicamente guida l’essere umano alla sua realizzazione ne è la concretizzazione fattuale. Rileva a proposito Ales Bello «La teologia che informa di sé la fatticità
R ECENSIONI
rimanda a Dio, il quale racchiude e crea tutte le cose» (p. 103). La presenza di
Dio nelle cose e, quindi, la sua immanenza e trascendenza rispetto alla
coscienza, rappresentano la sommità, per così dire, a cui conduce la “domanda regressiva”, il metodo archeologico voluto da Husserl nella sua vita o,
meglio, nella sua “vocazione” di filosofo.
Da questo punto di arrivo, seguendo il senso infinito e continuativo della
ricerca fenomenologica, muove la sua allieva e assistente Edith Stein alla cui
riflessione è dedicata al seconda parte del testo in esame. Edith Stein, contrapponendosi alla limitazione della fenomenologia eidetica alla sola analisi dell’essere essenziale, concentra la sua attenzione sul suo legame con il momento
attuale-reale. La fenomenologia hyletica a cui era approdato Husserl, esige
secondo Stein, una rivalutazione più profonda. Sotto il profilo hyletico, infatti, le
cose manifestano in senso forte il loro senso; pertanto, non è soltanto la sfera
noetica ad essere “donatrice di senso”, ma piuttosto, in maniera primale, nella
sfera hyletica emergono i presupposti stessi della donazione del senso. È la
coscienza a registrare tutto questo. Nella coscienza infatti come in uno specchio, sottolinea Ales Bello, «si riflettono i vissuti che provengono dalle realtà
della psiche e dello spirito» (p. 129). Dalla realtà hyletica, dunque, la fenomenologa è indotta ad una riflessione sulle tre realtà dell’essere umano di corpo,
psiche e spirito, L’unità della coscienza come formazione del sé da parte dell’io,
di derivazione tomasiana, consiste appunto nell’unità di corpo vivente, (psicofisico) e anima spirituale. Nella loro sintesi “abita” l’io, esteso in ognuna di quelle realtà; nella “profondità” dell’essere umano, nella sua parte più spirituale,
invece, si rivela Dio come “già presente”. Al contempo, in tale sua attività spirituale prende forma la materia, la “superficie” in cui si rende concreta l’intera sintesi, vale a dire, l’individuo umano nella sua realtà e nei suoi legami intersoggettivi. A questo proposito, nota Ales Bello, Stein fa del tema fenomenologico
dell’entropatia il luogo della presa di coscienza dell’esperienza vissuta estranea.
Nella capacità di sentire ciò che l’altro “sente” è possibile riconoscere originariamente tale sentire stesso; ed alla luce di un simile sentire deve essere fondata
la vita di una comunità personale e, dunque, la società politica, lo Stato. D’altra
parte, tale connotazione dell’interiorità umana e del sentire che la caratterizza,
apre il cammino, già iniziato da Husserl, verso la tascendenza di un Assoluto,
rivestendolo sotto l’influenza della lettura di santa Teresa d’Avila e di san Giovanni della Croce, di una profonda vena mistica. In tale prospettiva, proprio per
la loro complementarità, osserva Ales Bello, «l’incontro fra fenomenologia e
mistica si presenta come efficace per un approfondimento reciproco» (p. 173).
Riguardo alla “questione della filosofia cristiana”, ovvero all’incontro tra teologia e filosofia, si muove anche la ricerca fenomenologica di Hedwig Conrad-Martius, a cui è dedicata la terza ed ultima parte del testo che stiamo esaminando.
Il suo contributo nei riguardi di un’ontologia reale, secondo l’omonimo titolo del
suo famoso Saggio del 1923, sembra seguire in prima istanza l’eidetica husserliana. In realtà se ne discosta, come rileva Ales Bello, per «l’insistenza sul
momento dell’essenza» e per «l’attenzione rivolta al recupero dell’esistenza» (p.
185). Nonostante queste basilari differenze, tuttavia, l’originale contributo alla
ricerca fenomenologica da parte di Conrad-Martius è notevole. Il suo richiamo
169
170
all’analisi del fattore realtà ed all’inserimento anche dell’idealità nell’ambito dell’esistere (nell’aspetto formale) conducono la fenomenologa alla fomulazione di
un’ontologia secondo cui un’entità reale è la sintesi del momento che funge da
portatore (il “sostrato”) e la “quiddità” (Washeit) di cui è “caricato”. La totalità di
ciò che si dà, è globalmente il “cosmo” noetico, ossia la “comprensione” intellegibile del mondo reale. Ma il mondo c’è, e secondo conrad-Martius, a differenza
di Husserl che suo avviso con la riduzione ha trascurato il momento della fattualità, occorre “garantire” che si dia qualcosa al di là del soggetto “che parla”. In tale
suo obiettivo, riferendosi anche ai risultati ottenuti dalle scienze della natura nel
XX secolo, Conrad-Martius giunge a rilevare l’intreccio tra fisica e metafisica, nel
fatto che l’indagine dello scienziato della natura rende imprescindibile il ricorso
ad una spiegazione di ordine “transfisico”, dei suoi asserti. In tale ordine di idee
e conseguentemente alla sua conoscenza del darwinismo e del neodarwinismo,
si inquadra la lettura di Conrad-Martius relativa all’origine dell’essere umano.
L’essere umano è innanzitutto da lei considerato una “totalità vivente” (Lebenstotalität) che deve essere riguardata nella complementarità dei suoi aspetti (nella
sua entelechia). Per quello che riguarda la sua origine e il suo sviluppo, invece,
occorre prestare attenzione al significato spirituale-religioso che ha avuto nella
sua evoluzione il peccato originale, con la corruzione dell’anima così come del
corpo. Secondo il suo evoluzionismo creativo (riferito a “potenze transfisiche”,
come si rileva nel testo in esame), Conrad Martius afferma che l’essere umano
non ha un’origine animale, ma che già nella sua fase embrionale si sia distinto
dagli altri primati per la sua posizione eretta. D’altra parte però, evidenzia Ales
Bello, a suo avviso, «ogni essere vivente, anche le piante, mostrano, in forza
della loro anima una forma che è corporea» (benché né affettiva né tantomeno
spirituale) (p. 229). Per tale ragione, l’origine ed il senso dell’essere umano sono
fortemente connessi alla comprensione dei processi della natura stessa. La
divergenza tra scienze della natura e metafisica, tra scienza e teologia, conclude Ales Bello in questa analisi del pensiero di Conrad-Martius, deve pertanto
guardare alla possibilità di un accordo «fra le diverse prospettive», suggerito dai
fenomeni stessi, «se opportunamente indicati» (p. 235).
Facendo riferimento ad una copiosa letteratura critica nonché a tutti i testi
degli autori principalmente esaminati e, riguardo a Husserl, anche a numerosi
Manoscritti inediti, L’universo nella coscienza riesce molto efficacemente a
tracciare una linea di continuità tra gli aspetti fondamentali della fenomenologia classica e le sue ramificazioni nei suoi principali interpreti. In particolare,
ponendo in evidenza il senso ultimo dell’indagine husserliana nell’esplicitazione del significato del compito del ricercatore filosofico e del suo continuo e, tuttavia, infinito adempimento da parte della “comunità dei filosofi”, Ales Bello ha
chiaramente ri-delineato gli obiettivi principali della ricerca fenomenologica
profilando, al contempo, «i campi teorici di rimando» (antropologia filosofica e
filosofia della natura) sulle cui basi si rende possibile effettivamente indagare
«come stanno le cose» e giungere, così, ad una fenomeno-logia, ossia ad una
«descrizione essenziale di ciò che ci viene incontro» (p. 242).
Nicoletta Ghigi
Tra i cosiddetti sistemi metaforici di lunga durata, o archetipici, quello che
contrappone la luce all’ombra è notoriamente dei più caratteristici. La stessa
esperienza percettiva primaria si presta –fortissima la tentazione di scrivere:
“naturalmente”– all’investimento simbolico; in virtù del quale è quasi sempre
l’ombra a farsi carico delle connotazioni negative (morte, privazione, oblio…),
laddove la luce è invece facilmente sinonimo di vita, pienezza, positività tout
court. A ben osservare, tuttavia, questo congegno simbolico bipolare, in apparenza tanto solidamente “motivato”, impeccabile, appare viziato all’origine dalla
indebita assimilazione dell’ombra alla tenebra. Nel volume di Antonio Prete
oggetto di questa nota l’autore può allora dar corso ad una sorta di meditata
apologia dell’ombra dimostrando di avere ben presente, tra l’altro, proprio l’arbitrarietà della sopra menzionata assimilazione: la indubbia complementarità,
registrata dai millennî, dell’ombra rispetto alla luce non è infatti dello stesso
genere di quella per cui anche la tenebra può esser vista come dalla luce
medesima inscindibile; e ciò in quanto due differenti modalità di articolazione
tra gli opposti risultano distinguendosi secondo le categorie del diacronico
–che pertiene propriamente alla dicotomia tra luce e tenebra: paradigmaticamente nel ciclo circadiano– e del sincronico, che è più congrua invece giustappunto al rapporto intrattenuto dalla luce con l’ombra. Quest’ultima rappresenta
in effetti la negazione della luce in praesentia; ragion per cui è possibile pensare, forse, all’ombra piuttosto come alla negativa della luce, e non tanto come
ad una sua semplice negazione: essa dunque non solo nega, ma anche –nel
suo negare– rivela. Guardare all’ombra, e dall’ombra, significa pertanto cogliere la natura ambivalente del reale, sfuggendo ad ogni mortificante concezione
unidimensionale di esso; e può essere operazione da cui prenda avvio una
serie di riflessioni dalla portata cospicua, per ampiezza e profondità.
Trenta gradi all’ombra è titolo argutamente polisenso. Sono effettivamente
trenta, le brevi prose che gradualmente immettono ad un Epilogo il quale fin
dal titolo (La luce, dall’ombra) riassume la valenza di questa ascesa al senso
autentico dell’ombra, o –che voglia dirsi– di questa discesa fin nel suo cuore
più riposto. Differente è la natura di tali prose, la loro configurazione anche
esteriore; non si sbaglierà di troppo ponendo provvisoriamente i diversi testi
all’incrocio tra poema in prosa, apologo filosofico (riflessione nella scia dei
grandi moralisti, e particolarmente di quel Leopardi cui l’autore è venuto consacrando negli anni tanto impegno esegetico), memoria autobiografica, racconto in senso stretto (ma meglio: frammenti, abbozzi più o meno compiuti, di
situazioni narrative; con certa predilezione per una matrice diegetica di tipo
“borgesiano”: si rivada esemplarmente a Questioni naturali). Costante è
comunque il riferimento al tema dell’ombra, a riscattarne –nella testura di un
complessivo elogio composto di tessere minute eppure ciascuna indispensabile alla resa dell’insieme: organica rapsodia– l’immagine poco lusinghiera cui
essa è costretta, nell’immaginario, da quella imponente tradizione cui si è
accennato in apertura. Prete lo fa dire alla luce stessa (Dialogo dell’ombra e
della luce): il medesimo «ammasso di fotoni» in cui essa si sostanzia secondo
R ECENSIONI
A. PRETE, Trenta gradi all’ombra, nottetempo, Roma 2004, pp. 127.
171
172
i fisici splenderebbe assai di meno senza il contrappunto della sua interruzione; l’ombra –pausa, iato, smagliatura sulla superficie di smalto della pura
lucentezza– permette di sottrarre la luce all’abisso di una sterile autotelicità, e
della luce rappresenta così, in un certo senso, il di fuori. L’ombra di cui l’autore indaga con acuta circospezione il mistero è allora una sorta di coscienza
della luce: è come l’eclisse che rivela la luna a se stessa, che la mostra nasconendola (Lezione di tenebre).
Tutto il reale –ci avverte l’autore– è in permanente chiaroscuro, si dispone
nei dominî del «crepuscolo»; solo la contiguità e la fusione tra l’ombra e la luce
possono essere emblema eloquente della sua costitutiva, sempre “attuale”,
ambiguità. Proprio tale ambiguità è inattingibile alla sola ragione, rappresenta
per essa un limite invalicabile. La ragione pura è per definizione manichea: non
coglie lo sfumato, la compresenza della luce nell’ombra e viceversa: essa si
esercita a proprio agio soltanto in piena luce, ritaglia sì campiture d’ombra, e
le classifica; ma per espungerle dal proprio corpus senza neppure pronunciarsi su di esse, sdegnosamente. Il lume della ragione dissolve fatalmente il margine d’ombra che pure lo invera, offrendo così l’espressione compiuta di ciò
che accade anche quando esso si accosta senza precauzioni a quella poesia
che –come la realtà di cui essa non è altro che cifrato specimen– proprio della
presenza dell’ombra vive, è oggetto umbratile per antonomasia. La ratio,
appressandoglisi senza riguardi, brucia l’oggetto che pure pretenderebbe illuminare, e in un fatale cortocircuito innesca la propria stessa autocombustione.
La ragione, in effetti, non ama i paradossi, che ha inventato per esorcizzare un
reale mai in totale sintonia con se medesima: mai completamente in piena
luce, mai oggetto ad essa completamente adeguato.
Maggior rispetto per l’intrinseca ambiguità del fenomenico, maggior riguardo per la poesia che ce lo restituisce fragile e intero, presenta invece una scrittura che sia attenta proprio allo sfumato, al non integralmente riconducibile in
piena luce: che miri con ciò a salvaguardare (e riprodurre) il continuamente
minacciato, l’esposto. Un altro modo di guardare alle prose di Trenta gradi
all’ombra è allora quello di considerarle animate dallo stesso scrupolo –di
carattere morale, prima ancora che estetico o conoscitivo– caratteristico di un
tal genere di scrittura. Riconoscere nei capitoli questa ulteriore marca –quella
che ne fa altrettante pagine di riflessione critica– permette di intercettare in essi
una sobrietà che deriva loro da una sottesa, implicita tensione argomentativa:
anche quando si tratti –ad esempio– di rievocare l’infanzia, il trasporto sentimentale, l’afflato rammemorante non prevaricano su di un tono che resta lucido, allusivo ma sempre padrone di sé: filosofico.
La meditazione di Prete sembra avvantaggiarsi di questa nativa sensibilità
per una parola partecipe della natura delle cose, in consonanza con gli elementi che essa contemporaneamente designa e trasfigura: come il Li Wajang
di Sul tremito delle ombre, l’autore sa riconoscere una simile parola, e farne
buon uso; parola in apparenza la più dimessa, che consente però di sorprendere il sentire stesso dell’ombra; dissolvendo così la tirannia del soggettivo,
l’arbitrio dell’osservatore troppo neutro o troppo egocentrico, comunque impositivo. L’ombra, còlta nel suo stesso irripetibile offrirsi e non investita di sensi
R ECENSIONI
estrinseci, restituisce nel supremo contingente il calco dell’Essere: sussume
nell’effimero l’eterno, ed è per il cercatore della verità come il vetro affumicato
che consente di guardare al Sole.
È l’illusione a se stessa trasparente che permette di dare profondità alla
luce, che ne impedisce il dissolvimento in una abbacinante, oceanica piattezza; questo intuisce ad esempio l’arte della pittura (Sulla soglia), come pure
quella stessa téchne cinematografica che ai suoi albori, soprattutto, ne continuò la promessa: permettendo entrambe –come ogni arte, come ogni autentica poïesis– di vedere il mondo dal di fuori, di scorgerne il senso. In una delle
folgoranti osservazioni che punteggiano la riflessione dall’ombra di Antonio
Prete, ed offrono in improvvise e suggestive accensioni gnomiche preziose
aperture all’intelligenza del lettore, l’autore definisce la luce come la lingua del
cinema, e l’ombra come la sua anima (Il lenzuolo bianco). In effetti la grande
arte si sforza di riprodurre l’alchimia del reale, lavora con l’ombra per parlare
della luce, per poterla vedere, per farne l’oggetto e non il mezzo della visione.
Così la parola –ombra della cosa che la cosa rivela rilevandola, sbalzandola
dal fondo di luce in cui essa altrimenti annegherebbe– potrà essere come l’ombra dello gnomone sul quadrante della meridiana: eventualmente riattingere
perfino il tempo acronometrico per eccellenza, quello dell’infanzia: essa medesima, la parola, simile all’ombra che nutre la luce ed al tempo afasico che alimenta quello adulto dei cronometri: in quanto anch’essa –nera luce– «intervallo tra l’assoluta lontananza e l’impossibile» (La meridiana).
La scrittura di Prete è pienamente consapevole dei prodigî possibili ad un
dire che rifugga dalla banalità, che si discosti dalla tautologia del meramente
referenziale, dall’angustia della classificazione (che cosa vale l’ombra dell’ulivo finché sia lasciata giacere nel suo astuccio?); e si impegna così a misurare
la distanza, o addirittura a sondare la estraneità, «tra la vita che è nello spazio
e le carte che la rappresentano» (Dalla lettera di un cartografo celeste a un
amico). La parola poetica, in senso lato, è tale anche perché prende atto di
questa incommensurabilità tra se stessa e l’essenza di ciò cui intende comunque riferirsi; l’autore sa che soltanto può valere –in certi casi– quel proferir
verbo che si aggiri insistente intorno alla luce del non dicibile, che ne cinga da
più lati l’assenza fiammeggiante, con le sue orbite tenaci descrivendone la
forma. Come l’ombra schiudendo così, tale parola “leopardiana”, quelle «lontananze che superano i confini del nostro immaginare»; e, nell’atto stesso di
aggirarsi attorno alla zona fulgida ed intangibile della verità, generando l’umana interpretazione, la quale –nel suo essere non altro che movimento attivato
da una abbagliante lacuna– è appunto ombra che manifesta una luce, la sprigiona.
Proprio il rapporto posto tra l’ombra e l’interpretazione è un altro momento
paradigmatico delle impennate di acume propriamente filosofico che la riflessione di Prete, in apparenza come svagatamente assorta, improvvisamente
conosce in queste prose; exploits che, al di là della stessa forza di suggestione che promana da una parola intrinsecamente allusiva, si mostrano capaci di
dar intensamente da pensare anche al di fuori di ogni atteggiamento di complicità con il “parlante”: se ne convince ad esempio chi applichi o riferisca le
173
174
immagini cui questi perviene nel corso della sua riflessione poetante ad un differente orizzonte epistemologico, a quella riflessione sostanzialmente poco
affine; e pensi un modo di intendere l’interpretazione quale quello restituito dall’immagine appena menzionata non solo come del tutto conforme a rendere
quella prassi abduttiva che taluni riconoscono come propria di ogni procedura
di decodifica linguistico-testuale; ma lo connetta, tale modo, allo stesso procedere della scienze naturali attraverso la formulazione di ipotesi cui si acceda
anche tramite la più franca invenzione: attitudine questa che infatti rimette in
onore l’azzardo e la fantasia, e riconosce nel cosmo le ragioni del caos (così
molta epistemologia contemporanea ha saputo render giustizia ai più ardimentosi voli immaginativi di tanti poeti-filosofi del passato). Unico si scopre così
essere lo studium della natura, la costitutiva quête degli esseri umani all’interno del proprio mondo; ricerca che riafferma per questa via, inoltre, la sua originaria valenza passionale ed erotica.
La parola che si eserciti nella pazienza amorosa dell’indagine avvicina la
figura di chi se ne sappia servire a quella dei filosofi che, nelle pagine del volume di Prete, sembrano voler insegnare soprattutto alle nuove generazioni la
valenza umbratile della verità, e mostrare come essa sia lontanissima dalla
monocroma chiarezza del dogma. Sempre dotate di una fluida naturalezza che
rende “filosofica” la pagina, la fa nitida e la tiene abbondantemente al di qua di
ogni concettoso arzigogolio (merito non secondario, visto che il tema ben si
sarebbe prestato –in altri– alla elucubrazione ed al ghirigoro barocchi), queste
descrizioni procedono insieme alla riflessione propriamente detta, si producono allacciate ad essa e con essa si intrecciano fittamente –rinnovato sodalizio
di Mito e di Logos.
Queste trentuno piccole variazioni sul tema dell’ombra –condotte con un
virtuosismo dell’intelligenza mai disgiunto da una sensibilità educata nel tempo
all’attenzione verso il minimo e l’ineffabile– si propongono così come altrettanti esercizî di quella “maieutica del segno” (Magrelli) che ha come presupposto
proprio una identificazione densa di implicazioni tra scrittura e nostalgia della
presenza, parola ed ombra. L’ombra di cui parla Prete è perciò tutt’altro che
una entità sfuggente: essa non è meno salda dell’Essere che rivela –ne costituisce l’impronta risonante. Nella convinzione che sia «possibile attingere se
non la verità almeno le sue metafore, appunto le sue ombre» –vale a dire che
sulle cose essenziali sia possibile soltanto Adombrare–, chi scrive cesella il
suo oggetto con l’amorosa perizia di un antico artigiano, sa osservarlo nelle
sue minute componenti, coglierne e riprodurne la cangiante consistenza. E
così, pazientemente, il maestro d’ombre e cartografo celeste saprà farsi nuovamente ragazzo, tornando come un tempo a guardare il mondo dall’ombra
–attraverso la parola: e sarà come scalare di nuovo l’arcobaleno. Perché
–secondo l’autore– non meno splendida dell’iride è l’ombra: custode materna
della luce, sua fedele e pudica testimonianza.
Marco Gaetani
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA «SEGNI E COMPRENSIONE»
Volumi:
L. A. ARMANDO, La ripetizione e la nascita. Scritti di storia della filosofa e della psicoterapia (1961-2004), Liguori, Napoli 2004, pp. 302;
L. A. ARMANDO, Prìncipi senza paura. Una lettura de “Il principe” di Machiavelli, Manni,
San Cesario di Lecce, 2004, pp. 190;
J.-R. Armogathe, L’anticristo nell’età moderna. Esegesi e politica, Le Monnier, Firenze
2004, pp. 148;
D. BOCCARDI, Saggi di filosofia della scienza, La Città del Sole, Napoli 2004, pp. 54;
L. BOTTANI, Cultura e prestanza, Mercurio, Vercelli 2004, pp. 320;
S. CAVACIUTI, L’alterità. Il problema morale nel pensiero di Maine de Biran, Cesati, Firenze 2004, pp. 236;
M. DE CERTEAU, La scrittura dell’altro, Cortina, Milano 2005, pp. 115;
S. CIURLIA, Unitas in varietate. Ragione nominalistica e ragione ermeneutica in Leibniz;
Congedo, Galatina 2004, pp. 278;
D. DE LEO, Michelstaedter filosofo del “frammento”. Con “Appunti di filosofia” di C.
Michelstaedter, Milella, Lecce 2004, pp. 120;
A. ERBETTA, a c. di, In forma di tragedia. Luoghi e percorsi della coscienza inquieta, Utet,
Torino 2004, pp. 268;
M. FORTUNATO, Alternative della vita. Esistenza e filosofia, Il melangolo, Genova 2004,
pp. 254;
G. INVITTO, L’occhio tecnologico. I filosofi e il cinema, Mimesis, Milano 2005, pp. 238;
M. G. LOMBARDO, La mente affettiva di Spinosa, Il Poligrafo, Padova 2004, pp. 190:
S. LUCCHESE, Federalismo, socialismo e questione meridionale in G. Salvemini, Lacaita, Mandria-Bari-Roma 2004, pp. 258;
P. MARIANO, Dicotomie e dinamiche della teoria della traduzione, Milella, Lecce 2005,
pp. 344;
C. MEAZZA, Note, appunti e variazioni sull’attualismo… passando per Heidegger, ETS,
Pisa 2004, pp. 260;
L. PAPINI, Ecumene e decisione. Teologia politica e critica della modernità in C. Schmitt,
Name, Genova 2004, pp. 664;
C. PERROTTA, a c. di, La scienza è curiosità. Scritti in onore di U. Cerroni, Manni, San
Cesario di Lecce 2004, pp. 342;
J.-P. SARTRE, Le Troiane, a c. di P. Bignamini, Mimesis, Milano 2005, pp. 102;
G. SCARAFILE, Proiezioni di senso. Sentieri tra cinema e filosofia, Effetà, Cantalupa
2003, pp. 112.
L. VAIANA, Il naturalismo di G. Santayana, Armando, Roma 2004, pp. 224.
Periodici:
‘Αρχή: Tradizione e modernità, a c. di P. Pastori, V, 2003-2004; Torre, Trepuzzi;
Acta philosophica, f. II, n. 13, 2004; Pontificia Università della Santa Croce, Armando, Roma;
175
Aesthetica Preprint, n. 72, dicembre 2004: M. HEIDEGGER, Dell’origine dell’opera d’arte
e altri scritti; C.I.S.d.E., Palermo;
Antologia Vieusseux, n. s., X, n. 29, maggio-agosto 2004; Polistampa, Firenze;
Estudios Franciscanos, v. 105, n. 437, sept.diciem. 2004; Provincias Capuchinas Ibéricas, Barcelona;
Estudios Mindonienses, n. 20, 2004; Diócesis de Mondoñedo-Ferrol;
Hermeneutica, n. s., 2004: Filosofia teologia politica. A partire da Italo Mancini; Morcelliana, Brescia;
Idee, n. 55, 2004: Sull’amicizia; nn. 56-57, 2004, Milella, Lecce;
L’immaginazione, n. 209, 2004; n. 210, 2005; Manni, San Cesario di Lecce;
Le Carte 6, 2004, Fondazione Romolo Murri per la storia del Modernismo;
Paradigmi, n. 66, a. XXII, n. s., settembre-dicembre 2004: Hans Jonas; Schena, Fasano;
Prospettiva persona, n. 49-50, dicembre 2004; Edigrafital, Teramo;
Recherces Husserlienes, v. 21, 2004; Centre de Recherches Phénoménologique des
Fac. Univ. Saint-Louis, Bruxelles;
Rivista di Filosofia, n. 3, 2004; il Mulino, Bologna;
Studia Patavina, n. 3, a. LI, settembre-dicembre 2004; Padova.
176
177
SAGGI
178
179
SAGGI
180