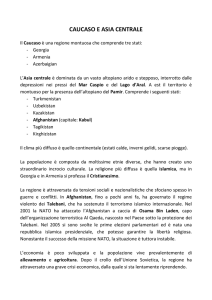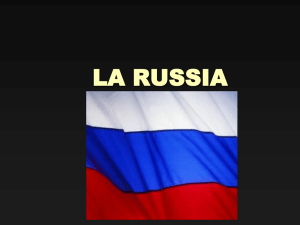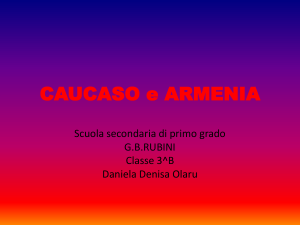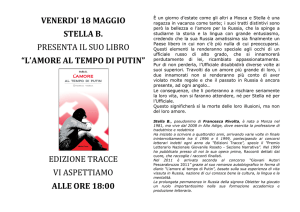00470238603801_COVAIT@EST
3-10-2006
14:31
Pagina 1
Osservatorio Internazionale
Il disincanto iracheno
Guerra e boom economico nel Golfo
Documentazione
ISBN 88-238-6038-5
9 788823 860384
Euro 10,00
La partita nel Caucaso
Un nuovo Grande Gioco?
Il confronto tra Stati Uniti e Russia
Il ruolo di Turchia e Unione Europea
La transizione politica
ISPI n. 1 2006 Quaderni di Relazioni Internazionali
Dossier - Caucaso
ISPI
Quaderni di Relazioni Internazionali
Quadrimestrale dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
n. 1 - Aprile 2006
La partita nel
Caucaso
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 1
Editoriale
di Boris Biancheri
Da oltre settant'anni l'ISPI è impegnato a promuovere in Italia l'analisi e il
dibattito sulle tematiche internazionali, attraverso una molteplicità di strumenti.
Tra questi, le pubblicazioni hanno sempre avuto un ruolo di primo piano.
“Relazioni Internazionali”, in particolare, è stata per molti anni uno straordinario
strumento di documentazione e un punto di riferimento non soltanto per
ricercatori e studiosi ma anche per diplomatici, giornalisti e rappresentanti
del mondo delle istituzioni e delle imprese, sia in Italia che all'estero.
Con “Quaderni di Relazioni Internazionali”, l'ISPI prosegue e sviluppa dunque la lunga
tradizione dell'Istituto quale osservatore e commentatore delle tendenze che si manifestano
nella vita internazionale e dei grandi temi contemporanei, che sono politici, ma anche
economici, finanziari, sociali, etici o giuridici. Sui temi, cioè, della dimensione internazionale
dei problemi della società di oggi.
I “Quaderni di Relazioni Internazionali”, che saranno pubblicati con cadenza
quadrimestrale, avranno prevalentemente carattere monografico, con dossier approfonditi
su aree geografiche o su tematiche trasversali. Come focus del primo numero è stato scelto
il Caucaso, in quanto rappresenta una delle regioni del mondo a più elevata conflittualità,
effettiva e potenziale.
La dissoluzione dell'Unione Sovietica ha, infatti, ricondotto in superficie le linee di faglia
di una diffusa frammentazione politica, etnica e confessionale che non ha mancato di
sfociare in sanguinosi e prolungati conflitti. Nel Caucaso meridionale, in particolare, si è
assistito allo scontro tra armeni e azeri (per l'Alto Karabakh) e all'insorgenza in Georgia
di due entità territoriali di fatto autonome (l'Ossetia meridionale e l'Abkhazia).
La regione caucasica è segnata da una serie di elementi di tensione tanto di natura
endogena quanto di natura esogena. I primi discendono dal complesso ed intermittente
processo di transizione da un sistema politico totalitario a un regime almeno apparentemente
democratico e da un'economia centralizzata e pianificata a un'economia di mercato.
I secondi dalla ricomparsa del cosiddetto “Grande Gioco” per il controllo delle risorse
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
1
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 2
editoriale
energetiche caspiche (pari a circa il 10% delle riserve mondiali) che contrappone,
anzitutto, Stati Uniti e Federazione Russa, ma che coinvolge anche Unione
Europea, Turchia e Iran.
È particolarmente interessante il ruolo dell’Unione Europea che comincia a
consolidare il proprio impegno, dopo aver a lungo palesato una sostanziale
inerzia nei confronti del Caucaso, limitandosi a offrire un contributo meramente
finanziario alla stabilizzazione e alla crescita economica dell’area. Accantonando
parzialmente la prudenza che le consigliava di mantenersi a distanza dalle
turbolenze regionali caucasiche e dalla complessa rivalità geopolitica tra Stati
Uniti e Federazione Russa, l’Unione Europea ha compiuto un salto qualitativo
nelle relazioni con le repubbliche del Caucaso, culminato nel giugno 2004 nella
decisione di inserire Georgia, Armenia e Azerbaigian nel quadro della Politica
europea di Vicinato.
L’Unione Europea ha profondi interessi nell’area, in primo luogo sul
versante economico, con particolare riferimento agli approvvigionamenti
energetici. La dimensione economica, tuttavia, mostra solo una parte degli
interessi dell’Unione Europea. A ben vedere, infatti, la necessità di pervenire alla
piena pacificazione e alla stabilizzazione di Georgia, Armenia e Azerbaigian non
è estranea al processo di allargamento dei confini sud-orientali dell’Unione
Europea e in particolare alla candidatura della Turchia. Per quanto sia azzardato
avanzare previsioni sui tempi e sulle effettive possibilità di compimento del
processo di integrazione europea di Ankara – avviato il 3 ottobre del 2005 con
l’apertura ufficiale dei negoziati – un eventuale ingresso della Turchia
condurrebbe le frontiere dell’Unione ad affacciarsi direttamente sul Caucaso.
Il nuovo atteggiamento nei confronti delle repubbliche caucasiche è coinciso,
traendone impulso, con una fase di loro evoluzione interna. Georgia, Armenia e
Azerbaigian hanno avviato un percorso di profonda riforma delle istituzioni
politiche ed economiche interne che – pur nelle marcate differenze nello stato di
avanzamento del processo – promette di avvicinarle agli standard occidentali.
Nonostante i passi in avanti compiuti, la politica dell’Unione Europea
rimane carente sotto molti punti di vista. La definizione degli Action Plans della
Politica europea di Vicinato – attualmente in negoziazione con i tre stati
caucasici – permetterà di compiere ulteriori progressi. Bruxelles ha comunque
cominciato a maturare la consapevolezza della centralità strategica del Caucaso,
del fatto che la propria prosperità economica e la propria sicurezza passano
anche dalla stabilizzazione di questa complessa regione.
Il Caucaso pone, in definitiva, un insieme di sfide
e di opportunità davanti alle quali l’Unione Europea
è chiamata a porre in essere una
strategia forte e condivisa.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
2
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 3
dossier
La partita
nel Caucaso
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 4
La partita nel Caucaso
Marco Antonsich
Prove di regionalizzazione nel Mar Nero.
Il caso della Black Sea Economic Cooperation
Introduzione
MARCO ANTONSICH
insegna Political
Geography alla University
of Colorado at Boulder.
Ha collaborato con il
CeMiSS, l’Institut de
Stratégie Comparée di
Parigi e il Finnish Institute
of International Affairs.
Quali processi di regionalizzazione o regionalismo sono oggi in atto nell’area
geografica del Mar Nero? Il Mar Nero si sta costituendo come un insieme regionale avente istituzioni e identità proprie? L’articolo cerca di rispondere a queste due
domande, focalizzandosi su quella che a tutt’oggi è la principale forma di cooperazione regionale nell’area, la Black Sea Economic Cooperation (Bsec).
Creata nel 1992, su iniziativa diplomatica turca, la Bsec, che raggruppa tutti i
paesi rivieraschi, più altri paesi balcanici e caucasici, è un’istituzione regionale costruita ad immagine delle istituzioni dell’Unione Europea e che mira, in accordo
con le direttive del Wto (World Trade Organization), a liberalizzare gli scambi
commerciali e finanziari nell’area.
A più di quindici anni dalla sua creazione, qual è stato finora il ruolo svolto dalla Bsec nel generare un processo di region-building nell’area del Mar Nero?
Questo articolo introduce dapprima il dibattito legato al termine “regione” e
quello legato ai processi di regionalizzazione e regionalismo, quali due modi del
medesimo processo di region-building. Quindi procede ad analizzare il caso della Bsec, evidenziando i principali ostacoli di tipo economico e geopolitico che limitano un efficace processo di regionalizzazione nell’area. Infine si sofferma sui
rapporti tra l’Ue e la Bsec, evidenziandone i limiti e dibattendo, nella conclusione, dell’utilità di un maggior coinvolgimento di Bruxelles in un’area di grande rilevanza strategica per l’Ue stessa.
Regione, regionalizzazione e regionalismo
Nella letteratura accademica, il termine “regione” è un termine ambiguo. Dal
punto di vista geografico, esso sfugge ad una precisa dimensione scalare, identificandosi a volte con la scala formata dall’insieme di più stati (la regione del Caucaso, la regione del Mediterraneo, ecc.), a volte con la scala dell’istituzione amministrativa regionale così come conosciuta in Europa (la regione Lombardia, la
regione Languedoc-Roussillon, ecc.). A questa ambiguità scalare è associata anche un’ambiguità di contenuto. Cos’è una regione?
Nell’ambito della letteratura geografica – la disciplina accademica maggiormente coinvolta in questo esercizio di definizione – non esiste una risposta uni-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
4
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 5
Prove di regionalizzazione nel Mar Nero
voca. Nell’ambito della geografia umana, la regione viene tradizionalmente vista
come il prodotto dell’interazione tra uomo e ambiente e trova nel paesaggio la
forma che porta i segni distintivi di una comunità unita organicamente al suo
ambiente attraverso pratiche di lavoro e di vita quotidiana. Nella geografia fisica,
la regione viene invece concepita sulla base della unità di principi orografici, climatici, biogeografici, geomorfologici, ecc. È proprio su questa unità fisica degli
ambienti geografici, spesso sostenuta anche da una presunta unità culturale ed
economica, che le dottrine geopolitiche del Ventesimo secolo hanno legittimato
sogni imperialistici.
Nell’ambito della scienza politica, la regione può essere invece concepita come un prodotto dei processi di de-/re-territorializzazione associati alla globalizzazione, come una nuova forma di assetto territoriale che viene ad affiancarsi allo stato-nazione.
Connesso con questa interpretazione è anche l’uso che della regione viene fatto nella disciplina delle relazioni internazionali. In questo caso, la regione emerge come una dimensione alternativa con cui pensare e plasmare la realtà internazionale – una forma istituzionale capace di regolare uno spazio entro il quale possono coesistere attori diversi (stati, enti locali, istituzioni internazionali, Ong,
ecc.) legati tra loro da rapporti di collaborazione non gerarchici. Contrariamente all’idea di regione oggi dominante in geografia e in economia, confinata alla
scala sub-nazionale, la nozione di regione e il processo di region-building ad essa
associato rimandano, nelle relazioni internazionali, ad una scala supra- o transnazionale. Ciò che è qui in gioco, o meglio in crisi, è il modello westfalianoweberiano del sistema degli stati moderni. Come noto, questo modello si reggeva sulla netta distinzione tra la sfera interna e la sfera esterna nell’esercizio della
sovranità. In un’epoca di flussi globali questa distinzione salta e con essa anche la
nozione westfaliana-weberiana di stato come ente retto da una burocrazia razionale, avente il monopolio legittimo della violenza e dotato di autorità esclusiva su
un determinato territorio.
A questa trasformazione ne può essere associata un’altra, quella che riguarda il
passaggio da government (forma di governo del territorio incentrata su istituzioni
dello stato gerarchicamente ordinate fra loro) a governance (forma di gestione del
territorio che rimanda ad un insieme di attori governativi e non – sindacati, associazioni, consorzi, Ong, ecc. – legati fra loro da rapporti di rete anziché gerarchici).
La regione emerge come il frutto stesso di queste pratiche di governance.
Se il processo di region-building venga innescato dall’alto, in genere da attori
statuali, o dal basso, attraverso la convergenza di interessi locali rappresentati da
associazioni, enti locali o organizzazioni di categoria, è fatto che può variare da
caso a caso. Ma sia nel primo (“regionalizzazione”) sia nel secondo caso (“regionalismo”), la regione che viene così in essere rispecchia generalmente una dimen-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
5
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 6
La partita nel Caucaso
sione post-nazionale o post-moderna, caratterizzata da una forma debole di governo del territorio, dall’intervento simultaneo di molteplici attori aventi status
giuridici diversi (multilevel governance) e da un’altrettanto debole forma di identità collettiva. Grazie alla capacità di unire in rete attori diversi e di superare la dicotomia westfaliana interno/esterno, il region-building approach viene sempre
più spesso presentato come fattore di pace, sicurezza (soft security) e sviluppo,
specialmente in aree caratterizzate da tensioni geopolitiche1.
La cooperazione regionale nel Mar Nero.
Il caso della Black Sea Economic Cooperation
Esiste oggi un processo di region-building nell’area del Mar Nero? Mentre su
scala sub-nazionale l’idea di regione, così come conosciuta in Europa occidentale, pare assente, essendo i regionalismi nell’area veri e propri movimenti separatisti anti-stato, su scala supra-nazionale forme di regionalizzazione sono invece
indubbiamente presenti. Accanto a diverse iniziative di cooperazione regionale
avviate da partner locali e statuali2, la forma di regionalizzazione oggi più importante nell’area va sotto il nome di Black Sea Economic Cooperation (Bsec).
Voluta all’interno del grande disegno di politica estera turca degli anni Novanta concepito dal Presidente Turgut Özal, la Bsec nasce a Istanbul, il 25 giugno
1992, con la firma di undici paesi: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria,
Georgia, Grecia, Moldavia, Romania, Russia, Turchia e Ucraina3. Nell’aprile 2004,
si è avuta l’adesione di Serbia e Montenegro, mentre la Repubblica di Macedonia
(Fyrom) sta oggi ultimando il suo accesso.
La Bsec è un’organizzazione economica regionale avente uno status giuridico
internazionale, con seggio di osservatore presso le Nazioni Unite e stretti rapporti di collaborazione con la World Bank e il Wto. La sua struttura istituzionale ricalca quella dell’Unione Europea, con un ente preposto a prendere le decisioni
fondamentali (il Consiglio dei ministri degli Affari esteri degli stati membri), una
presidenza a rotazione semestrale, un segretariato permanente (Permis, con sede
a Istanbul), un’assemblea parlamentare (Pabsec, con sede amministrativa a Istanbul, composta da rappresentanti parlamentari degli stati membri che si riuniscono due volte all’anno e prendono decisioni aventi solo potere consultivo) e una
banca (the Black Sea Trade and Development Bank), con sede a Salonicco, dotata di un capitale di 1,45 miliardi di dollari, versato principalmente da Turchia
(16,5%), Grecia (16,5%), Russia (16,5%), Bulgaria (13,5%), Romania (13,5%) e
Ucraina (13,5%) e avente lo scopo di finanziare e promuovere progetti di sviluppo regionale. Affiancano queste istituzioni altri tre enti: il Black Sea Economic
Cooperation Business Council, ente internazionale non-governativo con sede a
1
2
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
6
3
F. TASSINARI, Security and Integration in the EU Neighbourhood. The Case for Regionalism, CEPS
Working Document, Bruxelles 2005, <http://www.shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1251>.
Vedi P. MANOLI, Microregionalism around the Black Sea, in S. BRESLIN - G. HOOK (a cura di),
Microregionalism and World Order, New York 2002; M. AYDIN, Europe’s New Region: The Black Sea in
the Wider Europe Neighbourhood, in «Southeast European and Black Sea Studies», 5, 2005, 2, pp. 257-283.
S. SAYAN - O. ZAIM, The Black Sea Economic Cooperation Project, in L. RITTENBERG (a cura di), The
Political Economy of Turkey in the Post-Soviet Era, Westport 1998, pp. 115-136.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 7
Prove di regionalizzazione nel Mar Nero
Istanbul, composto da rappresentanti delle varie comunità economico-finanziarie degli stati membri, avente funzioni informative nei confronti del Consiglio dei
ministri; l’International Center for Black Sea Studies, un centro studi con sede ad
Atene, avente il compito di presentare soluzioni pratiche su come allargare e intensificare la cooperazione regionale nell’area così come i rapporti tra Bsec e Ue;
e, infine, il Bsec Coordination Center for the Exchange of Statistical Data and
Economic Information, centro di informazione statistica, costituito in seno dell’Istituto nazionale di statistica della Turchia, con sede ad Ankara, avente il compito di creare una base statistica comune fra gli stati membri.
Così come enunciata dai due documenti fondanti della Bsec, la Istanbul La Bsec si propone di favorire la cooperazione
Summit Declaration e il Bosphorus Sta- economica e promuovere le relazioni di buon vicinato
tement (1992), – aggiornati poi dalla e amicizia tra paesi della regione
Charter of the Organization of the Bsec (1998) – la finalità di questa istituzione non
si limita solo ad una cooperazione economica regionale, ma ambisce a trasformare il Mar Nero in «un mare di pace, stabilità e prosperità, impegnandosi per la
promozione di relazioni di buon vicinato e di amicizia»4. Secondo i firmatari della carta istitutiva della Bsec – e in particolare la diplomazia turca – questo progetto di stabilità è pensato per contribuire alla costruzione di una «nuova architettura dell’Europa», in modo cioè da «facilitare il processo e le strutture dell’integrazione europea».
Sebbene l’obiettivo iniziale di creare una zona di libero scambio sia oggi diventato un obiettivo in cui in molti non credono più5, la Bsec continua comunque a sostenere misure volte alla liberalizzazione del commercio nell’area secondo le direttive assunte nell’ambito del Wto. Al fine di realizzare quel mare di pace, stabilità e prosperità, la Bsec è attiva su diversi fronti, tra cui l’armonizzazione del settore bancario e finanziario, la protezione ambientale, lo sviluppo turistico, i trasporti, la lotta all’immigrazione clandestina, alla criminalità organizzata e al traffico illecito di armi, di droghe e di materiale radioattivo.
A più di dieci anni dalla sua nascita, la Bsec stenta però a decollare. Quali sono le cause di questa mancata regionalizzazione del Mar Nero? Nel paragrafo che
segue cercheremo di analizzarle con riferimento agli aspetti di natura geografica,
istituzionale, economica e geopolitica.
I limiti della cooperazione regionale
Un primo problema riguarda la definizione geografica della regione Mar Nero. Così come definita dal capitolo III, art. 6 della Charter of the Organization of
the Black Sea Economic Cooperation, l’adesione alla Bsec è aperta ad ogni stato che
4
5
Black Sea Economic Cooperation (Bsec), Charter,
<http://www.Bsec-organization.org/main.aspx? ID=Charter>.
P. MANOLI, Limiting Integration: Transnational Exchanges and Demands in the BSEC Area, in «Agora
Without Frontiers», 10, 2005, 4, pp. 268-291.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
7
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 8
La partita nel Caucaso
lo desideri e che si impegni ad adempiere ai principi e agli scopi della Bsec stessa. Quali siano dunque i confini territoriali della regione Mar Nero rimane per
statuto nozione sfuggente. Così come nel caso dell’Ue, anche la Bsec non viene
definita in rapporto ad uno spazio geografico preciso, ma in base a criteri di natura politico-economica che lasciano aperto questo spazio a stati che al Mar Nero sono estranei dal punto di vista geografico. L’assenza di un confine geografico
preciso, mentre da una parte echeggia il principio post-moderno di spazi a geometrie variabili, dall’altra però contribuisce ad ostacolare la formazione di una
chiara coscienza regionale, che accompagna ogni processo di region-building.
Dal punto di vista istituzionale, il diverso status giuridico che i paesi Bsec hanno relativamente all’Ue può essere visto come un ulteriore impedimento al processo di regionalizzazione. Nella Bsec vi sono infatti stati membri (Grecia), stati
candidati a far parte dell’Ue (Bulgaria, Romania e, in posizione più incerta, Turchia), stati considerati come potenziali candidati (Serbia e Montenegro, Albania
e Repubblica di Macedonia) e stati che non hanno ancora alcuna prospettiva di
entrarvi (Ucraina, Moldavia, Russia, Georgia, Armenia e Azerbaigian). Dato questo diverso status giuridico, impegni verso una maggiore cooperazione tra i membri Bsec sono ostacolati da obblighi internazionali pregressi. Così, ad esempio, la
firma dell’accordo sulla semplificazione dei visti per cittadini Bsec che si recano
in altri paesi Bsec per motivi d’affari è stata prorogata a tempo indeterminato, dati i problemi nel sottoscriverlo specialmente di Bulgaria e Romania che, essendo
paesi candidati all’accesso all’Ue, hanno obblighi internazionali più stringenti in
materia di visto6. Non solo. Ognuno degli stati Bsec intrattiene con l’Ue rapporti bilaterali che giudica vantaggiosi e che teme di perdere se questi rapporti dovessero passare da bilaterali a multilaterali, qualora il processo di regionalizzazione dovesse intensificarsi e l’Ue trattasse direttamente con la Bsec anziché con i
singoli paesi7. In altre parole, sono gli stessi stati membri della Bsec a frenare
un’accresciuta regionalizzazione dell’area.
Quest’ultimo punto si riflette anche
Oggi la Bsec viene percepita da alcuni suoi membri
sulla finalità stessa della Bsec, la quale
come una tappa intermedia nel percorso destinato
pare percepita dai suoi membri non soa culminare con l’ingresso nella Ue
lo come uno schema di cooperazione
economica regionale, ma soprattutto come un’anticamera per il loro ingresso nell’Ue8. Questa duplice finalità, seppur non contraddittoria in sé, di fatto mina alle
basi lo sviluppo della Bsec, la quale sembra appunto essere vista da alcuni suoi stati membri non come una meta in sé, ma solo come una tappa intermedia di un
percorso la cui destinazione finale si chiama Ue. In altre parole, il fine di mettersi
assieme non pare dettato da un autentico spirito di regionalizzazione, ma dal desiderio di sfruttare uno schema di cooperazione regionale per attrarre l’interesse
dell’Ue ed innescare così iniziative volte all’integrazione europea di questi stati9.
6
7
8
9
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
8
Ibidem, p. 270.
M. AYDIN, Europe’s New Region..., cit., p. 265 e pp. 274-275.
P. MANOLI, Limiting integration..., cit., p. 272.
Secondo alcuni commentatori questa è stata anche la ragione principale che ha spinto la Turchia a dar
vita alla Bsec. Vedi Ö.F. GENÇKAYA, The Black Sea Economic Co-operation Project: A Regional Challenge
to European Integration, in «International Social Science Journal», 45, 1993, 4, pp. 549-557;
S. SAYAN - O. ZAIM, The Black Sea Economic Cooperation Project, cit.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 9
Prove di regionalizzazione nel Mar Nero
Sempre dal punto di vista istituzionale, occorre dire che la Bsec, come riconosciuto dai suoi stessi paesi membri, manca oggi di risorse adeguate, di un’agenda
con chiari e realistici obiettivi e di un’autorità riconosciuta dagli stessi membri.
Riguardo a quest’ultimo punto occorre aggiungere che i meccanismi decisionali
del Consiglio dei ministri della Bsec, finalizzati al raggiungimento di un consenso unanime su ogni argomento, rischiano di spingere anche la Bsec in quella
joint-decision trap che F. W. Scharpf ha analizzato in riferimento all’Ue. Per superare ogni possibile veto, le decisioni vengono cioè prese al minimo comun denominatore, ma questo significa che si tratta di decisioni poco o per nulla incisive
per lo sviluppo dell’istituzione regionale10.
Bisogna inoltre aggiungere che all’interno della Bsec non vi è un paese che eserciti un vero e proprio ruolo-guida, capace di trainare dietro di sé tutti gli altri paesi. Turchia e Grecia sono i paesi maggiormente attivi nello sviluppare la cooperazione regionale nel Mar Nero ma, ad esempio, quando nel primo semestre del
2003 ha avuto la presidenza di turno dell’Ue, la Grecia ha deciso, con sorpresa di
molti paesi membri della Bsec, di non inserire nell’agenda europea il tema del rafforzamento della collaborazione istituzionale tra Ue e Bsec – tema che oggi come
allora costituisce uno dei punti centrali degli sforzi della Bsec11.
Seppur importanti, questi ostacoli sono comunque poca cosa quando confrontati alle ragioni economiche e, soprattutto, geopolitiche che pesano sullo sviluppo della Bsec.
Dal punto di vista economico, l’area della Bsec rappresenta, sulla carta, una regione con grandi potenzialità: circa 350 milioni di persone e oltre 330 miliardi di
dollari all’anno di commercio estero. Di fatto, però, questa regione è afflitta da
forti carenze strutturali che limitano le opportunità commerciali e la rendono poco attraente agli investimenti esteri. Decenni di economia pianificata hanno impedito la nascita di un tessuto di piccole e medie imprese sulle quali basare uno
sviluppo regionale. La scarsa dotazione infrastrutturale (trasporti e telecomunicazioni) – unitamente all’incompatibilità o alla carenza di sostegni finanziari al
commercio estero – non solo non facilita questo sviluppo, ma vanifica anche
quel vantaggio di prossimità geografica che di per sé potrebbe innescare flussi
commerciali intra-regionali12. Questo spiega ad esempio perché, nel 2000, il valore dell’interscambio fra i paesi Bsec è stato di 48 miliardi di dollari ovvero solo
il 16% del commercio estero totale dei paesi Bsec13. La verità è che, dal suo varo,
la Bsec non ha favorito una maggiore dipendenza dei singoli paesi Bsec dal commercio interno all’area regionale stessa. A parte alcuni piccoli stati (Moldavia,
Georgia e Azerbaigian), tutti gli altri – eccezion fatta per l’Ucraina – non sono
particolarmente sensibili agli scambi intra-Bsec. La Turchia, che rappresenta il
paese maggiormente coinvolto nell’interscambio regionale, è però anche il paese
la cui economia, in valori assoluti, è la meno dipendente da questo interscambio
F.W. SCHARPF, The joint-decision trap: Lessons from German Federalism and European Integration, in
«Public Administration», 66, 1988, Autumn, pp. 239-278.
11
M. AYDIN, Europe’s New Region..., cit., p. 282n.
12
S. SAYAN, The Effects of the BSEC on Regional Trade Flows, in «Agora Without Frontiers», 10, 2005, 4,
pp. 334-347.
13
P. MANOLI, Limiting Integration..., cit., p. 276.
10
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
9
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 10
La partita nel Caucaso
(solo il 10% del suo commercio estero dipende dal commercio con l’area Bsec).
I mercati importanti, per tutti i paesi della Bsec, non sono localizzati nell’area, ma
in Europa. Nel 2000, l’interscambio Ue-Bsec ammontava a 140 miliardi di dollari ovvero il 46% del commercio estero della Bsec, ma rappresentava solo il 3% del
commercio estero dell’Ue, a dire della scarsa importanza commerciale di quest’area per l’Ue stessa.
Inoltre, bisogna considerare che anche quel poco di interscambio regionale
che esiste all’interno della Bsec è dominato dal settore energetico (petrolio, gas,
elettricità). Questo significa l’assenza di una divisione regionale del lavoro fra gli
stati dell’area, senza la quale non si ha un vero mercato regionale e conseguenti
domande di governance regionale14.
Non sorprende quindi come la creaL’obiettivo di creare una zona di libero scambio
zione di una zona di libero scambio sia
è rimasto solamente sulla carta
rimasta alla fine un obiettivo solo sulla
carta, di fatto non percepito come strategico dagli stessi membri della Bsec. Ad
eccezione della Turchia, che ha spinto fin dall’inizio per un’integrazione regionale, tutti gli altri paesi Bsec non hanno mostrato particolare interesse ad avviare basi di cooperazione economica regionale, preferendo al contrario accordi bilaterali. La stessa business community presente nell’area non mostra una coscienza regionale, ma rimane fortemente frammentata su scala nazionale.
A ciò si devono aggiungere quelli che abbiamo definito come ostacoli di natura geopolitica, che possono essere analizzati su scala globale, regionale e locale.
Su scala globale, l’area del Mar Nero è oggi il campo principale dove il vincitore della guerra fredda reclama le spoglie del vinto. Dopo l’ingresso nella Nato
di Romania e Bulgaria, il 29 marzo 2004, Ucraina e Georgia paiono infatti possibili candidati in un futuro allargamento della Nato. Gli Stati Uniti premono per
espandere l’Alleanza atlantica ad Est, incontrando le resistenze della Russia. È
chiaro quindi che attorno al Mar Nero si gioca il nuovo confronto Est-Ovest del
post-guerra fredda. L’area del Mar Nero continua cioè oggi a rivestire quel carattere di crush zone15 o shatterbelt16 che l’ha contraddistinta fin dall’inizio del secolo scorso – area caratterizzata da instabilità interna, dove due o più potenze globali si scontrano.
L’importanza per gli Stati Uniti di quest’area, connessa al Caspio e alle sue risorse petrolifere, si può oggi facilmente declinare con l’adattamento della famosa formula geopolitica di Halford Mackinder: «Whoever rules the Persian
Gulf/Caspian Sea region commands the world’s oil; Whoever rules the world’s oil
commands the world economy; Whoever rules the world economy commands
the world»17.
Questa conflittualità su scala globale produce inevitabilmente un clima di tensione anche su scala regionale, fra due dei principali attori dell’area, Russia e Ucrai-
Ibidem, p. 280.
J. FAIRGRIEVE, Geography and World Power, London 1915.
16
S.B. COHEN, Geography and Politics in a World Divided, London 1964.
17
J. O’LOUGHLIN, The Political Geography of Conflict: Civil Wars and Hegemonic Shadow, in C. FLINT
(a cura di), The Geographies of War, New York 2004.
14
15
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
10
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 11
Prove di regionalizzazione nel Mar Nero
na. Nonostante la risoluzione pacifica degli scottanti problemi della ripartizione
della flotta sovietica e delle basi militari del Mar Nero, gli attuali passi dell’Ucraina verso una piena adesione all’alleanza euro-atlantica non possono non mettere
in allarme il Cremlino, che sembra disposto ad usare la sua arma oggi più efficace, la fornitura di energia allo spazio ex sovietico e all’Occidente, per condizionare il destino dell’allargamento euro-atlantico. La Turchia, il terzo attore regionale
nell’area, ha cercato di svolgere il ruolo di pacificatore in questo mare di tensioni,
sfruttando lo spirito di collaborazione avviato con la Istanbul Summit Declaration
e il Bosphorus Statement e dando così vita, nell’aprile 2001, al Black Sea Naval Cooperation Task Group (Blackseafor). Formato da Turchia, Russia, Ucraina, Romania, Bulgaria e Georgia, Blackseafor non è un’alleanza militare a carattere difensivo o offensivo, ma semplicemente un’iniziativa diplomatico-militare per fronteggiare emergenze umanitarie e ambientali nel Mar Nero, oltre che per favorire visite reciproche fra le diverse marine militari. Sebbene positiva, pare improbabile
che una simile azione possa disinnescare tensioni geopolitiche che rimandano ad
uno scontro su scala più ampia.
Su scala locale, infine, occorre osservare come tutto attorno al Mar Nero, da
Ovest ad Est, l’area sia costellata da profonde rivalità e, in alcuni casi, anche da
aperti conflitti militari tra gli stati membri della Bsec.
Al di là delle tensioni tra Grecia e Albania e del contenzioso tra Grecia e Repubblica di Macedonia sul nome di quest’ultima, anche i rapporti tra Grecia e Turchia
rimangono tesi, a causa della questione di Cipro. La Transnistria, la regione separatista della Moldavia abitata in larga parte da una popolazione di lingua russa e
le cui attività criminose internazionali alimentano una forte instabilità regionale,
genera a sua volta tensioni tra la Moldavia stessa, la Russia e la Romania. Nel Caucaso, la guerra tra Armenia e Azerbaigian per l’Alto Karabakh – guerra che l’esistenza della Bsec è stata incapace di frenare – continua a pesare nei rapporti diplomatici tra questi due stati, che di fatto sono pressoché inesistenti: la frontiera è
chiusa e le migliaia di sfollati azeri ospitati in campi profughi in Azerbaigian continuano ad avanzare bellicosi progetti revanscisti. Frontiera chiusa anche tra Turchia e Armenia, con l’Armenia che preme affinché la Turchia riconosca il genocidio perpetrato contro gli armeni all’inizio del secolo scorso e con la Turchia pronta a giudicare in tribunale per vilipendio alla nazione ogni turco che riconosca
questo genocidio pubblicamente. Seppur non in lotta contro altri stati dell’area, la
Georgia rimane comunque impegnata a contenere le spinte separatistiche di regioni come l’Ossetia e l’Abkhazia, alimentate dalla Russia, che, a propria volta, ha
il suo bel da fare nel contenere in particolare il separatismo ceceno.
Da notare che la presenza della stessa Russia nella Bsec può essere vista anche
come un’ulteriore spiegazione del mancato decollo della Bsec. Usciti da decenni
di dominio sovietico, i paesi dell’area temono infatti che una regionalizzazione
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
11
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 12
La partita nel Caucaso
del Mar Nero, sebbene proposta dai turchi, possa aprire le porte ad una nuova
egemonia russa18.
Entro un simile scenario geopolitico pensare che il Mar Nero possa diventare
una regione vera e propria pare quanto mai azzardato. Eppure, nelle intenzioni dei
suoi promotori, la Bsec vuole essere anche una risposta all’instabilità geopolitica di
quest’area19. Non è un caso che uno fra i pochi forum di incontro tra Armenia e Turchia e tra Armenia e Azerbaigian sia costituito oggi proprio dalla Bsec.
L’Unione Europea e il Mar Nero
Nonostante l’Ue rappresenti il principale partner commerciale dei paesi
Bsec oltre che, per molti di questi paesi, la meta finale di ogni regionalizzazione nell’area, Bruxelles ha finora mostrato un atteggiamento distaccato verso
questa istituzione regionale, privilegiando meccanismi di cooperazione bilaterale20. Seppur non invisi ai paesi Bsec stessi, questi accordi bilaterali contribuiscono però indirettamente a frenare lo sviluppo in senso regionale dell’area del
Mar Nero.
Dal punto di vista geostrategico, quest’area è importante per l’Ue essenzialmente sotto due aspetti tra loro correlati: trasporti ed energia. Il Mar Nero può
essere infatti visto come una piattaforma logistica per i trasporti tra i paesi Ue
e quelli dell’Asia centrale ed orientale. Di fatto, questa valenza logistica del Mar
Nero è già stata presa in considerazione dalla Commissione europea, che, nella sua politica dei trasporti, ha incluso appunto il Bacino del Mar Nero – unitamente all’Area euro-artica e di Barents, l’area del bacino mediterraneo e
l’area dei mari Adriatico e Ionio – nelle cosiddette Pan European Transport Areas
(PETrAs).
Dopo il Golfo Persico, l’area del Mar
Il Mar Nero è il naturale ponte tra l’Ue e l’Asia centrale Nero-Caspio è la seconda fonte di pee orientale oltre che una primaria fonte di risorse
trolio al mondo e a tutt’oggi circa il
26% del fabbisogno dell’Ue proviene
energetiche
da quest’area21. Oleodotti (e gasdotti – essendo la Russia il primo produttore di
gas naturale al mondo) attraversano l’area eurasiatica e su quali debbano essere i
percorsi di queste pipelines si confrontano gli interessi di grandi multinazionali,
spalleggiate da attori statuali regionali e globali.
In termini geopolitici, questa rete di oleodotti, gasdotti, corridoi e aree paneuropee di trasporto che va dal Mar Nero all’Europa occidentale, in parte attraverso i Balcani, ha spinto alcuni commentatori a coniare il cosiddetto schema
geopolitico dei “Tre Mari” (Mar Caspio, Mar Nero, Mar Adriatico) – schema particolarmente caro a coloro i quali in Italia premono per dare all’Adriatico (e alle
P. MANOLI, Limiting Integration..., cit., p. 291.
M. AYDIN, Europe’s New Region..., cit., p. 263.
20
P. MANOLI, Bringing the Black Sea Economic Cooperation and the European Union Closer, in
«Southeast European and Black Sea Studies», 5, 2005, 2, pp. 167-169.
21
European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Energy and Transport in Figures,
2004, <http://www.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/2004_en.htm>.
18
19
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
12
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 13
Prove di regionalizzazione nel Mar Nero
regioni italiane che vi si affacciano) un ruolo privilegiato nella stabilizzazione
e nello sviluppo della penisola balcanica22.
Nonostante il grande interesse geostrategico che l’area del Mar Nero-Caspio riveste per l’Ue e nonostante gli inviti fatti ripetutamente dal Consiglio dei ministri
della Bsec affinché la Commissione europea entri a far parte della Bsec in qualità
di membro osservatore, Bruxelles ha finora mantenuto un atteggiamento molto
cauto verso un impegno multilaterale nella regione. Il fatto che quest’area sia segnata a tutt’oggi da un’accesa rivalità tra due pesi massimi come Russia e Stati Uniti può forse aver scoraggiato un intervento più deciso da parte dell’Ue, la quale di
fatto è priva di una strategia chiara verso quest’area23. La recente adozione della Politica europea di Vicinato (Pev), seppur creata nel 2003 per dare all’Ue una visione di politica estera coerente ed organica per tutta l’area di vicinato, non sembra
comunque aver risolto la contraddizione fondamentale che attanaglia l’Ue come
attore internazionale, ovvero il nesso interno/esterno: l’incapacità di decidere chi
è fuori e chi è dentro – nesso che, nonostante le dottrine post-moderne e postwestfaliane, continua a rimanere il principio guida del “politico” nell’ambito delle relazioni internazionali. La Pev non esclude infatti che la partnership possa tramutarsi in membership, vanificando quindi l’obiettivo stesso della Pev, concepita
appunto per gestire lo spazio extracomunitario.
Oggi l’Ue ha accordi bilaterali con
tutti i paesi Bsec, ma c’è chi chiede che L’Ue mantiene un atteggiamento prudente nei confronti
dagli accordi bilaterali di partnership della Bsec continuando a prediligere accordi
si passi ad accordi di stabilizzazione e su base bilaterale
associazione, come quelli firmati dall’Ue con i paesi membri del Patto di stabilità per l’Europa del Sud-Est e che aprono potenzialmente le porte ad un ingresso nella Ue24.
A tutt’oggi l’Ue nicchia, continuando a procrastinare un suo impegno più
chiaro in quest’area e di fatto lasciando cadere le richieste Bsec di dar vita a una
nuova “dimensione” regionale per il Mar Nero da affiancare alla Northern Dimension e alla dimensione euro-mediterranea.
Un maggior coinvolgimento dell’Ue nella regionalizzazione dell’area del Mar
Nero, capace di trasformare quest’ultimo da spazio-frontiera a spazio-ponte25,
potrebbe però contribuire a disinnescare pericolose politiche di esclusione, a
danno soprattutto della Russia, portate avanti da chi, attore esterno all’area, gli
Stati Uniti, ha interessi diversi da quelli europei.
M. ANTONSICH, Il Nord-Est tra Mitteleuropa e Balcani: il caso del Friuli-Venezia Giulia, in AA.VV.,
Geopolitica della crisi. Balcani, Caucaso e Asia Centrale nel nuovo scenario internazionale, Milano 2002,
pp. 141-249. Il fatto che Grecia, Albania, Serbia e Montenegro facciano parte della Bsec di fatto
orienta geopoliticamente la regione del Mar Nero più verso i Balcani che verso il Mediterraneo.
23
A. FERRARI, Il Caucaso e l’Europa. Una prospettiva storica, ISPI Policy Brief, n. 14, febbraio 2005,
<http://www.ispionline.it/it/documents/pb_14_2005.pdf>.
24
P. GAVRAS, The Black Sea and the European Union: Developing Relations and Expanding Institutional
Links, in «Southeast European and Black Sea Studies», 4, 2004, 1, pp. 23-48.
25
AA. VV., The Black Sea as Boundary or Bridge? Implications of EU and NATO Enlargement and the
Regional Security, SIPRI Seminar Report, Stockholm 2003, <http://www.sipri.org/contents/conflict/
BlackSeaPaper2.doc.pdf>.
22
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
13
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 14
La partita nel Caucaso
Conclusione
Sebbene oggi un processo di regionalizzazione esista nell’area del Mar Nero,
questo processo sembra essere vittima dell’ambiguità con cui la Bsec, la principale
istituzione regionale nell’area, è nata: alternativa all’Ue, in un autentico spirito di
regionalizzazione, oppure cavallo di Troia per poter penetrare in Europa?
Dato lo scarso coinvolgimento dei paesi dell’area negli schemi di cooperazione regionale proposti dalla Bsec e le dichiarate volontà di questi paesi – ad eccezione di Russia e, in maniera più ambigua, Azerbaigian – di voler aderire all’Ue,
la seconda ipotesi sembra oggi prevalere.
La regionalizzazione nel Mar Nero, per quanto limitata, non è perciò fine a se
stessa, ma è un surrogato di una cooperazione con l’Ue che si spera un domani
possa aprire le porte ad una piena integrazione.
Nonostante quasi quindici anni di esistenza, la Bsec non è stata ancora in grado di trasformare il Mar Nero in un mare di pace, stabilità e prosperità, così come si era ripromessa nel 1992.
Ostacoli di natura infrastrutturale,
La volontà di pervenire ad una piena integrazione nella assenza di adeguati meccanismi deciUe ha oscurato l’originario spirito di regionalizzazione
sionali, scarsità di piccole e medie imdella Bsec
prese che possano attivare lo sviluppo
economico, tensioni geopolitiche su scala locale, regionale e globale contribuiscono ancora oggi a frenare il processo di region-building nell’area del Mar Nero.
Il ruolo di attore regionale della Turchia che, assieme alla Grecia, spinge per
una maggiore cooperazione regionale non è da solo sufficiente ad innescare meccanismi virtuosi di collaborazione istituzionale. Pesa su questo tentativo anche
l’ambiguo status “europeo” della Turchia agli occhi di Bruxelles. Questo, unitamente ai timori di intervenire in un’area gravata da forti conflittualità locali e dove è anche in corso lo scontro freddo tra Russia e Stati Uniti per l’allargamento
dell’Alleanza atlantica, ha di fatto spinto l’Ue ad adottare un basso profilo nei
confronti della Bsec e del processo di regionalizzazione dell’area. Tuttavia, un
ruolo più incisivo di Bruxelles nel processo di region-building potrebbe disinnescare il pericoloso scenario che va oggi profilandosi, sulla scorta della politica statunitense, di escludere la Russia da uno scacchiere geopolitico ritenuto fondamentale da Mosca. Il futuro dell’Ue come attore di politica internazionale e della sua Pev passa quindi anche da come saprà affrontare la sfida della regionalizzazione del Mar Nero che, dal 2007, con l’ingresso di Romania e Bulgaria, diventerà la nuova frontiera dell’Europa.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
14
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 15
Georgia, Armenia e Azerbaigian. Pedine del nuovo “Grande Gioco”?
Aldo Ferrari
Georgia, Armenia e Azerbaigian.
Pedine del nuovo “Grande Gioco”?
Introduzione
Secondo la maggior parte degli analisti, la competizione politica, strategica ed
economica tra Stati Uniti e Russia nei paesi post-sovietici del Caucaso (e dell’Asia
centrale) costituisce il dato saliente delle dinamiche dell’intera regione1. Una
competizione reale anche se non cruenta, che riprende alcuni aspetti del great game di kiplinghiana memoria, vale a dire la lunga rivalità tra Russia e Gran Bretagna per le regioni a cavallo tra i rispettivi imperi. La suggestione di questo parallelo storico non deve però condizionare oltre misura l’analisi della situazione
odierna, che è determinata da fattori in larga parte differenti da quelli ottocenteschi. In particolare, occorre tener presente la pluralità di agenti statuali locali
(Georgia, Armenia, Azerbaigian, Turchia, Iran), super-statuali (l’Unione Europea
in primo luogo, ma anche Nato, Osce, Guuam) e sub-statuali (multinazionali,
Ong, lobbies di vario tipo, diaspore e così via) che interagiscono a livelli diversi
nella regione2.
In particolare, le prospettive delle tre repubbliche transcaucasiche – Georgia,
Armenia e Azerbaigian, divenute indipendenti dopo la dissoluzione dell’Urss –
sono solo in parte riconducibili alla rivalità geopolitica tra Stati Uniti e Russia.
ALDO FERRARI insegna
Lingua e letteratura
armena all’Università
Ca’ Foscari di Venezia
ed è responsabile del
Programma di ricerca
Caucaso - Asia centrale
dell’ISPI.
La Georgia: sognando l’Occidente
La Georgia post-sovietica è caratterizzata da due dinamiche fondamentali: la
crisi dei rapporti con le minoranze nazionali al suo interno e la forte propensione ad uscire dall’orbita russa per avvicinarsi all’Occidente.
Secondo il censimento sovietico del 1989, le minoranze nazionali – russi,
armeni, azeri, abkhazi, osseti ed altri – costituivano il 30% degli abitanti della
Georgia. Due di queste popolazioni, gli osseti e gli abkhazi, erano titolari rispettivamente di una regione e di una repubblica autonoma. A Sud-Ovest, al confine
con la Turchia, un’altra repubblica autonoma – l’Agiaria, abitata da georgiani prevalentemente musulmani – ha mantenuto per una decina d’anni una sorta di indipendenza ufficiosa da Tbilisi. A Sud-Est, al confine con l’Armenia, la regione
della Javakheti, abitata in maggioranza da armeni, si trova in una situazione di
perdurante tensione, pur senza arrivare ad una esplicita rivendicazione separatista. Durante la breve e convulsa presidenza di Zviad Gamsakhurdia (1991-1992)
1
2
Per uno sguardo più vasto sulle dinamiche di questa regione rimando al mio Il Caucaso. Popoli e
conflitti di una frontiera europea, Roma 2005.
M. EDWARDS, The New Great Game and the New Great Gamers: Disciples of Kipling and Mackinder,
in «Central Asian Survey», 22, 2003, 1, pp. 83-102.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
15
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 16
La partita nel Caucaso
Tbilisi si rifiutò di aderire alla Comunità degli stati indipendenti (Csi) e portò
avanti una politica micro-imperiale ostile sia alla Russia che alle autonomie delle minoranze etniche presenti sul suo territorio3. Osseti e abkhazi riuscirono a
rendersi de facto indipendenti dopo brevi ma violenti conflitti nel periodo 19921993, grazie all’aiuto sia di volontari caucasici (nel caso dell’Abkhazia) sia della
Russia, peraltro in forma non ufficiale. Oltre 150.000 georgiani vennero espulsi
dalla regione. Nei primi mesi del 1992 un colpo di stato estromise dal potere
Gamsakhurdia e al suo posto venne eletto l’ex ministro degli esteri di Gorbachev,
Eduard Shevarnadze, che nell’ottobre 1993 firmò il decreto di adesione alla Csi.
Dal 1994 truppe della Csi a guida russa sono interposte tra abkhazi e georgiani.
Nell’Ossetia meridionale le cose sono andate in maniera analoga, con violenti
scontri tra i georgiani e gli osseti locali, che chiedevano l’unificazione con la Repubblica dell’Ossetia settentrionale. Anche qui sono forze militari russe che da allora separano le due popolazioni.
Né la sconfitta nei conflitti con i seLa Georgia è stretta tra la duplice esigenza di risolvere la cessionisti abkhazi e osseti né la graviscrisi dei rapporti con le minoranze nazionali interne e di sima situazione economica in cui è precipitata la Georgia hanno però modififuoriuscire dall’orbita russa
cato la sua aspirazione a fuoriuscire dall’orbita russa e ad avvicinarsi all’Occidente. In questi anni post-sovietici la Georgia, o almeno la sua élite, ha in effetti coltivato con ostinazione il progetto di un completo distacco dalla Russia e di ingresso in Europa che sembra derivare da una sorta di fideistica attesa di una salvezza
provvidenziale, proveniente dall’esterno, dal lontano Occidente4.
In effetti l’orientamento filo-occidentale della Georgia si è dimostrato in larga misura in contrasto con le realtà geopolitiche. Non solo con la volontà di Mosca di mantenere un ruolo attivo nella regione transcaucasica, ma anche con lo
scarso interesse che l’Europa ha mostrato concretamente nei suoi confronti sino
a poco tempo fa. È per questa ragione che la Georgia ha individuato nell’inserimento nella Nato il primo e più importante passo verso Occidente, nella speranza che l’avvicinamento militare potesse accelerare l’integrazione del paese con le
strutture europee5. Tuttavia l’ostilità russa e la prudenza della Nato hanno sinora impedito che questa aspirazione georgiana venisse accolta.
Da un punto di vista economico, la scelta filo-occidentale ha indotto la Georgia ad appoggiare sin dal 1995 la richiesta degli Stati Uniti per la creazione di vie
di transito energetico che passino sul suo territorio ed escludano la Russia. In
questo senso Shevarnadze si è mostrato meno accondiscendente alle richieste
russe di quanto fosse inizialmente lecito attendersi. Sotto la sua guida la Georgia
ha mantenuto in effetti un atteggiamento oscillante tra la propensione filooccidentale e la necessità di non irritare ulteriormente il grande vicino settentrionale, militarmente minaccioso e dal quale dipendono largamente le forniture
3
4
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
16
5
O. VASILIEVA, La Georgia quale modello di piccolo impero, in C.M. SANTORO (a cura di),
Nazionalismo e sviluppo politico nell’ex Urss, Milano 1995, p. 213.
A. ZUBOV, Il futuro politico del Caucaso, in P. SINATTI (a cura di), La Russia e i conflitti nel Caucaso,
Torino 2001, p. 68.
K.S. GADÎIEV, Geopolitika Kavkaza, Moskva 2001, p. 381.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 17
Georgia, Armenia e Azerbaigian. Pedine del nuovo “Grande Gioco”?
energetiche del paese, soprattutto per quel che riguarda il gas e l’elettricità. In particolare, un trattato bilaterale del 1995 diede alla Russia il diritto a mantenere per
25 anni le quattro basi presenti sul territorio georgiano6. A parte quella di Vaziani, situata nei pressi di Tbilisi, le altre basi russe si trovavano proprio in regioni
più o meno fuori del controllo del governo centrale come l’Agiaria e l’Abkhazia,
oppure abitate da una minoranza nazionale, come quella di Akhalkalaki, in Javakheti. In questi anni la Georgia è entrata a far parte, insieme ad Azerbaigian,
Ucraina, Uzbekistan e Moldavia del Guuam, vale a dire dell’associazione promossa dagli Stati Uniti per controbilanciare l’egemonia russa nella Csi. Tbilisi si è anche avvicinata all’Unione Europea, sottoscrivendo nel 1996 l’accordo di partenariato e cooperazione e divenendo nel 1999 membro del Consiglio d’Europa.
Le scelte politico-economiche di Tbilisi hanno cominciato a portare qualche
frutto visibile a partire dal 1999, quando è stato inaugurato l’oleodotto che da Baku porta il petrolio a Supsa, sul litorale georgiano del Mar Nero, ponendo così fine all’egemonia russa sull’esportazione del petrolio caspico. Nello stesso anno la
Georgia ha denunciato il trattato di sicurezza collettiva della Csi, avvicinandosi
ulteriormente alla Nato e, durante il vertice Osce di Istanbul, Tbilisi e Mosca
hanno firmato un nuovo trattato per la graduale riduzione della presenza militare russa in questo paese. Negli anni successivi si è verificato peraltro un peggioramento dei rapporti russo-georgiani, soprattutto in seguito alla decisione di
Mosca di introdurre un regime di visti obbligatori. Una ulteriore fonte di attrito
è data dal fatto che la Russia accusava Tbilisi di appoggiare, almeno passivamente, i guerriglieri ceceni, in particolare dando loro ospitalità nella valle di Pankisi,
nel Nord della Georgia. Nel frattempo, nonostante la crescente insoddisfazione
popolare nei suoi confronti, dovuta soprattutto al permanere di una situazione
economica più che precaria, nel 2000 Shevarnadze venne rieletto presidente, continuando a barcamenarsi alla meglio tra Russia e Stati Uniti.
Il mutamento dello scenario interDopo l’11 settembre, con l’avvio del Train and Equip
nazionale seguito all’11 settembre
2001 ha coinvolto in misura notevole Program, gli Stati Uniti hanno stabilito una propria
anche la Georgia. Sin dal febbraio presenza militare in Georgia
2002, infatti, Washington ha inviato in questa repubblica un contingente militare, sia pur limitato (200 uomini) e preposto all’addestramento anti-terroristico
(Train and Equip Program). Il dispiegamento di militari statunitensi in Georgia è
seguito alla “scoperta” di militanti di al-Qaeda proprio nella valle di Pankisi. Nonostante Putin abbia cercato di far buon viso a cattivo gioco dichiarando che l’arrivo di militari statunitensi in Georgia non preoccupa il governo russo, tale fatto
– che segue di poco il loro più consistente dislocamento nelle repubbliche centroasiatiche ex sovietiche – ha un significato strategico molto preoccupante per la
Russia. La presenza di militari statunitensi in Georgia collide infatti con la dottri-
6
Su questo argomento si veda il mio Georgia e Russia. Un’amicizia senza basi, ISPI
Policy Brief, n. 4, marzo 2004, <http://www.ispionline.it/it/documents/pb_4_2004.pdf>.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
17
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 18
La partita nel Caucaso
na strategica, affermata a partire dalla fine del 1993, secondo la quale Mosca rivendica funzioni di peacekeeping e mantenimento della stabilità nel territorio dell’intera Csi e la formazione di una fascia di “buon vicinato” lungo i confini russi7. La
presenza americana in Georgia costituisce inoltre un fattore inquietante per larga
parte dell’opinione pubblica russa, nonché per i vertici militari. Da parte russa
si sospettava infatti non solo che questi istruttori potessero addestrare le truppe
georgiane in vista di una riconquista di Abkhazia e Ossetia meridionale, ma anche
che – nonostante le smentite ufficiali di Washington – l’operazione costituisse un
primo passo per l’insediamento stabile di truppe statunitensi nella regione.
I rapporti russo-georgiani hanno avuto un picco di crisi nell’agosto 2002,
quando Mosca giunse a minacciare un’azione militare. Un incontro tra Putin e
Shevarnadze nell’ottobre dello stesso anno, nel quale venne raggiunto un accordo sul controllo congiunto della valle di Pankisi per contrastare lo sconfinamento in Russia di guerriglieri ceceni, sembrò migliorare la situazione. Shevarnadze
si spinse a definire la Russia uno dei due principali partner strategici del suo paese, ovviamente insieme agli Stati Uniti. Tale dichiarazione, peraltro, suscitò immediatamente le reazioni negative degli oppositori del presidente, che vi lessero
un pericoloso cedimento alle pressioni russe.
La politica di equilibrio tra Russia e Occidente condotta da Shevarnadze risultava ormai insoddisfacente sia verso l’interno che verso l’esterno. Mentre in Russia la sempre più stretta cooperazione militare di Tbilisi con gli Stati Uniti e
l’esplicito appoggio alla guerra in Iraq suscitavano una crescente irritazione, per
altri aspetti Shevarnadze appariva a Washington troppo cedevole nei confronti di
Mosca. Un’impressione rafforzatasi nei mesi seguenti, quando la Georgia cedette alla Russia il controllo pressoché totale dell’energia elettrica del paese. Nel 2003
la popolarità di Shevarnadze era ormai al minimo, soprattutto alla luce di una situazione economica sempre difficilissima. A partire dalle elezioni locali, che si
svolsero il 2 giugno in un’atmosfera di disordine e violenza, il potere dell’anziano presidente iniziò a sgretolarsi rapidamente. Gli Stati Uniti cominciarono ad
appoggiare apertamente i suoi oppositori (soprattutto con i finanziamenti di
George Soros a movimenti giovanili e reti televisive)8. La cosiddetta “rivoluzione
delle rose” è stata guidata principalmente da persone di netto orientamento filooccidentale, come Nino Burjanadze, Zurab Zhvania e soprattutto Mikheil
Saakashvili, impostosi come la figura dominante dell’opposizione. Dopo le elezioni parlamentari del 2 novembre, che avevano visto la contestata vittoria delle
forze filo-presidenziali, la situazione è sfuggita di mano a Shevarnadze, costretto
alle dimissioni. Dopo una presidenza pro tempore di Nino Burjanadaze, le elezioni del 4 gennaio 2004 hanno visto il trionfo di Saakashvili, che ha ottenuto il
97,5% dei voti. Stranamente, tale percentuale “bulgara” non sembra aver destato
particolari sospetti tra i commentatori internazionali. La “rivoluzione delle rose”
7
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
18
8
D. DANILOV, Russia’s Search for an International Mandate in Transcaucasia, in B. COPPETIERS
(a cura di), Contested Borders in the Caucasus, Brusselles 1996,
<http//poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/chosol.htm>.
P. SINATTI, La Georgia tra Mosca e Washington, in «Limes. Rivista di geopolitica», 2004, 1, p. 292.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 19
Georgia, Armenia e Azerbaigian. Pedine del nuovo “Grande Gioco”?
georgiana ha in effetti ricevuto una notevole apertura di credito da parte dell’Occidente, inaugurando il processo di cambiamento geopolitico proseguito in
Ucraina e, sinora con minor successo, in Kirghizistan e Moldavia.
Questa evoluzione politica della
La “rivoluzione delle rose” ha visto l’ascesa al potere
Georgia è avvenuta indubbiamente
con il favore ed il sostegno degli Stati di un’élite apertamente filo-occidentale
Uniti. Washington appare infatti intenzionata a fare della Georgia il paese chiave
del suo ridispiegamento strategico e militare nella regione caucasica, il punto
di partenza del processo di transizione egemonica che sta avendo luogo nella
Transcaucasia nonostante l’opposizione della Russia9. Si tratta comunque di un
processo non esente da rischi. Il più immediato può provenire dalla tentazione, oggi forte a Tbilisi, di sfruttare l’appoggio statunitense per porre fine in maniera violenta alla virtuale indipendenza delle repubbliche secessioniste. La riconquista del
territorio nazionale, che faceva parte del programma elettorale di Saakashvili, è
iniziata in Agiaria, il cui presidente, Abashidze, nel maggio 2004 è stato costretto
a rifugiarsi in Russia. Va però tenuto presente che, per quanto prevalentemente
musulmani, gli abitanti dell’Agiaria sono georgiani e non hanno nei confronti di
Tbilisi la forte ostilità di abkhazi e osseti. La partita per riprendere il controllo dei
territori abitati da queste ultime popolazioni potrebbe quindi risultare più difficile e foriera di gravi complicazioni internazionali. Tuttavia la determinazione di
Saakashvili a proseguire in questa direzione è fuori questione. Poco dopo aver vinto la partita in Agiaria, il presidente georgiano ha iniziato quella in Ossetia meridionale. Nell’estate 2004 la tensione in questa regione portò ad una serie di incidenti frontalieri, scaramucce ed accuse reciproche tra le parti e non è escluso che
nell’immediato futuro possa precipitare verso un vero e proprio scenario di guerra.
Per quel che riguarda l’Abkhazia, la Georgia ha reso noto un nuovo piano di
pace che prevede la creazione di una federazione al cui interno Sukhumi conserverebbe una vasta autonomia. In cambio della definitiva rinuncia all’indipendenza, l’Abkhazia manterrebbe quasi tutti i diritti sovrani, lasciando a Tbilisi solo la
politica estera, la difesa, il controllo doganale e la lotta al crimine. Ai profughi
georgiani verrebbe concesso un ritorno graduale e volontario. Tuttavia, sembra
improbabile che gli abkhazi accettino la perdita della loro sostanziale indipendenza sinché la Russia continuerà a sostenerli. La sconfitta del candidato appoggiato da Mosca – Raul Khajimba – alle elezioni presidenziali del gennaio 2005 costituisce peraltro un segnale importante, anche se al momento appare improbabile che il vincitore, Sergei Bagapsh, possa rovesciare l’orientamento politico del
suo paese. Va anche considerato che da un punto di vista economico tanto l’Abkhazia quanto l’Ossetia meridionale sono completamente dipendenti dalla Russia, verso la quale è orientato in maniera pressoché esclusiva il loro commercio
dopo la rottura con Tbilisi. La stessa presenza delle basi militari russe supporta
9
Su questo tema si veda il mio La Georgia tra Federazione Russa e Stati Uniti: un modello di transizione
egemonica?, in A. COLOMBO (a cura di), La sfida americana. Europa, Medio Oriente e Asia Orientale
di fronte all’egemonia globale degli Stati Uniti, Ricerca CeMiSS/ISPI, Milano 2006, pp. 56-78.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
19
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 20
La partita nel Caucaso
in maniera consistente l’economia locale di queste repubbliche ed una loro chiusura avrebbe esiti molto negativi a livello occupazionale. In effetti, la prospettiva
di ritornare sotto il controllo di Tbilisi sembra essere sia politicamente che economicamente poco allettante per Abkhazia e Ossetia meridionale.
L’intensificazione delle rivendicazioni georgiane su queste regioni ha inoltre
ravvivato la prospettiva di un loro incorporamento nella Federazione Russa. Più
volte sollecitata dai dirigenti di Abkhazia e Ossetia meridionale, questa sorta di
annessione di territori giuridicamente appartenenti alla Georgia sembra peraltro
scarsamente praticabile, soprattutto alla luce delle forti ripercussioni interne ed
internazionali che un’operazione del genere potrebbe avere. Mosca appare ancora intenzionata a sostenere l’ufficiosa indipendenza di queste repubbliche da Tbilisi, ma la questione è di comprendere sino a che punto possa arrivare tale protezione di fronte all’evidente volontà georgiana di risolvere a proprio favore la partita, nella sicurezza di avere l’appoggio degli Stati Uniti. In effetti la situazione in
Georgia diverrebbe estremamente pericolosa se si acutizzasse la rivalità tra la
Russia e gli Stati Uniti per il controllo di questo paese sfruttandone le tensioni interne. Un ulteriore dispiegamento militare statunitense, magari con l’obiettivo di
difendere il nuovo oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, inaugurato alla fine del maggio 2005, confermerebbe i timori russi sulla volontà di Washington di insediarsi
stabilmente nel Caucaso e potrebbe inasprire la situazione. L’invito alla prudenza rivolto da uno specialista statunitense appare pertanto del tutto condivisibile:
«Gli Stati Uniti dovrebbero adesso aiutare la nuova leadership della Georgia
a pensare creativamente riguardo alle questioni fondamentali della sovranità, del
controllo territoriale e del quadro istituzionale. Il governo centrale deve riconoscere la realtà multietnica e multireligiosa del paese e accettare un decennio di
state-building nelle regioni secessioniste, permettendo la creazione di un governo locale. Se questi sforzi avranno successo, la Georgia potrebbe davvero diventare quell’esempio positivo per l’Europa orientale e l’Eurasia che gli osservatori
hanno tanto a lungo atteso»10.
È auspicabile che tale prudenza animi peraltro anche i policy-makers di Washington, mentre da parte di Mosca è fondamentale che si riconosca definitivamente la sovranità della Georgia, rinunciando ad intromettersi nei suoi affari interni. Il raggiungimento di un accordo per la definitiva chiusura delle basi russe
in questa repubblica entro la fine del 2008 sembra essere un passo sostanziale in
questa direzione.
Pur nell’effettivo contrasto di interessi tra Russia e Stati Uniti, è in effetti possibile che si giunga ad un accordo tra la superpotenza globale e quella regionale,
sbloccando così la situazione politica della Georgia, che ne ha sinora pregiudicato
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
20
10
C. KING, A Rose Among Thorns. Georgia Makes Good, in «Foreign Affairs», 83, 2004, 2, p. 18.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 21
Georgia, Armenia e Azerbaigian. Pedine del nuovo “Grande Gioco”?
lo sviluppo. Un altro aspetto rilevante
La politica estera georgiana pare finalizzata a superare
della politica della nuova dirigenza
georgiana sembra essere l’accresciuto l’antinomia Russia/Usa a favore di un triangolo strategico
interesse per l’Europa, dimostrato sin che includa l’Ue
dalla nomina a ministro degli esteri di Salome Zurabishvili, in precedenza ambasciatrice di Francia a Tbilisi. La politica estera georgiana appare in effetti intenzionata a superare l’antinomia Russia/Usa a favore di una sorta di triangolo strategico che prevede anche l’Unione Europea, in prospettiva con un ruolo persino più
importante. Per la sua posizione geografica e l’accentuata propensione occidentale ed europea, la Georgia potrebbe in effetti divenire il motore dell’avvicinamento
economico e politico della regione all’Unione Europea. La svolta della politica europea nei confronti delle tre repubbliche della Transcaucasia, entrate nel giugno
2004 a far parte della Politica europea di Vicinato, è in larga misura collegata proprio all’evoluzione della situazione in Georgia11.
L’Armenia: la politica del “doppio binario”
Minuscola, priva di sbocco sul mare e di risorse energetiche, l’Armenia ha sofferto in modo particolare la rottura delle relazioni economiche dell’epoca sovietica, durante la quale questa repubblica era tra le più sviluppate. Soprattutto le sue
industrie ne sono state fortemente penalizzate. A questa difficile situazione economica va aggiunta una collocazione geopolitica particolarmente difficile. Alla
frontiera meridionale dell’Armenia si trova infatti la Turchia – erede di quell’Impero ottomano che annientò la comunità armena nei territori anatolici – che continua ancora oggi a negare il genocidio. La presenza di questo vicino minaccioso
rende particolarmente grave il contrasto dell’Armenia con l’altro paese transcaucasico confinante, l’Azerbaigian turco e musulmano, provocato dal conflitto per
l’Alto Karabakh. Gli scontri tra armeni e azeri per questa regione a larga maggioranza armena erano iniziati già negli ultimi anni del periodo sovietico. Dopo la
dissoluzione dell’Urss e la costituzione della Csi, il 2 dicembre 1991 la popolazione armena dell’Alto Karabakh approvò con un plebiscito l’indipendenza della regione, denominata Repubblica armena dell’Artsakh. Gli scontri armeno-azeri si
trasformarono allora in una guerra aperta. Benché, almeno ufficialmente, il conflitto coinvolgesse solo gli armeni dell’Alto Karabakh e non quelli della Repubblica armena, la Turchia chiuse la frontiera con Erevan, minacciando anche di intervenire militarmente. Il blocco economico azero e turco, sommandosi al crollo
della produzione industriale, determinò negli anni 1992-1993 una impressionante crisi economica. Ebbe allora inizio un notevole fenomeno migratorio, in
particolare verso la Russia, che in questa situazione costituiva un’ancora di salvez-
11
A. FERRARI, Il Caucaso e l’Europa. Una prospettiva storica, ISPI Policy Brief, n. 14, febbraio
2005, <http://www.ispionline.it/it/documents/pb_14_2005.pdf>.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
21
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 22
La partita nel Caucaso
za per l’Armenia. Non sorprende quindi che Erevan abbia immediatamente manifestato la volontà di mantenere un legame preferenziale con Mosca, concedendole il diritto di mantenere per 25 anni basi militari sul suo territorio. In questo
periodo difficilissimo la piccola Repubblica armena ha inoltre usufruito di buone relazioni con il vicino Iran che, benché islamico, ha rapporti difficili sia con
Ankara che con Baku.
La sanguinosa guerra nell’Alto Karabakh ha visto il netto successo militare degli armeni, che non si sono limitati ad espellere la popolazione azera della regione,
ma hanno anche conquistato vasti territori dell’Azerbaigian. Nel maggio 1994 questa situazione è stata sanzionata con un cessate il fuoco tra gli armeni dell’Alto Karabakh e l’Azerbaigian. Da allora, più di dieci anni di negoziati non sono riusciti a
sbloccare la situazione. Si contrappongono infatti in tale questione due opposti
principi giuridici: l’intangibilità delle frontiere (a favore dell’Azerbaigian) e il diritto all’autodeterminazione dei popoli (a
L’Armenia persegue una politica che affianca allo storico
favore degli armeni dell’Alto Karabakh).
legame di sicurezza con la Russia una crescente
Questa irrisolta questione ha sensipropensione occidentale
bilmente compromesso lo sviluppo
della Repubblica armena, che per le sue ridotte dimensioni avrebbe particolare bisogno di una stretta collaborazione con tutti i suoi vicini. Nonostante tale difficilissima situazione, l’Armenia è riuscita a sopravvivere. Ad aiutarla, oltre al sostegno russo (e iraniano), è stata la notevole compattezza etnica e culturale, nonché
il sostanzioso appoggio economico della diaspora. L’inserimento obbligato nell’asse informale Mosca-Tehran è peraltro accompagnato da una forte propensione occidentale, favorita dall’esistenza di comunità diasporiche particolarmente numerose ed influenti in Francia e negli Stati Uniti. La Repubblica armena si è dunque
sforzata in questi anni di condurre una politica del “doppio binario” o “di complementarità”12, nel complesso con buoni risultati. Lo stretto legame con Mosca costituisce una garanzia di sicurezza nei confronti dei suoi vicini ostili, ma non ha
sinora pregiudicato il rapporto con gli Stati Uniti. Nel complesso l’Armenia continua a godere di una forte “simpatia” internazionale, anche grazie al sempre più
diffuso riconoscimento del genocidio del 1915. Tuttavia la situazione di questa repubblica rimane molto difficile, soprattutto a causa della mancata soluzione della questione dell’Alto Karabakh, che la esclude da diverse prospettive di sviluppo
economico, in particolare dal transito delle risorse energetiche dell’Asia centrale e
del Caspio. È probabile che un’eventuale soluzione di tale conflitto – impossibile
senza il consenso dell’Occidente – consentirebbe all’Armenia di eliminare o ridurre l’attrito con i due stati turchi confinanti e quindi di porre fine alla stretta dipendenza dall’appoggio russo. Si tratta tuttavia di una questione molto spinosa, al
punto che nel 1998 il primo presidente post-comunista dell’Armenia, Levon Ter
Petrosyan, è stato costretto alle dimissioni di fronte alla decisa opposizione popo-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
22
12
L. ZARRILLI, L’Armenia post-sovietica: un profilo geografico, in idem (a cura di), La grande regione del
Caspio. Percorsi storici e prospettive geopolitiche, Milano 2004, p. 93.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 23
Georgia, Armenia e Azerbaigian. Pedine del nuovo “Grande Gioco”?
lare alla sua disponibilità ad una soluzione di compromesso sulla questione. Al suo
posto è stato eletto Robert Kocharian, egli stesso originario dell’Alto Karabakh.
Nonostante una certa involuzione negativa della situazione politica interna –
soprattutto dopo l’assassinio in parlamento, avvenuto nell’ottobre 1999, del primo ministro, del presidente del parlamento e di alcuni altri deputati – l’Armenia
ha compiuto passi importanti verso l’integrazione nelle strutture internazionali.
Nel 1996 ha sottoscritto con l’Unione Europea l’Accordo di partenariato e cooperazione, divenendo in seguito anche membro del Consiglio d’Europa. Nel frattempo, inoltre, l’economia ha iniziato a crescere in maniera rilevante (con tassi
di sviluppo intorno al 10% a partire dal 2001) e nel dicembre 2002 il paese è divenuto membro del Wto. L’evoluzione della situazione internazionale dopo l’11
settembre 2001 ha posto però l’Armenia in una situazione estremamente complessa. I buoni rapporti con l’Iran creano difficoltà con Washington. Inoltre, il dislocamento di militari statunitensi nella vicina Repubblica georgiana è stato osservato a Erevan con una certa inquietudine, in quanto potrebbe preludere ad
una completa esclusione dalla Transcaucasia della Russia, che resta il principale
sostenitore dell’Armenia contro l’Azerbaigian e la Turchia. È vero, peraltro, che
negli ultimi anni vi sono stati alcuni segnali di distensione tra Erevan e Ankara,
in particolare dopo la vittoria elettorale del Partito della giustizia e dello sviluppo, meno legato all’eredità kemalista e quindi – almeno in teoria – alla tradizionale posizione negazionista riguardante il genocidio armeno. Anche se una svolta in questo senso appare al momento ancora remota, l’eventuale soluzione del
complesso contenzioso turco-armeno modificherebbe in effetti radicalmente le
prospettive geopolitiche dell’Armenia e di tutta la Transcaucasia. Per l’Armenia
ha una grande rilevanza anche l’apertura dei negoziati tra l’Unione Europea e la
Turchia, definitivamente avviati il 3 ottobre 2005. Questo processo appare teoricamente promettente anche per la questione dell’Alto Karabakh, la cui soluzione
diviene sempre più prioritaria per la stabilità dell’intera regione, soprattutto alla
luce del completamento dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan.
Ancora adesso, tuttavia, il principale alleato dell’Armenia rimane la Russia,
che negli ultimi anni ha ulteriormente esteso la sua penetrazione economica nel
paese, del quale controlla circa la metà dell’energia elettrica. Inoltre, dal settembre 2003 anche la centrale nucleare di Metzamor è in sostanza in mano russa. Nella sfera militare la stretta alleanza con la Russia è stata riconfermata da una serie
di nuovi accordi firmati nel novembre 2003 tra i ministri della difesa dei due paesi. La specificità storica e geopolitica dell’Armenia continua dunque a farne un fedele alleato di Mosca e ad impedire una penetrazione strategica degli Stati Uniti
in questo paese. Tuttavia si cominciano ad osservare segnali di cambiamento da
parte dell’opinione pubblica, che secondo recenti sondaggi preferirebbe far parte dell’Unione Europea anziché della Csi.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
23
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 24
La partita nel Caucaso
L’Azerbaigian: petrolio e potere dinastico
La grande importanza dell’Azerbaigian nel contesto post-sovietico è dovuta
soprattutto alla sua produzione petrolifera, che rappresenta un’importante alternativa a quella mediorientale, nonché alla sua posizione privilegiata come transito del gas e del petrolio estratti nell’Asia centrale. Il paese ha saputo sinora trarre solo un limitato guadagno da questa situazione vantaggiosa.
Dopo le brevi presidenze dell’ex segretario del Partito comunista dell’Azerbaigian, Ayaz Mutalibov, e di Abulfaz Elchibey, capo del Fronte popolare, di tendenza nazionalista, filo-turca ed antirussa, l’Azerbaigian è stato retto con mano ferma da Heydar Aliyev, che era stato segretario del Partito comunista azero prima
di Mutalibov, venendo rimosso da Gorbachev per il suo conservatorismo. Nella
politica interna Aliyev stabilizzò la caotica amministrazione statale collocando
nei posti-chiave parenti o persone a lui vicine, ma senza risolvere la questione dell’Alto Karabakh.
Negli oltre dieci anni di permanenza al potere, Aliyev è riuscito ad evitare lo
scontro frontale con la Russia, ma senza mai divenirne una marionetta, anzi. Pur
mantenendo il paese nella Csi, egli rifiutò infatti di accogliere truppe di Mosca sul
territorio dell’Azerbaigian; ma soprattutto Aliyev firmò nel settembre del 1994
quello che è stato definito “l’affare del secolo”, vale a dire l’accordo per lo sfruttamento dei grandi giacimenti petroliferi azeri, situati nel Mar Caspio, con un consorzio occidentale, che avrebbe ricevuto il 70% degli utili, mentre il 30% venne
riservato a Baku. Tuttavia, dopo il trattato di adesione alla Csi e all’unione economica dei suoi membri, egli decise prudentemente di cedere una percentuale,
limitata peraltro al 10%, anche alla compagnia russa Lukoil. Negli anni successivi, però, i rapporti dell’Azerbaigian con la Russia sono stati resi difficili sia dal sostanziale appoggio di questa all’Armenia sia dal fatto che Mosca non ha gradito
la scelta azera di appoggiare il progetto statunitense di costruzione dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, a scapito della tradizionale direttrice russa.
Nel 1996 Baku sottoscrisse con l’Unione Europea l’Accordo di partenariato e
cooperazione, divenendo poi membro del Consiglio d’Europa. Nello stesso anno
l’Azerbaigian entrò nel Guuam, riconfermando così la sua riluttanza a rientrare
nell’orbita di Mosca e una dichiarata propensione filo-occidentale. Tale scelta ha
fatto sì che, nonostante la limitazione degli aiuti imposta nel 1992 dal Congresso degli Stati Uniti a causa della mancanza di libertà politica interna e del blocco
economico attuato nei confronti dell’Armenia, l’Azerbaigian abbia attratto notevoli investimenti esteri, in particolare statunitensi. Il paese non ha però conosciuto un vero sviluppo e la sua economia resta fragile ed eccessivamente dipendente dal petrolio13. Né, d’altra parte, tale orientamento è sinora valso a recuperare le
perdite subite durante la guerra con gli armeni dell’Alto Karabakh. Visto lo stal-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
24
13
F. POLLICE, L’Azerbaigian: geografie di una transizione, in L. ZARRILLI (a cura di), La grande regione
del Caspio..., cit., pp. 113-119.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 25
Georgia, Armenia e Azerbaigian. Pedine del nuovo “Grande Gioco”?
lo negoziale, la possibilità che nel territorio conteso torni a divampare la guerra
è sempre reale, nonostante la debolezza militare dell’esercito di Baku, più numeroso ma meno organizzato e motivato di quello armeno.
Questi fallimenti interni ed esterni, nonché il forte autoritarismo di Aliyev e
la sua gestione familistica delle risorse del paese hanno suscitato una tenace opposizione, che tuttavia non è riuscita a coalizzarsi e a impedirne la rielezione nel
1998. Nonostante i notevoli limiti in materia di democrazia, alla leadership autoritaria e clanica di Heydar Aliyev va riconosciuto il merito di essere riuscita a stabilire rapporti preferenziali con gli Stati Uniti e la Turchia senza però pregiudicare le relazioni con l’Iran e la Russia. Il presidente Putin ha cercato in effetti sin
dall’inizio del 2001 di migliorare le difficili relazioni della Russia con l’Azerbaigian,
acconsentendo, sia pure in maniera ambigua, alla costruzione del tanto contestato oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Per la Russia è in effetti di particolare importanza economica la soluzione dei problemi di divisione del Mar Caspio, dove è di gran lunga la maggior potenza militare. Da parte di Baku, la volontà di
migliorare i rapporti con Mosca deriva anche dal fatto che un gran numero di
azeri lavora in Russia, contribuendo non poco con le loro rimesse all’economia
del paese.
Il relativo miglioramento delle relazioni russo-azere ha in qualche mo- L’Azerbaigian è riuscito a porre in essere rapporti
do limitato la penetrazione statuniten- preferenziali con Stati Uniti e Turchia senza pregiudicare
se. In Azerbaigian, inoltre, il cambia- le relazioni con Iran e Russia
mento delle prospettive geopolitiche dopo l’11 settembre 2001 ha avuto sinora
conseguenze relativamente limitate. La principale è stata l’abolizione nei primi
mesi del 2002 delle restrizioni all’assistenza statunitense imposte a Baku nel 1992.
Inoltre si è rafforzata la cooperazione militare tra Washington e Baku, soprattutto in funzione anti-iraniana. Ciononostante, nel corso della guerra in Iraq del
2003 l’atteggiamento di Baku è stato alquanto prudente, poiché Aliyev, la cui salute era ormai minata, non voleva sacrificare all’alleanza con gli Stati Uniti il sentimento di solidarietà per l’Iraq ampiamente diffuso in un paese musulmano come l’Azerbaigian. Benché la possibilità di accogliere basi statunitensi non sia
esclusa dalla dirigenza azera, si ha in effetti l’impressione che Baku abbia ceduto
definitivamente alla Georgia la chance di divenire il paese-chiave della penetrazione statunitense nella regione.
La declinante salute del vecchio presidente azero ha dato luogo ad una transizione familiare del potere da padre a figlio simile a quella avvenuta alcuni anni fa
in Siria. Nonostante i forti dubbi sulla sua legalità, l’elezione di Ilham Aliyev a
presidente, avvenuta nell’ottobre del 2003, è stata bene accolta sia dalla Russia che
dagli Stati Uniti. Mosca spera evidentemente che il giovane Aliyev, il quale per rafforzare la sua ancora debole posizione ha bisogno dell’appoggio del grande vici-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
25
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 26
La partita nel Caucaso
no settentrionale, abbia ereditato l’equilibrio politico del padre. Per quel che riguarda Washington, gli interessi connessi al transito petrolifero e al controllo del
radicalismo islamico sono troppo grandi perché si guardi eccessivamente alle incerte credenziali democratiche del nuovo presidente.
Va peraltro segnalato che l’inaugurazione nel maggio 2005 dell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan può portare ad un cambiamento radicale della situazione. Ora
che il petrolio di questo discusso oleodotto può finalmente entrare nel mercato
internazionale, l’Azerbaigian si trova nella condizione di trar profitto dalla posizione filo-occidentale assunta in questo decennio, migliorando nettamente la sua
ancora precaria economia, con possibili ricadute anche sulla situazione militare
nell’Alto Karabakh. Se a questo si aggiungesse un più deciso orientamento politico e militare di Baku verso Washington, la transizione egemonica nella Transcaucasia compirebbe un passo decisivo.
Conclusione
Dopo la dissoluzione dell’Urss le repubbliche transcaucasiche sono state
ampiamente coinvolte nel duello strategico tra Russia e Stati Uniti. Il loro
orientamento è però tutt’altro che univoco, in quanto risente fortemente della
specificità storica e geopolitica di ognuna di esse. La Georgia è senz’altro la più
filo-occidentale, soprattutto dopo la “rivoluzione delle rose” del 2003, mentre
l’Armenia conserva un legame obbligato ma fortissimo con la Russia. L’Azerbaigian, pur manifestando un orientamento filo-occidentale, mantiene una politica
di equilibrio con Mosca.
L’accresciuta penetrazione statunitense nella regione, soprattutto in Georgia,
rischia indubbiamente di ravvivare la competizione con la Russia. Tuttavia, nonostante i contrastanti interessi politici ed economici, Mosca e Washington sembrano destinate a trovare un accordo nell’area transcaucasica, anche sulla base
della retorica della lotta al terrorismo internazionale. La stabilità della regione e
le sue potenzialità di sviluppo dipendono in effetti essenzialmente dall’equilibrio
con cui gli agenti interni ed esterni si muoveranno nell’ambito di una transizione egemonica che sembra al momento irreversibile. Da questo punto di vista,
nonostante tutti i dubbi e le difficoltà, l’inserimento delle tre repubbliche della
Transcaucasia nella Politica di Vicinato da parte di una Unione Europea che non
ha mire egemoniche nella regione potrebbe costituire realmente un fattore di rilievo, sottraendola all’odierna situazione di “faglia” geopolitica per far sì che la sua
posizione strategica divenga occasione di sviluppo e non di conflitto.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
26
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 27
Il Caucaso nell’orizzonte strategico americano
Corrado Stefanachi
Il Caucaso nell’orizzonte strategico americano
Dai margini al centro: un’introduzione
Ad uno sguardo retrospettivo, che abbracci l’intero periodo post-bipolare, si
rivela la graduale promozione del Caucaso meridionale nella “mappa mentale”
della politica estera e di sicurezza degli Stati Uniti. Tutto sommato marginale ancora fino alla metà degli anni Novanta, per lo più relegato alla politica americana di vigile “sorveglianza” della Russia post-sovietica, il Caucaso ha guadagnato
un nuovo peso man mano che le incognite e le sfide emerse nel “Grande Medio
Oriente” hanno richiamato quote crescenti di attenzione e impegno della potenza americana. Collocata alle estreme propaggini nord-orientali del “Mediterraneo
allargato”, la regione del Caucaso rimane un tassello della politica di “interramento” e chiusura continentale applicata dagli Stati Uniti alla Russia post-sovietica,
proponendosi al contempo quale naturale “interfaccia” o “cerniera” geopolitica
tra il sistema di sicurezza euro-atlantico e il “Grande Medio Oriente”. Più precisamente, il Caucaso acquisisce un crescente valore in quanto naturale corridoio
di uscita delle ingenti risorse energetiche centro-asiatiche, tanto più preziose sul
piano politico nel momento in cui l’incertezza radicale che avvolge le due sponde del Golfo Persico consiglia una diversificazione degli approvvigionamenti
energetici che allenti la dipendenza dal Golfo stesso, e ancora come un naturale
corridoio di accesso strategico all’area del “Grande Medio Oriente”, tanto più irrinunciabile nel momento in cui l’estensione del campo di intervento diretto
americano (Afghanistan, Iraq), la moltiplicazione dei punti di crisi nella regione
(Iran) nonché l’assottigliamento della posizione diplomatica americana (a cominciare dalle diffidenze, peraltro ricambiate, nei confronti dell’Arabia Saudita)
consigliano una politica di diversificazione del “pacchetto” logistico che sostiene
la presenza/proiezione americana nel Golfo e nelle aree circostanti.
Ciò che si delinea insomma è il peculiare valore di “periferia centrale” del
Caucaso meridionale, snodo geopolitico in contatto con una pluralità di arene regionali nevralgiche per la configurazione degli assetti politici globali (relazioni
con Russia, Medio Oriente e Golfo, Asia centrale); nei termini del pensiero strategico americano, si tratta di un’area dotata di «valore estrinseco»1 piuttosto che
intrinseco, rilevante cioè più per il sostegno che essa è in grado di fornire alle posizioni e alle iniziative americane nei limitrofi teatri in cui si concentrano le risorse del potere mondiale, e in cui si gioca la partita dell’unipolarismo, che per il
potenziale geopolitico aggregato che l’area contiene al proprio interno.
Allargando lo sguardo all’orizzonte globale della strategia unipolare america-
1
M. DESCH, The Keys that Lock Up the World. Identifying American Interests in the Periphery, in
«International Security», 14, 1989, 1, pp. 86-121.
CORRADO STEFANACHI
è Ricercatore in Scienza
Politica e docente
incaricato di Relazioni
Internazionali presso
l’Università degli Studi
di Milano. Collabora alle
attività di ricerca del
CeMiSS e dell’ISPI.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
27
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 28
La partita nel Caucaso
na, l’area del Caucaso può essere in effetti considerata come un anello nella ininterrotta catena di mari interni, bacini “mediterranei” e postazioni costiere che, dal
litorale atlantico dell’Europa baltica attraverso il “Mediterraneo allargato” fino
agli specchi marittimi del Sud-Est Asiatico che si sciolgono nel Pacifico occidentale, apre il rimland eurasiatico, scacchiera cruciale per la determinazione degli
assetti di potere mondiali2, all’influenza politica e, all’occorrenza, alla proiezione
strategica degli Stati Uniti. E tuttavia, man mano che quella strategia unipolare è
chiamata a fare i conti con forme di contestazione politica e contrapposizione militare che si manifestano all’esterno dell’arena strettamente interstatale (cioè l’“insorgenza”3 jihadista, con le sue tattiche asimmetriche di guerriglia e terrorismo
transnazionale), e che fanno semmai leva proprio sulla crisi della sovranità e della territorialità che colpisce diverse aree del sistema internazionale (è il fenomeno dello “state-failure”)4, l’area caucasica compie un ulteriore salto nella scala gerarchica degli interessi americani, scoprendosi infine fronte e prima linea della politica di sicurezza della potenza unipolare.
Sullo sfondo del trauma dell’11 setIl Caucaso si configura come snodo geopolitico
tembre, il vuoto di potere lasciato nella
e come fronte della strategia americana di lotta
regione dallo smantellamento della pax
al terrorismo internazionale
sovietica si è mostrato agli occhi americani in tutta la sua ambivalenza: in quanto straordinaria opportunità geopolitica ma anche come insidia e fonte di vulnerabilità. Se infatti il vacuum post-sovietico ha consegnato agli Stati Uniti l’inedita possibilità di comprimere al massimo
la secolare influenza russa lungo una delle sue tradizionali direttrici di espansione e di coltivare al contempo nuovi approcci alla sicurezza del Golfo Persico, la
stentata sovranità dei paesi emersi dalla frammentazione sovietica e la precarietà del loro controllo territoriale, sorta di “vuoto dentro al vuoto”, hanno iscritto
a pieno titolo il Caucaso meridionale (e l’Asia centrale post-sovietica) in
quell’“arco di instabilità” eurasiatico da cui è venuta la sfida più clamorosa alla
overseas presence americana, sottospecie del collegamento tra il collasso statuale
afghano e l’islamismo radicale transnazionale.
Con il suo mosaico etno-culturale parzialmente immerso nell’universo islamico, con le sue “zone franche” che si negano al controllo degli stati regionali (Alto Karabakh, Ossetia meridionale, Abkhazia, ecc.) e che “smagliano” il tessuto della sovranità, con i suoi confini interstatali “porosi” e sovente contestati, il Caucaso meridionale si è imposto senz’altro negli ultimi cinque anni quale parte integrante del problema della sicurezza americana, e come uno dei teatri su cui Washington sta inseguendo la soluzione. La collocazione geografica e l’“imperfetta”
transizione alla sovranità espongono il Caucaso al rischio di infiltrazione ideologica e politica del radicalismo islamico (sia da Nord, dal Caucaso russo, con il per2
3
4
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
28
B.R. POSEN, Command of the Commons: The Military Foundation of U.S. Hegemony, in
«International Security», 28, 2003, 1, pp. 5-46.
Nel senso qui di D.J. KILCULLEN, Countering Global Insurgency, in «Journal of Strategic
Studies», 28, 2005, 4, pp. 597-617.
Sulla ridefinizione dei codici politico-strategici degli Stati Uniti in risposta alla (nuova) politica
«internazionale» de-territorializzata, mi permetto di rimandare a C. STEFANACHI,
Deterritorializzazione della politica e ridefinizione della politica di sicurezza americana, in
«Quaderni di Scienza Politica», 5, 2005, 1, pp. 155-180.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 29
Il Caucaso nell’orizzonte strategico americano
sistente focolaio ceceno, che da Sud, dall’irrequieto Medio Oriente e dall’Asia centro-meridionale), facendo in ogni modo di quest’area un ambiente ideale per le
attività di “guerriglia” transnazionale e destabilizzazione terroristica intraprese
dall’“Islam radicale”, nonché uno dei naturali crocevia dei flussi e dei circuiti
transnazionali che compongono il “lato oscuro” della globalizzazione, e che alimentano i peggiori incubi dei policy-makers americani: a cominciare dal traffico
clandestino di componenti sensibili e tecnologia per le armi di distruzione di
massa5.
Dal “prisma russo” al “prisma del Golfo”: il Mar Nero e il Caucaso
meridionale nella strategia unipolare americana
All’indomani del 1991, la politica americana nel Caucaso è stata in misura
prevalente una funzione della strategia di congagement della Federazione Russa,
problematico mix di containment ed engagement dell’erede più ingombrante dell’Unione Sovietica: lo stabile coinvolgimento della Russia nella cornice istituzionale atlantica, dettato dall’obiettivo di prevenire il manifestarsi di una pericolosa “sindrome weimariana”6, reazione revanscista e nazionalista al trauma del declassamento internazionale e della perdita dell’impero, si è accompagnato al mantenimento (e anzi all’estensione) di salde posizioni geopolitiche eventualmente
attivabili al servizio di una rinnovata strategia di contenimento, nella malaugurata ipotesi che il dialogo lasciasse il posto ad una nuova stagione di confronto.
In questo quadro, l’avvio da parte della Nato di forme di “dialogo strutturato” con
la Russia è coesistito nel corso degli anni Novanta con il suo impegno ad allargare la comunità di sicurezza atlantica verso Est e Sud-Est, fino al pieno inglobamento nell’orbita occidentale dei due nevralgici sbocchi marittimi, il Mar Baltico e il Mar Nero, sui quali si è sempre giocata buona parte della partita della promozione di Mosca al rango di grande potenza globale7.
Proprio il bacino del Mar Nero è andato d’altronde ad assumere un valore
geoeconomico di prima grandezza per Mosca, in quanto transito obbligato per
le sue esportazioni di petrolio verso i mercati internazionali, tanto più cruciale sul
piano politico per una potenza che, come appunto la Russia post-sovietica, ricava circa la metà dei proventi del suo export dalla vendita di gas e di petrolio, e che
tende a rivendicare lo status di grande potenza internazionale sulla base appunto del suo assoluto rilievo nel mercato globale dell’energia. Com’è stato giustamente osservato, «il ruolo della Russia come paese esportatore di gas naturale e
petrolio ne determina il profilo nella divisione internazionale del lavoro, il peso
geopolitico e geoeconomico e le future potenzialità nel sistema delle relazioni in-
5
6
7
Si veda su questo aspetto, D. ALBRIGHT - C. HINDERSTEIN, Unraveling the A.Q. Khan and
Future Proliferation Networks, in «The Washington Quarterly», 28, 2005, 2, pp. 111-128.
Sull’analogia weimariana come principio ispiratore della politica americana verso la Russia,
si veda W.E ODOM, Realism about Russia, in «The National Interest», 2001, 65, pp. 56-66.
C.S. GRAY, The Geopolitics of the Nuclear Era: Heartland, Rimlands, and the Technological
Revolution, New York 1977.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
29
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 30
La partita nel Caucaso
ternazionali»8: conseguentemente l’attrazione del Mar Nero nel “campo di forze”
atlantico rappresenta forse il singolo fattore più importante di condizionamento
politico sulla proiezione internazionale russa, nonché la “polizza d’assicurazione”
più affidabile contro l’eventualità di un ritorno della Russia ad un profilo di grande potenza globale.
Corollario caucasico dell’ambivalenL’immissione del Mar Nero nel “Mediterraneo allargato”
te strategia americana (e atlantica) di
dota gli Stati Uniti di un formidabile strumento di
rapprochement strategico con Mosca e
condizionamento nei confronti della Russia
contestuale perimetrazione della sua
proiezione geopolitica nell’entroterra continentale è stata, almeno fino alla metà
degli anni Novanta, un’attitudine tutto sommato riguardosa nei confronti degli
interessi russi lungo la dorsale caucasico-caspica, nella quale Washington ha definito inizialmente il suo interesse geopolitico nei termini sostanzialmente negativi
della preservazione dell’assetto pluralistico scaturito della dissoluzione dell’Urss,
contro ogni eventuale aspirazione russa ad una rinnovata chiusura egemonica o
controllo neo-imperiale dell’area. Gli Stati Uniti sono stati tra i primi a riconoscere la sovranità degli stati dell’area, ma non si sono avventurati molto più in là di
questo primo passo, interessati in effetti a sottrarre anziché aggiungere, ad assicurare al Caucaso una prospettiva certa di indipendenza da Mosca senza avviare però
un coinvolgimento americano di tipo diretto o continuativo nell’area, né contemplando uno stabile apporto di quest’ultima all’infrastruttura politico-strategica globale americana. Semmai, Washington si accontentava di delegare all’alleato turco
(non certo indifferente alle sorti dell’Azerbaigian turcofono e all’orientamento internazionale della limitrofa Georgia, “territorio-cuscinetto” incuneato tra Turchia
e Russia9) il compito di assistere da vicino la transizione caucasica, di fungere da
“catalizzatore” della cooperazione regionale, e ancora di attivarsi magari come
punto di collegamento tra il Caucaso e il collaudato dispositivo strategico atlantico10. Significativamente, fino alla metà degli anni Novanta le stesse risorse energetiche del Caucaso (Azerbaigian) e dell’Asia centrale furono inquadrate da parte
americana in un’ottica sostanzialmente locale più che globale, più «come uno
strumento utile a sostenere le economie degli stati della regione», nei termini di
Brenda Shaffer, che come un fattore nell’equazione energetica globale11.
In qualità di paese rivierasco e contiguo alla Nato, estrema punta orientale del
“forcipe” costiero necessario a sbalzare il Mar Nero dallo spazio russo e ad immetterlo nel circuito marittimo del “Mediterraneo allargato”, la Georgia è stata fin da
principio gratificata dagli Stati Uniti della maggiore attenzione tra i paesi dell’area12. Washington ha più volte condannato l’intromissione russa nei conflitti seL’osservazione è di L. VARDOMSKI, riportata in A. FERRARI, La regione del Mar Nero e la politica
estera russa, in AA. VV., Il grande Medio Oriente, Milano 2002, pp. 57-108.
F.S. LARRABEE - I.O. LESSER, Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty, Santa Monica 2002, pp.
104-107.
10
Per una panoramica sulla politica americana nel Caucaso meridionale, si veda B. SHAFFER, US Policy,
in P. BAEV et. al., The South Caucasus: a Challenge for the EU, «Chaillot Papers», n. 65, December
2003, in particolare pp. 54-55.
11
Ibidem, p. 54.
12
Mi permetto di rimandare a C. STEFANACHI, Gli Stati Uniti e il bacino del Mediterraneo: aspetti
politico-strategici, in F. ZALLIO (a cura di), L’Europa e il Mediterraneo. Partner o vicini scomodi?,
Milano 2004, in particolare pp. 134-141.
8
9
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
30
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 31
Il Caucaso nell’orizzonte strategico americano
paratistici attivi nel paese, usati da Mosca come leva di pressione su Tbilisi13. È invece stata severamente limitata dall’interferenza del Congresso americano, condizionato dalla lobby armeno-americana, la libertà di manovra delle diverse amministrazioni nei confronti dell’Azerbaigian, depositario delle risorse energetiche
dell’area e, come tale, chiave di volta dello sviluppo e dell’autonomia regionale14.
Sull’impulso dei gruppi di pressione armeni, il Congresso ha imposto nel 1992
sanzioni contro Baku (Sezione 907 del Freedom and Support Act) che proibiscono l’assistenza diretta americana al governo azero, ad eccezione degli aiuti umanitari e della cooperazione nella non-proliferazione e disarmo. Gli Stati Uniti
hanno però fatto immediatamente proprio il progetto di corridoio energetico
Est/Ovest, impostato sull’asse azero-georgiano-turco, sostenendo il tracciato Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc) proposto originariamente (nel 1992) dal presidente azero Elcibey15 e impregnato inequivocabilmente di diffidenza nei confronti della
Russia, emersa dalla frammentazione del sistema economico sovietico come monopolista del trasporto dell’energia caspica verso i mercati internazionali, e come
tale dotata evidentemente di un’ingente capacità di condizionamento indiretto
sulle piccole repubbliche caucasiche16. Il principio della «molteplicità delle pipelines» sottoscritto dagli Stati Uniti, diretto a negare il monopolio dei transiti dell’energia caspica a vantaggio di un’unica potenza («implicitamente la Russia»)17,
è presto diventato il cardine della politica di consolidamento dell’indipendenza
politica dell’area, e la costruzione di un oleodotto che, correndo esternamente al
territorio russo e passando attraverso la Georgia, collegasse il Caspio al Mediterraneo orientale, ne è diventata la traduzione operativa, quale «ulteriore testimonianza del fatto che gli stati del Caucaso meridionale sono attori sovrani e indipendenti, sui quali la Russia ha il diritto naturale di influenza, ma non di dominare o dettare le politiche»18. Più in generale, il progetto è diventato il punto di
“solidificazione” di un allineamento regionale turco-georgiano-azero proteso
verso Occidente, sotto il benevolo patrocinio americano, che ha lasciato alla preponderante influenza russa nell’area la sola Armenia (priva di sbocchi al mare così come di significative risorse naturali), e che si dotava anche di qualche sostanza politico-militare; indicativamente, Ankara forniva ai due paesi caucasici un aggancio alle strutture di sicurezza atlantiche, attivando nel 1996-97 iniziative di
cooperazione strategica con Tbilisi e Baku nei settori dell’addestramento e della
modernizzazione militare, evidentemente cruciali nel creare le premesse di compatibilità con l’Alleanza atlantica19.
B. SHAFFER, cit., pp. 56-57.
Z. BRZEZINSKI, La grande scacchiera, Milano 1998, p. 192.
15
G. BENSI, La Cecenia e la polveriera del Caucaso. Popoli, lingue, culture, religioni, guerre e petrolio
fra il Mar Nero e il Mar Caspio, Trento 2005, p. 285.
16
E senz’altro determinata a mantenerlo, attraverso la conferma della centralità della linea BakuNovorossiysk (Mar Nero); si veda S.F. STARR, The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: School of Modernity,
in S.F. STARR - S.E. CORNELL, The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West, Central
Asia-Caucasus Institute, Silk Road Studies Program, Uppsala 2005, p. 8.
17
S.E. CORNELL, US Engagement in the Caucasus: Changing Gears, in «Helsinki Monitor», 16,
2005, 2, pp. 111-119.
18
Cit. in S.E. CORNELL - M.T. SERETELI - V. SOCOR, Geostrategic Implications of the
Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline, in S.F. STARR - S.E. CORNELL, cit., p. 17.
19
F.S. LARRABEE - I.O. LESSER, cit., p. 105.
13
14
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
31
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 32
La partita nel Caucaso
Già a quel tempo tuttavia si coglievano i segnali di una rivalutazione del Caucaso che non passava più prevalentemente dal “prisma russo”, ma era trainata invece dalle nuove incertezze nel Medio Oriente. Il trasferimento nel 1999 dell’Asia
centrale sotto la competenza di Centcom simboleggia forse nel modo più eloquente la crescente forza centripeta esercitata dal Golfo Persico e dal Medio
Oriente sulle limitrofe periferie ex sovietiche nella visione geopolitica americana20. Alla metà degli anni Novanta, la scoperta di ulteriori riserve petrolifere nel
Caspio e le prospettive di una domanda globale comunque sostenuta (alla metà
del decennio, altra data dotata di valore simbolico, la Cina ha cominciato ad importare petrolio, prefigurando l’attuale pressione dell’Asia sul mercato energetico globale) hanno inserito stabilmente le risorse caspiche nell’equazione economica globale, mentre il persistente potenziale di destabilizzazione geopolitica del
Golfo conferiva a quelle risorse un valore sempre più marcatamente politico. Nella seconda metà negli anni Novanta, lo stallo e poi la profonda crisi del processo
di pace in Medio Oriente, l’inconclusività della “dual containment policy” clintoniana nei confronti di Iraq e Iran, la crescente insofferenza saudita verso la presenza militare americana nella Penisola arabica sono stati tra i fattori che incentivavano la ricerca di contrappesi extra-regionali alla centralità energetica del
Golfo Persico; nel 1999, l’aggregazione del consenso politico e il sostegno finanziario intorno al progetto Btc e alla costruzione del gasdotto Baku-Erzurum
(Turchia) venivano «a rappresentare un importante successo americano nella regione»21.
D’altra parte, il potenziale di turboIl Mar Nero e il Caucaso meridionale hanno acquisito la
lenza e conflitto nel Golfo nonché i viqualità di fondamentale porta d’accesso al Grande Me- coli ciechi incontrati dalla politica medio Oriente
diorientale americana alla fine degli anni Novanta moltiplicavano i possibili scenari di intervento americano nell’area,
ma a condizioni diplomatiche e logistiche verosimilmente assai meno favorevoli
rispetto a quelle incontrate nel 1990-91; in effetti, la diversificazione del “portafoglio” diplomatico e logistico americano in Asia occidentale22 è diventata un
obiettivo tanto più pressante per Washington quanto più si è andata erodendo in
quegli anni la base di consenso nel mondo arabo-islamico intorno alla leadership
regionale americana, e anche su questo tavolo il Mar Nero e il Caucaso hanno
avuto qualcosa da offrire alla potenza americana.
A ben vedere, già all’inizio degli anni Novanta, subito all’indomani dell’intervento nel Golfo, fu vagheggiata negli ambienti politici repubblicani l’idea di un
innovativo “approccio da Nord” all’accesso al Golfo Persico, teso cioè a valorizzare il Mediterraneo orientale e di lì il Mar Nero (in particolare attraverso un ulteriore “investimento politico”, in quel caso, su Israele e Turchia) nel dispositivo
di proiezione militare americano, ad attenuazione della dipendenza dal proble-
I. BERMAN, The New Battleground: Central Asia and the Caucasus, in «The Washington Quarterly»,
28, 2004-2005, 1, p. 60.
21
B. SHAFFER, cit., p. 55.
22
Sul problema dell’accesso all’Asia, già prima dell’11 settembre, P. BRACKEN, Fuochi a oriente.
Il sorgere del potere militare asiatico e la seconda era nucleare, Milano 2001.
20
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
32
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 33
Il Caucaso nell’orizzonte strategico americano
matico quadrante sud-orientale dell’area (Suez/Aden/Hormuz)23. È indicativo
che, negli anni Novanta, l’ambizione ad allargare la cooperazione con i paesi dell’area si sia manifestata segnatamente presso il Dipartimento della Difesa americano, benché le interferenze del Congresso americano e l’endemica instabilità regionale abbiano poi continuato ad ostacolare la messa in pratica di quell’indirizzo. Rimane comunque significativo del crescente interesse verso l’area il fatto che
già nell’aprile del 2001 la nuova amministrazione repubblicana abbia intrapreso
proprio nel Caucaso una delle sue più impegnative iniziative di politica estera di
inizio mandato, ospitando i colloqui di pace azero-armeni, in marcata controtendenza rispetto al principio dichiarato da parte degli esponenti repubblicani durante la campagna elettorale di astensione dalla risoluzione dei conflitti regionali. Di lì a breve, in ogni modo, l’intervento militare contro l’Afghanistan talebano avrebbe mostrato tutto il valore strategico dell’area del Mar Nero e del passaggio caucasico come porta d’accesso all’area cruciale del “Grande Medio Oriente”24.
Un “approccio da Nord”: strategie di accesso all’Asia
Non dev’essere sottovalutato l’apporto del Mar Nero occidentale all’Operazione Enduring Freedom in Afghanistan. Nelle funzioni di retroterra strategico, Bulgaria e Romania hanno fornito agli Stati Uniti il contributo più prezioso tra quelli offerti dagli alleati europei nelle fasi iniziali della campagna militare afghana;
le pressioni americane affinché la Nato aprisse già nel novembre del 2002 le sue
porte a Bucarest e Sofia sono senz’altro riconducibili proprio alla positiva valutazione americana del contributo offerto dai porti e dalle basi aeree del Mar Nero occidentale25 (protette da una forza marittima multinazionale che riuniva i
paesi rivieraschi sotto direzione turca). Tra il Mar Nero e le cruciali postazioni
avanzate che Washington ha potuto attivare a ridosso del teatro afghano (soprattutto in Uzbekistan e Kirghizistan), il Caucaso si è inserito come un problematico “collo di bottiglia” logistico, essenziale corridoio di transito chiuso tra un Iran
quantomeno guardingo verso la nuova assertività militare degli Stati Uniti in
Asia centrale, da una parte, e, dall’altra, una Russia disponibile a collaborare nella lotta al radicalismo islamico ma non fino al punto di aprire il suo spazio aereo
agli aerei americani impegnati nelle missioni di combattimento26. In tali condizioni, lo spazio aereo di Georgia e Azerbaigian (tra i primi paesi ad aderire alla
cosiddetta “guerra globale al terrorismo” e a concedere agli Stati Uniti i diritti di
transito e sorvolo nonché l’uso delle struttura di rifornimento) si è imposto come «l’unica rotta realistica attraverso cui gli aerei militari hanno potuto essere dispiegati dal territorio della Nato all’Afghanistan»27. Non può pertanto sorprendeC. STEFANACHI, Gli Stati Uniti…, cit.
K. YALOWITZ - S.E. CORNELL, The Critical but Perilous Caucasus, in «Orbis», 48, 2004, 1, pp. 105-116.
25
Riprendo qui C. STEFANACHI, La Nato: la sfida del mutamento, in A. COLOMBO - N. RONZITTI
(a cura di), L’Italia e la politica internazionale. Edizione 2003, Bologna 2003, pp. 145-159.
26
Mosca ha infatti concesso i diritti di sorvolo soltanto per missioni umanitarie e logistiche, non di
combattimento.
27
S.E. CORNELL, US Engagement…, cit., p. 113.
23
24
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
33
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 34
La partita nel Caucaso
re che soltanto quattro mesi dopo l’inizio delle ostilità (febbraio 2002) gli Stati
Uniti abbiano inviato un piccolo contingente militare in Georgia, con compiti di
assistenza e addestramento dell’esercito di Tbilisi nel campo dell’anti-terrorismo
(sotto le insegne del Georgia Train and Equip Program, Gtep), inaugurando a tutti gli effetti la politica di cooperazione diretta con il Caucaso, e proprio sul terreno specificatamente militare28, né può sorprendere che subito dopo l’11 settembre l’amministrazione Bush sia riuscita finalmente ad ottenere dal Congresso la
deroga alle sanzioni che limitavano la cooperazione con Baku. Ebbene, la successiva campagna militare in Iraq non ha fatto altro che ribadire l’interesse geostrategico americano per il Mar Nero e il Caucaso meridionale, mentre l’opposizione turca all’apertura di un secondo fronte nell’Iraq settentrionale (come nel
1991) ha dato urgenza all’obiettivo della diversificazione degli alleati e delle postazioni americane anche all’interno dello stesso “approccio da Nord”.
Nel 2004, è stato rinnovato il Train
Le campagne militari in Afghanistan e Iraq hanno
and Equip Program a favore della Georaccresciuto l’interesse strategico americano per il
gia (i cui porti sono stati peraltro visiMar Nero e il Caucaso meridionale
tati dalla VI Flotta americana); uomini
del 16mo Battaglione di Montagna dell’esercito georgiano addestrati nell’ambito
del Gtep sono presenti sia in Afghanistan che in Iraq, dove nel 2004 Tbilisi ha raddoppiato il proprio contingente29. Non c’è dubbio inoltre che la cosiddetta “rivoluzione delle rose” del 2003, che ha portato alla presidenza della repubblica Mikheil Saakashvili con il suo pronunciato orientamento filo-occidentale, si sia giovata del sostegno politico americano. Quanto all’Azerbaigian, nel dicembre del
2003 il Segretario alla Difesa americano Donald Rumsfeld esprimeva al Presidente azero Ilham Aliyev l’interesse di Washington all’apertura di una base aerea nella penisola di Apsheron, nei pressi di Baku, contestualmente all’avvio di colloqui
sulla cooperazione nell’addestramento militare delle forze armate azere30. Da allora, le voci relative all’allestimento di postazioni militari americane nel paese
(così come in Georgia), nel quadro della complessiva ristrutturazione della overseas presence americana in Eurasia, non hanno smesso di circolare negli organi di
informazione e nella letteratura specializzata31. Con Baku l’amministrazione Bush
ha avviato inoltre esercitazioni marittime nel Caspio volte a rafforzare la protezione delle attività petrolifere offshore azere; né si deve dimenticare d’altronde
che, nel peculiare impasto di realpolitik e ideologia, di imperativo geostrategico e
missione democratica, che ispira l’attuale politica estera americana, l’attrazione
dell’Azerbaigian nell’orbita politica di Washington è chiamata ad assolvere anche
ad una funzione simbolica di indubbio rilievo: paese musulmano laico e secolaPer una ricostruzione di questo nuovo approccio, si veda A. FERRARI, La Georgia tra Federazione
Russa e Stati Uniti: un modello di transizione egemonica?, in A. COLOMBO (a cura di), La sfida
americana.
Europa, Medio Oriente e Asia orientale di fronte all’egemonia globale degli Stati Uniti, Ricerca
CeMiSS/ISPI, Milano 2006, pp. 62-64.
29
Georgia to expand its deployment in Iraq, in «Central Asia – Caucasus Analyst», September 8,
2004, <http://www.cacianaliyst.org>.
30
I. BERMAN, cit., p. 62.
31
S. BLANK, American Bases in the Former Soviet Union?, in «Central Asia – Caucasus Analyst»,
February 25, 2004, <http://www.cacianalyst.org>; idem, New Military Trends in the Caspian,
in «Central Asia – Caucasus Analyst», June 1, 2005.
28
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
34
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 35
Il Caucaso nell’orizzonte strategico americano
rizzato, Baku ha qualche credenziale per presentarsi come modello politico
esportabile nel mondo islamico, nell’ambito della campagna politica per «vincere i cuori e le menti» che guida la controinsorgenza americana del mondo islamico. Ad oggi Baku è l’unico paese islamico impegnato in Iraq al fianco degli Stati Uniti.
Oltreché sulle relazioni bilaterali, gli Stati Uniti possono infine contare sulla
consolidata presenza dell’alleato turco, e sull’estensione dell’impegno regionale
della Nato32. Con l’inaugurazione, nel maggio 2005, dell’oleodotto Baku-TbilisiCeyhan (seguita in autunno da quella del gasdotto Baku-Erzurum), la Turchia è
effettivamente diventata l’anello di collegamento tra il Caucaso meridionale e il
Mediterraneo orientale; Ankara svolge inoltre un ruolo di leadership nelle iniziative congiunte (come Black Sea Harmony, affiliata alla missione Active Endevour
che la Nato svolge nel Mediterraneo) di protezione delle linee di comunicazione
marittime che solcano il Mar Nero33. Dal canto suo, la Nato ha dichiarato al summit di Istanbul del giugno 2004 la volontà di innalzare il profilo della sua presenza nelle «regioni strategicamente importanti del Caucaso e dell’Asia centrale»34,
attivando Individual Partnership Action Plans sia con la Georgia che con l’Azerbaigian, che aspirano entrambi ad entrare nell’Alleanza.
Conclusione: gli incentivi all’approfondimento della presenza americana e le incognite future
Evidentemente gli Stati Uniti sono nel Caucaso per rimanerci: perché ancora
non si intravedono all’orizzonte iracheno (e afghano) schiarite tali che consentano loro di disimpegnarsi da quei teatri e dalle aree circostanti; perché il “Grande Medio Oriente”, come mostra drammaticamente la “crisi nucleare” iraniana,
non promette di diventare nei prossimi anni un luogo tranquillo, in cui gli Stati
Uniti possano permettersi di diradare la loro presenza, rinunciando a mantenere (e possibilmente incrementare) partner e posizioni indispensabili a sostenere
eventualmente le iniziative di intervento; e perché anzi l’accresciuta (se possibile) importanza geopolitica del Golfo negli assetti politici globali prodotta dalle
nuove dipendenze economiche asiatiche, farà tanto più di quest’area uno dei teatri nevralgici del balance of power mondiale35. È probabile insomma che la presenza regionale americana non arretrerà nei prossimi anni, e che anzi sia destinata
ad aumentare e ad abbracciare una pluralità di “panieri” e dimensioni cooperative, in linea con la natura multidimensionale delle attuali minacce alla sicurezza internazionale. Nel momento in cui, nel Caucaso come altrove, la politica estera
americana torna prepotentemente ad essere soprattutto politica di sicurezza, la poS.E. CORNELL et al., Regional Security in the South Caucasus: The Role of NATO, Central
Asia – Caucasus Institute, Washington, D.C. 2004.
33
O. BABAOGLU, The Black Sea Basin: A New Axis in Global Maritime Strategy, in «Policy
Watch», n. 1027, The Washington Institute for Near East Policy, August 24, 2005.
34
NATO Embraces Central Asia and the Caucasus at Istanbul Summit, in «Eurasia Insight»,
June 6, 2005, <http://www.eurasianet.org>.
35
C. STEFANACHI, L’Asia orientale tra regionalizzazione e leadership americana,
in A. COLOMBO (a cura di), La sfida americana..., cit., pp. 103-131.
32
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
35
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 36
La partita nel Caucaso
litica di sicurezza, modulata su minacce che non provengono più esclusivamente
dagli stati sovrani, tende in effetti a dilatarsi fino a comprendere tutto quello che
prima dell’11 settembre gli esponenti dell’attuale amministrazione americana non
esitavano a scansare sdegnosamente, rubricandolo sotto le insegne impolitiche
dell’«assistenza sociale internazionale»36: come appunto lo state- e nation-building
oppure la soluzione dei conflitti locali.
Senza dubbio, in poche altre aree del
Le crisi effettive e potenziali che interessano il Grande
sistema internazionale come il Mar NeMedio Oriente non consentono agli Stati Uniti di
ro e il Caucaso il “fallimento dello stato”
disimpegnarsi dal Caucaso
mostra di essere parte del problema della sicurezza, e in pochi altri ambiti regionali la “ristatalizzazione” della politica internazionale, cioè il ristabilimento delle funzioni di controllo territoriale degli stati, si impone come parte integrante della politica di sicurezza americana. Dalla
Transnistria all’Asia centrale, passando per le zone franche della Georgia e dell’Azerbaigian (Alto Karabakh), l’area del Mar Nero e il Caucaso soffrono di una rarefazione della sovranità che rende problematico “filtrare” i traffici e le attività
transnazionali che nutrono a loro volta fenomeni temibili come il terrorismo e la
proliferazione; nei termini di Asmus e Jackson, «si ritiene diffusamente e correttamente che questi frammenti irrisolti dell’impero sovietico servano ora come
punti di transito per armi, droghe, vittime dei traffici [di esseri umani], e come terreno di coltura del crimine organizzato transnazionale e, ultimo ma non per importanza, del terrorismo»37. Dopotutto, il Georgia Train and Equipment Program è
stato avviato all’indomani della scoperta di attivisti qaedisti nella Valle del Pankisi, al confine con la Cecenia, con l’obiettivo ufficiale di incrementare l’efficacia dell’esercito georgiano nell’anti-terrorismo; allo stesso modo, il sostegno finanziario
all’Azerbaigian è stato diretto primariamente al rafforzamento del controllo dei
confini e dei flussi, specialmente delle capacità di contrasto della proliferazione. In
questo contesto, la soluzione dei conflitti etno-nazionali, interstatali (Alto Karabakh) e intestini (Abkhazia, Ossetia meridionale, Agiaria) che lacerano il “tessuto” politico regionale non può non apparire come un passaggio obbligato38. D’altra parte, il rischio cui si espongono gli Stati Uniti è che proprio il loro appoggio
ai partner regionali possa favorirne l’irrigidimento, e determinare la radicalizzazione dei conflitti esistenti invece di moderarli; già all’indomani della “rivoluzione delle rose” qualcosa di simile si è osservato in Georgia, dove è forte «la tentazione […] di sfruttare l’appoggio statunitense per riprendere la politica micro-imperiale di Gamsakhurdia e porre fine in maniera violenta alla virtuale indipendenza delle diverse entità resesi de facto indipendenti nei primi anni Novanta»39. In
modo simile, l’Azerbaigian misura il valore della partnership con gli Stati Uniti anche con il metro del suo rafforzamento nei confronti dell’Armenia.
Indicativo di questo rovesciamento di prospettiva, per esempio, F. FUKUYAMA, Esportare
la democrazia. State-building e ordine internazionale nel XXI secolo, Torino 2005, pp. 126-127.
37
Cit. in R.D. ASMUS - B.P. JACKSON, The Black Sea and the Frontiers of Freedom,
in «Policy Review», June 2004, <http//:www.policyreview.org>.
38
S. BLANK, Rumsfeld and the Caucasus: America’s deepening involvement in the South
Caucasus conflicts, in «Central Asia – Caucasus Analyst», September 8, 2004,
<http://www.cacianalyst.org>.
39
A. FERRARI, La Georgia…, cit., pp. 69-70.
36
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
36
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 37
Il Caucaso nell’orizzonte strategico americano
Ma non è certo questa l’unica incoLa presenza americana nella regione è destinata
gnita legata alla presenza regionale degli Stati Uniti. Al livello di politica in- a divenire una componente strutturale della geopolitica
terna americana, le pesanti interferen- unipolare degli Stati Uniti
ze delle lobbies etniche del Congresso non smettono di sottrarre coerenza e linearità all’agenda regionale americana, con esiti a volte davvero paradossali: mentre
l’amministrazione persegue il riavvicinamento all’Azerbaigian ed è impegnata a
sbloccare il conflitto azero-armeno, il Congresso continua a beneficiare l’Armenia con i finanziamenti più ingenti tra quelli erogati agli stati regionali (e tra i più
elevati in assoluto), finanziando peraltro direttamente anche l’enclave armena
dell’Alto Karabakh40. Qui come altrove, in secondo luogo, Washington sconta la
divaricazione tra gli imperativi, potenzialmente confliggenti, della collaborazione strategica con l’area e della sua democratizzazione politica; la profonda crisi
del 2005 nei rapporti tra gli Stati Uniti e il loro principale partner in Asia centrale, l’Uzbekistan, mostra nitidamente come la “questione democratica” abbia un
peso nelle scelte regionali americane, ma anche come essa possa interferire nell’immediato con le linee d’azione raccomandate dalla geopolitica; nel Caucaso, le
dubbie credenziali democratiche di Aliyev hanno in effetti contribuito a frenare, fin dal 2003, la cooperazione tra Washington e Baku, mentre i segnali di rinazionalizzazione della politica di Saakashvili in Georgia allungano alcune ombre anche sulle prospettive del consolidamento democratico a Tbilisi41. Non si
può infine non menzionare l’acuita diffidenza, e anzi ormai la scoperta avversione, nutrita dalle altre grandi potenze extra-regionali, Russia in testa, nei confronti di una perdurante presenza americana che, giustificata sotto le insegne dello
“stato d’eccezione” dell’11 settembre, sembra ormai sul punto di cristallizzarsi in
una componente “strutturale” della geopolitica unipolare.
40
41
B. SHAFFER, cit., p. 59.
A. FERRARI, La Georgia…, cit., p. 68.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
37
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 38
La partita nel Caucaso
Il punto di vista di un diplomatico
Paolo Serpi*
Con la dissoluzione dell’Urss e il riconoscimento internazionale nei primi anni Novanta di Georgia, Armenia e Azerbaigian, l’area del Caucaso meridionale ha
riacquistato per l’Italia come per l’Unione Europea
quella centralità in termini geo-strategici che era stata
a lungo tenuta in ombra dalla presenza incombente
dell’Unione Sovietica.
Il riemergere di tre stati indipendenti e sovrani ricchi di cultura e tradizioni millenarie e il contemporaneo
riaccendersi di conflitti inter-etnici, al loro interno come
nei loro rapporti interstatuali, hanno causato tuttavia
un evidente rallentamento nel processo di transizione
e consolidamento democratico i cui effetti si sono riverberati spesso in maniera negativa sulla stabilità della regione caucasica.
Posto che la stabilizzazione e messa in sicurezza
del corridoio strategico che percorre i vecchi confini
meridionali dell’Unione Sovietica, dall’Asia centrale al
Mar Nero, costituisce una delle priorità della politica
estera italiana e dell’Unione Europea, il ruolo di anello
di congiunzione geopolitico del Caucaso meridionale
fra la falda euro-asiatica e quella mediorientale ha fatto acquisire a quest’area un’importanza e un rilievo del
tutto particolari.
Il rilievo geo-strategico dell’area transcaucasica è
oltretutto avvalorato sotto una duplice prospettiva:
quella della sicurezza e quella energetica. Si tratta infatti di area potenziale di transito e accesso a traffici illeciti, permeabile al terrorismo di matrice mediorientale, oltre che passaggio preferenziale di linee essenziali di approvvigionamento energetico per l’Italia come
per l’Unione Europea.
Un continente europeo da poco ampliato nella sua
dimensione comunitaria, con prospettive nel breve e
medio periodo di nuove espansioni, vede inoltre l’esigenza di un ricentraggio degli assetti conseguenti all’ingresso dei dieci nuovi paesi membri Ue, con la volontà
e l’impegno italiano di ricomprendere anche la regione
del Caucaso nell’obiettivo di valorizzare quella direttrice sud-orientale dell’asse di consolidamento dell’Europa, dove sono collocati i nostri prioritari interessi geostrategici ed economici.
Nel quadro di un’esigenza sentita da parte italiana
di un’attività di prioritarizzazione geografica degli obiettivi del nostro paese che guardi al di là dell’Europa a
venticinque, è stato possibile in questi ultimi anni rivolgere un’attenzione e una cura particolari a sviluppare
proficui rapporti di collaborazione bilaterale con i paesi del Caucaso, affiancandoli efficacemente allo sforzo
parallelo di dialogo e cooperazione sviluppato dalla diplomazia comunitaria.
In uno spirito di sostanziale sintonia e complementarità fra politica estera italiana ed europea, due sono
state le direttrici dell’impegno comune indirizzato ai paesi del Caucaso. In primo luogo si è operato per assecondare e sostenere il processo di transizione democratica
e il consolidamento dei tre stati caucasici, che hanno conosciuto in questi anni sviluppi sicuramente positivi. In
secondo luogo si è agito con pazienza ma con costanza
e determinazione nel tentativo di dare soluzione ai cosiddetti “conflitti congelati” della regione, che continuano a rappresentare una seria minaccia da un lato al consolidamento della sovranità dei tre stati caucasici e dall’altro alla stabilità della regione nel suo complesso.
* Capo Ufficio IV della Direzione Generale per i paesi dell'Europa, Ministero degli Affari Esteri.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
38
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 39
Il punto di vista di un diplomatico
Se idealmente l’approccio dell’Unione Europea nei
riguardi del Caucaso meridionale è stato marcato da
un’accentuata regionalizzazione, fin dalla nomina di
Heikki Talvitie nel luglio del 2003 come rappresentante
speciale Ue, la direttrice dell’attività diplomatica dell’Italia è stata contraddistinta da una linea di bilateralismo
parallelo che ha interessato e coinvolto i tre paesi della
regione.
Le visite in Italia, che si sono succedute a brevissima scadenza nella prima metà del 2005, dei tre presidenti di Georgia, Armenia e Azerbaigian sono state una
prova evidente di questo nostro approccio equilibrato
e costruttivo.
La parallela e complementare attività italiana e comunitaria si è finora indirizzata su alcuni obiettivi che
sono stati ritenuti prioritari nei rapporti con i paesi dell’area caucasica, ai quali dal giugno 2004 è stata estesa la Politica europea di Vicinato. Si fa riferimento in
particolare a un sostegno diretto allo sviluppo di relazioni di cooperazione tra gli stessi tre paesi e i loro vicini settentrionali e meridionali indirizzate prioritariamente ai settori dell’economia, delle risorse energetiche e dei trasporti.
Analoga attenzione è stata fornita allo sviluppo in
quei sistemi economici – per molti versi ancora ostaggio di pesanti “incrostazioni” di matrice sovietica – di
un clima complessivo più favorevole alla presenza delle piccole e medie imprese e all’apertura alla collaborazione e agli investimenti dall’estero. In questo particolare settore, come noto, l’Italia possiede un know
how di spiccato rilievo che, già applicato con successo
in svariate realtà post-comuniste, potrebbe trovare an-
che nel Caucaso meridionale un ambiente di crescita
assai favorevole. In quest’ottica si inquadrano gli accordi siglati, a fine 2004, dal Sottosegretario agli Esteri
On. Boniver con le autorità di quei tre paesi, intese che
– una volta a regime – vedranno affiancate, in un’opportuna attività di interazione, le sfere governative e gli
ambienti imprenditoriali.
Ma al di là di questi aspetti, pur importanti, sarà
proprio la riuscita e compiuta transizione democratica
in ognuno dei tre stati verso standard prossimi a quelli vigenti in Occidente l’obiettivo fondamentale verso
cui convergere con convinzione. Anche in questo campo l’Italia può fornire un contributo positivo, in particolare sul piano del rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiose. Nel 2005 le esperienze italiane di autonomia regionale hanno formato, per quanto riguarda
il Trentino-Alto Adige e la Sicilia, oggetto di studio e di
verifica da parte di esponenti del governo di Tbilisi e di
una delle potenziali repubbliche “secessioniste” della
Georgia, l’Abkhazia meridionale. È ora auspicabile che
da tali ravvicinate prese di contatto – che da parte nostra siamo pronti ad allargare ad altre realtà regionali
italiane e ad altre entità caucasiche interessate – gli interlocutori di quell’area geografica sappiano trarre utili indicazioni, adoperandosi con convinzione e con spirito cooperativo all’individuazione di formule mutuamente accettabili, al fine di assicurare con uguale efficacia e forza il rispetto dei principi dell’integrità territoriale e della tutela delle minoranze.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
39
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 40
La partita nel Caucaso
Alessandro Vitale
La politica estera russa e il Caucaso
ALESSANDRO VITALE
è Ricercatore in Scienza
Politica e docente
incaricato di Studi
Strategici all’Università
degli Studi di Milano.
Nonostante la sua politica estera “ufficiale”, orientata alla collaborazione con
le istituzioni euro-occidentali, con tutte le repubbliche ex sovietiche e in particolare con quelle che fanno parte della Comunità degli stati indipendenti (Csi), la
Russia contemporanea conduce una politica estera parallela, basata su grandi finalità strategiche, che assumono nel caso del near abroad un’estrema rilevanza.
Più ancora che in altre aree ex sovietiche, in quella caucasica la fondamentale
e dominante finalità strategica russa rimane quella della conservazione di un
ruolo egemonico primario di influenza politica. Non solo perché l’importanza
del contesto caucasico è diventata evidente in relazione alla dinamica della politica energetica mondiale e alla fase di acuta crisi che il settore dell’approvvigionamento energetico sta attraversando, ma anche per profonde ragioni storiche e
connaturate alla natura stessa della Russia quale compagine politica per definizione ex imperiale che nel Caucaso, nel quale ha incominciato ad essere coinvolta dall’epoca di Ivan IV il Terribile (e nella regione transcaucasica dal 1722, a seguito di una spedizione di Pietro il Grande), ha visto la formazione, pur contraddittoria, di alcune delle sue basi d’appoggio principali e che oggi continua a giocare una partita che percepisce come decisiva per la sua sopravvivenza come potenza innanzi tutto regionale.
Eredità imperiale e ruolo russo nel Caucaso:
una premessa necessaria
L’incertezza sulla “natura politica” della Russia contemporanea (che non riesce a “contenere” e a rispecchiare l’identità russa)1, influisce in modo consistente
sulla sua politica interna e su quella estera2. Senza indagare le costanti tendenze
culturali russe di tipo imperiale, data l’evidente continuità del rapporto fra “identità russa” e impero (russo e sovietico), è pressoché impossibile comprendere la
politica estera della Russia post-sovietica, ma questo modo abituale di procedere spiega solo una parte dei problemi della politica estera attuale e della collocazione del paese nell’ambito delle relazioni internazionali contemporanee. Infatti, se da una parte sono corrette le indagini sulle difficoltà di auto-definizione e
di collocazione per i russi, ormai privi dello storico impero bi-continentale, sulle ambiguità della definizione di cosa sia “russo” e cosa non lo sia (culturalmente ed etnicamente), i principali problemi che ancora oggi la Russia deve affronta1
2
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
40
Si veda C.M. SANTORO, Russia: un sistema politico in cerca di identità, in «Relazioni Internazionali»,
1994, 25, pp. 4-11. Qui più che altrove infatti, come ha scritto D. Trenin: «The problem of space is
inseparably linked to and compounded by the problem of identity». Si veda D. TRENIN, The End of
Eurasia: Russia on the Border Between Politics and Globalization, Carnegie Endowment for
International Peace, Washington, D.C. 1992, p. 16.
L’identità nazionale è cruciale nella formulazione della politica estera. La crisi dell’identità russa, dopo
la fine del suo dominio egemonico imperiale nell’Eurasia, crea una specifica politica estera.
E.A. MILLER, The Changing Face of Eurasia: Russian and Ukrainian Foreign Policy in Transition, in
«Comparative Strategy», 22, 2003, 4, pp. 373-390.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 41
La politica estera russa e il Caucaso
re sono quelli che derivano dalla sovrapposizione fra dimensione statale moderna e dimensione imperiale. Che dallo stato imperiale sovietico potesse emergere
uno stato russo senza problemi di auto-identificazione e di auto-legittimazione
non era affatto scontato, anzi era fin dall’inizio molto problematico, come dimostrano i dibattiti in Russia sul tema, tipici degli anni 1991-93. Del resto, già nella
seconda metà del XIX secolo era fallito il tentativo zarista di fondere “nazione” e
stato, di dotare la Russia di una national state ideology, cercando di identificare la
dinastia con la “nazione russa”. L’unica identificazione possibile infatti in Russia
rimaneva quella “sovranazionale”, legata alla religione, fonte di un “patriottismo
imperiale” e non “nazionale” di tipo occidentale. La logica dell’empire building si
è scontrata con quella del nation building, provocando un incomplete nation making. Non a caso dopo la disintegrazione dell’impero russo nel 1917-21, lo sforzo sovietico era stato totalmente rivolto verso il tentativo di ricomporre l’impero servendosi di qualsiasi mezzo, comprese le false promesse fatte alle popolazioni non-russe dell’ex impero zarista. Anche se la dirigenza bolscevica cercherà di
trasformare l’impero in uno stato dotato di tutte le caratteristiche occidentali moderne, unitario e centralizzato, quanto più omogeneo possibile, negando l’evidenza, cioè la natura imperiale di questo stato, la realtà indefinita della Russia farà da
sfondo a questo sforzo ed oggi non a caso essa tende a riemergere. Anche se nel
corso del Novecento l’impero è collassato due volte, il tentativo di costruire uno
stato non-imperiale in Russia ha sempre incontrato serie difficoltà.
Va anche detto che, dopo il collasso degli Imperi, la loro “ombra” rimane a
lungo nella storia, non scompare: questo è ancor più vero per la Russia, dove l’impero è stato fonte di identificazione e perfino di “etnogenesi” per i russi, ai quali
ha dato un’identità di tipo imperiale-universalista, ma non ha mai risolto il problema della formazione anomala dello stato nella regione eurasiatica, nella quale conserva tutta la sua ambiguità e incertezza. Non è certo un caso che rimanga
anche oggi così forte in questo paese il problema, in Russia endemico, di definire “se stessi” e “gli altri”, di trovare una collocazione in rapporto alla comunità internazionale e all’Europa, così come in relazione con i paesi vicini. La stessa dimensione interno/esterno rimane con ogni evidenza indefinita nella Russia postsovietica, per i cittadini della quale lo stesso concetto di near abroad è qualcosa
che sta a metà strada fra queste due dimensioni, determinanti e necessarie per definire uno stato moderno, se nettamente distinte e delimitate da un rigido confine territoriale. Nel contesto eurasiatico i tempi, la geografia, il contesto internazionale di stampo solo apparentemente occidentale e la centralizzazione esasperata hanno sempre creato difficoltà nello stabilire confini etnici e territoriali e non
solo per la Russia. A questo problema, comune alla regione, va aggiunta però in
Russia l’abitudine “organicista”3 a pensare in modo imperiale e di considerare alcune repubbliche oggi indipendenti o alcune regioni ex imperiali come “parti or-
3
Mi sia consentito di rimandare per questo tema al mio Le ideologie imperiali grande-russa e serba come
fattori di ricomposizione delle rispettive aree geopolitiche, Working Papers ISPI, Milano 1996.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
41
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 42
La partita nel Caucaso
ganiche” della Russia (in quanto soggetto “naturalmente” imperiale) e i suoi abitanti come Rossijane, cioè come “russi” non etnicamente (Russkie), ma ex abitanti dell’impero russo-sovietico. Se questo ha evitato fino a oggi in Russia l’esclusivismo etnico interno, tipico di uno stato nazionale post-imperiale modernizzato, ad esempio sul modello turco, che potrebbe avere conseguenze distruttive4,
crea però anche evidenti problemi con i vicini. Non va dimenticato che in Russia
il trauma per la perdita dell’impero nel 1991 non è stato ancora metabolizzato:
un impero secolare ha perso il Caucaso, l’Asia centrale, l’Ucraina, il Baltico e il
Mar Nero, in quella che viene ancora sentita in Russia come una “catastrofe geopolitica”, nella quale la Russia ha smarrito le sue abituali caratteristiche di “centro di gravità” del continente eurasiatico. Quasi venticinque milioni di “russi etnici” sono diventati minoranze in stati formalmente indipendenti e internazionalmente riconosciuti; la Russia ha perso quel prestigio internazionale che oggi
con la sua politica estera sta cercando di riguadagnare e ha subìto una “asiatizzazione geografica” che l’ha posta di fronte a concorrenti asiatici in condizioni ancora oggi migliori.
Di qui anche le frequenti rinascite
La Russia non ha ancora metabolizzato il trauma
della retorica nazionalista-organicista
causato dalla dissoluzione dell’impero sovietico
“neo-imperiale”, che può fare presa sulla mass mentality non tanto perché coincida con una “volontà di dominio”, ma
per la stessa natura genetica dell’impero, le cui tracce sono rimaste nella coscienza dei russi, anche se è mancata negli anni Novanta una vera nationalist mass mobilization e il ritratto del “nazionalismo aggressivo” tracciato da molti analisti occidentali si è certo rivelato eccessivo, dato che la pressione esercitata dall’ideologia imperiale sulla classe politica erede diretta del sistema imperiale sovietico è
molto più consistente di quella rinvenibile nella popolazione e nell’opinione pubblica5. Se fino ad oggi su questo aspetto la classe politica russa al potere è riuscita infatti a premere relativamente poco, anche per la stessa difficoltà di formazione di un’identità russa post-imperiale, non è detto che in futuro altri esponenti
politici, provenienti dall’esercito o dall’ex complesso militare-industriale, non
possano farlo. Il periodo sovietico ha indebolito il sentimento nazionale russo fin
quasi a distruggerlo6, tuttavia il cambiamento interno può influenzare la politica
estera russa7 e per rafforzare la legittimità del regime politico può non essere più
utilizzabile l’attuale politica estera di informe e declaratoria cooperazione internazionale e di moderata apertura all’Occidente, favorita dalle lobbies politicoeconomiche interne. Diventando dominanti, queste forze possono portare alle
estreme conseguenze la svolta verso l’affermazione degli interessi nazionali russi, che già oggi sta producendo una politica estera carica di elementi neoimpe4
5
6
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
42
7
Si veda A. LIEVEN, The Weakness of Russian Nationalism, in «Survival», 41, 1999, 2, p. 67. Le chiusure
degli stati nazionali indipendenti nei confronti della Russia possono ancora stimolare una forma di
nazionalismo russo non più pluralista o “multietnico” di tipo imperiale come quello attuale, ma chiuso,
esclusivista ed “etno-nazionale”, che sarebbe disastroso per l’intera regione.
La quale però rimane convinta che la posizione stessa della Russia, la sua storia, conferiscano una
particolare responsabilità nell’equilibrio regionale e mondiale. J.C. ROMER, Géopolitique de la Russie,
Paris 1999, p. 6.
A. LIEVEN, cit., p. 55.
Su questo, si veda M. McFAUL, Precarious Peace: Domestic Politics in the Making of Russian
Foreign Policy, in «International Security», 22, 1997-1998, 3, pp. 5-35.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 43
La politica estera russa e il Caucaso
riali8 e che nel Caucaso, non solo quello che rimane “interno”, incomincia a rivelare tutta la sua portata.
Le conseguenze politiche dell’ambiguità imperiale
e il Caucaso post-sovietico
L’attuazione pratica di questa concezione imperiale, che tende a sopravvivere
e che produce rilevanti conseguenze politiche, ma che non è sufficiente per spiegare la politica estera della Russia nei confronti dei suoi vicini, già impostata dal
19929 sulla base degli interessi vitali russi, è favorita oggi da tutta una serie di occasioni, di possibilità e di legami che la Russia è in grado di utilizzare per continuare ad esercitare le sue pressioni e la sua influenza regionale. In altre parole, è
necessario, per comprendere il rapporto fra la Russia e i suoi vicini, trovare il legame tra queste continuità politico-culturali e le reali occasioni che esse hanno
di manifestarsi. Inoltre, mentre le mentalità e le continuità culturali (ad esempio
l’habitus imperiale) sono molto difficili da cambiare, queste occasioni per esercitare un dominio politico, questi legami e dipendenze sono storicamente più variabili, perché di origine meno antica e quindi possono mutare ed essere trasformate agendo sulla loro stessa struttura.
Le principali occasioni che consentono la ripresa di un’influenza imperiale sono:
1. i legami di dipendenza ex sovietici, economici e burocratici, sopravvissuti al
crollo dell’impero e che costringono le repubbliche oggi indipendenti a forme
di vecchie dipendenze dall’ex centro imperiale;
2. le difficoltà dello state-building nello spazio eurasiatico, alle quali possono far
fronte solo aperture, accordi di tipo “federale”10, compromessi, e non impossibili e ostinate chiusure statuali di tipo occidentale moderno;
3. le antistoriche chiusure che le istituzioni euro-atlantiche conservano nei confronti della Russia, alle quali questo paese risponde con una ricerca di occasioni di recupero dell’influenza nelle aree ex imperiali e con il consolidamento di
una propria area esclusiva di influenza politica.
Se è normale che dopo la fine di un dominio imperiale colonizzatori e colonizzati siano obbligati dalle vecchie relazioni reciproche a interagire ancora per lungo tempo, nello spazio ex sovietico questo accade in modo molto evidente: i legami fra l’ex centro imperiale e le repubbliche oggi indipendenti sono infatti rimasti molto forti e cogenti. Questi legami, creati appositamente nel periodo staliniano per impedire l’indipendenza delle repubbliche, si manifestano oggi nelle dipendenze energetiche (caso ucraino e georgiano, fra i più evidenti), nelle infrastrutSi veda U. RA’ANAN - K. MARTIN, Russia: A Return to Imperialism?, New York 1996.
Il 1992 è la data d’inizio della nuova politica estera russa, stimolata dagli avvenimenti in Moldavia,
in Tagikistan, nel Caucaso, e dalla preoccupazione per la diaspora russa nelle repubbliche indipendenti.
10
È ad esempio la soluzione in parte già accettata per il contrasto fra Moldavia e Transnistria.
La frattura che si è prodotta qui, che è certo più l’eccezione che non la regola (A. LIEVEN, The
Weakness of Russian Nationalism, cit., p. 55), è solo l’esempio estremo di conflitti di frontiera
ancora irrisolti e presenti in tutta l’area occidentale ex sovietica.
8
9
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
43
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 44
La partita nel Caucaso
ture comuni e nei legami industriali rimasti dal periodo sovietico: tutti aspetti che
non si riescono a superare, con gravi pericoli per le nuove “indipendenze”.
Giocare su queste interdipendenze è sempre più facile e vantaggioso per l’ex
centro imperiale ed è possibile farlo anche enfatizzando apertamente la priorità
degli interessi vitali russi nel near abroad e negli stati indipendenti, dando vita a
una specie di nuova Dottrina Monroe, giustificata con una “responsabilità politica e morale” della Russia nei confronti dei paesi e dei popoli che per secoli variamente sono stati inglobati nell’impero. Questo ancora escludendo ufficialmente il progetto di una “ricomposizione” imperiale, ma ponendosi come fine,
non sempre apertamente confessato, quello della “reintegrazione sovrastatale”
delle repubbliche ex sovietiche e dell’autodeterminazione delle minoranze russe
in esse contenute.
Le repubbliche caucasiche ex sovieLa Russia reputa il Caucaso un’area di sua pertinenza
tiche vengono ancora considerate come
geopolitica e gioca sulle interdipendenze per perpetuare parte di un’area di forte “pertinenza”
il controllo sulle nuove repubbliche
geopolitica russa e per questo rimangono poco sicure e soggette alla continua minaccia di smembramento territoriale
interno, che si è già verificato in Georgia e in Azerbaigian (questioni dell’Abkhazia, dell’Ossetia e dell’Alto Karabakh), diventando strumento di pressione russa.
I conflitti esplosi nel momento dell’indipendenza di Armenia, Georgia e Azerbaigian sono infatti serviti a Mosca per mantenere una forte influenza regionale e per
costringere Georgia e Azerbaigian ad entrare nella Csi e a firmare il protocollo inerente il sistema di sicurezza collettiva (di Tashkent). Le aspirazioni alla “ricomposizione imperiale”, che rinascono periodicamente nella Russia post-sovietica, puntano marcatamente anche su questi paesi, considerati spazio esclusivo di influenza. La politica estera russa considera il Caucaso come un obiettivo politico-strategico di influenza irrinunciabile, da perseguire pur con i ridotti mezzi dei quali
oggi dispone e a dispetto delle resistenze di antica data che incontra nelle regione o di quelle interne, persino spesso provenienti dal campo nazionalista (Solzhenitsyn, Zhirinovsky, ecc.) o dell’indifferenza che dilaga nei confronti del Caucaso nell’opinione pubblica russa, stanca della violenza dispiegata nella sua parte
settentrionale: in generale infatti si ritiene da più parti che la Russia perda tempo e risorse a continuare una partita di domino in una regione come quella caucasica. La classe politica russa non cede però sulla questione, proprio perché l’abbandono della Transcaucasia senza tentare di ottenere la formazione di paesi favorevoli o per lo meno non ostili alla Russia, e a maggior ragione la perdita della
Ciscaucasia interna (Caucaso settentrionale), che pur era stata auspicata da un intellettuale come Solzhenitsyn prima della disintegrazione dell’Unione Sovietica,
potrebbe essere visto come segno di ulteriore debolezza e incoraggiare altre repubbliche, oltre a quella cecena, a proclamare l’indipendenza in un effetto domino11.
11
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
44
A. FERRARI, Il Caucaso. Popoli e conflitti di una frontiera europea, Roma 2005, p. 68. Non va
dimenticato che già Boris Eltsin aveva fatto notare che tutte le iniziative russe di pace erano state viste
in Cecenia come una prova di debolezza del potere federale. Cfr. G. BENSI, La Cecenia e la polveriera
del Caucaso. Popoli, lingue, culture, religioni, guerre e petrolio fra il Mar Nero e il Mar Caspio,
Trento 2005, p. 248.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 45
La politica estera russa e il Caucaso
In altri termini, è proprio la caratteristica “genetica” dello stato (imperiale) russo a trasformarsi in motore interno dell’espansione egemonica, perché qualora
questa venga a mancare, rimarrebbe solo il vuoto di un’aggregazione politica inconsistente e in potenziale, permanente disintegrazione. Questo tuttavia pone la
Russia di fronte a problemi di difficile soluzione nel Caucaso settentrionale (Cecenia) e nell’intera Transcaucasia.
Lo “sganciamento frenato” delle repubbliche caucasiche indipendenti
dall’influenza egemonica russa
I primi segni di attivismo statunitense nell’area hanno costretto la Russia, dal
2003 in particolare, a rispondere con ripetuti tentativi di recupero dell’influenza
nell’area caucasica meridionale, per ragioni di prestigio neoimperiale, ma anche
geopolitiche, strategiche, economiche ed energetiche. L’importanza di queste regioni per Mosca è naturalmente speculare rispetto a quella che viene percepita in
America e nelle repubbliche ex sovietiche. Riuscire a mantenere il controllo del
trasporto degli idrocarburi provenienti dalla regione significa per la Russia poter
stabilire un monopolio assoluto e condizionare d’un sol colpo sia le repubbliche
indipendenti che l’Europa occidentale e gli Stati Uniti assetati di risorse energetiche per la loro economia interna. Per gli Stati Uniti e le repubbliche caucasiche
significa poter gestire le proprie risorse e rendersi indipendenti dalle precedenti
dipendenze imperiali. Finché il petrolio del Caspio, quello kazako e quello azero
passavano per la Russia sfruttando la rete di infrastrutture creata nel periodo sovietico e le repubbliche della Transcaucasia dipendevano da Mosca per le forniture di gas, Mosca è riuscita a mantenere una posizione privilegiata nella regione. La
realizzazione di oleodotti alternativi, con la concomitante scoperta di giacimenti
di gas offshore, ha incominciato a privare considerevolmente la Russia di questo
strumento di pressione. Sarebbe però sbagliato far corrispondere la rinnovata presenza russa nel Caucaso soltanto a questioni di monopolio energetico, dato che la
politica interna (che comprende anche le drammatiche questioni del Caucaso settentrionale, del conflitto in Cecenia e della Russia meridionale) e quella estera sono condizionate anche dalle sopra ricordate ragioni di eredità imperiale.
In sostanza la Russia è coinvolta
La frammentazione politica, etnica e confessionale
nella complessità del Caucaso con politiche alterne e in gran parte ineffica- della regione caucasica rende assai ardua la politica
ci (quando non disastrose, come nel di influenza della Russia
caso ceceno, anche se finora lo scopo di evitare il contagio e l’effetto domino all’interno della Russia è stato ottenuto), che cercano di gestire una condizione fra
le più frammentate non solo dell’ex Urss12, ma del mondo. Le nuove entità pro-
12
P. SINATTI, La Russia e i conflitti nel Caucaso, Torino 2000, p. X.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
45
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 46
La partita nel Caucaso
clamatesi indipendenti (Abkhazia, Ossetia meridionale, le cui popolazioni Mosca
considera quasi come propri cittadini) hanno ottenuto il suo appoggio, ma sono
prive al loro “interno” di interlocutori stabili e affidabili; è pressoché impossibile, tranne che con le repubbliche ex sovietiche divenute indipendenti dopo il
1991 lungo le linee repubblicane dell’ex impero interno, stabilire con gli attori
della regione relazioni interstatali ben definite e che passino per le rispettive capitali; non esiste un centro di riferimento unico per l’intera regione. Inoltre, appoggiare le cause delle entità che hanno alimentato la frammentazione di Georgia e Azerbaigian ha avvicinato pericolosamente alla necessità di chiederne il riconoscimento internazionale, cosa che avrebbe finito per internazionalizzare anche il conflitto “interno” ceceno.
La frammentazione politica, confessionale, etnica13 di una regione complessa
come quella caucasica14 – nella quale si intrecciano attori statuali instabili e indefiniti, attori sovranazionali, influenze esterne e attori substatuali “a grana molto
fine” – rimane così estrema da rendere in gran parte “scivolosa” e scarsamente efficace la presa della politica russa di influenza. Il suo impegno in Cecenia rende
difficile l’estensione a tutto il Caucaso di un’egemonia che riprenda le vecchie
pertinenze imperiali. Di qui il lungo processo di rafforzamento della presenza statunitense che ha puntato, con la sponsorizzazione dell’oleodotto Baku-Supsa e di
quello Baku-Tbilisi-Ceyhan e con l’appoggio alla Georgia di Saakashvili e al nuovo Azerbaigian stanco dell’“interdipendenza alla russa” e volto alla ricerca di uno
sfruttamento diretto delle proprie risorse petrolifere, a rafforzare il senso di indipendenza delle repubbliche, ma che ha contribuito a complicare la situazione dell’area.
Tuttavia l’impegno in Iraq e la neL’impegno degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iraq
cessità di non sacrificare agli interessi
ha interrotto il processo di transizione egemonica
delle repubbliche caucasiche quelli
cominciato nel 1991
energetici americani dipendenti dalla
Russia, hanno reso instabile l’influenza americana e incompleta la transizione
egemonica. In tal modo la Russia conserva la forza per dettare condizioni precise alla Georgia e all’Azerbaigian; rifiuta l’internazionalizzazione del peace keeping nell’Ossetia meridionale (e anzi lavora per una sua riunificazione con quella settentrionale, che fa parte della Russia)15 e in Abkhazia, sostenendo che il suo
ruolo rimane neutrale; mantiene uno status quo vantaggioso per la sua politica,
pur non riuscendo a conquistare una piena influenza sulla Transcaucasia e utilizza il ricatto energetico per condizionare in particolare la Georgia, accusandola di
fomentare l’instabilità nell’area, di appoggiare il terrorismo ceceno; si serve del
frozen conflict dell’Alto Karabakh fra armeni e azeri per tenerli entrambi sotto
pressione, dato che con la pace il ruolo russo verrebbe meno e forse persino l’Armenia potrebbe richiedere il ritiro del contingente militare russo.
G. BENSI, La Cecenia e la polveriera del Caucaso..., cit., p. 25.
M.R. DJALILI (a cura di), Le Caucase postsoviétique: la transition dans le conflit, Bruxelles 1995,
pp. 1-4; A. FERRARI, La Georgia tra Federazione Russa e Stati Uniti: un modello di transizione
egemonica?, in A. COLOMBO (a cura di), La sfida americana. Europa, Medio Oriente e Asia Orientale
di fronte all’egemonia globale degli Stati Uniti, Ricerca CeMiSS/ISPI, Milano 2006, pp. 56-57.
15
La possibilità che la Russia ricorra alle armi per annettersi l’Ossetia meridionale sono tutt’altro che
remote. Cfr. G. BENSI, La Cecenia e la polveriera del Caucaso..., cit., p. 377.
13
14
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
46
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 47
La politica estera russa e il Caucaso
Non va dimenticata la differenza fra le dichiarazioni ufficiali del governo russo, basate su una politica di buon vicinato con le repubbliche ex sovietiche, e la
realtà del fatto che essa viene intesa in senso territoriale, cioè come una “cintura”,
uno spazio a cerchi concentrici, con al suo cuore sempre la Russia e i suoi interessi regionali e subregionali vitali. Nel Caucaso la classe politica russa vede una
partita essenziale per la sua identità neoimperiale e la conservazione della dignità calpestata di superpotenza di peso mondiale. Infatti non fa distinzioni fra Caucaso settentrionale e Transcaucasia, includendoli in un unico sistema dal peso rilevante, sia in termini economici che di sicurezza e trascurando le suddivisioni fra
dimensione interna e near abroad16. È un po’ quello che accade anche nell’ambito della fascia delle repubbliche occidentali ex sovietiche.
In questo senso pertanto si può parlare di “sganciamento frenato” delle repubbliche ex sovietiche dell’area transcaucasica dall’influenza egemonica dell’ex centro imperiale17. I fattori di contenimento della loro indipendenza reale continuano ad essere molto numerosi e il confronto fra le repubbliche e Mosca rimane impari. In alcuni casi, come quello dell’Armenia, l’influenza russa viene accettata per
ragioni storiche, per le innegabili funzioni che essa ha avuto nella protezione degli armeni di fronte ai paesi confinanti – la Turchia come “nemico ereditario” – e
oggi rispetto all’Azerbaigian. Inoltre, non sempre l’influenza statunitense riesce
a costituire un reale contrappeso alle implicazioni pratiche che la politica russa
comporta nel tentativo di ristabilire il proprio controllo su tutta la regione, estendendolo fino ai confini dell’ex impero sovietico. La politica estera russa nella
Transcaucasia rimane, al di sotto del formale rispetto delle indipendenze riconosciute, contrassegnata da una sorta di spinta interna a salvaguardare e difendere
i propri interessi vitali utilizzando tutti gli strumenti costanti della politica e della strategia, dal divide et impera al rapporto protectio/oboedientia, allo sfruttamento dell’arma energetica, a quello delle “leve etno-nazionali” e culturali (sia nelle
repubbliche principali che negli attori minori e subnazionali), alla ricerca di referenti che possano costituire una testa di ponte utilizzabile nella regione.
Se è vero che lo strumento energeLo sganciamento delle repubbliche transcaucasiche
tico è stato il grimaldello con il quale
la politica statunitense è riuscita a in- dal controllo russo potrebbe rivelarsi un’illusione
serire un dato nuovo e irriducibile nel- di breve periodo
l’equilibrio geostrategico dell’area, è anche vero che nel lungo periodo l’impegno
americano ancora di tipo full spectrum dominance rischia di esaurirsi per sovraccarico e sovraestensione, vulnerando in profondità il vecchio disegno, delineato
come noto da Brzezinski18, di penetrazione massiccia nella regione, lasciando così alla politica estera russa maggiori possibilità di ristabilimento di un ruolo egemonico. L’interesse che l’Europa e le istituzioni euro-occidentali dimostrano poi
nei confronti di Georgia e Azerbaigian rimane estremamente limitato nonostante
A. FERRARI, La Georgia tra Federazione Russa e Stati Uniti..., cit., p. 57.
Ibidem, pp. 56-57.
18
Z. BRZEZINSKI, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives,
New York 1997; trad. it. La grande scacchiera, Milano 1998.
16
17
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
47
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 48
La partita nel Caucaso
l’estensione nel giugno 2004 della Politica europea di Vicinato ai paesi transcaucasici. Come accade per le altre repubbliche occidentali ex sovietiche escluse dagli
allargamenti, anche per le repubbliche indipendenti transcaucasiche questo favorisce la lenta ripresa del peso della politica estera russa, che passa anche per il
mantenimento di basi militari in loco, ritenute di vitale importanza per impedire il prevalere dei governi più ostili a Mosca o la riconquista delle entità (ad esempio Abkhazia e Ossetia meridionale) appoggiate dalla Russia.
La difficoltà di aprirsi integralmente a Occidente significa, per le repubbliche
che aspirano a fuoriuscire dall’ex orbita imperiale, continua ricaduta nella stagnazione, corruzione endemica, paralisi politica ed economica. La Georgia dipende fortemente dalla Russia per gli approvvigionamenti energetici e per la sua
ripresa economica; rimane infatti inserita nelle sopra citate relazioni di dipendenza interrepubblicane di marca sovietica e la pretesa di sganciamento nel breve periodo è un’illusione, come dimostra la profonda crisi economica georgiana, dalla quale non basta a salvarla la “relazione speciale” con gli Stati Uniti o l’apertura di nuovi oleodotti19. La possibilità che la presenza e il dispiegamento strategico statunitense nell’area, per quanto in futuro potenziabili, possano diventare un
ostacolo effettivo agli interessi e alla politica estera russi nell’area, rimane remota e molto debole. Sono del resto sempre più frequenti gli inviti americani alla
prudenza sulla questione, così come le pressioni politiche per rendere più autonome le singole dirigenze nazionali caucasiche, responsabilizzandole anche nei
confronti dei contrasti interetnici interni, senza dover impegnare in futuro la superpotenza in un contrasto pericoloso e inconcludente con la Russia, che pur non
rinuncia ad ingerirsi negli affari interni delle repubbliche transcaucasiche.
Conclusione
La politica estera russa nel near abroad rimane condizionata non solo dalle sue
forze interne consolidatesi nei secoli, ma anche dalle attuali condizioni storiche
che vedono specifici rapporti con l’Occidente. Infatti le potenzialità insite nell’apertura e nella cooperazione con le istituzioni euro-occidentali, che renderebbero obsoleta la politica egemonica esclusiva nelle regioni a ridosso dell’Europa
istituzionale, rimangono paralizzate da antistoriche chiusure nei confronti della
Russia e da ancora scarsi luoghi di confronto e di accordo sul Caucaso. L’Europa
istituzionale comunitaria attuale alimenta, molto più della Nato estesa a Est20, il
senso di esclusione della Russia, cosa questa che si salda con il suo storico senso
di inferiorità nei confronti dell’Europa occidentale, con la sindrome dell’accerchiamento21 e che ha sempre stimolato, per reazione, chiusure anche da parte russa e revanscismo imperiale. Un problema molto grave questo, che stimola in RusA. FERRARI, Il Caucaso. Popoli e conflitti..., cit., p. 98.
Enlargement a Est che infatti è stato sopportato fino a oggi con meno problemi. Mi permetto
di rimandare, per questo argomento, ad A. VITALE, Ogólne uwagi i oficjalne stanowisko Woch
w kwestii rozszerenia NATO na Wschód, in Fundacja Mi´dzynarodowe Centrum Rozwoju
Demokracji – Friedrich Ebert Stiftung, Polska a dalsze otwarcie NATO, Kraków, 1999, pp. 61-70.
21
J.C. ROMER, Géopolitique de la Russie, cit., pp. 96-102.
19
20
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
48
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 49
La politica estera russa e il Caucaso
sia il tentativo di ristabilire l’area della propria “competenza imperiale”, geopolitica e geostrategica, a differenza di tutto quello che “sta al di fuori”, con una nostalgia per l’egemonia potenziale russa sull’intera Landmass eurasiatica, dal Baltico al Mar del Giappone, cercando di far coincidere di nuovo Russia ed Eurasia.
Questo non si basa solo sull’idea ossessiva del mantenimento dell’“unità-integrità”
territoriale, fine dichiarato più volte come il principale interesse nazionale russo
(e apparso chiaramente nelle sue implicazioni pratiche con la repressione in Cecenia), ma anche su una reazione rispetto agli assetti esterni e al loro grado di
“chiusura/esclusione”.
In ogni caso, è certo che le chiusure dell’Europa comunitaria hanno un forte impatto regionale, come dimostrano le attuali relazioni russo-ucraine, russobielorusse, russo-georgiane e russo-azere e possono favorire, in una Russia spinta dopo il 1991 sempre più verso Oriente, i sostenitori della ripresa del suo ruolo di grande potenza, i sostenitori della potenza imperiale o quei fautori della forza i quali, attorniando il presidente russo, auspicano un rafforzamento e una centralizzazione integrale dello stato (che in Russia rimane per forza di cose “imperiale”), così come un coerente e razionale piano di riacquisizione dell’influenza
russa sulle repubbliche indipendenti, parallelamente a un arresto della penetrazione occidentale22. Possono quindi dare nuovamente forza agli isolazionisti, ai
nazionalisti del “patriottismo imperiale”, a tutti i nostalgici di un impero che oggi avrebbe caratteristiche meno occidentali che mai. Certo, questo non è sembrato preoccupare molto i politici occidentali, i quali in gran numero guardano con
favore a un rafforzamento del potere statale in Russia, così come si auguravano,
in maggioranza, che l’impero sovietico non crollasse. Il problema è che in Russia
uno “stato forte” non è affatto sinonimo di “stabilità politica”, quanto piuttosto
di potere imperiale omogeneizzante e centralizzante, con tutte le conseguenze interne ed esterne, nei confronti dei paesi confinanti, che questo può provocare.
Va tenuto presente che come l’Unione Europea in questo processo di chiusura è favorita dai grandi spazi sui quali si estende, così lo è anche la Russia. Per questi grandi spazi amministrativi (o militarizzati) è infatti molto più facile mantenere pretese territoriali di tipo statuale moderno, comprese quelle espansioniste,
così come dotarsi di rigidi confini, rispetto a quanto non lo sia invece per comunità politiche più piccole e di dimensioni più ridotte. Queste ultime non possono infatti durare a lungo se non si aprono verso l’esterno, sia per ragioni economiche (il prezzo dell’autarchia per i piccoli stati è molto maggiore che per i grandi e a lungo andare è insostenibile), che per ragioni politiche: transborder cooperation e integrazione diventano necessarie per non rimanere soffocati. I grandi
spazi politici incontrano difficoltà molto minori a minare le politiche di creazione di una transnational community, ad esempio in Europa.
Se l’Europa comunitaria ha contribuito a rafforzare un “cordone sanitario” dal
22
J. BUGAJSKI, Russia’s New Europe, in «The National Interest», 2003/2004, 74, p. 84.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
49
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 50
La partita nel Caucaso
Baltico al Mar Nero, isolando per dieci anni la Russia, questo ha favorito in quel
paese anche una ripresa della retorica “organicista” di stampo neoimperiale, che
si trova espressa spesso chiaramente nei discorsi politici russi più diffusi e che toccano un tasto sensibile di quella cultura politica. L’allargamento della Ue del resto ha il duplice effetto di rendere l’Europa comunitaria più chiusa geograficamente (ed economicamente) e più distante per la Russia, provocando un approfondirsi del gap economico e sociale, marginalizzando questo importante paese
eurasiatico. Nel Caucaso non si trattava di ingerirsi in questioni interne complesse e problematiche, ma semplicemente di superare le chiusure, che invece rischiano di riproporsi con la prospettiva dell’ingresso della Turchia nella Ue, che dovrà, com’è avvenuto per i paesi dell’Europa centrale, rafforzare le sue frontiere e
applicare le politiche protezioniste eurocomunitarie.
L’influenza dei fattori internazionali può dunque essere molto cogente nelle
scelte russe di politica estera. La chiusuLa chiusura occidentale nei confronti di Mosca incentiva
ra occidentale offre incentivi alla pretele istanze russe favorevoli all’esercizio di un controllo po- sa russa di stabilire una preponderanza
litico ed economico del Caucaso
economica e militare nello spazio eurasiatico, e in quello caucasico in particolare, e influenza la scelta fra una via di hard
domination (con la fine dell’indipendenza dei suoi vicini ex sovietici) o di soft domination (con solo un’influenza culturale ed economica, accettata dai vicini):
queste opzioni non sono solo condizionate da variabili interne quali la debolezza o gli alti costi di un’eventuale svolta neoimperiale.
A queste forti tendenze possono rispondere solo consistenti politiche di cooperazione con la Russia e non di chiusura da parte euro-occidentale (come in una sorta di immotivata continuazione della vecchia politica franco-inglese che tentava di
mantenere la Russia al di fuori del Caucaso, appoggiando contro di lei alternativamente impero ottomano e Persia o peggio ancora in una continuazione della guerra fredda) e delle stesse repubbliche indipendenti, come accade invece con la nuova politica dei visti, pur nel giustificato rifiuto di tentativi di restaurazione imperiale o di integrazione politica ed economica “alla russa” (cioè relazioni di dominazione e di sottomissione imperiale), ma prendendo atto delle inevitabili conseguenze che le chiusure provocano nell’area da sempre23 e della possibilità della cooperazione internazionale (anche fra americani e russi) in un’area che non possiede
come destino ineluttabile quella di sottostare a una potenza imperiale esterna24. Le
nuove chiusure statali-nazionali nel Caucaso rischiano di alimentare il revanscismo
imperiale russo nella regione – esasperato anche dall’incapacità ormai più che decennale della classe politica russa di trasformare l’ex centro imperiale in un polo
d’attrazione naturale per le nuove repubbliche indipendenti (anche per il pessimo
esempio dato con la distruzione della Cecenia) – ma lo stesso può paradossalmente fare l’attendista e tardiva Politica europea di Vicinato.
Le difficoltà di comprensione fra russi e caucasici durano da secoli, sia a causa di chiusure
culturali delle popolazioni montanare non solo della Ciscaucasia, ma anche della Transcaucasia,
sia a causa della mancata accettazione da parte russa del forte sentimento di indipendenza che
caratterizza queste popolazioni: tutti elementi ricorrenti che paralizzano la reciproca
collaborazione. Sui precedenti storici: A. FERRARI, Il Caucaso. Popoli e conflitti..., cit., pp. 35-37.
24
I nuovi forum economici russo-transcaucasici stanno dimostrando quanto siano consistenti
le prospettive di una cooperazione priva di tensioni.
23
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
50
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 51
Turkey’s Policies toward the South Caucasus and its Integration in the EU
Mustafa Aydin
Turkey’s Policies toward the South Caucasus
and its Integration in the EU
Geopolitical Changes in the Post-Soviet Caucasus
The Caucasus has been in the forefront of world attention since the end of the
Cold War, mainly because of nearby hydrocarbon resources and plethora of ethnic conflicts. Moreover, the region has had to contend with regional and international rivalries of outside powers for influence. Since 1991, the region has witnessed four ethnically motivated conflicts (Nagorno-Karabakh, Abkhazia, South
Ossetia and Chechnya) with varying degrees of international involvement and
plenty of regional complexities, making it one of the hot spots of the world. All
four conflicts were for secession and have not yet been resolved. The existing instruments for conflict resolution and peacekeeping such as the UN, OSCE and
NATO, as well as the security and confidence building agreements like the CFE
Treaty, have proved to be inadequate to deal with these new/old challenges and
have so far only been partially successful in containing (not solving) them. They
have become, to all intents and purposes, what are now popularly called “frozen
conflicts”.
Several factors have exacerbated violence in the Caucasus. First of all, domestic sources, such as ethnic diversity, religious differences, economic inequality and
less than fully democratic governance throughout the region have to be mentioned. In addition to the challenges of economic and political transition, Caucasian states, since independence, have had to contend with populations searching for and developing a sense of national identity. Thus, since independence,
they have been struggling with the need to replace the social and economic model based upon socialist ideology with a new thinking that could also help them to
define their separate “identities”. Although the Soviet Union had created three
union republics in the Caucasus, it did not support national identities, rather creating a mixture of tribal and ethnic groups. Resulting ethnic overlap became a
recipe for crises once the restraining authoritarian control of the Soviet Union
collapsed.
The situation is further complicated by the diversification of religious faiths
that are closely related to separate national and ethnic identities. The role of religion, especially the fears from radical Islam taking root above all in northern
Caucasus as a result of unpredictable changes, disillusioned hopes, economic
deprivation and lack of employment opportunities, has been discussed extensively within and without the region. It has so far proved more of a source of anxiety
MUSTAFA AYDIN,
Professor of International
Relations at the Economic
and Technology University
of Ankara, as well as at
the Turkish National
Security Academy.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
51
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 52
La partita nel Caucaso
than a real threat, though religious fanaticism could still turn out to be a dangerous factor in the future, especially in the context of North Caucasian separatist
movements against the Russian Federation.
The rapid economic and social changes since the Soviet collapse have left
many people with a much lower standard of living than they previously had, and
without the social safety net that had benefited them under the Soviet regime.
These rapid changes and economic pressures have led to widespread individual
and institutional corruption, while the hasty exploitation of the regional hydrocarbon resources has caused environmental damage to the unique ecosystem of
the Caspian Basin. Although these resources offer tremendous economic opportunities, the uneven development patterns especially within the countries that
own the resources (i.e. Azerbaijan in the Caucasus) are also a significant potential source of instability. Differences in the natural resource bases could also provoke economically driven migration, polarize ethnic groups, and cause increased
tension. It is also worth considering what effect the anticipated wealth resulting
from the natural resources will have on the regional problems, such as NagornoKarabakh between Azerbaijan and Armenia.
The regional leaders had earlier concluded that, given the present volatile conditions in their countries, a period of authoritarian rule was necessary in the
transition from communist totalitarianism to liberal democracy. Thus, while the
struggle for national identification went on within each republic, authoritarianism provided a tempting solution as “the only way to keep the country together”.
However, this created a source of long-term trouble as it put a lid on boiling problems, preventing ventilation and causing violent eruptions in the longer term.
The replacement of this ideology with a more democratic version of governance
through successive popular revolutions – which currently seems to be the dominant theme in post-Soviet Eurasia – also risks creating sources of instability, at
least in the short-term.
On the international level, the iniThe power vacuum created in the Caucasus by the
tial power vacuum created in the region
collapse of the USSR attracted a lot of external powers
by the collapse of the Soviet Union had
attracted many external powers into playing a dangerous game. Among the countries envisioned to play a key role were the Russian Federation, Turkey, Iran, the
United States, and lately the European Union. Obviously, each power has had its
specific objective, and the competition so far has had economic, political, ideological and religious dimensions. While Russia initially welcomed Turkish influence in the region as a counterweight against Iranian dominated pan-Islamism,
these views by now have shifted, and Russian-Iranian relations rapidly developed
after initial suspicion and reached an all-time high, with Iran becoming not only an important trading partner and profitable arms customer, but also an impor-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
52
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 53
Turkey’s Policies toward the South Caucasus and its Integration in the EU
tant exponent of Moscow’s interests in the region and a counter against the growing influence of the West in general. However, with the increased presence of the
US in the region since September 11, the regional balance of power has yet again
changed decisively. Though the EU has also become more involved in regional affairs through its Special Representative for the Caucasus and recent inclusion of
the region into its new Neighbourhood Policy, it is clearly the US and the Russian Federation that are currently at the forefront of the international competition
for influence.
The legal quandary over the definition of the Caspian Sea’s status and the controversy surrounding the issue of transporting natural resources out of the region
have also affected regional politics. Obviously, the full potential of regional wealth
can only be enjoyed widely if its energy resources have a stable access to international markets. This motivates regional states to co-operate and provides an incentive for international efforts to resolve the region’s conflicts. At the same time,
the undetermined status of the Caspian Sea has prevented regional countries
from exploring their full potential for foreign direct investment and transportation of the hydrocarbon deposits under the Caspian seabed. Moreover, competition among countries to host the pipelines out of the region also created possibilities for conflicts. What was at stake was the oil and gas transit revenues that
countries could extract from the pipelines passing through their respective territories and – more importantly – the pipeline network, considered as one of the
key factors for securing influence throughout the region. The flowing of oil from
the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline later this year would clearly weaken the economic and transport (thus political) dependence of Caucasian states on Russia.
Azerbaijan would emerge as a new competitor for Russian oil and gas; the role of
the Western states, whose oil and gas companies provide necessary investments,
will increase, as will the role of Turkey; and EU countries would be able to diversify their oil and natural gas sources.
Turkey’s Approach toward the Caucasus since the End
of the Cold War
Since the worldwide changes experienced from the late 1980s onwards, Turkey
has found itself at the centre of Eurasia which has become the focal point of global geopolitics, and has been cited as an important actor because of its strong historical, cultural, ethnic and linguistic bonds with the newly independent states of
Eurasia. The emergence of eight independent states (three in the Caucasus) to
Turkey’s northeast at the end of the Cold War presented Turkey with both opportunities and potential risks.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
53
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 54
La partita nel Caucaso
Having based its post-war foreign and security policies on the strategic importance for the West of its location vis-à-vis the Soviet Union, Turkey at first took a
lukewarm approach towards the end of the Cold War. While the emergence of liberal democracies in Eastern Europe created a buffer zone between Western Europe and Russia, Turkey still felt threatened by the lingering uncertainties regarding its immediate neighbourhood. At this juncture, the emergence of newly independent states beyond its Caucasian border was a challenge.
When faced with the opportunity to establish relations with the individual Soviet republics after Gorbachev’s opening of the Soviet system from 1985 onwards,
Turkish policy was initially designed to avoid perception that it was seeking to undermine the USSR. Since then, however, Turkish policy toward the Caucasus has
changed dramatically, and after the USSR formally broke up in December 1991,
the implementation of a new policy soon followed. Turkey became the first country to recognize the independence of the new republics (Azerbaijan on December 9; Georgia and Armenia on December 16), and signed protocols with them
(except Armenia), initiating diplomatic relations. As a result, by the end of 1991,
Turkey completely abandoned its Moscow-centered stance, and embarked on a
program of active relations with the Caucasian states.
Although cultural, linguistic, and reBy the end of 1991, Turkey embarked on a program
ligious affinities were stimulating factors
of active relations with Caucasian states based on
for forging closer ties with Azerbaijan,
Ankara’s new attitude toward the repragmatic policies
gion was based more on pragmatic economic and foreign policy considerations.
Foremost, changes in the international environment forced Turkey to play an enlarged role in regional politics. Turkey expected to gain economic benefits from
the development of closer ties with the Caucasian republics. There was also an expectation that Turkey would become more influential in regional and global politics. Finally, Turkey’s secular and democratic credentials were expected to enhance its importance as a model for future development in the region.
While Turkey was aiming to achieve a greater role in the Caucasus (and Central Asia), the fear that the vacuum left by the collapse of the Soviet Union could
lead to Islamic fundamentalism among the Muslims of Eurasia led the West (Europe as well as the US) to promote Turkey as a Muslim, yet secular and democratic model. Thus, as a result both of growing self-confidence about its potential and
political support of the West, Turkey felt ready to take advantage of the new economic and political opportunities when the new states emerged from the former
Soviet Union. Despite all the promising signs, however, it quickly became clear
that Turkey was neither fully capable nor alone in its bid to fill the power vacuum. On the contrary, the competition between the rival countries seeking influence in the rapidly changing Eurasia included the Russian Federation, Turkey,
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
54
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 55
Turkey’s Policies toward the South Caucasus and its Integration in the EU
Iran, and the US among others. Thus, various possibilities for conflict among the
regional rivals shortly emerged.
From the Turkish perspective, the possibility of a confrontation with either
Iran or Russia created disquiet. Turkey was concerned that Iran would attempt to
have an impact on identification of Muslim people both in North and South Caucasus, an apprehension shared at the time by the Russian Federation and the
West generally. Iran, on the other hand, worried that Turkey’s active role in the
region might create a Turkic hegemony on its northern and western frontiers.
Thus, a competition ensued briefly between the two opposing models of political development: the secular model of Turkey with its political pluralism and the
Islamist model supported by Iran. While Turkey became the first country to extend recognition to Azerbaijan, Iran did not conceal its concern over the Turkish
action, accusing Turkey of pan-Turkism, and the West of instigating such sentiments. Fears were expressed that the Turkish recognition would encourage an independent Azerbaijan to lay claim to a “greater Azerbaijan”. Even though Turkey
never played to such sentiments, Iran still dreaded such a possibility.
While locked in an influence comThe growing competition between the rival countries
petition with Iran, Turkey at the same
time did not wish to alienate or alarm seeking influence in the changing and challenging
Moscow by exerting too much influ- Caucasus includes Russian Federation, Turkey,
ence in the region. In the meantime Iran and the US
Russia, becoming increasingly concerned about Turkish intentions in the region,
became more aggressive in its assertion of its own rights in its “near abroad”. This
put Russia and Turkey on the opposite sides of a developing axis in the region.
Turkey, on the other hand, realizing the Russian sensitivities regarding ethnic
strife in the Caucasus, repeatedly reassured Moscow of its opposition to any further fragmentation of Russia, and has since 1995 adopted a policy stressing that
the benefits of cooperation with Russia are still greater than those of the rest of
the former Soviet republics.
In the meantime, Turkey’s relations with Armenia in the Caucasus have been
an especially delicate topic because of a number of issues, such as the border between the two states and the historical baggage that they brought into the relations.
Although Turkey recognized Armenian independence without any preconditions,
the border between the two countries immediately became a source of controversy as the latter has consistently refused to recognize the common border, originally drawn by Gumru Treaty signed on December 2, 1920 between Turkey and the
short-lived independent Armenian Republic, and later confirmed by the Kars
Treaty of 1921 between Soviet Union and Turkey. After the collapse of the Soviet
Union, however, some Armenian Parliamentarians called for non-recognition of
the borders established by the Kars Treaty. Moreover, the preamble of the Armen-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
55
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 56
La partita nel Caucaso
ian Constitution implicitly laid claims on Turkish territories by referring to Armenian Independence Declaration that called for restitution of the territories «unjustly lost during and after the First World War». Thus, in the spring of 1992,
Turkey stipulated that it would not proceed to formalize diplomatic relations with
Armenia until it provided formal written recognition of existing borders.
Apart from the border issue, references in the Armenian Independence Declaration to «killings of Armenians by the Ottoman Turkey in 1915» and later Armenian efforts to obtain international recognition for it also created tension between the two countries. Although former Armenian President Ter-Petrosyan,
recognizing the need to enhance his country’s relations with Turkey on a realistic basis, refrained from bringing the issue into the agenda and thus offered an
opening, developments in the Caucasus, i.e. the Karabakh problem, had prevented further reconciliation between the two countries. With the advent of nationalist Robert Kocharian into power in Armenia in March 1997, the possibility of
rapprochement between the two countries was shelved for a time. Armenian signature of a friendship and cooperation agreement with Russia in 1997, allowing
Russian forces to be stationed in the country, also put Armenia and Turkey on the
opposite sides of the emerging political alignments in the region.
The Karabakh problem has been an important constraint on Turkish policy
towards the Caucasus in general. It has presented difficult options for Turkey.
There exists a longstanding public sympathy for the Azeri cause in Turkish public opinion, which has strongly encouraged the Turkish government to side with
Azerbaijan. The Turkish governments, however, have so far refrained from acting
on pressures for direct intervention and choose to mobilize international response to the problem. Nevertheless, the conflict firmly underscored the dilemmas that face Turkey in its efforts to maintain neutrality regarding ethnic conflicts
in the former Soviet republics. Turkish policy in relation to Karabakh mainly
aimed to prevent escalation of the conflict to a level that seriously threatens Turkish security, and thus compels it to intervene militarily. But it also stopped the
tentative moves from both sides of the Turkish-Armenian border to put an end
to historic differences.
Azerbaijan, on the other hand, was on top of the list of countries that everybody expected Turkey to have close relations with in the post-Cold War era. To
the point, Turkish-Azeri relations started off in 1991 with a leap forward based
on cultural, linguistic, and historic links as well as shared economic, political and
strategic interests. In time, Turkey has become the only country that consistently supported Azerbaijan in its struggle over Karabakh, risking its relations with
Armenia and Russia along the way. Although the harmonious relationship between the two countries established during the presidency of Ebulfeyz Elchibey
was somewhat cooled down with the advent to power of Heydar Aliyev in Azer-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
56
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 57
Turkey’s Policies toward the South Caucasus and its Integration in the EU
baijan, the cooperation continued and even expanded after a brief interregnum
into various domains. Apart from strategic cooperation against Russian attempts
to re-establish its dominancy over the Caucasus, the two countries have been cooperating on the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline project, on Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas pipeline project, various cultural programs and thriving trade,
as well as the establishing and training of a national army of Azerbaijan.
Georgia, too, rapidly became one of Turkey’s important foreign policy openings after the collapse of the USSR. Relations have thrived on the Georgian opposition to Russian dominance in the Caucasus, its support for the realization of
the BTC project, and its willingness to cooperate with Turkey on different areas,
from tourism to security. Turkey, in return, has been more than willing to extend
its friendship, economic, political and military support to Georgia, which offered
a foothold in the Caucasus and a gateway to Central Asia. In contrast to Russian
meddling with ethnic issues in Georgia, Turkey’s bipartisan approach to Abhazian and Ossetian problems and continuing reaffirmation of Georgia territorial
integrity greatly helped to enhance the relationship. As a result Turkey became the
biggest trade partner of Georgia shortly after its independence and, in the words
of former Georgian President E. Shevarnadze, a strategic partner. In addition,
starting with a cooperation in military education, Turkey, under the PfP program,
offered its advice and help to Georgia in establishing the Georgian army. The two
countries then moved on to cooperate in the restoration of Marnauli airfield and
Vaziyani military base in Georgia after the withdrawal of the Russian forces. Recently, when Georgia was again put under pressure by Russia in the aftermath of
9/11, with accusations that it was harboring Chechen gunmen, Turkey, with
American backing, was again forthcoming in its support. Finally, the arrival of
American military advisers to Georgia in the wake of 9/11 and recent change of
government sealed Georgia’s western orientation. This, together with TurkishGeorgian-Azerbaijani three-party security cooperation, is poised to bring a new
dimension to evolving Caucasian geopolitics.
Clearly, the emergence of indeWith the emergence of independent republics in the
pendent republics in the Caucasus after the collapse of the Soviet Union Caucasus, Turkey has become one of the important
represented a turning point in players in a region where it previously had only
Turkey’s regional role and policies. It a marginal influence
has become one of the important players in a region where it previously had only a marginal influence and no active involvement. Although economic and political conditions in the region are unlikely to stabilize for some years, it is without doubt that Turkish policymakers will continue with their efforts to create new
networks of interdependency between Ankara and the regional capitals. Even if
Turkey’s initial vision towards Eurasia in general proved somewhat unrealistic,
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
57
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 58
La partita nel Caucaso
the effects it generated did set the tone for Turkish policy for the rest of the 1990s
and early 2000s. While Turkey has not necessarily become the model to which the
new states of the Eurasia aspire, its thriving private sector, its secular approach toward Islam and its functioning democracy continue to have their appeal in the
region.
Turkey’s EU Integration and the Caucasus
The expected enlargements of the Union, taking in Romania and Bulgaria by
2007 and Turkey sometime around 2015 will carry the EU to a new geography
and a set of new neighbours that it had so far a limited experience dealing with.
The relevance of the Caucasus for the EU has clearly increased since the end of
the Cold War as it has increasingly become difficult to manage as a result of contested borders, mixed ethnic groups, enforced migration, economic deprivation,
widespread unemployment, authoritarian regimes, bad governance, and competition of outsiders for influence. Other volatile and widespread elements, such as
poverty, corruption, organized crime and territorial claims, threaten continuously to undermine both the existing regimes and the equilibrium in the region.
The consequences of such an event would be felt throughout Eurasia and would
inevitably have a significant impact on Europe1.
The existence of Western-based multinational oil companies in the region clearly indicates an increased Western interest in gaining access to Caspian oil and gas.
While the possibility of transferring large-scale oil and gas deposits to Europe raises hopes for regional economic development and prosperity, European dependency on Middle Eastern oil and Russian natural gas, together with declining North Sea
production, raises the safe and uninterrupted supply of a new source, coming out
of the Caspian Basin through the Caucasus, to utmost importance. This aspect of
the security of the European energy supply inevitably brings a number of related
issues to Europe’s doorstep. Among others, the disagreement on the status of the
Caspian Sea; competition among the regional countries to host pipelines towards
Europe; and threats to a steady supply of energy sources as a result of domestic instabilities in the region would clearly affect wider Europe.
From the financial perspective, there are a number of European companies
operating in the region, linking Europe to the instabilities and structural problems of the Caucasus. Threats to stability in the region, an obvious gateway between energy rich Caspian Basin and Europe without much alternative, would
clearly affect European economies. Therefore, the EU is keen for the resolution
of the various conflicts in the region and changing of the code of conduct between regional countries. Moreover, various problems emerging from the region
1
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
58
For further analysis of regional problems and their relevance to Europe see M. AYDIN, Sources
of Insecurity and Conflict in the Caucasus and the Black Sea Region, in «Turkey Insight»,
November 2001, pp. 125-147; idem, Volatile Politics and Constancy of Instability in the Caucasus
and its Effects on the Mediterranean Stability and Security, in A. MARQUINA - H.G. BRAUCH (eds.),
The Mediterranean Space and Its Borders: Geography, Politics, Economics and
Environment, Mosbach and Madrid 2001, pp. 167-198.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 59
Turkey’s Policies toward the South Caucasus and its Integration in the EU
(ranging from environmental disasters, smuggling of drugs, people and guns
across the region to ethnic-based conflicts, border problems and demographic
challenges) have the potential to spill over into the EU area, threatening disruption of the smooth functioning of the EU economy and political stability. With
the planned enlargements in the near future, bringing the EU nearer to the region, these issues acquire even more urgency for the EU, which has to find ways
to avoid the escalation of problems before they affect European countries.
Although the European Commission’s Wider Europe-Neighbourhood Communication in March 20032, in a clear oversight, left the Caucasian countries out
of the EU’s “neighbourhood”, the Thessalonica Council recognized the problem,
and the Luxembourg Council meeting of June 2004 included South Caucasian
countries into the newly renamed European Neighbourhood Policy3. The Union
also appointed a Special Representative to the Caucasus on July 7, 2003, to “develop contacts” and to “encourage the three countries to cooperate on themes of
common interest”. He was also given the task of “assisting the countries of the
South Caucasus in carrying out political and economic reforms, preventing and
assisting in the resolution of conflicts, promoting the return of refugees and internally displaced persons, engaging constructively with key national actors
neighbouring the region, supporting intra-regional cooperation and ensuring
coordination, consistency and effectiveness of the EU action in the South Caucasus”4. The appointment reflected the end result of discussions within the EU on
the need for a reinforced and enhanced EU role in the region.
However, the EU has so far failed to
Turkey’s EU integration will provide the Union with
find ways to positively affect the political reforms in ethnically problematic needed direct access, deeper understanding and strong
Georgia, territorially threatened Azer- inroads to the South Caucasus
baijan, or Russian-leaning Armenia. It also failed to promote suitable solutions
to currently frozen conflicts in the region, which affect trade, security, and regional cooperation. Illegal immigration, drug trafficking and organized crime activities that in general cause concern in Europe, also continue without much improvement. Finally, the inefficient border control agencies and widespread corruption creates a transit route through the Caucasus for much of the heroin
seized in the EU.
Overall, the situation in the region, though stabilized, does not lend credit to
hopes for rapid improvement in security and stability in the near future. None of
the separatist conflicts has yet been solved satisfactorily, and prospects for their
solution are unpromising. The instability due to frozen conflicts continues to feed
profitable criminal activities, terrorism, and further migration. The political sta2
3
4
European Commission, Wider Europe-Neighbourhood: A New Framework for Relations with our
Eastern and Southern Neighbours, Communication from the Commission to the Council and the
European Parliament, COM(2003) 104 final, 11 March 2003.
Council Conclusions on Wider Europe-New Neighbourhood, 16 June 2003, par. 3;
<http://europa.eu.int/comm/external_relations/we/doc/cc06_03.pdf>; Council of the European
Union, 2590th Council Meeting (Luxembourg, 14 June 2004), Press Release 10189/04,
<http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/040614_GAERC_Conclusion_on_ENP_(provisional_
version).pdf>.
Decision Taken by Written Procedure, 11027/23, Brussels, 7 July 2003.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
59
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 60
La partita nel Caucaso
bility in the region cannot be guaranteed while these conflicts remain unsolved.
It is also clear that the migration and population displacements emerging as a result of conflicts, decreasing standards of living or environmental catastrophes can
create insecurity, heighten ethnic tensions, undermine regional social order and
consequently affect the nearby EU countries.
In all these areas of concern, Turkey’s EU integration will bring the Union
closer to the region and will allow it to develop more effective policies from a
more approachable position. Turkey will provide the EU with much needed direct access, deeper understanding and strong inroads to the region that have been
lacking and desperately needed in the Union.
One of the most efficient ways to deal with regional security problems would
be to establish conflict prevention and crises management mechanisms, which
can be developed easily with European help and expertise. In this context, the
Turkish proposal to establish a Caucasian Stability Pact along the lines of the Stability Pact for Southeast Europe is an innovative and inclusive idea, and could be
developed further as Turkey’s integration into the EU progresses. The overwhelmingly positive answer Turkey received both from regional countries and also from the world’s leading countries to the original proposal, shows that the
need to establish such a cooperation arrangement in the region is widely recognised. What is required, however, is a political drive and economic support from
outside the region, both of which the EU can easily provide.
Since various dormant conflicts are the main obstacle for further regional cooperation and enhancement of peace and stability on the doorstep of Europe, the
EU should also help their solution by offering its good offices as a way out of the
current deadlock. The appointment of the EU Special Representative to the South
Caucasus was a start. However, with his limited mandate and without a regional
power base, he was not able to accomplish much in the region. Turkey, as an influential neighbouring country to the Caucasus, could easily provide both easy
access to the decision makers of the region, as well as necessary logistical support
and political clout to the EU Special Representative should its integration process
with the EU develop up to such levels.
After a successful solution of the various conflicts, the next step would be rehabilitation of the former conflict zones, with support to grassroot civil initiatives
and NGO activities in an attempt to further consolidate civil society and democratization in the region. As part of the ethno-political problems in the region
stems from the intolerances of majorities toward minorities, further democratization would also contribute to solving the conflicts. The EU has the expertise to
take a leading position in these efforts.
Given the importance of multilateral cooperation in the field of energy and the
EU’s need for diversified resources, it should increase support for the implemen-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
60
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 61
Turkey’s Policies toward the South Caucasus and its Integration in the EU
tation of new energy interconnection
Turkey’s aim to become a regional hub for hydrocarbon
network projects in the region. In this,
the main aim should be to establish di- resources could in the long run provide much sought
rect, secure and stable connections be- after energy security to European countries
tween the producing fields of the east and the consuming markets of the west. The
recently agreed proposals between Turkish, Greek and Italian energy authorities
to extend the Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas pipeline to southern Europe has
that very aim. Moreover, Turkey’s aim to become a regional hub for hydrocarbon
resources, including Azeri, Russian and Iraqi oil as well as Azeri, Russian, Iranian
and Turkmen natural gas, could in the long run provide much sought after energy security to European countries.
While aiming for further integrative actions on the energy field, the EU should
also highlight security of supply, competitiveness and protection of the environment as priority goals. To overcome infrastructure (legal, commercial, transportation, etc.) bottlenecks in the region and to improve climate for trade and investment, the EU needs to prepare a region-wide multilateral cooperation agreement/strategy to complement existing bilateral treaties, and support projects with
the emphasis on regional cooperation. Support given to the promotion of regional trade and economic cooperation would in the longer run also help build the
capabilities of the regional states for cooperation as well as conflict resolution.
Any such effort on the EU’s part would inevitably have to include Turkey, the
main connection point between the Caucasus and the EU area.
In addition to extending trans-European networks (transport, energy, etc) to
cover the regional countries, the EU could support development of the regional
solutions to transport, energy and environmental problems, as well as increasing
its support to the creation of suitable environmental infrastructures for sustainable development. The EU could also help regional states to set up more efficient
border control regimes to reduce cross-border crime rates. The EU’s experience
in this area is already extensive and could easily be expanded to include the Caucasian states. With the further integration of Turkey to the EU structures, it is
clear that Turkish borders with the Caucasian countries would become for the
time being the EU’s external border, and as such would require a particular attention for the protection of the EU area from illegal trafficking of humans as well
as drugs and other goods.
Conclusion
The collapse of the USSR has been a mixed blessing for Turkey. While the century-old Soviet/Russian threat to Turkey’s security disappeared, the vacuum cre-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
61
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
dossier
3-10-2006
11:59
Pagina 62
La partita nel Caucaso
ated by this departure in Eurasia has become the breeding ground on Turkey’s
borders for potential risks and threats for regional security. Yet Turkey has become an important stabilizing actor in the emerging Caucasian disorder. The
positive role Turkey may play in this region has been extensively discussed not
only within Turkey but also in the West.
While Turkey has traditionally avoided involvement in regional politics, it has
been unavoidably drawn into the volatile new politics of the Caucasus, where Armenia and Azerbaijan are locked in a potentially expandable conflict, where
Georgian politics is highly unstable, and where Chechens fight to break away
from the Russian Federation. Moreover, its rivalry with Iran and the Russian Federation over influence on the new states of the Caucasus presented risks and difficult policy choices to Turkey. Mindful of these dangers, Turkey has attempted
to play down the importance of these potentially threatening tendencies, sought
closer relations with both Russia and Iran as well as with the Caucasian republics,
emphasizing its moderate secular character together with liberal economy and
democratic tradition. Its integration and accession to the EU will further create
lines of influence in the region, as well as provide direct access between the Union
and the South Caucasus.
It is clear that Turkey has undergone a dramatic shift away from its traditional policy of isolationism, and that Turkish foreign policy is increasingly focusing
on the Caucasus, alongside the Middle East. Although Turkey has disavowed any
intention of intervening militarily in clashes in the former Soviet territory, it is
still conceivable that Turkish forces might be invited by these states to play the
role of peace-keepers between or within them. In this context the ArmenianAzerbaijani conflict has already presented Turkey with a sense of the difficulties
that it might encounter in the near future if it chooses to engage in ethnic and nationalist conflicts in the region.
The emergence of independent republics in the Caucasus has represented a
turning point in Turkey’s regional role and policies. Turkey has become one of the
important players in a region where it had no role to play previously. Although
economic and political conditions in the region are unlikely to stabilize for some
years, it is without doubt that Turkish policymakers will continue with their efforts to create new networks of interdependency between Ankara and the regional capitals. Turkey’s EU connection will clearly aid the latter to enhance these connections. It is also without doubt that the other regional players, i.e. Russia and
Iran, will continue to view these policies with suspicion and challenge them.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
62
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 63
osservatorio internazionale
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 64
internazionale
Alessandro Colombo
Il disincanto iracheno
Le promesse mancate
della guerra contro l’Iraq
ALESSANDRO COLOMBO è
Professore straordinario
di Relazioni Internazionali
all’Università degli Studi
di Milano e Direttore
dell’Osservatorio Sicurezza
e Studi Strategici dell’ISPI.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
64
In qualunque sfera dell’agire umano
e, in particolare, in quella politica, non è
possibile giudicare la buona o la cattiva
riuscita di una decisione se non si tiene
più conto degli obiettivi di chi l’ha presa. Si può sempre immaginare, naturalmente, quali obiettivi avrebbe potuto
avere al loro posto, o rammaricarsi per il
fatto che non li abbia avuti oppure, se si
ha sufficientemente a cuore la sua reputazione, imputargliene sempre di nuovi
in modo che tutto quello che accade appaia comunque razionale, promettente
o, perché no, perfettamente coerente con
le sue “vere” intenzioni. È l’operazione
che molti commentatori fecero quindici
anni fa con Gorbachev, trasfigurato da
riformatore fallimentare dell’Unione
Sovietica ad artefice visionario del suo
superamento. Ed è la stessa operazione
che, in nome della stessa passione per la
coerenza, stanno facendo da qualche anno a questa parte molti nemici e molti
amici dell’America. Convinti per la ragione opposta della sua onnipotenza, i
primi non riescono ad ammettere che
essa abbia potuto subire il trauma
dell’11 settembre 2001 senza almeno
averlo acconsentito e i secondi che essa
non stia ottenendo nella guerra successiva quello che, in fondo, doveva essersi
proposta. Anche a costo di non chiedersi più che cosa, appunto, si era proposta.
1
Se si applica questa elementare regola di giudizio alla guerra contro l’Iraq del
2003, nessuno sviluppo futuro in termini di stabilizzazione o persino di democratizzazione del paese potrà cancellare
il fatto che l’avventura irachena è già
pienamente fallita. Gli aspetti più appariscenti del fallimento sono contenuti
nel ricchissimo paniere offerto tra il
2002 e il 2003 per legittimare la guerra e
sfilatisi a uno a uno nei mesi successivi.
L’assenza di qualunque traccia di armi
di distruzione di massa o di legami tra il
regime di Saddam Hussein e il terrorismo non ha soltanto screditato ulteriormente l’autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di fronte al
quale erano state portate le presunte
prove della colpevolezza irachena, ma ha
intaccato l’impianto stesso della dottrina della guerra preventiva, che presupporrebbe l’esistenza di una intelligence
almeno tanto accurata da potere accertare in anticipo se e dove si trovino le
minacce che è necessario «colpire prima
che siano interamente formate»1.
Se si guarda alle argomentazioni
utilizzate per legittimare la guerra
contro l’Iraq, l’avventura irachena
può già considerarsi pienamente
fallita
Il crescente ritardo nel successo,
che gli Stati Uniti pensavano di avere
già ottenuto al momento della presa di
THE WHITE HOUSE, The National Security Strategy of the United States of America,
Washington, D.C., September 2002.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 65
Il disincanto iracheno
Baghdad, ha tradito la scommessa sulla
quale avevano puntato, di potere evitare
di rincorrere gli altri al momento delle
scelte per aspettare che fossero gli altri a
rincorrere loro al momento del successo,
insieme alla presunzione di potere cooptare ritardatari e recalcitranti alle proprie condizioni e senza impegni sul futuro, manipolando premi e punizioni e
trasformando gli stessi contesti multilaterali in agenzie di ridistribuzione dei
costi politici, economici e militari di
scelte unilaterali. Anzi, nell’attesa di una
fuoriuscita dall’impasse, l’impegno in
Iraq ha prodotto e continua a produrre
un effetto disgregante sul sistema di alleanze degli Stati Uniti sia al di fuori sia,
soprattutto, all’interno della regione,
dove persino tradizionali alleati come la
Turchia assistono con crescente fastidio
all’impatto della politica americana sulla stabilità regionale (a cominciare, naturalmente, dall’evoluzione del Kurdistan). Tanto che, limitatamente a questo
aspetto, l’impasse iracheno rischia di rivelarsi persino più costoso politicamente di quello del Vietnam che, sebbene incomparabile per dimensioni dell’impegno e numero delle perdite, fino al momento in cui si protrasse ebbe almeno il
merito di esercitare un effetto coesivo
sulle alleanze regionali degli Stati Uniti,
fornendo una prova inconfutabile della
serietà del loro impegno a chi a quella
serietà doveva tutta la propria sicurezza.
L’incapacità di ricostruire in tempi
ragionevoli un tessuto di ordine e sicurezza e di conquistare, grazie a ciò, “le
menti e i cuori” della popolazione ha
trasformato sì l’Iraq in un polo di attra-
2
3
Gli Stati Uniti hanno finito per fare
dell’Iraq un failing state e un polo
d’attrazione del risentimento
anti-occidentale
zione politico e culturale per il resto del
mondo arabo e islamico, ma nel senso
opposto a quello auspicato, come magnete non della democratizzazione ma
del risentimento anti-occidentale che
tutti i sondaggi rivelano in fortissima
crescita nel mondo arabo e in tutto il
mondo islamico. Di più: il continuo deterioramento della situazione politica e
militare in Iraq ha materializzato il peggiore dei timori della vigilia2. Per liberarsi una volta per tutte di un rogue state,
uno “stato canaglia”, gli Stati Uniti hanno creato al suo posto un failing state,
uno “stato al collasso”. Mentre, per evitare che questo potesse definitivamente
trasformarsi in un focolaio di instabilità
e terrorismo, hanno dovuto prendersi
direttamente sulle spalle il compito di
controllarne il territorio, trasformando
l’Iraq in una «West Bank delle dimensioni della California»3, ancorata (almeno nell’immaginario dei nazionalisti arabi e dei radicali islamici) a quella
occupata da quarant’anni dalle truppe
israeliane e destinata, come questa, a
dare nuovo alimento alla contestazione
anti-occidentale e al terrorismo.
Il progetto di transizione alla democrazia si è smarrito dapprima nel generale collasso dello stato e poi nella lacerazione dell’identità nazionale irachena
lungo linee di faglia etniche e religiose,
che ha trasformato le elezioni generali
nello stesso tipo di scontato censimento
P.W. SCHROEDER, The Risks of Victory. An Historian’s Provocation, in «The National Interest»,
2001/02, 66, pp. 22-36.
B. CUMINGS, Is America an Imperial Power?, in «Current History», 2003, 102, p. 360.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
65
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 66
internazionale
etnico nel quale si erano già trasformate
le elezioni in Bosnia o in Kossovo, facendone la premessa o di una dittatura della maggioranza o di una scomposizione
del paese dietro la maschera di un improbabile federalismo o di qualche sfortunata e fragile combinazione tra l’una e
l’altra4. Mentre, tanto in Iraq quanto negli altri paesi della regione nei quali si
sono tenute elezioni (più o meno) libere, queste hanno visto l’affermazione di
gruppi e movimenti estranei alle politiche e ai valori occidentali o dichiaratamente anti-occidentali, conformemente
all’altrettanto scontato «paradosso della
democrazia» già denunciato, tra gli altri,
da Samuel Huntington5: «Gli esponenti
delle società non occidentali non vincono le elezioni facendo vedere a tutti
quanto sono occidentali. Al contrario, la
competizione elettorale li induce ad abbracciare quelli che considerano i valori
prevalenti nel paese, e questi hanno solitamente un carattere etnico, nazionalista e religioso». Anche la reazione dei
promotori della democratizzazione ha
seguito il solco già tracciato, negli anni
Novanta, dal sostegno alla messa fuori
legge del Fronte islamico di salvezza in
Algeria e del Partito del benessere in
Turchia dopo i rispettivi successi elettorali. Dalle limitazioni imposte in Egitto
alla libera partecipazione dei Fratelli
musulmani alle intimidazioni rivolte in
comune dagli Stati Uniti e Israele contro
Hamas nelle elezioni palestinesi, l’esportazione globale della democrazia sembra
funzionare come il rapporto tra parlamento e Corona nella Cacania di Musil6:
«C’era un parlamento, il quale faceva un
4
5
6
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
66
7
uso così eccessivo della propria libertà
che lo si teneva quasi sempre chiuso; ma
c’era anche un paragrafo per gli stati di
emergenza che serviva a far senza parlamento, e ogni volta che tutti si rallegravano per il ritorno dell’assolutismo la
corona ordinava che si ricominciasse a
governare democraticamente».
Nello stesso tempo, l’impulso a compensare la nuova intromissione nello
spazio politico ed economico del mondo arabo con il rilancio del negoziato
israelo-palestinese si è arrestato di fronte al “doppio regionale” dell’unilateralismo americano, la politica del “fatto
compiuto” di Israele – che ha continuato a operare al di fuori delle cornici negoziali disegnate da qualsivoglia contesto multilaterale (come l’impalpabile
“quartetto” Usa-Ue-Onu-Russia) gettando sul tavolo, questa volta, il ritiro
unilaterale dalla Striscia di Gaza, la costruzione del Muro e la prosecuzione
della colonizzazione ebraica nei Territori (che è quasi raddoppiata dall’inizio
dei cosiddetti negoziati di pace)7 – col risultato di dare nuovo alimento alla percezione della politica americana e, per
estensione, occidentale nella regione come di una politica iniqua se non, decisamente, neocoloniale.
Infine, invece di intimidire paesi confinanti come Siria e Iran, convincendoli
a rinunciare a perseguire politiche ostili
o addirittura indebolendo i rispettivi regimi politici, l’invasione militare dell’Iraq rischia di avere procurato loro un
ulteriore incentivo a dotarsi di armi di
distruzione di massa in grado di dissuadere future iniziative militari degli Sta-
E.N. LUTTWAK, Iraq: The Logic of Disengagement, in «Foreign Affairs», 84, 2005, 1, pp. 26-36.
S.P. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York
1996; trad. it. Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano 2001, p. 129.
R. MUSIL, Der Mann ohne Eigenschaften, 1930; trad. it. L’uomo senza qualità, Torino 1972, vol. 1, p. 29.
Per una stima aggiornata e capillare, si veda il sito web di B’Tselem. The Israeli Information
Center for Human Rights in the Occupied Territories, <http://btselem.org/English/index.asp>.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 67
Il disincanto iracheno
ti Uniti8, proprio nel momento in cui
l’intrappolamento delle forze armate
statunitensi in Iraq indebolisce la credibilità della loro pressione militare. Mentre la decisione iraniana di procedere
con lo sviluppo dell’energia nucleare in
campo civile – denunciando il diktat
della cosiddetta comunità internazionale come illegittimo in quanto fondato su un principio di discriminazione a
favore di alleati degli Stati Uniti come il
Pakistan e Israele, che la tecnologia nucleare hanno potuto impunemente svilupparla anche nel settore militare – ha
avuto l’effetto di stringere attorno alla
nuova presidenza radicale dell’Iran anche quei settori riformisti sui quali gli
Stati Uniti puntavano per minare dall’interno la repubblica islamica.
Dall’Iraq all’Iran, ai territori
palestinesi, il quadro mediorientale
attuale è tutt’altro che pacificato
Sotto l’effetto combinato di tutti
questi fallimenti, la decisione americana di invadere l’Iraq non ha portato
niente di simile a un rafforzamento della stabilità regionale, anzi ha creato le
premesse per nuovi conflitti e, potenzialmente, nuove crisi internazionali. Il
2006 si presenta totalmente diverso da
come veniva immaginato tre anni fa
dagli strateghi del Greater Middle East:
l’Iraq non è ancora pacificato, un nuovo scontro politico-diplomatico è sul
punto di esplodere con l’Iran e il negoziato israelo-palestinese, che non ha
fatto passi avanti negli ultimi anni, rischia di finire trascinato nella spirale di
8
9
radicalizzazione di tutte e due le parti.
Una strategia alla prova.
Democrazia e ordine
internazionale nella dottrina Bush
Ma al di sotto di questi fallimenti
puntuali e, per i più ottimisti, ancora reversibili, quella che invece è già irreversibilmente fallita è l’intera Grand Strategy della prima amministrazione Bush.
Fondata su una rappresentazione del sistema internazionale del dopo 11 settembre come sistema di guerra, nel quale sarebbero costantemente in gioco gli
interessi di sopravvivenza che hanno
sempre giustificato la sospensione delle
regole ordinarie della convivenza internazionale, e sorretta da una combinazione tutt’altro che inusuale nella politica estera e nel nazionalismo statunitense tra eccezionalismo, trionfalismo e spirito missionario9, la nuova dottrina politico-strategica risponde a una visione
coerente e, a suo modo, intellettualmente sofisticata del ruolo degli Stati Uniti,
ma a prezzo di una semplificazione concretamente insostenibile dell’attuale
contesto internazionale.
La Grand Strategy di Bush, fondata
sulla rappresentazione del sistema
internazionale come sistema di
guerra, è irreversibilmente fallita
L’architettura della dottrina Bush
può essere riassunta in cinque punti, in
ciascuno dei quali elementi innovativi
convivono con forzature teoriche e poli-
D.P. CALLEO, Power, Wealth and Wisdom, in «The National Interest», 2003, 72, pp. 5-15;
R. JERVIS, The Compulsive Empire, in «Foreign Policy», 2003, 137, pp. 82-87.
J. MONTEN, The Roots of the Bush Doctrine. Power, Nationalism, and Democracy Promotion
in U.S. Strategy, in «International Security», 29, 2005, 4, pp. 112-156.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
67
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 68
internazionale
tiche. Il primo punto, oltre che la vera
architrave del nuovo disegno della politica estera americana, è il radicale rovesciamento della concezione dell’ordine
internazionale. Diversamente che durante la guerra fredda e negli anni immediatamente successivi a essa, quando
l’ordine internazionale veniva concepito
in termini di difesa dell’intangibilità dei
confini, delle sfere di influenza e dei
principali accordi internazionali (come
il Trattato Abm), la nuova dottrina americana scompone definitivamente la
triade ordine/intangibilità/containment.
Promuovere l’ordine non equivale più a
difendere la distribuzione esistente dei
diritti, delle risorse e del territorio ma, al
contrario, richiede di imporre mutamenti nell’equilibrio delle diverse aree
regionali, nella loro sistemazione territoriale e persino nel regime politico dei
singoli stati – come è già avvenuto con
l’abbattimento del regime di Saddam
Hussein e come è annunciato nel progetto complessivo della Greater Middle
East Partnership concepito dal Dipartimento di Stato Usa in preparazione del
vertice del G8 del giugno 2004: «Il Grande Medio Oriente potrebbe continuare
sulla stessa strada, allargando ogni anno
la propria popolazione di giovani impossibilitati a godere di sufficiente occupazione, di sufficiente istruzione e di
sufficienti diritti politici. Se ciò accadesse, questo porrebbe una minaccia diretta alla stabilità della regione e all’interesse comune dei membri del G8. L’alternativa è la strada delle riforme»10.
Questa revisione del concetto dell’ordine internazionale è, con ogni pro-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
68
10
Per la dottrina Bush, la promozione
dell’ordine passa attraverso la
revisione dello status quo piuttosto
che la sua difesa
babilità, il principale punto di forza della dottrina Bush. In essa convergono il
riconoscimento anche teoricamente
realistico dell’impossibilità di perpetuare nell’attuale contesto internazionale la
nozione difensiva della stabilità maturata all’epoca della guerra fredda; quello
altrettanto incontestabile della crisi
strutturale e con ogni probabilità irreversibile dello status quo di sistemi regionali come quello mediorientale, ancora eredi della prima decolonizzazione
– uno status quo che non merita più di
essere difeso per la semplice ragione che
una difesa efficace non sarebbe più praticabile; la capacità seduttiva di una immagine visionaria e alternativa di “nuovo ordine”, alla quale oppositori e critici
non hanno saputo replicare fino a oggi
che con il richiamo scontato e comunicativamente debole al diritto e alle istituzioni esistenti, in una situazione nella
quale, oltretutto, sia l’uno che le altre patiscono una crisi crescente di effettività e
legittimità.
Sennonché questa felice combinazione di realismo e immaginazione del futuro si regge su una interpretazione maliziosa e storicamente semplicistica di
quale sia la causa della propensione al
conflitto e alla guerra dell’ordine mediorientale. Sarà pur vero, infatti, che esso
sta vivendo la crisi terminale della sistemazione politica interna e internaziona-
President Bush’s “Greater Middle East Partnership Initiative”. U.S. Working Paper for G-8,
in «al-Hayat», February 13, 2004.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 69
Il disincanto iracheno
le seguita al collasso dell’Impero ottomano prima e del sistema dei mandati
poi. Ma ad alimentare questa crisi potrebbero essere, in combinazione variabile fra loro, fattori politicamente, economicamente e storicamente eterogenei
quali la cronica diseguaglianza tra stati
ricchi di popolazione ma poveri di risorse e stati ricchi di risorse ma poveri di
popolazione (come gli staterelli arabi del
Golfo Persico sostenuti dalla Gran Bretagna prima e dagli Stati Uniti poi); o la
tensione strutturale tra la prevalenza
numerica degli stati e dei popoli arabi e
la supremazia politica, economica e militare dei tre soli stati non arabi del Medio Oriente (Israele, Turchia e Iran)11; o
l’inevitabile e prevedibile crisi di legittimità delle eredità politiche, culturali e
persino territoriali dell’impatto occidentale sul resto del mondo12, da cui dipendono ancora sia la configurazione
interna di diversi paesi (come la lunga
egemonia della minoranza sunnita in
Iraq e di quella alawita in Siria, eredità
del mandato britannico la prima e di
quello francese la seconda) sia la stessa
configurazione territoriale della regione
(come l’inclusione della regione curda
attorno a Kirkuk nell’Iraq sotto mandato inglese alla fine della Prima guerra
mondiale).
Oppure, ancora, la cronica instabilità
del sistema politico mediorientale potrebbe essere aggravata e almeno in parte
creata proprio dalle politiche degli attori
extraregionali, a cominciare naturalmente dal più influente di tutti, gli Stati Uniti,
che alla radicalizzazione dei conflitti interni e internazionali hanno presumibil-
mente contribuito con il sostegno di fatto alla quarantennale occupazione israeliana della Cisgiordania, di Gaza, delle alture del Golan e di Gerusalemme Est,
l’opposizione di ancora più lungo periodo all’emergere di leadership nazionaliste
forti e autorevoli (dal colpo di stato contro Mossadeq in Iran nel 1953 alla distruzione politica e militare dell’esperimento
nasseriano all’indebolimento sistematico
dei leader vecchi e nuovi del movimento
palestinese) e, in compenso, il sostegno a
regimi autoritari e corrotti che difficilmente sopravviverebbero senza di loro,
dalle monarchie petrolifere degli staterelli arabi del Golfo Persico al governo fondamentalista dell’Arabia Saudita. Per non
parlare, poi, della propensione stessa della politica estera degli Stati Uniti a gestire
ogni crisi e ogni minaccia (reale o percepita) in modo tale da gettare i semi per la
crisi o la minaccia successiva, come accadde negli anni Ottanta con il rafforzamento militare dell’Iraq di Saddam Hussein in funzione di contenimento dell’Iran khomeinista o, all’inizio degli anni
Novanta, con il via libera concesso all’occupazione siriana del Libano in cambio
del sostegno o, almeno, dell’acquiescenza
araba alla guerra contro l’Iraq – e come è
prevedibile che stia avvenendo anche oggi con l’inevitabile rafforzamento della
posizione dell’Iran per effetto della distruzione del tradizionale contrappeso
iracheno.
Di questa complessità storica e politica non resta la minima traccia nell’analisi strategica dell’amministrazione.
Il collasso, riconosciuto realisticamente,
dell’ordine politico mediorientale è poi
C.M. SANTORO, Geopolitica e geostrategia del “Sistema Sud”, in C.M. SANTORO, Rischio da Sud.
Geopolitica delle crisi nel bacino mediterraneo, Milano 1996, pp. 15-35.
12
H. BULL, La rivolta contro l’Occidente, in H. BULL - A. WATSON (a cura di), L’espansione della società
internazionale. L’Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri, Milano 1994, pp. 227-238.
11
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
69
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 70
internazionale
risolto nell’unico e rassicurante fattore dell’Europa centrale e orientale»14.
dell’assenza di democrazia:
La prima amministrazione Bush
«La democrazia e la libertà» recita il ha tentato di trasformare la teoria
progetto di Greater Middle East Partner- della pace democratica in
ship «sono essenziali per il fiorire dell’iniziativa individuale, ma sono estrema- programma politico
mente marginali in tutto il Grande Medio
Oriente. Nel rapporto di Freedom House
del 2003, Israele era l’unico paese della regione a essere designato come “libero”,
mentre solo altri quattro erano registrati
come “parzialmente liberi”… Questi indicatori scoraggianti non sono tuttavia
coerenti con la volontà espressa dai popoli della regione: nell’Arab Human Development Report del 2003, per esempio, gli
Arabi sono risultati in cima alla lista
mondiale di coloro che appoggiano il
principio che “la democrazia è migliore di
qualunque altra forma di governo” e hanno espresso il livello più alto di rifiuto del
governo autoritario. Il G8 potrebbe manifestare il suo sostegno alla riforma democratica nella regione»13
attraverso strumenti quali l’assistenza allo svolgimento di libere elezioni, il sostegno e il rafforzamento di mass-media indipendenti, lo sviluppo della società civile e delle organizzazioni non governative,
l’inserimento di queste ultime nella società della conoscenza anche attraverso il
superamento del digital divide tra il
Grande Medio Oriente e il resto del
mondo nonché, naturalmente, l’annullamento del ritardo di prosperità della
regione, che «richiederà una trasformazione economica simile per dimensioni a
quella intrapresa dai paesi ex comunisti
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
70
13
14
Questa prognosi è il secondo elemento della dottrina politica e strategica dell’amministrazione Bush. Trasformando in programma politico la teoria
della pace democratica, secondo la quale le democrazie non si sarebbero mai
fatte e non si farebbero mai la guerra tra
di loro (e alla quale non interessa minimamente se e quanto l’abbiano fatta o la
facciano agli altri, per esempio in quelle
invisibili digressioni dall’eguaglianza
che furono le spedizioni coloniali e, nel
caso americano, le “guerre indiane”), la
Greater Middle East Partnership si aspetta coerentemente dalla diffusione della
democrazia non soltanto la moltiplicazione di regimi politici comunemente
ritenuti migliori di tutti gli altri, ma anche l’allargamento della “pace separata”
fra di loro.
Sennonché, in questo modo, essa trascura la possibilità che l’attuale mancanza di democrazia dipenda, a propria volta, da una condizione generale di insicurezza alimentata dalla debolezza (anche
identitaria) dei singoli stati e da quella
complessiva del sistema interstatale mediorientale; che, in condizioni come
queste, l’instaurazione democratica produca almeno in una prima fase un rafforzamento delle tensioni interne e internazionali, invece che una propensione all’accomodamento e alla modera-
President Bush’s “Greater Middle East Partnership Initiative”, cit.
Ibidem.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 71
Il disincanto iracheno
zione; soprattutto, che il rifiuto dei governi autoritari che risulta dai rapporti e
dai sondaggi effettuati dalle organizzazioni indipendenti non indichi un aumento della forza d’attrazione del modello e delle politiche occidentali, ma sia
rivolto prima di tutto contro le élite, i
governi autoritari o le democrature sostenuti dagli Stati Uniti.
La fiducia nel fatto che sarebbe bastato aprire il vaso di Pandora del vecchio
ordine mediorientale per ottenerne uno
nuovo basato sul desiderio universale di
sicurezza, prosperità e libertà ha rispecchiato la consueta combinazione tra fondamentalismo democratico e trionfalismo tipica dell’attuale amministrazione.
Qualcosa di simile, come ha osservato
ironicamente un critico americano15, alla retorica del libero mercato applicata
alla geopolitica: l’idea che basti rimuovere in un colpo solo i lacci dell’iniziativa
individuale per avere un mondo più sicuro, più prospero e più sano.
L’unipolarismo e la
militarizzazione della politica estera americana
Sebbene espressa nei termini militanti e trionfalistici propri dell’ultima
amministrazione, la religione civile del
mercato e della democrazia sembrerebbe comunque riportare la dottrina Bush
nell’alveo di quasi tutta la politica estera
americana del passato, compresa quella
seguita in Europa centro-orientale e nei
Balcani dall’amministrazione precedente di Bill Clinton. Sennonché a questo
15
obiettivo condiviso la nuova dottrina
politico-strategica degli Stati Uniti aggiunge anche l’individuazione di uno
strumento altrettanto universale per
raggiungerlo: la superiorità militare
comprovata dalla serie ininterrotta di
guerre vittoriose e a costo quasi zero del
decennio precedente. La consapevolezza
di tale superiorità, che non ha precedenti per dimensioni nella storia delle relazioni internazionali moderne, aveva
contribuito già sotto la passata amministrazione a indebolire il principio di
cautela che normalmente trattiene la
tentazione di ricorrere con regolarità alla minaccia e all’uso della forza. Basti
pensare che, dalla fine della guerra fredda a oggi, gli Stati Uniti vi hanno ricorso più di una volta ogni due anni: 1989
(Panama), 1991 (Iraq), 1993 (Somalia),
1995 (Bosnia), 1996 (Iraq), 1998 (Afghanistan, Sudan e Iraq), 1999 (Jugoslavia), 2001 (Afghanistan), 2003 (Iraq).
Consapevoli della propria superiorità militare, dalla fine della guerra
fredda ad oggi, gli Stati Uniti hanno
fatto ricorso alla guerra più di una
volta ogni due anni
Definitivamente liberata dallo choc
dell’11 settembre e dalla proclamazione
che l’ha seguito della guerra globale contro il terrorismo, questa rimilitarizzazione della politica estera americana si è
condensata in quello che merita di essere considerato il terzo pilastro della dottrina Bush: la disponibilità, orgogliosamente rivendicata in tutti i principali
documenti ufficiali, a “spendere” senza
J.L. GADDIS, Grand Strategy in the Second Term, in «Foreign Affairs», 84, 2005, 1, p. 15.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
71
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 72
internazionale
remore lo strapotere militare per ottenere i propri obiettivi, cioè preservare il
momento unipolare, esportare la democrazia e prevenire sul nascere le minacce
alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti,
dei loro amici e dei loro alleati. Sospinta
dalla formidabile combinazione tra la
certezza della vittoria e la reviviscenza
delle dottrine della guerra giusta16, e per
niente trattenuta dal bipartitismo proprio del sistema politico statunitense
che, al contrario, offre un potente incentivo a «fare gara di patriottismo» in occasione di tutte le iniziative militari del
paese17, questa disponibilità ha il vantaggio di assicurare agli Stati Uniti una
marcia in più rispetto ai propri avversari e ai propri stessi alleati, ma lo svantaggio di incoraggiare gli Stati Uniti a combattere non soltanto guerre necessarie
ma anche guerre evitabili, perché condotte contro soggetti concretamente
non in grado di minacciare la loro sicurezza, o per acquisire vantaggi secondari o trascurabili, oppure per acquisirne
altri che potrebbero essere acquisiti in
qualche altro modo. È il vizio denunciato due anni fa dal più autorevole studioso neorealista di Relazioni Internazionali, Kenneth Waltz18, in un brevissimo intervento su International Security. Certe
teorie «sostengono che le democrazie
sono efficaci nello scegliere le vittime
che sanno di potere sconfiggere. Ma perché, se i paesi sono posti su livelli così diversi, una guerra deve essere combattuta? I più deboli difficilmente possono
minacciare i più forti, eppure le democrazie ricorrono alla guerra contro di loro. Se questo è vero, allora sappiamo
72
Il potere militare torna ad essere
visto come un mezzo non per
impedire ma per promuovere
mutamenti
A rafforzare i rischi di un impiego
poco responsabile dello strumento militare contribuisce il quarto elemento della dottrina politico-strategica dell’amministrazione. Coerentemente con la revisione in senso offensivo della concezione dell’ordine internazionale, dopo
essere stato concepito per più di cinquant’anni come uno strumento per
contenere i nemici, dissuadendoli dalla
tentazione di minacciare o alterare lo
status quo, anche il potere militare torna
a essere visto come un mezzo non per
impedire ma per promuovere mutamenti. Come tutti gli elementi visti in
precedenza, anche questo mischia premesse realistiche con forzature politiche
e teoriche. Da un lato, il passaggio dal
containment all’offensiva possiede un
fondo indubbio di razionalità strategica, in virtù dell’impensabilità di un second strike da parte dell’avversario, in
primo luogo, ma soprattutto in virtù di
quella che gli Stati Uniti hanno interpretato come la lezione basilare dell’11 settembre: la crescente inadeguatezza della
deterrenza, cioè dell’impianto politico e
concettuale a cui si erano tenuti stretti
nei cinquant’anni della guerra fredda.
Come afferma l’ultima National Securi-
M. WALZER, Arguing about War, New Haven & London 2004; trad. it. Sulla guerra, Roma-Bari
2004, cap. 1: «Il trionfo della dottrina della guerra giusta (e i pericoli del suo successo)».
17
J.L. HARPER, Anatomy of a Habit: America’s Unnecessary Wars, in «Survival», 47, 2005, 2, pp. 57-86.
18
K.N. WALTZ, Fair Fights or Pointless Wars?, in «International Security», 28, 2003/04, 3, p. 181.
19
THE WHITE HOUSE, The National Security Strategy..., cit., p. 15.
16
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
qualcosa di preoccupante sul comportamento dei paesi democratici: che essi,
appunto, eccellono nel combattere e
vincere guerre non necessarie».
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 73
Il disincanto iracheno
ty Strategy19, «la deterrenza basata soltanto sulla minaccia di rappresaglia ha
meno probabilità di funzionare contro i
leader dei rogue states più disponibili ad
assumersi rischi» e, a maggior ragione,
«contro un nemico terrorista le cui tattiche dichiarate sono la distruzione indiscriminata e l’attacco a innocenti, i cui
cosiddetti soldati aspirano al martirio e
la cui protezione più potente è l’assenza
di statualità».
La dottrina della guerra preventiva si
presenta come la risposta coerente a
questa prognosi di inadeguatezza. Secondo l’interpretazione proposta dagli
Stati Uniti, essa non sarebbe appunto
che un adattamento del vecchio e riconosciuto principio della legittima difesa
alle condizioni del nuovo sistema internazionale:
«Per secoli, il diritto internazionale ha
riconosciuto che le nazioni non devono
necessariamente subire un attacco prima
di potere legittimamente agire per difendersi contro forze che manifestano un pericolo immediato di attacco. Gli studiosi
di diritto e i giuristi internazionalisti hanno spesso condizionato la legittimità della
risposta preventiva (preemption) all’esistenza di una minaccia immediata – per
lo più una mobilitazione visibile di eserciti, marine e forze aeree in preparazione di
un attacco. Noi dobbiamo adattare il concetto di minaccia immediata alle capacità
e agli obiettivi degli avversari di oggi. I rogue states e i terroristi non cercano di attaccarci usando mezzi convenzionali, perché sanno che tali attacchi fallirebbero. Al
contrario, essi si affidano ad atti di terro-
20
Ibidem.
re e, potenzialmente, all’uso di armi di distruzione di massa … Maggiore è la minaccia, maggiore è il rischio dell’inazione
– e più stringente è l’opportunità di agire
in anticipo per difendersi, anche se rimane incertezza sui tempi e sul luogo dell’attacco nemico. Per anticipare o prevenire
simili atti ostili da parte dei nostri avversari, gli Stati Uniti, se necessario, agiranno preventivamente” 20».
Sennonché proprio la guerra contro
l’Iraq ha messo a nudo le fragilità e i possibili paradossi che si annidano in questo calcolo strategico. Non solo per la ragione che abbiamo già visto, la difficoltà
di accertare in anticipo se un soggetto
costituisca oppure no una minaccia immediata alla sicurezza; o per l’effetto disgregante che errori di valutazione di
questa portata hanno sul complesso dei
principi, delle norme e delle regole della
convivenza internazionale; o, ancora,
per il rischio di una diffusione politicamente e giuridicamente distruttiva della
dottrina della guerra preventiva anche
nelle mani di altri paesi, altrettanto disposti a farne un uso disinvolto valutando in modo discrezionale (e altrettanto
superficiale) chi siano i paesi pericolosi e
dove e quando cominci la minaccia. Il
principale rischio della dottrina della
guerra preventiva si trova, in realtà, proprio nel suo presupposto strategico:
l’idea che i nuovi nemici non rispondano ad alcun modello di razionalità e,
quindi, che le loro scelte non dipendano
dal contenuto delle scelte altrui, bensì da
una ostilità assoluta e irrimediabile nei
confronti dei loro valori. Per quanto
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
73
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 74
internazionale
plausibile possa apparire, questo presupposto tende ad avere un effetto corrosivo sulla responsabilità degli attori.
Chi si convince di avere a che fare con un
soggetto assolutamente irresponsabile
rischia di sentirsi sollevato, a propria
volta, dalla necessità di fare scelte responsabili, con la scusa che qualunque
scelta produrrebbe comunque lo stesso
risultato.
Una strategia costosa
Rimane un ultimo elemento, nel
quale la dottrina della prima amministrazione Bush rivela il massimo della
discontinuità nei confronti della politica
estera statunitense del secondo dopoguerra ma, allo stesso tempo, anche il
massimo della continuità con la preoccupazione dominante e ricorrente della
politica americana dell’ultimo trentennio: quella di tenere in equilibrio impegni e risorse, evitando la malattia mortale delle potenze egemoni, la crisi fiscale.
Coerentemente con la concezione offensiva dell’ordine internazionale e con
la conseguente dottrina della guerra preventiva, già in occasione della guerra
contro l’Afghanistan del 2001 la decisione americana di chiamare a uno a uno
gli alleati più fidati aveva avuto il significato di sottolineare la determinazione
a non dipendere dal consenso e dai veti
altrui, anche a costo di marginalizzare le
principali organizzazioni internazionali.
Ma è stato proprio in occasione dell’ultima guerra contro l’Iraq che gli Stati
Uniti hanno avuto modo di mettere
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
74
21
Ibidem, p. 31.
ostentatamente in mostra la loro nuova
disposizione nei confronti dei contesti
multilaterali. A differenza del multilateralismo proprio delle istituzioni permanenti ereditate dal passato, quello prefigurato dalla National Security Strategy e
realizzato nella coalizione ad hoc contro
l’Iraq è un multilateralismo à la carte,
potenzialmente aperto a tutti ma privo
di qualunque identità istituzionale, fondato ogni volta su alleanze diverse (coalitions of the willings) ma sempre limitato negli scopi e nella durata, disponibile
alla cooperazione con le istituzioni internazionali ma, in caso di disaccordo,
esplicitamente preparato a lasciare agli
Stati Uniti e ai loro alleati più fidati il
potere di «agire separatamente quando i
nostri interessi e le nostre speciali responsabilità lo richiedano»21, anche al di
sopra dell’architettura della Carta delle
Nazioni Unite.
Questa ultima revisione, che chiude
Il multilateralismo concepito
dalla National Security Strategy
è un multilateralismo à la carte,
potenzialmente aperto ma
sprovvisto di ogni identità
istituzionale
l’eccezione multilaterale dell’epoca bipolare per riportare la politica estera
americana alla consuetudine precedente
a non farsi intrappolare in entangling alliances, rivela una volte per tutte anche la
preoccupazione fondamentale della
dottrina Bush. Sebbene, infatti, le polemiche seguite allo strappo iracheno abbiano posto l’accento su elementi quali
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 75
Il disincanto iracheno
la necessità di sospendere le norme ordinarie della convivenza internazionale in
nome della lotta contro il terrorismo, o
quella opposta di difendere a ogni costo
le norme e le istituzioni esistenti, agli occhi dell’amministrazione Bush l’alternativa tra multilateralismo e unilateralismo si è posta prima di tutto in termini
di costi. Se, a differenza dell’amministrazione precedente (che pure non aveva
disdegnato il ricorso periodico a iniziative unilaterali), l’attuale amministrazione ha deciso di tenersi mani libere
nella scelta delle missioni e degli alleati,
è perché ha ritenuto che i possibili svantaggi dell’unilateralismo nella redistribuzione dei costi dell’egemonia con gli
alleati sarebbero stati minori dei vantaggi derivanti dall’opportunità di risparmiare impegni utili soltanto a salvare i
contesti multilaterali permanenti di cui
l’America fa parte, Alleanza atlantica inclusa.
La stessa preoccupazione tiene insieme, a ben guardare, anche tutti gli altri
elementi della nuova dottrina politicostrategica statunitense. Consapevole di
non potere rinunciare a dettare e difendere l’ordine internazionale unipolare,
ma preoccupata per i rischi di una incombente divaricazione tra l’aumento
continuo degli impegni e la possibile diminuzione delle risorse necessarie a finanziarli, l’amministrazione Bush ha
scommesso sul fatto che modificare lo
status quo si sarebbe rivelato meno costoso che insistere nel puntellarlo; che la
superiorità militare avrebbe offerto agli
Stati Uniti la possibilità di ottenere i mutamenti desiderati al minor costo e nel
minor tempo possibile, conformemente
all’utopia della “guerra leggera” coltivata
dal Dipartimento della Difesa alla vigilia
dell’invasione dell’Iraq; che la guerra
preventiva si sarebbe dimostrata meno
costosa e più efficiente di una estenuante dissuasione del tipo di quella praticata per tutti gli anni Novanta nei confronti di Iraq e Iran e sorretta dallo stanziamento politicamente insostenibile di
100.000 soldati americani in Arabia Saudita.
Quella che è fallita in Iraq è proprio
questa scommessa. Invece che una guerra leggera, i cui costi avrebbero potuto
essere oltretutto facilmente ridistribuiti
al momento del successo, quella contro
l’Iraq si è rivelata una guerra costosissima sia in termini politici che economici,
a maggior ragione perché tali costi gli
Stati Uniti se li sono dovuti accollare
quasi tutti su di sé. Come le scelte opposte del decennio precedente, anche quelle dell’amministrazione Bush non sono
riuscite ad alleggerire il peso dell’unipolarismo, anzi hanno dimostrato una volta di più quali sono e continueranno a
essere i suoi insuperabili vincoli: che non
esiste alcuna vicenda, neppure la cosiddetta guerra globale al terrore, in grado
di sostituire l’ubiquità e la chiarezza strategica della guerra fredda; che non esiste
alcuna soluzione universale, neppure la
democrazia, capace di promuovere la pace e la stabilità in tutte le regioni; che non
esiste, infine, nessuno strumento, neppure lo strapotere militare, capace di assicurare sempre e comunque al più forte il
successo che si aspetta.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
75
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 76
internazionale
Franco Zallio
L’involontario benessere.
La guerra in Iraq e le economie del Grande Medio Oriente
FRANCO ZALLIO
è Direttore di Global Watch
e Senior Research Fellow
per il Mediterraneo Medio Oriente presso
l’ISPI.
Le valutazioni della politica statunitense per il Grande Medio Oriente sono
assai mutevoli e oscillano tra un’episodica euforia – in genere connessa a
qualche scadenza elettorale che ha dato
il risultato sperato – e una diffusa depressione, dipendente soprattutto dall’andamento del conflitto in Iraq. Qui
adotteremo un diverso criterio, non basato né su calendari elettorali né su vicende belliche, bensì sulla dimensione
economica. Esamineremo quindi l’impatto di questa politica “trasformativa”
– e specialmente della guerra in Iraq –
sulle economie del Grande Medio
Oriente, un tema che si presta facilmente a essere ignorato.
Un velo è caduto sul nesso che intercorre tra l’insuccesso iracheno e l’elevato prezzo del petrolio; anche la scelta di
ricorrere, per la guerra in Iraq, a una
coalizione di “volonterosi” è considerata solo per l’aggravio sostenuto dal bilancio statunitense mentre se ne trascurano gli effetti regionali. In realtà, le risorse spese dagli Stati Uniti sono anche
risorse risparmiate dalle monarchie del
Golfo che, al contrario, nella guerra del
1991 avevano dovuto sostenere la parte
preponderante dei costi.
Grazie all’elevato prezzo del petrolio le monarchie del Golfo1, liberate dalla concorrenza della produzione petrolifera irachena – il cui livello non ha
neppure lontanamente confermato le
1
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
76
2
attese prebelliche – e sollevate dal finanziamento della guerra, hanno registrato uno straordinario miglioramento economico. Il loro Pil, per prendere
in considerazione il più semplice degli
indicatori economici, è passato dai 347
miliardi di dollari del 2002 ai 572 miliardi di dollari del 20052, con un incremento del 65%.
Non vi è dubbio che questo non fosse il risultato atteso da chi sostenne la
guerra in Iraq, ma un simile benessere
– per involontario che sia – sta producendo effetti di rilievo non solo nel
Golfo ma nell’intero Grande Medio
Oriente. Ci soffermeremo qui su queste
dinamiche, concentrandoci sui paesi
arabi, al cuore degli obiettivi trasformativi degli Stati Uniti.
Un confronto con la guerra del 1991
Conviene prendere le mosse dal
confronto tra la guerra iniziata nel 2003
e quella del 1991. Le loro conseguenze
economiche – legate essenzialmente all’andamento del prezzo del petrolio e
alle forme di finanziamento dello sforzo bellico – sono nettamente diverse.
Consideriamo per primo il petrolio.
In seguito all’occupazione irachena
del Kuwait nell’agosto 1990 il prezzo
del petrolio si impennò, quasi triplicando in un trimestre, mantenendosi
I regni di Arabia Saudita e Bahrein, il sultanato di Oman, gli emirati di Kuwait e Qatar e la Federazione
degli Emirati Arabi Uniti. Questi sei stati hanno costituito nel 1981 il Consiglio di cooperazione del
Golfo (Ccg), con obiettivi di sicurezza ed economici; a gennaio 2003 è entrata in vigore l’unione
doganale a cui dovrebbe seguire in futuro l’unione monetaria.
Stime dell’Economist Intelligence Unit, tratte dai più recenti Country Reports
(<http://www.eiu.com>, cons. 31 gennaio 2006).
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 77
L’involontario benessere
poi elevato fino all’avvio delle ostilità a
gennaio 1991. Ma appena l’esito favorevole della guerra fu evidente, il prezzo si
ridusse bruscamente, stabilizzandosi ai
livelli precedenti l’invasione del Kuwait.
Inizialmente, la guerra del 2003
sembrava presentare un andamento simile: nella fase preparatoria si ebbe una
crescita del prezzo, seguita da una impennata nel periodo immediatamente
precedente lo scoppio della guerra e da
una consistente riduzione dopo la rapida conquista di Baghdad. Fondandosi
sull’esperienza del 1991, a inizio 2004
gli analisti si attendevano un calo del
prezzo del petrolio e ritenevano che
l’obiettivo di prezzo dell’Opec (una
banda di oscillazione di 22-28 dollari al
barile) fosse difficile da raggiungere.
Invece, nel 2004 il prezzo del petrolio è
aumentato di un terzo, toccando i 38
dollari al barile, per poi crescere di oltre
il 40% nel 2005 e superare in media i 54
dollari al barile. In termini reali, il prezzo medio del 2005 è il doppio di quello
del 2002.
Cause strutturali ed eventi occasionali si sono combinati nel sostenere il
rialzo del prezzo. Tra le prime vi è soprattutto la concentrazione della crescita economica globale nei paesi asiatici ad alto consumo di petrolio, che –
insieme ad una prolungata fase di limitati investimenti nell’estrazione e nella
raffinazione – ha ridotto la capacità
produttiva inutilizzata di greggio e fatto emergere strozzature lungo tutta la
catena produttiva, e in particolare nella
raffinazione. Tra gli altri fattori, le consistenti operazioni di investitori non
commerciali, i riflessi delle crisi politiche in Nigeria e Venezuela, il conflitto
tra il governo russo e la società petrolifera Yukos, gli uragani del 2004-2005.
Dal 2002 ad oggi il prezzo medio
del petrolio, in termini reali,
è raddoppiato
Ma non certo ultimo è il ruolo svolto dalla guerra in Iraq, e soprattutto dal
fatto che le grandi attese riguardo le risorse petrolifere irachene siano andate
deluse. Nel periodo in cui si andava
preparando la guerra, si accreditarono
numerose previsioni straordinariamente ottimistiche sulle prospettive petrolifere dell’Iraq nel dopo Saddam
Hussein. Fondandosi sull’estensione
delle riserve petrolifere del paese (seconde al mondo dopo quelle saudite) e
ipotizzando un rapido afflusso di investimenti da parte delle compagnie petrolifere internazionali, si prevedeva
che la produzione petrolifera irachena
avrebbe potuto raggiungere i 6 milioni
di barili al giorno entro gli ultimi anni
del decennio (a fronte dei 2 milioni
prodotti nel 2002). Ottimismo che si
riaffermò nei primi mesi dell’occupazione tanto che a ottobre 2003 Philip J.
Carroll, l’ex dirigente della Shell statunitense che in quel periodo amministrava l’industria petrolifera irachena,
si fece scrupolo di tranquillizzare il
mercato assicurando che l’aumento
della produzione si sarebbe attuato con
cautela per evitare che il prezzo del petrolio crollasse.
Come sono poi andate le cose è noto: l’insicurezza dominante nel paese –
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
77
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 78
internazionale
e in particolare i numerosi attentati e
sabotaggi che hanno colpito l’industria
petrolifera in tutte le sue componenti,
dall’estrazione al trasporto e alla raffinazione – ha impedito il rilancio dell’estrazione di petrolio, ancora oggi inferiore al livello precedente la guerra.
Nel 2005 la produzione petrolifera è
addirittura diminuita.
Le attese così deluse non hanno solo ridotto l’offerta di greggio su un
mercato internazionale già in tensione
ma hanno aggravato l’incertezza del
mercato in un contesto dove il tradizionale garante dell’approvvigionamento
energetico mondiale, oltre ad essere
impantanato in Iraq, mantiene relazioni che variano dal sospetto accigliato al
conflitto latente con Arabia Saudita,
Russia e Iran, i primi tre esportatori
mondiali di petrolio. E l’incertezza sostiene le attese di rialzo del prezzo nel
breve termine, come potrebbe indicare
il fatto che a partire dal 2004 la usuale
relazione negativa tra prezzo del petrolio e livello delle scorte industriali si è
rovesciata. Ancor più significativo è il
ruolo dell’incertezza nel ritardare le decisioni di investimento necessarie sia
per riequilibrare i rapporti tra domanda e offerta di greggio3 sia per rivedere
la composizione tra petrolio e altre fonti del fabbisogno energetico mondiale.
Sarebbe davvero sorprendente se tutto
questo non avesse incoraggiato le tendenze rialziste del prezzo del petrolio
già alimentate da altri fattori.
3
4
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
78
Naturalmente, l’elevato prezzo del
petrolio esercita effetti molto favorevoli sui paesi esportatori, e in particolare
sulle monarchie del Golfo, che per sopraggiunta hanno beneficiato di un
consistente aumento della produzione
(del 20-30% tra il 2002 e il 2005 in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar). Aumento naturalmente
facilitato dalla mancata crescita della
produzione irachena. L’effetto complessivo è stato straordinario: le entrate
petrolifere delle monarchie del Golfo
hanno toccato, in termini reali, livelli
anche superiori a quelli del boom degli
anni Settanta.
Le monarchie del Golfo hanno
beneficiato dell’aumento sia
del prezzo sia della produzione
di petrolio
Il mancato rilancio della produzione petrolifera irachena implica, al contempo, l’archiviazione delle fantasiose
teorie prebelliche secondo cui, in virtù
dell’auspicata rapida crescita della produzione petrolifera, la ricostruzione
dell’Iraq si sarebbe in larga misura finanziata da sé4. Ed è proprio sugli
aspetti finanziari che si rileva la seconda grande differenza rispetto alla guerra del 1991, la quale inferse gravi danni
economici alle monarchie del Golfo.
Nel 1991 esse contribuirono infatti
in misura molto elevata al finanziamento della guerra, sia direttamente (trasfe-
Sul ruolo della guerra in Iraq nel ritardare la normale reazione dal lato dell’offerta insistono L. BILMES
e J. STIGLITZ (The Economic Costs of the Iraq War: an appraisal three years after the beginning of the
conflict, Harvard University-John F. Kennedy School of Government - Faculty Research Working Paper
RWP06-002, January 2006, <http://ksgnotes1.harvard.edu/research/wpaper.NSF/RWP/RWP06-002>),
che attribuiscono alla guerra in Iraq il 20% (ipotesi conservativa) o il 40% (ipotesi moderata)
dell’incremento del prezzo del petrolio, ossia 5 o 10 dollari al barile.
L’allora vice Segretario alla Difesa Paul Wolfowitz sostenne di fronte al Congresso statunitense che
«abbiamo a che fare con un paese che può effettivamente finanziare la sua ricostruzione, e in tempi
relativamente brevi», Hearing of the Defense Subcommittee of the House Appropriations Committee,
March 27, 2003.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 79
L’involontario benessere
rimenti al bilancio Usa, forniture gratuite di carburanti e materiali militari
alle forze della coalizione) sia indirettamente (cancellazione di vecchi debiti ed
erogazione di nuovi finanziamenti ai
partecipanti arabi della coalizione, principalmente Egitto, Marocco e Siria). Secondo le stime dell’epoca, la sola Arabia
Saudita sostenne costi per 55 miliardi di
dollari; i soli Stati Uniti ricevettero contributi finanziari pari a 17 miliardi di
dollari dall’Arabia Saudita, 16 miliardi
di dollari dal Kuwait e 4 miliardi di dollari dagli Emirati Arabi Uniti.
Nel caso dell’Arabia Saudita – e, ovviamente, del Kuwait allora occupato –
il finanziamento della guerra fu di gran
lunga superiore alle entrate petrolifere
addizionali ricavate dal temporaneo
aumento del prezzo del petrolio5. Per il
Kuwait – scarsamente popolato (2,8
milioni di residenti, ma soltanto 956
mila nazionali, nel 2004) e con un’elevata produzione petrolifera pro capite
– l’assorbimento dei costi finanziari
della guerra è stato relativamente indolore. Ben diverso è il caso dell’Arabia
Saudita, la cui popolazione è assai più
consistente e in rapida crescita (dai 15
milioni del 1990 ai 23 milioni del 2004)
e che dispone di una produzione petrolifera pro capite decisamente inferiore.
5
6
Da una guerra all’altra:
l’Arabia Saudita alla ricerca
di un equilibrio economico
Il finanziamento della guerra del
1991 peggiorò drasticamente i conti
dell’Arabia Saudita: a fine 1991 il debito pubblico era pressoché triplicato in
termini nominali, e raddoppiato in percentuale del Pil, rispetto a due anni prima; nello stesso periodo le riserve valutarie del paese si sono ridotte del 30%.
Cominciò così un decennio segnato
da un crescente squilibrio economicofinanziario, che alimentò tensioni sociali e rafforzò l’opposizione radicale.
Un solo dato basta a porre in luce il deterioramento degli anni Novanta: il debito pubblico, che a fine 1989 era pari al
22% del Pil, a fine 1999 toccò il 119%
del Pil. Una parte rilevante del debito
era in effetti dovuta a organismi parastatali (i Fondi pensione del settore
pubblico e di quello privato), ma va notato che in una economia rentière la necessità per i Fondi pensione di liquidare attività sull’estero per acquisire debito pubblico indebolisce gravemente le
prospettive di lungo termine6.
Inoltre, il deterioramento finanziario annunciava quello sociale e in particolare l’insorgere di un problema occupazionale. La stagnazione delle entrate petrolifere non permetteva di ampliare l’occupazione nel settore pubblico così da assorbire i nuovi entranti nel
Nelle altre monarchie del Golfo, invece, le entrate petrolifere addizionali furono superiori al
finanziamento della guerra. Anche da questa diversità origina il divergente sviluppo negli anni Novanta
dell’Arabia Saudita, da una parte, e degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar dall’altra: la prima impegnata
nel lento recupero dei danni finanziari della guerra, i secondi in forte espansione economica e
finanziaria. Da qui le crescenti tensioni all’interno del Consiglio di cooperazione del Golfo, con il
progressivo emergere delle insofferenze dei partner minori nei confronti dell’Arabia Saudita, di cui
risentono l’egemonia nel Consiglio e da cui temono nel lungo periodo minacce alla loro sovranità.
Almeno in teoria, infatti, un’economia rentière fondata sulla rendita petrolifera potrebbe conservarsi
anche dopo l’esaurimento della produzione di petrolio grazie ad una rendita sostitutiva prodotta dagli
investimenti all’estero accumulati nel frattempo. Il finanziamento del deficit pubblico attraverso la
riduzione delle attività sull’estero – prima quelle dello stato e poi quelle degli organismi parastatali –
rappresenta perciò una diminuzione della “speranza di vita” dell’economia rentière.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
79
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 80
internazionale
mercato del lavoro. D’altro canto, data
la discrepanza tra le qualifiche dei giovani sauditi e le necessità del settore
economico privato, questo nel 2004 occupava 5,3 milioni di immigrati e soltanto 700 mila nazionali. Di conseguenza, la disoccupazione dei nazionali è
cresciuta lungo gli anni Novanta e, secondo i probabilmente ottimistici dati
ufficiali, nel 2002 era pari al 10% (8%
per gli uomini e 22% per le donne).
Per gran parte degli anni Novanta la
monarchia non parve in grado di porre
rimedio a questo progressivo deterioramento economico e sociale. Questa
inerzia fu in larga parte la conseguenza
del vuoto di potere seguito all’infarto
di cui fu vittima re Fahd nel 1995: l’attuale re Abdullah ha assunto numerose
responsabilità di governo solo a partire
dal 1997 ed è salito al trono soltanto alla morte di re Fahd nell’agosto 2005.
Durante questo lungo interregno il
controllo sull’economia si è allentato
ed è stato necessario il crollo del prezzo
del petrolio nel 1998-99 per costringere la monarchia saudita a scelte fino ad
allora rinviate.
Nella storia recente dell’Arabia Saudita il punto di svolta non è costituito
dall’11 settembre 2001 ma è proprio il
1999. In quell’anno, da una parte,
l’Arabia Saudita ristabilì il suo ruolo
centrale nel mercato petrolifero, organizzando il contenimento della produzione a sostegno del prezzo. Dall’altra,
si avviarono le riforme economiche con
l’istituzione del Consiglio economico
supremo presieduto dall’allora principe della corona Abdullah e l’adozione
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
80
di misure di aggiustamento macroeconomico e di liberalizzazione (riduzione
di sussidi, apertura della Borsa agli investitori esteri, accelerazione dei negoziati per l’ingresso nel Wto, ristrutturazione del settore elettrico, rilancio del
settore turistico).
L’Arabia Saudita vive una crescita
economica favorita da un decisivo
processo di riforme avviato nel 1999
Riforme che negli anni successivi si
sono approfondite attraverso nuove
leggi sugli investimenti esteri, il mercato dei capitali e le assicurazioni, e con
l’avvio di privatizzazioni. Altre misure
di liberalizzazione sono state adottate
in preparazione all’adesione al Wto – in
vigore da dicembre 2005 – e in connessione all’unione doganale tra i paesi del
Ccg. Infine, dopo l’esito infelice di un
primo tentativo avviato nel 1998, il settore del gas è stato aperto agli investitori esteri grazie ad alcuni accordi raggiunti nel 2003 con diverse società petrolifere internazionali, una soltanto
delle quali statunitense.
L’11 settembre ha dunque colto
l’economia saudita in una fase in cui
importanti riforme erano in corso e, indirettamente, le ha agevolate. Le misure
di contrasto al terrorismo adottate negli
Stati Uniti e in Europa, che limitano la
mobilità delle persone e dei capitali
(maggiori difficoltà a ottenere visti,
controlli più rigidi alle frontiere, applicazione severa di controlli finanziari,
ecc.), hanno colpito specialmente i cittadini dei paesi arabi, così incentivando
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 81
L’involontario benessere
il rimpatrio di parte dei loro capitali detenuti nei paesi occidentali, o quanto
meno dei redditi da essi prodotti. Il
rientro dei capitali e il loro investimento nell’economia locale hanno rinvigorito il settore economico privato nelle
monarchie del Golfo, e questo nuovo vigore sta dando al boom economico oggi in corso una coloritura affatto peculiare.
Un boom diverso da tutti gli altri
Come abbiamo visto, dal 2003 le entrate petrolifere delle monarchie del
Golfo sono nettamente aumentate;
inoltre – a differenza del 1991 – queste
entrate accresciute sono rimaste a loro
totale disposizione. Conviene allora
domandarsi come sono state utilizzate:
può soccorrerci ancora un confronto,
non più con la guerra del 1991 ma con
le precedenti fasi di boom, collegate ai
bruschi aumenti che il prezzo del petrolio registrò in concomitanza della
guerra arabo-israeliana del 1973 e della rivoluzione iraniana del 1979. Di
nuovo grandi sono le differenze che
vengono alla luce.
La prima, e più rilevante, attiene alla
struttura economica delle monarchie
del Golfo, allora così primitiva da richiedere quasi una creazione ex nihilo, e oggi invece molto sviluppata. Durante i
boom degli anni Settanta il settore pubblico – trovatosi improvvisamente a disporre di risorse ingentissime – aveva
come interlocutore un settore economico privato debolissimo e molto arretra-
7
to. Di conseguenza, la funzione centrale
di un’economia rentière – la circolazione
della rendita petrolifera tra la popolazione – dovette essere espletata tramite
meccanismi primitivi come elargizioni
dirette (cessione gratuita di terreni, finanziamenti a tasso zero, cancellazione
di crediti, ecc.), fornitura gratuita o a
prezzi fortemente sussidiati di servizi
pubblici, assunzioni di massa nel settore
pubblico. Lo stato si addossò inoltre lo
sviluppo infrastrutturale e industriale
del paese e per realizzarlo dovette ricorrere massicciamente all’importazione,
non solo di beni ma anche di lavoratori
qualificati, dirigenti, e così via. La situazione odierna è affatto diversa e il settore privato è in grado di cogliere ogni sorta di opportunità economica, sia quelle
offerte dalla circolazione della rendita
petrolifera sia quelle connesse ai processi di riforma economica.
L’impiego odierno della elevata rendita petrolifera differisce dagli anni Settanta non solo per la maggiore forza del
settore privato, ma anche per la maggiore debolezza del settore pubblico
che, in Arabia Saudita come in altri
produttori petroliferi del mondo arabo, è assai indebitato. La prima utilizzazione delle entrate petrolifere addizionali è andata dunque a ridurre il debito, con risultati impressionanti. Il caso
più clamoroso è proprio quello dell’Arabia Saudita, il cui debito pubblico
– che, come si è detto, nel 1999 era pari
al 119% del Pil – è sceso a fine 2005 al
41% del Pil7. Il rimborso del debito si è
in parte tradotto in accresciuta liquidità interna e dunque in un potenzia-
Press Release from Ministry of Finance, Kingdom of Saudi Arabia, 12 December 2005; Samba Financial
Group, Saudi Arabia’s 2006 Budget, 2005 Performance, 13 December 2005, <http://www.samba.com>.
Naturalmente, la riduzione del rapporto debito/Pil non è dovuta soltanto ai rimborsi netti di debito ma
è stata agevolata anche dall’aumento del Pil nominale causato dalla forte crescita del prezzo del petrolio.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
81
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 82
internazionale
mento del settore privato locale, che si
aggiunge a quello già alimentato dal
rimpatrio di capitali dall’estero.
L’aumento della spesa pubblica è invece stato contenuto, nonostante il forte aumento delle entrate petrolifere8.
Nel 2004 le monarchie del Golfo hanno
così risparmiato circa due terzi delle risorse petrolifere addizionali.
Di conseguenza, il settore privato è
stato, nella fase iniziale, il principale
agente del boom economico, mentre il
governo ha svolto prevalentemente un
ruolo di sostegno, attraverso quei processi di apertura economica di cui abbiamo visto sopra l’esempio saudita.
Si è dovuto aspettare il 2005 perché
la spesa pubblica si ampliasse significativamente, attraverso la concessione di
rilevanti aumenti salariali ai dipendenti pubblici e l’avvio di grandi progetti
infrastrutturali pluriennali. Il caso dell’Arabia Saudita può di nuovo considerarsi paradigmatico. Appena salito al
trono, re Abdullah ha concesso un aumento salariale del 15%9 nonché approvato un programma di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici e di capitalizzazione degli istituti
pubblici di credito a lungo termine, che
comporta una spesa complessiva di 22
miliardi di dollari10 in un quinquennio.
E nel budget per il 2006 la spesa pubblica cresce del 20%; in particolare, la spesa in conto capitale è prevista ad un livello tre volte quello del 2004.
Non vi è dubbio che l’incertezza dominante sul mercato petrolifero sia stata una delle cause di
una allocazione così prudente delle entrate petrolifere addizionali. Infatti anche i governi,
e non soltanto gli analisti, prevedevano per il 2004 un ribasso del prezzo, tanto che l’Arabia Saudita –
predisponendo il bilancio pubblico per il 2004 – ipotizzò un prezzo di circa 20 dollari al barile.
9
Si trattava peraltro del primo aumento salariale da un ventennio. Aumenti ai dipendenti pubblici sono
stati approvati anche in Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti (in quest’ultimo caso l’aumento
è stato del 25%).
10
Per avere un termine di paragone, si tenga conto che nel 2005 il Pil saudita è stato pari a 308 miliardi
di dollari (ma nel 2002 fu di soltanto 189 miliardi di dollari).
11
Già nel 2004 un’altra grande società degli Emirati Arabi Uniti aveva ottenuto la licenza per creare la
seconda rete di telefonia mobile dell’Arabia Saudita. E questo malgrado le crescenti tensioni tra i due
paesi legate alle irrisolte questioni di confine.
8
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
82
L’aumento della spesa pubblica per
investimenti non mancherà di stimolare ulteriormente il settore privato, che
potrà beneficiare di numerose commesse pubbliche essendo ormai in grado – a differenza degli anni Settanta –
di partecipare a progetti di dimensione
assai rilevante. Similmente accadrà per
gli investimenti delle società statali, in
primo luogo di Aramco che, per ampliare la capacità produttiva di petrolio, investirà 14 miliardi di dollari in un
quinquennio. D’altra parte il settore
privato ha a sua volta in corso ingenti
investimenti per il rafforzamento della
propria capacità produttiva, oltre che
in nuovi progetti in diversi settori.
La facilità con cui il mercato azionario sta accogliendo negli ultimi anni i
collocamenti iniziali di Borsa, insieme
alla maggiore liquidità delle banche locali nonché alle accresciute risorse a disposizione delle banche d’investimento
pubbliche, favorirà i piani di investimento del settore privato. La cooperazione tra settore privato e settore pubblico nel sostenere la rapida crescita
economica del paese si potenzierà ancora. Ne è un segno eloquente il progetto di una nuova città, King Abdullah
City, che sarà realizzata con un’operazione mista pubblico-privato, dove il
capofila del settore privato è una grande società degli Emirati Arabi Uniti11.
L’impetuosa crescita economica degli ultimi anni, fornendo ai regimi ri-
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 83
L’involontario benessere
sorse con cui accrescere il consenso,
rappresenta evidentemente un fattore
di stabilizzazione interna che contrasta
con gli influssi destabilizzanti che la crisi irachena diffonde nella regione. Certamente, il boom economico in corso
non è in grado di risolvere il problema
occupazionale, che ha una natura strutturale legata ai processi di formazione
scolastica ed è quindi difficilmente modificabile in tempi brevi. Tuttavia, i
consistenti aumenti di reddito e ricchezza pro capite degli ultimi anni potrebbero essere sufficienti a ridurne le
implicazioni politiche.
Gli effetti regionali del
rafforzamento dei paesi del Golfo
Sulla base delle ingenti risorse petrolifere addizionali che i governi hanno risparmiato e dunque hanno ancora a disposizione, dei buoni risultati
nella cooperazione tra settore pubblico
e settore privato, nonché dei fattori
economici e politici che continuano a
sostenere il prezzo del petrolio, ci si può
attendere che il boom economico non
sia destinato a concludersi rapidamente. Conviene dunque interrogarsi sull’influsso che esso già esercita e ancora
eserciterà non solo nel Golfo ma negli
altri stati arabi.
Il boom economico delle monarchie
del Golfo, favorito dalle entrate
petrolifere, non pare destinato a
esaurirsi rapidamente
12
Il boom in corso nelle monarchie
del Golfo sta infatti influenzando in
misura significativa anche il resto del
mondo arabo. Nel momento in cui fattori politici ed economici scoraggiavano i flussi finanziari verso gli Stati Uniti, il boom ha rivitalizzato i flussi di capitali intra-regionali, un fenomeno che
da oltre vent’anni non registrava più
dimensioni significative.
I mercati mobiliari sono stati i primi
beneficiari di questi flussi, con risultati
impressionanti. Nel 2004 le borse della
regione sono cresciute in media di oltre
il 60%, più che in ogni altra regione del
mondo. E nel 2005 l’andamento delle
borse è stato ancora più favorevole, con
aumenti superiori al 100% in Arabia
Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti12.
Ma i flussi di capitali non si sono diretti soltanto verso i mercati mobiliari
della regione. Sebbene manchino statistiche attendibili, è visibile un netto aumento degli investimenti che dai paesi
del Golfo si dirigono in diversi altri settori, tra cui l’immobiliare, residenziale
e turistico, l’industria pesante, la telefonia, i servizi finanziari.
Questi capitali si dirigono soprattutto nei paesi della regione dove sono
in corso processi di liberalizzazione
economica che offrono opportunità significative (si pensi ai casi, pur assai diversi tra loro, di Egitto, Marocco e Siria); gli investitori del Golfo offrono così un importante sostegno ai processi di
riforma.
E i flussi provenienti dai paesi del
Golfo non sono soltanto flussi di capitale. Ad essi si sono aggiunti flussi turisti-
Sono di conseguenza cresciute le preoccupazioni per un possibile crollo delle quotazioni, sui mercati
azionari come degli immobili.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
83
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
11:59
Pagina 84
internazionale
ci di grande rilievo, al punto che nell’intera regione i flussi valutari legati al settore turistico stanno superando quelli
generati dalle rimesse degli emigrati. E
l’aumento dei flussi turistici è interamente dovuto ai flussi intra-regionali,
poiché i flussi turistici provenienti dagli
Stati Uniti sono crollati e anche quelli
provenienti dai paesi europei sono diminuiti. Infine, sebbene in misura assai
inferiore a quanto successo per i flussi di
capitali e servizi, anche i flussi intraregionali di merci sono aumentati, pur
rimanendo inferiori al 10% del totale,
una quota ancora bassa.
Dunque, le relazioni economiche
intra-regionali si sono decisamente
ampliate negli ultimi anni. Ma questa
accresciuta integrazione economica regionale solleva almeno due questioni.
L’accresciuta influenza economica
delle monarchie del Golfo sul resto
della regione complica l’esercizio
di influenza politica da parte degli
attori regionali e degli Stati Uniti
La prima riguarda il fatto che essa va a
detrimento dei tradizionali centri della
regione, come l’Egitto e la Siria, la cui
classe imprenditoriale fatica a reggere
l’urto di un concorrente regionale assai
più agguerrito. Tensioni e risentimenti
nei confronti degli investitori del Golfo
si diffondono nel settore privato degli
altri paesi arabi, per lo più debole e
fiaccato da decenni di collusione con le
forze politiche dominanti. Queste tensioni e questi risentimenti non si limiteranno al mondo degli affari ma si ri-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
84
fletteranno nelle relazioni politiche.
Non può certo essere dato per scontato
che i tradizionali attori regionali accettino di buon grado una maggiore assertività delle monarchie del Golfo.
La seconda questione attiene alla
politica statunitense per la regione. Il
rafforzamento del settore economico
privato nelle monarchie del Golfo e il
fatto che dal Golfo si diffondano capitali e tecniche manageriali nel resto del
Grande Medio Oriente rappresentano
evidentemente dei progressi economici
e sociali. Ma non sembra che ne possano derivare, se non in tempi molto lunghi, progressi in campo politico, specialmente per quanto riguarda l’obiettivo statunitense di promuovere la democrazia nella regione. La forza acquisita negli ultimi anni ha anzi permesso
al settore privato del Golfo di sviluppare relazioni di cooperazione, e non più
di dipendenza, con i regimi dei loro
paesi. E questa nuova forza sociale tende a vedere con sospetto la promozione
della democrazia, temendo che i processi elettorali finiscano per avvantaggiare forze retrograde dal punto di vista
della modernizzazione economica e sociale, e spesso fautrici di un consistente
ruolo pubblico nell’economia. La politica statunitense di promozione della
democrazia nella regione dovrà quindi
fare i conti, oltre che con i regimi, con
questa nuova forza sociale che rischia
di rappresentare un’ulteriore fonte di
resistenza.
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 85
L’involontario benessere
Conclusione
Come abbiamo visto, i processi di liberalizzazione economica avviati dalle
monarchie del Golfo negli anni Novanta hanno incoraggiato lo sviluppo di un
dinamico settore privato. Le misure di
contrasto al terrorismo adottate in Occidente dopo l’11 settembre hanno poi stimolato il rimpatrio di parte dei capitali
detenuti all’estero dal settore privato del
Golfo: il loro investimento locale ha ancora rafforzato l’economia privata.
L’aumento del prezzo del petrolio
ha dato luogo nelle monarchie del Golfo a un boom economico in cui, a differenza di quelli degli anni Settanta, il
settore privato gioca un ruolo centrale.
Ruolo che è stato trainante nella fase
iniziale, quando i governi hanno utilizzato le entrate addizionali per rimborsare debito pubblico piuttosto che per
ampliare la spesa, e che rimane di
grande rilievo anche ora che i governi
hanno avviato politiche decisamente
espansionistiche.
Le ampie disponibilità finanziarie e
le crescenti competenze gestionali hanno progressivamente indotto il settore
privato del Golfo ad investire, direttamente o attraverso investimenti di portafoglio, in altri paesi della regione. Particolarmente consistenti nel Vicino
Oriente, questi investimenti tendono
ora a diffondersi anche nel resto del
Grande Medio Oriente.
Sta così crescendo l’influenza economica dei paesi del Golfo sul resto della
regione, così come le dinamiche politiche messe in atto dalla guerra in Iraq ne
13
ampliano l’influenza politica. La guerra
in Iraq ha infatti riacceso una serie di
conflitti, etnici e settari, che dall’epicentro iracheno si stanno diffondendo al resto del Golfo, al Vicino Oriente, al Nord
Africa e verso l’Asia meridionale.
Gli effetti economici e politici della
guerra in Iraq convergono
nel rafforzare il ruolo del Golfo
nel Grande Medio Oriente
Il ruolo regionale del Golfo sarà ancora accentuato dalla sfida nucleare
dell’Iran – anch’esso rafforzato economicamente13 oltre che politicamente
dalla guerra in Iraq – e dalla competizione tra sauditi e iraniani per influenzare i movimenti islamisti del Vicino
Oriente, specie dopo le ultime elezioni
in Egitto e Palestina.
Più in prospettiva, il settore privato
delle monarchie del Golfo – rinvigorito
dal boom economico – potrà investire
nella ricostruzione irachena una volta
che le condizioni locali lo consentano.
In questo modo potrà sostenere la minoranza sunnita dell’Iraq e contribuire
a contenere l’espansionismo sciita stimolato dal nuovo radicalismo iraniano.
Le dinamiche economiche e politiche suscitate nella regione dalla nuova
politica statunitense concorrono dunque a rafforzare il settore economico
privato nonché ad accentuare l’importanza regionale del Golfo. Tuttavia, non
vi è alcun indizio che l’auspicata riforma democratica, con la conseguente attesa pacificazione del quadro regionale,
ne sia la naturale conseguenza.
Il Pil iraniano è passato dai 116 miliardi di dollari del 2002 ai 176 miliardi di dollari del 2005,
con un aumento del 52%.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
85
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
osservatorio
3-10-2006
internazionale
documentazione
11:59
Pagina 86
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 87
documentazione
a cura di Antonio Mascia
Dichiarazione congiunta Russia-Georgia sul ritiro delle basi russe in territorio georgiano
Il 30 maggio 2005 a Mosca, i ministri degli Esteri della Federazione Russa e della Georgia – Sergei
Lavrov e Salome Zurabishvili – hanno firmato una Dichiarazione congiunta concernente la cessazione del funzionamento delle basi e delle altre infrastrutture militari russe e il contestuale ritiro delle truppe di Mosca (circa 3.000 unità) dislocate in territorio georgiano1.
Tale Dichiarazione giunge al termine di quattordici anni di complesse trattative e vede la rinuncia
da parte russa ad alcune fondamentali condizioni, legate alla tempistica ed ai costi delle operazioni di ritiro, precedentemente ritenute imprescindibili. A fronte dell’iniziale richiesta di Mosca di definire un calendario che contemplasse il graduale ritiro delle proprie truppe nell’arco di undici anni,
si è pervenuti ad un testo che riduce il lasso di tempo necessario a tale scopo a soli tre anni. Per
ciò che riguarda le rivendicazioni economiche della Russia, che si spinse a chiedere una compensazione di alcune centinaia di migliaia di dollari per la propria rinuncia alle basi in Georgia, la Dichiarazione congiunta non dispone nulla.
Le basi di Mosca in Georgia, lasciate in eredità dalla guerra fredda, risultano completamente anacronistiche alla luce dell’assetto geopolitico caucasico determinato dalla dissoluzione dell’Unione
Sovietica e sviluppatosi nel rinnovato quadro internazionale che ne è scaturito, e la loro chiusura
costituisce uno dei punti fondamentali del programma di politica estera del governo georgiano giunto al potere con la “rivoluzione delle rose”. Nel corso degli ultimi quindici anni le autorità dei due
paesi hanno tentato di definire status e disciplina delle infrastrutture militari di Mosca mediante la
stipula di due accordi. Il primo, di natura bilaterale, datato 1995, sanciva il diritto russo a conservare per venticinque anni le quattro basi presenti in territorio georgiano (Vaziani, Batumi, Gudauta,
Akhalkalaki), ma non fu mai ratificato dal parlamento di Tbilisi. Il secondo accordo, firmato dai due
paesi in occasione del vertice Osce di Istanbul del novembre 1999, disponeva l’evacuazione delle
basi di Vaziani e Gudauta e il conseguente ritiro delle risorse umane e materiali russe ivi presenti
entro il 1° luglio del 2001. La base di Vaziani (nei pressi di Tbilisi) è stata effettivamente chiusa nel
2000, quella di Gudauta (in Abkhazia) ha visto una contrazione della presenza delle truppe di Mosca, ma continua a ospitare una forza militare russa di peacekeeping.
La Dichiarazione congiunta del 30 maggio 2005 prevede che la Russia consegni le proprie basi di
Akhalkalaki (in Javakheti) e Batumi (in Agiaria) e le proprie installazioni militari alla controparte
georgiana ed evacui le proprie truppe entro la fine del 2008, secondo le seguenti modalità ed il relativo calendario:
• cessione delle strutture di riparazione dei mezzi blindati e dei carri armati situate a Tbilisi entro il 15
giugno 2005;
• cessione delle strutture di comunicazione presenti a Zvezda e a Kojori (nei pressi di Tbilisi), del campo di addestramento di “Gonio” e di altre infrastrutture minori entro il 1o settembre 2005;
• ritiro, entro la medesima scadenza, di almeno 40 veicoli corazzati, di cui non meno di 20 carri armati;
• cessione di ulteriori installazioni previste da una lista definita congiuntamente in due fasi successive:
1o gennaio 2006 e 1o ottobre 2007;
• evacuazione delle armi pesanti, comprese quelle previste dal Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, dalla base di Akhalkalaki entro la fine del 2006;
• ritiro completo delle truppe dalla base di Akhalkalaki e ritiro parziale da Batumi entro il 1o ottobre 2007
(con una possibile proroga alla fine del 2007 qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano);
• ultimazione del ritiro da Batumi e chiusura del quartier generale del Russia’s Group of Forces in the
Transcaucasus a Tbilisi nell’arco del 2008.
1
Joint Statement by the Ministers of Foreign Affairs of the Russian Federation and Georgia,
<http://www.mid.ru/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/bf502c80081d8ac5c32570120056b2d2?OpenDocument>.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
87
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 88
documentazione
La Dichiarazione congiunta prevede inoltre che:
• dal momento della firma della Dichiarazione le basi russe continuino a funzionare in assetto da ritiro,
riducendo l’addestramento e adoperandosi nell’organizzazione dell’evacuazione;
• i due paesi si impegnino ad indicare un ammontare concordato di risorse umane e materiali e alcune infrastrutture della base di Batumi che verranno utilizzati nel quadro del Georgian-Russian Anti-Terrorist Center in via di creazione;
• Russia e Georgia procedano tempestivamente alla firma di un Accordo che vincoli giuridicamente le due
parti su calendario, modalità di funzionamento e ritiro delle basi militari russe di Batumi e Akhalkalaki e
delle altre infrastrutture militari russe presenti sul territorio della Georgia (secondo quanto già stabilito
dalla Dichiarazione congiunta di Russia e Georgia firmata a Istanbul nel 1999);
• le due parti avviino le procedure atte a consentire una formale ispezione della base di Gudauta da parte dell’Osce, al fine di valutare la veridicità della posizione ufficiale di Mosca che dichiara di averla evacuata nel luglio 2001.
L’implementazione delle misure previste dalla Dichiarazione congiunta ha incontrato, o rischia di incontrare, alcuni ostacoli di natura economica, politica e giuridica, che minacciano di ritardarne l’attuazione. Il primo di essi attiene alla sfera economica ed è riconducibile alla riluttanza di Mosca a
farsi carico interamente degli oneri materiali impliciti nei processi di smobilitazione e, soprattutto,
di riallocazione delle proprie truppe. Il ministro degli Esteri russo Ivanov nel mese di giugno del 2005
ha dichiarato di voler procedere nell’arco del triennio 2006-2008 all’installazione di due basi militaˇ
ri in prossimità del confine georgiano, e più precisamente nel territorio della Karacai-Circassia
ea
Botlih in Dagestan. Nello stesso mese il presidente della Commissione Difesa e Sicurezza della Duma, Gennadii Gudkov, al termine di una visita privata nelle due basi russe di Akhalkalaki e Batumi,
segnalava la difficoltà di rispettare le scadenze dettate dalla Dichiarazione congiunta e indicava, in
mancanza di un incremento dei finanziamenti americani, la necessità di elevare a cinque il numero di anni necessari al completamento del processo di ritiro. Il testo della Dichiarazione, che prevede solamente «la cooperazione tra le parti al fine di attrarre i finanziamenti esteri necessari a coprire i costi di trasporto connessi al processo di ritiro», pare escludere ogni riferimento a contributi destinati al riposizionamento delle truppe russe. Tuttavia, l’assenza di una disciplina specifica in relazione ai finanziamenti contribuisce ad accrescere le occasioni di divergenza tra Russa e Georgia sulla ripartizione degli oneri economici del ritiro.
Il secondo ostacolo concerne la costituzione del Georgian-Russian Anti-Terrorist Center (Gratc). La
Dichiarazione si limita a menzionare la decisione di porre in essere la struttura di cooperazione in
chiave anti-terroristica, facendo ricorso «ad un ammontare concordato di personale militare e di
strutture tecniche e materiali della base di Batumi», e ne rimanda la disciplina ad un accordo separato. L’omissione di ogni precisazione in merito alla natura, alla composizione e al funzionamento
del Gratc ha dato adito ad un ampio spettro di interpretazioni, che va da quelle di chi lo intende come una sorta di think tank con compiti meramente analitici, a quelle di coloro che intravedono
l’eventualità che assuma il carattere di una nuova installazione militare russa. Sebbene non siano
state espresse posizioni ufficiali in proposito, è assai probabile che la questione sia destinata a vedere la contrapposizione di due prospettive difficilmente conciliabili. Da un lato, Tbilisi non pare disposta ad accettare di buon grado la sostituzione di fatto delle obsolete basi militari russe con un
Gratc concepito come una struttura militare con funzioni operative. Dall’altro, Mosca mostra la propria predilezione per una struttura in grado di operare con effettivi poteri militari in una duplice prospettiva: nel breve periodo, per contrastare l’attività dei guerriglieri ceceni presenti nella Valle di
Pankisi; nel medio-lungo periodo, per arginare la penetrazione americana in Georgia, avviata nel
2002 con l’invio di un contingente militare preposto all’addestramento anti-terroristico nel quadro
del Train and Equip Program.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
88
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 89
Il terzo, e più rilevante, ostacolo scaturisce dalla natura non giuridicamente vincolante della Dichiarazione congiunta. Nel testo in questione si invitano le parti ad «approntare tutte le misure necessarie ad implementare gli impegni concordati, inclusa la preparazione e la stipulazione, nel più breve tempo possibile, di un Accordo su calendario, modalità di funzionamento e ritiro delle basi militari russe di Batumi e Akhalkalaki e delle altre infrastrutture militari russe presenti sul territorio della Georgia…». Senza sottostimare la rilevanza politica e la specificità dell’impegno pubblicamente
assunto da Mosca e Tbilisi, resta da valutare quanto l’assenza di un vincolo giuridico formale potrà
essere sfruttata da coloro che, specie sul versante russo, vorranno temporeggiare, procrastinando
le scadenze concordate, o ridefinire alcuni elementi della Dichiarazione.
Raccomandazioni della Commissione europea relative ad Armenia, Azerbaigian e Georgia
Il 2 marzo 2005 la Commissione europea ha pubblicato tre Country Reports aventi in oggetto Armenia, Azerbaigian e Georgia, e una comunicazione diretta al Consiglio contenente una serie di dettagliate raccomandazioni sulle tematiche da considerare nella formulazione degli Action Plans relativi ai tre paesi del Caucaso meridionale2. Tali documenti costituiscono il punto di approdo di un
graduale processo di avvicinamento tra l’Ue e i paesi caucasici, che ha avuto modo di dipanarsi tra
il 1999 e il 2004.
Le relazioni, di natura bilaterale, tra Unione Europea e Armenia, Azerbaigian e Georgia presero formalmente avvio nel luglio del 1999 con l’entrata in vigore dei Partnership and Cooperation Agreements destinati a legare l’Ue a ciascuno dei tre paesi del Caucaso meridionale.
Nel luglio del 2003 Bruxelles ufficializzò la nomina dell’ambasciatore Heikki Talvitie a Rappresentante speciale per il Caucaso meridionale affidandogli un ampio mandato che, tra le altre cose, prevede: 1) un’assistenza nell’ambito del percorso di implementazione delle riforme politiche ed economiche; 2) un ruolo attivo nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti regionali, con un’attenzione particolare alla promozione del processo di ritorno dei rifugiati e dei profughi nei rispettivi territori di appartenenza; 3) un incoraggiamento e un sostegno allo sviluppo di relazioni di cooperazione tra gli stati della regione in primis nei settori dell’economia, delle risorse energetiche e dei trasporti; 4) un accrescimento dell’efficacia e della visibilità dell’Ue nella regione.
Un ulteriore passo avanti fu compiuto con la “Strategia di Sicurezza” dell’Unione Europea, adottata in via definitiva nel dicembre del 2003, che sottolineava la necessità di un interesse «stronger and
more active» da parte dell’Ue nei confronti della regione del Caucaso e prescriveva l’avvio di una
risoluta azione finalizzata a garantire stabilità e sviluppo dei paesi caucasici. Nel maggio del 2004 la
comunicazione della Commissione europea, “Politica europea di Vicinato. Documento di Strategia”,
raccomandava al Consiglio di includere l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia nella sfera d’azione
della Politica europea di Vicinato e invitava ad intraprendere la preparazione di specifici Action
Plans, condizionando l’intero processo all’impegno dei tre paesi nel consolidamento dell’autorità
della legge e della tutela delle norme dello stato di diritto, oltre che ad una risoluta azione di pacificazione dei conflitti in corso. Armenia, Azerbaigian e Georgia entrano quindi a far parte della Politica europea di Vicinato nel giugno del 2004.
I Country Reports e le raccomandazioni del marzo 2005 determinano un salto qualitativo nei rapporti tra l’Unione Europea e i paesi in questione e sanciscono l’avvio di una fase di più intenso e
concreto coinvolgimento dell’Ue nel Caucaso meridionale.
La comunicazione della Commissione segnala i più significativi progressi compiuti da Armenia,
Azerbaigian e Georgia, le questioni cruciali irrisolte e le più rilevanti sfide che questi paesi si trovano ad affrontare.
2
Comunicazione della Commissione al Consiglio, Politica europea di Prossimità. Raccomandazioni per l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, l'Egitto e il Libano, <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0072it01.pdf>
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
89
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
11:59
Pagina 90
documentazione
ARMENIA
L’Armenia ha fatto registrare negli ultimi anni buone performance macro-economiche con assai significativi tassi di crescita che consentono di intravedere i primi segnali di un’inversione di tendenza
rispetto agli elevati livelli di povertà precedentemente riscontrati. Con l’ingresso nel Wto (World Trade Organization), avvenuto nel corso del 2003, l’Armenia ha attivato un processo destinato a produrre riforme chiave nella direzione di un’economia orientata al mercato. Erevan sta inoltre compiendo
sostanziali progressi sulla via dell’armonizzazione tra la propria legislazione e quella dell’Ue. Una menzione particolare merita l’adozione di una risoluta strategia di contrasto alla corruzione.
Rimangono, tuttavia, aperte una serie di problematiche. Le più rilevanti sfide che attendono la leadership armena attengono alla tutela dei principi democratici e dei diritti umani e richiedono l’implementazione degli obblighi scaturenti dall’appartenenza al Consiglio d’Europa e all’Osce. I progressi più urgenti sono quelli che concernono il sistema elettorale – come segnalato dall’Office for Democratic Institutions and Human Rights in occasione delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2003 – e la difesa delle libertà individuali, in particolare la libertà di stampa. Con riferimento al settore economico, sono da ritenersi di primaria importanza, al fine di pervenire alla definizione di un clima favorevole agli affari e agli
investimenti, il perseguimento di un maggiore rispetto della legge, il miglioramento del sistema fiscale e
dei dazi doganali e la lotta alla corruzione. Una soddisfacente e duratura soluzione del conflitto con
l’Azerbaigian per l’Alto Karabakh, che continua a pervadere ogni aspetto della vita politica ed economica
dell’Armenia, consentirebbe di rimuovere un serio ostacolo al pieno sviluppo delle potenzialità del paese.
AZERBAIGIAN
Le più rilevanti sfide che l’Azerbaigian si trova a dover affrontare concernono il rafforzamento dell’autorità della legge e delle strutture democratiche, la lotta alla corruzione e alla frode, la tutela dei
diritti umani (in linea con gli obblighi discendenti dall’appartenenza al Consiglio d’Europa e all’Osce).
Sul versante economico si impone la necessità di creare un clima favorevole agli investimenti e di
pervenire alla diversificazione dell’attività economica. Diviene inoltre importante accrescere la trasparenza nella gestione dei proventi del petrolio e del processo di privatizzazione del settore. Oltre
alla sfide di natura politica ed economica, la soluzione del conflitto con l’Armenia per l’Alto Karabakh va segnalata come evento che consentirebbe di rimuovere un sostanziale ostacolo allo sviluppo del paese.
Viene infine sottolineata l’intenzione della Commissione di aprire una delegazione in Azerbaigian
nel corso del 2005, un obiettivo in effetti non ancora realizzato; al contrario, delegazioni della Commissione sono già operanti in Armenia e Georgia.
GEORGIA
Nel Country Strategy Paper del 2003 la Commissione descriveva con toni assai negativi il quadro
politico georgiano. Nel documento in questione si dava conto di una situazione complessiva connotata da povertà diffusa, da gravi problemi nell’esercizio dell’autorità politica e nell’amministrazione della legge, da elevati livelli di corruzione, da relazioni tese con la Russia, da conflitti interni con
le Repubbliche secessioniste di Abkhazia e Ossetia meridionale e, infine, da un elevato ammontare di debito estero.
La “rivoluzione delle rose” del novembre 2003, e lo spirito riformatore che l’ha accompagnata, furono pertanto accolti positivamente dall’Ue e dalla più ampia comunità internazionale. Il conseguente svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari relativamente libere ed eque e l’avvio di un
ampio programma di riforme vengono reputati progressi positivi. I successi raggiunti riguardano, in
modo particolare: 1) il contrasto ad alcune forme di corruzione; 2) l’aumento del gettito fiscale; 3) il
pagamento regolare di salari e pensioni; 4) il contenimento del contrabbando; 5) buone performance macro-economiche; 6) la reintegrazione dell’Agiaria nel sistema economico, sociale e ammini-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
90
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
12:00
Pagina 91
strativo della Georgia; 7) la rinnovata fiducia dei donatori esteri (con il successo della Conferenza
dei donatori svoltasi a Bruxelles nel giugno del 2004).
Restano, tuttavia, aperte una serie di problematiche fondamentali la cui soluzione passa per il rafforzamento dell’autorità della legge, il consolidamento del sistema democratico (in linea con i vincoli di appartenenza al Consiglio d’Europa e all’Osce), la lotta alla corruzione, la creazione di un clima favorevole agli investimenti, l’attuazione di un trasparente processo di privatizzazione di alcuni
settori dell’economia georgiana, il miglioramento delle relazioni con la Russia e la soluzione pacifica dei conflitti interni che oppongono il governo georgiano alle regioni secessioniste.
La Commissione, tenendo conto dell’attuale contesto politico, economico e istituzionale descritto
dai Country Reports, indica una serie di interventi comuni ai tre paesi. In particolare gli Action Plans
in negoziazione con Armenia, Azerbaigian e Georgia dovrebbero prevedere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
il consolidamento dello stato di diritto;
il rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti umani;
l’ampliamento delle strutture democratiche e degli strumenti atti a garantire un maggior pluralismo;
il miglioramento del clima economico e la modernizzazione del settore pubblico;
la riforma del sistema fiscale e di quello dei dazi, con una legislazione in linea con gli standard internazionali ed europei, accompagnata da una risoluta lotta alla corruzione e alla frode;
il progresso nel processo di riduzione della povertà;
il perseguimento di uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle norme di tutela ambientale;
il compimento di progressi in direzione della soluzione dei conflitti e di un miglioramento della cooperazione regionale;
l’intensificazione del dialogo politico, con un ulteriore progresso nell’implementazione dei Partnership
and Cooperation Agreements del 1999;
il sostegno alle riforme economiche in vista di una graduale integrazione nel mercato interno dell’Ue;
un ulteriore supporto per la riabilitazione economica delle aree teatro di conflitto nell’ottica di una
composizione dei conflitti in corso;
un accrescimento del supporto finanziario che preveda l’estensione al 2007 del mandato della Banca europea per gli investimenti;
un ampliamento del sostegno alla cooperazione regionale;
il rafforzamento della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni che possibilmente
includa l’apertura di un tavolo di dialogo teso alla definizione di un accordo in materia di visti;
l’intensificazione della cooperazione nei settori dell’energia, della comunicazione elettronica, dei trasporti, dell’ambiente, della sanità, della scienza e della tecnologia.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
91
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
12:00
Pagina 92
documentazione
L’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan e il “Grande Gioco” per il controllo
delle risorse energetiche del Caspio
Il 25 maggio 2005 ha avuto luogo, davanti ai presidenti di Azerbaigian, Georgia e Turchia – Ilham
Aliyev, Mikheil Saakashvili e Ahmet Necdet Sazer – e ai rappresentanti ufficiali di una trentina di paesi, tra i quali il titolare del dipartimento americano per l’energia Samuel Bodman, l’inaugurazione della pipeline Baku-Tbilisi-Ceyhan (Btc). Assai significativamente nessun rappresentante della Federazione Russa, che ha apertamente osteggiato la realizzazione dell’opera, ha preso parte alla cerimonia.
L’oleodotto Btc conduce il greggio estratto dai giacimenti petroliferi offshore azeri del Mar Caspio
(Chirag, Azer e Guneshli) alle sponde del Mar Mediterraneo meridionale, mediante un tracciato lungo 1.760 chilometri, che prende il via dalla capitale dell’Azerbaigian, percorre il territorio della Georgia, attraversandone la capitale, e giunge al porto turco di Ceyhan. La pipeline Btc consente di bypassare gli Stretti turchi del Bosforo e dei Dardanelli, ormai congestionati da un volume di traffico (circa 3 milioni di barili al giorno) divenuto insostenibile tanto per ragioni ambientali quanto per ragioni
di sicurezza, quanto infine per ragioni economiche legate ai lunghi tempi di percorrenza delle rotte
verso i mercati occidentali.
L’infrastruttura in questione, finalizzata alla creazione di un corridoio di transito petrolifero in grado
di rispondere alla crescente domanda internazionale di risorse energetiche, fu concepita in maniera tale da soddisfare la duplice esigenza di porre rimedio alla chiusura geografica del Mar Caspio, e
di aggirare la rete monopolistica delle pipelines russe. La concreta progettazione dell’oleodotto Btc
prese avvio all’indomani dell’implosione dell’Unione Sovietica per impulso del presidente azero Heydar Aliyev e del suo omologo georgiano Eduard Shevarnadze. Nel 1994 Heydar Aliyev concluse con
il consorzio occidentale denominato Azerbaijan International Operating Company (Aioc) il cosiddetto «contratto del secolo», che prevedeva un accordo per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi caspici dell’Azerbaigian e che, nella ripartizione dei proventi, riservava a Baku una quota pari al 30%. Il
consorzio era guidato dalla britannica BP, che assunse la funzione di gestore dell’oleodotto (con una
quota pari al 30,10%) ed era composto dalla State Oil Company of Azerbaigian (25%), dalle americane Unocal (8,90%), Conoco-Philips (2,50%) e Amerada Hess (2,36%), dalla norvegese Statoil (8,71%),
dalla turca Turkiye Petrolieri Anonim Ortakligi (6,53%), dall’italiana Eni (5%), dalla francese Total-FinaElf (5%), dalle giapponesi Itochu (3,40%) e Inpex (2,50%).
La costruzione dell’imponente opera, che prevede un ampio corollario di infrastrutture di pompaggio
e di sicurezza, ha avuto inizio nel settembre del 2002 e ha comportato un investimento complessivo
di quasi 4 miliardi di dollari, in parte finanziati da fondi pubblici internazionali canalizzati attraverso l’International Finance Corporation della Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Al massimo delle sue potenzialità operative, nel 2009, la pipeline Btc sarà in grado di trasportare un milione di barili di greggio al giorno, pari a circa l’1% della domanda mondiale di petrolio.
L’oleodotto Btc si colloca in una posizione di primo piano nel quadro del cosiddetto “Grande Gioco”
per il controllo delle ingenti risorse di idrocarburi presenti nel bacino del Mar Caspio che vede, in primo luogo, la contrapposizione tra Stati Uniti e Federazione Russa, ma che promette di coinvolgere
un numero crescente di attori internazionali.
Il Caucaso meridionale assume in tale contesto una funzione strategica centrale configurandosi come naturale terreno di transito di quelle infrastrutture di trasporto energetico in grado di inaugurare
una rete di pipelines alternativa rispetto a quella russa e di recidere i vincoli che il sistema monopolistico concepito e mantenuto da Mosca impone tuttora alle giovani repubbliche dell’area.
Già dai primi anni Novanta, gli Stati Uniti posero al centro dei loro interessi di sicurezza nella regione caucasica la cosiddetta Multiple Pipeline Strategy, che segnalava, tra l’altro, l’urgenza di: 1) assicurare la sovranità e l’indipendenza dei paesi che si affacciano sul bacino caspico; 2) favorire la de-
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
92
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
12:00
Pagina 93
finizione di strumenti di cooperazione economica tra i paesi dell’area e la Turchia; 3) diversificare e
facilitare l’accesso alle risorse energetiche del Mar Caspio.
L’impulso statunitense alla realizzazione della pipeline Btc fu determinante e costituì un evidente elemento di continuità della strategia degli Stati Uniti nella regione ex sovietica, a prescindere dall’orientamento dell’amministrazione di volta in volta in carica.
Accanto agli opposti interessi di Stati Uniti e Federazione Russa mossi, gli uni, dall’esigenza di accrescere la propria presenza economica e militare nell’area e, l’altra, dalla determinazione a contrastare il graduale quanto ineluttabile processo di contrazione della propria influenza, si collocano gli interessi dei paesi del Caucaso meridionale e quelli dell’Europa.
L’oleodotto Btc, assieme alle altre opere infrastrutturali in via di costruzione, costituisce per Georgia
e Azerbaigian un formidabile strumento per il conseguimento di obiettivi politici ed economici vitali.
Il successo del processo di transizione, destinato a culminare nel raggiungimento della piena libertà, indipendenza e sovranità delle due repubbliche, passa necessariamente dall’emancipazione dal
sistema di forniture energetiche sotto il controllo russo. La pipeline Btc, inoltre, pone le premesse
per l’avvio di un graduale percorso di ampliamento delle relazioni con la principale destinataria degli idrocarburi caspici, l’Ue. Per quanto concerne il versante economico, Tbilisi e Baku reputano che
– per effetto, rispettivamente, degli introiti derivanti dai diritti di transito (stimati attorno all’1,5% del
prodotto interno lordo georgiano) e delle crescenti esportazioni di greggio – l’oleodotto Btc possa
fungere da volano per le loro economie e possa favorire una maggiore integrazione economica tra
i paesi della regione meridionale del Caucaso.
L’Europa, costretta a fare i conti con una crescente domanda interna di risorse energetiche, considera la pipeline Btc come uno strumento essenziale per diversificare il proprio paniere di fonti di approvvigionamento e per svincolarsi dalla dipendenza strategica dal Golfo Persico (per quanto riguarda il petrolio) e dalla Federazione Russa (per il gas).
L’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan è al centro di un progetto di ampliamento che coinvolge il Kazakistan. Il governo kazako ha annunciato di voler porre in collegamento i ricchi giacimenti petroliferi di
Tengiz, Atirau, Aktjubinsk, localizzati sul proprio territorio, e il giacimento offshore di Kashagan con
l’oleodotto azero-georgiano-turco. Più precisamente il progetto prevede la costruzione di una pipeline sottomarina che congiunga il porto kazako di Aktau con Baku. In attesa del completamento dell’oleodotto il Kazakistan sta provvedendo ad allestire una flotta di petroliere in grado di coprire la medesima distanza.
La pipeline Btc svolge inoltre la fondamentale funzione di catalizzatore di tutta una serie di opere per
il trasporto energetico, tra le quali il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (denominato South Caucasus Pipeline, Scp), che collega il giacimento azero di Shah Deniz con la città turca Erzurum e che si estende per gran parte degli 880 chilometri del proprio tracciato parallelamente all’oleodotto Btc. Secondo le previsioni questa pipeline dovrebbe essere completata entro la fine del 2006, mentre si cominciano ad avanzare progetti che ipotizzano, da un lato, la costruzione di un collegamento sottomarino che connetta le imponenti risorse del Turkmenistan al gasdotto Scp e, dall’altro, di un’estensione dello stesso gasdotto alle sponde del Mar Mediterraneo. Questa pipeline risulta di particolare interesse per l’Europa che avrebbe la possibilità di rifornirsi del gas di cui necessita ad un costo inferiore rispetto a quello stabilito dal monopolista russo Gazprom.
Merita infine una menzione l’oleodotto Baku-Supsa operativo dal 1999, costato circa un miliardo di
dollari e destinato al trasporto del cosiddetto «early oil» con una capacità decisamente inferiore rispetto a quella della pipeline Btc. Concepito per trasportare 100.000 barili al giorno lungo un tracciato di 915 chilometri che va dai giacimenti petroliferi offshore azeri di Chirag, Azer e Guneshli ai porti georgiani sul Mar Nero di Supsa e Batumi, ha subìto lavori di ampliamento che ne hanno più che
triplicato la capacità di trasporto (200.000 barili al giorno a Supsa e 140.000 a Batumi), ma ogni ulteriore investimento è stato bloccato a favore dell’implementazione dell’oleodotto Btc.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
93
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
12:00
Pagina 94
documentazione
Il costo della guerra in Iraq
Nei mesi che precedettero l’avvio delle operazioni belliche in Iraq, le stime sull’impatto economico del
conflitto furono sorprendentemente poche e non particolarmente approfondite. In un’intervista al
«Wall Street Journal» il consigliere economico della Casa Bianca Larry Lindsey sostenne che la soglia
superiore del costo della guerra poteva essere valutata in 100-200 miliardi di dollari e che nel dopoguerra la rapida ripresa della produzione petrolifera irachena avrebbe avuto effetti benefici per l’economia americana. L’editoriale del giornale fece propria questa tesi sostenendo che «il modo migliore
di controllare il prezzo del petrolio è una breve guerra all’Iraq, coronata da successo»1.
Soltanto altre due stime vennero rese note, da parte rispettivamente dello Staff democratico dell’House Budget Committee, e del Congressional Budget Office. Pur muovendo da premesse diverse e ricorrendo ad approcci differenti, esse concordarono nel ridimensionare la previsione di Lindsey e pronosticarono una breve e vittoriosa guerra che sarebbe costata intorno a 50 miliardi di dollari.
Partendo dal presupposto che il costo della guerra viene sistematicamente sottovalutato, l’economista William D. Nordhaus dell’Università di Yale pubblicò a ottobre 2002 uno studio che, distinguendo
i costi diretti della guerra da quelli indiretti, pervenne a due stime: l’una basata sull’eventualità di un
conflitto di breve durata e dall’esito favorevole, l’altra sull’eventualità di un conflitto prolungato. Nel
primo caso l’onere economico per gli Stati Uniti sarebbe ammontato a circa 120 miliardi di dollari, nel
secondo a oltre 1.5002.
Le evidenze emerse nell’arco dei tre anni che ci separano dall’inizio del conflitto, mostrano l’inadeguatezza di gran parte delle analisi pre-belliche — intrise di eccessivo ottimismo in relazione agli esiti e ai benefici dell’azione militare americana — e impongono di interrogarsi sull’effettivo costo della
guerra in Iraq.
La prima valutazione da compiere riguarda evidentemente il costo direttamente a carico del bilancio
degli Stati Uniti, operazione non del tutto semplice data la molteplicità delle linee di bilancio e la scarsa trasparenza del bilancio del Dipartimento della Difesa. Un primo tentativo in tal senso è stato effettuato da Amy Belasco in un rapporto preparato per il Congressional Research Service e pubblicato nell’ottobre del 20053.
Negli anni finanziari 2003-2005 la guerra in Iraq ha richiesto lo stanziamento di 212,1 miliardi di dollari che vanno sommati ai 2,5 devoluti negli esercizi finanziari 2001-2002 per la pianificazione dell’invasione. L’ammontare totale è, pertanto, pari a 214,6 miliardi di dollari. Il quadro tendenziale, inoltre, mostra un incremento sostanziale dei finanziamenti per la missione in Iraq, passati dai 51 miliardi di dollari dell’anno finanziario 2003, ai 78,7 del 2004 per toccare gli 82,5 contabilizzati per il 2005. Aggiornando il dato al dicembre dello scorso anno, l’onere totale per la guerra in Iraq si attesta intorno ai
250 miliardi di dollari. Si noti che, sempre secondo il rapporto del Congressional Research Service, dall’anno finanziario 2003 ad oggi il costo medio mensile delle operazioni in Iraq è balzato da 4,4 a 7,1
miliardi di dollari (pari a quasi 240 milioni di dollari al giorno), con un incremento del 33%.
Questi dati, pur superiori a gran parte delle stime pre-belliche, concorrono a delineare un quadro tutt’altro che esaustivo. Gli stanziamenti registrati dal bilancio degli Stati Uniti costituiscono, infatti, soltanto una parte dei costi complessivi della guerra. In uno studio assai dettagliato pubblicato nel gennaio del 20064, il premio Nobel Joseph E. Stiglitz e Linda Bilmes, dell’Università di Harvard, hanno cercato di quantificare anche i costi indiretti della guerra.
Lo studio di Stiglitz e Bilmes suddivide i costi indiretti in costi che gravano o graveranno sul bilancio
federale americano, costi economici e costi macroeconomici, giungendo a due differenti stime, l’una
prudenziale, l’altra moderata.
1
Saddam's Oil, in «Wall Street Journal», September 15, 2002.
W.D. NORDHAUS, The Economic Consequences of a War with Iraq, October 29, 2002,
<http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/iraq.pdf>.
3
A. BELASCO, The Cost of Iraq, Afghanistan and Enhanced Base Security Since 9/11, CRS Report for Congress RL33110,
October 7, 2005, <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf>.
4
L. BILMES - J. STIGLITZ, The Economic Costs of the Iraq War: an Appraisal Three Years after the Beginning of the Conflict,
January 2006, <http://ksgnotes1.harvard.edu/research/wpaper.NSF/RWP/ RWP06-002>.
2
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
94
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
12:00
Pagina 95
I costi a carico del bilancio federale comprendono, anzitutto, la copertura delle spese per le cure mediche a carico della Veterans Administration. Si stima che finora i soldati feriti siano oltre 16.500, dei
quali, secondo i dati del Pentagono riportati in un’analisi di Scott Wallsten e Katrina Kosec dell’American Enterprise Institute5, il 20% ha subìto ferite molto gravi che implicano danni cerebrali e il 6% un’amputazione, mentre circa il 30% dei soldati ha registrato problemi di salute mentale nei 3-4 mesi successivi al rientro dall’Iraq. Una parte di questi soldati necessiterà di cure mediche prolungate, se non
vitalizie, e la Veterans Administration dovrà elargire numerosi sussidi di invalidità. La stima complessiva di tali costi va dai 91 miliardi di dollari della previsione prudenziale ai 214 di quella moderata.
In secondo luogo, vanno menzionali i costi per il ritiro, il trasporto e la smobilitazione delle truppe presenti in Iraq, valutati tra 6 e 8 miliardi di dollari.
In terzo luogo, si colloca l’incremento delle spese per garantire un sufficiente e costante reclutamento delle truppe. In particolare è stato necessario assumere nuovi reclutatori, investire maggiori risorse nelle campagne pubblicitarie ed offrire una serie di incentivi economici ai soldati. L’onere che ne è
derivato per il bilancio della Difesa è stimato da Stiglitz e Bilmes tra 104 e 139 miliardi di dollari. Tale
stima è calcolata al netto delle risorse risparmiate per la cessazione delle operazioni di pattugliamento della no-fly zone (tra 11 e 15 miliardi di dollari all’anno).
Vengono infine valutati anche gli interessi sul debito acceso per finanziare i costi della guerra.
Per quanto concerne i costi economici i due studiosi fanno riferimento: alla mancata produzione di reddito cagionata dalla morte, dall’invalidità o dal ferimento grave dei soldati e dei contractors impegnati in
Iraq; alla dislocazione di circa il 40% dei componenti della Guardia Nazionale e del Corpo dei Riservisti
lontano dal territorio americano; all’accelerazione dell’ammortamento degli equipaggiamenti militari.
Restano infine da calcolare gli effetti macroeconomici prevedibili, che Stiglitz e Bilmes individuano nell’impatto dell’incremento del prezzo del petrolio (attribuibile alla guerra in Iraq per il 20-40% del totale) e
delle spese per la difesa. Altri rilevanti fattori, come l’aumento dell’insicurezza globale, sono ritenuti sostanzialmente impossibili da stimare e dunque vengono tralasciati. Sotto queste ipotesi, l’onere complessivo generato dagli effetti macroeconomici della guerra è stimato tra 187 e 1.050 miliardi di dollari.
In definitiva, la sommatoria dei costi di bilancio diretti ed indiretti, dei costi economici e macroeconomici conduce i due studiosi a segnalare che, in un’ottica di previsione prudenziale, il costo totale della
guerra in Iraq può essere indicato in 1.026 miliardi di dollari mentre in un’ottica moderata tale cifra sale a 2.239 miliardi di dollari.
Un approccio assai differente, fondato su un’analisi costi-benefici, è adottato nello studio di Wallsten e
Kosec, al quale si è già fatto cenno. Vengono qui trascurati alcuni elementi presi in esame da Stiglitz e
Bilmes (quali gli effetti macroeconomici della guerra) per concentrarsi sui costi diretti delle operazioni
militari e su quelli derivanti dalla morte o dal ferimento grave dei soldati americani. Sulla base di proiezioni effettuate dal Congressional Budget Office sul futuro impegno americano in Iraq, vengono anche
proiettate le stime fino al 2015. Si perviene in questo modo a tre differenti valutazioni che individuano
il costo della guerra per gli Stati Uniti nel periodo 2003-2015 in una somma (in termini di valore attuale netto) compresa tra 540 e 672 miliardi di dollari — a fronte di benefici (costi evitati) pari a 110-125 miliardi di dollari. I due analisti dell’American Enterprise Institute completano il quadro compiendo un’indagine sui costi a carico degli altri partner della coalizione e su quelli che gravano sull’Iraq, che ammontano rispettivamente ad una somma compresa tra 87 e 103 miliardi di dollari e ad una tra 192 e 424, a
fronte di costi evitati, nulli per i partner della coalizione ma pari a 192-433 miliardi di dollari per l’Iraq
(sulla base di una stima secondo cui la permanenza del regime di Saddam Hussein avrebbe prodotto
10.000 vittime all’anno). La valutazione dei costi complessivi del conflitto iracheno si assesterebbe, pertanto, tra un minimo di 820 e un massimo di 1.199 miliardi di dollari, a fronte di costi evitati stimati tra
302 e 558 miliardi di dollari.
5
S. WALLSTEN - K. KOSEC, The Economic Costs of the War in Iraq, Working Paper 05-19, AEI Brookings Joints Center for
Regulatory Studies, September 2005, <http://aei-brookings.org/admin/ authorpdfs/page.php?id=1188>.
Quaderni di
Relazioni Internazionali
n. 1 Aprile 2006
95
00470238603801_VOLAIT@0001-0096#
3-10-2006
12:00
Pagina 96
00470238603801_COVAIT@EST
3-10-2006
14:31
Pagina 1
Osservatorio Internazionale
Il disincanto iracheno
Guerra e boom economico nel Golfo
Documentazione
ISBN 88-238-6038-5
9 788823 860384
Euro 10,00
La partita nel Caucaso
Un nuovo Grande Gioco?
Il confronto tra Stati Uniti e Russia
Il ruolo di Turchia e Unione Europea
La transizione politica
ISPI n. 1 2006 Quaderni di Relazioni Internazionali
Dossier - Caucaso
ISPI
Quaderni di Relazioni Internazionali
Quadrimestrale dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
n. 1 - Aprile 2006
La partita nel
Caucaso