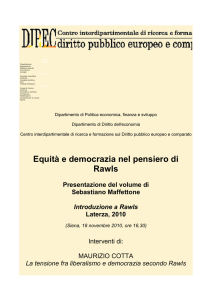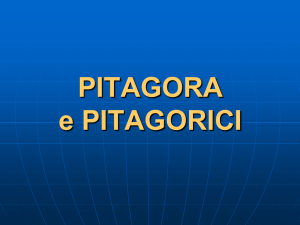RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XVIII
NUOVA SERIE - N. 51 - GENNAIO-APRILE 2004
Manni
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di filosofia
dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano
di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce,
e dello stesso Dipartimento.
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
2
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce),
Antonio Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno),
Antonio Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De
Leo, Lucia De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia,
Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel. (0832) 294627/8;
fax (0832) 294626.
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto
I, 51 73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/205577 - 0832/200373. Iscritto
al n. 389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento
annuo: Italia t 25,00, Estero t 35,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero
Manni s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da
gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo t 10,00, degli anni precedenti il doppio.
Stampato presso Tiemme - Manduria
nel dicembre 2003 - per conto di Piero Manni s.r.l.
SOMMARIO
5
R. Raggiunti
IL SIGNIFICATO LINGUISTICO E FILOSOFICO
DELLA LINGUISTICA GENERALE DI F. DE SAUSSURE
11
N. Comerci
IDENTITÀ DIACRITICA E INTERSOGGETTIVITÀ
NELL’ONTOLOGIA DI M. MERLEAU-PONTY
26
E. Rizzuti
ORIZZONTI DEL COMPRENDERE.
L’IMPURITÀ COME METAFORA TRASVERSALE
44
A. Micheloni
L’ETICA DEL DISCORSO E LE SUE POSSIBILITÀ
IN FUNZIONE DI UNA SOCIOLOGIA ETICA. A PARTIRE DA HABERMAS
66
W. McBride
LA LEGGE DEI POPOLI DI J. RAWLS: UN RIESAME CRITICO
79
G. Bonacina
DALLA FILOSOFIA DELLA VITA ALLA LOGICA ERMENEUTICA
84
M. Gaetani
SCRUPOLI (E PICCOLE ASTUZIE) DI UN MAESTRO DELLA MODERNITÀ.
NOTA SU LÉVI STRAUSS
95
R. Rossetti
L’EPICA ODISSEA COME NAUFRAGIO DELLA MENZOGNA
110
A. Stanca
HESSE: DALL’UOMO A DIO. UNA STORIA SENZA TEMPO
113
M. T. Russo
IL CORPO GUARDATO: AUTENTICITÀ E IMMAGINE
122
Anna Rita Merico
RAPPRESENTAZIONE
E SPAZI DELLA CITTADINANZA FEMMINILE
126
Recensioni
3
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o
Dipartimento di Filosofia – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola
facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella non dovrà
superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche
su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa
comunicazione e approvazione dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
4
IL SIGNIFICATO LINGUISTICO E FILOSOFICO
DELLA LINGUISTICA GENERALE
DI FERDINAND DE SAUSSURE
La distinzione fondamentale, che ci viene fornita dal Cours de Linguistique
générale, è quella di langue e parole. Saussure considera i sintagmi e le frasi
costruiti su forme o moduli regolari come entità che sono da attribuire alla langue, anziché alla parole. La langue è “la parte sociale del linguaggio, esterna
all’individuo, che da solo non può né crearla né modificarla, essa esiste solo
in virtù di una specie di contratto stipulato fra i membri della comunità”1.
La langue, distinta dalla parole, è un oggetto che si può studiare separatamente. Potenzialmente, tutte le frasi sono già date nella lingua in quanto
nella lingua sono già date tutte le regole per la combinazione delle parole.
Saussure, a questo punto, si domanda in quale maniera la parole sia presente nel modello collettivo della langue. Egli afferma che, a rigore, “non vi è
niente di collettivo nella parole, le sue manifestazioni sono individuali e
momentanee”2.
Il Nostro afferma ancora che si può parlare di “una linguistica della parole.
Ma bisognerà non confonderla con la linguistica propriamente detta, quella
della quale la langue è l’unico oggetto”. Bisogna non cancellare i limiti che
separano i due domini. Ma la lingua, qualsiasi lingua, non stabilisce e non prescrive che alcune parole, aventi un particolare significato, debbano o anche
soltanto possano essere combinate in una certa maniera con altre. De Mauro,
nella sua Introduzione al Corso, da lui tradotto3, cerca di porre in evidenza gli
aspetti più significativi e originali della linguistica generale di Saussure, con la
seguente osservazione: “Il punto di partenza delle riflessioni di Saussure è l’acuta consapevolezza della individualità assoluta, irripetibile del singolo atto
espressivo, quell’atto che egli chiama naturalmente in francese parole, e parole chiamano ormai i linguisti nelle più diverse lingue del mondo”4.
Il carattere di individualità e libertà della parole veniva spiegato proprio in
riferimento a quella “libertà di combinazione” che costituisce l’aspetto più interessante della parole. Come osserva De Mauro, Saussure, affermando il
carattere di “individualità assoluta, irripetibile, del singolo atto linguistico”
aveva in mente più il lato semantico di esso che quello astrattamente sintattico. Le differenze semantiche di una stessa parola, qualunque essa sia, risultano chiaramente dai diversi contesti significazionali in cui la parola viene a
trovarsi. Mi pare si debba affermare che nel Saussure sono contenute tutte le
premesse valide per giungere a quelle conclusioni.
André Burger, in un articolo del 19615, ha contribuito in maniera notevole a
chiarire la distinzione saussuriana di signifié e signification. Per Burger, giustamente, la nozione di signifié è da attribuire alla langue e quella di significa-
SAGGI
di Renzo Raggiunti
5
6
tion o sense alla parole. Che cosa fa sí che il significato, entità potenziale,
nella parole si attualizzi e si trasformi nella significazione?
Malgrado le differenze foniche e significazionali in cui quella parola si attualizza successivamente, noi dobbiamo dire che si tratta sempre della stessa
parola. La lingua, in questo senso, è un tesoro depositato nel nostro cervello.
Questo tesoro –afferma Saussure– si è potuto formare in virtù di una facoltà
ricettiva e coordinativa. La spiegazione di Saussure non va più in là. Tale facoltà coordinativa non potrebbe operare, a livello di lingua, se non vi fosse, prima
di tutto, una facoltà astrattiva, capace di cogliere il generale dal particolare, l’astratto dal concreto. Ma la lingua rinvia necessariamente alla parole: “historiquement, le fait de parole précède toujours. Comment s’aviserait-on d’associer une idée à une image verbale, si l’on ne surprenait pas d’abord cette association dans un acte de parole? D’autre part, c’est en entendant les autres que
nous apprenons notre langue naturelle: elle n’arrive à se déposer dans notre
cerveau qu’à la suite d’innombrables expériences”6.
Saussure associa alla facoltà ricettiva una facoltà coordinativa, ma quest’ultima non è in grado di funzionare senza una facoltà astrattiva. La distinzione di langue e parole, rigorosamente formulata da Saussure, contiene
implicitamente la tesi di una attività astrattiva, che sia fondamento di quel
“tesoro depositato nel nostro cervello”, che è la lingua. Tuttavia non troviamo
nel Cours e neppure nelle fonti una affermazione o una serie di affermazioni
che si riferiscano esplicitamente a tale attività astrattiva. Come si può spiegare questa lacuna? De Mauro, giustamente osserva che Saussure evita deliberatamente di usare il termine “astratto”, poiché, nell’ambiente culturale del
suo tempo, dominato dalla “epistemologia kantiana, idealistica, positivistica”7
quel termine ha subito una svalutazione.
Tuttavia la tesi di una facoltà astrattiva, e della conseguente attività astrattiva, è una conseguenza inevitabile della tesi saussuriana sulla lingua e la
relazione-distinzione di langue e parole.
Bisogna spiegare come il significato (signifié) si trasformi nella significazione (signification o sens). La signification è un elemento semantico che si integra con gli altri, nella combinazione della parole. La significazione può essere
considerata come il contenuto semantico globale di un’intera frase anche
molto complessa, e può essere considerata come il singolo contenuto semantico portato dal singolo vocabolo all’interno di una frase composta di molti
vocaboli. Dobbiamo, però, osservare che il termine “significazione” e il termine “significato” si presentano talvolta nei testi saussuriani, con un significato
generico e impreciso: si dà il caso che si adoperi il termine “significazione” per
designare il “significato”.
A questo proposito, possiamo osservare che il termine “significazione”,
come il suo equivalente “senso” si presentano talvolta nei testi saussuriani con
un significato generico e impreciso, comprensivo tanto della nozione di “significazione” quanto di quella di “significato”. Un esempio di questa imprecisione
lo troviamo alle pagine 158, 159 del Cours nelle quali la signification è rappresentata semplicemente come la “contre-partie de l’image auditive”.
Ma la via giusta, indicata dallo stesso Saussure, è quella che ci conduce al
SAGGI
fattore contestuale. È il contesto linguistico il fattore linguistico determinante il
carattere specifico e particolare della significazione.
Il criterio denotazionistico, vale a dire del “concreto riferimento che un individuo fa con un segno ad un certo oggetto” può essere un fattore determinante –di natura extra-linguistica– delle particolarità di una significazione entro un
atto linguistico, ma non esaurisce il contenuto di essa. Per cogliere il significato autentico del termine saussuriano “significazione” la via giusta è quella
che conduce al fattore contestuale, più propriamente contestuale-linguistico.
Ritornando al Cours, la pagina presa in esame, in cui si parla di parole di
significato diverso le quali possono avere una stessa significazione, che corrisponde alla pagina 160 dell’edizione originale, è da attribuire esclusivamente
agli editori. Infatti, come si può constatare, osservando l’edizione critica dello
Engler, le proposizioni che abbiamo citato dal Cours non trovano un puntuale
riscontro nelle fonti. Quanto è affermato in esse, sul rapporto fra il significato
e la significazione, dipende da una errata interpretazione degli editori, che
hanno, in questo caso, a mio parere frainteso, il pensiero del Maestro.
Nell’ultimo capitolo del terzo corso8 Saussure sostiene che ciò che permette alla concezione delle lingua di evitare la soluzione nominalistica è il fatto
che la significazione (senso), pur essendo dipendente dal valore (significato),
ne è tuttavia distinta. Significato e significazione non si identificano, rimangono distinti, e ciò consente di attribuire al significato una flessibilità e mutevolezza, che lo rende diverso da lingua a lingua e, all’interno di una stessa lingua, suscettibile di trasformazioni diacroniche. Anche se Saussure non lo
afferma esplicitamente, le significazioni, che hanno il loro piano di realizzazione nella parole, nella loro possibilità di attuazione infinita, costituiscono il fattore principale di trasformazione del significato. Come le significazioni dipendono dai significati, i significati dipendono dalle significazioni.
Libertà e originalità dei rapporti sintattici o contesti linguistici, indeterminatezza del numero delle significazioni: è quanto basta per rendere illusorio e
contraddittorio il tentativo di produrre una qualsiasi classificazione delle significazioni. Langue e parole sono due termini che, nel pensiero di Saussure, si
oppongono, ma, nello stesso tempo, si completano e si condizionano reciprocamente. Sappiamo che non sono pochi i linguisti che mettono in dubbio la
validità di questa distinzione saussuriana9.
Ma vi è un altro argomento, di particolare interesse, quello dell’idioletto
(una lingua individuale), che avrebbe in comune con la parole un carattere di
individualità. Vi è da chiedersi quale sia il rapporto fra tale idioletto e la langue.
L’idioletto è in una relazione necessaria e ineliminabile con la lingua “sociale”?
Se l’idioletto è in una relazione necessaria con la lingua “sociale”, è fuori discussione che l’idioletto non può essere individuale come la parole propriamente detta.
È certo che la nozione di “lingua individuale” non mette radicalmente in crisi
la nozione di langue, poiché la prima assorbe in sé senza annullarla la nozione di langue, e neppure la distinzione saussuriana di langue e parole.
L’aspetto individuale dell’idioletto non ha niente in comune con l’aspetto individuale della parole anche se prefigura e si integra con quell’aspetto. Può
7
8
essere di aiuto, nella discussione di questo argomento, l’esame di alcune tesi
contenute nell’articolo dello Spence, A Hardy Perennial: the Problem of “la
Langue” and “la Parole”10.
Lo Spence fa notare, e io credo giustamente, che nella definizione di langue come “sistema” vi è qualche incertezza o incoerenza, e che la nozione di
lingua come sistema non corrisponde esattamente ad una realtà, che sarebbe la maniera in cui parla, ad un dato momento, un certo gruppo linguistico,
poiché, all’interno di esso, vi sono gruppi distinti che, parlando in maniera
diversa, impiegano, in certo modo, sistemi diversi. Ma questa considerazione
non può indurci a pensare che si possa fare a meno della nozione di langue
come sistema: si tratterà della coesistenza di più sistemi somiglianti che si
influenzano reciprocamente. Lo Spence è convinto, in contrasto con le osservazioni che gli vengono rivolte da alcuni studiosi, che la stessa lingua individuale è già, in certa misura, collettiva. Un altro studioso, il Malmberg, in un suo
saggio Système et méthode11 colpisce nel segno, quando afferma che la presunta lingua individuale è sempre una lingua collettiva, e non può non essere
collettiva se è una lingua. E su questo punto non può non trovarsi d’accordo
con lo stesso Spence. Vi debbono essere dei caratteri comuni a più lingue
individuali che costituiscono il sistema linguistico di gruppo o collettivo. Un
individuo, di una determinata lingua, riesce a comunicare con gli altri in virtù di
quei caratteri che sono comuni alla lingua che egli ha nella sua mente, e alle
lingue che sono nelle menti degli altri.
È ben vero quello che afferma il Malmberg12 quando sostiene che la presunta lingua individuale è sempre una lingua collettiva, e non può non essere collettiva se è una lingua. Su questo punto dovrebbe essere d’accordo lo stesso
Spence il quale considera come errata una considerazione puramente “atomistica” della lingua individuale, poiché ogni lingua individuale è in un rapporto di
interdipendenza con le altre lingue individuali. Ogni lingua individuale incorpora
necessariamente in sé il sistema linguistico di gruppo o collettivo. Altrimenti l’individuo non riuscirebbe a comunicare con gli altri. La lingua come “fatto mentale” è insieme “un fatto sociale”, uno strumento di scambio interindividuale.
Tuttavia, secondo lo Spence, la lingua non può essere contrapposta alla parole,
poiché essa contiene già in sé degli elementi soggettivi, individuali.
L’errore di Saussure consisterebbe nel non aver messo in evidenza che la
lingua si forma nella mente degli individui, e, perciò, ha già dei caratteri di individualità che preludono alla parole. Ma, come bisogna osservare, quello che
conta, perché si possa opporre la langue alla parole, è il fatto che questa lingua, detta individuale, ha prima di tutto un carattere collettivo. Perciò si può
dire che l’opposizione langue-parole non è solo giustificata, ma si verifica già
all’interno della lingua cosiddetta individuale, in quanto, essa ha insieme un
carattere individuale e un carattere collettivo.
Non vi sono dubbi sul fatto che anche la proposizione formulata mentalmente sia già un atto di parole. E atto di parole è anche ogni espressione che
un autore fissa graficamente sulla carta senza pronunciarla materialmente.
Quello che conta al di là delle differenze che possono esservi fra le lingue
cosiddette individuali, è il sostanziale nucleo comune, il sistema che ognuna
SAGGI
di esse incorpora. All’interno di uno stesso gruppo linguistico si verifica, come
osserva Jespersen nell’opera citata, l’esistenza di diversi gruppi, a causa di
diversi distinti fattori.
Ognuno di questi gruppi usa il sistema linguistico in maniera un po’ diversa, e, perciò, ha un sistema linguistico diverso, senza contare che all’interno
di uno stesso gruppo si riscontrano altre differenze, che fanno capo alle lingue
individuali. Perciò un gruppo linguistico non ha una sola langue.
Tuttavia le convergenze e le somiglianze dei distinti sistemi linguistici sono
preponderanti rispetto alle divergenze e alle differenze. Su queste convergenze e somiglianze può essere fondato il concetto saussuriano di langue
senza il quale risulta inconcepibile ogni atto di comunicazione linguistica.
Lo Spence avanza su queste tesi di Jespersen alcune riserve e termina
con un giudizio piuttosto negativo sulla distinzione saussuriana: “Questa
distinzione fra langue e parole originariamente agì come un considerevole stimolo per il pensiero linguistico; ma si è tentati di concludere che ora essa produce confusioni nello stesso”13.
Non si può essere d’accordo con il giudizio alquanto negativo sulla distinzione saussuriana di langue e parole. Ha le sue buone ragioni Saussure nell’affermare risolutamente che il compito del linguista è quello di scoprire il
sistema al di là delle differenze che possono verificarsi nelle maniere di parlare dei distinti gruppi che costituiscono una comunità. Il problema filosofico
della comunicazione non è estraneo alla mentalità prevalentemente scientifica di Saussure.
La langue che è il codice a mezzo del quale soltanto i singoli atti linguistici
possono risultare comunicativi, espleterà la sua funzione in maniera sempre
migliore quanto più saranno eliminate le differenze con cui i diversi gruppi e
singoli individui utilizzeranno il codice-lingua.
In relazione al concetto di signification o sense e della definizione che di
esso viene data da Saussure, risulta opportuno il riferimento alla posizione
assunta dal semiologo Luis Prieto, che, a mio avviso, dà del suddetto concetto una versione non conforme alla tesi saussuriana, e, per alcuni aspetti unilaterale. Nella sua prospettiva, Prieto manifesta una tendenza ad una interpretazione, che potrei definire di tipo neopositivistico, e che risulta, in special
modo nella sua opera Principes de Neologie (l’Aja, 1964). Egli vuol ridurre i
concetti di “significato” e “ senso” entro i limiti di un comportamento linguistico
controllabile attraverso la “situazione”, collegata direttamente all’atto linguistico. Il senso di un atto di parole è il “rapporto sociale” che si stabilisce in virtù
di quell’atto. Per Prieto il “rapporto sociale”, ed esso soltanto, costituisce il
senso dell’atto semico.
Possiamo osservare legittimamente che, anche per Saussure, il senso di un
atto linguistico può stabilire un determinato rapporto sociale, ma, per Saussure,
giustamente, il senso di un atto linguistico non costituisce sempre e unicamente l’atto linguistico mediante il quale si stabilisce, fra parlante e ascoltatore, un
determinato rapporto sociale. L’atto di parole con il quale si esprime un verso
poetico non ha certamente come conseguenza lo stabilirsi, fra parlante e ascoltatore, di un determinato rapporto sociale.
9
F. DE SAUSSURE, Cours de linguistique générale, Payot, Paris 1960, p. 3.
Ivi, p. 38.
3
T. DE MAURO, Introduzione, in F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, Laterza, Bari
1967.
4
Ivi, p. IX.
5
A. BURGER, Signification et valeur du suffixe verbal français, in Cahiers F. De Saussure, 18,
1961.
6
F. DE SAUSSURE, Cours, cit., p. 37.
7
ID., Corso, n.70, pp. 388, 389.
8
R. GODEL, Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. De Saussure,
Genève 1957, p. 236.
9
V. O. JESPERSEN, Mankind, Nation and Individual from a Linguistic Point of View, Oslo 1925,
Cap I; N. C. W. SPENCE, A Hardy Perennial: the Problem of “la Langue” and “la Parole”, “Archivium
Linguisticuum” IX, 1957 pp. 1-27.
10
Archivium linguisticuum, 9, 1957, pp. 1-27.
11
Lund, 1945.
12
Ibidem.
13
Ivi, p. 26.
1
2
10
IDENTITÀ DIACRITICA E INTERSOGGETTIVITÀ
NELL’ONTOLOGIA DI M. MERLEAU-PONTY
1. Intorno ad alcuni inediti
Il pensiero di Merleau-Ponty si caratterizza per il tentativo di liberare la fenomenologia dall’eredità postcartesiana della soggettività che, secondo il filosofo,
sopravvive ancora nell’Ego trascendentale husserliano. La problematizzazione
delle capacità costitutive e auto-costitutive del soggetto co-determina così la
“necessità di un ritorno all’ontologia”1, fondata sulla comune appartenenza del
Leib e del mondo ad una medesima carne (chair), in uno sconfinamento
(empiètement) reciproco che radicalizza il legame del soggetto al sensibile.
Nella nuova ontologia la coscienza inizia un percorso di auto-ricognizione
che anticipa e sottende il definirsi stesso della dicotomia soggetto/oggetto, in
quanto si scopre preceduta dal percepito e da quelle strutture (grandezza, profondità etc.) che credeva di imporgli e che invece si trova a dover subire. La
fenomenologia dell’Être sauvage si configura infatti come movimento di autoespressione del senso che de-centra il soggetto dal luogo di origine della verità:
“Non siamo noi a percepire, è la cosa stessa a percepirsi laggiù, –non siamo noi
a parlare, è la verità a parlarsi in fondo alla parola–”2. La percezione si apre alla
“fede percettiva”, nel senso “che le cose ci possiedono, e che non siamo noi a
possederle”, e tale stato di de-possessione si estende anche al linguaggio, in
quanto “il linguaggio esprime, almeno lateralmente, una ontogenesi di cui fa
parte”3, con la conseguenza che “il linguaggio ci possiede e non siamo noi a possederlo […] è l’essere a parlare in noi e non noi a parlare dell’essere”4.
La rivisitazione delle categorie tradizionali della metafisica incide inoltre
sulla differenza ontologica (l’Essere non è fondamento o sostanza del mondo
ma piuttosto la sua latenza), mentre il ripensamento delle dinamiche di trascendenza, nell’evidenziare il primato del trascendente, se per un verso riabilita a livello di sensatezza il corpo, per l’altro allontana in maniera decisa la soggettività dagli esiti totalizzanti del trascendentale kantiano ed hegeliano. La
Natura carnale del corpo dis-loca infatti l’individuo in una sfera di anonimato
che sembra suggerirne la nullificazione a favore dell’Essere: “Io, veramente, è
nessuno, è l’anonimo […]. Ma è proprio lui a pensare, ragionare, parlare, argomentare, soffrire, godere, ecc.? Evidentemente no, giacché non è niente”5.
In una nota inedita de Le visibile et l’invisible6, il filosofo precisa inoltre che:
Ce n’est pas nous qui perçevons dans le sens du je qui parle. Qu’est-ce exactement que le je silencieux? L’Être parle en nous et perçoit en nous –le je perceptif
(le je de retention primaire) comme écart– comme on, anonyme, –première surrection du sens– sens de figure-et-fond- schéma corporel d’espace et de temps.
SAGGI
di Nicola Comerci
11
Merleau-Ponty dunque antepone al primato dell’Io l’anonimato del Si (On),
in quanto si percepisce, si parla e si pensa nel soggetto nella misura in cui tali
operazioni gli sono non-date quanto gli è non- dato il suo essere-al-mondo, e
l’io non si definisce se non come scarto (écart); cerchiamo di capire meglio.
Se in realtà non si tratta di delegare, heideggerianamente, ogni forma di iniziativa all’Essere, poiché “L’Essere è ciò che esige da noi creazione affinché
ne abbiamo l’esperienza”7, si deve invece cogliere il carattere anonimo dell’io
in relazione alla perdita per il soggetto della positività che l’Idealismo gli riconosceva. Nel contrapporre infatti alla costituzione coscienzialista di Husserl l’idea di “istituzione”8, Merleau-Ponty allontana il rischio del nichilismo come
conseguenza della de-soggettivizzazione del soggetto, in quanto il “per-sé”
resta “incontestabile, ma derivato: è il culmine dello scarto nella differenziazione”9. Questo radicale cambio di prospettiva ha come conseguenza immediata la crisi della visione ipseitaria dell’identità personale, in quanto ne deriva
l’impossibilità di una “pienezza” del sé tale da poter garantire la continuità dell’identità nella variazione temporale. Si tratta dunque di re-imparare a pensare l’identità secondo i parametri differenziali dell’ontologia della chair.
Riguardo a questo tema, in un’altra nota inedita10, Merleau-Ponty indica il
percorso da seguire:
l’ipséité doit m’apparaître comme dérivant d’une Selbstheit qui n’est pas encore
celle d’un ego. Reste que, si cette Selbstheit n’est pas vraiment moi au sens
empirique, elle ne l’est pas non plus au sens trascendental.
12
La ri-cognizione della dimensione identitaria deve muoversi dunque su un
piano altro, pre-tematico, non meramente empirico né idealisticamente trascendentale; in questo senso l’io è anonimo, in quanto “anteriore ad ogni
oggettivazione, denominazione”, precedente ogni categorizzazione oggettivante. L’identità personale andrà così ri-elaborata secondo l’idea di una presenza a sé a carattere differenziale, “I.e. di una presenza a sé che è assenza
da sé, contatto con Sé mediante lo scarto rispetto a Sé”11, e si configura come
processo di auto-differimento che precede e fonda l’idea classica di una soggettività unitaria.
Queste considerazioni spostano il discorso dalla positività dell’auto-costituzione alla passività dell’etero-istituzione identitaria operata dall’Essere e dagli
Altri. La fenomenologia merleau-pontyana si incentra infatti su quella che il filosofo francese chiama (rispetto alla “prima”, quella eidetica) la “seconda” direzione del pensiero di Husserl, l’analisi della Lebenswelt, e ciò determina la
necessità di radicare la formazione dell’identità umana all’interno di un vissuto esperenziale il cui orizzonte ontologico è fortemente condizionato da presupposti culturali (“le Lebenswelt, c’est la nature, mais aussi la culture”12) e in
quanto tali inevitabilmente intersoggettivi. In questo modo la riflessione sull’identità personale coinvolge la problematica questione dell’esperienza
dell’Altro13, secondo un orientamento ben preciso. Un percorso di allontanamento dalle “filosofie della coscienza” come quello intrapreso da MerleauPonty prevede infatti che non si possa affrontare autonomamente prima la
questione dell’identità personale per poi passare a quella dell’intersoggettività
SAGGI
senza il rischio di ricadere nella descrizione di una operazione di trascendenza in senso idealista. Una corretta analisi fenomenologica deve invece mostrare come il legame tra sé e l’Altro sia già esistente e concretamente vissuto
prima di ogni oggettivazione costitutiva, e deve indicarne le correlazioni: è
questa la strada che qui si intende seguire.
Il carattere culturale della Lebenswelt introduce inoltre il discorso sul linguaggio, in quanto “retrouver le Lebenswelt, c’est ici retrouver l’historique
sédimenté qui Strecke en nous. Il est langage, niedergeschlegene Logos”14. Il
linguaggio è dunque la dimensione in cui è possibile accedere al sapere sedimentato intersoggettivo del mondo-della-vita, ma non soltanto questo. Nel prosieguo della nota inedita sopra citata, Merleau-Ponty, con un evidente riferimento critico ad Husserl, spiega infatti come a livello langagière si manifesti in
maniera evidente l’ulteriorità della costituzione rispetto all’esperienza vissuta
dell’Altro e alla comune appartenenza al sensibile:
tout énoncé concernant Moi entraîne aussitôt un énoncé concernant l’alter ego,
–lequel annule le premier ou au moins le transforme. P. ex.: je suis constituant,
entraîne: l’autre est constituant et donc: je suis constitué. Pour comprendre comment je suis à la fois constituant et constitué, il faut comprendre que l’affirmation
de moi (comme constituant) n’est pas le contraire de l’affirmation d’autrui (comme
consti-tuant), ni donc de moi (comme consti-tué), et qu’au contraire, en vertu du
phénomène fondamental de l’alter ego, qui est la dialectique en action, ma universalité et ma particularité sont synonymes, ma liberté de Stiftung du monde et
mon appartenance à ce monde ne font qu’un15.
Si rende pertanto necessario capire in che modo l’io possa porsi come
“scarto”, si tratta cioè di ripercorrere la dinamica di quella che abbiamo definito istituzione “diacritica” del sé, cercando di comprenderne il carattere dialettico attraverso la ricostruzione dei rapporti con l’esperienza d’autrui16, e soffermandoci sul ruolo che in questa dialettica riveste il linguaggio. Questa apertura dell’ontologia all’intersoggettività consentirà altresì di spostare il discorso
sulle implicazioni etiche derivabili dall’intera argomentazione qui proposta, in
modo da coinvolgere anche un altro aspetto poco conosciuto della filosofia di
Merleau-Ponty, la riflessione sulla morale, al fine di evidenziare ulteriormente
l’attualità e la contemporaneità del suo pensiero.
2. Una questione aperta
Il tema dell’Altro rappresenta uno dei luoghi meno frequentati del pensiero
di Merleau-Ponty17; cercheremo dunque di ricostruire il modo in cui il filosofo
ha interpretato la possibilità di un rapporto intersoggettivo seguendo un percorso argomentativo che, partendo dall’analisi della trascendenza, coinvolge
la sfera ontologica dell’identità personale, del linguaggio e quindi dell’etica.
Nella prospettiva merleau-pontyana la filosofia si trova a confrontarsi di
continuo, nel non potersi esimere dal farlo, con il carattere paradossale della
propria natura di analisi trascendente interna all’orizzonte che intende trascendere, pur rimanendovi immersa nel non potervisi sottrarre in quanto pro-
13
14
pria condizione di possibilità. In questo modo, il filosofo francese si trova a
dover pensare razionalmente una dimensione di senso, l’irriflesso, nello stesso tempo tema e condizione di possibilità del pensiero stesso; compito non
facile, in quanto l’apertura all’irrazionale deve avvenire razionalmente, si tratta cioè di pensare una dimensione che ontologicamente si sottrae alle categorie del pensiero: “Non è dunque l’irriflesso a contestare la riflessione, ma è
la riflessione a contestare se stessa, perché il suo sforzo di ripresa, di possesso, di interiorizzazione o di immanenza non ha senso, per definizione, se
non rispetto a un termine già dato, il quale si ritira nella sua trascendenza sotto
lo sguardo stesso che va a cercarvelo”18. Invitto sottolinea con efficacia l’assoluta centralità di questo tema nel pensiero di Merleau-Ponty nel dire che il
“chiasma di raison e déraison […] costituisce la cifra di tutta la speculazione
merleaupontyana”19.
La questione d’autrui rappresenta così il momento della trascendenza20 in
cui secondo Merleau-Ponty in misura maggiore si manifestano i limiti del realismo e del coscienzialismo idealista. L’Altro infatti si pone come trascendenza pura in quanto è veramente Altro se è assolutamente tale (e non alter ego).
L’Altro mi trascende, ma la sua trascendenza non si limita alla presenza fattuale di un trascendente, in quanto trascende l’atto stesso del presentarsi: “è
presenza di una non-presenza”21. Il che non implica che la sua assenza manifesti un’altra presenza, ma che si presenti come “una certa assenza”22, in
quanto nella sua esperienza il darsi e il ritrarsi si identificano, come messa in
questione dell’opposizione tra soggetto esperenziale e soggetto trascendentale. Sebbene l’Altro si costituisca nell’esperienza muta come un’altra apertura all’Essere, esso è invisibile, ma tale invisibilità è reale se come me può
essere presentata.
Perché l’apparizione dell’Altro sia possibile, è necessario dunque che la
coscienza si configuri come il proprio superamento, che realizzi se stessa nell’oltrepassarsi. Una dimensione intersoggettiva reale necessita di una rivisitazione dell’immanenza del soggetto nel suo farsi trascendenza, una immanenza che si compie nell’apertura (ouverture), di cui la percezione non può rendere conto. Il soggettivismo in cui ancora si muove la Fenomenologia della
Percezione dimostra che la coscienza percettiva è ancora troppo presso-di-sé
per potersi aprire agli Altri, di modo che le viene impossibile concepire una trascendenza radicale: poiché l’Altro è “presentazione originaria dell’impresentabile”23, la sua trascendenza è trascendenza ontologica più che fenomenica.
Il passaggio all’ontologia della carne consente a Merleau-Ponty di affermare
che “la trascendenza è l’identità nella differenza”24, sulla base della reversibilità
chiasmatica generata dalla dinamica senziente/sensibile delle mani che si toccano descritta da Husserl nel § 36 di Ideen II, in cui si determina la parentela
ontologica tra il Leib e il sensibile riabilitato ontologicamente come “forma universale dell’essere grezzo”25. La dimensione sensibile della carne deborda i limiti del corpo: “Il mio corpo è fatto della medesima carne del mondo”, poiché “di
questa carne del mio corpo è partecipe il mondo, esso la riflette, il mondo sopravanza su di essa ed essa sopravanza sul mondo […] essi sono in rapporto di
trasgressione o sopravanzamento”26, le cui dinamiche sono determinate dalla
SAGGI
reversibilità interna all’Essere come movimento di auto-articolazione. Tale movimento si ripercuote carnalmente anche sulla sfera identitaria del soggetto, nel
definirne come sempre prossima e mai attuata in pieno la coincidenza con se
stesso. Il distacco dall’antropocentrismo dell’auto-trasparenza si manifesta così
sia nell’autosfuggimento del corpo: “Il toccarsi, vedersi del corpo” non è “raggiungersi, è viceversa sfuggirsi, ignorarsi, il sé in questione è scarto”27, sia nella
sfera razionale: “la riflessione non è identificazione a sé […] ma non-differenza
con sé”28. Dal corpo proprio, la reversibilità ontologica coinvolge anche l’Altro,
che diviene momento di “un’unica intercorporeità”29. Questa tesi merleau-pontyana ha generato una serie di perplessità; cerchiamo di capire.
Pangallo sostiene che questa prospettiva manterrebbe l’argomentazione
all’interno della sfera immanente della percezione, tale da impedire ogni apertura etica, al punto da rilevare in Merleau-Ponty una forma di “nichilismo”30,
riprendendo in questo modo la tesi di Levinas, che rileva come l’intercorporeità rappresenti un vincolo troppo forte per lasciare spazio ad un qualunque
moto di avvicinamento: manca una separazione, una distanza da superare
necessaria all’etica31. A tal proposito, Carbone sottolinea invece come nella
stretta di mano sia già prefigurata “la possibilità –che pertanto non significa
garanzia e non esclude la differenza né il conflitto stesso– di una comunicazione” e dunque anche di “una relazione etica”32 che lo stesso Levinas coglierebbe implicitamente nella “non-indifferenza reciproca degli uomini che si chiama anche amore” soltanto che pone l’accento sull’“ordine che viene, attraverso il volto umano, da molto in alto, fuori dal mondo”33. Seguendo Meazza rileviamo inoltre che il problema di fondo di Levinas è che nell’intercorporeità merleau-pontyana “il profilo del volto tende a sbiadire”, in quanto la Naturalità
ontologica del corpo finisce per definire ancora da un punto di vista totalizzante e, in quanto tale, immanente, l’individualità del soggetto34. Si tratta dunque di prendere atto di una diversa concezione della trascendenza, in quanto
Merleau-Ponty, come si è visto, si muove alla ricerca della trascendenza all’interno dell’immanenza del mondo, e questo orientamento coinvolge il valore
morale senza per questo suggerirne derive nichiliste35.
Ritornando ad un’analisi testuale più attenta, si deve rilevare inoltre come
l’intercorporeità non implichi, come si vorrebbe, una indistinzione estesiologica; in quanto è fondata su di “una reversibilità sempre imminente e mai realizzata di fatto” in cui “io non giungo mai alla coincidenza; essa si eclissa nel
momento di realizzarsi”36. L’idea è dunque quella di un legame sinestetico concreto che indica la comune appartenenza sensibile in un rapporto dinamico,
costitutivamente incompiuto in quanto concepito come spazio della prassi e
della morale, quest’ultima intesa, come si vedrà, come un compito più che un
destino. L’intersoggettività è dunque per Merleau-Ponty una “questione aperta” nel duplice senso di problema filosofico ed esistenziale, problema da risolvere ma in se stesso non definibile in maniera esaustiva perché caratterizzato dalla sempre imminente e mai compiuta reversibilità della carne37. E questo
a sua volta non significa che non si possa cercare di ricostruire le dinamiche
e i luoghi della reversibilità intersoggettiva. Verrà qui perciò proposta una linea
di lettura della riflessione merleau-pontyana sull’intersoggettività non limitata
15
all’intercorporeità, in relazione ai suoi legami con il nostro tema, l’identità personale. Seguiremo pertanto un percorso che dal Visibile continua
nell’Invisibile, al fine di comprendere il ruolo d’autrui nell’istituzione diacritica
del sé, all’interno delle due dimensioni del corpo proprio e del linguaggio.
3. Il mondo come Visibilità: il corpo istituito
16
Nel chiedersi “come comprendere la soggettività?”, Merleau-Ponty sostiene che “la soluzione va cercata nella visione stessa”38. La reversibilità del tatto
si estende anche agli altri sensi, in particolare alla vista, interpretata come
voyance, capacità di cogliere l’Invisibile nel Visibile, in modo da evidenziare la
priorità crono-ontologica del Sensibile sul senso, cioè della Visibilità sulla
visione e del Visibile sull’Invisibile, in un movimento che non può non coinvolgere l’Altro. L’Altro infatti è un visibile come le cose, ma diverso da esse perché la sua visione testimonia la presenza di un vedente come lo sono io: come
me l’Altro è apertura e, in questo senso, non è mai davanti a me, ma mi avvolge, è intorno a me, decentra la mia apertura nell’orizzonte del mondo in un làbas che per lui è un ici. La reversibilità si manifesta nell’apertura carnale al
mondo basata su prospettive autonome, che fanno sì che l’Altro resti distante
e diverso da me nella prossimità generata dal rapporto di inerenza (en être)
carnale all’Essere; la negatività della separazione è l’altro lato della positività
generata dall’appartenenza allo stesso mondo sensibile. In una nota inedita39
Merleau-Ponty spiega infatti che:
Le passage de l’Ego à l’alter ego ne sera jamais accomplì si (l’) on ne comprend
pas que je ne suis je constituant ou vie séparée, homme individuel (c’est à l’egard
de ce problème, la même chose), –que je suis si impliqué dans le monde, ni spectateur de toutes choses, ni temoin d’une vie (d’un douleur) unique, mais monade
oublieuse d’elle– même, entraînée par son fonctionnament propre dans le monde
même, que je touche dans sa formation, loin de toute recherche suivie, loin de
tout Uberschauen, entraînée de même coup en autrui en tant que le monde unique, à l’état brut, n’est nullement mien, que l’autre historique, y parle son langage monumentale.
Il mondo rappresenta così l’orizzonte ultimo dell’intersoggettività, e la sua
trascendenza è possibile nell’offrirsi non ad una Visione pura ma a visioni
viziate dalla prospetticità, nel senso che io co-percepisco la percezione visiva
di uno stesso mondo che trascende il soggetto stesso che la opera. In quanto si offre alle molteplici aperture visive degli Altri, il mondo non è se non
Visibilità, e gli Altri non sono se non queste aperture. Il Visibile si decentra a
profitto di un altro visibile in se-stesso-vedente, e questo testimonia il mio scarto rispetto ad esso. Ne deriva una “Intra-ontologia” basata su di “un mondo
visto nell’inerenza a questo mondo”40, dunque come fatticità assoluta che contiene tutto compreso la sua stessa possibilità, in quanto l’oggettività del mondo
è tale perché il Visibile è già abitato da Altri. In questo modo l’intersoggettività
si presenta, di rimando, come la dimensione ultima di comprensione del
mondo, e questo si riflette sulla nostra ricerca sull’identità personale.
SAGGI
Se è vero infatti che la datità del mio essere-al-mondo, il mio esserne precede ogni rappresentazione che io ne posso avere, è altresì vero che nello
sguardo altrui io supero, in quanto assumo, la prospetticità delle mie visioni del
mio corpo e del mondo, in modo che l’Altro riveste un valore istitutivo nella mia
percezione del mio corpo. Scrive Merleau-Ponty che “grazie ad altri occhi,
siamo pienamente visibili a noi stessi; quella lacuna in cui si trovano i nostri
occhi e la nostra schiena è colmata”41. In quanto è se stesso nell’essere parte
dell’Essere, nell’esserne della Visibilità, ciò comporta altresì che per diventare
vedente il soggetto deve farsi visibile, e questa depossessione costituisce
nello stesso tempo garanzia di presenza a sé. Il soggetto afferma se stesso
negandosi, si perde nel ritrovarsi e si ritrova nel perdersi: il movimento per cui
si fa vedente per co-percepire l’altra visione non si distingue da quello per il
quale si fa visibile per un’altra visione; si de-centra e differisce dialetticamente la propria auto-costituzione nel duplice scarto diacritico in relazione
all’Essere e agli Altri, nel senso che ritrova la propria identità corporea, (e dunque sensibile), nell’essere esposto all’Altro: l’apertura all’Altro precede l’identità in modo che l’alterità si mantiene sempre in questa apertura42.
Ne deriva inoltre che a livello percettivo l’Altro può essere tale solo a condizione di non esserlo, di essere altro, mondo. L’Altro si costituisce nell’esperienza muta come estensione del chiasma carnale, vale a dire come rapporto
dell’Essere a se stesso. In questo modo l’intersoggettività è tale nel non esserlo, nell’essere un momento dell’alterità radicale del mondo: non c’è alternativa
per me tra la percezione del mondo e l’apertura all’Altro, se non nel senso che
a livello percettivo c’è più esperienza del mondo che dell’Altro, in quanto quest’ultimo mi si dà diacriticamente, come scarto, assenza riferita. L’esteriorità
della carne sensibile più che attestare nega un’altra presenza in quanto il
mondo non può aprirmi ad un’interiorità altrui: l’Altro, a livello sensibile, mi si
offre più come mondo che come io. Ne consegue che l’Altro, nel sensibile, mi
si offre rimanendo da me distinto, e questo vuol dire che mi si dà come negazione43, scarto differenziale tra me e il mondo: la reversibilità manifesta il suo
statuto eminentemente diacritico. Se, dunque, l’esperienza dell’Altro si fonda
sull’anonimato della visione, sulla Visibilità del mondo, se ne conclude così
che l’esistenza dell’Altro mi si dà come anonima.
Poiché però il mondo non rappresenta la negazione della soggettività per
la comune Natura carnale, l’anonimato non sfocia in una confusione indistinta: l’intersoggettività si pone come identità dell’identità e della differenza carnale, “reversibilità imminente” appunto. La dimensione ontologica dell’inerenza carnale si manifesta così come una dimensione primordiale intersoggettiva, che evidenzia la crisi dell’autonomia identitaria del soggetto e orienta il
pensiero verso una soggettività che diviene se stessa nel farsi altro-da-sé, in
una comune appartenenza al sensibile che rende possibile l’istituzione reciproca.
Nel concludere questo paragrafo, non si può non rilevare il capovolgimento che Merleau-Ponty opera della concezione oggettivante dell’attività visiva,
in quanto, alla violenza della reificazione, il filosofo contrappone la positività
dell’istituzione. Invitto spiega questo punto e ci indica la strada da seguire:
17
Corpo e mondo sono della stessa stoffa, dirà Merleau-Ponty. Per ciò anche il
rapporto con gli altri, così come è mediato dallo sguardo, è un rapporto di reciproca rivisitazione, di stupore, di arricchimento vicendevole. Già nella
Phénoménologie de la perception era esclusa ogni possibile invadenza del
soggetto-vedente a danno del soggetto-oggetto veduto: è possibile violenza e
oggettivazione nello sguardo –diceva Merleau-Ponty– solo quando si rifiuta la
comunicazione.44
La funzione istitutiva operata nel Visibile deve continuare dunque anche nel
rapporto con l’Invisibile, in quanto lo spazio dell’intersoggettività rappresenta il
luogo in cui l’Essere si configura in maniera diversa e permette all’Invisibile di
acquistare consistenza nell’oggettività ideale. Nell’apertura all’Altro, MerleauPonty individua il momento in cui l’Essere deve ritornare su se stesso e modificare la modalità di questa apertura aprendosi all’Invisibile, e questo movimento avviene nella comunicazione attraverso il linguaggio.
4. L’Invisibile: la parola istituente
18
Nell’esperienza dell’Altro si manifesta la teleologia ontologica che può
aprirsi alla ragione soltanto nella comunicazione linguistica, come sublimazione del dato nel senso e, di rimando, iscrizione dell’Invisibile nel Visibile.
In quanto la carne rappresenta l’orizzonte a cui tutti apparteniamo ed in cui
tutti ci apparteniamo, essa costituisce infatti la condizione di possibilità della
comunicazione45. Merleau-Ponty tenta di superare il dualismo platonico nel
conferire al linguaggio il compito di portare ad espressione l’irriflesso da cui
nasce, quell’esperienza “muta” o silenziosa del sensibile che si estende anche
al mondo delle idee, in quanto “l’idealità pura non è senza carne”, sebbene “si
tratti di un’altra carne”: “È come se la visibilità che anima il mondo sensibile
emigrasse, non già fuori di ogni corpo, ma in un altro corpo meno pesante, più
trasparente, come se mutasse carne, abbandonando quella del corpo per
quella del linguaggio46”. Se per un verso dunque l’Invisibile cessa di vivere in
un improbabile iperuranio e riscopre la sua dimensione carnale (che non significa, si badi, ritornare ad uno sterile determinismo), per l’altro la sfera ideale si
apre all’intersoggettività della comunicazione.
La relazione all’Altro ridiscute così l’opposizione tra l’ordine sensibile e l’universo del senso: la riflessione ontologica si arricchisce dell’attenzione
costante dimostrata da Merleau-Ponty per il linguaggio47. Sebbene quest’ultimo rappresenti in se stesso la “fodera dell’essere”, la dimensione in cui è
possibile portare ad espressione l’irriflesso, nello stesso tempo apre ad un
nuovo modo di significare non riducibile alla semplice presentificazione, che
ne chiarisce il rapporto con l’esperienza percettiva, in quanto il senso di quest’ultima può essere compreso soltanto a partire dalla parola48. Nel conservare dunque la derivazione sensibile del linguaggio, Merleau-Ponty riflette sulla
peculiarità propria di questa forma espressiva, che è la capacità di sedimentare un senso e di renderlo disponibile per ulteriori utilizzazioni. L’autonomia
della langue saussuriana fa sì infatti che il linguaggio sia “qualcosa di simile
Même pour savoir ce que nous pensons nous avons besoin de le mettre en langage commun.
Connaissance de soi passe dans connaissance d’autrui: le chiasma.
Nel linguaggio dunque ritroviamo il chiasma, la “reversibilità imminente”
della carne che sottostà alla formazione della coscienza. Nel dialogo non c’è
differenza tra diventare se stessi e farsi Altro, in quanto, nell’unità tra linguaggio e pensiero, si diviene se stessi esponendo le proprie parole. L’Altro, nel
parlarmi, si distacca da se stesso al fine di ricongiungersi a sé, mi espone le
sue ragioni in modo che diventino sue nel momento in cui le espone: più che
parlarmi si parla in me, continua a ricevere la propria parola come se fosse
proferita da un Altro.
Il linguaggio si pone dunque come operazione di auto-trascendenza che
sfocia nella conquista di se stessi attraverso l’Altro:
Le langage est un acte de trascender. On ne peut donc le considérer simplement
comme une enveloppe de la pensée; il faut voir en lui un instrument de conquête
du moi par contact avec autrui54.
Il dialogo deve essere dunque inteso come “sconfinamento di me nell’altro
SAGGI
ad un essere”49, poiché la sua riflessività interna lo rende autoreferenziale e
autonomo, al punto da sembrare distaccato dal mondo.
Tali considerazioni si ripercuotono ulteriormente sulla questione dell’identità personale, in quanto il linguaggio apre ad una dimensione di senso
in cui emerge, in maniera decisa, sul punto di vista egologico, la preminenza della relazione intersoggettiva. Finché il discorso permane nella dimensione carnale, io e l’Altro siamo ancora separati, scissi in quanto assenze
pure. Se nella dimensione sensibile l’esistenza dell’Altro mi si dà come anonima, nella parola invece si manifesta quell’unione tra mondo naturale e
mondo culturale in cui l’intersoggettività, che a livello percettivo era presuntiva, diviene predominante50, e si apre un dominio di senso che sposta il discorso da una “comunanza di essere” ad una “comunanza di fare”51. Nel linguaggio si accede all’Altro e quindi al mondo, in modo che non ci si rapporta ad un elemento neutro come avviene nell’esperienza sensibile. La parola
porta la relazione intersoggettiva ad un livello diverso dal semplice riferimento ad un mondo comune, in quanto nel dialogo si accentua la perdita
della positività del soggetto in relazione ad una sua frammentazione istitutiva. Nella parola io ritrovo infatti i segni di un mondo culturale in cui io stesso nasco: il senso riviene a se stesso anziché depositarsi come esteriorità
visibile, e la coscienza si scopre istituita dai discorsi altrui e inserita in un
mondo culturale rispetto al quale più che afferire positivamente mostra di differire negativamente. Non si tratta di contrapporre due soggettività pre-costituite linguisticamente, in quanto nel linguaggio io e l’Altro co-nasciamo come
io e Altro e come Altro e io: si pensa con i pensieri degli Altri, si parla con le
parole degli Altri52.
Negli appunti inediti preparatori al corso del lunedì tenuto presso il Collège
de France nell’a.a. 1952-5353, Merleau-Ponty precisa che:
19
20
e dell’altro in me”, in modo tale che “la percezione di un autentico alter ego
presuppone che il suo discorso […] abbia il potere di rifarci a propria immagine e di aprirci ad un altro significato”55. Questo non significa che la parola realizzi “l’impossibile accordo tra due totalità rivali” nel farci “rientrare in noi stessi” o nel farci trovare “qualche spirito unico al quale parteciperemmo”, ma
significa che “ci concerne, ci raggiunge indirettamente, ci seduce, ci trascina,
ci trasforma nell’altro e trasforma l’altro in noi, perché abolisce i limiti del mio
e del non-mio, di ciò che è non senso per me, di me come soggetto e dell’altro come oggetto”56.
In questo modo nella dimensione langagière viene superata e nello stesso
tempo conservata la distanza intersoggettiva esperita nel mondo sensibile,
distanza che è data dal fatto che l’Altro è assente nella sua presenza.
L’elemento di questa distanza che fa presentire una vicinanza è appunto il
mondo culturale, separazione e nello stesso tempo prossimità. Quella dialogica rappresenta così la sfera in cui si congiungono la presenza e l’assenza
dell’Altro, una presenza che rimane dissimulazione in quanto la parola esprime nella misura in cui la sua dimensione significante si determina nell’offrirsi
ad un’altra parola, poiché io “parlo in seguito a […] ciò che dice l’altro”57. Ne
deriva che nel dialogo il sé si ritrova come mancante, e realizza la sua unione
all’Altro come separazione e come perdita costruttiva dell’identità soggettiva in
quanto “io sono, grazie alla parola, messo in presenza di un altro me stesso
che ricrea ogni momento del mio linguaggio e mi sostiene anche nell’essere”58.
La differenza tra le coscienze non rinvia così a molteplici corpi visibili: è la
parola l’elemento di questa differenziazione nell’unità. Se infatti le coscienze
fossero pregiudizialmente molteplici, non ci sarebbe comunicazione; se la
coscienza fosse Una, non ci sarebbe bisogno di comunicare. Non si può tornare all’idealismo di una interiorità contenuta da un corpo. Nel dialogo il sé
carnale si scopre etero-istituito dall’esterno nella sua differenza: l’allontanamento dal coscienzialismo idealista opera nel linguaggio il differimento della
soggettività personale alla dimensione intersoggettiva, in quanto “Vi è parola
(e dunque personalità) solo per un <io> che porta in sé questo germe di spersonalizzazione”59. Ciò non implica che nel linguaggio la carne permanga nell’esteriorità del sé, in quanto in questa estraneità si manifesta l’esteriorità della
carne a se stessa, come “identità dell’identità e della differenza”.
Con l’istituzione langagière si conclude l’analisi qui proposta dell’istituzione
diacritica del sé, mentre si apre il problema della sua continuità nel variare
temporale. Una identità personale priva della pienezza che gli derivava dall’autonomia auto-costitutiva, si trova infatti a non raggiungere mai una posizione di definitività tale da considerare concluso il proprio processo di formazione. L’Io, come abbiamo visto, si pone sempre in scarto anche rispetto a se
stesso, seguendo il principio di una identità personale sempre in costruzione,
al punto da poter parlare di una sorta di variazione nella persistenza, di una
continuità nella trasformazione60, senza seguire alcuna dinamica teleologica o
finalistica che sorvolando l’empirìa faccia dimenticare il carattere sempre contingente della nostra esperienza di vita.
Tali implicazioni non possono non avere conseguenze per la vita vissuta.
5. La moralità “à faire”
Ristabilire la trascendenza nell’immanenza costituisce il senso proprio
della ri-definizione dell’orizzonte trascendentale operata da Merleau-Ponty
nell’idea di “superriflessione”61, come trascendentale interno all’esperienza,
non più avulso e separato da essa, capace così per un verso di conservare le
pretese della sensibilità, per l’altro di salvaguardare l’attività razionale, “in una
lontananza dell’uomo rispetto al mondo che non si allarga mai fino a diventare una spaccatura”62. L’allontanamento dal paradigma conoscitivo del soggetto moderno e del riduzionismo scientifico si apre così ad una trascendentalità
immanente originariamente intersoggettiva, che trova le sue radici nella comunicazione e nel linguaggio, verso una universalità “laterale” non più presupposta ma da raggiungere. Il pensatore francese si muove verso l’individuazione
di una ragione comunicativa in un movimento che sconfina sulla sfera dell’etica, in quanto l’Altro è stato individuato non all’interno della dimensione conoscitiva ma nel percorso stesso di definizione del trascendentale63.
Questo de-centramento razionale del soggetto e il suo radicamento in una
dimensione intersoggettiva mette così in crisi la prospettiva volontaristica e
comporta che anche la trascendenza del valore etico debba essere colta nell’immanenza al mondo. La fenomenologia rivela l’inserimento dell’io non in un
“un regno dei fini” trascendenti ma in un orizzonte immanente di trascendenza a cui anche il valore spirituale non può sottrarsi. La morale si scopre fondata su quell’appello (sollicitation) e su quella pretesa (exigence) di cui spesso Merleau-Ponty parla come superamento del pragmatismo e del moralismo
in vista di un dover-fare che deve essere delineato partendo dalla fatticità condizionante che prescinde dalle nostre scelte. In questo modo l’etica si trova a
confrontarsi con l’azione e la responsabilità storica, in una visione della libertà che trova nell’Altro la sua condizione di possibilità e non il suo limite; si tratta dunque di individuare una diversa concezione del dovere morale basata
sullo sconfinamento delle soggettività capace di orientare moralmente una
dinamica relazionale di per sé non più intrinsecamente etica.
La teleologia dell’Espressione ontologica crea così le condizioni per l’individuazione del principio di una morale all’interno della reversibilità carnale tra
gli individui che fonda il riconoscimento nell’istituzione reciproca dell’identità
personale, e tale principio si configura come una “bonne forme du rapport, qui
est celle de la réciprocité”64. La reciprocità è “buona” perché capace di generare valori, e non è da intendersi come simmetrico riconoscimento reciproco in
quanto strutturata asimmetricamente nell’alterità costitutiva del sé. Il rispetto
dell’Altro nasce nell’intreccio (Entrelacs) chiasmatico tra sconfinamento e
reversibilità che sottolinea più la differenza che la somiglianza, una somiglian-
SAGGI
Una visione del sé permeato dall’operare intersoggettivo non può evitare infatti il riferimento ad una dimensione valoriale ed etica di cui, per ovvi motivi di
brevità, cercheremo però di fornire una semplice indicazione di percorso e non
una trattazione esaustiva.
21
za nella differenza, che si ripercuote sul soggetto stesso, la cui perdita di trasparenza accomuna le soggettività incarnate nel movimento d’istituzione reciproca. Ciò comporta non la scomparsa ma la ridefinizione della dimensione
personale: la sfera intersoggettiva precede tutte le altre dimensioni in modo
tale che la relazione dialogica non è quella in cui le soggettività si atomizzano,
ma quella in cui esse si istituiscono reciprocamente nel loro incontro differenziale, in un “movimento, dapprima violento, che supera ogni significazione” in
quanto “se l’altro è veramente un altro, occorre che a un certo punto io sia sorpreso, disorientato, e che ci ritroviamo non più in ciò che abbiamo di simile ma
in ciò che abbiamo di differente”65. Il riconoscimento avviene così lateralmente, nella non-coincidenza tra gli individui che trova nel desiderio l’attestazione
della distanza e nello stesso tempo della volontà di ricongiungimento.
Fondata sull’istituzione diacritica del sé e sulla struttura asimmetrica della
reciprocità, la morale non vive in una sfera autonoma ma in un mondo intersoggettivo concreto, in cui i valori etici vengono istituiti all’interno dell’orizzonte dell’intersoggettività sensibile e langagière, in cui si determina la stessa
identità personale dell’uomo. La scomparsa della positività intrinseca del valore morale non sfocia dunque nel relativismo etico ma piuttosto nel suo radicamento nel vissuto esperenziale della storia in cui forte è il ruolo rivestito dalla
prassi, dall’azione concreta, in quanto se è vero che “il faut que je m’élève à
penser autrui comme réciprocable avec moi”, ne deriva altresì che “la moralité n’est pas donnée, mais à faire”66.
22
1
M. MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, texte établi par C. Lefort, Gallimard, Paris 1964,
tr. it. di A. Bonomi, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 1969; edizione riveduta a cura di M.
Carbone, Bompiani, Milano 1994, p.183.
2
Ivi, p.202.
3
Ivi, p.122.
4
Ivi, p.210.
5
Ivi, p.258.
6
Si tratta di un “inedit sans date” intitolato Paragraphe ultérieur sur l’Offenheit, che C. Lefort
data intorno al 1958 di cui qui ripropongo alcune parti (così come farò anche di altri inediti citati
più avanti) su cortese autorizzazione di M.me Suzanne Merleau-Ponty, alla quale vanno i miei più
sentiti ringraziamenti. Tale nota fa parte dell’insieme di “Notes de travail” al “Livre en projet 19581960”, Boîte III, D.M.O., B.N.F. (attualmente disponibile anche in microfilm: Vol. VIII –catalogato
come: MF 9852, ff. 168-169), note non annesse da C. Lefort nella redazione de Le visibile et l’invisible, che ho potuto consultare presso il “Fondo Merleau-Ponty”, Département des Manuscrits
Occidentaux, Bibliotèque Nationale de France (Site Richelieu) di Parigi. Desidero ringraziare inoltre la prof.ssa Daniela Calabrò per le preziose indicazioni “logistiche”.
7
Ivi, p.213.
8
Nel delineare l’idea di un soggetto “instituant, non constituant”, Merleau-Ponty scrive infatti
che “on cherche ici dans la notion d’institution un rèmede aux difficultés de la philosophie de la
conscience. Devant la conscience, il n’y a que des objets constitués par elle. Même si l’on admet
que certains d’entre eux ne le sont <jamais complètement> (Husserl), ils sont à chaque instant le
reflet exact des actes et des pouvoirs de la conscience, il n’y a rien en eux qui puisse la relancer
vers d’autres perspectives, il n’y a, de la conscience à l’objet, pas d’échange, pas de mouvement”
(ID., L’institution. La passivité. Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Préfacé par
Claude Lefort, Belin, 2003, p. 123 (la citazione è tratta dal Résumé del corso su L’Institution).
ID., Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p. 207.
Si tratta della nota del 6 Ottobre 1958 che fa parte anch’essa dell’insieme di “Notes de travail” al “Livre en projet 1958-1960”, f.162 (per la cui localizzazione si veda supra, nota 6).
11
Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p. 208.
12
ID., Notes de cours (1959-1961), Gallimard, Paris 1996, p.76.
13
L’importanza di questo problema è tale per Merleau-Ponty al punto da far convergere in
esso le sue critiche alla metodologia realistica e idealistica; in particolare a quest’ultima posizione
accomuna anche la costituzione husserliana, incapace, a suo parere, di rendere conto della
dimensione intersoggettiva perché impostata sull’egologia del soggetto (si veda Signes,
Gallimard, Paris 1960; tr. it. di G. Alfieri, Segni, Il Saggiatore, Milano 1967, p.128). In realtà il giudizio di Merleau-Ponty è troppo severo perché viziato da parzialità, in quanto confina l’intera riflessione di Husserl sul tema dell’Altro alle riflessioni condotte nella V delle Meditazioni Cartesiane,
non considerando i numerosi inediti sull’intersoggettività di cui però il pensatore francese non
poteva disporre. Per un’analisi di questi inediti si veda N. DEPRAZ, Les figures de l’intersubjectivité. Étude des Husserliana XIII-XIV-XV, “Archives de Philosophie”, n. 55, juillet-sept. 1992.
14
M. MERLEAU-PONTY, Notes cit., p. 76, nota a.
15
ID., nota inedita del 6 Ottobre 1958 cit. Ho riportato in corsivo le sottolineature originarie del
testo.
16
A tal proposito Merleau-Ponty scrive che “[Autrui est] non constitué-constituant, i.e. ma
négation, mais institué-instituant” e in margine appunta che “par rapport à moi, parce que je suis,
par rapport à moi-même, institué-instituant” (L’institution. La passivité, cit., p. 35).
17
Al di là dei vari riferimenti al tema presenti in vari studi, al momento esistono infatti soltanto
due opere di un certo rilievo dedicate esplicitamente a questo argomento: MARIO PANGALLO, Il problema filosofico dell’alterità. Saggio sul solipsismo e l’intersoggettività in Maurice Merleau-Ponty,
Euroma, Roma 1989 e il fondamentale lavoro di Ronald Bonan in due volumi, La dimension commune, L’Harmattan, Paris, Budapest, Torino 2001: vol. I: Le problème de l’intersubjectivité dans la
philosophie de Merleau-Ponty; vol. II: L’institution intersubjective comme poétique générale, le cui
conclusioni verranno discusse nel prosieguo del discorso.
18
M. MERLEAU-PONTY, Le philosophe et son ombre, in AA.VV. Edmund Husserl (1859-1949),
Den Haag, M.Nijhoff, 1959, pp. 195-220; poi in Il filosofo e la sua ombra, in Segni, cit., pp. 211238, p. 214.
19
G. INVITTO, La tessitura di Merleau-Ponty. Ragioni e non-ragione nell’esistenza, Mimesis,
Milano 2002, p. 89. Attraverso la feconda metafora della “tessitura”, Invitto ricostruisce il movimento continuo e coerente del pensiero merleau-pontyano dai primi scritti agli ultimi sbocchi ontologici, secondo una prospettiva che qui assumo senza riserve: la ricerca di una “afilosofia” intesa
come “non filosofia” o “filosofia negativa”, come un pensiero che non sorvola il mondo ma si concentra sull’immanenza, un pensiero che supera se stesso nel confrontarsi con qualcosa che è
altro-da-sé, la contingenza dell’Être brut ma anche della politica, della tecnica e, dunque,
dell’Altro.
20
Scrive il filosofo che “la trascendenza oggettiva non è posteriore alla posizione dell’altro: il
mondo è già qui, nella sua trascendenza oggettiva, prima di questa analisi, ed è il suo senso stesso che sarà esplicitato come senso… [Dunque l’introduzione all’altro non è ciò che produce <la
trascendenza oggettiva>: l’altro ne è uno degli indici, un momento, ma è nel mondo stesso che si
troverà la possibilità dell’altro].” (Le visible et l’invisible, tr.it. cit., p.190).
21
In questi termini si esprime Renaud Barbaras nel suo De l’être du phénomène. Sur l’ontologie de Merleau-Ponty, Millon, Grenoble 1990, (“présence d’une non-présence” p. 44), che ho
tenuto presente durante l’analisi dell’intersoggettività.
22
M. MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p. 104.
23
Ivi, p. 219.
24
Ivi, p. 238.
25
Le philosophe et son ombre, tr. it. cit., p. 225.
26
Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p. 260.
27
Ivi, p. 261.
28
Ivi, p. 219.
29
Le philosophe et son ombre, tr. it. cit., p. 221.
30
M. PANGALLO, Il problema filosofico dell’alterità, cit., p. 21
9
SAGGI
10
23
24
31
E. LÉVINAS, De l’intersubjectivité. Notes sur Merleau-Ponty, in ID., Hors du sujet, Fata
Morgana, Paris 1987, tr. it. Dell’intersoggettività. Note su Maurice Merleau-Ponty, “Aut-Aut”, n.
232-233, luglio-ottobre 1989, pp.140-145, p.145.
32
M. CARBONE, Ai confini dell’esprimibile. Merleau-Ponty a partire da Cézanne e da Proust,
Guerini, Milano 1990, p. 125 nota.
33
E. LÉVINAS, De l’intersubjectivité cit. p.145.
34
C. MEAZZA, Il Testimone del Circolo. Note sulla filosofia di Lévinas, Franco Angeli, Milano
1996, p.145; si vedano in particolare le pp.143-146.
35
È singolare a riguardo notare, pur nella rilevante e insopprimibile diversità di prospettive, la
comunanza di orientamenti riscontrabile con le tesi avanzate da K. Wojtyla nel saggio recentemente pubblicato L’uomo nel campo della responsabilità (Bompiani, Milano 2002, cura e
Introduzione di Antonio Delogu, Presentazione di A. Wierzbicki). Come nota infatti Delogu nel saggio introduttivo all’opera, nella prospettiva etica del filosofo Wojtyla, sulla base dell’attenzione
posta dalla fenomenologia (a cui Wojtyla si richiama) sul valore costitutivo e teoreticamente significativo della dimensione esperenziale, “i valori non costituiscono oggetto di conoscenza separato in quanto nell’immanenza si ritrova la trascendenza, nel dato il senso” (p.31).
36
M. MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p.163.
37
Rimando su questo punto alle acute conclusioni di R. BONAN, La dimension commune, cit.,
vol. I, pp. 337-347.
38
M. MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p. 210.
39
Si tratta della nota de Le visible datata Gennaio 1959 che, come le altre citate, fa parte dell’insieme delle “Notes de travail” al “Livre en projet 1958-1960” f. 250 (si veda di nuovo la nota 6).
40
Le visible et l’invisible, tr.it. cit., p. 240.
41
Ivi, p. 159.
42
Barbaras scrive a proposito che “la relation aux autres précède en quelque sorte […], l’identité personnelle” (De l’être du phénomène cit., p. 289) e un po’ più avanti ribadisce che “Il n’y
a de divenir-soi que comme devenir-autre, de conquête de l’identité que comme ouverture aux
autre” (Ivi, p. 294).
43
Si deve tenere ben presente il senso di questa negazione, in quanto Merleau-Ponty precisa che “Dire che c’è trascendenza, essere a distanza, equivale a dire che l’essere (nel senso sartriano) è talmente gonfiato di non-essere o di possibile che esso non è solamente ciò che è” (Le
visible et l’invisible, tr. it. cit., pp. 197-198).
44
G. INVITTO, “ Esprit ” e “ raison ” filosofi francesi del novecento, Capone editore, Lecce 1987,
pp. 81-87, p. 85. Invitto oppone allo sguardo di Sartre, indice di una “dialettica totalizzante di violenza” (pp.81-82), che porta all’oggettivazione del mondo e dell’Altro, le analisi della visione condotte da Merleau-Ponty e rileva come esse siano da interpretare all’interno della più generale trasformazione del problema della trascendenza che il filosofo intende operare.
45
Si veda M. CARBONE, Carne, “aut-aut”, n. 304, Luglio-Agosto, pp.99-119.
46
M. MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p. 168.
47
Per un’attenta analisi di questo interesse, e in particolare modo per le teorie di F. De
Saussure, si veda M. CARBONE, Ai confini dell’esprimibile, cit., pp. 73-113; sulla presenza metodologica (e non solo langagière) dell’influsso saussuriano nell’ontologia della carne, mi sia concesso rimandare anche a: N. COMERCI, Del linguaggio incarnato. Intorno a Merleau-Ponty, in
AA.VV., Linguaggio e percezione. Le basi sensoriali della comunicazione linguistica, Carocci,
Roma 2002, pp. 57-63.
48
Si veda M. MERLEAU-PONTY, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, “Bulletin de la Société française de Philosophie”, t. XLI, 1947; poi in M. MERLEAU-PONTY, Le
primat de la perception et ses conséquences philosophiques, Verdier, Paris 1996, pp.39-104, pp.
55-56.
49
Signes, tr. it. cit., p. 67
50
In questo modo devono essere integrate le pur imprescindibili analisi di Bonan che, ne La
dimension commune, tende a considerare il linguaggio come “epifenomeno” del mondo sensibile,
con il risultato di non conferire il giusto peso alle possibilità intersoggettive che la parola manifesta in piena autonomia dal sensibile. Merleau-Ponty precisa infatti che “non possiamo più, per
spiegare la comunicazione, invocare la nostra appartenenza a uno stesso mondo, poiché è questa appartenenza che è in questione e di cui appunto si tratta di dare conto. Tutt’al più possiamo
SAGGI
dire che il nostro radicamento sulla stessa terra, la nostra esperienza di una stessa natura, è ciò
che ci lancia nell’impresa: esse non saprebbero garantirla, non bastano a compierla” (M. MERLEAUPONTY, La prose du monde –datato 1950-51– texte etablì et présenté par C. Lefort, Gallimard,
Paris 1969; tr. it. di M. Sanlorenzo, La prosa del mondo, Editori Riuniti, Roma 1984, p. 143).
51
Ivi, p. 142.
52
“La parola passa da uno spazio di coscienza all’altro per un fenomeno di sopravanzamento o di propagazione. Come soggetto parlante e attivo io sopravanzo su altri che ascolta, come
soggetto ascoltatore e passivo, lascio sopravanzare altri su di me. Nell’esercizio del linguaggio, io
verifico su me stesso che l’attività è l’altro lato della passività. È allora che l’idealità ‘fa il suo
ingresso’. Tanto nel mio rapporto con me stesso, tento nel mio rapporto con altri non c’è sorvolo
né idealità pura. C’è ricoprimento di una passività da parte di una attività: è così che io penso in
altri e che mi parlo. La parola non è un prodotto del mio pensiero attivo, seconda rispetto a esso”
(M. MERLEAU-PONTY, Husserl aux limites de la phénoménologie, corso del 1959-60 presso il
Collège de France, tr. it. Husserl ai limiti della fenomenologia, in M. MERLEAU-PONTY, Linguaggio
storia natura, Bompiani, Milano 1995, pp. 117-123, p. 120).
53
Si tratta del “Cours du lundi” intitolato Recherches sur l’usage littéraire du langage, i cui
appunti preparatori sono conservati anch’essi presso il “Fondo Merleau-Ponty”, Département des
Manuscrits Occidentaux, Bibliotèque Nationale de France (Site Richelieu) di Parigi e consultabili
in microfilm (Vol. XI – catalogato come: MF 9846). Il corso è diviso in due parti: la prima dedicata
a Valéry (da cui è tratta la citazione: f. 54), la seconda a Stendhal; ai corsi sono annesse le “Notes
pour les leçons sur Stendhal” e alcune “Notes sur Sartre et Parain, d’aprés Situations I ”.
54
M. Merleau-Ponty à la Sorbonne (1949-1952). Résumé de ses cours établi par des étudiants
et approuvé par lui-meme, “Bulletin de psychologie”, t. XVIII, n. 236, 1964, Paris, pp. 109-336; poi
Cynara, Grenoble 1988, p.55.
55
M. MERLEAU-PONTY, La prose du monde, tr. it. cit., p. 145.
56
Ivi, pp. 146-147.
57
Ivi, p. 145.
58
Ivi, p. 45, corsivo nel testo.
59
Ibidem.
60
R. Bonan (La dimension commune, cit., vol. II, pp.116-137) propone di utilizzare la nozione
di stile per indicare un tratto forte della personalità capace di garantire continuità nel modificarsi
temporale.
61
Le visible et l’invisible, tr. it. cit., p. 163.
62
A. DELOGU, Né rivolta né rassegnazione. Saggio su Merleau-Ponty, ETS, Pisa 1980, p.118.
63
Bernard Waldenfels parla a proposito di una “razionalità responsiva” che disloca il soggetto
da un piano di indubitabilità ad un piano in cui la razionalità non si conquista tramite l’epoché ma
si raggiunge nel confronto dialogico; si vedano in particolare: B. WALDENFELS, Ordnung im
Zwielicht, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1987; ID., Antwortregister, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1994.
64
R. BONAN, La dimension commune, cit., vol. II, p. 217. È merito di Bonan aver sottolineato
l’importanza di questo tema (tratto da Marcel) nella riflessione merleau-pontyana.
65
M. MERLEAU-PONTY, La prosa del mondo, cit., p.144.
66
ID., Le primat de la perception, cit., p. 79.
25
ORIZZONTI DEL COMPRENDERE.
L’IMPURITÀ COME METAFORA TRASVERSALE
FRA PSICOPATOLOGIA E ANTROPOLOGIA
DEL SACRO
di Eva Rizzuti
Psicopatologia e sacro
26
Una psicopatologia intesa come area di ricerca che si inscrive in un ampio
orizzonte ermeneutico e si propone quale intersezione fra i vari punti di vista di
ermeneutiche specifiche, e come compito la conoscenza e la descrizione
scientifica di possibili progetti di mondo, tende implicitamente a connettere
fenomeniche cliniche diverse ed apparentemente discontinue secondo rintracciabili e comprensibili percorsi esistenziali e narrativi. Ci conduce naturalmente
a privilegiare le continuità narrative piuttosto che le discontinuità nosografiche.
In questo senso l’approccio comprensivo-interpretativo –che possiamo
definire in senso lato ermeneutico– è l’unico in grado di salvaguardare dall’oggettivazione e dall’illusione dell’oggettivazione la simmetrica originalità del
suo oggetto di studio, il vissuto esperienziale nel suo duplice codice semantico, quello soggettivo irripetibile e quello universale delle esperienze antropologiche globali ed estreme. Una riflessione psicopatologica che voglia tendere
a ritrovare nel mondo psicotico un significato unitario, una sua semantica elementare ma specifica, non può esimersi dal dettato binswangeriano: “La psicopatologia non potrà che attingere dall’antropoanalisi” (1947).
Il compito dell’ermeneutica nel contesto antropofenomenologico potrebbe
trovare una delle sue realizzazioni a questo livello: nella decifrazione delle
esperienze-limite (il caso, il dolore, la morte, la colpa, la lotta), che Jaspers
chiama esperienze di confine: quelle situazioni che “nei confronti del nostro
esserci hanno un carattere di definitività”, “sfuggono alla nostra comprensione”, “sono come un muro contro cui urtiamo e naufraghiamo” (1932).
Ciò che qui sosteniamo è la possibilità di un chiarirsi reciproco fra esperienze-limite della psicopatologia ed espressioni-limite del discorso religioso:
ciò in virtù dell’incomparabile potere delle espressioni-limite di ridescrivere le
esperienze-limite, come Paul Ricoeur ha ampiamente dimostrato. “Il referente
ultimo del linguaggio religioso –sono le parole dell’A.– è l’esperienza umana
centrata attorno ad esperienze-limite, corrispondenti alle espressioni-limite del
discorso religioso”. “Varie procedure quali l’intensificazione, l’oltrepassamento
o trasgressione, lo spingersi fino al limite, trasformano il linguaggio poetico in
linguaggio religioso: esso non è una invenzione tra le tante; è, si potrebbe dire,
una metafora-limite” (1978).
Affermiamo inoltre, in continuità con le parole di Ricoeur, che è l’antropologia del sacro a costituire un “connettore forte” fra psicopatologia ed antropoanalisi: quanto ci proponiamo di svolgere nel presente contributo.
Individuare o tentare di individuare un connettore, ossia ricercare una continuità e non dei semplici parallelismi formali all’interno dei possibili modi dell’esperirsi dell’uomo –nel nostro caso dell’uomo come homo religiosus e come
homo aegrotans– ed in specie operare ciò in rapporto ad un tema eminentemente arcaico e sovradeterminato, come quello dell’impurità (definita dalla
Douglas “una vera e propria introduzione alla religione comparata”), tutto ciò
significa in primo luogo scontrarsi nel labirintico panorama delle scienze delle
religioni con problemi di metodo: equivale a dire col problema dell’oggetto.
Infatti non si intende qui indagare il ‘fatto’ religioso, ciò che è compito delle
scienze storiche, né i fondamenti epistemologici della sua verità di cui si occupa la teologia, né le categorie psicoantropologiche della credenza dal punto di
vista della psicologia, e così via; si intende bensì studiare il fenomeno: se il
fenomeno (Van der Leeuw, 1933) è “ciò che presuppone un secondo termine
ossia il soggetto pensante a cui si mostra” e se “non mai dato nel tempo né
nello spazio, ma potenzialmente ricostruibile”, è più che mai pertinente in questo campo l’antico principio citato da Eliade (1948) proprio in apertura al suo
Trattato: “la scala crea il fenomeno”.
L’Antropologia religiosa o Antropologia del sacro ha interesse per noi in
quanto, come ha affermato R. Bastide, “cerca di capire l’uomo che crea e
manipola tutto un simbolismo (homo symbolicus), quello del soprannaturale o
del sacro (homo religiosus)” (1985). Ed è la via “del simbolo, della parabola
–ha scritto Durand– come elementi costitutivi dell’universo del mito (sermo
mythicusl)” la via regia, “la prospettiva in cui abbiamo voluto collocarci per studiare gli archetipi fondamentali dell’immaginazione umana […] il patrimonio
immaginario dell’umanità, costituito dalla poesia e dalla morfologia delle religioni” (1963, 1985).
A sua volta la Fenomenologia religiosa –e il principale riferimento è all’autentico manifesto di questo indirizzo, la Fenomenologia delle religioni di G. van
der Leeuw nonché alle correnti culturali da cui ha attinto facenti capo a
Schleiermacher, Otto, Dilthey, Husserl, Jaspers– ha posto l’accento in particolare: sul versante esperienziale del fenomeno religioso; sulla categoria del
sacro designante sia l’oggetto dell’esperienza religiosa sia la disposizione del
soggetto a coglierlo; sull’autonomia della fenomenologia del sacro di contro al
riduzionismo positivistico. Ed è su questi presupposti che può fondarsi un’analisi fenomenologica in chiave ermeneutica dell’esperienza religiosa. Come
scrive van der Leeuw: “La religione si può considerare come esperienza vissuta comprensibile, o come rivelazione incomprensibile; l’esperienza vissuta,
nella sua ricostruzione, è un fenomeno: la rivelazione non è un fenomeno, ma
sì la risposta dell’uomo alla rivelazione” (1933).
Ma l’opera a cui si farà il più ampio riferimento, come la più pertinente e la
più affine sia sul piano dei temi trattati che delle ascendenze dottrinali (Husserl,
Jaspers, Kierkegaard, Pettazzoni, Eliade), è quella di P. Ricoeur (1960) ed in
particolare la sua Simbolica del male, seconda parte di Finitudine e colpa.
In quest’opera l’Autore approda, dopo aver mostrato come la fallibilità con-
SAGGI
L’esperienza del sacro e il male
27
28
tenga in sé quella possibilità del negativo la quale fa sì che l’umanità dell’uomo sia il “luogo di manifestazione del male”, ad una vasta ermeneutica delle
forme molteplici attraverso cui l’uomo nel corso dei secoli si è rappresentato il
male e la colpa. Il male –impurità o peccato– è “il punto sensibile, la crisi del
legame dell’uomo con il suo sacro”, crisi che il mito esplicita a suo modo e cioè
attraverso il linguaggio della confessione (di cui il mito è l’elaborazione secondaria). Il linguaggio “che parla al filosofo della colpa e del male –linguaggio
della confessione– è da cima a fondo un linguaggio simbolico; non parla di
impurità, di peccato, di colpevolezza in termini diretti e propri ma in termini
indiretti e figurati”. I simboli primari del male –dell’impurità, del peccato, della
colpevolezza– si possono comprendere soltanto percorrendoli bidirezionalmente e circolarmente: “gli ultimi sprigionano il senso di quelli che li precedono, ma i primi prestano agli ultimi tutta la loro potenza di simbolizzazione”. Se
l’impurità è un “momento superato della coscienza di colpa”, la colpevolezza
a sua volta “era già nella visuale più arcaica di tutte le esperienze, quella dell’impurità”; se l’impurità “compiuta solo quando divenuta colpevolezza”, la colpevolezza “può dirsi soltanto nel linguaggio indiretto della cattività (del peccato) e dell’infezione (dell’impurità) ereditato dalle due istanze precedenti”. La
“ripetizione” della coscienza religiosa della colpa è una delle due vie per accostarsi al problema del male: la via della descrizione astratta della fallibilità o del
chiarimento e dell’interpretazione si rifà sempre ad una ricchezza che, precedente al discorso filosofico, può essere solo compresa per il tramite di una
ripetizione “in immaginazione e simpatia”, una ripetizione “in noi stessi” della
coscienza religiosa della colpa, della confessione che la coscienza religiosa fa
del male umano, “la confessione della colpa, che al tempo stesso è la confessione della libertà” che prende su di sé il male (impurità o peccato). È l’atto con
il quale il male assunto su di sé che ci crea il problema: “l’uomo che tale simbolica rivela è non meno vittima che colpevole” o, come ha mostrato
Kierkegaard (1844), nello stesso tempo colpevole e innocente.
Per quanto riguarda il sacro, anziché azzardare definizioni omnicomprensive ci limitiamo a richiamare l’attenzione su tre aspetti specificamente attinenti al soggetto in questione:
α) La sua qualità strutturale di categoria psicoantropologica; cioè, oltre che
i contenuti, le figure e le espressioni caleidoscopiche, nel sacro si può discernere un elemento strutturale che si configura come una “categoria originaria”
(Otto, 1917; Cassirer, 1923), una “categoria della coscienza e non uno stadio
della storia” (Eliade, 1948).
β) La speciale labilità del suo legame con l’umanità dell’uomo, il suo ospitare –come ha mostrato Ricoeur– un punto critico, una crisi, un’esperienza critica per eccellenza: l’esperienza del male, impurità o peccato. E “proprio perché il male è l’esperienza critica del sacro scrive l’Autore –la minaccia di dissoluzione del legame fra l’uomo e il suo sacro fa sentire con estrema intensità la dipendenza dell’uomo dalle forze del sacro; il mito della ‘crisi’ è, allora, al
tempo stesso, il mito della ‘totalità’” (FeC) (l).
γ) Un terzo aspetto della sfera del sacro concerne la curvatura mitopoietica e parabolizzante del suo linguaggio, per entro la singolare qualità di que-
Nella sublime cornice della figura antropologica di Isaia annientato nello spirito
dinanzi alla sfolgorante visione del tempio, immagine della sovranità, della maestà, della santità che esige infinitamente, è proprio l’immaginario che parla e dice:
“Ahimè! Sono perduto, perché sono […] impuro” (Is. 6:5).
Se inoltre è vero che, come ha mostrato Ricoeur, “il simbolo dà perché è
intenzionalità primaria che dà analogicamente il senso secondo”, tale curvatura simbolizzante del linguaggio religioso può essere pensata in stretta relazione sia con quella “funzione generalissima dello spirito umano che è la funzione del separare e del riunire” e del significare disgiungendo e riunificando il
mondo caotico delle impressioni (Cassirer, cit.), sia con quella modalità motivante o “stimolazione interiore o assimilatrice” (intentio ad assimilationem, cit.
in FeC) su cui M. Blondel fondava l’analogia o l’atto analogico o –come direbbe C. Campo– quello “spirito analogico, se non vogliamo dire metaforico, della
facoltà compiutamente poetica –profetica– di volgere la realtà in figura, vale a
dire in destino “ (1987).
SAGGI
st’ultimo, simbolico-metaforica per eccellenza e come tale poetica e rivelante,
luogo di manifestazione del nostro essere nel mondo e grazie a ciò luogo privilegiato dell’ascolto e per l’ascolto dell’immaginario.
L’impurità: il versante antropologico
Il panorama della letteratura relativo al tema dell’impurità, o del puro e dell’impuro, così come si è inizialmente delineato in seguito alla consultazione
delle rispettive voci in opere enciclopediche di vario carattere ma soprattutto
storico-religioso (2), comprende una serie di studi che saranno in gran parte
elencati e di cui sarà descritto sommariamente il contenuto, al fine di illustrare l’estrema eterogeneità del campo di studio nonché gli sconfinamenti cui i
vari studiosi si espongono nel tentativo di indagarlo analiticamente, con il risultato o di assegnargli il confine stesso del sistema culturale di appartenenza
(volendosi focalizzare sul rilievo dei casi concreti, per rispettarne la complessità) ovvero di dilatarlo troppo e svuotarlo di ogni contenuto (volendone rivendicare una struttura). È altresì importante sottolineare l’incertezza dei limiti
delle nozioni di puro e impuro rispetto a numerose altre –quali la sacralità, il
tabù, il peccato, la colpa, la malattia, la disgrazia– nei confronti delle quali conservano rapporti complessi, ma diretti e, si può dire, inestricabili.
In un vasto numero di pubblicazioni lo storico del giudaismo, J. Neusner
(1973-1979), che si è occupato dell’idea e del sistema della purità nel mondo
ebraico biblico e post-biblico, ne ha posto in risalto i differenti significati e ambiti
di estrinsecazione: metafora a significazione etica, paradigma centrale della vita
cultuale, strumento di controllo sociale; ne ha seguito gli sviluppi e i percorsi storici fino alle articolate interpretazioni dell’età mishnaico-talmudica, sotto la pressione di fatti eccezionali (estraniazione dal Tempio, isolamento culturale-politico).
L’analisi storica di L. Moulinier (1952) del puro e dell’impuro nel pensiero
greco dalle origini fino al IV secolo, punta nell’insieme a far emergere la mol-
29
30
teplicità delle loro forme concrete –cioè le diverse circostanze in cui si impongono le purificazioni e la grande varietà di forme del rituale– e a confutare le
teorie che si sono sforzate di ricollocare la nozione di impuro nel contesto di
un pensiero religioso e simbolico. La nascita di un bambino, il parto della
donna, la morte e soprattutto l’omicidio (3) sono le principali evenienze in cui
si impongono le purificazioni religiose; le impurità possono colpire gli uomini,
le famiglie, le città, i luoghi santi, gli stessi dèi; le lustrazioni utilizzano l’acqua
ma anche il fuoco, lo zolfo, alcuni tipi di piante (scilla o fico), gli incantesimi,
eccetera. Per quanto dotata di una esistenza soprannaturale, l’impurità non ha
che un aspetto perfettamente positivo: un sudiciume, una macchia materiale
(sangue, fango, sporcizia, sudore) da allontanarsi con un gesto catartico (4).
Lo studio sistematico della “confessione dei peccati” quale si pratica nelle
varie religioni [R. Pettazzoni (1929-36)], tende a disegnare lo svolgimento
della pratica penitenziale in necessaria relazione allo svolgimento dell’idea
religiosa di peccato, secondo una ricerca condotta sì nel senso della storia
delle religioni, ma con metodo comparativo e con grande sensibilità ai problemi delle permanenze (con metodo quindi definibile storico-fenomenologico).
Con quest’opera monumentale il Pettazzoni (5) ha offerto numerosi e importanti contributi al tema del peccato e dell’impurità: a) Ha segnalato la larga diffusione del rito confessionale sia presso le culture superiori che presso le etnie
c.d. primitive di tutta la fascia ecumenica, in forme che vanno dai cerimoniali
strettamente magici di espulsione del ‘peccato’ alle vere e proprie pratiche di
pentimento e di mortificazione. b) Ha fornito una classificazione tipologica
della confessione (rivelazione, discolpa o semplice elencazione; segreta o
pubblica; resa direttamente o attraverso mediazione sacerdotale) e della natura del rito (dichiarazione verbale, rituali di trasferimento, atto di sottomissione
e riconoscimento della propria condizione creaturale) e ne ha messo in luce il
parallelismo con le varie concezioni, etico-religiosa e magica, relative al ‘peccato’: vera e propria carica di impurità materiale, sostanza peccaminosa che
può essere espulsa o trasferita su un oggetto ovvero atto, dimensione dell’esistenza che sussiste nella contrapposizione polare con un divino più o meno
personificato. c) Ha fatto emergere la commissione fra concezione ‘magica’ e
concezione ‘religiosa’ del peccato o fra impurità e peccato, e, correlativamente, la consistenza nelle religioni c.d. superiori di rituali che riflettono la nozione
di peccato come presenza materiale e comportano atti di espulsione magica
della colpa.
L’opera dell’indologo L. Dumont (1966), Homo hierarchicus –al cui centroè
il sistema indiano delle caste ed una teoria generale della società basata
sulla contrapposizione fra modello olistico e individualistico– ci fornisce l’esempio di uno speciale campo di manipolazione della dicotomia puro-impuro,
rappresentato dal complesso socio-religioso della casta indiana: l’opposizione puro-impuro risulta evidenziata quale suo fondamento intellettuale, in una
delle sue prerogative precipue e cioè quella di sistema simbolico in grado di
assimilare a sé e plasmare sul proprio ordine l’ambiente antropocosmico (6).
Fa inoltre emergere, più descrittivamente, alcuni aspetti dell’impurità così
come li sottolinea il caso dell’India: la qualità religiosa della nozione di impu-
L’impurità: il versante psicopatologico.
“Con questa sporcizia naturale (dice I.G.) si può anche aver a che fare, e
infatti ne viene a capo, mentre il pensiero dell’insudiciamento è ciò di cui non
si può venire a capo “ (von Gebsattel).
SAGGI
rità e il suo essere svincolata, ben differenziata dalla nozione di pericolo (il
brahmano è ‘vulnerabilÈ all’impurità del lavandaio, del barbiere, del sacerdote funerario –ossia ‘puro’– e non pericoloso –ossia sacro– per la gente comune come invece lo è il capo-tribù); la stretta relazione con la natura organica
dell’uomo (ci sono dodici secrezioni d’impurità secondo Manu (7), tra cui la
saliva, l’escremento e la sorte inferiore riservata alla mano sinistra, la ‘mano
della sporcizia’), il suo offrirsi come equivalente funzionale della frattura fra
uomo (religioso e sociale) e natura: l’impurità segna l’irruzione del biologico
nella vita sociale.
Gli scritti di A. Pazzini (1947-65), storico della medicina, tracciano una storia della patologia dalle origini fino al XVI secolo dedicando ampio spazio ai
modelli magico-religiosi di malattia (miasmatico, demoiatrico, teurgico, sciamanico e sacerdotale) e particolarmente al concetto di malattia come impurità
ed al correlativo postulato profilattico e terapeutico di questa concezione, quello di depurazione. Secondo quanto descrive Pazzini: la malattia è impura perché opera dei maligni emissari delle divinità del male e del loro malefico potere di inquinare un essere umano coinvolgendolo in quella atmosfera di impurezza di cui essi stessi sono i simboli; lo stato di impurezza fisica coincidente
con quello di malattia da considerare alla stregua di uno stato allotropico dell’impurezza morale, e cioè di un peccato (8); l’impurità somiglia al contagio,
ma in modo superlativo: chi tocca l’impuro contrae il suo stesso stato, ma
anche chi passa per la via per la quale questi è passato, chi tocca un oggetto
da lui toccato. L’impurità deve essere lavata, purificata (9), non per motivo di
igiene ma per più alta interpretazione religiosa: pertanto i mezzi di purificazione solo sporadicamente (il caso dell’acqua) si trovano a coincidere con i nostri
mezzi di disinfezione. Oltre che per mezzo di abluzioni, bagni o aspersioni, la
purificazione può essere effettuata per mezzo del fuoco (simbolo di purezza)
(10) per mezzo dell’urina di bue mista a ceneri o anche per mezzo dello sguardo di un cane, a patto che sia giallo e con due macchie nere sopra gli occhi
(religione iranica). Quando poi la malattia opera del miasma (un etere malefico composto dalle impurità che inquinano l’aria, sotto la forma p. es. delle esalazioni graveolenti provenienti dalle putrefazioni) il massimo potere depurativo
o antimasmatico posseduto dalle essenze odorose: così erbe, resine, unguenti si gettavano su grandi fuochi producendo le ‘fumigazioni’. La depurazione
dunque mistica, come mistica l’infezione prodotta dall’impurità e dal contatto
degli oggetti impuri: sempre ispirate al concetto di distruggere un ‘quid’ che è
nocivo in una sfera nella quale il morale e il fisico non sono disgiunti, nella
quale non sono riconosciute come sussistenti le leggi naturali che seguono il
loro naturale decorso, le cause seconde.
31
32
Come scrive von Gebsattel: “I.G. era perseguitata dal fantasma dell’impuro […] in questa minaccia di insudiciamento è insita una forza equivoca; essa
si rivolge a due istanze diverse: alla nausea e alla coscienza morale. E di due
elementi è costituita questa ‘impurità’: della fisionomia revulsiva dello sporco
e del gesto ammonitore del comandamento morale” (1938).
Nella crisi fobica –ci riferiamo segnatamente alla rupofobia, la paura dello
sporco, dell’impuro– il contenuto fobico, lo sporco, non propriamente un oggetto, ma un contenuto tramite il quale entra in crisi l’oggettivazione, che minaccia, imprigiona la presenza, onde la presenza sta dinanzi al contenuto fobico
nel rischio di identificarsi immediatamente ad esso, spossessata del suo stesso farsi presente (De Martino, 1977).
È oltremodo significativo che nell’esperienza ipocondriaca, in cui è possibile intravedere una delle testimonianze più arcaiche e dirette di ogni crisi
antropologica radicale, una figura centrale della specificità antropologica sia
proprio l’impurità. Le sue tematiche possono essere colte appieno solo se si
considera questo linguaggio del corpo, a sua volta un simbolo principe dell’impurità; il corpo malato, legato, paralizzato, contagiato, infetto, corrotto,
combusto: una “declinazione delle grandi metafore del male attraverso le quali
si esprimono nell’uomo le più radicali esperienze di alienazione e di scacco”
(Muscatello, 1992).
Andremmo oltre gli scopi d questo contributo se ci soffermassimo sull’assoluta centralità dei correlativi del puro e dell’impuro nell’anoressia nervosa,
talvolta addirittura classificata come “disturbo sacro” (Inglese, 1998). Basti
pensare ad alcune delle problematiche specifiche con cui si manifesta: il rifiuto del corpo, espresso dal rifiuto del cibo come affermazione di autonomia
verso l’angoscia di incorporazione (Thoma) o come operazione proiettiva di
confusione del cibo con la madre (Bergeret); l’edificazione del modello dell’Io
puro e incorporeo, libero da ogni vincolo carnale, e proteso verso l’immortalità e l’autogenerazione (Laing), “l’ermafroditismo ideale” (Brusset); l’investimento duplice del corpo, sia come luogo di negazione del suo aspetto carnale, sia di fascinazione per il suo doppio disincarnato. Al culmine della “vergogna del corpo” e dell’ideale di purezza che essa nasconde potremmo ritrovare quell’ideale psicotico dell’acorporeità che, fra l’altro, Janet e Binswanger
hanno descritto rispettivamente nel Caso Nadia e nel Caso Ellen West
(1903,1945).
Il concetto ricoeuriano della circolarità e della bidirezionaltà dei simboli primari del male –impurità, peccato e colpevolezza– ci fa comprendere tout court
come una possibile via di accesso all’universo dell’Impurità in psicopatologia
passi per il tramite dell’universo della Colpa ossia, precisamente, della sua
polarità metaforica. Non è un caso che già da oltre mezzo secolo
(Hesnard,1949) ci sia stata fornita una sistematica trattazione della patologia
psichica sotto la specie della Colpa, e la medesima sia stata qui definita come
area tematica trasversale della psicopatologia.
Si pensi al paranoide perseguitato che si appella ad un tribunale immaginario posto in un certo luogo del suo spazio allucinato, mal identificabile ma
non per questo per lui meno operante, a cui si rivolge e chiede giustizia; al
Gli psicopatologi sono proprio indotti a constatare che le preoccupazioni morbose dei malati sono, paragonate a quelle del soggetto normale, di un genere assolutamente speciale, sviluppate intorno ad un piccolo numero di temi tra i quali
nulla di equivalente stato ritenuto degno d’interesse dalla Psicologia ufficiale nell’opinione comune. Si tratta sempre, dal punto di vista del loro significato umano,
di Colpe immaginarie, di Accuse esterne che si servono di Attacchi calunniosi e
iniqui e Difese disperate, di Potenze ciniche o poste come al di sopra della morale comune; o ancora dell’incarnazione di una esistenza alienata sadica e lubrica,
cioè, originariamente immorale, o ancora di una malattia misteriosa inflitta come
una sofferenza morale punitiva e sacra o come una punizione sovrumana […].
Questo scenario di colpevolezza, una volta ammesso, pare in grado di ricongiungere su un medesimo piano di significazione tutti gli altri stati morbosi nei quali
una colpevolezza morbosa della stessa natura umana e patologica si traveste
sotto una moltitudine di forme laddove li individueremo dalla Gelosia delirante alla
maledizione superstiziosa dei nervosi colpiti da Fobia, passando per i lavori forzati metafisici dell’ossessivo, lo scatenamento nei maniaci di un’immoralità caricaturale, ecc., e, in tutti gli alienati il fondo candidamente osceno dei loro lamenti; senza contare questa eterna lotta, nella loro coscienza, tra la più bestiale lascivia e la più ardente aspirazione alla purezza (Hesnard, op. cit).
L’impurità: fantasma e metafora
L’impurità, che la ricerca sul versante antropologico ha mostrato come la
più antica metafora del male, una sorta di simbolo la cui ricchezza è tale da
essere in grado di significare analogicamente tutti i gradi dell’esperienza del
male: dalle sue modalità più arcaiche (magico-animistiche) a quelle più speculative e più interiorizzate (colpevolezza, servo arbitrio).
L’impurità è una sostanza, una macchia materiale; ma anche un atto che
sviluppa un male; anche una forza, un fantasma, uno spirito, una potenza, un
demone. È l’epifania del numinoso nel suo attributo terrificante, spaventevole,
il principio angosciante, il tremendum. È insieme una sostanza e un essere
invisibile. È oggettiva e soggettiva. È interna ed esterna. È causa e conseguenza. È se stessa ed anche il suo contrario che maledice e si vendica.
È un linguaggio, una confessione. Eppure un affetto, un affetto primordiale, cosmico, il “tremor”, il “phobos”, la paura primaria, l’angoscia (12).
È un linguaggio simbolico che parla del male, un linguaggio che cerca di
rendere figurabile ciò che di per sé sfugge ad una figurazione: la dura realtà
della sofferenza. Una fucina della significazione, della metafora: essa è là
SAGGI
paranoide persecutore che con mezzi deliranti punisce i suoi nemici; al melancolico che si rivolge gigantesche accuse ed implora la punizione, la sua stessa morte non parendogli sufficiente penitenza all’enormità delle sue colpe;
persino al maniaco che indirettamente tradisce la paura del giudizio nel ripudio euforico dei valori tendente a privare di ogni consistenza gli esseri e il
mondo; all’ossessivo, l’anancastico in lotta con la maledizione castigatrice
della sua emergenza coatta; al pervertito che cerca giustificazioni continue al
suo comportamento, oppure postula la validità di una morale che non è la
nostra; e via dicendo (11).
33
34
dove l’angoscia lotta fra il suo moto d disgregazione e la caparbietà di resistervi; tra l’esperienza muta e indicibile della destrutturazione e la disperata
ricerca di una parola, un senso, un progetto, una visione del mondo; o, come
ha detto Kierkegaard, nel “solco” tra angoscia e colpa.
Se l’impurità è un “momento superato della coscienza di colpa”, se essa è
dunque coglibile in un registro metaforico, possiede però anche una sua innegabile realtà fantasmatica.
Il mondo dell’impuro può essere rappresentato come al di là del ‘cosmo’,
dello spazio abitato, ordinato, conosciuto, determinato: uno spazio straniero,
brulicante di demoni e larve, popolato di fantasmi, un mondo che è posseduto dalla potenza del tremendo, dal terrore, dal pericolo, dall’insicurezza, dall’impotenza. È saturo di sovrannaturale, di energie e forze misteriose che emanando da oggetti e luoghi, e dandosi in sempre nuovi punti dello spazio e del
tempo, insidiano la “presenza”, tendono a invaderla e a possederla.
Si può comprendere allora come la psicopatologia affondi le radici in questo vissuto matriciale dell’impurità: attraverso la “crisi” dell’esistenza, il malessere, la crisi radicale dell’uomo (De Martino); uomo in quanto “presenza” virtualmente ma permanentemente revocabile, fragile, non garantita, sempre
esposta al rischio di flettersi, crollare, naufragare, dileguarsi, defluire nel
mondo. Della crisi radicale dell’uomo (“crisi della presenza”) il fenomeno della
psicosi rappresenta un estremo esemplare modello, o, in altri termini, qui si
innesta l’esperienza psicopatologica come espressione estrema della crisi,
come esperienza-limite.
Assumendo dunque il tema dell’impurità come forma di discorso religioso od
espressione-limite o metafora-limite, discorso rivelante, apofantico dell’orizzonte originario del nostro essere nel mondo ed in grado di ridescrivere esperienze-limite della vita umana, seguendo il già citato paradigma ricoeuriano del
“reciproco chiarimento” fra espressioni limite ed esperienze-limite, tenteremo
un percorso attraverso quei contenuti tematici che, quantunque provenienti da
diverse situazioni, paiono costellarsi attorno a questa metafora portante.
L’analisi intertestuale mediante l’intercalazione di alcuni squarci di protocolli clinici e antropologico-culturali ci è parsa operazione sufficientemente dimostrativa non soltanto delle tesi proposte, ma altresì di una possibile lettura ermeneutica del tema dell’impurità, nonché di quella “continuità” delle forme di vita
psichica, da intendersi non già come curiosa elencazione di omologie o isomorfismi meramente formali, bensì come il segno tangibile della multidimensionalità dell’uomo; quella continuità più volte additata e invocata tra diversi
ordini o dimensioni: la sfera del sacro, la sfera del sociale, la sfera del sé.
Un tentativo di indagine fenomenologica sull’immaginario.
Prima di ogni cosa l’impurità è un qualcosa che infetta, un qualche cosa di
quasi materializzato che contamina come una sporcizia, un caricarsi materialmente di un fluido, di una sostanza, di un che di reale, di oggettivo, una macchia, un sudiciume.
“Quando vedo un cane –dice E Sp.– ho la sensazione che mi capiti qualcosa. Se
siedo in qualche posto e passa un cane, il piede collocato nella sua direzione mi
duole per ore. Sento come un impedimento a stare insieme ad altre persone, perché mi sembra che qualcosa mi venga addosso. Allo stesso modo non mi metto a
sedere dove capiti, perché poi penso che qualcosa mi sia venuto addosso. Se mi
chiedete: che cosa, questo qualcosa non può essere che lo sporco […]. Non è la
paura dei batteri o di alcunché di simile, c’ è tuttavia sempre qualcosa che mi viene
addosso o che mi blocca”. (Un caso di cinofobia e rupofobia, von Gebsattel, cit.).
L’impurità è tuttavia un atto che sviluppa un male, un fluido, un quid misterioso e nocivo, un’impurità che agisce magicamente e dinamicamente; tuttavia una forza, nel campo della nostra esistenza inseparabilmente fisica e psichica, una potenza nefasta che va al di là di colui che compie quest’atto, poiché egli stesso è preso, catturato, sedotto dalla forza che ha scatenato, oltrepassato e avvolto.
Veleno cadaverico e altre materie in putrefazione, di cui erano portatori i raggi, si
ammucchiarono dunque indefessamente sul mio corpo giorno dopo giorno, ora
dopo ora, con l’idea di potermi finalmente schiacciare in tal modo e particolarmente derubarmi del mio intelletto. –Invece un processo reale, cioè per me soggettivamente certo, […] che io abbia avuto temporaneamente in corpo l’anima di
Flechsig. Era una palla o una matassa abbastanza voluminosa, che io vorrei
paragonare, più che a ogni altra cosa, a un volume corrispondente di cotone o di
una ragnatela, che mi era stato scagliato nella pancia per mezzo di un miracolo
[…]. E in particolare conservo di ciò un ricordo molto sicuro riguardante la sensazione di un odore e gusto cattivo, che tali anime impure cagionano a colui nel cui
corpo esse penetrano passando per la bocca (D.P.Schreber, cit.).
L’impurità è una potenza malefica che suscita e diffonde le impurità che emanano da sé, e simultaneamente calamita su di sé le impurità di tutti gli esseri, di
tutti gli oggetti che questo stesso atto mette in rapporto –un qualsiasi rapporto;
un miasma che irradia e assorbe in tutte le direzioni, pur restando attaccato.
SAGGI
L’estrazione del sangue dall’ombelico presso i Bechuana, il vomito (simulato) presso i Kikuyu, le abluzioni e i lavacri presso gli Ewe e i Bashilange, il
bagno forzato di chi si trova in stato di impurità presso i Sulka (o sle, impurità
che, a quanto dicono, si vede negli occhi…), l’abbruciamento del cordone
presso gli Huichol, l’asportazione di pietruzze o conchiglie presso i Cagaba:
sono, al pari della estrazione del sangue dal polpaccio presso i Semang e
Sakai, al pari del gettato delle schegge dal ventilabro presso i Wakulwe, altrettante operazioni che pur nella diversità loro, hanno un significato univoco ben
chiaro: per esse l’uomo intende levarsi di dosso, o di dentro, o comunque eliminare ed allontanare qualche cosa (Pettazzoni, cit.).
Ma è una sporcizia che nuoce per mezzo di proprietà invisibili, che attenta,
che incombe, che si approssima minacciosamente. L’impurità, per quanto
inseparabile dalla realtà materiale, ha tuttavia una sua esistenza soprannaturale: una sostanza nemica, ostile, peccaminosa che non solo corrompe e contamina, deturpa e imbruttisce, intacca l’essere intimo, infiacchisce le membra
nella loro potenza, ma annienta la presenza, la deruba, la costringe ad abdicare, paralizza, blocca, non lascia-più-procedere
35
Certi atti, contrari all’ordine del mondo, nascondono una potenza nefasta che va
molto al di là dell’agente umano; l’uomo che compie queste azioni si trova preso
nella forza che ha scatenato. L’efficacia dell’impurità ricopre così cosa un campo
d’azione di cui le parti e i momenti appaiono connessi gli uni a gli altri […]
L’impurità sotto la forma di un loimos (pestilenza) potrà anche estendersi a tutto
un territorio: terra infertile, greggi infeconde, bambini mostruosi. Nella potenza del
daimon si trova dunque oggettivato il sistema, più o meno ampio, delle relazioni
umane, sociali e cosmiche, che l’oltraggio sacrilego all’ordine ha perturbato.
Originariamente è questo disordine che l’impurità manifesta attraverso la varietà
delle sue forme concrete (Moulinier, cit.).
È un miasma che dilaga inesorabilmente fin oltre l’orizzonte, eppure vieneaddosso, che promana da sé eppure non ci-si-può-liberare.
La Signora […] porta sempre i guanti di filo, ma non se ne sente garantita a sufficienza.
Se deve prendere in mano un oggetto qualunque, anche pulitissimo, per esempio
il cappello accuratamente coperto e riposto nell’armadio, comincia nell’intimità
della sua coscienza una battaglia. Quel cappello è stato esposto alla polvere della
strada; la spazzola che l’ha pulito anch’essa un nido di polvere; come fare a toccarla? E toccandola coi guanti, non bisognerà in seguito toccare i guanti per
toglierseli e per rimetterli? Allora l’esitazione assume proporzioni angosciose:
l’ammalata diventa pallida e affannosa, piange, si dispera, s’accusa di essere una
pazza, una cattiva moglie, una madre capricciosa e frivola. Più volte s’è confessata e più volte ha desiderato la morte (Misofobia, Tanzi e Lugaro, cit.).
36
È un misfatto, che le purificazioni dal canto loro tentano di annullare con
un’azione specifica, non per questo azione totale e diretta, ma sempre significata. Se la macchia non è un sudiciume, se infetta l’indegno, rende indegno
colui che è infetto. Se il rito di purificazione allude al simbolismo dell’impurità,
l’atto come rito sopprime simbolicamente, così come l’impurità simbolicamente infetta. Nessuna azione totale e diretta è atta alla eliminazione dell’impurità. L’eliminazione sempre significata in segni parziali, sostitutivi, abbreviati,
che non esauriscono il loro significato nell’utilità immediata, letterale.
Il fedele persiano spinge così in là il principio della purificazione che, per eliminare con le abluzioni ogni sorta di lordura, arriva a lavarsi gli occhi quando sono stati
lordati dalla vista di un infedele (Taylor, cit. da Bachelard).
È vero che l’impuro non accede al livello dell’indegno, altrimenti svanirebbe la magia del contatto e del contagio; rimane nel chiaroscuro di una
‘metaxy’, di una via di mezzo (Hillman direbbe la sede dell’anima), né fisica né
materiale, né spirituale né astratta, fra il vitale e lo psichico, la creatività e la
creaturalità.
Ma la paura dell’impuro non è solo in una rappresentazione in cui si esprime un tormento, non solo in tutto ciò su cui si posa l’inquietudine.
Esisteva –per I.G.– uno stato di paura per tutto ciò che si connette con la morte e
con i morti, e al tempo stesso un essere posseduta da questi contenuti. Quanto
abbia forma oblunga, quadrangolare, ottusangola, significa “bara” e va evitato o calpestato […] in certo modo significa morte tutto ciò che è di colore nero, scuro, gri-
SAGGI
gio e cosi via. Distingue tutti gli oggetti e tutte le funzioni in “buoni” e “cattivi” […].
Dall’analisi risulta insistentemente che ogni cosa ‘cattiva’ o ‘proibita’ è in connessione con la morte e ne ha il significato. Ad esempio non può pronunciare frasi in cui
ricorra qualcosa che suoni negazione, dato che ogni ‘no’, ogni ‘non’ significano
morte, e il pronunciarli la mette in contatto con la morte e la rende cattiva e colpevole […]. Aveva d’altra parte sempre la “sensazione che potesse esistere un peccato grave che non aveva confessato” […]. Nel complesso di peccaminosità e di
impurità di I.G. l’attributo ‘impuro’ o ‘peccaminoso’, designa un aspetto delle cose o
delle persone che non ha nulla a che vedere con un imbrattamento materiale o una
sporcizia reale […]. La coscienza morale, in quanto ‘Ruf der Sorge’ (Heidegger),
parla di un pericolo particolare […]. Questo pericolo nel diventare impuri, cioè a dire
cattivi, e nel rendere cattivi. Una forza equivoca dunque insita in questa minaccia di
insudiciamento; essa si rivolge a due istanze diverse: alla nausea e alla coscienza
morale. E di due elementi è costituita questa ‘impurità’: della fisionomia revulsiva
dello sporco e del gesto ammonitore del comandamento morale. Essa è sospesa
tra il mondo naturale e il mondo morale (Fobia anancastica, von Gebsattel, cit.).
È già un terrore etico, un timore che anticipa lo scatenarsi di una collera
vendicatrice, che affronta una minaccia al di là della sofferenza e della morte.
Jahvé degli eserciti, egli è colui che dovete trattare come santo, ed egli deve
essere l’oggetto del vostro timore, ed egli deve essere colui che vi fa tremare. Ed
egli deve divenire come un luogo sacro; ma come una pietra contro cui urtare e
come una roccia su cui inciampare […] come una trappola e come un laccio per
le case di Israele. E molti fra loro certamente inciamperanno e cadranno e saranno infranti, e saranno accalappiati e presi (Is.8).
L’impurità è la stessa vendetta, la vendetta della purezza violata: il mondo
dell’impurità include nel suo ordine dell’impuro le conseguenze dell’azione o dell’avvenimento. Mal-agire e mal-patire sono coordinabili in un’azione immediata:
non sussistono le cause seconde. L’uomo soffre perché è impuro, quindi Dio
innocente; la sua rovina, la sua maledizione è inscritta nella purezza originaria.
La nuova vita nell’aldilà è la beatitudine cui l’anima umana poteva essere sollevata. Certo, ciò non poteva accadere senza una purificazione e cernita preliminare dei nervi umani, cosa che a seconda della differente costituzione delle anime
umane necessitava un tempo più o meno lungo e, secondo il risultato, anche certi
gradi intermedi preparatori. A Dio –o se si preferisce questa espressione, al cielo–
occorrevano solo nervi umani puri, poiché la loro destinazione era quella di essere articolati in Dio stesso e infine diventare, in quanto “vestiboli del cielo”, in un
certo senso elementi di Dio medesimo. I nervi umani moralmente corrotti sono
anneriti; uomini moralmente puri hanno nervi bianchi; quanto più in alto un uomo
si sarà trovato in vita dal punto di vista morale, tanto più la costituzione dei suoi
nervi si avvicinerà alla bianchezza o alla purezza perfetta, che è propria dei nervi
di Dio fin dall’inizio […]. È da escludere che ciò possa avvenire senza una purificazione preliminare, perché difficilmente si potrà trovare un uomo che sia esente
da colpa, i cui nervi dunque non siano stati sporcati una qualche volta […]. Chi
volesse applicare in questo caso l’espressione di “punizione”, deve tener per
fermo che lo scopo non è nell’infliggere un male, bensì soltanto nel procurare la
condizione necessaria alla purificazione […]. Anche la trasmigrazione delle anime
sembra essere servita alle anime umane impure […]. Le anime perfettamente
depurate attraverso il processo di purificazione salivano in cielo e giungevano in
tal modo alla beatitudine (D.P. Schreber, cit.).
37
L’impurità è già una coscienza, la coscienza che scopre “nel timore e nel
tremore” la legge di retribuzione: se il male di sofferenza è un male scandaloso, irrazionale, allora mal-agire e mal-patire non sono più coordinabili, deprivati di significazione. È l’aspirazione, l’attesa che la sofferenza abbia una
misura, un senso, un fine, che sia figurabile in un Destino. L’impurità entra nell’universo della paura non solo attraverso il divieto, ma attraverso la confessione, ed attraverso la confessione che si apre all’altro e a se stessa e si chiede: perché sperimento questa malattia, questo fallimento; che peccato ho
commesso? Nell’affannosa ricerca di un senso l’uomo sofferente cerca un
significato come causa del suo soffrire, implora un cenno, e per questo cerca
in sé un peccato, una colpa.
M.B. afferma che “lei stessa avrebbe divorato il proprio figlio […] non solo, ma tutti
quelli presenti in reparto hanno contribuito a mangiarlo”, “si tratta del bambino che
è a casa, non di quello che ho in grembo”, “perciò vuole andare a casa subito per
vedere come sta” […]. “Vedo, a volte, un fratellino morto sul tavolo che ho ucciso
io, e mi sento in colpa per quello che ho fatto in passato”. Si fanno sempre più frequenti i rituali di purificazione durante il giorno e la notte. Viene spesso trovata
durante la notte a fare la doccia; interrogata su ciò, risponde che “si sente sporca”, che “di notte la violentano e la sporcano di escrementi, la obbligano a fare
‘servizi indescrivibili’, al che lei deve per forza lavarsi per togliere dal suo corpo
questo sporco che la ossessiona e la opprime” […]. Durante la notte ripete quasi
ossessivamente l’atto di lavarsi: “Mi lavo perché sono sporca e devo purificarmi”
(Caso di schizofrenia paranoide; nostra osservazione.).
38
La confessione, così come il lavacro, non è essenzialmente che liberazione: liberazione, come ha scritto Pettazzoni, da quello smarrimento che prende l’uomo al manifestarsi dei primi sintomi del male, liberazione da una pena
che opprime, liberazione da una intollerabile angoscia.
L’impurità entra nell’universo della paura non solo attraverso il divieto, ma
attraverso la confessione, la coscienza si apre all’altro e a se stessa, e si chiede: perché sperimento questa malattia, questo fallimento; che peccato ho
commesso? Il sospetto nato, l’apparenza degli atti viene posta in questione.
“Signore, sono forse io?” […]. Conosceva in realtà l’uomo che lo tradiva, per questo disse:
“Non siete tutti puri”. Essendosene gravemente addolorati, cominciarono ciascuno a dirgli: “Chi Signore? Non sono io, vero? […]. Chi ha fatto il bagno non ha
bisogno di lavarsi i piedi, ma interamente puro. E voi siete puri, ma non tutti.
Conosceva in realtà l’uomo che lo tradiva. Per questo disse: “Non siete tutti puri”
[…] E uno dei suoi discepoli –quello che egli amava– questi, appoggiandosi indietro sul suo petto, disse: “Sono forse io?” (Gv.13, Mt. 26, Gv. 24).
Il progetto di una confessione che riveli il senso nascosto dei comportamenti, se non ancora delle intenzioni, è presente al centro della più umile “confessione di peccato”.
Ho lavato le mie mani, purificato il mio corpo con pura acqua sorgiva che si trova
nella città di Eridu […]. Il cattivo genio, il demone maligno, malattia, peste, febbre,
incendio, dolore, lamento, estenuazione, sospiro, pena, disperazione, angoscia di
Desoille (1938) ha posto: l’incubo prima del dramma, la nausea prima della
caduta, il terrore prima del mostro, il sogno prima della realtà. È per questo
che Bachelard (1943) ha detto: con i sogni soffriamo e con i sogni guariamo.
1
Ed è nel suo esperirsi come dipendente dalle forze del sacro che l’uomo scopre un’essenza
del tragico, l’ineluttabile insidia del nodo che incatena enigmaticamente la forza e la debolezza,
come suggestivamente lasciano intendere le parole di Paolo: “poiché quando sono debole allora
sono potente” (2 Cor. 12).
Una fragilità che è soggiacente al male della sofferenza, la perenne minaccia di un punto sempre incline alla rottura –è ciò che Nietzsche pare additare in queste parole: “Ma tu che sei profondo, tu soffri troppo profondamente anche per le piccole ferite e ancora non sei riuscito a guarirti che già lo stesso verme velenoso ti è strisciato sulla mano” (1884).
E il mito –il mito a cui allude Ricoeur, cioè quello che parla del principio e della fine del male–
rappresentando di per sé una “comprensione della realtà umana in toto, ricolloca, attraverso una
reminiscenza e una aspettazione l’esperienza dell’uomo in una totalità” (FeC). Ma è proprio l’esperienza così ‘sacralizzata’ e contrassegnata dall’essere, come ha mostrato Jarnes (1901),
“sistematica e riflessiva, lealmente avvinta a ideali interiori determinati” che è pericolosamente
predisposta a deflagrare.
2
Si indicano le principali fonti e voci consultate: “Fluro e Impuro”, Enciclopedia delle Religioni,
Vallecchi, cit.; “Flurezza”, Dizionario Biblico, E Koenig, cit.; “Puro/ Impuro”, Enciclopedia Einaudi,
cit.; “Flurit, Impurit”, Dizionario Biblico, J. McKenzie, cit.; “Purité, Nuovo Dizionario delle Religioni,
H.Waldenfels, cit.; “Puro VS Impuro”, Dizionario delle Religioni, G. Filorarno, cit.; “Purity and
Impurity”, Encyclopedia Judaica, cit.; “Puret, Purification”, Dictionnaire de Spiritualité, cit.; “Puret
et Impuret”, Dictionnaire de la Bible, Supplement, cit.; eccetera. Da notare che si viene rimandati
a: “Sacro”, “Tabù”,”Peccato”, “Confessione dei peccati”, “Malattia e guarigione”.
3
È nel caso della morte, soprattutto della morte violenta e specialmente dell’omicidio, che la
comunità si sente minacciata dall’impurità, colpita e corrotta da una potenza di contagio, un miasma, che esige una vigilanza inquieta e angosciosa.
4
J. P. Vernant (1974) a sua volta, respingendo le concezioni di Moulinier, insiste sul carattere
simbolico dell’impurità sul suo aspetto di forza religiosa; sul suo rapporto con l’aspetto temibile (il
tremendum) del sacro, ma anche con il suo volgersi nel senso buono attraverso quegli stessi
mezzi materiali che insozzano: il sangue, la polvere, gli abiti dei morti, lo stesso pharmakos.
5
È utile segnalare che La confessione dei peccati di R. Pettazzoni è una delle opere a cui si
è ispirato P. Ricoeur e da cui ha attinto per la sua Simbolica del male e, particolarmente, per il
capitolo dedicato all’’impurità.
6
Considerata in una prospettiva strutturalista, la posizione di Dumont, riguardo alla dicotomia
puro-impuro come sistema simbolico in grado di descrivere e fondare l’ordine sociale, potrebbe
sembrare affine a quella della Douglas ma i due Autori giungono a conclusioni differenti, come si
evince da ciò che è detto qui di seguito ed anche più oltre.
7
Manu è un personaggio mitico che nella cultura indù è considerato il progenitore della razza
umana. È ritenuto fondatore dell’ordine sociale e a questo titolo gli vengono attribuiti molti assiomi e versetti. Il Manavadharmiasastra o Trattato del dharma, meglio conosciuto come Legge di
Manu, è un’opera di autorità incontestata in materia di dharma (l’ordine sia cosmico che religioso
e sociale, il ‘dovere’ morale e religioso).
8
Così il Pettazzoni nel descrivere l’enunciazione-eliminazione del peccato presso i Babilonesi:
“Incantesimo, ossessione, peccato furono nozioni fluttuanti e interferenti. Il peccato fu messo sullo
SAGGI
cuore, spavento, tribolazione, sciagura […], ira degli dei, pianto […], le cattive
malie, stregonerie, venefici, malefizi umani, vadano con l’acqua del mio corpo […],
l’acqua di purificazione delle mie mani […], porti via il mio peccato, mi liberi dal peccato e prenda via il cruccio (Testi di scongiuro babilonesi, cit. in Pettazzoni).
39
40
stesso piano delle altre cause del male; non solo, ma tutte le cause diverse si confusero con quello che era il loro effetto comune, e principalmente con la malattia […]. Il male, particolarmente il
male fisico, quando non appariva evidente la sua causa naturale, si credeva che fosse cagionato
dalle arti magiche, oppure dall’assalto od ossessione di qualche demone maligno. Altrimenti, il
male poteva essere conseguenza di un’azione commessa dall’uomo, di qualche sua violazione o
trasgressione o ribellione ai voleri della divinità, cioè di un peccato” (1929-1936).
9
Ricorda Girard (1972) che la parola greca katharsis (purificazione religiosa) è un’operazione
concepita nelle modalità di un drenaggio o di un’evacuazione, la messa a morte del katharma,
l’oggetto malefico che introducendosi dall’esterno nell’organismo umano vi porta il disordine (la
malattia); ma a sua volta katharma designa anche e anzitutto una vittima sacrificale umana, una
variante di pharmakos (la vittima che deve calamitare sulla propria persona i cattivi germi ed evacuarli); parallelo quindi lo slittamento che conduce dal katharma umano alla ‘catarsi’ medica
(droga che evacua gli umori nocivi) e dal pharmakòs umano al phàrmakon (veleno e rimedio ad
un tempo).
10
All’opposto l’acqua o il fuoco possono essere interdetti in merito alle purificazioni, in quanto considerati divinità purissime che potrebbero essere contaminate con il contatto dell’oggetto impuro.
11
Si potrebbero aggiungere a questi esempi moltissimi altri che si riferiscono però propriamente a comportamenti autopunitivi (paralisi funzionari di varia specie, mutacismi, sitofobie, atti
autolesivi, negativismi, catatonie, ecc.): ciò che di proposito tralasciamo poiché il significato collegato alla colpa di queste emergenze non risulta esplicito, ma abbisogna per essere compreso di
una (sia pure, in certi casi, facile) spiegazione interpretativa.
12
Nell’esperienza, nella paura dell’impuro, il male ossia la realtà umana del male (malattia,
disgrazia, peccato), è vissuto non soltanto come esperienza dolorosa, ma anche come forzasostanza; non soltanto come una rivelazione sintomatica di un atto malvagio (un peccato) o di una
azione commessa generatrice di male, ma anche come un evento indipendente dalla sua volontà che si impone dall’esterno; non soltanto come “materialità” che non può non sussistere (in
quanto sfera fisica e sfera etica non sono disgiunti), ma come una “malizia” di cui il soggetto stesso non può non essere autore (secondo la “casualità personale interna” di Arieti, “tutto ciò che
accade è una malignità di cui si ha colpa”).
BACHELARD G., 1942. Psicanalisi delle acque. Purificazione, morte e rinascita, trad. it. Ed. red,
Roma 1987.
BACHELARD G., 1943. Psicanalisi dell’aria. Sognare di volare. L’ascesa e la caduta, trad. it., Ed. red,
Como 1988.
BASTIDE R., 1985, “Anthropologie religieuse”, in Encyclopaedia Universalis, vol.2, Paris.
Bibbia (La), Scritture ebraco-aramaiche: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, 1-2 dei
Re, 1-2 Cronache, Ester, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste o Qoelet, Isaia, Geremia,
Lamentazioni, Ezechiele, Amos, Giona. Scritture greche: (Vangeli) Matteo, Marco, Luca,
Giovanni; Atti degli apostoli; (Lettere) Romani, 1-2 Corinti, Galati, Efesni, Filippesi,
Colosses, 1-2 Tessalonicesi, 1-2 Timoteo, Tito, Filemone, Ebrei, Giacomo, 1-2 Pietro;
Apocalisse (o Rivelazione), in La Sacra Bibbia, vers. dai testi originali, Ed. Paoline, 1968;
La Sacra Bibbia, trad. sec. la Vulgata di A. Martini, Peruzzo, 1987; La Sacra Bibbia, a cura
di S. Garofalo, Marietti, 1964; Novum Testamentum Graece et Latine, a cura di A. Merk,
SPIB, Romae 1984.
BINSWANGER L., 1945, “Il caso Ellen West”, in Il caso Ellen West, trad. it., Bompiani, Milano 1973.
BINSWANGER L., 1947, “L’indirizzo antropoanalitico in psichiatria”, in Il caso Ellen West, trad. it.,
Bompiani, Milano 1973.
BRENA G. L., 1983. “Metafora e metafisica”, in Metafore dell’invisibile. Ricerche sull’analogia
(Contributi al XXXIII Convegno del centro di Studi di Gallarate, apr. 1983), a cura di G.
Santinello, Morcelliana, Brescia 1984.
CALASSO R., 1974. L’impuro folle, Adelphi, Milano.
CALLIERI B., 1991. Il senso di colpa: Note di psicopatologia antropologica, in E. FELICI e G.
VETRONE, a c. di Colpa e vergogna. Aspetti socio-antropologici.
CAMPO C., 1987. “Attenzione e poesia”, “Gli imperdonabili”, “Parco dei cervi”, in Gli imperdonabili, Adelphi, Milano.
CARGNELLO D. CALVI L. A., 1961. Principi ordinativi per un inquadramento antropoanalitico delle
fobie, in Schweiz. Arch. f. Neurol. Neuroch., Psichit., 87, 327.
CASSIRER E., 1923. Filosofia delle forme simboliche, trad. it. La Nuova Italia, Firenze, vol. I e vol.
II, 1961-1964.
CAZENEUVE J., 1958. L’Impureté, “Le Sacré et la pratique religieuse”, in Les rites et la condition
humaine, Presses Universitaires de France, Paris.
CHASSEGUET-SMIRGEL J., 1975. “Il Super-io e l’ideale dell’Io”, in L’ideale dell’Io. Saggio psicoanalitico sulla “malattia d’idealità”, trad. it., Cortina, Milano 1991.
COLETTE, 1941. Il puro e l’impuro, trad. it., Adelphi, Milano 1980.
DE MARTINO E., 1973. Il mondo magico, Boringhieri, Torino.
DE MARTINO E., 1977. La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di
C. Gallini, Einaudi, Torino.
DELUMEAU J., 1983. Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, trad.
it., Il Mulino, Bologna 1987.
DESOILLE R., 193 8. L’Exploration de l’activité subconsciente par la méthode du rêve éveillé,
D’Artrey, Paris 1938.
DESTRO A., 1989. “L’azione rituale di fronte al santuario”, in In caso di gelosia. Antropologia del
rituale di Sotah, Il Mulino, Bologna.
DILTHEY W., 1911. Ermeneutica e religione, trad. it., Patron, Bologna 1970.
DOUGLAS M., 1966. Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, trad. it.,
Il Mulino, Bologna 1975.
DUMONT L., 1966. “Dal sistema alla struttura: il puro e l’impuro”, in Homo hierarchieus. Il sistema
delle caste e le sue implicazioni, trad. it., Adelphi, Milano 1991.
DURAND G., 1963. Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia
generale, trad. it., Dedalo, Bari 1972.
DURAND G., 1989. “L’uomo religioso e i suoi simboli”, in Trattato di antropologia del sacro, a cura
di J. Ries, cit.
DURKEIM E., 1912. Le forme elementari della vita religiosa, trad. it., Edizioni di Comunità, Milano
1963.
SAGGI
Bibliografia
41
42
DURKEIM E., HUBERT H., MAUSS M., 1901. “Su alcune forme primitive di classificazione”, in Le origini dei poteri magici, trad. it., Boringhieri, Torino 1977.
ELIADE M., 1948. Trattato di storia delle religioni, trad. it., Boringhieri, Torino 1976.
FELICI F., VETRONE G. (a cura di), 1991. Colpa e vergogna. Aspetti socio-antropologici, psicologici,
psicopatologici, Atti del Convegno, Arezzo 17-18 febbraio 1990, Gruppo ed. Marcon
Università, Città di Castello.
FRAZER J. C., 1911-1913. “Tabù e i pericoli dell’anima”, “Il capro espiatorio”, in Il ramo d’oro. Studio
sulla magia e la religione, trad. it., Boringhieri, Torino 1965.
FREUD S., 1907. Comportamenti ossessivi e pratiche religiose, in Opere, Boringhieri, Torino 1972,
vol. VII.
GEBSASTTEL von V. E., 1938. “Il mondo dell’anancastico”, in MINKOWSKI E., GEBSATTEL von V. E. e
STRAUSS E.W., Antropologia e psicopatologia, trad. it., Bompiani, Milano 1967.
GENTILI C., MUSCATELLO C. F., BALLERINI A. e AGRESTI E., 1968. Psicopatologia del vissuto somatico nella schizofrenia: studio clinico e fenomenologico dei deliri a tema somatico, “Riv.
Sper. Fren.”, 89, 1077.
GIRARD R., 1972. La violenza e il sacro, trad. it., Adelphi, Milano, 1980.
GOLDBERG J., 1985. La colpa. Un assioma della psicoanalisi, Feltrinelli, Milano, 1988.
GRELOT P., 1985. “Peccato nella Bibbia”, in POUPARD P., VIDAL J., RIES J., COTHENET E.,
MARCHASSON J., DELAHOUTRE M., 1985. Grande Dizionario delle Religioni, trad. it.,
Cittadella e Piemme, Assisi e Casale Monferrato 1988.
GUITTON J., 1991. Il puro e l’impuro, trad. it., Piemme, Casale Monferrato 1993.
HESNARD A., 1949. L’universe morbide de la faute, Presses Universitaires de France, Paris.
JAMES W., 1901/2. Le varie forme della coscienza religiosa. Studio sulla natura umana, trad. it.,
Fratelli Bocca, Milano 1904.
JANET P., 1903. Les obsessions et la psychastnie, E. Alcan, Paris.
JASPERS K., 1932. “Situazioni-limite”, “La coscienza assoluta”, in Filosofia, trad. it., UTET, Torino 1978.
JOURNET CH., 196 1. Il male. Saggio teologico, trad. it., Borla, Roma 1993.
JUNG C. G., 1938-40. Psicologia e religione, in Opere, Boringhieri, Torino 1979, vol. XI.
KIERKEGAARD S., 1844. Il concetto dell’angoscia. Semplice riflessione per una dimostrazione psicologica orientata in direzione del problema dogmatico del peccato originale di Virgilius
Hanfniensis, trad. it., in Opere, Sansoni, Firenze 1972.
LAING R. D., 1969. L’io e gli altri, trad. it., Sansoni, Firenze 1977.
LEEUW G. van der, 1933. Fenomenologia della religione, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino 1975.
MICHAUX L., 1968. Le fobie, trad. it., Il pensiero scientifico, Roma 1972.
MINKOWSKI E., GEBSATTEL VON VE e Strauss E. W., Antropologia e psicopatologia, trad. it.,
Bompiani, Milano 1967.
MOULINIER L., 1952. Le pur et l’impur dans la pensée des Grecs, d’Homère à Aristote, Libraire C.
Klineksieck, Paris.
MUSCATELLO C. F., SACARDOVI A., SCUDELLARI P. RAVANI C., VISTOLI P., 1992. Al di là di una fenomenologia descrittiva: l’ipocondria come metafora del male. Seminario Ist. Ottonello, non
publ., Bologna.
MUSCATELLO C. E., SCUDELLARI P., 1993b. Figure del narcisismo. La metafora del fiore e le sue
metamorfosi grafiche in un caso di anoressia mentale, Teda edizioni.
MUSCATELLO C. F., RIZZUTI E., BOLOGNA M., SCUDELLARI P., 1994. Esistenza come parabola. Una
riflessione antropoanalitica, “Comprendre. Archive International pour l’Antropologie
Phénoménologique ”, n. 7.
NEUSNER J., 1973. The idea of purity in Ancient Judaism, Brill, Leiden.
NOTH M. (traduzione e commento), 1978. “Levitico”, in Antico testamento, trad. it., Paideia, Brescia
1989, vol. 6.
ODIER CH., 1966. L’angoscia e il pensiero magico, trad. it., Giunti-Barbera, Firenze 1975.
OTTO R., 1917. Il sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e la sua relazione al razionale, trad. it.,
Feltrinelli, Milano 1966.
PAZZINI A., 1947. Storia della medicina, S.E.I., Milano.
PAZZINI A., 1948. Gli argini della scienza: depurare, immunizzare, curare, in L’uomo e le malattie,
Bompiani, Milano.
PETTAZZONI R., 1913. La scienza delle religioni e il suo metodo, “Scientia”, 7: 239247, Bologna.
PETTAZZONI R., 1920-21. L’essere supremo nelle religioni primitive. L’onniscienza di Dio, Einaudi,
Torino 1957.
SAGGI
PETTAZZONI R., 1929-36. “Primitivi”, “Babilonia”, “Israele”, “Grecia”, in La confessione dei peccati,
Zanichelli, Bologna.
PUECH H. C., 1970-76. Storia delle religioni, trad. it., Laterza, Bari 1976.
RICOEUR P., 1960. Finitudine e colpe, trad. it., Il Mulino, Bologna 1970.
RICOEUR P., 1975. Ermeneutica biblica, trad. it., Morcelliana, Brescia 1978.
RIES J., (a cura di), 1989. Trattato di Antropologia del Sacro, trad. it., Jaca Book, Milano, vol. I (Le
origini e il problema dell’homo religiosus).
RIES J., 1989. L’uomo religioso e il sacro alla luce del nuovo spirito antropologico, in Trattato di
Antropologia del Sacro, a cura di J. Ries, cit.
SACCHI S., 1976. “Il sacro e il profano. L’impuro e il puro”, in Storia del mondo giudaico, S.E.I., Torino.
SACCHI S., 1983. “Onmia munda mundis” (Tito, 1,15): Il puro e l’impuro nel pensiero ebraico, in Il
pensiero di Paolo nella storia del cristianesimo antico, Ist. Fil. Classica, Genova.
SACCHI S., 1984. Il puro e l’impuro nella Bibbia. Antropologia e storia, in Quaderni di Henoch, vol.
VI.
SCHREBER D. P., 1902. Memorie d un malato di nervi, trad. it., Adelphi, Milano 1974.
SONTAG S., 1977. Malattia come metafora, trad. it., Einaudi, Torino 1979.
TACCHI VENTURI P., 1970-71. Storia delle religioni, UTET, Torino.
TANZI E., LUGARO E., 1923. Trattato delle malattie mentali, S.E.I., Milano.
TURCHI N., 1922. Manuale di Storia delle religioni, Fratelli Bocca, Torino.
VERNANT J. P., 1974. “Il puro e l’impuro”, in Mito e società nell’antica Grecia. Religione greca, religioni antiche, trad. it., Einaudi, Torino 1981.
VERNANT J. P., SCHIAVONE A., 1991. Ai confini della storia, Einaudi, Torino 1993.
VERGA A., 1897. “Sulla rupofobia”, in Studi anatomici sul cranio e sull’encefalo psicologici e frenatrici, F. Manin Wright, Milano, vol. III (Parte psicologica e frenopatologica), tomo 2°
(Frenopatologia speciale).
WIDENGREN G., 1969. Tabù e Sacralità, in Fenomenologia della religione, trad. it., Dehoniana,
Bologna 1984.
ZUNINI G., 1966. Homo religiosus. Capitoli di psicologia della religiosità, Il Saggiatore, Milano.
43
L’ETICA DEL DISCORSO E LE SUE POSSIBILITÀ
IN FUNZIONE DI UNA SOCIOLOGIA ETICA.
A PARTIRE DA HABERMAS
di Antonio Micheloni
44
La teoria sociale deve affrontare, in ognuna delle sue proposizioni, problemi di coerenza critica. Si pongono cioè questioni di aderenza all’oggetto dell’indagine, che il soggetto conoscente non deve mai prevaricare. La teoria
sociale è quindi in questo senso “dialettica”. L’etica del discorso di Habermas
si assume, nel contorto panorama della “crisi della filosofia”, il compito specifico di riscoprire le radici “umane” della conoscenza, illuminando quel versante del sapere che il positivismo ha oscurato e che risulta costitutivo. La soggettività è pensata da Habermas come linguaggio. Il contesto umano del sapere si articola nell’espressione linguistica, e l’identità “umana” che la società ha
perduto con l’imporsi storico di istituzioni spersonalizzanti va riconquistata con
l’ausilio dello strumento umano del dialogo. L’etica del discorso si apre quindi
nelle intenzioni dell’autore ad una prospettiva di cambiamento sociale: la
società va restituita ai suoi attori umani, e deve essere reinterpretata all’insegna di una razionalità discorsiva.
Per Habermas la fondazione della trascendentalità non può conoscere una
base tradizionalistica, e necessita di essere ripensata in nuovi termini. Il presente articolo vuole suggerire, partendo dalle riflessioni di Habermas sulla trascendentalità del linguaggio, una discussione sull’adeguatezza teoretica e
politica di una tale proposta. Il sospetto è che l’abbandono della dialettica,
maturato da Habermas in sincronia con la sua “svolta linguistica”, non sia in
realtà che il riflesso di un deciso scarto verso l’aspetto soggettivo del rapporto fra l’uomo e la realtà. Per questa via, la riflessione condurrebbe ad un equivoco in merito alla reale natura dell’interazione fra l’uomo e la sua dimensione sociale, ed anche il proposito in sé indiscutibile di una riconduzione del
sapere alle sue radici autenticamente umane, cioè la dichiarata centralità del
problema di una teoria della conoscenza, soggiacerebbe a tale malinteso.
Occorre chiarire, partendo da un concetto di “uomo” correttamente inteso,
quanto di questo sia andato perduto in seguito al mutarsi della società da tacito “patto di collaborazione” fra uomini ad ambito eterodiretto di controllo e
gestione dei pensieri e delle azioni. S’impone un ritorno alla teoria critica, conferendo un particolare rilievo a quei tratti di radicalità teoretica che essa è
riuscita ad incarnare nella sua più recente formulazione (da noi individuata nell’opera La società dello spettacolo del pensatore francese Guy Debord). Cos’è
l’uomo, e come è indotto a pensarsi nell’odierna società? Questo articolo, partendo proprio dalla questione sollevata da Habermas, vuole avanzare la tesi
che il problema della trascendentalità non è più una prerogativa dell’uomo che
riflette sulle operazioni della sua coscienza, ma delle istituzioni del potere di
SAGGI
una società che non riconosce più i suoi legittimi componenti e si libra al di
sopra dei destini umani come un organismo dotato di regole proprie. In ragione di ciò, lo strumento del linguaggio fallirebbe in partenza, perché ciò che un
tempo poteva essere un mezzo che l’uomo aveva a disposizione per capirsi,
è diventato oggi il principale strumento per allontanarlo da ogni reale consapevolezza di sé. Tuttavia, ciò che potrebbe essere il campo d’indagine di una
semplice sociologia della comunicazione non spiega ancora tutta la realtà del
condizionamento sociale. La pubblicità, questo autentico simulacro degli interessi economici, modella la vita comunitaria al punto che l’uomo è indotto a
trascurare le sue reali necessità a vantaggio di bisogni accessori, indotti per
favorire la politica della vendita di merci. In questo processo, l’intima coscienza della reale natura umana, l’intero universo degli affetti e della reciproca solidarietà, va disperdendosi. Per ottenere ciò, il linguaggio ha dovuto abdicare
alla sua identità razionale e si è costituito ad immagine dei molteplici interessi
che è chiamato a veicolare. Esso assume sempre più una dimensione evocativa. La trascendentalità non è più decisa sul piano umano, ma su quello sociale. Il concetto di società dell’immagine spiega la nuova dimensione della
comunicazione.
I. Il problema filosofico della trascendentalità alla luce dello sviluppo positivistico
del sapere. La crisi della filosofia.
Il riconoscimento della “crisi della filosofia”,1 che trova i suoi prodromi nell’empirismo radicale di Hume e nel criticismo kantiano per poi ricevere una
decisa sanzione con l’iconoclastia nietzschiana, impone un’indagine sulla
conoscenza che prescinda una volta per tutte da formulazioni unilaterali: s’intende sgomberare il campo tanto dal vecchio obiettivismo (che formula la
conoscenza nei termini di un’adaequatio del soggetto conoscente ad una realtà data), tanto dal soggettivismo di più chiara matrice kantiana, che pretende
di ridurre la conoscenza alle operazioni del tutto soggettive della coscienza,
non riuscendovi peraltro appieno. Si potrebbe anzi affermare che con Kant si
assiste ad una “introiezione” del vecchio obiettivismo, nella misura in cui le
forme della sensibilità e le categorie dell’intelletto costituiscono delle strutture
fisse ed imprescindibili. Non a caso proprio la deduzione trascendentale,
nucleo del trascendentalismo kantiano, scopre un residuo fisso di obiettività
proprio al centro della coscienza: è l’io, l’appercezione trascendentale, principio di una spiegazione “formale” di come accade che la realtà nasca in principio sintonizzata con le capacità della coscienza di percepirla, ma esso stesso
oscuro e indecifrabile.
L’emergere nella seconda metà del XIX secolo della concezione positivistica della scienza va visto come un ritorno al vecchio obiettivismo: con la consacrazione del dato percepibile a unità prima ed assoluta della conoscenza,
non ha più senso una teoria della conoscenza, e in tal modo la filosofia abdica ad una delle tematiche che l’avevano caratterizzata in modo immanente: le
possibilità della conoscenza come misura della verità per una disciplina che
45
46
assume a proprio scopo principale la verità. La fenomenologia di Husserl reagisce alla contraffazione positivistica della filosofia, nella ferma convinzione
che il sapere umano non può trovare altra legittimazione che nell’uomo stesso, nelle operazioni immanenti della coscienza.2 Il positivismo rappresenta il
consegnarsi della filosofia all’operazionismo delle scienze, alla logica del risultato, alla stringente ottica della produttività. Il problema di ciò che può essere
definito vero o falso non è in grado di sostenere il confronto con il problema di
una razionalizzazione della vita comunitaria, che richiede regole di applicabilità di norme e di strategie finalizzate in ultima istanza, che lo si espliciti o meno,
ad un’ottimizzazione delle capacità produttive dell’organismo sociale. Il positivismo si trova dunque nell’imbarazzante situazione (imbarazzante per la filosofia, ma non certo per le scienze) di bloccare la teoria della conoscenza nel
vicolo cieco di una formulazione che l’avvicina in modo deciso ed irreversibile
alla teoria di stampo scientifico, vale a dire ad una teoria che è predeterminata da una prassi intesa in senso tecnicistico ed è vincolata all’obiettivo di un
intervento operativamente “efficace” nella realtà naturale. Da questo errore
non è immune Marx. Anche il padre del comunismo formula le sue teorie a partire dall’aspettativa di un risultato. Ciò lo fa soggiacere, secondo la stessa logica della fallibilità delle teorie scientifiche, al rischio di un’invalidazione delle
analisi del Capitale, rischio che con il fallimento delle prospettive di una rivoluzione che neutralizzasse il capitalismo ha palesato infine tutta la sua realtà.
La prospettiva del risultato, motivata dal potenziale stesso delle forze produttive, dalla crescente capacità dell’uomo di domare le forze naturali, ha condotto Marx a prefigurare un risultato auspicato proprio a partire da ciò che lui,
nella società in cui viveva, aveva identificato come fonte di ogni oppressione.
Con tutto ciò egli ha creduto, ormai irretito in un’ottica di positivismo storico, di
rilevare nella storia umana delle direttive che potessero funzionare alla stregua di determinanti effettuali. L’autoriflessione del marxismo, che matura delle
tappe fondamentali in Lukács e nella scuola di Francoforte, ha portato ad una
rivalutazione del giovane Marx, e alla contestuale rivalorizzazione dell’analisi
teorica, cioè più propriamente filosofica. Il dato empirico è assumibile in questo orientamento come un apporto necessario, in grado certo di convalidare o
all’occorrenza correggere la teoria, ma non al punto da preordinarla, come
nella prospettiva di un risultato da conseguire scientificamente. L’autonomia
relativa della teoria è in fondo un problema di coerenza filosofica, che non può
sussistere laddove l’aspettativa del risultato tenga in ostaggio il pensiero, privandolo della sua indipendenza.
Se la crisi della filosofia, pervenuta (seppur in modo condizionato, nell’opinione di Heidegger ed Habermas) all’autocoscienza con Nietzsche –Nietzsche
che non a caso assume come uno dei principali obiettivi della sua critica proprio
il positivismo– consiste nella cattiva interpretazione della teoria, allora la filosofia della crisi, che muove in molteplici direzioni principalmente da questa raggiunta consapevolezza, dovrà ripartire proprio dalla riproposizione di una teoria
della conoscenza come principale dato epistemologico e criterio metodologico,
cioè esattamente da quell’indirizzo che è da considerarsi, e non solo per quanto riguarda le gnoseologie soggettivistiche, il dato filosofico più caratterizzante.
SAGGI
Il problema di ciò che sia vero o falso non può dunque essere circoscritto
alla sfera unicamente teoretica, ma coinvolge inevitabilmente la morale, le
regole del vivere. Questo è ciò che l’errore del positivismo, di una filosofia
scientificamente intesa, porta a riconsiderare. Il dato pratico del controllo sperimentale dei processi naturali, e cioè l’obiettivo principe di un intervento
umano nella natura diretto al suo controllo, depriva la teoria di ogni slancio filosofico, desautorando ogni intenzione di chiarificazione della verità, nell’unico
ambito possibile di una teoria della conoscenza. Il positivismo reca la testimonianza di come un errato coinvolgimento della filosofia nella prassi snaturi la
teoria in quanto tale, rovesciando il cammino dell’etica, che ora è predeterminata dalla prassi, lungi dal guidarla con la forza delle sue convinzioni.
La consapevolezza di fondo di una teoria che non può essere disgiunta
dalla prassi ha, a ben vedere, sempre percorso la filosofia, anche se esigenze di “sistemazione” del sapere hanno comportato la ripartizione fra i due
ambiti. Così, mentre nella filosofia di Platone non c’è nessuna distinzione tra
conoscenza ed azione, ma la contemplazione delle Idee s’indirizza attraverso
l’opera dei “reggitori-filosofi” alla organizzazione di un sistema politico ideale,
per contro in Aristotele l’agire morale è sottoposto ad una circostanziata analisi. Elemento comune della sapienza greca è comunque, dal bios teoretikós
di Pitagora in poi, la consapevolezza che la conoscenza per la conoscenza è
di per sé un atteggiamento profondamente etico, che non manca alla fine di
ripercuotersi sul vivere individuale e sociale.
Con il positivismo, come per ogni altra teorizzazione di un’agire strumentale, la conoscenza riceve validità e conferma nel risultato. Questo è il peculiare rapporto che esso instaura fra teoria e prassi: la teoria è, precisamente, la
teoria scientifica, e la prassi si riduce al processo di convalida di quella teoria,
a sancire la sua applicabilità futura, nel processo tecnico-tecnologico di addomesticamento della natura ai fini della progettualità umana.
La filosofia di Jurgen Habermas si colloca dunque nell’incerto orizzonte
della filosofia contemporanea, ampiamente delimitato dalla consapevolezza
della crisi dello statuto “fondamentalistico” della filosofia, della sua pretesa di
fondare in modo assoluto il sapere sulla ferma base o di un carattere impositivo della realtà sul soggetto che conosce, ovvero sul carattere formale e regolativo della struttura della coscienza. Si potrebbe dire che sia lo stesso istinto
di sopravvivenza della filosofia, che si può vedere incarnato nel vitalismo di
Nietzsche, a dettarle questa strategia. Nel momento in cui la filosofia, in uno
sforzo di autocoscienza, percepisce la minaccia già ampiamente realizzata di
una sua passiva sussunzione nel meccanismo sistemico della produzione
attraverso l’assorbimento teorico nei canoni del positivismo –che s’incarica di
attuare questo trapasso– essa è costretta a rivedere le proprie pretese nella
direzione di un trascendentalismo condizionato. Ogni volta che la filosofia è
approdata a conclusioni sistemiche ha prodotto una reazione. Il tentativo
hegeliano di assorbire la scienza nella filosofia ha posto fine alla discussione
sul rapporto fra filosofia e scienza, e ha costituito il fermento teorico per l’emergere del positivismo come un’orgogliosa dichiarazione d’indipendenza
della scienza da ogni integralismo filosofico. Già l’evidenza di uno sviluppo
47
48
indipendente della scienza –che si chiariva in particolar modo, con la
Rivoluzione industriale, nello sviluppo delle tecniche produttive– era in grado
di smascherare quell’ambizione della filosofia come ideologia.3
La pretesa dei grandi filosofi di rappresentare l’ultima incarnazione della
filosofia, con allegato il messaggio più o meno esplicito che dopo di loro nulla
più sarebbe stato possibile aggiungere (ciò è particolarmente palese con Kant
e con Hegel), ha comportato ampie oscillazioni nel cammino del pensiero speculativo, tanto più significative quanta era la forza di imposizione degli assunti che si intendevano di volta in volta contrastare. Ma la riapertura del discorso filosofico occidentale ha ogni volta sollevato dubbi su quale potesse essere la direzione da prendere, ponendo il problema di un chiarimento delle metodologie e degli obiettivi, cioè in una parola la questione della autocoscienza
della filosofia.
Risulta conseguente che il processo di revisione della filosofia, dopo la sua
involuzione positivistica, deve essere immanente, deve poter essere condotto
con gli strumenti della tradizione filosofica senza che questi le siano dettati dall’esterno. Vale a dire: la rinascita della filosofia nel segno della sua autonomia
richiede che, per non poter essere più controllata dall’esterno, debba imporsi
essa stessa delle condizioni. Occorre innanzitutto depurare la sua concezione
dalle contaminazioni positivistiche, cioè dalle condizioni che ne hanno determinato un utilizzo strumentale. L’assunto metodologico della fedeltà al dato ha
svolto il compito di attuare in modo graduale questo deleterio sviluppo, rivestendolo di un tessuto ideologico che potesse mascherarlo. Il prodotto finale di
tale processo, condotto con meticolosa cura e spesso senza che i principali
autori potessero avvedersene (l’ideologia si distingue dalla esplicita menzogna
proprio perché si cela anche ai suoi esecutori sociali), è stata la neutralizzazione di quella tipologia di pensiero che proprio la filosofia aveva in custodia.
Completato il percorso, l’illusione si è dissolta ponendo di fronte al risultato
compiuto. Il positivismo si è rivelato per quello che era: il travaglio della filosofia nel partorire un figlio a lei estraneo e che immancabilmente l’ha rinnegata
una volta venuto alla luce. La scienza di concezione galileiana, imbrigliata nella
produzione per effetto stesso della sua vocazione ad un pragmatismo che subordina il lavoro teorico al compito del controllo dei fenomeni naturali, ricava da
sé le proprie regole operative (la verifica delle ipotesi in sede sperimentale), ma
deve lasciarsi guidare quando si tratti della “socializzazione” dei suoi risultati.
Essa ha l’autorità e la competenza per decidere delle procedure specifiche e
nondimeno i mezzi e le risorse le vengono generosamente messi a disposizione, ma non può nulla in merito al controllo sull’applicazione sociale delle sue
conquiste sperimentali. Nel momento decisivo essa non è più padrona del
gioco, ed anzi proprio ora capisce di non esserlo mai stata. Essa può vantare
la piena competenza delle leggi che regolano la natura, ma la traducibilità
sociale dei risultati di laboratorio e le strategie dei fini non le si addicono. Al pari
dell’operaio della catena di montaggio essa non può decidere dell’utilizzo di ciò
che mette a disposizione. Il suo potere di controllo sulla natura si traduce nel
potere che l’industria attua sugli uomini.
Il riduttivismo del positivismo può esser visto come l’ultima fase di un pro-
SAGGI
cesso di reazione alle pretese assolutistiche della filosofia tradizionale. Ma la
mancanza di un’autocoscienza che assumesse la guida di questo processo di
revisione ha determinato la neutralizzazione della riflessione sui fini all’interno
della filosofia (riflessione che è ancora presente in Comte, pioniere inconsapevole di questo nuovo corso), e il trionfo della ragione strumentale, che ben
presto non si distingue più dall’uso “produttivo” della scienza.
La riflessione sulla crisi della filosofia, che è quindi anche la riflessione sulla
crisi della nostra epoca, è stata condotta di volta in volta in termini diversi. In
Marx lo statuto epistemologico della filosofia si limita ad un valore di posizione funzionale, per quanto importante. La critica al filantropismo filosofico di
Feuerbach è condotta alla luce di un’idea di filosofia che coincide con la prospettiva del suo superamento, in direzione di una prassi trasformatrice. Il confronto con la tradizione filosofica è presente, e può aver funto da spinta emotiva per l’inedita affermazione di uno statuto pragmatico-sociale della filosofia,
ma non va oltre e si addentra senza soluzione di continuità nel suo nuovo
obiettivo, immergendosi nelle problematiche concrete. Il proposito di un superamento della filosofia fa tutt’uno con il primato dell’oggetto, fino al momento
in cui la tensione verso la prassi non conduce Marx a ridurre la teoria al rango
di leggi storico-effettuali di un evoluzionismo economico-sociale, corrompendo
l’equilibrio che la legava alla teoria e orientando l’indagine verso la base positivistica di una soluzione rivoluzionaria delle ingiustizie sociali che è possibile
prevedere con margini di esattezza scientifica. Il “positivismo” di Marx è riconosciuto anche da Habermas a partire dal suo particolare punto di vista, che
interpreta le varie manifestazioni del positivismo (tanto nelle scienze naturali
come nelle scienze sociali) alla stregua di deficit nell’applicazione di una teoria della conoscenza, la quale ogni volta è più o meno intenzionalmente sacrificata ad un’ottica oggettivistica: “Marx non ha mai discusso esplicitamente il
senso determinato di una scienza dell’uomo intesa come critica dell’ideologia
nella sua differenza col senso strumentalistico di una scienza della natura.
Sebbene egli stesso abbia stabilito la scienza dell’uomo nella forma della critica e non come scienza naturale, propende sempre a collocarla dalla parte
delle scienze naturali. Egli non ha mai ritenuto necessaria una giustificazione
della teoria della società dal punto di vista di una critica della conoscenza.”4
Tutto ciò si lega al ruolo che la categoria materialistica del lavoro assolve nella
dottrina marxiana come produttrice di storia. La categoria del lavoro rappresenterebbe un’ipoteca naturalistica sul processo di interpretazione delle dinamiche sociali, perché il lavoro produce la storia modificando il rapporto dell’uomo con la natura; le forme della società scaturiscono dai mutamenti nei
rapporti di produzione, che hanno le proprie fondamenta nelle diverse modalità con cui si da nella storia il rapporto dell’uomo con la natura. Nondimeno,
questo pregiudizio naturalistico condizionerebbe pesantemente il processo di
autocoscienza del soggetto sociale, che non può prescindere dal suo collocamento nella costellazione di rapporti sociali materialisticamente intesi e nemmeno, contestualmente, dal compito che la dottrina gli assegna.
Dopo l’esito positivistico dello sviluppo filosofico, si è resa necessaria una
ridiscussione della metodologia filosofica che assolvesse nel contempo lo
49
50
scopo di ridefinire il senso della riflessione filosofica rapportandolo al suo contenuto più propriamente umano. La fenomenologia di Husserl ricorda che la
filosofia è una questione umana; essa ha a che fare con il senso delle esperienze e con quei fini che una filosofia positivisticamente intesa non è in grado
di riconoscere e valorizzare. Il valore socialmente terapeutico di una filosofia
correttamente intesa è implicito nel riconoscimento che con la corruzione dell’esperienza umana, per effetto della ritraduzione quantitativa del sapere
attuata dalla scienza moderna, si prepara un destino di crisi che coinvolge
assieme alla natura del sapere anche la genuinità del rapporto dell’uomo con
il mondo e con i suoi simili.
Habermas ripropone la fedeltà ad un indirizzo pragmatico della filosofia,
vincolando il discorso metodologico ad una prassi sociale. Anche la sua filosofia, come quella di Husserl, si rivolge alla valorizzazione di un ambito originario dell’esperienza, il “mondo della vita”. La metodologia del discorso si
arricchisce per tal via di una dimensione etica che il positivismo rinnegava
assieme alla dimensione umana, privilegiando in modo esclusivo la procedura monologica della definizione delle proposizioni denotative, che si richiamano all’assunto dell’indiscutibilità del dato come principio formale della ricerca
scientifica. Con la sottrazione del lato soggettivo della discussione scientifica
a buona ragione il sapere scientifico può definirsi “oggettivo”, ma rinunciando
alla verifica per via argomentativo-razionale delle sue proposizioni di base,
rinunciando cioè ad un confronto intersoggettivo sui suoi criteri fondativi, esso
diventa nient’altro che l’intrattenersi del metodo con se stesso: il suo “monologo”. Manca il momento della problematizzazione, un approccio dubitativo che
si estenda oltre la verifica della corrispondenza di una proposizione con il fatto
osservato. La scienza deve tornare a fondarsi su presupposti umani: solo quel
fondamento intersoggettivo che la riflessione sul “mondo della vita” mette a
disposizione può liberare il campo dagli equivoci e prevenire l’azione che elementi perturbatori possono esercitare sulla ricerca della verità.
Nel positivismo la conoscenza coincide con il metodo, ed è legata al conseguimento di un’efficacia strumentale: “Ogni storia informa dei fatti e dei destini di un soggetto, siano essi fatti e destini attraverso i quali esso solo si costituisce come soggetto. La teoria della scienza però si sbarazza del problema del
soggetto conoscente; essa si orienta direttamente alle scienze che sono date
come sistemi di proposizioni e modi di procedere; possiamo anche dire: come
un complesso di regole secondo le quali le teorie vengono costruite e verificate. Per una teoria della conoscenza ridotta a metodologia, i soggetti che procedono secondo queste regole perdono la loro importanza: i fatti e i destini
appartengono semmai alla psicologia dei soggetti della conoscenza, abbassati a persone empiriche –per la spiegazione immanente del processo della conoscenza non spetta loro alcun peso.”5 La dottrina degli elementi di Mach rappresenta l’esempio più eclatante di come tra l’altro l’obiettivismo del positivismo
porti all’esito paradossale di un rinnovato ed insospettabile idealismo, collegato al ripresentarsi della problematica kantiana della cosa in sé.6
I.2. Nel suo contributo alla disputa fra positivisti e dialettici nel congresso di
sociologia di Tübingen del 1961,7 Habermas sostiene l’indirizzo dialettico sotto-
II. Jurgen Habermas:
l’“agire comunicativo” interpreta la corruzione dell’identità sociale
Occorre chiedersi quanto la teoria dell’agire comunicativo e l’etica del discorso che ne costituisce uno sviluppo riflessivo possano di per sé esprimersi in modo adeguato attorno a ciò che la società è realmente. E, contestualmente, secondo anche quelle che sono le intenzioni dell’autore, in che misura
e secondo quali pretese di legittimità essa si candida ad essere un coerente
sviluppo della critica sociale di stampo tradizionale. Habermas, come già anticipato, ha piena coscienza del carattere condizionato della riflessione filosofica, della sua crisi. Il confronto con la realtà sociale, nella sua dimensione epocale, non può non costringere a rivedere il ruolo della filosofia, soprattutto in
considerazione di una situazione che ha comportato un oscuramento del suo
ruolo. Se la filosofia ha subito in modo pesante il condizionamento della società al punto da essersi dissolta nel sapere scientifico-strumentale, le sue pretese vanno riviste alla luce di questo condizionamento, non per ratificare il
ruolo che la società le ha imposto, ma al contrario per recuperarne il senso alla
luce di una revisione critica che deve tener conto di ciò che è la società nella
nostra epoca. Una nuova concezione della filosofia sarà tanto più coerente e
plausibile quanto più diretto sarà il contatto con quella realtà sociale che ne
SAGGI
lineando le contraddizioni alle quali va incontro una sociologia che pretende di
analizzare le configurazioni e le dinamiche sociali nella modalità di un approccio naturalistico. Se nel campo delle scienze naturali un approccio obiettivistico
ha ancora una ragione d’essere, nel panorama delle scienze umane la mancata maturazione di una teoria della conoscenza si fa sentire con gli esiti più paradossali: il soggetto conoscente non può infatti prescindere da quella che è la
sua posizione all’interno dell’oggetto che vuole indagare. Non sussistono le
condizioni ideali per un’indagine di tipo osservativo: il soggetto conoscente
deve interpretare anche la sua posizione all’interno dell’organizzazione sociale
che esamina. Allo scienziato sociale manca proprio l’intima consapevolezza
della complessità di ciò con cui ha a che fare, e con questa anche la coscienza che la società, intesa come totalità, opera al suo interno, e lui ne è parte integrante. Egli rimane vittima della sfera immanente delle coazioni sociali, tanto
più quanto rinuncia al compito di riflettere sulla propria attività. Se l’oggetto nelle
scienze naturali è vittima passiva delle intenzioni manipolative dell’uomo-scienziato, nelle scienze sociali si attua quella che Habermas definisce la “vendetta
dell’oggetto”.8 L’autoriflessione della scienza sociale deve condurre alla sua critica, alla coscienza della sua pre-comprensione nel sistema che analizza.
Escludere il soggetto conoscente dalle dinamiche oggettive (e viceversa) significa equivocare sulla natura di queste, e applicare alla ricerca un riduttivismo
che la rende particolarmente adatta ad un suo utilizzo strumentale. La sociologia che considera la società degli uomini come un oggetto della natura alla stregua delle scienze naturali offre il destro alle forze del condizionamento sociale
e diventa essa stessa parte di questo piano.
51
52
ridefinisce arbitrariamente le competenze. Allo stesso modo ciò deciderà dell’efficacia o al contrario del carattere ideologico dei rimedi proposti.
La teoria dell’agire comunicativo risponde alla crisi della filosofia riscoprendo la trama genuinamente intersoggetiva della comunicazione, che si
annuncia nella forma della partecipazione di più individui ad un discorso nel
quale ognuno può avanzare pretese di validità che possono essere accolte o
rifiutate in merito alle loro capacità di imporsi di fronte al giudizio raziocinante
degli altri partner, in una situazione che deve rispecchiare il più possibile le
condizioni di un rapporto libero da interferenze interne ed esterne. Così “non
è più privilegiato quell’atteggiamento oggettivante, in cui il soggetto conoscente si orienta verso se stesso come ad entità nel mondo. Nel paradigma
dell’intesa è fondamentale piuttosto l’atteggiamento performativo dei partecipanti all’interazione, che coordinano i loro piani d’azione, intendendosi reciprocamente su qualcosa del mondo.”9 Il criterio della verità viene riportato,
dopo l’equivoco positivista, alla dimensione più propriamente umana. La verità e la pretesa di validità di un assunto sono subordinate ad una negoziazione per via argomentativo-razionale. Questa ipotesi di soluzione sembra tener
conto del “corto-circuito” nel quale il sistema delle relazioni interpersonali è
incorso con i nuovi sviluppi della comunicazione di massa, così come dell’interferenza esercitata dai grandi agenti della mediazione sociale (il potere e il
denaro), come illustrato nella teoria parsonsiana dei media, che Habermas
tiene in gran conto. La filosofia s’incarica di precisare le condizioni nelle quali
sia di nuovo possibile pervenire ad una libera contrattazione di significati, aldilà di quelli che quotidianamente vengono imposti ai soggetti dagli agenti sistemici della mediazione sociale e dagli organi della comunicazione di massa. Il
riconoscimento di questa sfida segna il punto d’intersezione fra la teoria etica
e la teoria critica della società. L’elemento intersoggettivo e dialogico nel quale
si muove la discussione sulla validità dei principi normativi è già di per sé un’apertura alla critica sociale, nella misura in cui la messa a punto di una metodologia del confronto veritativo porta al riconoscimento di ciò che nella società può distorcerlo fino a corromperlo.
Questi elementi estranei possono penetrare naturalmente nella discussione e inficiare un’argomentazione la quale da parte sua deve conoscere come
unico criterio direttivo e come esclusivo principio di verifica e convalida l’istanza dell’“argomento migliore”. Il concetto di verità viene dunque rielaborato
secondo criteri procedurali suscettibili di problematizzazione e verifica. Viene
liberato il campo da ogni pretesa assolutistica di verità, senza però rinunciare
a un criterio fondativo: solo che questo si pone a giustificazione della discussione sulla verità, più che su una verità presupposta come tale.
L’universalizzazione è quindi legata all’aspetto procedurale, e non si riferisce
a contenuti specifici. La fondazione ha cioè basi pragmatiche, si fonda su presupposti pragmatici, e concerne le condizioni pragmatico-trascendentali di
ogni discorso possibile. È l’argomentazione in genere, con i suoi presupposti,
l’unica struttura che noi possiamo presupporre, e di cui pure lo scettico deve
ammettere la presenza nel momento stesso in cui prende parte dal suo punto
di vista alla discussione, pena il coinvolgimento in una “contraddizione perfor-
SAGGI
mativa” (come osservato da Apel).10 Il principio di universalizzazione come
regola principale di una logica dell’argomentazione rende possibile l’etica del
discorso perché è implicito nei presupposti dell’argomentazione in genere, di
quell’agire comunicativo (il mondo della vita, sostrato di ogni agire umano) del
quale il discorso costituisce una delucidazione riflessiva. Queste regole del
discorso, va precisato, non hanno una natura convenzionale, ma sono dei presupposti inevitabili. Tutti noi siamo pronti a riconoscere che il confronto dialogico poggia su delle condizioni imprescindibili: regole logico-semantiche (l’assenza di contraddizioni nel discorso del parlante, la coerenza nell’attribuzione
di un medesimo predicato a soggetti equivalenti nei loro aspetti rilevanti, la
necessità da parte dei partecipanti di attenersi ad un’univocità nel rapporto fra
i significati e le loro espressioni); regole di carattere procedurale, sul cui piano
inizia a prender corpo la ricerca dell’argomento pragmatico-trascendentale,
nella misura in cui vengono qui precisate le direttive di “ricerca cooperativa
della verità organizzata come gara” (il presupposto di un riconoscimento della
buona fede dei partecipanti, in un complesso di norme che palesa un sostanziale carattere etico); regole legate all’aspetto processuale (la necessità fondante di garantire le pari condizioni nel confronto, preservandolo da coazioni
di carattere repressivo).11
Il principale strumento di connessione della teoria della comunicazione con
la teoria sociale è per Habermas rappresentato dall’interesse della conoscenza all’emancipazione. La teoria sociale tiene conto dei risultati della teoria del
linguaggio. Già Peirce e Dilthey avevano prospettato nei rispettivi campi d’indagine degli interessi che animano la ricerca, ma ciò in modo parziale e quindi insostanziale. Il pragmatismo identifica nell’agire controllato nel risultato
come procedura della scienza l’interesse al controllo tecnico della natura,
mentre l’ermeneutica è orientata da un interesse pratico-umanistico: l’interpretazione del linguaggio e delle operazioni quotidiane. In entrambi i casi però
fa capolino uno sviluppo obiettivistico, che risulta dal difetto di un’impostazione di tipo trascendentalistico. Peirce non distingue in modo chiaro fra il dato di
fatto e il modo umano della disposizione tecnica della natura (assimilabile al
distinguo heideggeriano fra essente ed essere).12 Dilthey, nello sforzo di connotare in modo sufficientemente “scientifico” le proprie riflessioni, rimane irretito in una visione positivistica della realtà e il promettente elemento dialogico
e intersoggettivo della sua analisi viene vanificato dal concetto di “penetrazione simpatetica”: l’esame del testo autobiografico, per dare spunto a conclusioni che si vogliono il più possibile “scientifiche”, richiede l’oscuramento della
personalità dell’interprete, nella scrupolosa osservanza del criterio positivistico dell’avalutatività. L’interprete viene investito del ruolo dello scienziato dei
fatti umani e per lui “rivivere” non deve essere altro dall’“osservare”. Un indirizzo di confronto paritetico con il contenuto umano di un testo tramandato
comprometterebbe l’oggettività dell’analisi, che è invece conservata nella
misura in cui un dialogo a distanza viene convertito in una procedura di attenta osservazione di dati. Ancora una volta lo spirito del positivismo è veicolato
da un particolare concezione di verità, che si adotta per decidere ciò che attenta alla validità di una ricerca: “Certamente, se noi descriviamo così i pericoli
53
54
dell’oggettività, abbiamo già assunto la prospettiva di quella teoria del rispecchiamento della verità che il positivismo ci vorrebbe suggerire con il modello
dell’osservazione controllata”;13 modello che si può ammettere per le scienze
naturali, ma che fa sentire tutta la propria inadeguatezza nel confronto con i
fatti umani, tanto nell’interessamento agli aspetti della vita individuale che
nella disamina delle dinamiche sociali. Già il concetto di “interpretazione” si
lega al fattore umano e alla inevitabile precarietà di un punto di vista che si
trova ad essere, volente o nolente, coinvolto e compreso nell’oggetto a cui si
dedica.
Gli interessi che le filosofie di Peirce e Dilthey portano all’attenzione risentono per Habermas del carattere particolaristico della loro filosofia. Ciò che
essi non arrivano ad individuare è l’interesse della conoscenza in quanto tale,
l’interesse della conoscenza per la conoscenza, cioè l’interesse della ragione
all’emancipazione. Ciò che manca alla metodologia dei due filosofi è il principio di autoriflessione della scienza, essenziale per riscontrare l’identità della
conoscenza con l’interesse.14 L’interesse inteso come emancipazione trova la
sua prima formulazione in Fichte. La paternità di questa intuizione è attestata
dalla famosa frase della Prima introduzione, nella quale si prospetta l’appartenenza dei diversi modi di fare filosofia ad altrettanti caratteri della personalità.15 La riflessione filosofica non è immune dalla volontà, ma ne è un fedele
derivato. Con ciò è abbattuta la differenza fra atteggiamento teoretico è atteggiamento pratico: la filosofia è animata da interessi; l’interesse non è un’interferenza nel cammino della verità, ma un impulso che testimonia della forza
che accompagna la ricerca della stessa. Fichte per primo libera la filosofia dal
contemplativismo della tradizione classica, che si ripresenta sotto mentite spoglie nello scientismo positivista e riconcilia la teoria con l’ambito vitale, che non
è più inteso come un elemento perturbatore.
Con la psicanalisi secondo Habermas la scienza perviene ai tratti di un’autocomprensione critica. La psicanalisi testimonia in modo perfetto della natura
dubitativa di ogni discorso veritativo. La ricerca della verità assolve uno scopo
terapeutico e la chiarificazione dei processi emotivo-cognitivi rimossi fa tutt’uno
con il carattere procedurale della terapia. Non a caso la portata di verità della
psicanalisi viene meno nel momento in cui Freud, negli scritti della maturità, sviluppa la sua dottrina in un sistema sacrificando l’aspetto procedurale, con il
quale la psicanalisi era nata, e che aveva fornito il materiale per la successiva
opera di sistemazione, a vantaggio di un insieme statico e descrittivo. La natura primigenia della psicanalisi si rivela nel suo carattere dinamico e processuale: essa parla di sé nel momento in cui agisce e non si lascia volentieri condensare in una visione strutturale o in una metodologia non vivificata da contenuti. Ciò comporta senz’altro una limitazione all’autoriflessione della scienza,
che pure Freud aveva avviato con sufficiente cognizione di causa e che non è
portata a maturazione a causa dell’ipoteca positivistica che grava sul fondatore della psicanalisi fin dall’inizio: “Al livello dell’autoriflessione non può certamente esserci, a differenza che nella logica delle scienze della natura e dello
spirito, una metodologia separata da contenuti materiali, perché la struttura
della connessione conoscitiva coincide con quella dell’oggetto da conoscere”.16
SAGGI
A differenza di Dilthey, la psicanalisi non mira a ricostruire le trame di una
vita dal punto di vista di un’ermeneutica letteraria, ma nasce dall’intuizione del
carattere costitutivo di deformazioni che si riconoscono socialmente provocate e che intaccano la personalità dell’individuo dissociandolo da una comunità
che fa sentire la sua autorità nel momento in cui impedisce ai suoi soggetti di
essere se stessi. L’interiorizzazione dei processi di coazione sociale sposta il
problema dalla sfera inessenziale della ricostruzione del senso di ciò che è
coscientemente inteso alla dimensione non saputa di un’interiorità socialmente rinnegata. Le deformazioni nel testo della vita non dipendono da un difetto
di trasmissione, ma si estendono oltre la dimensione del mezzo. Esse non
hanno carattere di accidentalità, perché il processo di interiorizzazione sancisce il loro carattere strutturale: “Le omissioni e le deformazioni che essa toglie
hanno un valore di posizione sistematico; infatti le connessioni simboliche che
la psicanalisi cerca di cogliere sono rovinate da interventi interni. Le mutilazioni hanno un senso come tali.” La ricomposizione della vita dunque è qui un
ricucire il tessuto di un’esistenza intimamente lacerata, e ciò evoca la radicalità della critica, che deve unire “l’analisi linguistica con la ricerca psicologica
di nessi causali.”17 È relativamente semplice istituire un parallelismo fra psicanalisi e agire comunicativo, in quanto quest’ultimo traspare dalla stessa tecnica analitica. Inoltre, l’“interesse” del paziente per la guarigione è presupposto
per la riuscita della terapia stessa, più che essere una semplice occasione per
la sua applicazione.18 La riuscita dipende poi dalla presa di coscienza da parte
del paziente della radicalità del suo male, che non può essere risolto da una
semplice cura di tipo sintomatico: il paziente deve farsi carico di una responsabilità verso la malattia e quindi assumere un preciso atteggiamento etico.19
Per finire, il medico deve porsi nei confronti del paziente su un piano di “partnership”, per installare la coazione nevrotica a ripetere all’interno del meccanismo del transfer, che richiede, al contrario dell’ermeneutica letteraria di
Dilthey, una partecipazione controllata della soggettività del medico.20 Il medico, potremmo aggiungere, non deve nemmeno atteggiarsi ad educatore, perché ciò comporterebbe un dislivello nel confronto, che ripresenterebbe i termini della trasmissione per via esogena di contenuti prescrittivi, compromettendo il confronto sul piano del libero agire comunicativo. La guarigione richiede la ferma presa di coscienza responsabile da parte del paziente del proprio
coinvolgimento nella riproduzione interna della malattia: i meccanismi deformativi fanno parte del suo mondo interiore, e costituiscono un ostacolo che il
soggetto stesso erige alla comprensione di sé. Proprio per questo la psicanalisi deve creare le condizioni per un’autoriflessione che incoraggi il paziente a
farsi soggetto di se stesso. Il soggetto conosce l’oggetto solo riconoscendosi
in esso; solo per questa via egli può liberarsi dalle proprie oggettivazioni patologiche e ricomporre la sua unità di soggetto, diventando a tutti gli effetti il principale interprete della propria esistenza.21
Da quanto riferito, risulta evidente che le conclusioni di Freud a livello di
psicologia individuale si debbano ampliare al sistema sociale nel quale sono
inscritte. Il concetto di normalità è un’elaborazione della società, e quindi
risente delle vicissitudini a cui una comunità va incontro nella sua evoluzione
55
storica. Freud non esclude l’ipotesi, poi ricalcata da Eric Fromm, 22 che un’intera società possa essere “malata”. E a questa radicale conclusione lo portano in modo esplicito le precise indicazioni eziologiche sottese all’intera sua
riflessione: Il disagio della civiltà riflette in chiave socio-evolutiva ciò che era
già implicito nel quadro della diagnostica individuale; è la società nel corso
della sua evoluzione verso la civiltà a generare nell’individuo la malattia, nel
momento in cui innalza una barriera allo sviluppo di uno stile di vita da una
serie di impulsi naturali non compatibili con i suoi obiettivi di autoconservazione. La società, osserva Habermas, viene irretita in un processo di riproduzione della nevrosi, nel quale la coazione a ripetere, che “blocca” l’individuo sul piano pratico e linguistico, cristallizza l’azione e la comunicazione
sociale su patterns circoscritti, riproducendo in un circuito chiuso quei meccanismi autoritari che consentono la custodia del quadro istituzionale: “Come
la coazione a ripetere dall’interno, così la costrizione istituzionale provoca
dall’esterno una riproduzione di comportamento uniforme, sottratta alla critica e relativamente rigida.”23
III. Teoria critica e realtà sociale:
il potere “trascendentale” del denaro in una società disumanizzata
56
Il pensiero di Habermas è stato soggetto a diverse critiche. Il suo intervento al congresso di sociologia di Tübingen era inteso a difendere la posizione dell’impiego della dialettica nel quadro delle scienze sociali, ma la direzione intrapresa, cioè la valorizzazione della possibilità di una comprensione
pratico-normativa del sociale, “avrebbe sempre più ridimensionato, e in prospettiva anche abbandonato, qualsiasi riferimento alla dialettica.” 24 La dimensione del dialogo punta a definire scrupoli metodologici volti a garantire le
condizioni dell’accertamento della verità e prospetta la creazione di “condizioni ideali” in sintonia con quelle che sono le regole dell’argomentazione in
generale, che è compito del discorso individuare riflessivamente. Ma per tale
via Habermas abdica necessariamente a quella radicalità della critica sociale che è un tratto distintivo nella concezione della dialettica di ispirazione marxista e quindi anche dell’originaria “teoria critica”. La “svolta linguistica” degli
anni Settanta opera nel senso di un deciso allontanamento dalle posizioni tradizionali della scuola di Francoforte. Le critiche più incisive vertono sulla difficoltà di fondare un processo di ricomposizione della razionalità sociale sul
piano di un semplice agire comunicativo. Il confronto fra la teoria dei sistemi
di Parsons e un “ambito vitale” svolto in chiave pratico-linguistica sembra
rimanere sospeso in un dualismo, nel momento in cui non viene risolto.
Questo è il senso della critica mossa a Habermas dal sociologo inglese
Anthony Giddens25: il riconoscimento di come i media strutturali del potere e
del denaro arrivino a “colonizzare il mondo della vita” dovrebbe portare ad
una strategia di intervento volta a modificare il complesso monetario-burocratico, invece che a pronunciarsi candidamente sulla sua immodificabilità di
struttura vincolante delle relazioni sociali. Come è possibile dichiarare la
SAGGI
necessità di preservare l’originario comunicativo e nello stesso tempo precludersi ogni possibilità di una prassi efficace dichiarando per la struttura l’inoppugnabile perentorietà di ciò che è dato? La possibilità di modificare i
sistemi non è presa in considerazione da Habermas. La critica di Giddens è
solo una fra altre dello stesso indirizzo e tenore.
In realtà, può sembrare, fuori da ogni sarcasmo, che Habermas voglia in
un certo qual modo “dialogare” con una realtà di cui pure riconosce la drammaticità e la necessità di farvi fronte. Nel volume secondo di Teoria dell’agire
comunicativo la presa di distanza da Marx non potrebbe essere più risoluta,
perché corrisponde al tentativo di spiegare il feticismo non attraverso la teoria
del valore, ma con l’impiego della teoria sistemica di media. Il feticismo nelle
relazioni sociali non è più prerogativa del processo di valorizzazione del capitale, attraverso l’astrazione dal lavoro vivo, ma fa leva su “un livello avanzato
di differenziazione sistemica a titolo proprio.”26 Il passaggio da una spiegazione della reificazione dei rapporti sociali mediante la teoria del valore ad una
che invece pone l’accento sull’interferenza dei media nei processi discorsivi
comporta un indebito snellimento nell’interpretazione dei fenomeni sociali, a
scapito della lungimiranza dell’analisi sociologico-critica, che disconosce le
sue radici dialettiche. La teoria dei media registra solo l’esito di un processo
senza indagarne le determinanti, e quindi ne sottovaluta la portata. Ciò è forse
un risultato della sopravvalutazione del linguaggio, a detrimento degli aspetti
autenticamente “vitali” dell’esistenza umana. Gli autori della Scuola di
Francoforte fanno proprio l’annuncio di Lukács che “la vita non vive”: la teoria
del valore non può essere abbandonata senza che ciò comporti la sottovalutazione delle reali dimensioni del processo di reificazione. L’immediato esito di
un rinnegamento di questa chiave interpretativa non può che essere l’obnubilamento della prospettiva della totalità sociale, che va invece tenuta sempre
presente, e la ricaduta in un particolarismo fatto di distinguo: la ricaduta nel
descrittivismo della sociologia empirico-formale. Ciò è comprovato dalla distinzione attuata da Habermas sulla linea di Parsons fra denaro e potere, una
distinzione che la teoria del valore-denaro di Marx non ammette: per Marx il
denaro nella società capitalistica costruisce l’identità degli individui e plasma il
vivere sociale. Le conseguenze teoriche di questa distinzione non tardano a
farsi sentire, assieme al loro carattere compromettente. L’adozione della teoria dei sistemi al posto della teoria del valore, con il correlato di una separazione del denaro dalla sua essenza di potere, porta Habermas ad appoggiare
la tesi che i due media così individuati non siano di per sé reificanti, pur sostituendosi al linguaggio nella sua funzione di coordinamento delle azioni
umane: “da ciò non scaturiscono, come nella trasformazione dal lavoro concreto in lavoro astratto, eo ipso effetti reificanti. L’adattamento a un altro meccanismo di coordinamento delle azioni e quindi a un altro principio di socializzazione avrà piuttosto come conseguenza una reificazione, ovvero una deformazione patologica di infrastrutture comunicative del mondo vitale, soltanto
nel caso in cui il mondo vitale non può ritirarsi dalle funzioni coinvolte; nel caso
in cui non può cedere in modo indolore queste funzioni, come sembra verificarsi nella riproduzione materiale, a sistemi di azione controllati da media.”27
57
58
Il processo di autocoscienza della soggettività borghese non conosce una
fase discorsiva, in rapporto ad un agire comunicativo preso come riferimento
fondamentale, ma si radica nel processo di accumulazione del denaro, che
nell’ultima fase del capitalismo arriva a caratterizzare ogni aspetto del comportamento sociale, attuando appieno quel carattere astrattivo che la teoria
marxiana del valore aveva individuato come fondamento dinamico della riproduzione del modo di vivere borghese. La teoria marxiana del valore si estende oltre le dinamiche della lotta di classe, che in realtà riguardano solo la prima
fase del capitalismo, quella nella quale esso era costretto ad escludere una
porzione della società, non essendovi le condizioni per dispiegare un potenziale assimilativo che comunque il carattere “astratto” del denaro lasciava presagire sia a livello estensivo che intensivo. Nel momento in cui si realizzò un
progressivo miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti,
dovuto a meccanismi di autoregolazione interni e all’azione dei sindacati, il
capitalismo poté far leva sulla stessa logica di distribuzione delle risorse del
marxismo operaio per mettere a sopire in modo sempre più perentorio i fermenti di contraddizione interna, fino al punto che questi divennero prerogativa
di qualche individualità illuminata. Il denaro cioè poté acquietare ogni spunto
di critica che si muovesse nel perimetro della sua logica senza mettere in discussione la realtà del suo potere sociale. Fu così possibile attuare un processo di decisa “borghesizzazione” del mondo occidentale, a dispetto di chi, come
Marx, prevedeva un incremento del valore di posizione del proletariato nel
quadro sociale, fino al trionfo rivoluzionario.
La dialettica della merce, per come è descritta da Marx nel primo libro del
Capitale, individua la forma “denaro” come suo ultimo stadio; ed esso è
appunto forma, principio motore della trasformazione sociale, secondo una
dialettica che il giovane Marx seppe delucidare mettendo a disposizione della
teoria sociale una chiave di lettura decisiva. Il risultato di questa dialettica è
l’assoluto potere di mediazione che il denaro riveste nei rapporti sociali e il suo
esclusivo diritto di veto nella definizione del nuovo soggetto umano:
Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che io posso pagare, ciò che
il denaro può comprare quello sono io stesso, il possessore del denaro medesimo. Quanto grande è il potere del denaro, tanto grande è il mio potere. Le caratteristiche del denaro sono le mie stesse caratteristiche e le mie forze essenziali,
cioè sono le caratteristiche e le forze essenziali del suo possessore. Ciò che io
sono e posso, non è quindi affatto determinato dalla mia individualità. Io sono
brutto, ma posso comprarmi la più bella tra le donne. E quindi io non sono brutto,
perché l’effetto della bruttezza la sua forza repulsiva, è annullata dal denaro.28
E ciò vale per ogni qualità dell’uomo, che in una società dominata dal denaro si definisce in base alla disponibilità dello stesso. Ne consegue che una
società dominata dal denaro è una società fondata sull’ideologia e la menzogna. Un processo di chiarimento che si proponga di recuperare la realtà delle
cose non può prescindere da ciò che ha determinato l’allontanamento da questa, non può non confrontarsi col potere di astrazione che il denaro come eminente forma di regolazione dei rapporti sociali rappresenta, e che ripropone a
SAGGI
livello totalizzante la forma “valore” nel suo prescindere dalla realtà del lavoro
vivo e dalle qualità materiali di ciò che questo produce. Il denaro è questa
forza smaterializzante della merce, è il momento nel quale essa, liberatasi da
ogni potere di ricatto della realtà (lo scambio delle merci implica un interessamento al loro potenziale di utilizzo, che fa leva sulle loro proprietà concrete) si
fa forma pura e può accedere alla dimensione dello spirito colonizzando ogni
aspetto della vita sociale, dalla cultura alla trasmissione delle informazioni fino
al più basilare scambio intersoggettivo. C’è secondo il nostro punto di vista
una linea di evoluzione storico-dialettica che unisce la teoria del valore nella
sua originaria formulazione alla nascita della società dell’industria culturale
descritta dagli autori della Scuola di Francoforte; una linea di evoluzione che
segue lo sviluppo del capitalismo fino al massimo dispiegamento dei suoi presupposti categoriali, che avviene con la società dello spettacolo di Guy
Debord.29 Secondo la realistica visione del pensatore francese nulla rimane
fuori dal gioco del denaro, ed anche il potere politico è soggetto a ridursi a funzione di un sistema che impone le proprie leggi. Questa lettura non autorizza
a pensare alla struttura del potere politico e burocratico come a qualcosa di
distinto dalla logica della produzione; a questo proposito il concetto di lobby (e
il peso che esso assume nella vita politica della maggiore fra le democrazie
–l’America–) dovrebbe fornire una indicazione vincolante.
In una situazione di questo tipo ogni potere di contrattazione non può
riguardare la verità, ma semplicemente l’accezione alla quale il senso comune conduce: le decisioni a proposito di interessi economici. In una società
organizzata corporativamente, tutte le discussioni d’ambito pratico possono
portare solo ad una convergenza attorno ad interessi particolari. Solo su questo piano è possibile effettivamente pervenire ad un accordo: quando si tratta
di affari, come recita la mentalità comune, ci può sempre essere un accordo.
Come insegna Habermas, lo scambio comunicativo può avvenire solo a
condizione di una equipollenza di ruoli e funzioni; ogni partecipante al discorso
deve vedere garantito il proprio diritto ad esprimere il suo punto di vista, a contare sulla buona fede e sulla sincerità degli altri, a non essere trascinato a conclusioni che altrimenti rifiuterebbe da un atteggiamento autoritario. Se lo scambio non avviene su un piano di uguaglianza, ma su un dislivello che nasce dalla
posizione autoritaria di uno o più partecipanti, la verità non si produce. In questo modo si può avere solo un accordo fra contraenti, cioè un accordo sui
rispettivi interessi, una soluzione di compromesso fra due posizioni idealmente
inconciliabili. In una società che ha perso di vista la verità di ogni oggetto, perché essa stessa si è autoistituita come realtà oggettiva, non si vede come una
qualsivoglia relazione destinata a pervenire ad un’intesa non debba soggiacere a queste condizioni. Lo stato di cose non lascia intravedere le possibilità dell’applicazione di una logica del discorso, perché la logica è decisa su un altro
terreno. La logica propriamente umana è destituita dalla logica degli interessi
particolari. Ogni aspetto del conoscere umano è inviluppato nell’interesse alla
salvaguardia della posizione economico-sociale di chi ne interpreta le funzioni,
e se possono esserci dei conflitti in merito alla questione della conquista dei
mercati (concorrenza), a monte è possibile individuare una convergenza di
59
60
sostanza: l’interesse privato come categoria a sé stante. Ogni considerazione
del lato umano ed etico di una faccenda soccombe al riconoscimento di una
legge che da Smith in poi si è impressa anche nelle menti delle inconsapevoli
e silenziose vittime del capitalismo: la legge del profitto, che nella società del
denaro è la legge della sopravvivenza. La vita dell’uomo è sempre stata governata da interessi, ma questi facevano leva su un concetto materiale di sopravvivenza e non configuravano una legge dell’accumulazione di denaro estesa
socialmente, nella stessa misura indicata dallo studio marxiano sulle società
precapitalistiche e dal suo riferimento al valore d’uso dei prodotti del lavoro
umano. È inevitabile che ogni discorso su un governo pratico della società non
possa che cadere in ultima istanza dal lato degli interessi che in essa sono rilevanti. Quello degli interessi è un meccanismo invincibile, che con il perfezionarsi della società capitalistica ha assunto l’identità di un automatismo sociale.
In questo senso la società capitalistica ha una capacità di autoregolazione: non
certo nel senso prospettato da Smith, che fa riferimento alla legge della domanda e dell’offerta e alla capacità del sistema di mantenere vivo in sé lo spirito di
una libera concorrenza (negata fin dalle origini dai processi di fusione industriale e dalla strategia dei cartelli).
Anche Habermas autorizza ed esprime la tesi di Weber, secondo la quale le
sfere della conoscenza umana si sbarazzano dell’invadenza della filosofia,
traendo da sé le proprie leggi e dimostrando di non aver bisogno di una supervisione filosofica: le scienze emergono dalle “visioni del mondo”, emancipandosi da interpretazioni sistematiche e elaborando un codice proprio; gli sviluppi cognitivistici delle etiche isolano da pregresse concezioni di “bene” semplici
idee di “giusto”, elaborate secondo asciutti principi deontici; infine è da registrare l’approdo dell’arte all’autonomia espressiva, il suo dar libero sfogo ad
una soggettività “deconcentrata”, verso un’“elaborazione sempre più pura dell’esperienza estetica fondamentale.” Per Habermas il sistema di autoregolazione delle sfere della conoscenza umana rende superflua l’azione di una critica
dell’ideologia all’interno di una teoria della società, e quindi anche l’opera della
dialettica: “La teoria della società non ha più bisogno di assicurarsi dei contenuti normativi della cultura borghese, dell’arte e del pensiero filosofico per via
indiretta, ossia in termini di critica dell’ideologia.”30 Il nuovo indirizzo dovrà essere quello di una collaborazione fra le scienze sociali e la filosofia, per lavorare
assieme, con lo strumento dell’intesa comunicativa, “ad una teoria della razionalità”. È compito dell’etica del discorso prendere atto della legittimità di questi
sviluppi immanenti alle “sfere di valori culturali”, ed analizzare il piano sul quale
le tre sfere vengono a convergere, senza pretendere di apportare dall’esterno
una giustificazione o una fondazione trascendentale: così anche il processo di
autocomprensione della scienza porta a ravvisare l’elaborazione di un contenuto etico, e ciò vale anche per l’arte; d’altra parte anche la morale si applica
nell’assorbimento di contenuti scientifici (“calcolo delle conseguenze, interpretazione dei bisogni ecc.”). La ripresa da parte di Habermas della teoria weberiana dell’autoregolazione delle sfere di valore culturali nella modernità sembra
richiamare per analogia la fallace teoria smithiana dell’autoregolazione del
sistema di mercato, stante anche il comune riferimento alla realtà borghese. Il
Ciò che originariamente si presentava come mezzo per promuovere la produzione, diventa un rapporto estraneo ai produttori. Nella stessa proporzione con cui i
produttori diventano indipendenti dallo scambio, questo sembra diventare indipendente da loro, e sembra crescere l’abisso tra prodotto in quanto tale e prodotto
in quanto valore di scambio. Non è il denaro che produce queste antitesi e contraddizioni; è piuttosto la sviluppo di queste contraddizioni e antitesi che produce
il potere apparentemente trascendentale del denaro.31
Quest’ultimo passo indica i termini nei quali è possibile pensare la trascendentalità oggi. È il denaro, nel momento in cui decide i termini del rapporto che l’uomo deve intrattenere con la realtà, ad imporre una sua teoria
SAGGI
mancato apporto di una categoria interpretativa realmente significativa (dato
l’abbandono dichiarato della dialettica e della critica dell’ideologia) porta in
modo naturale Habermas a perdere di vista il processo che si svolge al di sopra
della precisazione storica dei tre ambiti nel loro interno cammino di differenziazione. La realtà della scienza è che essa, dopo essersi liberata dal vecchio realismo dei sistemi filosofici, è ricaduta nel nuovo obiettivismo dell’impostazione
positivistica; simile destino ha riguardato la morale, che è caduta dalla teoria
della buona condotta in riferimento a spiegazioni della struttura dell’ordine
oggettivo e di pronunciamenti sulla essenza dell’uomo, in una forma esclusiva
di utilitarismo; per finire, l’arte, dopo essersi ritagliata un ambito proprio nella
teorizzazione borghese dell’art pour l’art è precipitata (dopo la parentesi avanguardistica dei primi decenni del Novecento e l’attuazione massima di quel
principio) nella spirale del consumo di massa dei prodotti spirituali (l’industria
dell’arte e della cultura). In effetti il sistema capitalistico ha portato a compimento il suo sviluppo e appare ora non più scardinabile, potendo avvalersi di
strategie di autoregolazione che esso ha perfezionato nel corso del suo cammino. Se di autoregolazione si può parlare, tuttavia, appare decisivo per una
sociologia critica il discorso attorno a quale sia la natura delle regole che il
sistema riesce ora ad applicare automaticamente in virtù dell’avervi uniformato
la coscienza comune. Marx si riferisce al concetto di prezzo –la manifestazione particolare della forma-denaro– per definire il carattere di arbitrio inerente
alle relazioni sociali traviate dall’opera di mediazione che il denaro esercita in
forma esclusiva: il prezzo esemplifica l’unica legge che opera nella società:
quella “legge media della sregolatezza, che agisce ciecamente (corsivo
nostro).” La dialettica della merce lasciata al suo naturale sviluppo produce
un’entità dotata di assoluta autonomia: l’economia, il cui sviluppo fu dettato da
quell’intraprendenza borghese cui lo stesso Marx si vide costretto ad attribuire
un titolo di merito, si divincola dal controllo umano e, come massima realizzazione di quel processo di astrazione che è il vizio originale del capitalismo, arriva a crearsi l’aura di una essenza metafisica che opera sulla testa dei soggetti, dotandosi di regole proprie. Il denaro come “equivalente generale delle
merci”, come trasformazione del prodotto del lavoro umano in puro valore di
scambio, consegna nelle mani del capitalismo quella vittoria sulla realtà concreta che l’originaria tensione fra valore d’uso e valore di scambio nella merce
aveva fino all’ultimo momento lasciato nel dubbio:
61
62
della conoscenza. Una prospettiva che non tenga conto del potere del denaro
conduce ad un cieco idealismo.
Habermas, anche secondo quanto è possibile trarre dalle critiche d’indirizzo marxista, sembra farsi interprete di una prospettiva di conciliazione che mal
si addice alle istanze critiche che la sua riflessione si propone di portare avanti. Coniugare il concetto d’interesse sul piano di una tensione della ragione
umana alla ricerca della verità potrebbe trovare posto in qualsiasi società che
non sia questa (Kant –l’indicazione è dello stesso Habermas– fu il primo a
decifrare un “interesse” della ragione, con un’indiscutibile portata etica, senza
poterlo però collocare e spiegare, e mettendo così in pericolo l’intera sua formulazione trascendentale). In ogni caso la sincera ricerca della verità sembra
essere sempre stata prerogativa di individualità eccelse; un puro spirito critico
non è qualcosa che si possa accampare come una qualità dell’uomo in quanto tale, e difficilmente la discussione attorno alla verità in sede consorziale
riuscirebbe ad aggirare i numerosi paletti che una società strutturata in un
determinato modo può metterle di fronte.
In una società governata da una logica perversa, ogni cambiamento verso
il meglio richiede necessariamente l’azione cosciente di un soggetto sociale.
Ogni formulazione di un concetto di “autoregolazione” non può che costituire
un supporto ideologico al libero dispiegamento della natura scellerata del
sistema. Ma se la ricetta del cambiamento viene a riguardare la possibilità di
attuare un confronto sulla verità di proposizioni nell’ambito di un’etica del discorso che individui ed applichi le regole di una logica dell’“argomentazione in
generale”, allora viene da chiedersi se esistano le premesse di libertà che permettano la necessaria costituzione delle condizioni ideali dello stesso. La pretesa di valorizzare l’etica del discorso nella direzione del cambiamento sociale deve poi portare a chiarire la presenza di un ambito istituzionale (o di una
certa rilevanza sociale) nel quale ciò possa avvenire. Habermas pende in considerazione l’istanza critica rappresentata dall’opinione pubblica della tradizione borghese, una situazione nella quale la separazione fra economia e politica consentiva un controllo critico della prima sulla seconda, nella valorizzazione di un concetto di libertà che si uniformava a quello dello scambio. Con il
crescere dell’ingerenza dello Stato nella società civile, si assiste alla privatizzazione della vita pubblica e alla pubblicizzazione della vita privata, nella misura in cui lo Stato sociale interviene nella vita privata e civile dei cittadini e d’altra parte la società civile si organizza in lobbies e corporazioni, influenzando
così più o meno direttamente la politica economica. L’opinione pubblica borghese però, come la stessa analisi di Habermas porta alla luce, nasce all’insegna dell’ideologia: essa si candida a rappresentare ideali assoluti, ma in
realtà nasconde sotto i suoi proclami gli interessi di una parte specifica della
società. I tratti dell’opinione pubblica infatti si definiscono secondo due discriminanti fondamentali, che sono la proprietà e la cultura, ed entrambe sono una
prerogativa di quella che si avvia ad essere la classe dominante. La sfera del
dibattito politico critico emerge da una dimensione letteraria che identifica le
istituzioni borghesi dello scambio culturale (i club letterari, i caffè, la stampa, i
salotti ecc.). L’ideologia salvaguarda la pretesa dell’“opinione pubblica” di rap-
Conclusione
È difficile difendersi dall’impressione di un certo accademicismo nella filosofia di Habermas: come se il metodo utile ad appianare le controversie teori-
SAGGI
presentare tutti gli uomini, ma ciò può accadere fino al momento in cui appare chiaro che al carattere rivoluzionario del capitalismo legato alla sua esigenza di rinnovare costantemente i termini del rapporto uomo-natura, si accompagna, come per ogni potere in via di consolidamento, un profondo conservatorismo nei rapporti di forza all’interno della comunità. La forza dell’emancipazione che ha guidato la borghesia verso un progressivo affrancamento dal
“ricatto” della natura (tanto nel senso del controllo dei processi naturali quanto nella formulazione filosofica e giuridica del principio di uguaglianza contro
le aristocrazie feudali) si cristallizza in un nuovo rapporto di dominio che non
tollera opposte rivendicazioni: “La sfera pubblica borghese si regge e cade
con il principio del libero accesso per tutti. Una sfera pubblica dalla quale fossero esclusi eo ipso determinati gruppi, non solo sarebbe imperfetta, ma non
sarebbe più neanche una dimensione pubblica.” La coscienza borghese concepisce il pubblico nel riflesso della concezione di uomo che matura: quella di
un individuo privato, votato alla riproduzione generazionale del guadagno.
Dunque è chiaro quale sia il luogo storico e sociale nel quale si realizza questa autocomprensione: “la sfera intima della famiglia patriarcale.”32
Con l’emergere dell’“opinione di massa”, l’opinione pubblica, ormai distrutta
nella sua stessa definizione, perde il suo carattere “critico” e diventa “manipolativa”: essa può farsi oggetto non tanto di un’analisi che ne chiarisca la natura
in rapporto alla sua dialettica con le istituzioni politiche, ma di un approccio
“socio-psicologico” che ne evidenzi il carattere viscerale e contingente.33
Occorre chiedersi: deve la teoria critica rinunciare al suo impegno di far partecipe la coscienza civile delle oscure strategie che sottendono la vita sociale?
Ed inoltre: esiste un soggetto sociale che possa attuare il programma di una
etica del discorso, per realizzarne le competenze all’interno di una critica della
società? La soluzione di Habermas è elitaria, e quindi idealistica: l’ideale del
dialogo richiama alla mente la prassi compromissoria della più tipica mentalità
borghese. È questa la stessa critica che Adorno rivolge a Popper in occasione
del già citato congresso di Tübingen, a proposito dell’ipotesi di uno statuto
“intersoggettivo” dell’accertamento della verità delle proposizioni scientifiche:
l’oggettività della scienza, fa capire Adorno, pur nei limiti con cui Popper la
intende con il suo criticismo, non è conseguibile attraverso un’estensione della
soggettività. In riferimento alle scienze sociali, ogni discussione che perda di
vista la realtà di preformazione dei rapporti sociali rimane impigliata senza rendersene conto nello stesso meccanismo. La fiducia che Popper nutre nella possibilità del raggiungimento di un accordo su una base di confronto “s’ispira
all’invecchiato modello liberale della tavola rotonda intorno a cui ci si riunisce
per trattare un compromesso.”34 La forza della mediazione sociale non risparmia neppure la discussione sulla verità scientifica.
63
64
che all’interno del contesto universitario potesse essere senz’altro esportato
nel mondo vissuto. Il criterio teorico-critico della fedeltà all’oggetto non autorizza una soluzione di questo tipo, perché esso impara a decifrare le tendenze che sono realmente in atto. Anche l’occupazione della riserva protetta della
ricerca filosofico-scientifica sta per essere ultimata: ciò a cui andiamo incontro
è la perdita de “l’idea stessa di uno spazio privo di pubblicità.” In ogni paese
del mondo è consuetudine che le istituzioni universitarie mettano a disposizione delle aziende le loro infrastrutture per la ricerca. In America la politica del
marketing sta per imporre i suoi marchi nelle scuole e nelle università, condizionando pesantemente i programmi educativi e la ricerca scientifica. A causa
delle carenze di politiche nazionali a sostegno dell’istruzione, sta diventando
consuetudine per le scuole richiedere i fondi di cui abbisogna all’industria privata, la quale giunge addirittura a commissionare ricerche aventi come tema i
propri articoli di vendita; si dissolve così il confine tra la comunicazione scientifica e la comunicazione di immagini legate a prodotti di largo consumo.
Con premesse di questo genere situazioni di conflitto d’interessi diventano
usuali: è tipico il caso di aziende farmaceutiche che finanziano ricerche indirizzate a comprovare l’efficacia e la sicurezza di un loro stesso medicinale.
L’occupazione dei campus universitari da parte dell’industria è potuta avvenire
senza significative resistenze: in parte per la fatale distrazione dei docenti, in parte
per la fedeltà di alcuni di questi all’assunto postmoderno che la “verità stessa è una
costruzione”: “E, dal momento che la verità è relativa, chi può affermare che i
Dialoghi di Platone rappresentino un’‘autorità’ più alta rispetto ad Anastasia della
Fox?”35 Questo prova che con il consolidarsi del potere dell’industria risulta sempre più difficile scorgere all’orizzonte un fermento intellettuale d’opposizione,
soprattutto in virtù del venir meno di un punto di vista che sappia scorgere la
dimensione “totale”di un’interconnessione fra un piano categoriale di natura critica
e la “fenomenologia” sociale. La formalità di una metodologia del discorso non
sembra rendere conto di un punto di vista critico sulla società che si dovrebbe
volere tanto radicale quanto radicale è la natura del potere che in essa opera.
Cfr. L. CORTELLA, Crisi e razionalità. Da Nietzsche ad Habermas, Guida, Napoli 1981.
“La filosofia si trova, lo ripeto, in una dimensione nuova rispetto a ogni conoscenza di tipo
naturale, e alla nuova dimensione, per quanto essa possa ancora avere connessioni essenziali
con le vecchie dimensioni –ciò che è già implicito in questa metafora– corrisponde un metodo
nuovo, radicalmente nuovo, che si contrappone a quello ‘naturale’. Chi nega questo non ha capito affatto il piano problematico peculiare alla critica della conoscenza.” (E. HUSSERL, L’idea della
fenomenologia. Cinque lezioni, Il Saggiatore, Milano 1981, pag. 64).
3
J. HABERMAS, Conoscenza e interesse, Laterza, Bari 1990, p. 26.
4
IVI, p. 48.
5
Ivi, p. 70.
6
Ivi, p. 82.
7
AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, Einaudi, Torino 1972.
8
Ivi, p. 156.
9
J. HABERMAS, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Bari 1988, p. 299.
1
2
Cfr. J. HABERMAS, Etica del discorso, Laterza, Bari 2000, pp. 89 e 91.
J. HABERMAS, Etica del discorso, cit., pp. 97-98.
12
J. HABERMAS, Conoscenza e interesse, cit., p. 134.
13
Ivi, p. 181.
14
Ivi, p. 195.
15
Ivi, p. 205. “Quello che uno sceglie come filosofia dipende da quello che è come uomo; infatti
un sistema filosofico non è inerte suppellettile che uno può dare o ricevere, come piace, ma è animato dall’anima dell’uomo che l’ha. Un carattere fiacco di natura o infiacchito e rilassato da servilismo
spirituale, raffinato lusso e vanità, non si eleverà mai all’idealismo.” La frase di Fichte rappresenta una
vera dichiarazione di quello che si potrebbe definire un carattere “attitudinale” della conoscenza.
16
Ivi, p. 248.
17
Ivi, p. 212.
18
Ivi, p. 228.
19
Ivi, p. 229.
20
Ivi, p. 231.
21
Ivi, p. 255.
22
Cfr. E. FROMM, Psicanalisi della società contemporanea, Edizioni di Comunità, Milano 1976.
23
J. HABERMAS, op. cit., pag. 267.
24
S. PETRUCCIANI, Introduzione a Habermas, Laterza, Bari 2000, pag. 166.
25
Cfr. ivi, pag. 176.
26
J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, Vol.II (Critica della ragione funzionalistica), Il
Mulino, Bologna, p. 1406.
27
Ivi, p. 1047.
28
K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1968, p. 153. Risulta
arduo spiegare in poche righe quello che è comunemente riconosciuto come uno dei punti più problematici ed oscuri della filosofia di Marx. Basti in questa sede far notare che il feticismo della
merce è il principio teorico che Marx adotta per chiarire l’essenza del capitalismo. Il feticismo della
merce è la traduzione dei rapporti reali in rapporti meramente quantitativi. In questo senso esso
rievoca l’obiettivismo della scienza moderna. In una società ad economia di mercato le differenti
qualità del lavoro si amalgamano in un’unità di misura univoca: il tempo di lavoro (astrattamente
inteso) socialmente necessario per produrre una data merce. L’alienazione attraverso il lavoro si
fonda su un vizio originario: il rinnegamento delle proprietà materiali del prodotto del lavoro umano
in funzione del suo ingresso nel mercato, e con ciò il trapasso del prodotto da termine di usufrutto (valore d’uso) a medium per l’accumulazione del guadagno (valore di scambio). Se nella dimensione dello scambio delle merci il valore d’uso può ancora rappresentare un elemento decisivo
nella contrattazione (l’acquirente richiede una merce specifica, che soddisfi dei bisogni più o meno
vitali. La prospettiva della scambiabilità di una merce conserva un ruolo centrale, e il prodotto è
pensato in primo luogo come valore di scambio, ma esso deve far fronte all’aspettativa di un valore d’uso da parte di ogni possibile acquirente) –con il denaro ciò non vale più. Il denaro pone fine
alla contraddizione fra valore d’uso e valore di scambio inerente alla merce, e realizza il valore
d’uso nella sua forma pura. Il denaro è così la merce per eccellenza, l’equivalente generale di tutte
le merci, l’universale mezzo dello scambio. Esso rappresenta la trasfigurazione di tutta la realtà a
simbolo, la traduzione di questa in un semplice rapporto fra grandezze.
29
G. DEBORD, La società dello spettacolo, in Commentari sulla società dello spettacolo,
SugarCo Edizioni, Milano 1990.
30
J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, cit., p. 1079.
31
K. MARX, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), La Nuova
Italia, Firenze 1968, p. 75.
32
J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Bari 2001, p. 106.
33
Ivi, pag. 284.
34
AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, cit., p. 41.
35
Cfr. N. KLEIN, No logo, Baldini&Castoldi, Milano 2001, pp. 119-141 (Il branding dell’istruzione).
10
SAGGI
11
65
LA LEGGE DEI POPOLI DI JOHN RAWLS
UN RIESAME CRITICO
di William McBride
66
Nel presente stadio della storia del mondo, è vero che abbiamo bisogno di
ripensare, in termini filosofici, le sfere politiche e sociali della vita, oramai intese come globali piuttosto che puramente nazionali. Tra il dicembre del 1971 e
il gennaio 1972, periodo in cui John Rawls pubblicò il suo libro, A theory of
Justice, quel bisogno già esisteva, benché il suo libro non fu, forse, chiaramente compreso quanto lo è adesso; ma Rawls decise, a quel tempo, di restringere la sua riflessione ad una società nazionale idealizzata e non si preoccupò
delle problematiche internazionali. A theory of Justice, per ragioni sociologiche,
e io penso anche per il merito di una certa onestà, consistenza interna e rigore intellettuale che tende ad esibire, nonostante le sue evidenti lacune, percepibili come sono già ad una prima lettura, divenne ampliamente letto, tradotto
e ammirato in tutto il mondo. Sfortunatamente, data la sua dominante influenza nei dialoghi filosofici e nella teoria sociale nel quarto di secolo che ha seguito alla sua pubblicazione, la sua disattenzione alle problematiche internazionali incoraggiò la stessa trascuratezza in aperto dialogo –ossia, nella maggior
parte degli altri lavori pubblicati in quest’area durante il periodo in questione.
Questa situazione mostra alcune similitudini, malgrado vi siano molte differenze, con quella di Aristotele, che filosofava con grande e apparente sincerità
sulla polis intendendola come l’unità politica fondamentale persino al tempo in
cui la confederazione macedone, controllata dalla famiglia reale, con la quale
aveva vissuto e che aveva conosciuto intimamente, era assorbita dal mettere
fine all’era della città-stato indipendente e ad inaugurare l’era ellenistica.
John Rawls, in ogni caso, aveva provato a ripensare alcuni dei suoi molti
orientamenti di base fino ad un punto in cui Aristotele, alla fine, per quanto noi
ne sappiamo, non arrivò. Il ritiro di Rawls dalle energiche morse della putativa
superiorità della sua teoria sulla giustizia, alla luce della difficoltà di indurre gli
appartenenti a gruppi religiosi e non che rifiutavano che la democrazia liberale
delle sue dottrine fosse convertita nella sua stessa fede politica, risultava nel
suo altro, molto più modesto, lavoro, Political Liberalism, che aveva suscitato la
delusione di molti dei suoi precedenti ammiratori, tra cui citiamo Brian Barry.
Rawls decise anche di prendere sul serio la critica assai diffusa riguardo alla
sua precedente sconfitta sulla valutazione della giustizia locale, insieme al fatto
che molti filosofi politici contemporanei (ad esempio Thomas Pogge, che sosteneva che la prima teoria rawlsiana poteva essere adattata ai contesti internazionali e che scrisse circa tale possibilità1) si erano interessati a questi argomenti, persino come egli non aveva ancora fatto. Il risultato di tutto ciò fu Law
of Peoples inizialmente pubblicato come un semplice saggio nel 19932 e suc-
NOTE
cessivamente trasformato in un piccolo libro avente lo stesso titolo3. Nel contesto di una generale considerazione dei popoli, in un periodo di cambiamenti,
propongo di offrire pochi commenti critici riguardo a questo lavoro che, soprattutto per merito del suo titolo, ha, alla fine, piuttosto aiutato ad accentuare la
discussione sulla nozione elusiva di “people” (gente, popolo).
Il volume di filosofia sociale e politica che fa parte del seguito del World
Congress of Philosophy in Boston del 1998, Volume 11, edito da David
Rasmussen, contiene, nei primi due capitoli, due estese discussioni di Rawls.
Concernenti sia altri tipi di argomenti che quello della giustizia globale, e mai
uno, di certo, menziona la versione lunga del libro The Law of Peoples, che
non era ancora reperibile durante il periodo del Congresso. Entrambi, comunque, si rifanno al titolo dei primi saggi di Rawls, ed entrambi, apportano a proposito degli stessi, conclusioni abbastanza negative. Dalla posizione di destra,
tanto per parlare (benché questo non sia veramente un buon modo di esprimersi), Karl Otto Apel dice: “Ho detto in anticipo che […] ho trovato, il modo
rawlsiano di globalizzare il problema della giustizia, piuttosto deludente. Vorrei
tracciare la ragione di questo ritorno al suo metodo o alla sua strategia di
estendere lo scopo della sua teoria della giustizia ai problemi globali”4. Si continua a dimostrare che, tra le altre cose, l’analogia indicata da Rawls, nel suo
articolo originale, tra cittadini a livello nazionale e Stati a livello globale viene
compromessa quando Rawls cerca di rettificarla sostituendo –come fa in
modo consistente nel libro– popoli con Stati, successivamente, in questo
modo, egli ci riporta indietro al livello di persone5. In altre parole, il metodo libero analogico che Rawls ha usato per effettuare trasferimenti da un livello all’altro, semplicemente, non funziona.
L’articolo successivo presente nel volume, scritto, secondo una prospettiva
di sinistra, dal venezuelano Antonio Perez-Estevez, contiene una lunga pagina di accuse dirette alla teoria rawlsiana in The Law of Peoples in quanto
“ovvio esempio di etnocentrismo ed Eurocentrismo”. I punti salienti della teoria di Perez-Estevez sono: (1) Rawls comincia con un pregiudizio implicito
secondo cui le società liberal-democratiche occidentali costituiscono la miglior
forma di organizzazione socio-politica e, pertanto, (2) che tali società devono
essere considerate come le “insiders”, ovvero coloro che sono dentro al Club
delle Nazioni e (3) che si aspettano di esibire il diritto di decidere chi dovrebbe e chi non dovrebbe essere ammesso al Club; e (4) la definizione di Rawls
di ciò che per lui rappresentano i minimi diritti umani che, stando al suo ordine internazionale, devono essere sostenuti, sono proprio quelli occidentali,
rafforzando, in tal senso, l’identificazione di “occidentale” con “umano”6.
Lasciatemi iniziare ponendo l’attenzione sul mio pieno accordo con le critiche che ho appena presentato (in ogni caso, sono meno entusiasta riguardo
agli altri aspetti dei commenti addotti da Apel, che però non ho menzionato; in
modo particolare, mi riferisco alla sua insistenza che una persino più grande
intensificazione di quella ostentata da Rawls in riferimento alla distinzione tra
giusto e buono costituirebbe un miglioramento). La mia impressione di base,
sia dopo una prima lettura di questo saggio, che più tardi quando ho letto il libro
con maggiore attenzione, è che questo lavoro di Rawls non è scritto con la stes-
67
68
sa dose di onestà, consistenza e rigore intellettuale (per ripetere le parole che
ho adottato all’inizio di questo scritto) come fu A theory of Justice –che è ad
hoc–, pieno di pregiudizi che sono lasciati senza alcuna giustificazione (punto
di vista di Perez-Estevez) è, in breve, molto deludente, per ripetere le parole di
Apel. Con ogni probabilità, un altro parallelo storico potrebbe condurci, questa
volta, con Gli elementi metafisici della Giustizia di Kant in contrasto con la
Critica Kantiana, nonostante io ritenga che, nel caso di Rawls, il contrasto tra
The Law of Peoples e A Theory of Justice è persino ingannevole.
Ma questa impressione necessita di un supporto dettagliato, e ciò è proprio
quello che mi aspetto di fare nei rimandi di questo scritto. Approfondirò cinque
punti: 1) il fallimento delle argomentazioni rawlsiane in funzione di una ridistribuzione globale; 2) la sua difesa di una immigrazione ristretta; 3) la sua descrizione dei così chiamati “rogue states” (Stati criminali); 4) la sua causale teoria
dell’arretratezza economica; 5) riallacciandomi a Perez-Estevez, la sua eccessiva soddisfazione, nonché la sua prospettiva di auto-congratulazione sulla
“democrazia liberale”. Ma prima di avviarci nella mia critica negativa, mi sembra giusto riproporre tutti i momenti di autentica introspezione che ricorrono, di
volta in volta, nel libro e che, se seguiti, potrebbero portare ad ulteriori cambiamenti e ad approcci utili sulle questioni dominanti della nostra era. Prima di
tutto, Rawls parla sprezzantemente in un punto (p.39) di “capitalismo globale”,
nonostante il fatto che ciò ricorra in una nota, in cui cita Michael Walzer menzionando e parafrasando Sidwick. Ancora, ciò costituisce una qualche ricognizione, comunque obliqua, sul concetto rawlsiano riguardo al fatto che il capitalismo globale potrebbe plausibilmente esercitare una influenza negativa nel
mondo odierno. Credo che questa sia l’unica parte dell’intero libro in cui questa possibilità viene esplicitamente presa in considerazione.
In secondo luogo, egli menziona, nel contesto di discussione, la carenza
di regimi democratici attualmente esistenti, tre istanze (più una in cui appare
in dubbio, benché sostiene sia stato asserito da altri) in cui il governo degli
Stati Uniti di America rovescia dei regimi democratici: è il caso di Allende in
Cile, Arbenz in Guatemala e Mossadeq in Iran, cui va aggiunto quello dei sandinisti in Nicaragua, essendo però, per supposizione un caso incerto. (In realtà, egli scrive che queste azioni sono intese dagli Stati Uniti tout court come
una libera maniera di parlare a ciò che io duramente obietto, specialmente
quando l’unica maniera di riferirsi a loro si suppone sia che gli Stati Uniti sono
una democrazia e che queste azioni di governo sono giudicate indemocraticamente). Ritengo piuttosto oltraggioso che Rawls sia riluttante nell’ammettere che il caso del Nicaragua fu anche un’istanza netta di una qualche sovversione. Non dimenticherò mai, per esempio, il rifiuto da parte del governo
degli Stati Uniti di riconoscere la sentenza della Corte di Giustizia secondo
cui l’effetto dell’esplosione del porto di Nicaragua sia stata una violazione
della legge internazionale. Ma Rawls, di certo, rifiuta risolutamente attraverso il suo libro, di dare supporto all’idea di autorità transnazionali, per cui forse
ha ben accolto quella decisione del governo degli Stati Uniti ritenendola
abbastanza ragionevole. In ogni caso, rimane il fatto che Rawls a suo credito una volta menziona (pur essendo tante!) poche azioni anti-democratiche
NOTE
che sono state compiute dal governo del paese a cui egli richiama fedeltà.
Il terzo testo che vorrei elogiare è a pag. 95 di The Law of Peoples. Qui
Rawls asserisce, largamente sulla base di Just and Unjust Wars di Michael
Walzer, ma anche come la nota a p.105 indica, in concomitanza con la recente denuncia dei principi di G. E. M. Anscombe della guerra politica di Harry
Truman, che le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki furono davvero sbagliate. Solo recentemente, da un necrologio, appresi del grado limite del senso
di orrore provato da Anscombe, basato in larga parte sulle sue esperienze personali legate alla legge cattolica e a quella naturale, alla decisone di Truman
di scatenare la guerra nucleare; l’autore del necrologio indicava persino ciò
che era identificabile come il fattore motivazionale nel suo scrivere di lei, della
sua grande classica filosofia analitica, l’Intenzione: ella desiderava in totale
accordo con lo scrittore, esplorare in profondità il problema dell’assegnazione
della nozione di responsabilità per ogni decisione. Rawls, d’altro canto, rende
molto chiara l’idea che, come Walzer e diversamente da Anscombe, è contrario a sospendere le limitazioni sull’uccisione di civili in guerra quando si verificano le condizioni per ciò che egli chiama l’“emergenza suprema”. In realtà, in
lungo e in largo, il tono di questo libro (diversamente dall’articolo, in cui queste questioni non emergono, o emergono veramente poco) è sorprendentemente militaristico, dalla sua prima insistenza sul fatto che gli stati liberaldemocratici che posseggono armi nucleari, o al massimo gli Stati Uniti, posseggono queste armi finché esistono degli stati fuorilegge (p.9) al suo forte
bisogno, più o meno verso la fine del libro (p.123), che la guerra contro le
società irragionevoli potrebbe essere necessaria e che pure noi dovremmo
essere pronti a farla.
Trovo Walzer, guida riconosciuta di Rawls, in questa questione delle condizioni di “emergenza suprema”, spesso auto-contradditorio, sino al punto dell’incoerenza7, e Rawls chiaramente asserisce (p.95) che concorda con ogni
punto del libro di Walzer. Così, in breve, anche nei tre punti in cui ho espresso qualche accordo sostanziale con Rawls, lo ritengo comicamente inadeguato al primo –un riferimento al capitalismo globale al centro di una nota– e in
definitiva non sul lato degli angeli quando arriva al secondo e al terzo.
(Rammento, tra parentesi, l’ultima occasione in cui assistetti ad una lezione
della prof.ssa Anscombe: fu alla sessione inaugurale del World Congress of
Philosophy a Bringhton nel 1988, dove parlò delle “intelligenze degli ordini più
alti” – cioè gli angeli.). Di seguito presento le cinque areee principali in riguardo che ho selezionato.
(1) Ridistribuzione delle risorse. Rawls esplicitamente afferma che, fino a
quando ciò che egli definisce “il dovere dell’assistenza” che porta le società
finanziariamente meno favorite sino ad un certo punto che consenta loro di
accogliere i governi democratici non è stato compiuto, non vi è alcuna ingiustizia dovuta ad ineguaglianze abbastanza considerevoli tra nazioni ricche e
nazioni povere. Come egli sostiene (p.114), “i cittadini di un paese dovrebbero sentirsi inferiori ai cittadini di un altro a causa della loro maggiore ricchezza”, allora la struttura di base della Società dei Popoli potrebbe essere considerata ingiusta, nello “stabilire che tali impressioni siano giustificate. Fino a
69
70
questo momento,” successivamente egli arriva a dire, “quando il dovere di
assistenza si realizza, ed ogni persona ottiene il suo governo rispettabile o
liberale, queste impressioni sono ingiustificate”. Proprio come in questo caso!
Rawls ha appena spiegato quanto sia irragionevole per i cittadini dei paesi più
poveri infastidirsi della grande ricchezza delle nazioni più ricche. Appare quasi
ridicolo mentre cerca di dare istruzioni ai più svantaggiati in riguardo a come
essi dovrebbero sentirsi. Ma questo punto di vista su una tale questione come
quella della giustizia globale dopo tutto, la sua totale prospettiva della giustizia in tutta la sua carriera è stata principalmente distributiva e soprattutto una
giustizia economicamente distributiva –è estremamente antistorica (eccetto in
un senso particolare che menzionerò alla fine della mia discussione in questo
scritto) e allo stesso tempo piuttosto insensibile, non uniformata a nessun
senso di obbligazione morale nei riguardi dell’individuo, da quando punta solo
al minimo ben-essere delle società, nell’insieme.
L’enorme squilibrio delle risorse globali, oggi, è il risultato di complessi processi storici e non, o comunque non lo è principalmente, di una mera fortuna.
La fortuna gioca un ruolo, certamente, come in alcuni casi simili a quello della
localizzazione delle riserve di petrolio combinata alla serie di sviluppi scientifici e tecnologici che non hanno seguito la precisa sequenza storica, che essa
seguì e che permise il rialzo del petrolio al suo esaltante stato come il carburante della scelta. Molti degli altri processi storici, portando all’attuale stato di
affari, implicavano conquista, strage, genocidio (come nel caso degli Indiani
del Nord America), ed estrema oppressione (come nel caso della schiavitù
negra). È altamente irrealistica l’idea di discutere le presenti differenze globali in distribuzione economica senza tenere conto degli effetti che quegli eventi
passati hanno sul presente. Ma realisticamente, il mondo tangibile di ciò che
egli chiamava “quasi giuste società”, non è mai stato seguìto da Rawls.
Oppure egli non ha mai completamente compreso il fatto che la disparità di
accesso ad alcune cose desiderate, alcune come ciò che egli chiama il valore della libertà individuale (distinguibile dalla libertà individuale per sé) in A
Theory of Justice8 e adesso il senso di auto-rispetto nazionale basato sulla distribuzione globale delle risorse ne The Society of Peoples, sono equivalenti
alla grande ineguaglianza nell’effettivo possesso di tali desiderabilità.
Come per la nozione di società, “popoli”, nell’insieme gli attori di base in
The Law of Peoples, questa è una buona occasione come poche per porre in
evidenza ciò che a me sembra drasticamente l’ovvio punto di questa sua
instabilità concettuale. Rawls davvero non cerca mai di definire una “persona”,
eccetto nel momento in cui si riferisce (p.23) ai tre criteri offerti da John Stuart
Mill per identificare la nozione di gente libera, vale a dire “un governo ragionevolmente davvero costituzionale”, “simpatie comuni” e natura morale. In
questo giorno in cui uno sforzo molto necessario è stato consacrato per determinare e, spesso per rideterminare, i parametri dei gruppi nazionali, e le guerre sono state combattute su queste questioni in Dubrovnik come in molti altri
posti, pochi filosofi oltre a Rawls che facevano affidamento su un qualche vago
e falsamente pio criterio, inteso come la base di un conto sistematico, sarebbero soggetti a divenire ridicoli. Allo stesso modo, ritengo che egli sia riuscito
NOTE
abbastanza bene rendendo la posizione di cosmopolitismo, che contrasta con
se stesso, notevolmente attraente.
(2) La difesa di Rawls della immigrazione restrittiva. Questo costituisce un
altro dei punti preminenti in The Law of Peoples, ed è per me uno di particolare interesse. Ho argomentato in molti posti9, che l’articolo della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, l’articolo 13, che garantisce il
diritto di immigrazione in realtà è astratto, insignificante, e ipocrita se non è
compreso ma anche garantito. Il diritto deve essere adottato come per un
immigrante per lo meno in un’altra entità politica. Ma Rawls, riconoscendo in
una nota a p.74 la possibilità che qualche argomento potrebbe fare, immediatamente lo congeda dicendo che “molti diritti sono senza motivo in questo
senso: per dare qualche esempio, il diritto di sposarsi, di invitare gente nella
propria casa, o persino di fare una promessa. Occorrono almeno due persone per parlare di questi diritti”.
Ma tutto questo mi sembra che, per richiamare quei più recenti così definiti diritti ad un diritto preciso, stipulato all’interno del contesto di una “legge dei
popoli”, sia estremamente sofista. In realtà, questi diritti non sono poi così
simili tra di loro. Inoltre, quando Rawls ha illustrato il punto della situazione
fatto da Apel, rispettando la supposta analogia da egli stesso sostenuta tra i
cittadini individuali di A Theory of Justice e i “popoli” in questo libro, significa
soltanto che forse non è così bravo in materia di analogie. Ciò che egli vuole
essenzialmente fare è evitare che qualsiasi inferenza sugli effetti delle presenti
ed eccessivamente restrittive politiche di immigrazione di alcuni paesi come gli
Stati Uniti e i firmatari ai Schingen Accords –politiche che accidentalmente
hanno subito qualche liberazione durante uno o due anni fa– sia ingiusta e che
pertanto dovrebbe essere abolita. Rawls non vede alcuna ragione di allentare
qualche restrizione –che in conclusione potrebbe essere usata per portare una
qualche redistribuzione economica, ed è per questo che egli non vede nessun
bisogno, fatta eccezione per un solo caso, discutibile, di emigrazione per
ragioni di persecuzione religiosa.
(3) La demonizzazione dei così definiti “Rogue States”. Benché io non sia
stato abile nel tracciare la sua esatta provenienza, questo termine fu, suppongo, l’invenzione di una mente brillante del Dipartimento di Stato degli USA risalente ad uno o a due decenni fa. Fu un facile sistema per separare i governi
“buoni” e “neutrali” da quelli “cattivi” con decreto. Probabilmente non fu il termine più appropriato al proposito –nell’inglese colloquiale del periodo più
recente era abbastanza comune, ad esempio, parlare di “adorabili criminali”–,
ma funzionò come si supponeva dovesse funzionare nel campo della propaganda della politica estera. Bene, ma si suppone che Rawls sia un filosofo e
non un propagandista, pertanto ciò che io ritengo sorprendente è il fatto che
egli voglia usare questa definizione in modo più o meno tecnico persino nei
suoi primi saggi su “The Law of Peoples”. Man mano che si legge il libro, l’espressione “stati fuorilegge” tende a sostituire quella di “stati criminali”, a
seconda del modo in cui Rawls tende a demonizzare il termine. E la sua è una
ricca demonologia. Spagna, Francia e l’Haspurg Empire sono, a suo dire, tra
i tanti stati fuorilegge della prima Europa moderna (p. 105). Egli sostiene che
71
72
i leaders degli stati fuorilegge sono dei criminali (p. 95). Afferma inoltre che
“Washington e Lincoln erano degli uomini di Stato”, ma Bismarck non lo fu
(p.97). Il problema del duro moralismo di questo aspetto del lavoro di Rawls è
perlomeno duplice. (a) Come può essere così utile, quando cercando di
assommare un approccio sistematico a questioni globali, getta così tanti regimi stato-nazione del passato in una trappola infuocata? È davvero Rawls così
ingenuo da pensare che i leader politici oggi sono così tanto buoni e migliori
rispetto ai leaders del passato? È il caso di George Washington: molti libri di
storia omisero ad esempio di menzionare che, in qualità di Presidente, egli
ordinò il massacro degli abitanti originali, puri nativi americani perché il prodotto di matrimoni misti tra Indiani e primi colonizzatori francesi, che costituivano la tribù WEA nell’odierna Lafayette, indiana, dove io vivo. Si trattò di una
rappresaglia condotta per attacchi sporadici compiuti su dei coloni anglo-americani lungo il fiume Ohio fino al sud. Se ogni possibile attacco è un massacro,
come Washington, apparentemente calcolò, allora non ci saranno più problemi. Ed il caso di Lincoln, il suo supporto alla politica militare di Grant aumentando al massimo il massiccio attacco furioso dell’Esercito del Nord all’inevitabile costo di disastri con l’interesse di mettere fine in modo veloce alla
Guerra civile americana, molto discussa e denunciata a quel tempo; ci si
aspettava, universalmente, che Lincoln perdesse le elezioni presidenziali del
1864 quando una precedente vittoria militare proprio un mese prima delle elezioni fece cambiare il parere dell’opinione pubblica. Ma allora Rawls ha chiaramente commesso un piccolo errore nel trovare con i rischi militari portati via
in nome di valori, particolarmente i diritti umani, specialmente quelli che egli
approva. Pertanto, suppongo che non avrebbe trovato obiezioni in merito a ciò
che ho osservato riguardo a Lincoln definendolo un “uomo di Stato”, ma con
buona probabilità egli vorrebbe, perlomeno, ripensare il caso di Washington.
(b) Il seguente problema circa lo stratagemma concettuale di Rawls riguardo
agli “Stati Criminali” è uno sul quale vorrei focalizzare l’attenzione molto più
che su (a), benché i due punti siano tra di loro connessi: chi è incaricato,
secondo lo schema rawlsiano, di stabilire quali stati sono fuorilegge, o in verità quali rientrano nelle cinque categorie che egli elenca, secondo uno stile
piuttosto bizzaro, più o meno all’inizio del libro? In questa lista (p.4) si legge
come segue: le società liberali e ragionevoli, le società rispettabili non liberali, gli “stati fuorilegge”, le società contrassegnate da sfavorevoli condizioni, e
le società che costituiscono un assolutismo benevolo. Andrebbe notato che
Rawls in questa lista aderisce alla sua politica di rifersi alle “società” e non agli
“Stati”, eccetto nel caso della terza categoria, “ Stati fuorilegge”. Per quanto io
ne sappia, Rawls non intende mai per “Stati fuorilegge” delle intere società
–qualcosa che sarebbe estremamente aspro e insolito da dire, duro non per
la capacità di Rawls di dirlo. Tuttavia, questo punto terminologico ha una certa
importanza per Rawls, poiché vorrebbe giustificare la guerra contro gli Stati
fuorilegge, ma non può, allo stesso tempo, fare a meno di notare che i popoli
che vivono sottomessi da regimi, includendo molti di quelli che non li supportano o attivamente li contrastano, sono uniti dalla sofferenza che ogni guerra
comporta; la Serbia nel 1999 è un caso evidente. È questa la realizzazione
NOTE
della Giustizia?
Per ritornare alla questione di chi possa o non possa decidere quali stati
sono da considerarsi fuorilegge, la corretta categorizzazione dovrebbe essere
decisa in seguito ad una revisione globale di un consiglio di civili, simile ai consigli locali aventi lo stesso nome, che considerano brutalmente le dichiarazioni della polizia in qualche città degli USA? Perez-Estevez crede di sapere a
chi, in accordo con lo stesso modo di pensare di Rawls, si suppone competa
questa funzione: la cerchia ristretta del Club delle Nazioni, e specialmente il
Presidente del Consiglio dei Direttori del Club, il Governo degli Stati Uniti.
Perez-Estevez ha ragione. Sed quis custodem custodiat?
Quella è di certo la questione preminente. Per quanto mi riguarda, non
sono l’unico a pensare, in tempi recenti, che spesso i più temibili tra gli stati
criminali sono stati, in teoria, quelli eletti dagli americani. È andata così, a
causa della vera a propria grandezza del potere militare che il governo controlla, nonostante ci siano anche numerosi altri fattori. Se per un attimo mettiamo da parte la questione della disputa del bombardamento della
Jugoslavia per mano della NATO e trascuriamo i casi più antichi, come ad
esempio quello del Cile, Rawls stesso riferisce che in anni più recenti abbiamo i casi di Panama e di Granada, insieme ad altre situazioni in cui il governo degli Stati Uniti ha minacciato di intervenire o di esercitare pressioni non
sottili in modo da impadronirsi, allo stesso modo, sia degli stati democratici
che di quelli non-democratici. Un buon esempio piuttosto recente è quello
della forte pressione esercitata dal governo degli Stati Uniti sul governo della
Grecia in modo da indurlo a supportare il bombardamento della NATO nonostante la forte opposizione della popolazione greca, come è stato dimostrato elezioni dopo elezioni. La naturale attribuzione dell’egemonico superpotere agli Stati Uniti e i suoi più stretti alleati, riguardo la decisione di quelli che
possono o non possono essere identificati come stati criminali, come è stato
tacitamente supervisionato da Rawls, è problematico per un alto numero di
ragioni addizionali frequentemente oltre ai modi criminali del superpotere
stesso. Tanto per cominciare, questo superpotere, si può duramente affermare che offre al mondo un modello ispiratore di democrazia in azione: dimostrazione della sconfitta delle elezioni presidenziali del 2000, esempio dell’acquisto dei voti al punto che meno del 10% delle elezioni dei membri del
Senato e della Camera dei Rappresentanti furono battuti da candidati che utilizzarono meno il denaro rispetto ai loro oppositori, esempio della particolarmente bassa affluenza alle urne, ed altro ancora. Inoltre, si può sempre duramente affermare che il superpotere possa offrire un esempio ispiratore del più
caro ideale di Rawls, nel libro in considerazione, cioè il rispetto per i diritti
umani: testimonianza del drastico aumento dei detenuti nelle carceri del
paese, testimonianza del movimento atto a privatizzare le prigioni in modo da
percepire interesse nel trattenere i detenuti per il maggior tempo possibile,
testimonianza della crescita del ricorso alla pena capitale, testimonianza
della tendenza a trattenere sia detenuti adulti che giovani, testimonianza dell’appropriazione di condannati crudeli in alcuni stati, come la Florida, persino
per il periodo successivo all’espiazione della loro condanna, ed altro ancora.
73
74
La macchia nelle mani degli Americani è di un colore molto marcato; per
Rawls, persino il “preppy”, come gli studenti del collegio dell’alta società della
sua stessa generazione venivano chiamati, che vestivano in modo caratteristico e mostravano un positivo ottimismo riguardo a se stessi, il loro paese e
il loro mondo, vede molto poco di tutto questo e non incorpora nessuna delle
sue implicazioni nella sua teoria.
(4) La spiegazione rawlsiana dell’arretratezza economica. Un aspetto
molto particolare tra le tante poco attraenti caratteristiche di The Law of
Peoples è il congiungimento che Rawls effettua su come le società che egli
definisce “oppresse” divengono tali. Egli sostiene che si tratta di un loro stesso errore di base: “Ritengo che le cause della ricchezza di un popolo e le
forme che assumono si trovi nella loro cultura politica e nelle loro tradizioni religiose, filosofiche e morali che supportano la struttura di base delle loro istituzioni politiche e sociali, come pure nei talenti industriosi e cooperativi dei suoi
membri, tutti supportati dai loro valori politici. Vorrei, inoltre ipotizzare che non
esiste nessuna società, in nessun posto del mondo, eccetto in casi marginali,
che non potrebbe, se ragionevolmente e razionalmente organizzata e governata, diventare ben-ordinata”. (p.108).
In breve, egli biasima le culture politiche povere, la mancanza di integrità
morale, e i fattori simili del fallimento di alcune società nello svilupparsi in modo
soddisfacente. Trovo terrificante che una persona del rigore di Rawls possa
accettare qualche spiegazione convenzionale e farlo senza riserve. Certamente,
alcune osservazioni sono quasi totalmente false, e tentano la strada delle spiegazioni per il ritardato sviluppo in molti posti. Ma per rendere un qualche fattore
morale, e allo stesso tempo, ottenere uno sviluppo ottimale, senza discutere,
significando qualcosa come “essere come noi”, equivale a dire, in filosofia sociale, come un eticista, che i membri di alcuni gruppi di minoranza posseggono una
bassa media di standards di vita e di guadagno poiché essi sono naturalmente
incapaci e pigri. Come affermò Rousseau riguardo alla gravissima citazione di
Aristotele, secondo cui alcuni sono schiavi per natura, egli ha confuso l’effetto per
la causa. Se una persona nasce in una condizione di schiavitù, sarà idonea alla
schiavitù, dice Rousseau10. Allo stesso modo, Rawls sembra essere convinto,
come Aristotele, che esistono delle società che sono arretrate per natura. Rawls
mostra una grande mancanza di raffinatezza, sia morale che intellettuale, in questo aspetto del suo lavoro. La spiegazione qui offerta può apparire, in contrasto
con la maggior parte del resto del suo testo, come storica, ma in realtà si tratta di
storia ipotetica e puramente astratta.
(5) La prospettiva rawlsiana eccessivamente auto-gratulatoria. PerezEstevez ha sostenuto, tra le altre cose, che Rawls identifica “occidentale” con
“umano”, specialmente nell’area dei diritti. Così Perez-Estevez si è espresso
al riguardo: The Law of Peoples non è aperto alla possibilità di ampliare i minimi diritti umani provenienti da società non-occidentali e da altrettante culture.
I minimi diritti umani di cui parla Rawls sono assunti come una concessione
delle società liberal-democratiche alle società gerarchicamente ben-ordinate.
La teoria rawlsiana sui diritti umani costituisce un nuovo sforzo utile ad applicare e ad allargare i valori occidentali, in cerchi concentrici, alle altre culture e
NOTE
alle altre società in modo da renderle simili alle società occidentali11.
Effettivamente, Rawls non ha mai esaminato in profondità il tema dei diritti umani, sebbene egli lo abbia certamente spesso toccato nella sua discussione, prima per ciò che concerne la giustizia e in seconda istanza per ciò che
riguarda il liberalismo politico, benché Ronald Dworkin, nel suo libro Taking
Rights Seriously e altrove, abbia sostenuto (senza, almeno per quel che so, ci
siano state alcune smentite sulla parte che Rawls ha avuto in questa affermazione) che la sua opinione sui diritti è compatibile con la teoria di Rawls.
Pertanto, ciò che Rawls ha effettivamente asserito, in tema di rafforzamento
dei diritti umani, al punto che qualche volta ci sia un’obbligazione per fare una
guerra o per difenderli, qualcosa è detto in un vuoto filosofico assoluto: si suppone che noi tutti sappiamo, “intuitivamente” credo, che alcuni principi sono
sbagliati se uccidono la gente. Ho sempre detestato la tendenza, diffusa da
qualche filosofo analitico, di far riemergere le così chiamate “intuizioni” per stabilire le questioni morali, e A Theory of Justice di Rawls possiede un largo carico di responsabilità per questa cattiva abitudine. Ma Perez-Estevez, ha senza
dubbio ragione nel pensare che i diritti che sono più importanti per Rawls sono
i tradizionali diritti negativi della tradizione liberale occidentale, come ad esempio il diritto di proprietà, e non certamente i più positivi come quelli riferibili al
vivere percependo uno stipendio, all’educazione, ad una buona condizione di
salute, e pertanto anche quelli elencati nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo e in altri documenti che hanno trasceso quella tradizione spostandosi in direzioni molti più progressive. Un testo in The Law of Peoples che
mi ha lasciato senza fiato quando mi sono apprestato a leggerlo per la prima
volta e che rinforza le diffidenze nutrite da Perez-Estevez in merito a quali diritti sono più importanti per Rawls è quello in cui egli discute l’importanza di
sostenere i limiti politici, in ogni caso anche se possono essere storicamente
e arbitrariamente contingenti.
Secondo la mia opinione, il punto della istituzione della proprietà privata è
che, a meno che non sia data la responsabilità ad un agente definito di sostenere un bene e, nel caso contrario, di tollerarne una perdita, quel bene tende
a deteriorarsi. In questo caso il bene non è altro che il territorio del popolo e la
sua capacità di sostentarlo perpetuamente; e l’agente è lo stesso popolo politicamente organizzato.
Permettetemi di suggerire, tra le altre cose, che potrebbe essere molto
interessante cercare di applicare questo passaggio del giudizio rawlsiano alla
situazione del Kosovo.
Il pensiero di Rawls, se questa sia poi la definizione più appropriata, riguardo ai diritti in The Law of Peoples, gli consente contemporaneamente di riservare l’orgoglio del posto, nella Società del Popolo, per coloro che praticano
una democrazia liberale –un altro concetto fondamentale che, al contrario
delle apparenze, egli non ha mai analizzato in profondità–, mentre certamente garantisce la condizione di seconda-classe, che è di gran lunga migliore
rispetto a quella dello stato furilegge, alle società gerarchiche, non-liberali che
egli reputa “rispettabili”.
Questo aggettivo, con le sue connotazioni molto moralistiche e persino con
75
76
qualche limite sessualmente puritano, è in sé abbastanza problematico se
viene usato in qualità di termine tecnico, che è proprio il modo in cui lo usa
Rawls. Da un lato, la sua accettazione accondiscendente all’esistenza di una
qualche società severa “rispettabile”, consente a Rawls di distogliere l’interesse per i diritti umani realmente universali, come una dissertazione scritta da
Pavlovic per l’Università di Belgrado argomenta in maniera molto interessante. L’idea di Pavlovic è che attraverso questo abbandono dei diritti umani universali in favore di un punto di vista finalizzato alle società, piuttosto che all’individuo, Rawls ha abbracciato un relativismo morale in un modo che è incompatibile con il liberalismo reale. Questa prospettiva, permette piuttosto a Rawls
di guardare quest’altro modo e non di essere completamente coinvolto riguardo ai possibili dissidenti, eccezioni al prevalere (che spesso significa, effettivamente, soltanto imposto), in qualche società, di valori convenzionali, come
nella seguente frase: “Una certa società immaginata da Rawls, benché essa
[…] possiede (gli stessi) elementi di giustizia egualitaria (come un’altra società molto più liberale), a causa del prevalere dei suoi valori religiosi e sociali,
posseduti liberamente dalle sue donne, non riduce l’indice della crescita della
popolazione e rimane piuttosto alta”.
Ma, dall’altro lato, noi sappiamo che le società “rispettabili” non liberali di
seconda-classe, nella Società delle Nazioni di Rawls necessitano sempre di
stare in guardia, per timore che qualche evento precipitoso le riporti ad essere classificate come stati fuorilegge dal Dipartimento di Stato rawlsiano nella
sua rivista annuale e, quindi, ad essere ritenuti i candidati potenziali per l’intervento esterno sul piano su cui essi falliscono abbastanza: rispettare quei
diritti umani che sono stati giudicati meritevoli rispetto a quell’anno.
Un’ultima, tra parentesi, serie di commenti riguardanti l’idea rawlsiana di
quali società sono e quali non sono liberali. Egli richiama, in parecchie occasioni, l’attenzione sul fatto che dal 1800 non esistono due società liberali che
sono in guerra tra di loro. Il lettore, in questo modo è tentato dal cominciare un
gioco, che però sarà sempre vinto da Rawls. Se qualcuno cerca di mettersi
alla pari apportando un esempio contrario, come quello della guerra tra gli
Stati Uniti e l’Inghilterra nel 1812, o la guerra andina in Sud America, ognuno
sa che Rawls risponderà dicendo che una oppure entrambe le società in questione non erano realmente liberali. Evidentemente, mi sembra che se giocassimo questo gioco, allora i casi di quasi guerra, come quelli delle mezze
ostilità tra la Grecia e la Turchia su Cipro, in tempi abbastanza recenti, potrebbe costituire anche un esempio. Ma la cosa migliore è non giocare del tutto a
questo gioco. Il punto più largo, oltre a questa parentetica digressione, è che
Rawls sa, o piuttosto finge di sapere, quali società sono davvero buone, e
quali invece sono puramente rispettabili, e noi tutti sappiamo quali egli giudica in questo modo; e ci fa sentire male se abbiamo quegli scrupoli che ci impediscono dall’essere considerati in qualità di diritti ragionevoli come lui. Ma questa atmosfera intellettuale che ho descritto non è più una in cui prevale la filosofia, ma piuttosto un ristretto, eurocentrico, se vogliamo, pregiudizio.
Conclusione. Ho, in modo stravagante, espresso la mia volontà di mostrare quanto Rawls, in questo lavoro, sembri ricongiungersi al suo precedente
NOTE
amichevole avversario, Jürgen Habermas, appoggiando, implicitamente, il
governo degli Stati Uniti e la politica della NATO nei Balcani e altrove, e anche
per riferirmi sia al mio primo riesame di A Theory of Justice, che effettivamente fu uno dei primi ad essere pubblicato, al di là delle migliaia di copie in stampa adesso12, e alla mia discussione riguardo ad un premio vinto per uno scritto su Rawls da uno studente coreano laureato, Wonsup Jung, al Congresso di
Filosofia del 199813. Facendo qui seriamente la mia promessa, il risultato
potrebbe essere un esercizio molto prolisso. Pertanto userò “diplomazia” con
le due più recenti referenze, asserendo che, nella mia critica del 1972, satirizzavo gentilmente sulle prime pretese di universabilità di Rawls, giustapponendo richiesta di prendere una posizione di sub specie aeternitatis con l’ovvio
fatto che si trattava di una nuova teoria, e concludevo che si sarebbe dato più
credito ai filosofi politici in futuro se si fossero dedicati a criticare le esistenti
ingiustizie piuttosto che al compito di Sisifo di cercare di costruire una teoria
della giustizia inattaccabile; ed è quello che nel 1998, ho, sempre in modo
gentile, suggerito e cioè che è arrivato il momento in cui dovremmo cominciare a calare completamente il sipario sull’era di Rawls e spostarci verso problemi e paradigmi teoretico-politici. Continuo ad essere d’accordo, ancora una
volta, su questi punti.
Come per Habermas e il bombardamento, ho scritto altrove su questo
argomento, nei miei articoli Habermas and the Marxian Tradition14, che ha
come punto di partenza uno scritto che ho inizialmente divulgato alla Korcula
Summer School, e What Values Remain?15, una condanna del bombardamento che inizialmente appresi a S. Pietroburgo, dove un partecipante russo
mi criticò poiché mi mostravo troppo duro nei confronti della NATO. Mi tratterrò, pertanto, dall’enunciare per esteso questi punti. Piuttosto elencherò solo
pochi passaggi, pensando al futuro. Effettivamente, come abbiamo visto,
Rawls –come in molte altre aeree di The Law of Peoples, egli sembra confuso e poco chiaro riguardo a ciò–, si sottrae al mostrarsi piuttosto orientato
verso un tradizionale status quo. L’enorme problema, sul quale sono ritornato
più volte, è quello della reale situazione del mondo con cui effettivamente dobbiamo confrontarci, in cui uno stato quasi criminale, il governo degli Stati Uniti,
e i suoi alleati servili sono normalmente in quelle posizioni di comando utili a
determinare chi dovrebbe essere premiato e chi dovrebbe essere punito, attraverso delle procedure che sono estremamente antidemocratiche, soprattutto
quando si affrontano argomenti di una certa entità. Almeno qualche volta,
come effettivamente è stato scoperto di recente nella gravissima invasione
della Baia dei Porci di Cuba, persino un presidente degli Stati Uniti poteva
essere seriamente raggirato dal capo della C.I.A. e da altri consiglieri posti in
posizioni da cui si può determinare il corso ultimo della politica globale. Una
qualche rispettabile teoria, per dire una novità, di relazioni tra i popoli, in questo giorno e in questa fase, deve tenere conto di queste realtà.
Per concludere, come ho già in precedenza chiarito, sono dello stesso
avviso di molti Europei e di tutti coloro che ritengono che una democrazia
autentica, cioè governata dal popolo, non consiste nel processo di essere eliminati dalla terra. Io mi affido totalmente ad una prospettiva cosmopolita, seb-
77
bene non ritenga che il cosmopolitismo implichi un individualismo etico o epistemologico, come ritiene Rawls, e ancor meno un individualismo metafisico.
Se il lavoro di Rawls ha un qualche merito sostanziale, oltre a quello di prendere alla fine sul serio pochi di quegli argomenti globali di cui dovrebbe aver
tenuto conto nel suo lavoro di trenta anni fa, è quello di spingere analisti perspicaci verso una direzione cosmopolita attraverso una ricognizione dei suoi
stessi gravi difetti –e forse anche facendoci realizzare che lo slogan “politico,
non metafisico” è una maniera mistificatrice di occultare una serie di pregiudizi influenti che non riflettono la struttura ultima del mondo sociopolitico.
(Traduzione a cura di Emanuela Monda)
T. POGGE, Realizing Rawls, Cornell University Press, Ithaca, 1990.
J. RAWLS, The Law of People, “Critical Inquiry” 20 (1993), pp.36-98.
3
J. RAWLS, The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge 1999. Tutte le referenze della pagina presenti nel testo di questo aricolo saranno prese da questo lavoro.
4
K. O. APEL, Is a Political Conception of Overlapping Consensus an Adequate Basis for Global
Justice?, D. RASMUSSEN, Social and Political Philosophy, The Proceedings of the Twentieth World
Congress of Philosophy, Philosophy Documentation Center, 2001, ed. Vol. 11, p. 9.
5
Ivi, p.12.
6
A. PEREZ-ESTEVEZ, Intercultural Dialogue and Human Rights: A Latin American Reading of
Rawls’s “The Law of Peoples”, Ivi, pp.21-22.
7
Mi riferisco in modo particolare al Capitolo 16 di Just and Unjust Wars, Basic Books, New
York 1977, nel quale Walzer, se da un lato difende il bombardamento di civili compiuto da
Churchill, riffacendosi al concetto di “emergenza suprema”, dall’altro riconosce che Churchill,
facendo ciò, era da ritenersi colpevole di “criminalità”, poiché quell’azione violava la proibizione
“assoluta” contro l’uccisione intenzionale di una vita innocente.
8
J. RAWLS, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge 1971, p.204.
9
In maniera particolare in The Rights of Aliens and of Other Others, “Archiv für Rechs-und
Sozialphilosophie”, IVR-Tagung Beiheft #67, Rights, pp.192-99.
10
J.-J. ROUSSEAU, Du Contrat Social, Libro I, Capitolo 3.
11
A. PEREZ-ESTEVEZ, op. cit., p.22.
12
W. MCBRIDE, Political Theory Sub Specie Aeternitates: A New Perspective, “Yale Law
Journal”, 81,5, April 1972, pp.980-1003.
13
ID., Reply to Wonsup Jung, Philosophical Forum, (Seul) 26 (1998), pp. 233-40.
14
ID., Habermas and The Marxian Tradition, in L. HAHN, Perspective on Habermas, Open
Court, La Salle 2000, pp.425-38.
15
W. MCBRIDE, What Values Remain?, in L. MOREVA, Simbols, Images and Stereotypes of
Contemporary Culture, Centre “Eidos”, S. Pietroburgo 2000, pp.70-83. Sia questo articolo che
quello menzionato in precedenza adesso compare come capitolo nel mio volume, From Yugoslav
Praxis to Global Phatos: Anti-Hegemonic Post-post-Marxist Essays, Lanham, Rowman &
Littlefield, Maryland 2001.
1
2
78
DALLA FILOSOFIA DELLA VITA
ALLA LOGICA ERMENEUTICA
La logica intesa come teoria generale del sapere può essere costituita da
una modalità puramente evocativa rintracciata nella parola, accanto alla più
tradizionale modalità puramente discorsiva? È possibile inoltre basare una
‘Storia dell’autobiografia’ sulla pregnante categoria dell’espressione, nella
quale si manifesta in modo sorprendente la capacità che la vita ha di prendere distanza da sé stessa? Queste sono solo alcune delle interessanti questioni che il pregevole volume di Massimo Mezzanzanica ci ispira1. L’Autore ci presenta l’importante quanto relativamente poco conosciuta figura di Georg
Misch (1878-1965), valente allievo del filosofo Dilthey e peraltro prosecutore
della corrente diltheyana nel dibattito filosofico novecentesco. Lo studio del
Mezzanzanica si segnala, fin dall’inizio, per la precisione e la scrupolosità con
cui egli ricostruisce a livello bibliografico, e quindi storiografico, l’attività di pensiero svolta da Misch, congiuntamente agli altri studiosi impegnati nell’elaborazione della filosofia di Dilthey quali Nohl, Groethuysen, Unger, Spranger.
L’opera di Georg Misch è stata purtroppo trascurata per lungo tempo e per
vari motivi, come spiega il Mezzanzanica, e questo è accaduto sicuramente
per la difficoltà del linguaggio di Geschichte der Autobiographie (Storia
dell’Autobiografia), il monumentale ed incompiuto lavoro cui il Misch dedicò
l’intera vita e Lebenphilosophie und Phänomenologie, saggio del 1930; ma
principalmente il motivo di tale trascuratezza è di origine politica. Infatti il
Misch, essendo ebreo ed allievo del liberale Dilthey, dovette abbandonare la
propria cattedra di filosofia a Gottinga e rifugiarsi in Inghilterra fino al 1946.
Purtroppo l’importante saggio Lebenphilosophie und Phänomenologie fu mandato al macero e pertanto divenne impossibile proseguire l’interessante dibattito tra la corrente diltheyana e la filosofia fenomenologica di Husserl e
Heidegger, che il sopraccitato saggio intendeva perseguire.
L’attuale risveglio dell’interesse per Misch è dovuto soprattutto all’iniziativa
partita da Bollnow e terminata da Kühne-Bertram e Rodi dell’Università di
Bochum di pubblicare i corsi di logica tenuti dal Misch stesso dagli anni 192728 fino al 1933-34.
Nel primo capitolo del suo scritto, il Mezzanzanica descrive l’attenzione iniziale di Misch nei confronti della concezione della morfologia di Goethe, il quale ha
aperto un nuovo orizzonte per la dottrina della scienza con la comprensione della
vita nell’organismo, in ciò che è storico-spirituale e nell’opera d’arte. In effetti la
morfologia goethiana fondata sulla visione di ‘tipi’ e ‘strutture’, che scorge nel molteplice l’unità vivente che ad esso conferisce una forma, è chiaramente in connessione con la dottrina diltheyana della Weltanschauung. La più profonda ten-
NOTE
di Giorgio Bonacina
79
80
denza della logica trascendentale, che tende a spiritualizzare le leggi di natura in
leggi dell’intuire e del pensare, appare superata nella visione dei fenomeni originari, dei ‘tipi’, delle leggi di formazione che rappresentano una molteplicità di
esperienze secondo la loro struttura e il loro significato essenziale2. Lo schema
logico fondamentale goethiano qui descritto si differenzia dalla filosofia kantiana,
che separa ‘forma’ e ‘materia’ della conoscenza ed, al contrario, connette forma
e materia, sensibilità e ragione, unità e molteplicità, quindi istituisce un rapporto
tra il tutto e la parte. Ciò che Misch vuole evidenziare è l’importanza della concezione tipologica di Goethe, che riduce la varietà delle forme naturali ad un modello ideale che sintetizza il particolare e l’universale, il sensibile e l’ideale, ed in tal
modo supera la scissione istituita da Kant. In effetti la peculiarità della concezione goethiana viene chiaramente sviluppata, secondo il Misch, da Dilthey, con i
suoi studi di psicologia descrittiva e analitica, di poetica, estetica, ed in particolare in Das Wesen der Philosophie dove l’analisi strutturale permette di comprendere le varie determinazioni di contenuto della filosofia quali articolazioni di una
sua unità strutturale originaria. L’importanza del concetto di struttura nella scuola
di Dilthey, rileva il Mezzanzanica, è fondamentale perché delinea entità viventi
che possono essere “dotate di significato”, e quindi contribuisce a definire con
chiarezza il metodo della dottrina di Dilthey basata sulla Weltanschauung, che
intende individuare tipi e strutture che ricorrono nella molteplicità dei sistemi filosofici susseguentisi nella storia dell’umanità. L’Autore ritiene opportuno richiamare alcuni tratti della dottrina della Weltanschauung di Dilthey, al fine di poter
meglio individuare la formazione filosofica del Misch e le sue personali ed interessanti critiche a tale dottrina, le quali influenzeranno direttamente i suoi corsi di
logica e la stesura della Storia dell’Autobiografia. Il concetto di struttura, scrive il
Mezzanzanica, è fondamentale in quanto espressione precipua del mondo
umano, sia a livello psicologico che a livello delle formazioni storico-sociali e spirituali e costituisce un punto d’articolazione dei livelli fondamentali dell’analisi psicologica, dell’estetica e degli studi sulla dottrina della visione del mondo. Il punto
di partenza della Weltanschauungslehre è quindi il contrasto tra l’aspirazione dei
sistemi filosofici a una validità universale e la coscienza storica della relatività di
ogni tentativo filosofico di ridurre la connessione della vita a una connessione di
concetti universalmente validi; ovvero l’aspirazione metafisica che Dilthey rintraccia nella filosofia. L’analisi strutturale svolge effettivamente un ruolo importante
per indagare la connessione dei sistemi filosofici con la vita intesa sia come vita
della coscienza e vita storica; perciò Dilthey pone in evidenza il fatto che la
Weltanschauungslehre sia proprio “espressione della vitalità”3. Tuttavia il Misch
ritiene doverosa “la revisione della posizione antimetafisica di Dilthey”, e questo
perché il carattere fondamentalmente analitico del metodo diltheyano è stato progressivamente occultato dai presupposti, i quali hanno avuto l’effetto di scindere
la filosofia in una teoria del sapere riferita alle scienze empiriche e in una
Weltanschauungslehre che deve mostrare l’unilateralità dei sistemi metafisici e
contemporaneamente la loro imprescindibiltà in quanto espressioni della vita. Il
Mezzanzanica, corredando il suo lavoro con riferimenti bibliografici sempre molto
precisi, rileva come il Misch ritenga essenziale la presenza nella filosofia di un
“movimento metafisico originario” ovvero una dimensione metafisica specifica ed
NOTE
SAGGI
irrinunciabile in contrasto con la dottrina diltheyana, la quale invece riduce la
metafisica alla tendenza a risolvere la connessione della vita in una connessione
concettuale, con l’evidente rischio di dissolvere l’unità strutturale dello spirito filosofico nell’analisi genetica e storico-psicologica del fenomeno della metafisica
stessa e di disarticolare “l’intiero della filosofia”4. Nel corso del secondo capitolo,
l’Autore pone in evidenza l’indirizzo comune di ricerca degli allievi di Dilthey,
Misch compreso, nel tentativo di connettere ricerca sistematica e indagine storica, quindi teoria e storia denominata “storia dello spirito” (Geistesgeschichte), la
quale si radica nella cultura illuministica francese (Montesquieu e Voltaire) e nel
movimento classico-romantico tedesco (Herder, Schelegel e Hegel). La “storia
dello spirito” è un tipo di approccio storico che si propone di cogliere le forze che
agiscono nei singoli ambiti culturali e al tempo stesso “l’unità della vita spirituale”
che in essi si esprime. Essa si propone di cogliere i fenomeni storici nel loro carattere individuale, ricondotto però ad un elemento generale e può giungere a
mostrare una “legalità dell’accadere” e quindi a constatare l’esistenza di una dialettica tra forme spirituali ed il significato a loro attribuito nell’insieme della storia
universale. L’oggetto della storia dello spirito è, in ogni caso, l’essere umano in
quanto Faktum irriducibile ad ogni fatto delle scienze della natura, considerato
come essere storico, soggetto a mutamenti nella struttura del suo rapporto con il
mondo e gli oggetti5. Il Mezzanzanica pone in evidenza l’influsso che la storia
dello spirito ha avuto sulla Storia dell’Autobiografia di Misch: innanzitutto l’autobiografia è una forma letteraria che si radica nella storiografia e nella presa di
coscienza di sé ed esprime il sapere che la vita ha di sé senza bisogno di irrigidimenti naturalistici, essendo riflessione sull’individualità in cui si sviluppano le
“categorie della vita” e secondariamente l’importanza della Geschichte der
Autobiographie di Misch sta soprattutto nel collegare l’esperienza storica con un
procedimento sistematico che nasce da essa e perviene a concetti storici per la
comprensione dell’individuazione umana, grazie alla connessione vissuta della
vita psichica. In altre parole, l’identità tra soggetto ed oggetto del comprendere e
la circolarità tra vita ed espressione inseriscono l’autobiografia di diritto nelle
scienze dello spirito, infatti l’individuo che cerca ed esprime con la propria autobiografia una connessione significativa della propria vita, forma già “una connessione della propria vita sotto diversi punti di vista”. Chi scrive la storia della propria vita dispone della conoscenza diretta dei fatti, si trova dinnanzi a sé la sua
vita “come un intiero che porta in sé il suo significato”. Quindi l’autobiografia è l’espressione di un “processo di spiritualizzazione” che si pone sulla via dal fattuale all’ideale e costituisce per il Misch “il carattere creativo dell’accadere storico”6.
Il Mezzanzanica nota, con acume, come nella Storia dell’Autobiografia il Misch
veda all’opera una logica dello sviluppo storico nella quale il momento dell’innovazione si intreccia alla continuità del passato, quindi al “legame produttivo di ciò
che è eterogeneo”7. Sicuramente la logica dello sviluppo storico del Misch si riverbera anche sullo sviluppo, da lui inteso, della filosofia. Molto importante a livello
storiografico è, a nostro avviso, l’interpretazione di Misch del pensiero di Dilthey,
che il Mezzanzanica riporta nel volume. In effetti il Misch si trovava a contrastare
le critiche di Husserl e Rickert al proprio maestro, che consistevano nel rilevare
la frammentarietà dell’opera di Dilthey. Il concetto di vita era sicuramente la meta
81
82
a cui tendeva la filosofia diltheyana, e questo in riferimento alla tradizione della
Deutsche Bewegung ed al mutato concetto di scienza, una scienza di contenuti
spirituali, che conferiscono alla vita il suo stesso significato. In questo senso la
filosofia della vita diltheyana tentava, secondo Misch, di superare la scissione tra
scienza ed etica, teoria e prassi cioè riunificare il Doppelbegriff di filosofia, scisso
nei due ambiti della scienza e della Weltanschauung8. Inoltre il Misch, come interprete della dottrina diltheyana, sviluppava un serrato confronto tra i testi di
Heidegger, Husserl e lo stesso Dilthey nel volume Lebensphilosophie und
Phänomenologie del 1930. Il rapporto tra “filosofia della vita” e fenomenologia,
secondo il Misch, va analizzato secondo la prospettiva illuministica e quella metafisica. Dal punto di vista heideggeriano dell’ontologia fondamentale, Husserl e
Dilthey non pongono il problema del modo d’essere della coscienza e della vita.
Secondo il punto di vista fenomenologico di Husserl, Heidegger e Dilthey sono
legati al permanere sul terreno della vita e della fatticità dell’esserci; mentre,
secondo la prospettiva diltheyana, Husserl e Heidegger sono limitati al carattere
ontologico e teoretico-puro delle loro rispettive filosofie9. In particolare, il Misch
rintraccia in Husserl la possibilità di una teoria del sapere come conoscenza
assoluta, secondo l’ideale platonico di una scienza delle essenze, attraverso il
metodo dell’epoché. La fenomenologia husserliana è limitata ad un atteggiamento puramente teoretico, quindi fondata sulla soggettività intesa quale sfera di validità assoluta per la fondazione della conoscenza proseguendo così quella filosofia logico-ontologica che vuole costruire il mondo a partire da un principio razionale10. Secondo il Misch, la filosofia nasce invece dall’unione di due tipi di sapere, quello illuministico e quello metafisico, unione che riconduce all’enigmatica
polarità di tutto il vivente e prende forma nel corso della storia con la designazione di quella logica dello sviluppo storico-spirituale, già definita nella Storia
dell’Autobiografia, come “unificazione dell’eterogeneo”.
Il Mezzanzanica ci conduce al sesto ed ultimo capitolo, dedicato all’idea di
una logica ermeneutica nell’opera del Misch. La logica, secondo la concezione mischiana, è teoria del sapere ovvero logica trascendentale che connette il
sapere in senso metafisico e illuministico, ampliando i fondamenti logici fino a
superare la distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito. Con la
logica trascendentale di Kant, afferma il Misch, il significato ontologico delle
categorie si è dissolto, ma le funzioni logiche sono state connesse alla forma
del giudizio, determinando così il pensiero come giudizio. Al contrario, è fondamentale riferirsi ai “concetti della vita” come “concetti di energia del mondo
storico”, i quali si ricollegano al “sapere pre-scientifico presente nel comportamento vitale dell’uomo come comprensione del senso e della significatività”,
perciò l’espressione, nella rievocazione del significato di ciò che è stato vissuto, come forma originaria del divenir consapevoli, è il punto di partenza della
logica11. Inoltre, per il Misch, senso e significato sono sussistenti sia sul piano
logico che sul piano della vita, mettendo in luce il loro legame intrinseco con
l’atto del significare e con il mondo dell’espressione12. Al livello dell’esperienza
vitale espressione e significato sono ancora uniti in modo inarticolato, mentre
sul piano del parlare si separano e creano le condizioni per la costituzione del
soggetto e dell’oggetto come entità differenti13. Il carattere dialettico dell’arti-
1
M. MEZZANZANICA, Georg Misch. Dalla filosofia della vita alla logica ermeneutica, Franco
Angeli, Milano 2001.
2
Ivi, p. 13.
3
Ivi, pp. 16-17.
4
Ivi, p. 37.
5
Ivi, pp. 40-41.
6
Ivi, pp. 65-67.
7
Ivi, p. 77.
8
Ivi, pp. 94-96.
9
Ivi, pp. 106-108.
10
Ivi, p. 117.
11
Ivi, pp. 149-151.
12
Ivi, p. 152.
13
Ivi, p. 157.
14
Ivi, p. 165.
15
Ivi, pp. 171-172.
NOTE
SAGGI
colazione del parlare, che fa muovere il pensiero in un senso non rettilineo,
pone il problema del “circolo della conoscenza”; che Dilthey individua come
limite essenzialmente negativo della conoscenza stessa, mentre, secondo
Misch, la circolarità tra sapere e vita svolge un ruolo sicuramente positivo e
fondamentale, soprattutto nelle espressioni evocative. Qui si fa strada la
distinzione mischiana, nella generale forma discorsiva, dei due poli della “constatazione puramente discorsiva” e dell’“espressione evocativa” legati rispettivamente “agli oggetti puramente teoretici e alle configurazioni ermeneutiche,
cioè comprensibili della vita”14. Il merito principale dell’originalità della logica
ermeneutica di Misch sta, secondo l’acuta analisi del Mezzanzanica, nella sua
capacità di rivalutare la forza espressiva ed evocativa della parola all’interno
delle scienze dello spirito, oltre alle formulazioni di tipo discorsivo-teoretico. Gli
oggetti delle scienze dello spirito mantengono un carattere espressivo in quanto significano di per sé qualcosa, “hanno un proprio sé, che in quanto configurazioni ermeneutiche sono qualcosa che ha una propria potenza in opposizione alle cose prive di sé”15. Il saggio del Mezzanzanica ci fa quindi apprezzare l’originalità della concezione della logica in un filosofo come Georg Misch,
che andrebbe meditata in profondità per le sue interessanti affermazioni sull’effettiva possibilità di costituzione di una “logica ermeneutica”.
83
SCRUPOLI (E PICCOLE ASTUZIE)
DI UN MAESTRO DELLA MODERNITÀ.
NOTA SU LÉVI-STRAUSS
di Marco Gaetani
84
Se l’interesse rivestito da un libro –e l’intrinseco valore che costituisce, in
ultima analisi, la ragione di tale interesse– si misura sulla quantità di spunti per
la riflessione che esso offre al lettore, e dalla loro qualità, allora non si potrà
che definire questo esile librino1 come indubbiamente interessantissimo, e di
estremo valore: non vi è in esso pagina e addirittura riga, infatti, che non solleciti l’esercizio del pensiero, che non faccia nascere feconde curiosità intellettuali, che non alimenti il motus dell’intelligenza. Potere della parola dei maestri, certo –e Marcello Massenzio opportunamente, nella breve presentazione
“en marge” al testo, precisa come la statura intellettuale di Lévi-Strauss, il suo
contributo alla cultura del Novecento, travalichino ogni steccato disciplinare:
non è soprattutto questo carattere “a-specialistico” a farci attribuire a pochissimi, in definitiva, la qualifica di maestri, senz’altra precisazione?
D’altra parte, non si può ignorare la circostanza per cui la parola magistrale medesima, talora, risulta tanto potenziata, e come moltiplicata nelle sue virtualità euristiche, quanto maggiormente essa ci viene presentata come parola
dialogante, in dinamico confronto con quella dell’Altro e verso quest’ultima in
grado di aprirsi: parola vivente e non monologica, quella dei maestri, per definizione: offerta alla condivisione, e non dogmatica. Tra i meriti non secondarî
del libro è allora anche quello di valorizzare al meglio la forma-dialogo con la
quale esso ci si offre; anche chi interroga e interloquisce ha una insostituibile
funzione, dentro la parola stessa di colui che risponde ed ammaestra. Marcello
Massenzio adempie in maniera esemplare a questa funzione in sommo grado
maieutica, collaborante: la sua voce si intesse con quella del maestro, e senza
mai sovrapporlesi non solo la segue amorevolmente, ma anche la sostiene,
l’indirizza con garbata acutezza, ne esplora con squisita intelligenza tutte le
possibilità, ce la fa pervenire –insomma– più preziosa e più autentica, e come
dialetticamente corroborata.
Tali riferimenti alla positiva dimensione di oralità ben evidente in questo
Itineraire non devono essere assunti, però, ingenuamente: l’occasione “televisiva” del colloquio è chiarita da Massenzio stesso nella premessa cui ci si è
già riferiti più sopra. Giunge quanto mai opportuno, tuttavia, questo resoconto
scritto del colloquio; non si tratta infatti di un semplice “verbale”, della trascrizione protocollare dell’incontro umano e del confronto intellettuale avvenuti il
26 Giugno dell’anno 2000 tra Claude Lévi-Strauss e Marcello Massenzio: è
come se, per una sua qualche peculiare paradossalità, la scrittura avesse
depurato l’oralità in un certo senso “viziata” tipica della parola massmediatica
–si vedano le pagine in cui Massenzio sottolinea la concreta invasività del
NOTE
SAGGI
medium, e lo smarrimento dell’intervistato di fronte alla “profanazione” del proprio studio da parte dell’apparato tecnologico–, ed è come se perciò la pagina
scritta ci ponesse di fronte (paradossalmente, lo si ripete) alla parola nella nativa freschezza propria dell’orale, come se la scrittura riattingesse a quella viva
presenza del parlato che la registrazione audiovisiva, significativamente, tradisce proprio mentre pretende di presentarcisi come mimesi senza residui del
vissuto dialogato.
Marcello Massenzio riesce a supportare con lucida discrezione LéviStrauss nella ricostruzione del suo itinerario intellettuale, ed è anche per merito del partecipe interlocutore che scorrono in ordinata sequenza, davanti agli
occhi ed alla mente del lettore, i titoli di molte opere che hanno segnato la cultura della seconda metà del Novecento, libri circondati ormai da una sorta di
aura mitica, leggendaria: dagli inizî (o quasi) pionieristici di Le strutture elementari della parentela fino alla matura tetralogia delle Mitologiche, attraverso
tappe altrettanto celebri ed importanti come quelle rappresentate da Tristi tropici, Antropologia strutturale, Il pensiero selvaggio, Razza e storia, ecc..
Appassionatamente sollecitato dal suo interlocutore, Lévi-Strauss si sofferma
di volta in volta su alcune specifiche questioni affrontate in ciascuna opera
rievocata, chiarendone talora l’origine, prendendo le distanze da alcune tesi
sostenutevi oppure dichiarandosi ancora soddisfatto di talune altre conclusioni. Contestualmente, l’intervistatore offre l’occasione all’intervistato di soffermarsi sull’importanza ricoperta per le proprie ricerche da autori che più o meno
sovente vengono citati a proposito dei lavori di Lévi-Strauss: Mauss,
Durkheim, Jakobson, Tylor, Saussure, Trubeckoj –per ricordarne solo alcuni;
ma non mancano neppure i nomi di altri maestri del secolo, del nostro “rivali”,
sodali o semplicemente compagni di strada: Freud, Sartre, Barthes.
Significativo poi come Rousseau– nome forse meno frequentato dagli studiosi dell’opera del nostro autore, ma come Massenzio rileva suo “referente privilegiato” –catalizzi l’attenzione di Lévi-Strauss più di altri, e come proprio su
di esso– considerato il “fondatore delle scienze umane” egli si soffermi più a
lungo che su qualsiasi altro autore. A partire da (o meglio per giungere a) questo interesse per Rousseau –per alcuni versi singolare, se si guarda ai modi
in cui esso si declina– è possibile procedere ad alcune considerazioni, alle
quali si intende dedicare questa breve nota senza pretendere di esaurire con
esse tutti i discorsi ed i pensieri sollecitati da questo, sotto diversi aspetti coinvolgente, “autoitinerario” lévistraussiano.
Non c’è che dire: la conversazione di Marcello Massenzio con Claude LéviStrauss raggiunge il suo scopo: coagulandosi attorno ad alcune tematiche
capitali, indugiando su alcuni nodi teorici delicatissimi, ma anche soltanto sfiorando o facendo intravedere in iscorcio talune problematiche perennemente
“in questione” tra gli studiosi di scienze umane, essa ci restituisce infatti per
intero la cifra complessiva del lavoro del grande antropologo francese; ma
anche e soprattutto ne porta ad evidenza il significato profondo, il senso progettuale originario; e dunque pure le costitutive inevitabili contraddizioni:
andando oltre con ciò, probabilmente, alle sue stesse intenzioni. Da questo
punto di vista il volumetto costituisce un prezioso tassello per chiunque inten-
85
86
da circoscrivere con esattezza il posto occupato da Lévi-Strauss nella cultura
occidentale, e rappresenta una “pezza d’appoggio” tra le più utili a ricostruire
–confermando e suffragando, del resto, quanto già emerge dalla lettura diretta delle opere maggiori dell’antropologo– il significato storico (di storia della
cultura e del pensiero, ma non solo) incarnato da Lévi-Strauss in quanto protagonista della “rivoluzione” strutturalista. L’intervista è insomma anche un
utile strumento non tanto per “fare i conti” con l’autore di Antropologia strutturale, ma piuttosto per cercare di storicizzarne l’esperienza alla luce di ciò che
viene dopo di lui e della sua opera –vale a dire dell’accadere presente.
Operazione che sembra non essere stata condotta, a tutt’oggi, fino alle sue
estreme conseguenze– per quanto il “processo” a Lévi-Strauss (anche di questo infatti, come sempre allorché ci si ponga di fronte all’eredità dei grandi, si
tratta) avesse cominciato ad istruirlo abbastanza per tempo Umberto Eco, in
La struttura assente2.
Quello che maggiormente colpisce il lettore di queste pagine è la riottosità
di Lévi-Strauss a vedere la propria ricerca, negli anni, sotto la forma di “un itineraire”. Nelle sue risposte alle sollecitazioni dell’interlocutore pare infatti di
avvertire sempre una specie di modestia, per la quale da una parte egli si
schermisce, incredibilmente ridimensionando la novità e l’originalità dei proprî
contributi, dall’altra sottolinea l’importanza in essi avuta piuttosto dalle semplici circostanze –anche esteriori ed estemporanee, del tutto contingenti: nel
caso dell’interesse per Rousseau, ad esempio, le cose starebbero così.
Sembra addirittura che il più giovane interlocutore abbia un’idea ben chiara
dello sviluppo e degli approdi della navigazione intellettuale lévistraussiana–
eccola scandita dai titoli delle sue varie opere, inesorabilmente supportata
dalla cronologia –e che l’anziano antropologo respinga invece tale idea, come
un tentativo di storicizzare, di vedere dal di fuori– nel proprio lavoro –una
coerenza ed una organica ratio che si ha timore oppure imbarazzo ad avallare. Come se Lévi-Strauss respingesse in partenza ogni ipotesi interpretativa
“forte”, per quanto elementare e palmare, e prendesse quasi le distanze dal
proprio pensiero una volta che gli venga presentato da altrui tutto oggettivato.
Ostinandosi a non volersi riconoscere nella saggia ricostruzione che la controparte mette sotto i suoi occhi (con la conseguente, straniante –ma appunto
per questo particolarmente significativa– impressione che Massenzio sappia
più su Lévi-Strauss di Lévi-Strauss stesso), il vecchio maestro dà l’impressione di non sopportare di esser riguardato dall’esterno, di non reggere la vista
della sua posizione teorico-metodologica irreversibilmente calata dentro la
storia e ad essa come definitivamente inchiodata. Attraverso gli occhi dello
studioso più giovane egli si sente giudicato, e teme che il suo progetto originario di senso emerga in tutta la sua ambivalenza, o semplicemente si manifesti nella sua portata di progetto. Non è gratuito il riferimento –quasi immediato, ad apertura di colloquio– all’antropologia (alla propria antropologia, l’americanistica) come disciplina del senso di colpa: un “péché inexiable” grava
sull’autore, il quale sa così bene di non poter essere il miglior giudice della propria opera da cercare di essere almeno il suo miglior difensore. Con il conseguente snaturamento del ruolo di Massenzio, inquisitore malgrée lui.
NOTE
Tutto è già evidente fin da sùbito, tuttavia, e gli elementi che aiutano a
veder chiare le ragioni profonde di questo singolare comportamento sfuggente sono già dati, fin dalla prime battute del dialogo –in cui infatti viene offerta
(quanto consapevolmente?) la chiave per comprendere il significato di tutta
un’esperienza intellettuale, per intenderne la peculiare valenza ideologica. Ci
si riferisce, ora, alla tempestività con la quale Lévi-Strauss si affretta a prendere le distanze dal pensiero postmodernista a proposito della magna quaestio relativa alla divaricazione (o viceversa alla convergenza) tra natura e cultura. La pretesa, attribuita a molti esponenti del sopra menzionato orientamento, di considerare tale opposizione come del tutto estranea alle civiltà “primitive”, e propria invece della forma mentis occidentale, viene respinta con
gesto che ci sembra in fin dei conti abbastanza inspiegabile, venendo da chi
parrebbe invece avere in molti modi precorso e favorito tale esito, tale tendenziale reductio ad unum. Ma l’istinto di difesa dell’antropologo non conta
meno, in questa subitanea presa di distanza, delle altrettanto profonde ragioni teoriche e ideologiche che Lévi-Strauss intende, più o meno consciamente,
far valere durante tutta l’entretien. Ha ragione Massenzio –contro le proteste
di modestia e la insistente propensione a ridimensionare del suo interlocutore– nell’attirare l’attenzione sulla suggestiva formula lévistraussiana che ci
parla di una “natura che supera se stessa”. Lo studioso italiano ha messo
infatti il dito nella piaga, dirigendosi al cuore stesso del cosiddetto kantismo di
Lévi-Strauss. Sùbito dopo si assiste ad un nuovo schermirsi del maestro, che
vorrebbe circoscrivere il contributo di Antropologia strutturale alla sua semplice funzione storico-culturale di “véhicule” delle teorie della linguistica strutturale, suscitando così –ancora– le ben comprensibili proteste del suo intervistatore. Ma il cerchio ormai si stringe: proprio il riferimento di Massenzio ad
una questione cardinale –dirimente, potrebbe addirittura dirsi– come quella
dell’efficacia simbolica porta Lévi-Strauss a venire finalmente allo scoperto, e
ad esplicitare la formula che a buon diritto potrebbe essere identificata come
il principio-guida di tutto il suo operare teorico: “comprendre de façon rationelle des choses qui semblent totalement irrationelles”. Qui le cose divengono
esplicite, apparendo integralmente il senso di tutto il progetto –esistenziale
non meno che intellettuale!– di Lévi-Strauss: l’Accademico di Francia ha realizzato, attraverso i suoi molti libri, il sogno del liceale-cartesiano, vale a dire
quello di fondere sensibile ed intellegibile in un’unica dimensione, di legare i
due orizzonti ad un solo destino.
Ciò che più importa è tuttavia di sapere in che modo tale sogno di adolescente sia stato concretizzato attraverso la prassi teorica dello studioso. E
questo pare essere avvenuto restando Lévi-Strauss a tutti gli effetti cartesiano, vale a dire “elevando” il primo livello, del sensibile, all’altezza del secondo.
In questo Lévi-Strauss è davvero un degno epigono di Freud, figlio cioè della
Modernità: un frutto pregiato e tardivo degli estremi sviluppi della metafisica
occidentale. Emergono –nel colloquio con Massenzio– non poche tracce del
fatto che tale processo di integrazione, di assimilazione e insomma di riduzione del sensibile all’intellegibile è stato effettivamente innescato, e portato a termine con magistrali rigore e perizia. Quando ad esempio –di nuovo infallibil-
87
88
mente– Marcello Massenzio rileva il fascino appassionante di un sapere teorico non disgiunto dal sentimento, e addita l’orizzonte davvero euforizzante
che lascia intravedere il sodalizio tra “taxinomie” e “amitié tendre”, si ha nuovamente l’impressione che il maestro non voglia o non possa intendere: la ricchezza dell’Inuit è da lui rimandata –riferendosi al canonico esempio delle
incredibili possibilità lessicali a disposizione in quella lingua per il referenteneve– a quella stessa propria dei linguaggî tecnici e settoriali; la profondità
delle lingue “primitive”, ancora, viene fatta coincidere con la loro capacità d’astrazione: vale a dire con la loro somiglianza a quelle non primitive. È come se
Lévi-Strauss non tenesse dietro alle sollecitazioni del suo interlocutore, come
se richiudesse immediatamente tutte le prospettive che questi invece intravede e vorrebbe spalancare, sottoporre all’acume del maestro.
In realtà l’unica “comprensione” cui Lévi-Strauss crede per se stesso e per
gli esseri umani, e che gli interessa davvero, è quella della Ragione, l’”intellezione” (in senso sartriano3) capace di inglobare nel proprio stesso processo
cognitivo –vale a dire nella propria specifica forma– tutti gli aspetti della realtà, e che finisce per scoprire come siano quelli suoi proprî i meccanismi celati anche nella macchina-natura. Non sembrano esservi margini per alcuna
esplosione (si pensa a Lotman) al di fuori delle rigide ed ubique strutture di
quest’unica Ragione onnicomprensiva: anche il mito –che sembra essere territorio per eccellenza exlege– deve avere, ci ha insegnato il maestro, le sue
leggi occulte, che è compito dell’antropologo di svelare. La Ragione avanza
imperterrita in questa sua opera di dissodamento, in questa rincorsa all’autosvelamento, e procede alla “comprensione” nel senso della “annessione”: di
quei territorî all’interno dei quali meno pareva avere titolarità. L’importanza del
ruolo del pensiero di Freud nella propria formazione, il suo “apport fondamental” è da Lévi-Strauss, del resto, dichiarata senza infingimenti. I rischi da lui
assunti saranno allora quelli stessi corsi dal medico viennese: un simile esercizio oltranzista ed intrusivo della Ragione non può che mostrare tutta la sua
ambiguità: la Ragione occupa ogni interstizio dell’esperienza, ma così sconfinando si confonde col suo opposto, si ribalta in esso: viene definito “una rêverie” l’approdo, pure teoricamente coerentissimo, nel porto seppellito di un
unico mito binario –il manicheismo vuoto e desolato di L’uomo nudo.
La Ragione (moderna) incalza e si appropria della Natura, pretende di riconoscervisi sempre. L’Utopia lévistraussiana coincide con un essere umano
legato a tale Natura, parte di essa per il medium di una struttura razionale
immanente e comune. L’ontologia strutturale, si sa, è fuori dalla storia –quella
stessa storia che Lévi-Strauss nega di avere mai disconosciuto se non nelle
sue sterili forme accademiche, e che poi invece si scopre rischiare (non certo
casualmente) di essere anch’essa inglobata dalle fauci della Ragione etnologica. Alquanto significativo, inoltre, che il riconoscimento del contributo dato da
Tylor alla fondazione dell’antropologia sia identificato nell’intuizione, da parte
dell’antropologo britannico, della presenza di leggi onnipresenti; e non meno
illuminante –anche per quanto si è detto a proposito dell’ascendenza razionalistico-cartesiana del pensiero di Lévi-Strauss– la rievocazione cui l’etnologo
procede dell’effetto provocatogli dalla lettura dell’Essai sur le don, effetto para-
NOTE
gonato a quello avuto da Malebranche leggendo Descartes: anche LéviStrauss sembra aver ricercato un suo nuovo Cartesio, con il quale sostituire
quello vecchio, ed averlo trovato non (sol)tanto in Mauss, con i suoi “rapporti
invarianti”, ma nei varî Freud, Jakobson, Saussure –e negli altri maestri della
Ragione moderna. Ed altrettanto significativo –nonché coerente con la già
segnalata strategia di auto-ridimensionamento constatabile per tutta la durata
della conversazione– come egli minimizzi anche la celeberrima polemica contro Sartre e lo Storicismo, pure puntualmente da Massenzio evocata (neppure di una querelle, si sarebbe trattato): vale a dire rimanendo più che mai evasivo sul merito teorico di quella discussione, e concentrandosi piuttosto sul
ruolo svolto –ancora– dalle mere circostanze estrinseche e contingenti
(l’”incrociarsi” del tutto casuale di due opere come la sartriana Critique e La
Pensée sauvage). Tale evasività non deve apparire come dettata dal proposito di adeguarsi alla natura divulgativa-massmediatica della discussione, con la
conseguente deliberata opzione di non addentrarsi nella disamina di questioni filosofiche effettivamente molto complesse: si è già detto come per tutta l’entretien Lévi-Strauss tenda a valorizzare l’importanza delle circostanze, anche
minime, a fronte di ogni tentativo di ricostruzione non si dirà teleologica ma
almeno obiettivante e storicizzante della propria esperienza intellettuale (affermazione esemplare di questo atteggiamento: “Je dirai que ça [l’analisi strutturale dei miti] fait partie du programme que je me suis trouvé avoir suivi. Non
pas du tout que je l’aie tracé à l’avance, ce sont les circonstances qui en ont
décidé”4); e neppure, si tratta, di una posa da gran vegliardo del pensiero
–pure altrove snobisticamente apparecchiata, riferendosi alle inevitabili lacune
della memoria di un uomo che “coincide con il secolo”. Si tratta, piuttosto, di
una estrema fedeltà e di una strenua coerenza rispetto a quella proposta intellettuale e ideologica originaria cui sopra si è fatto riferimento.
Questo maestro che afferma di essere vecchio quanto il secolo vuole essere fino in fondo fedele al suo secolo, e conosce se stesso ben più di quanto
forse non voglia far credere. Nella sua opera l’esercizio del pensiero finisce
per assorbire ogni aspetto della realtà, e si insinua fin nelle zone per il logos
meno ospitali: il pensiero è dietro alla “rêverie” non meno che al mito. L’a priori della Ragione ontologica è l’ombra di cui non ci si può liberare, ed è per questo che esso rassicura e dà certezza, esattamente come il cogito cartesiano.
In virtù di questo a priori si può ben scoprire, allora, che Durkheim –studioso
vecchio stampo– apprese tutto delle società australiane senza muoversi dal
suo accademico scrittoio, facendo a meno di ogni ricerca sul campo. Il pensiero è garantito in partenza, in quella che rischia di configurarsi come una
scolastica più l’agostinismo –circostanza che rimanda ancora, a ben vedere,
a Descartes. Come la musica e come la mitologia, il pensiero diventa una
macchina per sopprimere il tempo lineare: che cosa sono le invarianti strutturali, se non delle “tranches sovrapposte”? Esse coesistono senza essere reciprocamente ingranate, perché ad organarle tra di loro –e con la Ragione conoscente che puntualmente le riflette– è sufficiente il loro esser dentro ad una
necessità rigorosa che tutto involve. Non è davvero snobismo l’affermare –di
fronte all’incalzare dell’interlocutore, che tenta di delineare un coerente “itine-
89
90
raire” lévistraussiano– che il proprio reiterato atto di comprensione del mondo
non origina affatto da motivazioni profonde, e che si è tanto e tanto bene operato semplicemente per non annoiarsi: è invece saperla lunga sulla natura
della propria posizione teorica. Ancora una volta, però, si può vedere come il
“comprendre” lévistraussiano non possa che essere usato soltanto come sinonimo di “capire”, “classificare”, cioè allegare nuovo materiale al faldone etichettato “Ragione”. Una attitudine da collezionista, questa –se non proprio da
bricoleur…–, o anche quella propria di chi sappia in partenza che i conti
dovranno comunque tornare, e il cui gusto è semplicemente nel verificare in
che modo ciò accadrà. Tutto questo il maestro non può che avvertire come
una colpa inespiabile: il postmoderno –l’infernale oggi che viviamo– rappresenta la sua cattiva coscienza.
Veniamo infine –come preannunciato– a Rousseau; c’è un’ambivalenza
palmare nella considerazione che Lévi-Strauss dimostra di avere del “più etnografo dei filosofi”. Da una parte, si può facilmente notare una esplicita ammirazione nei suoi confronti, che rischia di sfociare in una indubbia proiezione
identificativa; Rousseau deve infatti le sue fondamentali intuizioni anche al suo
essere stato “homme de terrain”, cioè al suo essersi dimostrato in grado di
vedere l’uomo come parte della natura, non estraneo al suo ambiente. Ciò
fuori da ogni suggestione romantica, perché da buon erede dell’Illuminismo
Lévi-Strauss concilia Descartes con Locke, “schiacciando” così impercettibilmente –per così dire– Rousseau su Voltaire: l’“expérience directe du terrain”
cui egli pensa è esattamente quella stessa propria di quegli “autori inglesi e
americani” il cui empirismo anglosassone integrerà la speculazione positiva
del continentale Durkheim.
In questo contesto di sostanziale, per quanto eterodosso, apprezzamento
per Rousseau si colloca poi l’abbozzo dell’interpretazione –spregiudicata e del
tutto non convenzionale– proposta da Lévi-Strauss a proposito del pensiero
roussoviano, interpretazione secondo la quale l’autore ginevrino si sarebbe
riferito per prima cosa ad una umanità “allo stato zero”, mentre l’età dell’oro
dell’umanità sarebbe stata da lui vista coincidere con il neolitico; a quest’epoca sarebbe seguita –infine– una corruzione, dovuta all’insorgenza del circolo
perverso “aumento demografico – civiltà della tecnica”. Per altri aspetti LéviStrauss prende tuttavia le distanze da Rousseau: laddove, ad esempio, egli
vede l’emergere nella sua opera di un individualismo virtualmente anarchico,
a-politico (frutto paradossale, questa atomizzazione dell’individuo, del dominio
preponderante della volontà generale: ribaltamento bizzarro del culto della collettività): esplicita sarà allora la contrapposizione tra il moderato Montesquieu,
cui si indirizza la dichiarata simpatia dell’autore, e il Rousseau “padre” dei giacobini. La preferenza cade ancora su di un autore che valorizza la loi, come
Tylor. Ecco: appare proprio qui, vale a dire “aggirandosi” nei dintorni di
Rousseau e delle sue costitutive ambiguità storiche, il sacro terrore di fronte
alla libertà assoluta, la vertigine che coglie trovandosi di fronte ad essa: da
questo sentimento panico nasce l’esigenza lévistraussiana –a questo punto si
potrebbe azzardare: psicologica prima ancora che teorica– dell’ordine, del fondamento, della regola, della struttura; il bisogno di circoscrivere, di semplifica-
NOTE
re, di ridurre analiticamente, di “smontare l’orologio” attraverso il logos alla
ricerca di leggi generali e rapporti costanti, tale bisogno è tutt’uno con l’affermazione dell’importanza del vincolo, del limite, del nomos.
L’esempio più caratteristico di questa esigenza originaria di strutturazione
ontologica del reale è dato probabilmente dall’attitudine lévistraussiana di fronte al linguaggio: laddove Lévi-Strauss pare evocare –affrontando il tema cruciale della libertà– il fantasma dell’antico avversario Sartre, ecco che invece
–e proprio mentre il lettore si aspetta di veder comparire, da un momento all’altro, il nome di colui che invece, evidentemente, deve essere ridimensionato o
rimosso– ecco che invece sùbito d’improvviso compare quello di Roland
Barthes. Avviandosi a concludere la conversazione il maestro sembra cioè
voler riprendere la schermaglia contro il postmoderno, con cui il colloquio era
stato inaugurato. Giunto quasi in chiusura dell’intervista la ben nota provocazione di Barthes sull’equivalenza tra linguaggio e fascismo offre l’opportunità
per ribadire –con forza vivace, con pronta reazione– l’esigenza della struttura,
la cui presenza soltanto ci vien detto poter consentire la libertà. Libertà che per
Lévi-Strauss non può che essere allora una libertà condizionata, quella dello
scacchista che –appunto in quanto tale– non può che stare alle regole del
gioco. Si può osservare proprio a proposito delle osservazioni sulla libertà e
sul linguaggio la ragione di ciò che si è detta la –del resto monumentale– “cattiva coscienza” di Lévi-Strauss (ma della Modernità tutta intera), vale a dire
quella sostanziale congruenza con gli esiti postmodernisti che non a caso
sùbito l’autore si era premurato di esorcizzare, suscitando non poche perplessità: il maestro sa bene, infatti, che tali esiti costituiscono l’altra faccia di quella reductio ad unum di cui egli stesso aveva sentito, liceale ancora, l’esigenza
e che attraverso il suo coerentissimo “itineraire” aveva tenacemente perseguito e prestigiosamente realizzato nei termini “cartesiani” che si sono osservati.
Ed infatti laddove per Lévi-Strauss è la Natura che “supera se stessa”, facendosi cultura senza soluzione di continuità –e questa Natura è Ragione non
meno della cultura–, nel postmoderno si assiste alla nascita di un monismo (e
di un conseguente monologismo) eguale e contrario: perché se è vero che la
monade presente viene egemonizzata dalla rappresentazione, e la Natura non
esiste più, è altrettanto vero che tale rappresentazione è pur essa Ragione
–ancorché storica e non naturale.
In questo presente compattamente chiuso su di sé Lévi-Strauss, l’uomosecolo, si trova a vivere, oggi; un presente ormai senza-natura e gremito di storia, in cui tutto è pertanto virtualmente reversibile e nulla lo è davvero; in siffatto presente il maestro si riconosce antico, cioè moderno. La sua “réaction pessimiste” nasce dall’aver smarrito l’alveo protettivo della Ragione-Natura, dal
fatto di scoprirsi inopinatamente vivere nel Caos senza fondamenti: è significativo che Lévi-Strauss, nelle righe conclusive della conversazione, parli dell’epoca presente ricorrendo a parole assai simili a quelle usate in precedenza per
descrivere il passaggio dalla “prima” alla “seconda” fase della periodizzazione
“roussoviana” da lui stesso proposta: aumento demografico (“l’evento del XX
secolo”, significativamente), la fine di una ricchezza e di una diversità umane
viste coincidere, sostanzialmente, con la persistenza e la coesistenza di picco-
91
92
le comunità legate al territorio, e già per questo conformi alla Natura –con implicita contrapposizione ai fenomeni di acculturazione omogeneizzante tipici della
postmodernità, all’oblio della Ragion naturale. Aveva visto giusto, l’ospite italiano, quando registrava smarrimento negli occhi del maestro di fronte all’invasione tecnologica della sua dimora, quando prestava sensibile ascolto alla sottile
inquietudine provocata dall’irruzione del Caos della storia dentro la cella protetta in cui ronza la Ragione, e costruisce operosa i suoi certi dominî –iridescente gemma posta al centro del diadema-universo, pietra preziosa sulle cui
molteplici facce il mondo riflette ancora le sue sembianze multiformi.
Ma giova concludere ritornando ancora a Rousseau. Lévi-Strauss sembra
non accorgersi (non volersi accorgere) del legame che unisce il linguaggio
scientificamente insoddisfacente dell’autore delle Confessioni alla qualità tutta
stilistica di tale linguaggio: da una parte l’antropologo del XX secolo, infatti,
non intende nascondere il proprio disappunto per l’approssimazione tutt’altro
che scientifica di colui che, per questo, non può che essere visto soltanto
come un precursore, forse perfino un po’ rozzo ed involuto rispetto ai suoi ben
più sofisticati successorî; dall’altra egli non può non restare ammirato di fronte allo “stile” dello scrittore. Ora –nota Lévi-Strauss con grande acutezza–,
attraverso questo stile tanto suo peculiare Rousseau si dimostrerebbe in
grado di dire con poche parole, o meglio “sous forme raccourcie”, cose che
avrebbero avuto altrimenti bisogno di lunghe e complicate perifrasi per essere espresse. Lévi-Strauss sembra però voler attribuire questa circostanza alla
natura esclusivamente anticipatrice, e non ancora storicamente perfezionata,
dell’opera del pensatore ginevrino. Come dire: quelle stesse cose saranno
dette meglio più tardi –soprattutto nel Novecento– ad opera degli eredi legittimi del “fondatore delle scienze umane”. Si giunge perfino a cercare di giustificare le tesi –come già visto distanziate– del Contrat social riferendosi al suo
carattere di “fragment”, a mostrarne l’intrinseca impervietà testuale, “qui oblige constamment à la réflexion pour comprendre exactement ce que Rousseau
avait dans la tête et voulait dire”. Fa quasi tenerezza la goffaggine di quel
“dans la tête”, del resto alquanto significativo di molti e fondamentali aspetti
dell’impostazione epistemologica lévistraussiana. Come significativo appare
anche quel “comprendre exactement”, ossimoro in cui è tutto il dramma storico ed intellettuale di Lévi-Strauss, contraddizione in termini in cui si inscrive
l’impasse della Modernità.
In realtà quello stile-prodigio, quella écriture capace di chiudere inspiegabilmente in linguaggio un senso irripetibile, riuscendo a farlo intendere agli
altri, è esattamente un modo di aggirare le “invarianti” del linguaggio medesimo e della Ragione. Sartre (già, ancora Sartre…) fa vedere molto bene come
funzioni questo paradossale fenomeno, proprio a proposito di Rousseau;
quando l’autore della Critique (in L’écrivain et sa langue5) si riferisce a questa
frase vertiginosa roussoviana, altrettanto incredibile di quelle che, probabilmente, non hanno mancato di colpire Lévi-Strauss fin dalla giovinezza: “Ero
dov’ero, andavo dove andavo, mai oltre”. Comprendere il senso di questa
affermazione significa, per Sartre, non tanto “smontare l’orologio” del linguaggio e della ratio su cui tale linguaggio si sostiene, ma piuttosto “ritrovare” l’e-
NOTE
spressione stessa, e “fondarla” conservandone “la densità concreta del vissuto”. Tale densità concreta del vissuto –altrettanto tenacemente avversata (fatto
del resto estremamente significativo) che la storia ed il pensiero dialettico: si
veda l’incomprensione lévistraussiana “des maîtres italiens en matière d’histoire des religions”, non a caso contestuale al rigetto di ogni considerazione
gnoseologica della “vie émotive” del ricercatore –proprio tale densità, dunque,
è serbata nella lingua letteraria, nelle forme di comunicazione/espressione
simbolica; attraverso tali forme è possibile dire di più, senza per questo privarsi di una “conoscenza per nozioni”.
A quest’ultima forma di conoscenza soltanto, tuttavia, Lévi-Strauss sembra
aver sempre creduto nel corso della sua lunga vita, e aver consacrato ogni
fatica della sua vicenda intellettuale: “j’ai choisi d’ouvrir la montre”. Oggi, quella fede gli si ritorce contro –come il riflesso del fotoperatore proiettato sulle
lenti degli occhiali del maestro, nell’immagine che lo ritrae insieme al suo gentile inquisitore collocata in fondo al nostro volumetto; gli si ritorce contro nell’estrema fase dell’esistenza, in cui il vecchio maestro fronteggia con strenua
coerenza e qualche “glissando” il fallimento dell’utopia della Ragion moderna.
Nel suo più giovane interlocutore egli vede continuamente chi lo svela, chi
potrebbe scoprirlo e mostrarne il disegno a petto della storia: perciò egli cerca
di sfuggire a certe osservazioni dello studioso italiano, pure oltremodo perspicue e suggestive; per questo cerca di “giustificarsi” talora troppo prosaicamente, tenta di smorzare i toni, di chiudere ogni possibile implicazione che sia
avvertita come anche soltanto remotamente pericolosa: Lévi-Strauss vuole far
credere che tutto –dalle strutture elementari della parentela ai caratteri del
mito– sia stato rinvenuto casualmente –e dimostrare con ciò che qualsiasi
strada avrebbe comunque portato alla Roma della Ragione ontologica, che il
suo sapere è eterno.
Probabilmente Lévi-Strauss sente di essersi rivolto, mediante il suo lavoro
di antropologo, alle manifestazioni umane proprie di quella fase “neolitica” che
–con il “suo” Rousseau– più prossima gli appare rispetto allo “stato zero”
–oggettivo e senza determinazioni assiologiche– in cui si danno le strutture
invarianti. In virtù di questa loro supposta maggiore vicinanza all’assoluto ora
si rimpiange la fine delle culture tradizionali sotto i colpi inesorabili della civiltà
postmoderna. Ma un rovello non cessa di affacciarglisi, l’incubo-Barthes, lo
strutturalista che sviluppa con temeraria coerenza, fino in fondo, le sue ipotesi di partenza, e si abbandona finalmente alla deriva postmodernista: il “très
long effort” di una vita si rivela fondato nient’altro che sul nulla, posto in atto
soltanto pour ne pas s’ennuyer. L’”inespiabile colpa” che questo maestro della
Modernità sente, forse, oscuramente tanto gravare su di sé coincide con la
responsabilità che si avverte nei confronti dell’oggi, con il sospetto –continuamente allontanato da sé– che la propria opzione in favore dell’eterno sia in
qualche modo legata ad un’altra eternità: quella infernale del presente.
93
1
C. LÉVI-STRAUSS, Un itinéraire. Entretien avec Marcello Massenzio, 26 juin 2000, L’Échoppe,
Paris 2002.
2
Si veda soprattutto quel vero e proprio pamphlet (definizione dello stesso Eco) costituito dalla
sezione D del saggio.
3
Entretien sur l’anthropologie, poi L’anthropologie in Situations IX – mélanges, Gallimard,
Paris, 1974.
4
Corsivi aggiunti.
5
Ancora in Situations IX – mélanges.
94
L’EPICA ODISSEA
COME NAUFRAGIO DELLA MENZOGNA
“Una verità cessa di essere vera quando
è creduta da più di una persona”
O. WILDE, Chamaleon, dicembre 1894
NOTE
di Romualdo Rossetti
1. Pellacis Ulixi: lo stratega dell’impostura.
Chi è quell’eroe omerico che rappresenta meglio di altri il dramma dell’uomo occidentale contemporaneo? Di quest’ultima umanità persa nei meandri
della propria voglia di possesso, schiava della propria morbosa curiosità, blasfema a tal punto da riuscire a servirsi dell’inviolabilità del sacro per il solo proprio tornaconto economico?
È facile, per chi non ritiene la lettura dei classici greci una noiosa perdita di
tempo, risalire alla figura del mitico Odisseo, frutto questi non dell’amore di una
donna per il suo uomo, ma della vendetta di due ladri incalliti1, tanto che nel
nome stesso dell’eroe di Itaca Odysào –imposto dal nonno materno– risuona
una radice terribile: quella appunto che testimonia l’odio, l’ostilità più profonda2
nei confronti dei propri rivali. Odisseo, l’eroe greco che più di ogni altro ha riposto la sua fortuna nella facoltà e nell’uso spregiudicato della propria intelligenza, un’intelligenza che non si ferma a comprendere, volta per volta, il dato storico, ma riesce abilmente a prevedere gli stessi eventi immergendosi nella psicologia di chi gli sta vicino: “In Ulisse l’ingegno è sempre indicato al massimo
grado: polymetis, poliméchanos, polytropos. A lui sono attribuiti gli aggettivi che
indicano le diverse sfumature dell’intelligenza preceduti dal prefisso poly-, che
ne moltiplica esponenzialmente l’efficacia, l’articolazione e i poteri. L’Ulisse
omerico è, infatti polymetis, ossia “ricco di mêtis”, polivocamente dotato di quella facoltà plurale […] che consente di cogliere rapidamente i termini di una
situazione, adattandosi a essa nel modo migliore. Ma Ulisse è anche polyméchanos, “ricco di stratagemmi”, indicando con le mechanaì quei “congegni” che
la mêtis, una volta colta l’effettività del problema con cui si ha a che fare, utilizza per oltrepassare la resistenza concreta delle difficoltà, vuoi risolvendole,
vuoi aggirandole. Egli, infine, è polytropos, ovvero “ricco di espedienti”, “adattabile al massimo grado”, “pieno di risorse” che gli consentono di cambiare direzione e punto di vista a secondo delle circostanze”.3
Però, nonostante l’arguzia che denota le sue gesta epiche, non riesce questi, a sottrarsi alla sventura di una vita errabonda della quale in ultimo sembra
apprezzare quasi il pericolo. La sua esistenza è un’esistenza costellata da trovate geniali che gli rendono giustamente merito –come quella che lo vede fin-
95
96
gersi pazzo4 per evitare di partire per Troia o quando riuscirà a smascherare
Achille5 dal nascondiglio nel quale sua madre Teti lo aveva nascosto perché
non partisse per l’assedio che lo avrebbe ucciso– e di altrettante sconfitte esistenziali che lo vedono bistrattato esule in terre straniere.
La sua morbosa curiosità, alla quale deve la propria sventura, accompagna
di pari passo la sua genialità, ed è la stessa che si ritrova a possedere oggi
l’homo oeconomicus occidentale, quello che forgia astutamente le proprie fortune calpestando quelle del suo prossimo: “Ulisse è anche in Dante, come in
Virgilio, scelerum inventor, e ‘giustamente’ collocato tra i fraudolenti, perché
inganna e s’inganna sul senso della propria ‘caccia’. Egli concepisce la ricerca (e all’inquisitio, all’interrogatio è certamente chiamata la nostra ‘semenza’)
come ricerca di qualcosa sempre oltre di sé. Nessun ente finito può soddisfarlo, ‘contentarlo’, e tuttavia non sa che trascorrere da finito a finito. L’infinito,
cui certamente anela, gli si manifesta sempre nella forma dell’obiectum da
afferrare e comprendere […]. Ulisse non è libero, perché ogni volta quel luogo,
quell’ente, quell’aspetto finito del mondo, lo incatenano; e anche quando, vecchio e stanco, giunto alla ‘tanto picciola vigilia’, pretende di potersi ‘trascendere’, di poter oltrepassare ogni finito, di nuovo ripete il suo errore”.6
La sua affinità all’homo oeconomicus contemporaneo non è un accostamento azzardato poiché economica era la sua scelta che, di volta in volta,
riusciva a subire il male minore, in uno stillicidio continuo di antiche amicizie,
nuovi amori, dolci ricordi e vane speranze. Così Odisseo continua ad essere
la metafora di chi continua a serbare rancore dinanzi alle eccezioni che la
natura gli riserba. È l’allegoria dell’ira funesta di chi vorrebbe dominare il
mondo ma ne è al contrario dominato per l’incapacità umana di possedere il
tutto, l’inconoscibile. L’eroe di Itaca incarna la tragedia di chi ama gestire ed
invece è gestito dagli eventi e dalle eccezioni delle regole che ha creato e nelle
quali ripone la sua fiducia, la sua stessa esistenza.
La sua navigazione nel mare dell’ignoto rappresenta l’immagine di colui
che si abbandona volontariamente alla veemenza degli eventi –ed è questa la
vera fides dell’eroe– alla forza di quel nulla primigenio che è l’incognita esistenziale più alta che però, si badi bene, mal si presta ad essere considerato
come ni-ente, come assodato sensibile della mancanza d’essere. All’opposto,
il nulla come ignoto rappresenta per il Greco l’unica persuasione ontologica
possibile che ci sostiene nell’esistenza terrena, anche in quella più tormentosa e buia, e che ci spinge a sfidare il divino, il nascosto che ancora non si è
riusciti svelare e possedere.
Il “mare oscuro dell’ignoto” diverrà ben presto per Odisseo e la sua progenie il gymnasium mentis che ci allena nella ri-cerca. L’arte del comprendere non sarà più considerata come “dono divino”, ma come vera e propria tèchne nautiké, strategia, filosofia, capacità di trovare la soluzione migliore
momento per momento: “La filosofia deve ‘salpare’ da ogni dóxa, da ogni
Nomos acquisito solo per forza di tradizione –ma, ad un tempo, e con tutte le
sue energie, contrastare l’equivalenza tra giusto ed utile, tra giusto e semplice equilibrio di potenza, tra giusto ed effettuale. Il viaggio della filosofia sarà,
allora, rivolto a guadagnare una terra ancor più salda di quella abbandonato,
2. Timeo Danaos et dona ferentes
Abbiamo detto di come Odisseo si dimostra eroe ma bisogna pure ricordare di come Odisseo, palesandosi, si doni di fatto agli altri. Del suo dono,
però, bisogna tenere in debito conto le conseguenze future che contiene. Vi è
NOTE
un Nomos finalmente ben fondato. Il mare apparirà via, metodo; e il possesso
del metodo, della diá-noia, del dis-corso, vera tèchne nautiké, strumento
necessario alla nóesis, alla perfetta, e in quiete, intuizione del vero ”.7
L’amore-odio che Odisseo ha per l’elemento marino dipende dalla sua
hybris, dalla sua tracotanza tutta ellenica che lo spinge a sfidare tutte le divinità del mare (Teti8 per la morte di Achille e Nettuno per l’accecamento di
Polifemo) che dovrebbero invece proteggerlo nel ritorno a casa e su cui ripone le speranze di salvezza dei suoi uomini. Il mare è nonostante tutto per l’eroe omerico l’elemento indispensabile per le proprie fortune; lo scrigno ricolmo
di ricchezze e di azzardi. Sarà polyphloisbos ovverosia: una “pianura” d’acqua
multisonante di lingue diverse, un palcoscenico ricolmo di attori diversi. Un distesa infinita d’acqua salata ricco di isole e caverne, gorghi ed inganni, insenature e fortezze; un labirinto di luoghi dissimili, dove l’unità si frantuma per
ricompattarsi più forte di prima, dove l’unica possibilità di risoluzione del problema dimora nella hybris della propria appartenenza, nella tracotanza più crudele che alloggia nel fondo dell’anima di ognuno. Sarà l’ambiente dai più nomi
e dai più significati: “Thálassa è per i Greci quello più usuale perché quello
materno: nel suo grembo sono cresciuti, lungo i suoi cammini hanno viaggiato per conoscere, combattere, commerciare. Thálassa: mare nostrum,
Mediterraneo. Non è nome generico del mare, è nome di persona. Pélagos
rappresenta la vasta distesa, l’interminabile plaga dell’alto mare. Quando,
come un deserto, il mare ci abbraccia da ogni lato, e ad un tempo ci custodisce e minaccia, quando il suo essere senza-limite contraddice con la massima forza il nostro ‘ritmo stento’, il nostro ‘balbo parlare’, allora esso assume il
nome di pélagos. E le ‘salmastre parole’ che ne intessono il canto appartengono allo háls, all’ undantem salum di Ennio. È il Mare come Sale: la via difficile-amara che sempre ci si agita intorno, perennemente inquieta. È, insieme,
il movimento e il sapore del Mare, la sua onda che si leva e ci bagna. Ma quando possiamo immaginarci il Mare come cammino, quando l’occhio discerne
nell’inquietudine del pélagos la possibile via, e la cerca e la prova, allora póntos diviene il suo nome più proprio (è lo stesso nome che indica il cammino in
sanscrito e in avestico). Un ponte è perciò anche il Mare –il più necessario e
arrischiato dei ponti, così come il ponte è il più arrischiato e necessario dei
sentieri tracciati dall’uomo”.9
La sua talassocrazia è tanto più regale quanto più si inoltra nell’incognito
che il mare rappresenta, un’incognita esistenziale che lo sprona a sfidare déi,
eroi, mostri ed amori. La sua eroicità risiede nell’azzardo, nel rischio corso alla
luce della ragione; di quella stessa ragione che contraddistinguerà, nel bene e
nel male, la storia politica ed economica del nostro continente culturale.
97
98
difatti un’enorme differenza tra i doni che il Greco elargisce e quelli che, invece, riceve nel corso della sua esistenza. I suoi nascondono sempre un tranello mentre quelli che riceve gli si dimostrano utilissimi come: la costante protezione di Minerva, l’otre ricolmo di venti favorevoli donatogli da Eolo, i consigli
di Agamennone nell’Ade, l’immortalità promessagli dalla ninfa Calipso10, la
nave offertagli da Alcinoo per il ritorno ad Itaca e l’arco di Eurito11 con il quale
sterminerà i Proci nella sala del trono della sua reggia.
Se l’intelligenza di Odisseo è un’intelligenza fuori dalla norma, lo è anche
perché, come già precedentemente citato, sa proiettarsi temporalmente in
avanti, riesce quasi predire gli eventi, come ad esempio quando imprigionato
dal ciclope nella caverna ed interrogato da questi, riesce a confondere il gigante dicendo di chiamarsi Ουύτις 12: “L’Oûtis di Ulisse è, quindi, il cristallo della
menzogna, il primo attraverso cui filtra la luce delle altre azioni compiute dall’uomo odisseico all’interno della caverna di Polifemo. Innanzitutto il dono del
vino che […] connette Ulisse alla sfera dell’ebbrezza e dell’annebbiamento,
ma anche, come ben sappiamo, a quella del teatro: ambiti dell’esistenza che
appartengono, tutti, al dio Dioniso, che è il dio dell’esser altro da sé […]. Sulla
linea dell’annebbiamento del vino, che fa perdere lucidità e sprofonda nel
sonno il Ciclope, si colloca anche l’espediente decisivo, plasticamente grandioso, dell’accecamento, che rende permanente l’effetto obnubilante dell’inebriante bevanda di Dioniso […]. Non ‘Nessuno’, quindi, ma Ulisse ha vinto
Polifemo, ‘il molto rinomato’, ‘il celebrato’, il ‘famoso’, riversando tutta quella
fama e quella gloria smisurata sulla sua identità, sul nome orgoglioso del figlio
di Laerte. Nessuno ‘stato di necessità’ lo richiede e, là dove la sopravvivenza
è assicurata, solo l’ambizione e, forse, il sapore della vendetta personale spiegano il surplus della rivelazione finale. La menzogna di Ulisse nell’antro del
Ciclope si chiude, quindi sotto il segno di quello stesso ‘voler-avere-di-più’ che
aveva mosso l’impresa del cavallo. Solo che, in questo caso, il di-più non è il
di-più del bottino (il possesso della cosa), ma il di-più dell’umiliazione e della
sopraffazione dell’avversario (l’annientamento dell’altro), da cui Ulisse trae
soddisfazione. Un’avidità e un’hybris che costeranno all’eroe odisseico, che
ha l’odio nel nome, ancora molte sofferenze e peregrinazioni”.13
Ma, a ben pensare, l’assonanza tra gli appellativi Odysào e Oûtis è più che
singolare, semanticamente parlando. È come se Odisseo, che in questo contesto rappresenta la fraudolenza ontologica, mentendo affermasse il vero e
viceversa in un sottile gioco logico-linguistico che rimanda alla più tarda scuola greca dello Stoà poikíle14.
Probabilmente, come il mito ci testimonia, per la prima volta nella storia del
pensiero occidentale ci si rese conto che l’ignoto, l’oûtis, il “nessuno” poteva
superare per magnificenza e grandezza d’ingegno il “tristemente noto”, e che
l’ignoto era in grado di tendere agguati allo sperimentato, al noto.
L’accecamento del “celebre” Polifemo testimonia l’imperfezione e l’esiguità del
dato di fatto dogmaticamente acquisito e la tragedia del sapere scientifico che
crede di possedere un’unica verità che non sa, però, prevenire il pericolo della
propria eccezione. Ma, analizzando meglio l’accecamento del ciclope si scopre come la pericolosità dell’atto si celi, ancora una volta, dietro un dono appa-
SAGGI
NOTE
rentemente gratuito (il vino soporifero di Marone di Ismaro); nella piana di
Troia il pericolo si celava invece, nel ventre di un “innocuo” dono votivo lasciato a far bella mostra di se sulla riva dai greci in ritirata; laddove però, la pericolosità odisseica si occultava proprio nell’apparente bontà del dato, nel profondo del significato logico del gesto: “Il cavallo è vuoto come la parola, che
non garantisce la presenza della cosa. Il significante, infatti, non è la cosa
significata, il nomen non è la res. I Troiani cadono nell’inganno di Ulisse perché, ancora immersi nell’arcaica concezione della comunicazione simbolica,
scambiano lo ‘strumento’, cioè il ‘mezzo’ della significazione, per la presenza
realizzata del significato, ovvero per un ‘dono disinteressato’ che si fa senza
perché. Di conseguenza, essi credono che il cavallo sia una reale offerta votiva agli dèi e non una nuova e più sofisticata espressione dell’‘interesse’ degli
Achei per il ‘possesso’ della loro città. Gli Achei, a loro volta, inaugurano con
l’inganno di Ulisse una concezione della comunicazione non più simbolica ma
‘segnica’”15.
Una volta visto per quale motivo i doni di Odisseo sono tanto insidiosi è
opportuno citare chi erano coloro i quali possedevano la facoltà intellettiva di
riconoscerli come minaccia e quindi di sconfessarli. Egli ha avuto nella sua tormentata esistenza più antagonisti, ma tre su tutti gli altri rappresentano per lui
una minaccia. Il primo fu Palamede per la propria onestà intellettuale, il secondo fu Laocoonte, il sacerdote dell’apollineo chiarore, lo smascheratore delle
insidie achee, il terzo fu Tersite uno dei comandanti greci dal disarmonico
aspetto ma dalla lingua tagliente come la spada.
La vittima più importante del suo rancore fu il saggio Palamede che lui considerò nemico perché quest’ultimo possedeva un’intelligenza diversa dalla
sua, un’intelligenza filantropica: “Palamede è una sorta di Ulisse depurato del
suo lato ermetico-mercuriale. È saggio ma non usa l’astuzia per mentire, ma
solo per svelare la menzogna”16. Il genio di Palamede è un genio equo, volto
al bene comune, molto diverso dalla sagacia del re di Itaca. Egli inventerà i
dadi, la dama, gli astragali per non far soccombere i Greci dalla noia e la paura
ed inventerà l’uso della moneta, delle unità di misura ed in ultimo della scrittura perché gli uomini non commettessero più frodi, né di natura economica, né
di natura intellettuale. Molti furono i motivi di attrito tra Odisseo e Palamede,
tra cui ricordiamo i più famosi: lo smascheramento del giovane Principe di
Itaca che si fingeva pazzo pur di non partire per Troia, i continui richiami etici
di Palamede, l’invenzione delle unità di misura e della scrittura di cui si servirà Odisseo per tramare contro il principe acheo tanto diverso caratterialmente
da lui: “Allo scontro fra Ulisse e Palamede, ciò che vediamo in gioco sono due
differenti volti della téchne: uno vincente e uno perdente. Ovidio, nelle
Metamorfosi, descrive Palamede con una battuta. Rispetto a Ulisse egli era
‘più svelto nella mente, ma meno capace di servire se stesso (sollertior isto et
sibi inutilior)’ (Met. XIII, 37-38). Le invenzioni di Palamede sono, infatti, invenzioni altruistiche, che sopperiscono alle mancanze e al bisogno degli altri […].
L’invenzione della scrittura, assieme a quella dei numeri che la tradizione gli
attribuisce, fanno di Palamede il nemico giurato di Ulisse perché queste forme
di fissazione del segno appaiono ai nostri occhi come tentativi di ancorare la
99
100
plastica essenza della parola orale, che l’uomo odisseico piega alla necessità
delle circostanze ma soprattutto alla dismisura della sua brama, alla precisione calcolatoria e archivistica del dato, al limite del ‘così com’è’ delle cose. La
tecnica ‘buona’ di Palamede è altruistica, ma è anche mirata al risparmio, alla
condizione di scarsità –la carestia dei suoi concittadini–, alla preservazione –la
memoria degli eventi–; mentre la tecnica ‘cattiva’ di Ulisse, il volto vincente
della tecnica, è eccessivo e autodistruttivo”.17
Così come ci tramanda il mito, Odisseo utilizzando l’invenzione più importante di Palamede, ottiene la sua agognata rivincita. Dicendo di aver avuto un
sogno premonitore il wanax spergiuro di Itaca avverte il comandante in capo
Agamennone di un possibile tradimento tra le file greche. Lo consiglia così di
far levare le tende e di spostare solo per poche ore l’accampamento acheo per
smascherare l’apostata. Nel frattempo, Odisseo si premura di seppellire di
nascosto, nel luogo dove sorgeva la tenda dell’odiato Palamede un sacco
ricolmo d’oro; poi costrinse un prigioniero frigio a falsificare una missiva che
sembrava scritta dal pugno stesso di Priamo affinché attestasse il tradimento
ordito da Palamede contro la sua gente. Dopo che il servo scrisse la missiva
Odisseo gli ordinò di consegnarla di persona al destinatario ma uccise il frigio
appena fuori dall’accampamento greco dando una dimensione verosimile al
tutto. Il giorno successivo, quando gli Achei riordinarono il proprio accampamento trovarono il corpo senza vita del prigioniero frigio e consegnarono la
falsa missiva che quest’ultimo recava con se ad Agamennone che richiamò
subito Palamede e lo interrogò duramente. Dato che l’eroe greco si dichiarava innocente, subentrò l’arguta malafede di Odisseo che con pretesto di scagionare il “compagno d’arme” consigliò il comandante in capo di cercare la
prova del tradimento nella tenda di Palamede, dove fu trovato l’oro che inchiodò definitivamente Palamede alle sue responsabilità. Gettato in un pozzo18, il
povero Palamede fu lapidato ma morte, ma prima di esalare l’ultimo respiro
ebbe la forza di gridare: O verità, io piango la tua morte che ha preceduto la
mia. L’uccisione di Palamede rappresenta il sacrificio della filantropia da parte
dell’egoismo, di quell’egocentrismo che ha connotato, quasi sempre, il procedere gnoseologico dell’Occidente, un procedere tutto utilitaristico che ha fatto
del tornaconto il suo vessillo più importante.
Ora, considerate le sventure di Palamede, soffermiamoci ad esaminare le
differenti forme di inimicizia di cui soffre Odisseo. Laocoonte gli è hostis perché milita nella parte avversa ma gli è similis perché è spergiuro19 come lui,
Tersite20 –come del resto il già citato Palamede– da commilito dovrebbe essergli amicus in quanto Greco ma nei fatti gli è inimicus perché riesce a smascherare la sottile ipocrisia odissea e quella dello stesso Agamennone, denunciandola perfino dinanzi all’assemblea generale achea.
Ma chi è Tersite? Questi, a detta di Omero era l’unico dei comandanti greci
a non avere nobili natali e per giunta era tanto deforme quanto arrogante; ma
dalla sua bocca fuoriusciva la conformità ai fatti ed agli eventi. Agamennone
aveva effettivamente abusato del suo ruolo di wanax supremo impossessandosi della bella Briseide e suscitando i comprensibilissimi risentimenti del valoroso Achille, che con un’azione fulminea prima del vero e proprio scontro cam-
NOTE
SAGGI
pale con i troiani, riesce a saccheggiare il territorio circostante Ilio impadronendosi della bella moglie del re Minete. E fu sempre il deforme Tersite a condannare apertamente Achille di necrofilia, quando quest’ultimo dopo aver ucciso l’amazzone Pentesilea ne amava il corpo esamine; ed anche quella volta
l’“arrogante” Tersite dovette subire l’onta delle percosse del “degno” figlio di
Teti, dell’eroe indispensabile alle file achee. Così, lo svelatore delle inconfessabilità auliche degli eroi “senza macchia” finisce, per essere denigrato dai
posteri e condannato come arrogante; ma non irriverente era il suo lògos
bensì fu probabilmente la prima forma di non soggezione dinanzi al potere ed
alla rinomanza; ed è per questo che è inviso ad Odisseo perché il dialogare di
Tersite mina le basi della sua stessa fama. Tersite in qualità di anti-eroe è un
personaggio moderno ed a noi più vicino di quanto si possa credere.
Tersite, dunque, lo scopritore della parresía, di quel parlar franco che non
si piega a nessun kérdos, a nessun “vantaggio regale” e che specificherà in
seguito il mondo ellenico da quello barbaro. La parresía sarà per forza di cose
inscindibile dall’ eleuthería, dall’isonomia21 e dall’isegoria22 specie nelle assemblee militari dove tutti i comandanti sono uguali senza eccezione alcuna, neanche dinanzi all’incarico più alto. Il modus loquendi proposto da Tersite è opposto a quello di Odisseo, che giustamente può essere considerato il padre dell’eristica e del tornaconto economico-culturale. La regalità del wanax itachese
è tanto più alta quanto più questi sa giocare con le parole e con i significati di
queste ultime; anche se quando quelle rare volte che si trova sprovvisto di giustificazioni fa ricorso alla forza bruta, a quella hý bris tutta ellenica per ridurre
al silenzio gli avversari.
Per quel che concerne Laocoonte invece, occorre ricordare che Odisseo e
il sacerdote troiano sono le facce di un’identica medaglia di cui il volere divino
della scommessa fa sì che uno dopo il lancio, veda la luce del sole e l’altra la
polvere della terra. Sono entrambi due modelli dissimili nella forma ma identici
nei contenuti di quella verbalità arcaica pre-logica e pre-grammaticale. La loro
parola può rappresentare la cosa ma può anche raffigurare il tutto. Può essere
se stessa ma anche altro da se, può dire il vero ed il falso, può contenere la
regola e l’eccezione, essendo in fin dei conti gli strumenti degli dei immortali al
servizio degli uomini. Però a differenza di Laocoonte, Odisseo è la parola che
costruisce l’immagine, quell’argomentare avveduto che conduce l’interlocutore
ad accettare unicamente la costruzione delle proprie tesi, essendo il più grande persuasore dell’antichità. La sua grandezza interiore emerge ogni volta che
apre bocca anche se la sua fisionomia a volte tradisce l’armonia della sua
capacità discorsiva. Antenore, uno dei capi troiani così lo descrive: “Io li ospitai
e li accolsi nella mia casa e di entrambi conobbi la persona e la mente sottile.
Quando furono in mezzo all’assemblea dei Troiani, se stavano in piedi Menelao
superava Odisseo di tutte le spalle, quando invece sedevano, era più maestoso Odisseo; ma quando esponevano a tutti i loro pensieri, parlava Menelao
speditamente, poche ma chiare parole: non era molto prolisso e conosceva l’arte del dire ma di età era molto più giovane; quando si alzava invece l’accorto
Odisseo, restava immobile guardando in basso, con gli occhi fissi al suolo; non
muoveva lo scettro né avanti, né indietro, lo teneva fermo, sembrava non
101
102
sapesse che dire; l’avresti detto in preda alla collera oppure pazzo del tutto; ma
quando dal petto faceva uscire la voce profonda e le parole che parevano fiocchi di neve in inverno, allora nessun altro uomo avrebbe sfidato Odisseo: allora non pensavamo a guardare il suo aspetto”23.
Odisseo non è un superuomo dal fisico possente, si differenzia molto dalla
prestanza fisica del Laocoonte morente che lotta contro i serpenti nel vano
tentativo di salvare i suoi figlioli24 che la statua della scuola di Rodi oggi ci testimonia. Il suo corpo non racchiude in sé il concetto di bellezza classica, le sue
forme non sono simmetriche, ha un busto più alto delle gambe25; ma conscio
della sua condizione umana, non sfugge dinanzi al pericolo, al contrario temporeggia, non lo affronta con l’impeto guerresco proprio di Aiace Telamonio o
del Pelide Achille. Egli si sofferma e lo esamina, cerca di conoscerlo, cerca
d’impadronirsi del suo lato più debole dialogando con lui, intessendo un’abile
trama di menzogne che astutamente pone in essere minuto per minuto, celando nel segreto del suo cuore e nel silenzio delle sue idee l’ultima meta. Pur
conoscendo bene l’arte della scherma, del pugilato e del pancrazio26 evita di
aggredire subito i suoi rivali ma cerca di comprenderne i punti deboli sui quali
attaccare. La tradizione letteraria ne ha fatto un eroe positivo tralasciando di
esaminare i suoi aspetti più oscuri che lasciano, oggi trapelare, l’enigmaticità
di un attore che ancora calca le scene dell’esistenza, in una tragedia che assume spesso i connotati di una farsa. Odisseo, non è uno stinco di santo, né può
esserlo. Egli è un soggetto idiota di nobili sentimenti. E questa mancanza di
nobilitas è quasi sempre frutto di una scelta, di un rimuginare patologico, proprio del talassocrate, del predone di mare. In lui la capacità si trasforma in
scaltrezza, la sopportazione degli eventi in pseudodeferenza; la discrezione in
impostura, il dubbio in inganno. Il suo sorriso si rinnova quasi sempre in ghigno; e le sue lacrime sono piante soltanto per far breccia negli animi. La gentilezza diviene cinismo inesorabile, crudele tracotanza. Odisseo disgiungendosi, diventa sfuggente, tanto che lo scaltro figlio di Laerte si tramuta quasi
sempre nel bastardo di Sisifo. Altro che ptoliethros27! Altro che nobile esule!
Nelle sue gesta riecheggiano le qualità del predone, le attitudini proprie dello
sciacallo. La sua pietas risiede unicamente nella vendetta meditata che è
un’altra delle sue temute peculiarità. Egli a differenza del Pelide Achille detesta la poesia perché come afferma Pindaro fa addormentare gli astanti e poiché lui non dimentica mai e ama fare sfoggio delle sue gesta inventando la
prosa fantastica che rende tutti interessati. Incarna del resto anche la coscienza dell’erista e la sua speculazione serve unicamente a riempire le sue tasche.
Odia l’ordine logico di qualsiasi pensiero che non sia egli stesso a produrlo ed
il suo nichilismo è una philosophia denstruens che rimpiange la sua incapacità etica di edificare un credo universale. Egli rappresenta non tanto l’enigma
del gioco divino quanto la finitezza fisiologica della propria natura logica, una
natura in costante pericolo per via delle fragili postazioni di partenza. È l’antiSocrate per eccellenza, è l’arrogante dell’ultim’ora che utilizza spudoratamente la menzogna senza sforzarsi di conoscere il fondo ontologico che anima e
contraddistingue quest’ultima. Di lui bisogna temere i doni e l’amicizia figuriamoci la vis argomentativa.
NOTE
SAGGI
Chi sancì in filosofia la grandezza dell’eroe omerico fu, ironia della sorte,
Platone, il paladino della Verità, di quella più alta, unica e divina che proprio
per questo non risiede in questo mondo costituito da infime apparenze. Egli
nell’Ippia minore rivalutò la capacità logica dell’inganno propria di Odisseo
definendola phronesis ovverosia capacità di discernere il meglio da ogni situazione storica. Odisseo era preferibile ad Achille proprio perché con la sua intelligenza spregiudicata, riusciva a districarsi logicamente tra la menzogna e la
verità sapendo essere, all’occorrenza, tanto pseudès (mentitore) quanto kaì
alethès (veritiero). La phronesis diveniva così, nella filosofia occidentale, indispensabile quanto la sophia poiché si comprese che con l’uso “saggio” della
parola si poteva imporre la verità più consona al momento, dato che probabilmente l’archetipo aletheia per sua natura si dimostrava, indomito a qualsivoglia collocazione concettuale definitiva.
La ricerca filosofica delle origini, come del resto quella attuale, fu così connotata da due anime: una facente riferimento al sentimento innato del pólemos
ovverosia a quell’individuare qualcosa o qualcuno come nemico e muovergli
guerra; l’altra al sentimento anche questo innato della stásis che si manifestava come quella falsa quiete che di fatto disturba l’interiorità di qualsiasi presunzione di evidenza. Il concetto di veridicità, come già accennato, sfuggiva
ogni determinazione dell’essere e mutava rotta trascinandosi dietro il suo presunto opposto, la falsità; così l’inganno che veniva a crearsi ogni qualvolta si
cercava di scoprire l’arcano della vita, dipendeva necessariamente oltre che
dall’insopprimibile tracotanza dell’imposizione logica umana –che si concretizza sempre come atto di mera hýbris– anche dalla flessibilità congenita delle
strutture linguistiche della propria cultura di appartenenza, in quanto il lògos
viene spesso esplicitato metaforicamente: “La menzogna è una questione linguistica in quanto rappresenta un caso particolare della metafora. La menzogna è una metafora che non si avverte come tale perché l’infrazione della predicazione contraddittoria viene occultata”.28
A parte queste attenuanti metaforiche, il concetto di falsità non era mai
stato assente dalla scena greca, tanto che proprio questo era stato considerato come il segno di riconoscimento degli dei e il mezzo necessario per comprendere ciò che si supponeva fosse solamente probabile: “In Grecia, a differenza del contesto culturale dell’Antico Testamento, il divino non è fondamento della veridicità, dal momento che gli dèi mentono di frequente fra loro e agli
uomini, e lo stesso Zeus, ‘custode dei giuramenti’ (∆ια όρκιου λέψεται) (DK
58 B 1 a), è per altri versi, un dio mentitore, che ricorre spesso al travestimento
e alla metamorfosi per sedurre i suoi numerosi amori”.29 E a quanto ancora ci
testimonia Esiodo nella sua Teogonia, la dea dell’inganno Apàte fu procreata
dalla Notte, mentre i Discorsi Menzogneri (Pseùdea) nacquero dalla temibile
dea della discordia Eris: “E generò anche Nemesi, sciagura degli uomini mortali, / notte (Nύξ) funesta; e dopo di essa Inganno (Aπάτην) e Amore / e
Vecchiaia rovinosa, e Contesa dal cuore violento. Poi Contesa (Eρις) odiosa
generò Pena dolente, / Oblio e Fame, e Dolori, che fanno piangere, Lotte e
Battaglie, e Delitti e Omicidi, / Discordia e Menzogne (Ψευδεα) e Discorsi
(Λόγους) e Ambigui Discorsi (Αµφιλλοίας), / Anarchia e Sciagura, che vanno
103
104
congiunte fra loro / e Giuramento (Oρκος), che agli uomini della terra grande
/sciagura reca quando qualcuno di loro, volendo spergiura (´επι´ορκου όµσση),
(Teogonia, 223-232)”.30
Ciò che connotò l’aletheia –allora stimata come quella sorta di locuzione
che contraddistingueva la linea di continuità prima esistente tra la credenza
religiosa e quella cosmogonica, ma al contempo segno caratteristico della frattura prodottasi tra il pensiero cosmogonico saldamente legato al mito e quello
cosmologico rivolto invece all’esperienza proto-scientifica– dal suo contrario fu
quel clima di ambiguità logica che connotò ogni singola speculazione, da quel
“gioco” di wittgensteniano rimando che vedeva il veridico (il noto) sommarsi e
sottrarsi allo stesso tempo all’ingannevole (l’ignoto). Si intuì, in parole povere,
che “semi” di verità potevano attecchire anche sul terreno scivoloso dell’inganno qualora tale esperimento spingeva l’ordine logico del mondo verso l’assurdo: “Dire la menzogna è dire una cosa che è: si tratta, come si può vedere, di un’applicazione disinvolta della concezione eleatica dell’essere. […]. È
indubbio, tuttavia, che la sofistica interpreterà in senso aporetico le scoperte
dell’ontologia eleatica, come attesta il famoso frammento 3 di Gorgia di
Leontini: ‘Nulla esiste, se anche alcunché esiste, non è comprensibile all’uomo; se pure è comprensibile, è per certo incomunicabile e inspiegabile agli
altri’ (DK 82 B 3). A invertite, ma analoghe conclusioni, […] giunse, infatti, il
seguace di Gorgia, Seniade di Corinto, per cui, invece, ‘tutto è falso’: se non
esiste un essere, non esiste nemmeno alcun pensiero dell’essere, e se il pensiero dell’essere significa verità, di conseguenza, data la non esistenza dell’essere, non c’è alcuna verità, ma solo ancora pseûdos”.31
Come si nota il filosofare ellenico da primigenia attitudine allo svelamento
della verità divenne mera arte oratoria della persuasione, disciplina in cui
Odisseo eccelleva per maestria. Dinanzi a tanto disfattismo culturale la figura
di Socrate cercò di porre un “ordine” etico nel mondo della filosofia utilizzando
l’ironia, quella “finta menzogna” che proprio perché tale è meglio disposta ad
accogliere e far nascere in ognuno il faro rischiaratore della verità: “Gettando
i suoi segnali d’ironia Socrate discriminava le vite dei suoi ascoltatori, sì che
solo chi comprendeva tali segnali poteva cominciare il percorso, necessariamente individuale e personale, di edificazione del bios philosophikòs. Scopo
di questo meccanismo, quindi, non era tanto di difendere una determinata dottrina dalla furia persecutoria del potere o dall’insolenza dei curiosi, quanto di
garantire quell’aggancio esistenziale che consentiva alla dottrina di essere
efficace e, di conseguenza, di essere vera. D’altra parte, l’ironia di Socrate non
può essere intesa come una forma d’ipocrisia o di finzione proprio perché essa
non è un’‘ironia semplice’ che consiste nel non dire qualcosa nel suo significato ordinario, ma per alludere ad altro, sicché, se si intende ciò che si dice
nel senso comune, questo risulta falso, ma un’‘ironia complessa’ in cui ‘ciò che
vien detto a un tempo è e non è ciò che si intende’, di modo che ‘il suo contenuto superficiale è inteso come vero in un senso, falso in un altro’. L’ironia
complessa di Socrate è, quindi, l’ambivalenza strutturale della vita umana
nella sua stratificazione originaria di immediatezza e mediazione”32.
L’opera socratica altro non fu, con tutte le dovute differenze, che il tentati-
3. Considerazioni conclusive
Come già appurato, la ricerca filosofica mantiene in sé sin dalle sue origini un lato oscuro, enigmatico, problematico che ha minato le basi di qualsiasi
indagine che si orientasse esclusivamente verso un’unica risoluzione veritativa dell’esistente.
La menzogna diviene, nella nostra cultura basata sul culto scientista dell’evidenza e della necessità del fenomeno, un’ “ombra”, ma un’ombra che attesta la più alta essenza ontologica ipotizzabile: “L’analisi critica ci conferma che
la necessità è una interpretazione –che la verità non è una sostanza delle
cose. […]. Chiamiamo verità il processo che ci rende finalmente formulabile un
mondo […]. Verità è una forma di organizzazione del materiale sensibile tale
da permettercene l’uso”33.
L’esistenza stessa si palesa contraddittoria e mendace quando si assiste
ad un’evasione veritativa. Si ripresenta così, la tragicità di un pensiero incompleto preda di manie di onnipotenza. La storia, quindi, si palesa come gioco
divino, come marasma d’eventi dispettoso ed imprevedibile ed il nostro rapporto con questa s’incrina quando constatiamo che la “veridicità” di determinati accadimenti risulta non più vera di quanto possa essere probabile il contrario. Dinanzi a questo valzer esistenziale la filosofia si dimostra inidonea a
prevedere future piroettes: “È la ‘filosofia’ a non intaccare il gioco –è la ‘filosofia’ a non poter produrre nuove esperienze– è la ‘filosofia’, ancora, a non poter
spiegare Nulla. Essa serve a mettere un ordine –che non potrà essere che l’ordine del gioco normale, secondo le norme con cui viene ora giocato, secondo
il suo impiego quotidiano. La ‘filosofia’ si limita a mostrare. Il problema del
cambiamento delle norme del gioco non è formalizzabile nella ‘filosofia’: questo è quanto si può dire. Essa può soltanto riportare al linguaggio ora all’opera. Se supera questi limiti, si tradisce […]. Nei suoi limiti, essa serve soltanto
a fare chiarezza su questo ordine”34.
Ed è in questo difficilissimo contesto metafisico –in cui la ricerca filosofica
viene intesa come creazione di un ordine razionale– che l’esistente si manifesta in tutta la sua contraddittorietà, e l’uomo da parte sua, altro non può fare
che lottare con-e-per la comprensione del fenomeno “verità”. L’umanità così
lotta, si dimena, si contorce, spasima, agonizza con la realtà per il possesso
della sua totalità e così facendo, s’immerge in questa e produce a sua volta:
trasformazione, storia, evento.
Ma non sempre si è dimostrato opportuno cercare di comprendere la realtà fenomenica col solo ausilio della ragione. Il più delle volte questa non basta
all’indagine ed ecco perché occorre approssimarsi al dilemma della verità e
del suo eventuale contrario con tutto se stesso, con i propri pregi ed i propri
NOTE
SAGGI
vo di far rinascere l’uomo palamediano, quell’uomo capace di liberare i suoi
simili dai gorghi del cháos concettuale, rifugio sicuro dei furbi e dei potenti, ma
come Palamede, Socrate muore per mano dello stesso potere politico, che utilizza odisseicamente la menzogna per conservare il proprio dominio.
105
106
difetti, con la propria intelligenza e col proprio corpo, con le proprie certezze e
coi propri dubbi, con le proprie “esattezze” e, si badi bene, con i propri errori.
E nell’affermare questo non possiamo non essere d’accordo con quanto scrive in proposito Miguel de Unamuno: “Il nostro uomo è un altro, fatto di carne
e ossa: io, tu, lettore mio, quell’altro che sta più lontano, tutti noi che pestiamo
la terra. E quest’uomo concreto, di carne e ossa, è il soggetto e al tempo stesso l’oggetto preminente di ogni filosofia, piaccia o no a certi sedicenti filosofi.
Nella maggior parte delle storie della filosofia che conosco, i sistemi vengono
presentati come se si originassero gli uni dagli altri, e i loro autori, i filosofi, a
stento appaiono come puri e semplici pretesti. La biografia interiore dei filosofi, degli uomini che filosofarono, ha un’importanza secondaria. Ma al contrario,
è proprio questa biografia interiore quella che ci permette di comprendere più
cose […]. La filosofia risponde all’esigenza di formarci una concezione unitaria e globale del mondo e della vita, e in conseguenza di tale concezione, un
sentimento che ingeneri una disposizione interiore e perfino un’azione. Ma
può accadere che tale sentimento, anziché essere la conseguenza di quella
concezione, ne sia la causa. La nostra filosofia, cioè il nostro modo di comprendere o di non comprendere il mondo e la vita, scaturisce dal nostro modo
di sentire nei confronti della vita stessa. E questa, come tutto il mondo affettivo, ha radici subconscie, a volte inconsce”.35
Cosicché il cercare la verità ha generato continui ed enormi sistemi di pensiero, magnifiche scuole, ferrei dogmi i quali non hanno fatto altro che contorcersi sulla stessa razionalità che li ha creati, che li ha posti in essere; e così il
voler raggiungere la verità tramite l’uso della sola ragione si è dimostrato tanto
inutile quanto il cercare di raccogliere l’acqua di un pozzo con un paniere fatto
di vimini; né l’utilizzare senza riflettere la menzogna ci ha reso meritevoli di
lode perché, la meccanizzazione della menzogna non ha fatto altro che creare nuovi dogmi, ed i dogmi, si sa, sono come il Golem36 di Meyrink, sono molto
rischiosi perché si ritorcono sempre contro chi li ha creati.
Il vero dilemma della quaestio risiede nella nostra logica occidentale tutta
intenta a ripiegarsi sulle sue stesse leggi; e come non condividere, a questo
punto il dubbio nietzscheano che afferma che: “Il mondo ci appare logico perché prima noi stessi lo abbiamo logicizzato”37. Bisognerebbe, invece, sforzarsi di utilizzare tutto noi stessi non per noi stessi ma per gli altri, siano questi
amici o nemici, prossimi o distanti, meritevoli o immeritevoli delle nostre attenzioni, ma per far questo dovremmo essere pronti a commettere un sacrificio;
bisognerebbe innalzare un altare sulla tomba di Palamede, sulla tomba di
quell’intelligenza solidale che ci fa essere soprattutto uomini e non tecnocrati
del guadagno e riuscire a sacrificare l’Odisseo che alberga nel profondo delle
nostre coscienze. Perciò, non l’uomo astuto egoisticamente inteso, ma soltanto quello che combatte per l’Essere (esistenza propria ed altrui) può definirsi protagonista; e se l’uomo odisseico con tutte le sue innumerevoli pecche
non riesce mai a trovare un porto sicuro dove dimorare lo deve al fatto che ha
ordito alle spalle di Palamede, alle spalle di quella saggezza solidale di cui
oggi l’umanità contemporanea è purtroppo deficitaria. Ed è questo il motivo
per cui l’uomo contemporaneo vacilla dinanzi alla propria problematica esi-
1
Nelle favole di Igino si narra una versione diversa della generazione di Odisseo, che Omero,
per la regalità dell’eroe di Itaca, forse volontariamente tralascia, ed è quella che lo vede figlio di
Sisifo l’astuto predone di bestiame, e non di Laerte. Scrive Igino che Autolico, nonno materno di
Odisseo, figlio a sua volta di Ermes il dio dei mercanti e dei truffatori, ricevette da quest’ultimo il
dono celeste di non essere mai colto in flagranza di reato che gli avrebbe permesso di essere il
ladro più abile, anche in virtù del fatto che aveva ricevuto dal messaggero degli dei anche un’altra
facoltà, quella di poter far mutare forma al bottino. Così Autolico, forte dei doni di suo padre, cominciò a depredare le mandrie di Sisifo, suo vicino, che pascolavano sulla zona di confine, tra i loro
rispettivi possedimenti. Sisifo ben presto si accorse che il numero delle sue pecore diminuiva progressivamente ed al contempo invece vedeva crescere, anche se di manto e morfologia diversa,
quelle di Autolico. Decise così, di incidere sotto lo zoccolo degli animali di sua proprietà un piccolo
segno di riconoscimento, astuto espediente che smascherò l’inganno di Autolico. A questo punto
Sisifo progettò una giusta vendetta e sotto bonario aspetto si introdusse nel clan di Autolico, sedusse Anticlea l’amata figlia del suo nemico, la derubò della verginità e generò con lei l’eroe omerico
che grazie ad un ingegnoso stratagemma riuscirà a far capitolare la possente città di Troia e a porre
fine all’annoso assedio. Cfr. IGINO, Miti, trad. di G. Guidorizzi, Adelphi, Milano 2000.
2
“Odisseo, il cui nome che significa “iroso” si riferisce al volto rosso del re sacro, è chiamato
Ulisse in latino, parola formata probabilmente da oulos, “ferita” e ischea, “coscia”, con allusione
NOTE
SAGGI
stenza, per cui da arguto Odisseo si tramuta nel confuso Ismaele di Melville
che una volta al timone del Pequod, per la vastità degli elementi che si trova
a solcare perde la rotta della propria esistenza e smarrito in una nuova ignota
dimensione medita: “Davanti a me non sembrava esserci null’altro che un’oscurità nera come l’inchiostro, resa di tanto in tanto spettrale da lampi rossastri. Mi sovrastava l’impressione che la cosa veloce ed impetuosa su cui mi
trovavo, qualunque essa fosse, non stesse affatto puntando la prua verso un
qualsiasi porto, ma stesse fuggendo precipitosamente da tutti i porti che aveva
a poppa. Fui pervaso da una sensazione di rigidità e sbigottimento, come di
morte. Le mie mani strinsero convulsamente la barra, ma con la folle idea che
in un certo qual modo la barra, per qualche incantesimo, si fosse invertita”.38
Se l’epica odissea rappresenta l’avventura dell’uomo oeconomicus contemporaneo, la rappresenta soprattutto perché ritrae un insuccesso, un tracollo non solo di quelle certezze che tendono per loro natura al “vero” come la
religione o la filosofia, ma anche di quelle che si rifanno espressamente ad un
“falso” ad una dimensione filantropicamente “distorta” come le attuali convinzioni tecniche ed economiche.
La menzogna naufraga come Odisseo di continuo nel mare magno della
storia ma non annega, fluttua invece vitale tra i marosi dell’esistente per far sì
che le rotte dell’umanità si avventurino di continuo nell’eccezione, nella possibilità, poiché solamente possibilizzando l’imprescindibile logico in una nuova
dimensione culturale si riuscirà a prospettare la nascita di una diversa humanitas che come nuova condizione esistenziale può, e di conseguenza dovrà,
imporsi sulla scena.
107
108
alla cicatrice prodotta da una zanna di cinghiale e che la vecchia nutrice Euriclea riconobbe quando egli tornò ad Itaca. I re sacri morivano spesso per una ferita del genere, ma pare che Odisseo
fosse riuscito a sopravvivere”. Cfr. R. GRAVES, I Miti Greci, trad. it. a c. di U. Albini, Longanesi,
Milano 1983, p. 681.
3
A. TAGLIAPIETRA, Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale, Bruno Mondadori, Milano 2001, p. 74.
4
Narra la leggenda che Odisseo era stato avvisato da un oracolo sulla pericolosità di una
sua partecipazione alla guerra di Troia. Il veggente gli aveva intimato che se fosse partito per
Troia sarebbe tornato in patria dopo vent’anni di sofferenze, misero e solo. Sentendo tale vaticinio il povero principe colto da terrore escogitò un valido stratagemma per sfuggire al richiamo militare. Si finse pazzo, accolse Agamennone, Menelao e Palamede, gli illustri ospiti che
erano venuti a prelevarlo, vestito da contadino sulla spiaggia. Aveva aggiogato un bue ed un
asino e con quelli arava l’arenile scagliando dietro le sue spalle manciate di sale come fossero chicchi di grano. Palamede che conosceva l’arguzia del giovane principe jonico prese di
colpo il piccolo Telemaco dalle braccia premurose di Penelope e lo pose dinanzi agli animali,
con l’intento di smascherare l’inganno e vi riuscì. Odisseo, pur di non far travolgere dagli animali la sua creatura dovette smascherare l’inganno e seguire a malincuore i tre nell’impresa.
Manterrà però nei confronti di Palamede, lo smascheratore, un odio implacabile. Cfr. R.
GRAVES, op. cit., p. 594.
5
Un’altra sua mirabile impresa fu lo smascheramento di Achille nel gineceo dove sua madre
Teti lo aveva nascosto per farlo sfuggire al suo pessimo destino. Teti nella sua veste divina era
cosciente che la partenza per Troia di suo figlio Achille avrebbe sancito la sua morte e per questo lo travestì di donna e lo affidò al re di Sciro Licomede nel cui palazzo, Achille visse per tempo
sotto il falso nome di Cercisera e fu in quel tempo che il pelide si congiunse con la figlia di
Licomede, Deidamia che lo fece padre di Pirro noto anche sotto il nome di Neottolemo. Nel frattempo i capi greci cosci che non sarebbero potuti partire senza il re dei Mirmidoni mandarono
Odisseo alla ricerca di Achille a Sciro, poiché avevano intuito qualcosa. Odisseo mascherato da
mercante si introdusse nel palazzo mostrando la sua mercanzia, per lo più gioielli profumi e stoffe che interessarono il folto gruppo di giovani nascoste dai veli. Argutamente tra i gioielli aveva
nascosto una spada finemente intarsiata che suscitò l’interesse di Achille travestito. Odisseo,
mentre le donne ed il figlio di Teti ammiravano la mercanzia fece squillare da alcuni suoi compagni che lo avevano aiutato nell’impresa una tromba che segnalava un pericolo imminente.
Tutte le donne corsero via sentendo il lugubre suono, tranne Achille che si precipitò ad impugnare la spada, smascherandosi. Dovette poi seguire il principe di Itaca ed abbracciare il suo tragico destino. Cfr. voce Achille, in Dizionario della mitologia classica, a c. di M. GRANT e J. HAZEEL,
CDE Edizioni, Milano 1986, p. 13.
6
M. CACCIARI, L’Arcipelago, Adelphi, Milano 1997, p. 67.
7
ID., Geo-filosofia dell’Europa, Adelphi, Milano 1994, pp. 54-55.
8
Secondo il filologo Giovanni Semerano la ninfa Teti, altro non sarebbe che la divinità mesopotamica Tiāmat, l’immensa dracena marina con cui Marduk plasma il mondo trasmigrata nel
mondo ellenico. Cfr. G. SEMERANO, L’infinito: un equivoco millenario. Le antiche civiltà del Vicino
Oriente e le origini del pensiero greco, Bruno Mondadori, Milano 2001, p.13.
9
M. CACCIARI, L’arcipelago, cit. pp.13-14.
10
In questa occasione Odisseo dimostra più che mai di essere la metafora della curiosità
umana poiché più che per nostalgia di vedere i suoi cari egli è interessato a conoscere il proprio
destino mortale.
11
È importante notare come la parola arco in greco si pronunci anche bìos come la vita che
quello strumento sa togliere.
12
“Quella sera il Ciclope ritornò e mangiò altri due dei dodici marinai: ma tosto Odisseo gli offrì
cortesemente una tazza del forte vino donatogli da Marone di Ismaro Ciconia; per fortuna Odisseo
ne aveva portato con sé un otre pieno. Polifemo bevve avidamente e ne chiese una seconda
coppa, poiché in vita sua non aveva mai assaggiato niente di più inebriante del siero del latte, e
υρι ς ”, rispose Odisseo, “o almeno
accondiscese a chiedere il nome di Odisseo. “Mi chiamo Ου ύ
υρι ς significa nessuno. “Ti mangerò per
questo è il mio soprannome che tutti mi danno”. Ora, Ου ύ
ultimo caro Nessuno” disse Poliremo”. Cfr. R. GRAVES, op cit., p. 669.
13
A. TAGLIAPIETRA, op. cit., pp. 107-108-109.
NOTE
SAGGI
14
Uno dei maggiori paradossi stoici, quello conosciuto sotto la dizione Del Mentitore, tradizionalmente attribuito ad Eubulide testualmente recitava: “Epimenide cretese proclamava che tutti i
cretesi erano bugiardi. Ma allora. Diceva il vero o diceva il falso, Epimenide?”. L’irrisoluzione così,
trionfa sovrana. Infatti, se Epimenide asseriva il vero si trovava a mentire perché sosteneva che
tutti i cretesi (lui compreso) erano bugiardi, quindi, per questo fatto si trovava di conseguenza a
dire il falso. Se, invece, asseriva il falso, si trovava nella posizione di non mentire e come cretese
diceva irrimediabilmente il vero. Così, Epimenide si trovava nella singolare status logico espressivo che lo vedeva mentire quando proclamava il vero e verificare il detto quando, invece, proclamava il falso. Cfr. D. LAERZIO, Vitae philosophorum, VII, 82-83.
15
A. TAGLIAPIETRA, op. cit., p. 95.
16
Ivi, p.111.
17
Ivi, pp. 113-114.
18
Secondo alcuni studiosi il pozzo simboleggia la saggezza oracolare dove lo stesso nome di
Palamede significa “antica saggezza”.Vedi R. GRAVES, op. cit., p. 618.
19
I Troiani dopo aver lapidato il sacerdote di Poseidone nove anni prima, avevano deciso di
non sostituirlo finché la guerra non fosse finita. Scelsero Laocoonte per ingraziarsi Poseidone.
Laocoonte era stato però precedentemente sacerdote di Apollo Timbro, ma aveva irritato il dio del
Sole sposandosi e procreando benché avesse fatto voto di celibato e, peggio ancora, si era macchiato di un peccato abominevole avendo amato senza vergogna sua moglie Antiope dinanzi
all’altare di Apollo.
20
Per un’ulteriore conoscenza di questo personaggio minore dell’Iliade si consiglia la lettura
dell’opera del grecista L. SPINA, L’oratore scriteriato (Per una storia politica e letteraria di Tersite),
Loffredo, Napoli 2002.
21
Eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
22
Diritto riconosciuto a ciascuno, per legge, di esprimere la propria opinione.
23
OMERO, Iliade, testo greco a fronte, a c. di M. G. Ciani, commento di E. Avezzù, Marsilio,
Venezia 1990, pp. 162-165.
24
L’orribile sorte che toccherà ai piccoli Antifate e Timbro per mezzo delle spire di due orribili
serpenti sarà da simbolizzare come la profezia che si ritorce contro se stessa, come la parola
espressa ma non ascoltata, come la verità che non svela l’inganno. I serpenti che uccideranno i
piccoli frutto della colpa sono gli stessi che stimolarono con la lingua biforcuta le orecchie dei piccoli Cassandra ed Eleno nella culla donandogli il potere della divina follia premonitrice.
25
Cfr. R. GRAVES, op. cit., p. 602.
26
Lo dimostrerà più volte, anche in età avanzata, quando arriverà nell’isola dei Feaci dove parteciperà contro voglia ad una prova agonistica, o più tardi nella sua dimora, quando sotto mentite spoglie, batterà con un solo pugno l’accattone Iro che lo aveva ingiuriato.
27
Distruttore di città.
28
A. TAGLIAPIETRA, op. cit., p. 65.
29
Ivi, p. 169.
30
ESIODO, Teogonia, testo greco a fronte, trad. it. di G. Arrighetti, Rizzoli, Milano 1984, pp. 78-79.
31
A. TAGLIAPIETRA, op. cit., p. 198.
32
Ivi, p.187
33
M. CACCIARI, Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittegenstein,
Feltrinelli, Milano 1976, pp. 63-64.
34
Ivi, pp. 91-92.
35
M. DE UNAMUNO, Del sentimento tragico della vita negli uomini e nei popoli, a cura di A.
Savignano, Piemme, Casale Monferrato 2000, pp. 47-48.
36
Secondo la tradizione Yiddish degli ebrei ashkenaziti di Praga l’automa di argilla creato da
Rabbi Loew, per difendere la gente del ghetto dai soprusi dei cristiani aveva incisa sulla fronte la
parola Emeth che in ebraico significa sia “verità” che “fedeltà”. Una volta sfuggito al controllo del
suo demiurgo seminò il terrore anche tra quanti doveva difendere. Fu infine distrutto facendogli
cadere la lettera E dalla parola Emeth che aveva incisa sulla fronte e che lo animava. Il nuovo
significato della parola fu Meth, che invece significava “Pace eterna” e da colosso di argilla divenne d’un colpo un cumulo di polvere.
37
F. NIETZSCHE, Frammenti Postumi, 1887-1888, Newton, Roma 1989, p.72.
38
H. MELVILLE, Moby Dick, Newton, Roma 1995, p. 335.
109
HESSE: DALL’UOMO A DIO
UN’OPERA SENZA TEMPO
di Antonio Stanca
110
L’esito di una recente indagine ha dimostrato che uno dei romanzi più letti
in Italia, dagli anni Ottanta ad oggi, è Siddharta dello scrittore tedesco
Hermann Hesse (1877-1962), Nobel per la Letteratura nel 1946. L’opera,
completata nel 1922, fu pubblicata nello stesso anno dalla S. Fischer di
Berlino e da noi comparve nel 1945 per i tipi della Frassinelli di Torino con traduzione di Massimo Mila. Essa va ascritta al periodo detto del Decadentismo.
In questa Hesse s’inserisce in modo singolare giacché le sue opere, come
quelle del contemporaneo e connazionale Thomas Mann, sono quasi sempre
impegnate nella ricerca di una combinazione, anche se difficile, tra ragione e
sentimento, materia e spirito. Hesse e Mann non evadono dalla realtà come
voluto dalla poetica decadente ma tendono a comprenderla, ad integrarla in
una visione più ampia, più articolata, a conciliarla con l’idea ed a farle coesistere. A differenza di Mann, Hesse perseguirà l’obiettivo con un rigore ed una
razionalità minori perché non rinuncerà agli abbandoni estatici o accensioni
mistiche che facevano parte della sua personalità fin dai tempi della prima
formazione. Egli è un passionale, un istintivo e come nella vita così nelle
opere la composizione dei due termini, reale e ideale, rappresenta una conquista che giunge dopo un percorso dalle alterne vicende durante le quali è
prevalso l’uno o l’altro. Questo avviene in ognuno dei suoi romanzi: in essi si
comincia sempre dall’inizio, si segue sempre una via nuova rispetto alla precedente come se nessuna meta fosse stata raggiunta prima. Siddharta, la
storia del principe asceta, costituisce uno dei tanti percorsi compiuti dall’uomo e dall’artista Hesse. Costante è il rapporto, in questo autore, tra quanto
vissuto e quanto scritto: egli s’immedesima nei suoi protagonisti e identico è
lo spirito che muove l’uno e gli altri. Succederà, quindi, che dopo un viaggio
in India concepisca Siddharta, breve romanzo d’ambientazione indiana, nel
quale lo scrittore rappresenta i propri umori di moderno intellettuale europeo
diviso tra l’adesione alla realtà, che nel libro corrisponde a “samsara”, e l’aspirazione ad evaderla, a liberarsene, a preferire l’idea o “nirvana”. Codesto
dissidio si risolverà, per Hesse e il suo principe indiano, nella scoperta ed
acquisizione di un sentimento nuovo che lo comprenda insieme ad ogni altro
contrasto ed elemento e aspetto del mondo e della vita, l’”Om”. Soltanto
quando Siddharta si sarà sentito disposto a vivere una vita cosmica, totale e
ne avrà fatto una nuova coscienza si placherà la sua brama di conoscere
che, comparsa nella prima giovinezza, lo aveva sempre inquietato e fatto di
lui un eterno scontento, un ramingo, un pellegrino. Per seguire tale richiamo
aveva abbandonato la casa del padre ed i privilegi della sua condizione
NOTE
SAGGI
sociale, la setta dei seguaci del Sublime Gotama, l’amico Govinda, l’amore di
Kamala e l’agiata posizione di mercante. In ognuna di queste esperienze
aveva intravisto l’aspirata realizzazione ma ogni volta erano sopraggiunti il
disgusto, il disprezzo per quanto ottenuto poiché rivelatosi riduttivo, limitativo
rispetto alle più estese esigenze del suo animo. Eppure si era impegnato,
prodigato in tali situazioni perché credute definitive ed invece aveva improvvisamente avvertito il vecchio richiamo e constatato il suo destino come non
ancora compiuto. Si sarebbe compiuto con la scoperta, da parte di Siddharta,
dei pensieri, delle azioni, delle parole, dei silenzi, della vita dell’umile barcaiolo Vasudeva, quello che lo aveva aiutato mentre fuggiva dai suoi luoghi
per inseguire i sogni. Tramite Vasudeva Siddharta sarebbe venuto a contatto
con i contenuti ed i modi della vita e con questi avrebbe identificato quella pienezza, quell’assoluto così a lungo ed invano cercati. Non rimaneva che scegliere di divenire l’erede materiale e morale di Vasudeva, di continuare le sue
azioni e pensieri dal momento che nella loro semplice unione stava quella più
complessa di vita ed opera cercata da Siddharta. Per lui che aveva “saputo
pensare, aspettare, digiunare” dietro il suo sogno era venuto il momento della
scoperta, della verità. Dal barcaiolo aveva appreso che la perfezione, la sublimità stavano nell’accettazione dell’esistenza come fenomeno molteplice,
infinito e che questo sentimento, questa coscienza rendevano l’uomo simile
al Dio supremo poiché abolivano ogni limite di tempo e luogo e trasformavano tutto in un eterno presente dove era possibile sentire in sé gli sterminati
aspetti della vita, la totalità, l’universalità del creato, l’immensità dell’essere,
il suo incessante divenire.
Siddharta si sarebbe trasformato in un altro Vasudeva, in una persona
comune, in un semplice barcaiolo giacché era divenuto consapevole che la
verità non risiede di là dell’uomo ma in lui, non oltre il fiume ma nel fiume sempre uguale e sempre nuovo come “la corrente della vita”, sempre unico e sempre multiplo come l’unicità e la molteplicità dell’essere. Il viaggio di Siddharta
si concludeva in lui avendo egli capito che per essere Dio bastava essere
semplicemente un uomo capace di vivere la cosmicità, di annullare ogni distacco, frattura, divisione tra gli esseri e le cose e viverli tutti e contemporaneamente spiegandoli e giustificandoli come gli innumerevoli e necessari
aspetti di un’esistenza che, senza soste, si ripete e si rinnova. Tutte le realtà
risultavano riunite in una sola ed immensa, tutte le vite, tutta l’umanità in una
vita, in un uomo liberati dai limiti di quantità, estensione, durata. Tale sentimento d’immensa compresenza e compartecipazione, tale dimensione superiore all’umana e pari alla divina avrebbero appagato Siddharta ed ogni uomo
che, come lui, si fosse sentito preso nello stesso destino.
Questo è il messaggio che proviene dal libro di Hesse, questo spiega l’interesse che ancora suscita presso il pubblico, specie giovanile. Esso interpreta le speranze, i sogni di quanti vorrebbero evadere dalla situazione vissuta in
cerca di altre realizzazioni e, perciò, soprattutto dei giovani moderni spesso
inquieti, insoddisfatti e propensi a cercare, cambiare, rinnovarsi, ad avvertire
impulsi, emozioni, slanci, a provare sensazioni di ampiezza, d’infinità. Anche
lo stile di Hesse ha favorito il successo del libro perché capace, con i suoi tra-
111
sporti lirici, di emozionare, entusiasmare, commuovere e, con la sua chiarezza, di risultare sempre vicino al lettore.
Hesse non è stato soltanto scrittore ma anche poeta e pittore e questi
aspetti della personalità, insieme al carattere mistico che tutta la pervade,
spiegano la sua prosa così pronta ad incidere nell’animo prima che nella
mente come appunto avviene con i versi e le immagini. Sono le qualità che
hanno fatto di Siddharta un riferimento continuo, un’opera senza tempo.
112
IL CORPO GUARDATO
AUTENTICITA’ E IMMAGINE
L’enigma dello specchio
C’è un tema che ricorre di frequente nel mito e nella narrativa favolistica,
declinato in molteplici versioni: è il tema dello specchio. Narciso si innamora
dell’immagine che in esso si riflette; in Biancaneve dei fratelli Grimm, allo
specchio si chiede quasi un’attestazione di valore del volto che proietta oppure un responso circa la propria identità, in Belinda e il mostro di Le Prince de
Beaumont; è ancora lo specchio a costituire una barriera che l’Alice di Carroll
attraversa per conoscere finalmente ciò che esiste al di là. Questo motivo così
noto, se da una parte esprime l’eterno desiderio dell’uomo di conoscere se
stesso, manifesta anche la consapevolezza che questo conoscersi non si realizza se non in una dialettica di opacità e trasparenza, dovuta al carattere
necessariamente ambiguo della nostra corporeità, che rimanda all’ulteriore
dialettica di guardare-essere guardati. È il corpo che ci es-pone, cioè ci svela
e, allo stesso tempo, in un certo senso, è il corpo che ci nasconde e ci vela:
l’alternativa tra essere e apparire, tra maschera e volto, tra persona e personaggio, che la filosofia e la letteratura universale hanno inteso ed espresso in
tanti modi, pur nelle sue diverse sfumature, mette in luce questa radicale
ambiguità. Attraversare lo specchio, dunque, per ricorrere ad uno dei motivi
fabulatori citati, sta a significare il tentativo di penetrare in quell’immagine dell’io, che lo specchio da una parte riflette e dall’altra nasconde, per mezzo di
una trasparenza che in realtà si rivela illusoria. “Lo specchio stende davanti a
noi, come una sfida e come un supplizio di Tantalo, l’ostacolo che noi stessi
costituiamo per noi; il voler penetrare la sua superficie e la sua profondità traduce il desiderio di giungere fino al cuore di ciò attorno a cui il nostro io è stato
organizzato”1.
Allo specchio, dunque, si affida la risposta a quell’esigenza di riconoscimento che in realtà esso non può soddisfare: in un certo senso gli si chiede di restituirci un’immagine nella quale ci sia consentito riconoscerci, ma la cui fedeltà
non dipende da criteri esterni e oggettivi, bensì da quel vissuto del nostro corpo
che noi riteniamo fedele nella sua esteriorizzazione. “La presenza che cercavo
nello specchio mi è resa da quella cosa che vedo e che divento ogni volta che
cesso di abitarmi per cogliermi nella forma dell’esteriorità. Lo specchio, infatti, mi
sorprende dall’esterno e mi spaventa quando, raggiungendomi impreparato, mi
cede quel segreto che è la mia corporeità colta dal di fuori”2.
NOTE
SAGGI
di Maria Teresa Russo
113
La corporeità tra visibile e invisibile
114
“Avere un corpo significa essere visibili ed essere guardati”3. Com’è noto,
si deve alla scuola fenomenologica, una più attenta e profonda riflessione sul
significato della corporeità, che ha consentito di superare in parte il tradizionale dualismo antropologico tra anima e corpo, che ha dato luogo alternativamente a uno spiritualismo disincarnato o a un materialismo fisicista. Attraverso
la distinzione husserliana tra Körper, il corpo inteso in senso puramente materiale e Leib, il corpo vivente, prerogativa degli esseri dotati di caratteristiche
psicofisiche, si è messa in luce l’essenziale partecipazione del Leib alle funzioni della coscienza e al rapporto che l’uomo ha col mondo. È quella che
Husserl ha definito “base hyletica”, per la quale la coscienza umana è interamente legata, nelle sue operazioni, al suo corpo4. Da una parte, dunque, non
esiste una soggettività pura della quale il corpo è semplice strumento, perché
non c’è percezione delle cose che non abbia come controparte e come mediazione il Leib; d’altro canto, quest’ultimo, essendo legato all’io, non costituisce
un semplice organismo, un puro dato naturalistico, non è cosa fra le cose, in
quanto rappresenta la condizione per poter porre le cose di fronte a sé. Se
grazie al Leib le cose mi sono di fronte, il Leib si sottrae a questa frontalità, in
quanto componente irrinunciabile di qualsiasi percezione: “se posso avvicinarmi e allontanarmi rispetto alle cose, non posso farlo rispetto al mio corpo
ed esso mi è dato o attraverso uno scorcio prospettico oppure in modo incompiuto; infatti, ad esempio, non posso vedere la mia testa. Quindi il corpo è per
noi una “cosa” fisica incompiuta, che tuttavia viene percepita come una cosa
reale perché nei processi cinestetici agisce o subisce. Ma che non sia una
cosa come le altre è chiaro nello stesso subire, infatti quando dico “la mia
mano è mossa”, in questo trovo già presente la componente psichica”5.
Tutto ciò che riguarda il corpo si proietta allora su uno sfondo significativo,
perché il corpo non è un oggetto tra gli oggetti. Come ha notato efficacemente
Merleau-Ponty, le cui analisi proseguono nella direzione indicata da Husserl6, “il
corpo non è un aggregato di particelle ciascuna delle quali rimarrebbe in sé, o
anche un intreccio di processi definiti una volta per tutte –esso non è dove è,
non è ciò che è–, poiché lo vediamo secernere in se stesso un “senso” che non
gli giunge da nessun luogo, proiettarlo sul mondo circostante fatto di materia e
comunicarlo agli altri soggetti incarnati. Si è sempre notato che il gesto o la
parola trasfigurano il corpo, ma ci si accontentava di dire che essi sviluppano o
manifestano un’altra potenza, pensiero o anima. Non si vedeva che, per poterla esprimere, in ultima analisi il corpo deve divenire il pensiero o l’intenzione
che esso ci significa. È il corpo a mostrare, è il corpo a parlare”7.
Non si tratta di negare la struttura bipolare corpo-anima, assorbendo quest’ultima nel primo, quanto di ricomporla in un’unità, interpretandola come tensione tra i due aspetti di un’unica persona umana, che, non riducendosi né
all’anima né al corpo, manifesta una dualità e non un dualismo. Non più considerato come limite o come un ostacolo da superare, secondo una mentalità
ascetico-dualistica, dalle radici platonizzanti, né come semplice organismo
fisico, il corpo viene invece riconosciuto in tutta la sua espressività, come la
Il significato del pudore
Se vi è un’“eccedenza di senso” della persona rispetto al suo corpo, il
pudore, in relazione allo sguardo dell’altro di fronte al quale si è esposti, si
NOTE
SAGGI
necessaria modalità di esistenza di un vivente il cui spirito è sempre “incarnato”, cioè inserito nel mondo e nel tempo grazie alla propria corporeità, intenzionalmente vissuta.
Queste considerazioni sono la premessa per comprendere l’ambiguità di
fondo che connota la corporeità. Se il mio corpo è “l’organo per essere visto”8 e
dunque ha carattere, potremmo dire, epifanico, rivelativo dell’io nella sua visibilità, è pur vero che esso, allo sguardo dell’altro, potrebbe non lasciar vedere che
se stesso, divenire opaco e dunque addirittura costituire una barriera. Il corpo è
ciò che mi espone agli altri, ma che, allo stesso tempo, non mi consegna mai
totalmente nella verità del mio essere, il cui senso trascende il corpo: da qui l’impossibilità del mito della trasparenza totale dell’io a se stesso e dell’io agli altri.
Scriveva Merleau-Ponty, in una nota del settembre del ’59: “Dov’è l’altro in
questo corpo che io vedo? Egli è (come il senso della frase) immanente a questo corpo (non si può staccare il senso della frase per porlo a parte) e tuttavia
è di più che la somma dei segni o delle significazioni di cui tale frase è il veicolo. Egli è ciò di cui queste significazioni sono sempre immagine parziale e
non esaustiva, e che però si attesta per intero in ciascuna di esse. Sempre in
corso di incarnazione incompiuta. Al di là del corpo oggettivo come il senso del
quadro è al di là della tela”9.
In ogni gesto corporeo, anche minimo, occorre saper leggere un linguaggio simbolico, se si intende coglierlo come gesto umano, cioè nel significato
ad esso sotteso e nell’intenzione che lo ha prodotto: in caso contrario, la corporeità dell’altro, che pure mi è di fronte e mi è visibile, si riduce a una somma
inespressiva di movimenti, un puro gioco di ombre cinesi che rimane un enigma indecifrabile10. Non a caso, la relazione di empatia, intesa come “esperienza di soggetti distinti da noi e delle loro esperienze vitali”11, ha come tramite e come mediazione precisamente la corporeità, attraverso la quale percepisco il vissuto dell’altro e lo comprendo, per analogia col mio proprio. Il
dolore, la gioia, le emozioni in genere, vengono “letti” nel corpo, non perché
siano soltanto mutamenti corporei, ma in quanto è il corpo ad esprimerli e a
consentirmi di raggiungere il centro personale dell’altro12.
Rimane, comunque, sempre una soglia di impenetrabilità, una sorta di diaframma che impedisce un accesso pieno della vista all’io e che non è da intendersi negativamente: è quella protezione della propria intimità, che tradizionalmente è stata definita col termine di pudore e che si può comprendere solo
alla luce di questa concezione unitaria della persona. “Si deve certo riconoscere –nota Merleau Ponty– che in genere il pudore, il desiderio, l’amore
hanno un significato metafisico, e cioè che sono incomprensibili se si tratta
l’uomo come una macchina governata da leggi naturali –o anche come un
fascio di istinti–, e che concernono l’uomo in quanto coscienza e libertà”13.
115
116
manifesta come reazione di protezione del significato di cui il corpo è portatore. Osserva ancora Merleau-Ponty: “Dire che ho un corpo è quindi un modo di
dire che posso essere visto come un oggetto e che cerco di essere visto come
soggetto, che l’altro può essere il mio signore o il mio servo, cosicché il pudore o l’impudore esprimono la dialettica della pluralità delle coscienze, e hanno
un significato metafisico”14.
Una riflessione sul pudore, che ne comprenda esattamente il contenuto
antropologico e non sia riduttiva o falsificante, si può condurre soltanto nell’ottica di un’antropologia integrale, che assegni alla corporeità il ruolo che le spetta nell’agire e nel sentire dell’uomo, nonché nel suo co-agire e co-sentire, che
avvengono necessariamente in un contesto di intersoggettività. Si tratta, in altri
termini, di cogliere in tutta la sua portata il significato personalistico del pudore.
Non sempre, storicamente, lo si è considerato in quest’ottica. Hegel, ad
esempio, ha interpretato il pudore come una rivendicazione dei diritti dello spirito sulla materia, quasi una ribellione dell’uomo che non si rassegna al suo
essere anche corporeo: è evidente l’impostazione spiritualistica, che ripropone in altri termini l’antico dualismo. “Il pudore è l’inizio dell’ira contro qualcosa
che non deve essere. L’uomo che diventa cosciente della sua destinazione
superiore, della sua essenza spirituale, non può non considerare inadeguato
quel che è solo animalesco, e non può non sforzarsi di nascondere quelle parti
del suo corpo che servono solo a funzioni animali e non hanno né una diretta
determinazione spirituale, né un’espressione spirituale”15.
L’interpretazione che Freud dà del pudore, al contrario, parte dal presupposto che nell’uomo esistono sentimenti in sé che non derivano dall’esterno:
dunque ha il merito, al contrario dei positivisti, che ritenevano il pudore un fenomeno puramente culturale, di considerare il pudore come appartenente alla
sfera delle realtà innate e non acquisite, pur non sottovalutando le influenze
della società e dell’educazione. Tuttavia, per Freud il pudore ha una valenza
essenzialmente negativa16, esso è da una parte il deposito storico delle inibizioni esterne, dall’altra una sorta di autocensura per cui l’individuo “non riconosce” ciò che di fatto desidera: in quest’ottica, è auspicabile, per la maturazione
della persona, che cada questo paravento, per far emergere la sostanza autentica della vita umana, da Freud identificata con le pulsioni della libido17.
È con Scheler18, e in seguito anche con la filosofia personalista19, che si fa
strada una riflessione più articolata sul pudore, che tiene conto della concezione della corporeità declinata in Körper e Leib. In netta antitesi con la posizione
freudiana, per Scheler il pudore è quel sentimento che esprime il chiaroscuro
della natura umana20, la quale sperimenta un conflitto tra il significato personale della propria corporeità, derivato dalla sua unione con lo spirito e il suo modo
di manifestarsi concreto ed effettivo21. Ancor prima che come reazione di fronte a qualcuno, esso insorge nella persona come un sentimento di se stessa,
come consapevolezza della propria situazione di confine: per questo né l’animale né Dio provano pudore. “L’uomo, nel suo essere più intimo, si percepisce
effettivamente e si coglie come ‘ponte’, come ‘passaggio’ tra due ordini di essere e di essenza, nei quali egli è con pari profondità radicato e ai quali non può,
neppure per un attimo sottrarsi senza cessare di essere ‘uomo’ 22.
NOTE
SAGGI
Se il corpo ci rende visibili e dunque guardati23, sorge allora una reazione di
pudore tutte le volte che lo sguardo dell’altro non rispetta questa dialettica di
interiorità ed esteriorità, cioè non coglie il carattere simbolico dei fenomeni fisici, che rappresentano, nella terminologia scheleriana, dei valori di espressione:
sono portatori di significati che trascendono il corpo, in quanto “simboli espressivi di intenzioni-di-atti di natura psichica provenienti da un io”24. E ciò riguarda
particolarmente tutte quelle parti del corpo più cariche di espressività.
Non sempre il vedere un corpo, dunque, comporta il riconoscimento del
suo valore: su questo tema è nota la posizione di Sartre, che tratta della “vergogna” come reazione di fronte allo sguardo dell’altro che mi riduce a “cosa”.
Per Sartre, però, è l’esistere stesso dell’altro che mi guarda a oggettivarmi e a
rendermi cosa, dunque a provocare la mia vergogna: “il mio peccato originale
è l’esistenza dell’altro”25. Il problema posto dalla posizione sartriana è duplice:
per il filosofo non esiste altro sguardo che quello reificante, perché necessariamente l’altro che mi guarda mi espropria del mio spazio; in secondo luogo,
la vergogna rappresenta sempre una reazione negativa, una difesa dalla
minaccia dell’alterità26.
Ma non è il “sapersi guardati” a determinare di per sé il pudore, quanto piuttosto il “sapersi oggetto di un certo sguardo”: quando, cioè, come nota
Scheler, non c’è coincidenza tra la propria intenzionalità e quella di chi guarda27. In altri termini, quando manca reciprocità tra l’atto dell’offrirsi allo sguardo e l’atto del guardare. Per questo nel sentimento del pudore è implicito un
“ritorno su se stessi”, nel quale ci si rende conto della divergenza tra il significato che si assegna al proprio gesto corporeo e il significato che può essergli
attribuito dall’altro. K. Wojtyla, nel saggio Amore e responsabilità28, trattando
questo tema, lo inquadra in un contesto personalistico, sottolineando come il
valore della persona sia strettamente legato alla sua oggettiva inalienabilità e
alla sua inviolabilità, che trovano espressione proprio nel pudore29.
Il pudore promuove l’unità della persona e manifesta una “richiesta di riconoscimento”, di fronte a un possibile sguardo oggettivante che la scindesse
nelle sue componenti, strumentalizzando o assolutizzando solo quella visibile.
La vergogna sartriana, dunque, non coincide con il pudore: quest’ultimo ha,
infatti, essenzialmente una valenza positiva, perché si riferisce ad “una determinazione axiologicamente positiva del proprio io”30. Non è semplice paura del
disonore, come voleva Aristotele31, nel IV libro dell’Etica Nicomachea né timore di suscitare disprezzo e neanche una reazione puramente difensiva: è la
consapevolezza del valore della propria intimità e la capacità di autopossesso
e di custodia del significato profondo del proprio corpo. Il pudore rivela il valore della persona, del carattere inviolabile della sua intimità; esso attesta la trascendenza dello spirito rispetto al corpo, che non ne manifesta l’essere in
modo totale: esiste lo scarto rappresentato dall’intimità, un sorta di regione di
confine tra la visibilità del corpo e l’invisibilità dell’io.
È chiaro che la piena reciprocità della visibilità si dà soltanto nello sguardo
d’amore: per Sartre sarebbe impossibile quella che K. Wojtyla definisce felicemente “la legge dell’assorbimento della vergogna da parte dell’amore”, per
la quale la vergogna intesa come pudore, che non è negativa, ma anzi rap-
117
118
presenta “una forza morale della persona”, viene orientata nella sua funzione
di svelare pienamente il senso del corpo a uno sguardo che lo coglie altrettanto pienamente31.
Non è allora lo sguardo di Dio a provocare la vergogna di Adamo ed Eva
nei confronti della propria nudità, come afferma Sartre; per lui è Dio che mette
a nudo i progenitori, perché costituisce il limite contro il quale essi si imbattono: “Se c’è un Altro, chiunque esso sia, ovunque sia, e quali che siano i suoi
rapporti con me, anche se non agisce su di me in altro modo che con la semplice comparsa del suo essere, io ho un di fuori, una natura; […] e la vergogna è –come la fierezza– l’apprensione di me stesso come natura, anche se
questa natura mi sfugge ed è inconoscibile come tale”32.
Per Sartre, l’essere visti dall’altro provoca la reazione di vergogna, cioè
quella ribellione all’oggettivazione che, più che una protezione dell’essere,
appare un rifiuto dell’essere stesso: “La vergogna è il sentimento della caduta
originale, non del fatto che abbia commesso questo o quell’errore, ma semplicemente del fatto che sono “caduto” nel mondo, in mezzo alle cose, e che ho
bisogno della mediazione d’altri per essere ciò che sono. Il pudore e, in particolare, il timore di essere sorpreso in stato di nudità non sono che specificazioni simboliche della vergogna originale: il corpo simbolizza qui la nostra
oggettività senza difesa. Vestirsi significa dissimulare la propria oggettività,
reclamare il diritto di vedere senza essere visto, cioè di essere puro soggetto.
Per questo il simbolo biblico della caduta, dopo il peccato originale, è il fatto
che Adamo ed Eva, “capiscono di essere nudi”33.
In realtà, non è lo sguardo di Dio, come ha efficacemente messo in risalto
Giovanni Paolo II, nei suoi scritti di teologia del corpo che contengono interessanti spunti antropologici, a determinare l’insorgenza della vergogna nei
progenitori, quanto piuttosto la trasformazione che subisce lo sguardo dell’uomo. Non è l’alterità in sé a rappresentare una minaccia per la mia indipendenza, in questo caso l’alterità di Dio: non è l’alterità ad alienarmi, ad espropriarmi di me stesso. Anzi, solo lo sguardo dell’altro può riconoscermi come
valore e, allo stesso tempo, mostrare il limite dell’affermazione di me stesso.
La nudità originaria, della quale i progenitori non provavano vergogna, sta a
simboleggiare che la reciproca esperienza del corpo era all’insegna della trasparenza, per cui il significato personale di esso veniva pienamente colto e
compreso, in un perfetto equilibrio tra esteriorità e interiorità34.
Corpi esposti e corpi nascosti
Se guardo l’altro come oggetto, il suo corpo perde il significato simbolico
che ha come rivelatore dell’io: dunque da simbolo, che rappresenta la realtà
della persona, che in un certo senso fa trapelare rendendosi trasparente, quel
corpo si riduce a pura immagine, intesa come simulacro35, che non allude a
nient’altro che a sé, opaco dunque, in quella pesantezza della carne che tuttavia non rimanda ad altri significati che quelli che la vista può scorgere.
Vi sono corpi esposti e corpi nascosti. Da un lato, vi sono corpi invisibili in
NOTE
SAGGI
quanto non oggetto di sguardo, perché irrilevanti, scomodi o deformi: corpi
nascosti, trafugati alla vista. E, d’altro canto, corpi in mostra, corpi esibiti: corpi
opachi, che non rimandano ad altro che a se stessi. Simulacri, non immagini:
moltiplicabili, riproducibili, polivalenti. Sono corpi che paradossalmente, pur investendoci con la loro presenza massiccia, si destrutturano, divengono oggetti privi
di personalità, in un’opacità che manifesta una leggerezza insostenibile: non
rivela la persona, ma la vela o, addirittura, la smarrisce. È il corpo ostentato dai
media o dalla pubblicità, non identificabile perché pura carne anonima, corpo
pubblico di tutti e di nessuno; l’essere di questo corpo è solo un essere-pressogli altri, un puro apparire e un mostrarsi36. “Quel corpo svelato sullo schermo è
dato-rifiutato. Rifiutato proprio in quanto è dato ed ha assunto tutta l’apparenza
di un corpo reale. Tanto più rifiutato quanto più sembrava dato […] E che sia rifiutato non sarebbe un problema (l’immaginario lo è sempre), se non fosse tanto
prodigiosamente offerto (al punto di non apparire più come immaginario in questo svelamento). Io sono frustrato da ciò che in apparenza mi riempie”37.
È il corpo scrutato da uno sguardo clinico impietoso, che intende leggervi soltanto i sintomi da inserire in un quadro nosografico già fissato; organismo de-personalizzato, trattato come un caso interessante, da esplorare come un oggetto di
ricerca38. Questo corpo esposto rimane così soltanto l’archetipo della malattia,
della morte, dell’handicap oppure della forma fisica, della colpa, del dolore, scrutati ed esibiti nella loro radicalità e universalità. Corpi che divengono maschere
tragiche o comiche, non riconosciuti come individualità: al massimo hanno la
familiarità del déja vu, ma non la consistenza di persone concrete da identificare
e da incontrare, perché non c’è reciprocità nel guardare. “L’uomo non cerca più
di penetrare nell’intimità di una coscienza, per sforzarsi di giungere con essa a
una comunione che arricchisce, ma si limita a percorrerla. Non si guarda più negli
occhi, ma si guardano gli occhi, non si contempla più un viso, ma lo si svisa, lo si
spoglia di se stesso applicando su di esso la maschera vuota dell’anonimato”39.
Il corpo nascosto, invece, si perde nell’insignificanza: è incapace di riconoscersi perché nessuno lo riconosce, nessuno lo raccoglie con sguardo d’interesse come portatore di senso. Non fa notizia, non è un caso, non è emergente: lo si relega nella fossa comune del corpo-massa (popolo, ceto sociale),
dove la parte è in funzione del tutto o del materiale umano, che si utilizza per
i propri scopi. È anche il corpo che viene intenzionalmente sottratto allo sguardo perché la sua presenza non sia perturbante, nascosto alla vista in modo da
negarne l’identità di persona: è il caso del feto abortito o del desaparecido, sul
cui cadavere inutilmente la madre reclama il diritto di piangere. C’è pure il
corpo che volontariamente desidera inabissarsi nell’anonimato, perché nessuno lo riconosca come responsabile: il volto del nemico che resta indefinibile o
il reo che desidera espiare la sua colpa senza che occhi curiosi lo scrutino nel
suo pentimento. Se esiste un diritto alla visibilità, una sorta di habeas corpus
che garantisce il proprio esserci in prima persona, esiste anche un diritto all’invisibilità, che assicuri la possibilità di dileguarsi quando l’essere visti diventa
arbitraria esposizione.
Se il corpo nascosto soffre d’invisibilità, il corpo esposto è, invece, il prodotto di quella libido videndi che sembra caratterizzare il nostro tempo: “guar-
119
120
do dunque sono” può essere il nuovo motto, col suo correlato necessario:
“sono guardato dunque sono”. Espressione entrambi di una fragilità interiore,
che ha bisogno per sostenersi di una sorta di consenso visivo: se vedere significa essere di più, nella sua illusione di controllo di persone e situazioni, essere visto significa essere di più, nella convinzione che l’essere-presso-altri
valga di più che l’essere in sé.
È quella che la tradizione teologica ha definito la concupiscentia oculorum:
“C’è una voluttà del vedere che perverte il senso originario della visione e trascina l’uomo stesso nel disordine. Fine del vedere è la percezione della realtà. La ‘concupiscenza degli occhi’ invece non vuole percepire la realtà, ma
vuole vedere. […] ‘La mira di questo vedere non è diretta a comprendere ed a
raggiungere consapevolmente la verità, ma è diretta alle possibilità di abbandonarsi al mondo’, così dice Heidegger in Sein und Zeit”40.
Paradossalmente, tanto il corpo esposto quanto il corpo nascosto non
manifestano la persona, perché non sono individuati e identificabili. Per questo la reazione all’esposizione e all’occultamento è identica: la vergogna, la
vergogna di essere-soltanto-corpo o la vergogna di non esserlo affatto. Il
pudore, invece, costituisce la salvaguardia a quella tensione tra opacità e trasparenza, visibilità e invisibilità, vicinanza e distanza, che è necessaria per
proteggere l’interiorità della persona. Se il semplice offrirsi alla vista non comporta di per sé un incontro, l’espressione di sé mediata dal pudore garantisce
un’autentica relazione interpersonale.
È evidente che l’alternativa che si pone è tra il costruire un’etica della vergogna oppure, al contrario, un’etica del pudore e, di conseguenza, una civiltà
della vergogna o una civiltà del pudore. Nella prima si è semplici spettatori
degli altri e la dialettica guardare-essere guardati oscillerà tra il voyeurismo e
la provocazione, che è il costringere a guardare: dunque tra il reclamare il diritto a vedere e la ribellione all’esposizione. In questo contesto, l’autentico significato dei gesti può smarrirsi e il rischio è quello di costituire un mondo di contatti senza incontri, dove ha più importanza la quantità –“quanti sono quelli che
mi vedono”– che la qualità.
Solo nella seconda si potrà realizzare un’autentica reciprocità delle relazioni, fatta di rispetto dell’intimità e del riconoscimento del carattere personale di quel corpo che siamo.
J. BRUN, La nudità umana, Sei, Torino 1995, p. 61.
U. GALIMBERTI, Il corpo, Feltrinelli, Milano 1987, p. 162.
3
M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 1993, p. 206.
4
Cfr. A. ALES BELLO, L’analisi della corporeità nella fenomenologia, in Corpo e pensiero, Atti
dell’VIII Convegno Studium, Roma 21-23 ottobre 1999, Studium, Roma 2000, pp. 485- 488.
5
Ivi, p. 488.
6
Nell’analisi condotta dal filosofo francese permangono, tuttavia, alcune ambiguità nella
descrizione del rapporto di connessione-distacco tra il corpo e la sfera psichico-spirituale, come
appare, ad esempio, nel valore assegnato alla sessualità (cfr. A. ALES BELLO, op. cit., pp. 492-493).
7
M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1965, p. 253.
1
2
ID., Il visibile e l’invisibile, cit., p. 257.
Ivi, p. 224.
10
Cfr. U. GALIMBERTI, op. cit., pp. 88-90.
11
E. STEIN, L’empatia, Franco Angeli, Milano 1986, p. 51.
12
La letteratura ha spesso esemplificato questo carattere espressivo del corpo, come nel caso
della novella di Pirandello, La mano del malato povero, dove la sola visione di una mano di un
ammalato in un ospedale consente al vicino di letto di ricostruire un’intera biografia: “Mi misi a contemplare con curiosità amorosa questa mano, e da essa a poco a poco mi feci narrare la favola
che vi dirò. Me la narrò coi cenni –s’intende– forse incoscienti, che di tanto in tanto faceva; con
gli atteggiamenti in cui s’abbandonava”: L. PIRANDELLO, Novelle per un anno, Mondadori, Milano
1990, pp. 112-114).
13
M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologia della percezione, cit., p. 235.
14
Ibidem.
15
G. W. F. HEGEL, Estetica, Feltrinelli, Milano 1963, p. 978.
16
Una valenza positiva è riconosciuta al pudore da parte di Freud, ma come “una resistenza
convenzionale a godere dell’amore”, una sorta di “ostacolo per spingere in alto la libido” (cfr. S.
FREUD, Contribution à la psychologie de la vie amoureuse, “Revue française de psychanalise”,
1936, 1, p. 18).
17
Si veda, a questo proposito, la critica puntuale che M. SCHELER muove a questa interpretazione di Freud nel suo saggio Pudore e sentimento del pudore, Guida, Napoli 1979, pp. 77-79.
18
La stesura del nucleo principale del saggio di SCHELER, Pudore e sentimento del pudore, cit.,
è da collocare tra il 1912-1913; la pubblicazione dell’intero saggio è del 1933, cinque anni dopo
la morte del filosofo.
19
Interessanti su questo tema le riflessioni di E. Mounier e R. Le Senne.
20
Cfr. M. SCHELER, op. cit., p. 19.
21
Cfr. Ivi, p. 21.
22
Ivi, p. 22.
23
Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 206.
24
Cfr. M. SCHELER, op. cit., p. 103.
25
J. P. SARTRE, L’essere e il nulla, Il Saggiatore, Milano 1984, p. 361.
26
Su questa posizione di Sartre si vedano le osservazioni di G. ZUANAZZI, Temi e simboli dell’eros, Città Nuova, Roma 1991, pp. 130-133.
27
M. SCHELER, op. cit., pp. 35-37.
28
K. WOJTYLA, Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1980.
29
Cfr. Ivi, p. 130.
30
M. SCHELER, op. cit., p. 107.
31
K. WOJTYLA, op. cit., p. 135.
32
J. P. SARTRE, op.cit., p. 361. Di questo parere è anche U. GALIMBERTI, Il corpo, cit., pp. 104105; 123-124.
33
J. P. SARTRE, op. cit., pp. 362-363.
34
Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova e Libreria Editrice Vaticana, Roma
20015, pp. 68-70.
35
Il simulacro differisce dall’immagine propriamente detta, in quanto non rinvia ad un significato posto al di là di esso, ma è autoreferenziale. Cfr. M. PERNIOLA, La società dei simulacri,
Cappelli, Bologna 1983.
36
Si vedano, a questo proposito, le osservazioni sulla trasformazione del significato del
corpo operata dai media, contenute nel capitolo Il corpo fra dissoluzione e manipolazione, in
G. BETTETINI – A. FUMAGALLI, Quel che resta dei media, Franco Angeli, Milano 1998, pp. 111148.
37
R. MOUNIER, Contre l’image, Paris 1963, p. 59, citato da J. BRUN, La nudità umana, cit., p. 41.
38
Si vedano a questo proposito le osservazioni di U. GALIMBERTI nel capitolo La scienza e la
riduzione del corpo a simulacro biologico (op. cit., pp. 46-51), dove però la critica del filosofo
all’oggettivazione del corpo operata dalla scienza sembra motivata soltanto dal fatto che questa
ha separato il corpo dal mondo.
39
J. BRUN, op. cit., p. 39.
40
Cfr. J. PIPER, Sulla temperanza, Morcelliana, Brescia 19652, p.102.
8
NOTE
9
121
RAPPRESENTAZIONE
E SPAZI DELLA CITTADINANZA FEMMINILE
di Anna Rita Merico
122
Una cittadinanza d’altro genere è il titolo dell’ultimo lavoro di Marisa
Forcina (Angeli, Milano 2003, pp. 220). Il sottotitolo, Discorso su un’idea politica e la sua storia, introduce alla forma attraverso la quale, nel testo, viene
attraversato il concetto di cittadinanza riferito al genere femminile a partire da
quanto/come, tale concetto, abbia/non abbia abitato le teorie politiche e le storie che ha contribuito a tessere all’interno del percorso della politica moderna.
Fondamentale la chiarificazione da cui il discorso prende corpo: non una
disamina di “errori” attraverso cui dimostrare il senso di esclusioni e subalternità del genere femminile dall’universo dei saperi filosofici quanto, piuttosto,
una serrata riflessione sulle connessioni che intimamente legano le concettualizzazioni filosofiche delle idee e delle rappresentazioni del femminile alla
storia delle teorie politiche. La ricerca –dunque– verte su quelle idee, pratiche,
meccanismi, visioni che fondano (non sempre nominati) i contenuti dell’organizzazione politica così come l’abbiamo conosciuta nella cultura occidentale.
Il disordine femminile temuto da Aristotele, il silenzio nella comunità voluto
da Paolo, per le donne, la necessità di tenere lontane le donne (in epoca
moderna) dai luoghi della politica, narrano una modalità attuata dal pensiero e
dai corpi maschili di costruire, intendere, volere lo spazio della politica inteso
come spazio di controllo del cambiamento e luogo di formazione della propria
autorità (autorità maschile).
L’elaborazione del concetto di cittadinanza, così come è giunto a noi, svela
molto delle dinamiche sottese ai modi attraverso cui si sono andati costruendo i contenuti della mascolinità nei diversi contesti storico-sociali dell’occidente europeo mentre, un filo rosso, attraversa la continuità delle misure che
hanno contribuito alla definizione storica del percorso teorizzato ed agito intorno alla parola libertà.
La libertà è, nella sua essenza, agita all’interno dello spazio della politica,
essa è lontana ed è altro dall’affanno riconosciuto alla vita quotidiana: affrancarsi dai luoghi della quotidianità è il passaggio fondamentale che ha sostanziato il senso e la teorizzazione del poter accedere allo spazio, ai luoghi della
politica.
Quotidianità ed ozio hanno rappresentato ciò che allontana dalla possibilità di essere nella propria libertà, quotidianità ed ozio hanno indicato ciò che è
altrove rispetto ai luoghi del potere, della politica. L’aver lavorato esclusivamente a fissare i contorni dell’identità maschile/femminile ha cancellato, per
secoli, il valore di ciò che diviene, il valore di un simbolico non inscrivibile nelle
tensioni alle continue nascite di sé a sé, di sé al mondo, di sé all’altro/a che
NOTE
SAGGI
delimitano l’universo concettuale di quello che, Marisa Forcina, definisce il
senso di una “cittadinanza senza frontiere”.
Continuo, nelle pagine, è il richiamo alla necessità di interfacciare il concetto di cittadinanza al concetto di libertà e alle condizioni che consentono alla
libertà di poter essere pensata/agita/vissuta. Le pratiche di libertà, individuate
dalle donne nel corso della storia del proprio genere, hanno segnato il significato di strategie e randomizzazioni della stessa soggettività femminile all’interno di contesti pubblici nei quali l’appartenenza, le identità collettive e singole hanno rappresentato un continuo affare, una dimensione continuamente
aperta alla contrattazione e mai data per scontata in maniera definitiva.
Il contratto che ha legato gli uomini tra loro segnandone appartenenze, luoghi, identità, sensi delle identità, fondazioni, ha generato –tra le donne– spazi
di riflessione per aperture ad una differenza che ha modificato le questioni dell’appartenere e dell’adesione alla norma. Il non-esser(ci) nella teorizzazione
classica della cittadinanza, nell’universalità dei diritti, ha ammantato la possibilità, ad etiche altre, di definirsi secondo una linea non gerarchica rispetto
all’etica forgiatasi nella radice dell’astratta universalità. L’immobilismo costituente la strutturazione della soggettività moderna, a partire dalla centralità del
ruolo occupato dalla ragione, non ha consentito di indagare/agire rapporti altri
tra pubblico e privato, non ha consentito di porre a tema il farsi delle pratiche
di socializzazione, non ha consentito il moltiplicarsi delle nervature che compongono l’articolata concettualizzazione delle forme politiche dell’odierna
democrazia.
Cosa è dentro e cosa è fuori dal territorio della virtù? Quanto la sfera etica
e la sfera politica hanno guadagnato dalla loro separazione? In che modo la
costituzione della sfera della proprietà privata ha visto l’inclusione di persone
(donne) oltre che di beni?
Quale naturalità ha costituito da sfondo alla sfera delle autorizzazioni e
delle autodeterminazioni che hanno sostanziato il concetto di cittadinanza così
come lo conosciamo?
Innervare la dimensione della cittadinanza con il concetto di proprietà è altro
dalla capacità di lasciare attraversare la dimensione della cittadinanza da quella della libertà: con questa sottile differenza le donne hanno dovuto misurarsi
dipanando il senso e le parole per logiche altre in grado di lasciar emergere l’esigenza di legami sociali di differente segno. La cittadinanza legata alla capacità di riscrittura del valore dei vincoli, quel dis-ordine tenuto fuori dalla polis e
che ha continuato a generare un ordine altro intramato all’interno di stanze e
poi riverberato nello spazio pubblico…: in maniera pertinente l’Autrice si sofferma sulla figura di Penelope come potente metafora della tessitura di un ordine
d’altro genere in grado di governare lo stesso ordine dato del potere.
L’idea di addomesticare le arroganze del passato attraverso l’intelligenza
dell’utilizzo di pratiche gestite in contesto risponde a precisi progetti in cui non
viene riconosciuta cittadinanza alle parità confusive ed alle sacralizzazioni
intoccabili delle forme politiche socialmente riconosciute. Lo spazio della cittadinanza è lo spazio dell’azione politica, dell’azione visibile nello spazio pubblico. Quale rappresentazione di sé potevano darsi le donne all’interno di quello
123
124
che, nel testo, viene –a ragione– definito lo spazio idiota, lo spazio senza cittadinanza in cui è vissuto il privato?
Nella fase storica in cui si andava fondando la forza dell’idea di rappresentanza, le donne venivano legate ad una rappresentazione di sé talmente univoca da divenire lo spartiacque tra tutto ciò che è codificato come
morale/immorale. È tale codificazione/rappresentazione che ha definito la verità e il senso di realtà di una politica volta a stabilizzare situazioni e gerarchie,
una politica che ha annullato il valore delle pratiche e ha sottratto ogni significato alla possibilità di modificare le situazioni.
La rigida codificazione degli ordini di appartenenza apre la strada a quelle
dimensioni dell’invisibilità e dell’assenza a fondo analizzate nel testo. La categoria del cittadino ha occultato, in passato, ciò che realmente occorreva e ciò
che mancava affinché fosse riconosciuto l’essere nella libertà e nell’uguaglianza.
Chiarificatore il passaggio sostenuto: “il problema della differenza nella cittadinanza è un problema di rappresentazione” (pag. 101). Questo passaggio
è il nodo legato alla possibilità di poter rappresentare un soggetto femminile,
questo dato sposta l’attenzione nella sfera esistenziale prima ancora che politica. L’analisi di questo passaggio parte da un assunto hegeliano: la necessità della rappresentazione come elemento imprescindibile per poter dichiarare
l’agito dell’esistenza, il legame tra rappresentazione e azione/concretezza, tra
rappresentazione e assenza: spostare questa concettualizzazione dall’ambito
sistemico del pensiero hegeliano alla dimensione esistenziale femminile, consente di aprire uno squarcio di grande centralità nel pensiero contemporaneo
legato all’analisi di genere.
L’agilità di analisi del lavoro si dipana nella capacità di toccare tematiche in
grado di rendere la complessità di cui è sostanziato il concetto di cittadinanza,
oggi. Quelle tematiche sono la tematica del riconoscimento intersoggettivo, la
tematica del conflitto legata a quella della visibilità, il richiamo alla reciprocità,
il valore dell’universale se collocato nel contesto, il valore della differenza. Al
termine provvisorio della riflessione, il luogo della cittadinanza appare come
luogo culturale per eccellenza, luogo in cui progetto di emancipazione e progetto di liberazione sono in grado di indicare legami, esperienze specifiche,
consapevolezze di significato da riconoscere al valore di un pensiero capace
di incarnarsi e dirsi politico perché produttore di narrazioni in orizzonti in cui
l’avere cittadinanza è pratica di ricerca rispetto al proprio progetto e rispetto
alla propria libertà di riconoscere o meno consenso all’altro/a.
L’invito a “decostruire le parole e storicizzare i termini” è il fulcro del metodo d’indagine utilizzato all’interno dell’intero lavoro. In esso la tensione a tenere insieme, a tenere ancorata la dimensione politica a quella dell’esistenza di
ognuno/a di noi, consente di attraversare tutti i limiti di una progettualità politica in cui la relazione con il medesimo è stata l’unica rappresentazione possibile, in cui la dimensione della condivisione, dell’approccio all’alterità ha avuto
il sapore dello spreco o del non-contemplato. Il testo induce a chiederci: “e se
fosse proprio questo spreco ad essere, oggi, di massimo bisogno, a servirci?”.
Attraverso il concetto di cittadinanza nel testo vengono, dunque, ripercorsi
NOTE
SAGGI
i tragitti che hanno sostanziato la moderna sfera della politica. Ciò che ci giunge è uno strumento agile di lavoro e di indagine.
Durante lo studio del testo mi hanno piacevolmente interessato le note,
esse sono state pensate come una sorta di finestra nel testo; in esse si è reso
conto anche delle relazioni e degli scambi sottesi alla stesura delle pagine,
relazioni attinenti al farsi di questa ricerca che, nel corso degli ultimi anni, sta
procedendo attraverso avanzamenti di consapevolezze su di un periodo del
pensiero contemporaneo nel quale, le donne, hanno contribuito a sollevare, in
maniera decisiva, questioni sulla politica e sulla odierna democrazia. In questa fase storica la riflessione sta “passando” attraverso i testi più che attraverso i luoghi; ciò sta contribuendo a definire metodi d’indagine ed a ridare chiarezza agli spaccati evocati come punti critici e rivelatisi, invece, nodi teorici da
attraversare includendovi le sollecitazioni che le tematiche dell’appartenenza,
della territorialità, della cittadinanza attiva, oggi, pongono.
125
D. DE LEO, Mistero e persuasione in Carlo Michelstaedter. Passando da
Parmenide ed Eraclito, Milella, Lecce 2003, pp.164.
126
Programmaticamente presentato come la prima parte di un trittico dedicato al rapporto di Michelstaedter con la filosofia greca, il volume in questione,
inserito nella Collana di ricerche sul pensiero etico-politico “L’uomo e la città”
diretta da Marisa Forcina, si caratterizza per la linearità e la scorrevolezza tipiche degli scritti di Daniela De Leo.
Arricchito da un’ampia presentazione della figura di Michelstaedter e da una
valutazione del suo rapporto con Parmenide ed Eraclito, il lavoro è incentrato
sulla trascrizione degli Appunti di filosofia: Parmenide ed Eraclito, cui faranno
seguito, nelle intenzioni dell’autrice, le pubblicazioni relative dapprima a
Empedocle, Zenone stoico e Platone e poi ad Appunti vari e sparsi di filosofia.
Gli inediti qui proposti, conservati nel Fondo Carlo Michelstaedter della
Biblioteca Civica di Gorizia, appartengono a quegli scritti vari non compresi
nella pubblicazione delle Opere della Sansoni. “Scritti nell’estate 1909 ruotano intorno al concetto fondamentale del dualismo persuasione e rettorica. Il
punto di riferimento è l’equazione essere= persuadere” (p. 66).
Oltre ad una vasta bibliografia presentata a conclusione del volume, l’autrice dedica un’appendice alla ricostruzione delle interpretazioni del pensiero
di Michelstaedter, sottolineando la avvenuta “valutazione del pensiero del
Goriziano sotto l’aspetto filosofico” (p.118) che, congiuntamente alla sua “acutezza d’ingegno”, alla sua “giovane età” e alla sua “scelta di morte”, ha contribuito a creare intorno all’autore “una sorta di fascino che colpisce anche chi
non è un critico o uno studioso” (p.120).
Michelstaedter diviene, nelle sue stesse parole utilizzate in un articolo su
Tolstoi, un pensatore senza età: “mi chiedo, se quest’uomo può avere un’età,
se quella sua forza sempre uguale di evoluzione verso un ideale lontano, quel
suo divenire morale non costituiscono una giovinezza più durevole che ogni
reale giovinezza” (p.15).
Nel delineare il percorso conoscitivo del suo autore, Daniela De Leo sottolinea, riprendendo la lettura di G. Brianese, “la prossimità tra Michelstaedter e
i Greci” (p.11), in particolar modo poi con riferimento a Parmenide ed Eraclito
che, nella prefazione alla sua tesi di laurea, La persuasione e la rettorica,
Michelstaedter colloca tra i persuasi: “i due presocratici, –dice De Leo– cercando di sfuggire a quella contrapposizione e separazione di un duplice ordine del mondo, orientandosi verso una ricerca di stabilità, rappresentano, per
Michelstaedter, l’autenticità unica del pensiero e dell’esistenza” (p.39).
Il substrato teoretico sul quale Michelstaedter elabora la sua tesi di laurea
è rappresentato dalla filosofia di Schopenhauer e Nietzsche, da D’Annunzio,
Ibsen, Tolstoi, recependo i quali, per De Leo, egli dà “vita ad un’opera di rideterminazione concettuale e semantica, complessa sintesi di un pensiero che
risulta essere incomprensibile fuori dalle traiettorie culturali dell’epoca” (p.30).
“Abbi il coraggio di vivere tutto il dolore della tua sofferenza”, dice
Michelstaedter in La persuasione e la rettorica, delineando così una morale
non semplicemente descrittiva, ma prescrittiva. Nella sua visione della vita,
RECENSIONI
SAGGI
ricorda De Leo, per Michelstaedter “l’uomo si adatta alla vita perché è indotto
a soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri dalla philopsichia, dall’amore della
vita, che egli chiama anche il dio del piacere. La philopsichia provoca, attraverso la rettorica, una persuasione illusoria, per cui l’uomo crede di poter ottenere […] piacere, amore, felicità” (p.26). “Gli uomini che vivono al di fuori della
persuasione, incapaci di instabilità, consegnati per intero al divenire, fingono
a se stessi un’esistenza che è invece solo illusione, per essi la necessità è il
muoversi” (p.64). Con Parmenide “la via della persuasione va intesa alla luce
della stabilità dell’Essere, quella della rettorica alla luce della via segnata dall’instabilità del divenire” (p.64).
Spazio, dunque, a questi inediti che De Leo ci propone, sottolineandone
l’attualità attraverso l’esistenziale “angoscia del mistero” che pervade il cuore
di Michelstaedter come quello dell’uomo contemporaneo.
Doris Campa
M. C. BRIGANTI, Amo dunque sono. L’esperienza femminile tra filosofia e testimonianza, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 112.
Scoprire i plurivoci linguaggi contenuti nel titolo di un libro, di un saggio, di
un articolo può essere un affascinante viaggio (pp. 95-96) empatico, un ponte
o un trampolino di lancio a volte un po’ rischioso tra autore/trice-lettore/trice.
Riuscire a disvelare cifre e codici inattesi può tuttavia spiazzare entrambe le
parti. Dico questo perché chi leggendo il titolo del testo di Maria Camilla
Briganti, Amo dunque sono. L’esperienza femminile tra filosofia e testimonianza, si aspettasse di trovare esperienze autobiografiche di amori femminili
potrebbe restare deluso/a.
L’Autrice, invece, con un titolo fortemente ammiccante e alla “moda” tenta
–secondo me– di riportarci ad un significato il più originario possibile (nel
senso etimologico) della parola “amore”. L’“amore” nel senso etimologico infatti deriva da una a (=alfa privativa) + mos, moris (=costume, comportamento,
regole, etichette): l’amore come capacità di fuoriuscire, di tanto in tanto, da
rigide e insensate categorie prestabilite una volta per tutte. Ma solo temporaneamente (=epoché ). Le protagoniste del testo della Briganti: Edith Stein,
Hannah Arendt e Simone Weil infatti sono donne senza etichette, donne che
non possono essere incasellate, che non possono essere inserite in “codici”,
“costumi” e “categorie” prestabilite dal momento che hanno saputo, ciascuna
a suo modo, divergere dalle proprie tradizioni culturali, filosofiche e totalitarie
ritornando alle proprie radici e ai propri “maestri”. Queste donne, perciò, hanno
saputo eludere la ragnatela del dominio totalitario. È questa la parte di eredità (pp. 103-106) più cospicua che ci hanno lasciato e per la quale oggi esse
sono diventate testimoni credibili.
Queste pensatrici (Stein-Arendt-Weil) sono poi accomunate anche dal “tessere” un “testo” (=textum : participio passato del verbo texere) fatto di trama e
ordito che le lega intersoggettivamente con il mondo e i suoi abitanti. Esse
127
con-vibrano con il mondo, ne sono responsabili e non guardano le vicissitudini esistenziali come un “aristocratico spettatore disinteressato” (p. 98), pensano agendo (pp. 45-48) e, soprattutto, pensano senza balaustre come dice H.
Arendt impegnandosi in prima persona. La Stein s’impegna per il diritto di voto
alle donne, per il diritto di sciopero degli operai e come crocerossina durante
la 1ª guerra mondiale. La Arendt s’impegna per ricercare l’agorà come spazio
pubblico di relazionalità e per sradicare ogni forma di totalitarismo. La Weil
s’impegna per il lavoro in fabbrica e l’esperienza da crocerossina.
Uno dei meriti più evidenti di Maria Camilla Briganti è l’aver colto e sottolineato lo sforzo sociale e politico di queste tre filosofe a loro volta espressione
di un “pensare al femminile” che chiede, ogni giorno di più, diritto di cittadinanza nella storia del pensiero filosofico occidentale perché possa svincolarsi
dai platonistici ceppi della schiavitù e cominciare a pensare senza balaustre.
Ida Maria Roberta Rodriquez
G. BORRELLO, Il Lavoro e La Grazia. Un percorso attraverso il pensiero di
Simone Weil, Liguori Editore, Napoli 2001, pp.130.
128
“Il titolo scelto da Giovanna Borrello per il suo saggio sulla Weil è una sfida.
La sua formulazione è un ossimoro. Porre insieme, affiancati il ‘lavoro’ (il lavoro operaio, il lavoro nella fabbrica) e la ‘grazia’ è provocatorio come contraddizioni di termini”. Così si legge nella prefazione al testo a cura di Aldo
Masullo, (p.XII), ma pur nella sua veritiera e palese attestazione, non è proprio
assecondando questa linea di tendenza che il saggio va letto.
Attraverso una riflessione continuata e continuativa che si pone come tema
centrale la sfera del lavoro, Giovanna Borrello ha tracciato un percorso filosofico, teso ad illustrare come il pensiero di Simone Weil si sia costruito ed evoluto passando da una prima fase, entro cui si inquadra perfettamente una visione critica del marxismo, una fase che si definisce politica, sino ad arrivare ad
una seconda fase che viene associata alla sua conversione e alla sua esperienza mistica, fase in cui si determina la sua volontà di amalgamare il pensiero politico con quello mistico e religioso, al fine di estrapolare una concezione
filosofico-politica volta a dimostrare che solo l’amore e l’accettazione, (come lo
spirito religioso insegna) possono superare gli ostacoli posti in essere dall’imperio della forza e dalla strumentalizzazione della soggettività umana.
Un passaggio fondamentale, poiché è proprio a partire da tale cambiamento che tutta l’opera prende il suo senso.
Una contraddizione, dunque, ma non fu proprio la Weil a sostenere che la
contraddizione si pone come l’unico strumento del pensiero in grado di elevarlo?
Eppure, quel che fondamentalmente si designa come contraddizione elevatrice, non è identificata, in questo caso, come lo schema dialettico di sintesi dei contrari. Giovanna Borrello, tra le pagine del suo saggio ci illustra perfettamente come per Simone Weil non ha alcun senso parlare di sintesi dei
RECENSIONI
contrari, quanto piuttosto di “unione dei contrari”, ecco perché la sua visione e
metabolizzazione del marxismo e soprattutto della filosofia hegeliana eredita
da entrambi soltanto la nozione di “rapporto”, nozione essenziale sulla quale
si erge con tutta la sua notevole importanza, quella sua speculazione filosofico-morale che ha portato Giovanna Borrello, per gradi, ad affermare la possibilità di accostare il lavoro alla grazia.
“Il lavoro è insieme costrizione e possibilità di riscatto e redenzione”
(p.124). Contrariamente alle impostazioni di pensiero hegelo-marxista,
Simone Weil, superando la concezione del “rovesciamento” (che con la rivolta degli operai contro i capitalisti non determinerebbe affatto una soglia di libertà egualitaria, quanto piuttosto uno stato contrario in cui impererebbe la forza
degli operai sui capitalisti), intravede nella dimensione del “rapporto” una contraddizione aperta […], in cui le due verità, le due polarità, non sono ridotte ad
una: il rapporto, infatti, implica la dualità e non l’unità; inoltre, lo stesso rapporto non chiude il processo di correlazione, ma lo rimanda ad un “altrove”,
che non si colloca sullo stesso registro logico ma in un assolutamente Altro
(p.17). Giovanna Borrello, effettuando un’analisi di lettura su un testo cardine
del pensiero della Weil, a proposito del tema del lavoro, La condizione operaia, arriva a mettere insieme degli elementi cardine della condizione lavorativa, che non vanno letti solo in chiave lavorativa, ma anche, e soprattutto assecondando una necessità squisitamente sociale.
Dalla sua esperienza in fabbrica, la Weil apprende il dislivello economico,
sociale e soprattutto giuridico, (nel senso di diritti) che esiste tra l’operaio e la
macchina, la macchina e il lavoro finito e infine tra il capitalista e l’operaio.
Questa serie di “contrari” si pongono non tanto in una continuità di “rapporti”,
quanto piuttosto in una dialettica di “contrari”, che non può che portare all’unità, penalizzando fortemente, in tal senso, la necessaria “dualità”.
Procedendo su questa linea di pensiero, però, Giovanna Borrello mette in
luce, non solo il circuito chiuso entro cui le relazioni tra i lavoratori e la fabbrica si edificano e si strutturano, ma anche la riflessione weiliana volta a rivelare che nonostante tali opposizioni e contraddizioni, in realtà non vi è alcuna
diseguaglianza tra vinti e vincitori, così come non ve ne è tra capitalisti e operai, poiché entrambe le categorie sono vittime, allo stesso modo, dell’imperio
della forza. La forza distrugge tutti quelli che tocca. Essa finisce con l’apparire esteriore sia a colui che la esercita sia a colui che la soffre. La forza è la
causa della trasformazione di ogni uomo, che la subisce o che la esercita, in
una “cosa”.
Eppure, solcando a fondo l’interpretazione weiliana della Borrello, quel che
immediatamente stupisce, proprio come una sorta di contraddizione, è la reazione all’oppressione in fabbrica con la quale la Weil stessa reagisce: la docilità, “una docilità di rassegnata bestia da soma” (p.18), una grande capacità di
adattamento alla necessità.
Capacità questa che si esplica essenzialmente in uno stato in cui è possibile il sopraggiungere di un imprevisto, un intervento gratuito, che riesce a
spezzare, anche se solo momentaneamente, il dolore e l’apatia derivanti dall’oppressione e dalla fatica. “Il gratuito si configura come l’unico intervento
129
130
possibile di sospensione della costrizione” (p.115) e ed è il lavoro che può stabilire un contatto tra l’uomo e il mondo soprannaturale, poiché sono proprio lo
sforzo e la tensione umana a collegarci a Dio.
Lungi dal fare apparire tale stato una rassegnazione pacifica e demotivata,
Simone Weil pone più volte l’accento sulla fondamentale differenza che esiste
tra accettazione e sottomissione. “L’accettaziopne delle sofferenze fisiche e
morali inevitabili, nella precisa misura in cui sono inevitabili, è il solo mezzo per
conservare la propria dignità. Ma accettazione e sottomissione sono due cose
molto diverse” (p.21) Giovanna Borrello riprende tale concetto e ne delimita, a
partire da esso, uno schema graduale che porterà, poco a poco, a delimitare
il quadro preciso della sua volontà di fare del “lavoro” e della “Grazia” due nodi
essenziali del pensiero di Simone Weil.
In questa variante si inserisce, non a caso, una prerogativa del lavoro che
definirei determinante, poiché determina la felicità o l’infelicità del rapporto che
ciascun individuo può stabilire con il suo lavoro, e cioè il rischio di divenire
“una cosa” utile a soddisfare i procedimenti meccanici di una catena di montaggio.
La dignità umana, del resto, non si può elidere dalla necessità di uno stato
soggettivo, che in quanto tale non dovrebbe mai correre il rischio di palesarsi
in uno stato oggettivo.
Il “lavoro lucido”, più volte menzionato nel corso del saggio, dimostra come
l’unica possibilità di rimanere se stessi in uno stato soggettivo sia proprio quello di non aderire ad un sistema meccanico di produzione che nasconde il fine
a cui tende la produzione per la quale si lavora. Il lavoro lucido, come Metaxù,
che all’interno del saggio prende posto come un intero capitolo (p.63), che letteralmente significa “ciò che sta in mezzo”, intermedio, si pone, nell’accezione
weiliana, come la sola possibilità di creare un ponte tra l’uomo e la realtà,
ovvero tra il suo lavoro e il risultato del suo lavoro stesso.
Simone Weil sostiene che l’unica strategia per determinarsi e mostrarsi
come pratica soggettiva è quella di informare i lavoratori del prodotto finito che
la loro parte di produzione andrà a completare, ed è proprio questa che ella
definisce “collaborazione pura” (p.39). Giovanna Borrello, cogliendo sapientemente il nesso tra tali speculazioni arriva ad illustrare come per la Weil, l’ostacolo che si frappone tra l’uomo e la realtà sia proprio l’intervento di volontà
estranee. “L’uomo non è mai di fronte alle condizioni della propria attività. La
società fa schermo tra l’uomo e la natura” (p.51) richiamandosi largamente alla
Microfisica del Potere di Michel Foucault e, assecondando il pensiero della
Weil, Giovanna Borrello, spiega con sottile maestranza il risultato di tale schermo tra l’uomo e la realtà, attraverso il concetto di potere, di quel potere che si
dirama e si protrae in ogni dove e in ogni quando, strumentalizzando la collettività, che pertanto si presenta, nel pensiero della Weil, come il nemico per
eccellenza dell’uomo inteso nella sua individualità. Ciò che nella prospettiva
weiliana, secondo la Borrello, permette il superamento della competizione
sociale, dei danni derivanti dalla collettività e soprattutto dell’esercizio della
forza è la potenza dell’amore, che implica ab-dicazione e di conseguenza
estirpazione della costrizione. Eredità del concetto di “passione” cristiana e di
RECENSIONI
redenzione divina, la capacità di amare e di attendere, di dare ed essere attraverso il proprio consenso, si delineano, in questo modo come i soli strumenti
capaci di rendere l’uomo una persona umana e non una “cosa”.
Si legge in conclusione al saggio di Giovanna Borrello “la giustizia ha in
comune con l’amore il consenso” (p.126), ma si tratta di un consenso libero e
sentito che nell’ottica weiliana deriva direttamente dalla capacità di amare la
sofferenza e accettare la fatica, in vista di un intervento gratuito capace di mitigare il patimento. Ma non solo questo. Attraverso questo suo saggio,
Giovanna Borrello è infatti voluta giungere a delle conclusioni fortemente intrise di sentimenti egualitari anche in termini di diritti della persona. Amore come
ab-dicazione, come consenso non significa forse esercizio della propria individualità giuridica attraverso un’equa rappresentanza? E non sono forse i concetti di rappresentanza, di giustizia e di libertà che fondendosi insieme rendono il quadro d’insieme della parola democrazia? Ed è proprio in questo modo
che Giovanna Borrello pone fine alle riflessioni contenute nel suo saggio: “La
giustizia come consenso è alla base delle virtù democratiche, ma non alla
base del pensiero democratico vigente che contiene un grave errore, quello di
confondere con il consenso una certa forma di consenso”.
Emanuela Monda
“Αρχη′ ”, IV (2002), La Storia e le storie. La storiografia filosofica tra vecchi e
nuovi paradigmi a cura di S. Ciurlia, pp. 267.
Nell’ultimo volume di Αρχη′ , dal titolo monografico La Storia e le sue storie,
sono raccolti saggi, che possono essere considerati in un rapporto di stretta
prosecuzione rispetto al volume precedente, intitolato Lógos e storia.
L’attenzione è ora dedicata al tema della crisi dello storicismo nella filosofia
contemporanea e all’analisi dei rapporti fra storicismo e metodologia della
ricerca storiografica.
Sandro Ciurlia nel saggio introduttivo, Discorrendo di Storia, metodi e storie…, richiamandosi all’esigenza di rinnovamento dell’esercizio storiografico
da piú parti avvertita e alla tesi di una “nuova storia”, nonché all’esperienza
culturale delle Annales, insiste su un produttivo paradosso: l’attualità di una
“storia globale” o “storia totale”. Il richiamo all’idea totale di storia consente a
Ciurlia di porre in rilievo con enfasi la curvatura problematica dell’aggettivo
‘totale’: totale, afferma l’autore, non è piú sinonimo di ‘assoluto’ e sul piano
della metodologia storica equivale a ‘sincronico’. Alla luce di tali premesse,
Ciurlia esalta la grande lezione degli Annalisti, propugnatori di una metodologia tesa a celebrare il pluralismo, a promuovere il dialogo fra gli studiosi, eppure rigorosamente specialistica. Abbattute le sovrastrutture storicistiche, l’approccio sincronico al problema della storia e “un apparentamento di fondo fra
le scienze umane” diventano i presupposti imprescindibili sui quali deve fondarsi la ricerca storica. La filosofia della storia, a sua volta, riveste un sottile
valore psicologico, autoconsolativo, perché emerge sempre di piú la necessi-
131
132
tà di sentirsi collocati in un contesto collettivo, metaindividuale. Sicché, la crisi
dello storicismo libera dalle filosofie della storia e rende la ricerca storiografica in grado di svincolarsi dai presupposti speculativi per ritenersi interrogazione critica delle fonti e, con ciò, impresa interpretativa.
Alla luce di tali considerazioni, Ciurlia, nel primo dei saggi (La sfera e il
punto: immagini filosofiche della storia a confronto), nelle due metafore geometriche della sfera e del punto individua due differenti concezioni filosofiche
della storia, due modi in cui il sapere storico ha pensato se stesso. La sfera,
perfettamente simmetrica ed armonica, viene ad identificarsi con la Storia, la
Storia del mondo; il punto con le storie, l’individuo “che crea significati e storie” in relazione ad un tempo e ad un contesto culturale. Riflettendo sull’attualità delle filosofie della storia e sulla loro crisi, l’autore si interroga sui motivi del
contrasto fra l’idea di un destino storico, che accomuna l’intera umanità che fa
la storia, e i nuovi orizzonti problematici emersi dinanzi alle tendenze globalizzanti del mondo contemporaneo. Cosí, la crisi dello storicismo classico chiude un’epoca e ne apre un’altra all’insegna delle categorie del dubbio, dell’incertezza e del “rischio” dell’avventura individuale.
Nel suo contributo, Alberto Nave (Giudizio teoretico e giudizio di valore nel
pensiero storiografico crociano) riprende la discussione crociana sulla distinzione fra il giudizio storico, che coincide con “un giudizio rigorosamente teoretico”, e il giudizio di valore, di natura empirica. Egli, prendendo le mosse dall’affermazione di Croce della storia “mai giustiziera, ma sempre giustificatrice”,
analizza le varie aree semantiche del giudizio storico, mettendone in evidenza il primato e la validità per una corretto esercizio storiografico.
Paolo Pastori (Fato, fortuna e virtù. Su alcuni aspetti della continuità nella
storiografia dell’epoca classica), attraverso una puntuale disamina della distinzione fra la storia come atto, fatto, impresa, (le res gestae) e il racconto, la
ricostruzione ordinata degli eventi compiuta dallo storico e la sua interpretazione (l’historia rerum gestarum), ha cercato di dimostrare quanti elementi di
inquietudine persistano nella storiografia dell’età classica greco-romana, in
confronto con le nascenti istanze delle filosofie della storia. L’autore, insistendo sull’idea di continuità fra le epoche e gli eventi, ripercorre le varie fasi che
hanno segnato la genesi della critica storica, fino alla nascita della “storiografia scientifica” di Tucidide.
Antonio Quarta (Sul senso della storia nella crisi del moderno. Appunti di
filosofia contemporanea) denuncia lo stato di crisi e di incertezza in cui versano le filosofie della storia nel nostro tempo. La storia non svolge piú il ruolo di
ricostruire gli eventi del passato e di metterli in relazione agli sviluppi del presente, né costituisce un’apertura al futuro o è foriera di aspettative. Anzi,
osserva Quarta, albergano il dubbio, lo scetticismo dinanzi ad ogni categoria
di riferimento, ad “ogni apparato concettuale”. Esiste solo uno spazio vuoto e
la convinzione che il mondo è indecifrabile e la speranza che, forse, proprio su
questo spazio vuoto, può allignare qualcosa di nuovo.
Massimo Sabbieti (La discontinua linearità del progresso quale costante
della critica storica), ripercorrendo alcune fra le piú importanti filosofie della
storia di matrice illuministica (Bossuet, Voltaire), si soffema a riflettere sullo
statuto del concetto hegeliano di “Storia universale”. Muovendo da una valutazione del valore dello storicismo, l’autore si chiede quale sia il significato
della storia alla luce delle filosofie attuali, quale il còmpito dello storico, quale
il rapporto fra metafisica e storia. Egli perviene alla conclusione che “la conoscenza storica deve farsi scienza”, che la ricerca storica deve tener conto dei
molteplici modi di essere, deve, talvolta, ricorrere alle classificazioni, riconoscere la diversità e l’individualità delle esperienze.
A conclusione della sezione dei Saggi, c’è il lavoro di Domenico Scalzo
(L’evento della storia. Riflessioni sull’inizio e la fine della storia in Martin
Heidegger), il quale, meditando sulla differenziazione storica fra la permanenza dell’essere e il divenire della temporalità nella filosofia heideggeriana, si
interroga sul concetto di “evento originario” inteso come compimento della storia. Attraverso una lucida analisi lessicale dei termini Kehre ed Ereignis, egli
chiarisce le implicazioni sottese al passaggio da una dimensione analitico-esistenziale, che caratterizza il senso dell’essere in Essere e Tempo, ad una
dimensione ontologica-destinale, “in cui è l’essere stesso ad accadere”, che
contraddistingue la seconda fase del pensiero di Heidegger.
La sezione dal titolo Forum: le vie del pensare ospita due contributi di storiografia della scienza. Salvo D’Agostino (Esperimento e teoria in Heinrich
Hertz) focalizza l’attenzione sull’epistemologia di Hertz, illustrando la sua
nuova concezione della scienza, fondata sulla sintesi di teoria ed esperienza.
Ciò implica un riconoscimento della specifica autonomia assegnata alla componente teorica, dalla quale lo scienziato deve trarre linfa vitale.
Ubaldo Sanzo (Alle origini dell’École Polytechnique), attraverso la ricostruzione delle fasi che hanno caratterizzato la nascita e le trasformazioni dell’École Polytechnique, si sofferma sulle vicende politiche della Francia rivoluzionaria entro cui si colloca la storia dell’École, studiandone i metodi, gli scopi,
nonché i programmi didattici e formativi.
L’ultima sezione della rivista, intitolata Effemeridi filosofiche, comprende
una serie di recensioni e di schede.
Alla luce delle obiezioni critiche sollevate dai singoli studi confluiti nella rivista, emerge un aspetto sostanziale: i tentativi metodologici e gli sviluppi
costantemente compiuti in seno al problema filosofico della storia per liberarsi dagli schemi interpretativi, talvolta, troppo rigorosi, inflessibili e intransigenti, e dalle categorie che, sovente, condizionano in misura negativa il percorso
storico. Si configura, cosí, un quadro teorico e metodologico dominato da
istanze pluralistiche, da una dimensione dinamica, dall’esigenza di orientarsi
verso le direzioni piú diverse, di applicare non un solo metodo ma tanti metodi, al fine di superare ogni posizione teorica totalitaria e universale, ogni riduzione di prospettiva e di arricchire il giudizio storico.
Luana Rizzo
133
il gallo silvestre
rivista semestrale diretta da Antonio Prete
Finora “il gallo silvestre” ha presentato, nelle rubriche Libro d’ore
e Poiesis, testi poetici e saggistici di grande rilevanza, spesso
tradotti per la prima volta in italiano (da Stevens a Michaux, da
Pessoa a Céline, da Celan a Jabès, ecc.). Nella rubrica La stanza del poeta ha fatto conoscere il lavoro in atto –versi, riflessioni,
frammenti– dei più significativi poeti italiani contemporanei. Ha
inoltre dedicato la parte tematica degli ultimi numeri allo studio
dei rapporti che intercorrono tra scrittura letteraria e antropologia.
Il sapere della letteratura, osservato al di sopra dei confini nazionali, il linguaggio della poesia, l’esperienza della traduzione poetica, l’etnografia, continuano ad essere i campi d’attenzione e di
cura della rivista. Su queste linee di ricerca e di espolorazione “il
gallo silvestre” proseguirà il suo lavoro, coinvolgendo nella sua
attività poeti e critici appartenenti a diverse lingue e culture.
134
Nell’ultimo fascicolo (n. 16 - luglio 2003)
Libro d’ore: Friedrich Nietzsche, Arthur Rimbaud, Derek
Walcott, Juan Gonzalo Rose, Marco Martos, Yves Bonnefoy
Poiesis: Antonio Prete, Franc Ducros, Pascal Gabellone
La stanza del poeta: Franco Buffoni
Abbonamento a due numeri: t 20,00
estero t 25,00 - sostenitore t 30,00
Amministrazione: Manni Editori
Distribuzione in libreria:
Joo Distribuzione
Via F. Argelati, 35 - Milano tel: 02/8375671
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “SEGNI E COMPRENSIONE”
(oltre quelle recensite nella rivista)
Volumi:
F. A. ASTORE, Catechismo repubblicano. In sei Trattenimenti a forma di dialoghi, a c. di L. La Puma, Lacaita, Manduria 2003, pp. CXIV, 84;
A. CAROLI, La valigia del tempo, L’Autore Libri, Firenze 2003, pp. 164;
M. CARBONE, D. M. LEVIN, La carne e la voce. In dialogo tra estetica ed etica,
Mimesis, Milano 2003, pp. 132;
S. CAVACIUTI, A. DENTONE, a c. di, Il corpo e le emozioni, vol. II, Bastogi, Foggia
2003, pp. 144;
A. COLOMBO, La società amorosa. Appunti a Fourier per una revisione dell’etica amorosa e sessuale, Dedalo, Bari 2003, pp. 200;
A. DENTONE, Silenzio, pref. di P. Boero, introd. di A. Ales Bello, Bastogi, Foggia
2002, pp. 108;
I. KANT, Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di I. Kant, a c. di L. Tundo
Ferente, Rizzoli, Milano 2003, pp. 116;
M. MAZZOCUT-MIS, Animalità. Idee estetiche sull’anima degli animali, Le
Monnier, Firenze 2003, pp. 154;
E. STEIN, Potenza e Atto. Studi per una filosofia dell’essere, pref. di A. Ales
Bello, trad. di A. Caputo, Città Nuova, Roma 2003, pp. 406.
A. J. TAMBURRI, Semiotica of Re-Reading, Associated University Press,
Cranbury-London-Mississauga 2003, pp. 132;
D. VERDUCCI, Il segmento mancante. Percorsi di filosofia del lavoro, Carocci,
Roma 2003, pp. 222.
Periodici:
Aesthetica Preprint, n. 68, agosto 2003: S. TEDESCO, Le sirene del Barocco;
C.I.S.d.E., Palermo;
Annuario Filosofico, n. 17, 2001; n.18, 2002; Mursia, Milano;
Hermeneutica, n. s., 2003: Esperienza estetica e teologia; Morcelliana,
Brescia;
Idee, n. 52-53, 2003: F. Rosenzweig e il Nuovo pensiero; Milella, Lecce;
Itinerari, n. 1-2, 2003, a n. 2: I sensi della sofferenza; Ed. Itinerari, Chieti;
L’immaginazione, n. 198, n. 199, 2003; Manni, San Cesario di Lecce;
Paradigmi, n. 62, a. XXI, n. s., maggio-agosto 2003, Nuove prospettive di
ricerca sul pensiero antico; Schena, Fasano;
Studia patavina, a.L, n.2, maggio-agosto 2003; Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale, Padova.
135
Il Protagora
Rivista di filosofia e cultura
fondata nel 1959 da Bruno Widmarr,
diretta da Fabio Minazzi
Semestrale, quinta serie
Nell’ultimo fascicolo
Husserl , La teoria del significato
F. Papi, Il secondo viaggio di Antonio Banfi
G. Preti, Critica del liberalismo
e del falsificazionismo di Karl Popper
O. L. Scalfaro, La memoria storica
quale strumento di libertà
G. Pesce, Dante di Nanni gappista
Inoltre
Studi di Antiseri (Croce), G. Pinciroli (Benjamin),
Minazzi (Popper, Parmenide e l’illuminismo presocratico)
Note e interventi su Banfi,
Resistenza e filosofia a Milano;
le Università Popolari; i giovani tra i due secoli;
Giuseppe Palmieri; Dibattito sulla scuola
Abbonamento:
t 38,00 per l’Italia (studenti t 31,00),
t 54,00 per l’estero.
Un fascicolo (pp. 432) t 19,00
Amministrazione: Manni Editori
Distribuzione in libreria:
Joo Distribuzione
Via F. Argelati, 35 - Milano tel: 02/8375671