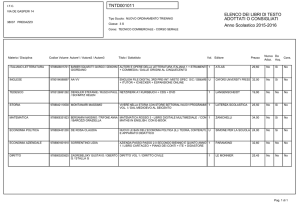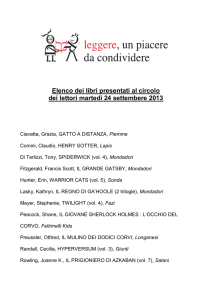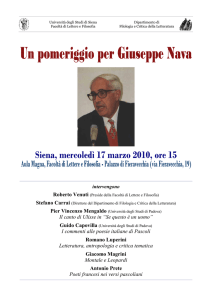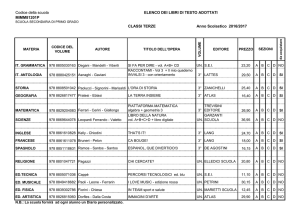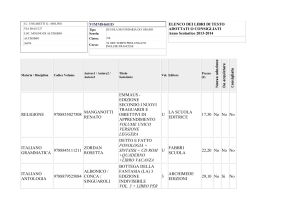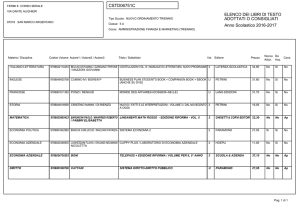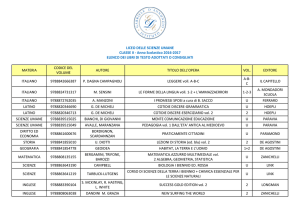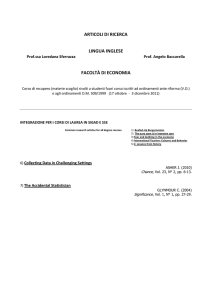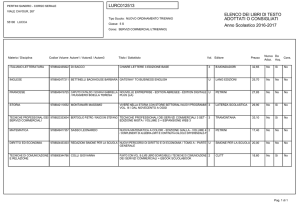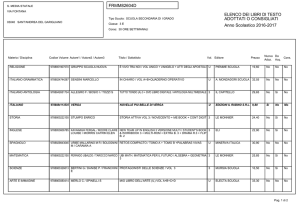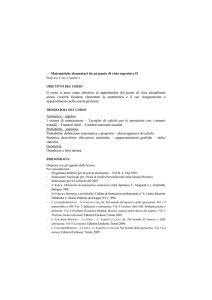Documento del 15 maggio per l’Esame di Stato - classi quinte
Liceo Statale
“ALVISE CORNARO”
Via Riccoboni, 14 - 35127 PADOVA
049 755.695 fax: 049 850.605
e.mail: [email protected]
p.e.c. [email protected]
web: www.liceocornaro.com
Codice fiscale. 80021490281
LICEO
SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
LINGUISTICO
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Regolamento, art.5)
Classe V sez. AA Liceo Scientifico - Scienze Applicate
Anno scolastico …2016/17
Coordinatore di Classe: prof.ssa LUISA FABRIS
Obiettivi espressi in conoscenze, abilità e competenze approvati dal
Collegio Docenti del Liceo Cornaro
Al termine del percorso di formazione lo studente/la studentessa:
conosce i contenuti disciplinari affrontati nell’ambito delle attività di apprendimento
(p. es.: dati, concetti, regole, metodologie);
2)
riconosce i concetti chiave nelle situazioni di apprendimento (nella comprensione e
analisi di testi e materiali sui diversi argomenti e ambiti disciplinari, nello sviluppo
degli esercizi, nella soluzione di problemi);
3)
rielabora le conoscenze attraverso l’analisi e la sintesi;
4)
applica efficacemente le conoscenze ed esercita le abilità nello svolgimento degli
esercizi;
5)
collega i contenuti in ambito disciplinare e/o pluridisciplinare;
6)
si serve di un lessico appropriato;
7)
utilizza il linguaggio specifico delle discipline;
8)
espone oralmente dando coerenza e unitarietà al discorso;
9)
espone per iscritto dando correttezza formale, coerenza e unitarietà al discorso.
1)
Conoscenze, abilità e competenze disciplinari sono definite nel Quaderno dei
Dipartimenti Disciplinari, a disposizione della Commissione.
1. Presentazione sintetica della classe:
1.1 Storia del triennio della classe
CLASSE
ISCRITTI ALLA
STESSA CLASSE
ISCRITTI DA
ALTRA CLASSE
PROMOSSI A
GIUGNO
NON AMMESSI
ALLA CLASSE
SUCCESSIVA O RITIRATI
TERZA
23
2
22
3
QUARTA
QUINTA
22
21
2
1
14
3
1. 2 Continuità didattica nel triennio
DISCIPLINE
Religione
Italiano
Informatica
Inglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Disegno e Storia
dell’arte
Educazione Fisica
DOCENTI 2014/2015
DOCENTI 2015/2016
DOCENTI 2016/2017
Simonetti Maria Brigida Simonetti Maria
Brigida
Lippi Laura
Lippi Laura
Russo Maria Rosaria
Russo Maria Rosaria
De Rosso Fabrizio
De Rosso Fabrizio
Chitarin Anna
Sardelli Maria
Antonietta
Chitarin Anna
Sardelli Maria
Antonietta
Zoppello Paolo
Pegorin Cristina
Zoppello Paolo
Pegorin Cristina
Fabris Luisa
Fabris Luisa
Zandonà Giorgio
Zandonà Giorgio
Simonetti Maria
Brigida
Lippi Laura
Bertelè Anna
De Rosso Fabrizio
Crobeddu Antioco
Cesare
Crobeddu Antioco
Cesare
Pegorin Cristina
Pegorin Cristina
Fabris Luisa
Zandonà Giorgio
Seren Renzo
Seren Renzo
Seren Renzo
1.3 Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi raggiunti
Nel corso del triennio la classe VAA, composta da 22 studenti e studentesse (16 maschi e
6 femmine), ha modificato la sua fisionomia originaria con l’inserimento di un nuovo alunno
proveniente da un altro Liceo cittadino in terza e con l’ammissione di studenti ripetenti del
quarto (2) e quinto (1) anno. Alla fine della terza due alunni non sono stati ammessi e uno
si è ritirato, mentre tra il quarto e quinto anno tre alunni si sono ritirati: due a causa di
problemi familiari e uno per frequenza all’estero.
Nell’anno scolastico in corso, ma anche nei precedenti, la classe si è distinta per il
comportamento corretto. Gli studenti sono stati generalmente rispettosi nei confronti degli
insegnanti e dei compagni di classe e, con il passare del tempo, è migliorato anche il loro
rapporto di amicizia pur nella diversità degli interessi dei singoli.
A parte qualche raro caso di irregolarità nella frequenza, peraltro sempre giustificato, gli
alunni hanno solitamente seguito le lezioni con continuità, anche se talvolta il
comportamento non è stato del tutto responsabile rispetto agli impegni scolastici.
Pur essendoci le condizioni favorevoli per lo svolgimento del lavoro scolastico, la
partecipazione alle lezioni si è rivelata spesso modesta, di conseguenza, da parte dei
docenti, la ricerca di strategie per coinvolgere gli studenti è stata piuttosto impegnativa.
L’interesse e l’impegno nello studio si sono intensificati in particolare nel corso del corrente
anno scolastico per un discreto gruppo di studenti, anche se i risultati ottenuti non sono
sempre stati adeguati all’impegno dimostrato. Infatti mentre qualcuno è riuscito ad
approfondire e rendere più efficace lo studio, ampliando il proprio sapere e la padronanza
delle competenze, altri non hanno ancora raggiunto questa autonomia, ma hanno bisogno
di essere indirizzati e guidati nei processi di apprendimento e rielaborazione delle
conoscenze.
La classe ha trovato la sua condizione migliore nell’attività di laboratorio e nei lavori di
gruppo, in particolare in Scienze, disciplina nella quale gli alunni si sono espressi al meglio
apprendendo e rispettando le regole del laboratorio, acquisendo esperienza e abilità e
facendo proprie tecniche che hanno permesso di svolgere con sicurezza, interesse e
spirito critico le attività proposte. La loro capacità di lavorare in gruppo ha consentito alla
classe di vincere il concorso indetto da La città della Speranza (Unistemday- marzo 2016)
e ha dato l’opportunità agli studenti di trascorrere “una giornata da ricercatori” dei
Laboratori di Biologia dell’Università degli Studi di Padova.
Quest’anno l’esperienza nei laboratori universitari si è ripetuta in modo pienamente
soddisfacente con il Progetto PNLS Biotecnologie.
In sintesi, anche se permangono elementi di debolezza nelle abilità espressive, sia nello
scritto che nell’esposizione orale, dall’analisi complessiva del processo di apprendimento,
il CdC rileva che gli studenti hanno acquisito abilità e competenze di base in quasi tutte le
materie con alcune differenze: un piccolo gruppo mostra una reale autonomia ed un
valido metodo di studio e di ricerca, un secondo gruppo ha raggiunto un livello di
preparazione da sufficiente a discreto, un terzo gruppo ha ancora alcune difficoltà sia
nell’applicazione che nell’organizzazione del lavoro.
A completamento del presente documento si prenda visione dell’allegato in busta chiusa.
2. Contenuti, spazi, tempi e criteri di valutazione
nell'ambito delle singole discipline: si rinvia alle schede per ogni disciplina: All. A
nell'ambito delle Aree disciplinari o comunque in ambito pluridisciplinare: si rinvia alle schede
concernenti le attività pluridisciplinari: All. B
3. Attività di potenziamento e integrazione del curricolo
(visite guidate, viaggi, conferenze, ecc., nell’ambito di progetti di potenziamento e/o integrazione
del curricolo e di percorsi di innovazione didattica)
1. Progetto PNLS BIOTECNOLOGIE in collaborazione con il Dipartimento di BIOLOGIA –
Università degli Studi di Padova
2. Progetto Carcere – Associazione Granello di Senape
3. Competenze di Cittadinanza: Lezione “Dallo statuto albertino alla costituzione” prof.ssa
Mazzei”
4. Orientamento Universitario: “EUFACTOR: scopri l’innovazione che c’è in te” promosso
dalla Commissione Europea e dall’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo
5. Conferenze nell’ambito della FIERA DELLA SCIENZA:
6. La storia della bomba atomica - prof. A.Pascolini Dipartimento di Fisica e AstronomiaUniversità degli Studi di Padova
7. Analisi del DNA contro la pirateria alimentare e I viaggi della Sindone raccontati dal Dna –
prof. G.Barcaccia – Dipartimento DAFNAE - Università degli Studi di Padova
8. Conferenza: Integrazione Europea – prof. M. MistriDipartimento di Economia
internazionale - Università di Padova
9. Percorso CLIL di Informatica
10. Corso di Primo Soccorso - Croce Rossa di Padova
11. Spettacolo teatrale “La Sfinge” su Enrico Fermi
12. Visita a Caporetto: Il Museo della Grande Guerra e Museo all’aperto (trincee).
13. Viaggio d’Istruzione a Trieste e Vienna con visita al Centro di Ricerca Elettra di Trieste e al
Campo di concentramento di Mauthausen.
4. Simulazioni di Terza Prova effettuate e criteri di valutazione adottati
(inserire: tipologia, discipline, tempi, consegne e testi delle prove effettuate)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA
GIUDIZIO
gravemente
insuff.
Insufficiente
sufficiente
discreto
buono/ottimo
ABILITÀ
Correttezza e
pertinenza dei
contenuti
Capacità di
sintesi:
individuazione e
collegamento dei
concetti
COMPETENZE
Applicazione di concetti e
procedure; capacità
espositiva e padronanza dei
linguaggi specifici
CONOSCENZE
INDICATORI
1/2
3
3,5
Conosce i
contenuti in
modo lacunoso
e non corretto
Conosce i
contenuti in modo
parziale e incerto
Conosce in
modo semplice e
schematico i
contenuti in
alcuni ambiti
disciplinari
4
Conosce i
contenuti in
modo corretto e
abbastanza
ampio nella
maggior parte
degli ambiti
disciplinari
5
Conosce i
contenuti in modo
preciso ed ampio in
tutti gli ambiti
disciplinari
1/2
3
3,5
4
5
Applica i
concetti in
modo confuso
ed espone i
contenuti in
modo
frammentario,
senza utilizzare
linguaggi
specifici
Applica i concetti
in modo
approssimato ed
espone i
contenuti in modo
confuso,
utilizzando termini
inappropriati
Applica i concetti
in modo ordinato
ed espone i
contenuti in
modo
abbastanza
corretto,
utilizzando
parzialmente i
linguaggi
specifici
Applica i concetti
in modo chiaro
ed espone i
contenuti con
ordine,
utilizzando in
modo corretto i
linguaggi
settoriali
Applica i concetti in
modo efficace ed
espone i contenuti
in modo coerente,
utilizzando con
proprietà i linguaggi
settoriali
1
Non individua i
principali
concetti chiave
o propone
collegamenti
incoerenti o
inconcludenti
2
Individua in
maniera parziale
o approssimativa
concetti e
collegamenti delle
questioni
proposte
3
Individua i
concetti chiave
essenziali, e
propone alcuni
collegamenti
fondamentali
4
Collega in un
percorso unitario
e coerente
concetti chiave
chiaramente
definiti
5
Propone una
sintesi precisa,
dettagliata e
articolata
Quesiti Simulazione della III Prova d’esame - TIPOLOGIA B
Tempo a disposizione per entrambe le prove 3 ore
12 dicembre 2016: Storia, Disegno e storia dell’Arte, Inglese, Fisica
STORIA
1- La Grande guerra: dopo aver esposto i motivi per cui l’Italia può dichiararsi neutrale
nella prima fase del conflitto, senza venir meno agli impegni assunti con il trattato della
Triplice Alleanza, descrivi quali singole personalità e gruppi costituiranno il variegato
schieramento degli interventisti e quello dei neutralisti evidenziando le rispettive posizioni.
2- Presenta le vicende storiche connesse al progetto politico di unificazione tedesca di
Guglielmo I e del cancelliere Bismarck che portarono prima al conflitto con l’Austria e in
seguito a quello con la Francia.
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
1- Illustra le caratteristiche tipicamente romantiche della Libertà che guida il popolo di
Eugéne Delacroix. (max. 12 righe)
2 – Descrivi le modalità tecnico-espressive di Giovanni Fattori attraverso la lettura della
Rotonda di Palmieri (max. 12 righe)
INGLESE
Answer the following questions in about 10 lines.
1Hemingway, Brooke and Rosenberg have different attitudes to war. Briefly tell about
them.
2What are the reasons for Eveline to stay? And what are the reasons to leave for
Buenos Aires?
3Tell about the main themes in “The Great Gatsby”, the ones that make it a novel of
the Jazz age.
FISICA
1
Definisci il campo elettrico (portando anche degli esempi). In particolare spiega
cosa sono il flusso e la circuitazione e quali proprietà godono nel caso del campo elettrico.
2
Descrivi il modello microscopico per la conduzione nei metalli. (elettroni di
conduzione, velocità di deriva, spiegazione microscopica delle leggi di Ohm)
3
Descrivi i tre esperimenti che mostrano l’esistenza di un legame tra campo
magnetico ed elettrico e per ognuno spiega la legge correlata. (campo magnetico generato
da un filo, forza su un filo, forza fra due fili)
7 aprile 2017: Filosofia, Fisica, Scienze, Inglese
FILOSOFIA
1-«Ora è chiaro che ci deve essere qualcosa di intermedio, che risulti omogeneo da un
lato con la categoria e dall’altro col fenomeno, affinché si renda possibile l’applicazione
della prima al secondo. Questa rappresentazione intermedia deve essere pura (senza
elementi empirici) e, tuttavia, per un verso intellettuale e per l’altro sensibile: essa è lo
schema trascendentale» (Kant, Critica della ragion pura, Analitica trascendentale).
Spiega cosa sono gli schemi trascendentali di cui parla il filosofo in questo brano.
2-«Così la natura è stata anche chiamata la ’caduta’ dell’idea da se stessa, in quanto
l’idea, come questa figura dell’esteriorità, si trova nell’inadeguatezza di sé a sé […]
qualsiasi rappresentazione dello spirito, anche la peggiore delle sue trovate, il giuoco dei
suoi umori più casuali … costituiscono un fondamento conoscitivo dell’essere di Dio più
alto di qualsiasi oggetto naturale singolo» (Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio, Filosofia della natura).
Per Hegel la natura è «l’idea nella forma dell’esser altro»: collegandoti al brano
sopraesposto chiarisci il significato filosofico del delicatissimo passaggio dall’idea alla
natura all’interno del suo “Sistema”.
3-«La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi
e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola
oppressori e oppressi sono sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta
ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese: una lotta che finì sempre o con una
trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta»
(Marx, Manifesto del partito comunista).
Facendo riferimento al precedente brano descrivi in che modo per Marx si realizzerà il
rovesciamento della società borghese e si instaurerà il «regno del proletariato».
FISICA
1
Tre resistenze 𝑅1 = 22Ω, 𝑅2 = 67Ω 𝑒 𝑅, sono connesse in parallelo ad una batteria
12V. La corrente totale che scorre attraverso la batteria è di 0,88A.
a)
b)
c)
d)
Calcola il valore di R.
Calcola la corrente che attraversa ogni resistenza.
Calcola la potenza dissipata in R.
Se la corrente totale nella batteria fosse stata maggiore, la resistenza R sarebbe
stata maggiore o minore? Giustifica la tua risposta.
2
Descrivi le principali proprietà delle onde elettromagnetiche e spiega come si
possono generare.
3
Una singola spira rettangolare di larghezza 20cm e lunghezza 45cm si muove come
nel disegno con una velocità v=6,8m/s
parallelamente alla sua lunghezza. La spira
attraversa ad un certo punto una regione in cui
è
presente
un
campo
magnetico
B=4,2Tperpendicolare al piano della spira.
Descrivi cosa accade nei seguenti casi
calcolando la velocità di variazione del flusso:
a) quando la spira sta entrando nella regione
in cui è presente il campo magnetico,
b) quando vi è completamente immersa,
c) quando sta uscendo.
Specifica, per ciascuna situazione, il verso
della corrente indotta se presente e giustifica
la tua risposta.
SCIENZE
1- Gli anticorpi monoclonali (MAb) derivano da un tipo di coltura cellulare molto particolare.
Dopo aver descritto come vengono prodotte e quali sono le caratteristiche delle cellule
coltivate, spiegare, con esempi, come possono essere usati i MAb.
2- Confrontare il ciclo riproduttivo del virus dell’influenza con quello dell’HIV
evidenziandone somiglianze e differenze.
3
La mappa riporta la rotta di Cristoforo Colombo nel suo primo viaggio verso le
Americhe. Spiegare scientificamente perché all’andata scelse una rotta più vicina
all’equatore mentre al ritorno una rotta più settentrionale.
INGLESE
Answer the following questions in about 10 lines.
1- Tell about guilt and innocence in “To Kill a Mockingbird”.
2- What are the main themes in “The Waste Land”? What does the poet think about
modernity?
Le prove svolte dagli studenti sono a disposizione presso la segreteria.
Padova, 11 maggio 2016…
Firma del Coordinatore
Timbro della
scuola
Firma del Dirigente
Scolastico
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Alvise Cornaro”
35127 PADOVA - Via Riccoboni, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
All. A
Relazione finale del docente: LAURA LIPPI
Disciplina Lingua e Letteratura Italiana
Classe VAA
A.S. 2016-2017
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
•
Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti.
La classe ha dimostrato un interesse abbastanza costante per la disciplina, aumentando, in
alcuni casi, rispetto all’inizio del triennio, le competenze di analisi del testo e migliorando il
metodo di studio. La maggior parte degli alunni è in grado di esprimersi nella produzione orale
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e alcuni riescono a rielaborare anche
autonomamente le conoscenze. Nella produzione scritta una parte degli studenti riesce ad
esprimersi in modo corretto, anche se a volte in maniera troppo sintetica. Solo qualche
studente/essa della classe riesce ad elaborare con originalità gli svolgimenti proposti.
•
Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Periodo dell’anno
N. di ore
impiegato
settembre
3 ore
(Testo di riferimento: vol. 2 Letteratura Letterature. Dal tardo
Cinquecento al primo Ottocento,Armellini-Colombo, Zanichelli)
Il Romanticismo Europeo e Italiano
Caratteristiche generali del Romanticismo Europeo; (pp
450-452. )
Il Romanticismo italiano: caratteristiche generali (pp. 466467);
La poesia dialettale in Italia:
Giuseppe Gioacchino Belli: “Er giorno der giudizzio”
(pp.608-609)
Giuseppe Gioacchino Belli: "Er caffettiere fisolofo"
(pp.610)
Alessandro Manzoni
Settembre/Ottobre 7 ore
La vita e le opere; (pp.722-727)
La poetica di Manzoni :
“L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante
per mezzo” da Lettera sul Romanticismo (pp.756-757).
Le tragedie (pp.727-729):
Coro dell’atto terzo da Adelchi (vol.2 pp.778-780)
Il romanzo (pp. 730-734)
La sventurata rispose (pp.742-749);
Giacomo Leopardi
La vita e le idee (pp.811-817);
Il primo ciclo dei Canti (p. 818);
La ricerca del vero (pp. 820-822)
Il ritorno alla poesia (pp. 822-825);
OttobreNovembre
16 ore
Dicembre
4 ore
Testi analizzati dell’autore:
“L’infinito” dai Canti (pp.856-858);
“A Silvia” dai Canti (pp.832-833);
“La quiete dopo la tempesta” dai Canti (pp.866869);
“Il sabato del villaggio” dai Canti (pp.869-871)
“Canto notturno di un pastore errante per l’Asia”
dai Canti (pp. 862-866);
“A se stesso” dai Canti (pp.871);
“La Ginestra o Fiore del deserto” dai Canti (pp.
872-882)
“Dialogo della Natura e di un Islandese” da Le
Operette morali (pp. 886-891).
Il Positivismo, il Naturalismo Francese e la Scapigliatura
(Testo di riferimento: vol. 3.1 Letteratura letterature. Il secondo
Ottocento, Armellini-Colombo, Zanichelli)
•
•
•
•
La scienza e l’evoluzionismo, il positivismo (pp.4-6)
La narrativa nell’età del naturalismo (pp.32-35)
La Scapigliatura in Italia (pp. 38-40);
La nascita della poesia moderna e il simbolismo
(pp.47-50)
Letture:
•
•
•
•
Gustave Flaubert: “ Le insofferenze di
Madame Bovary” da “Madame Bovary” pp.
61-63;
Emile Zola: da “Il romanzo sperimentale”
p.22;
Emile Zola: “La stireria” da “L’Assemoir”
pp.69-73;
“L’albatro” da “I fiori del male” di C.
Baudelaire (p.155);
•
“Corrispondenze” da “I fiori del male” di C.
Baudelaire (p.156);
• “Spleen” da “I fiori del male” di C. Baudelaire
(p.157)
Il Verismo Italiano e Verga
• Vita (pp.256-258);
•
Il verismo di Verga (pp.258-259);
•
I Malavoglia (pp.259-262);
•
Le novelle rusticane e Mastro Don Gesualdo
(pp.262-263)
Dicembre-gennaio
7 ore
Testi analizzati dell’autore:
•
“Nedda” (on-line);
•
“Fantasticheria”, da “Vita dei campi” (pp.282284)
•
“Rosso Malpelo”, da “Vita dei campi” (pp.296307);
•
“Cavalleria Rusticana”, da “Vita dei campi”
(pp.307);
•
“Libertà”, da “Novelle rusticane”( pp.268-273);
•
“Come le dita di una mano” da “I Malavoglia”,
(pp.319-321)
•
“Non voglio più farla questa vita”, da “I
Malavoglia”, (pp.323-328);
•
“Ora è tempo di andarsene”, da “I
Malavoglia,(pp.328-332);
•
“Mastro don Gesualdo ricorda” da “Mastro Don
Gesualdo” (pp.334-336);
•
“Morte di Mastro don Gesualdo” da “Mastro Don
Gesualdo” (pp. 341-344)
Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio
• Giovanni Pascoli: vita e opere (pp.364-367); La poesia
Febbraio-marzo
(pp.368-372);
Testi analizzati di Pascoli:
•
“L’assiuolo” da Myricae (pp.376-379);
•
“Arano” da Myricae (pp.389-390)
•
“Novembre” da Myricae (pp.pp.390-391);
•
“Lavandare” da Myricae (p. 391);
10 ore
•
•
•
“Temporale” da Myricae (p.392);
•
“X agosto” da Myricae (pp.394-395);
“Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio
(pp.407-409);
Gabriele d’Annunzio: vita (pp.424-426); un’opera
multiforme (pp.426-434); la fortuna e la critica (pp. 435438)
Testi analizzati di D’Annunzio:
• “La vita come opera d’arte” da Il piacere, libro I,
cap II (pp. 444-445);
• “La pioggia nel pineto” da Alcyone (pp.439-443);
• “La sera fiesolana” da Alcyone (pp.476-478);
(Testo di riferimento: vol. 3.2 Letteratura letterature. Il
Novecento, Armellini-Colombo, Zanichelli)
Luigi Pirandello
• La vita (pp. 264-266);
•
Le idee (pp.266-268);
•
Le opere (pp.268-270);
Aprile
4 ore
Aprile Maggio
4 ore
Testi analizzati dell’autore:
•
“Il sentimento del contrario” da L’umorismo (pp.
290-292)
•
“Un caso strano e diverso” da Il Fu Mattia
Pascal, (pp. 297-298);
•
“Lo strappo nel cielo di carta” da Il Fu Mattia
Pascal (pp.299-300);
•
“Siamo qua in cerca di un autore” da Sei
personaggi in cerca d’autore (pp.305-310)
•
“Fisso in questa eternità di maschera” da Enrico
IV (pp.310-315);
•
“La carriola” da Novelle per un anno (pp.276283);
Italo Svevo
• La vita (pp.326);
•
Le opere (pp.328-334);
•
La fortuna (pp.334-336);
•
Testi analizzati dell’autore:
•
“La prefazione del dottor S.” da La coscienza di
Zeno (p.357);
•
“Preambolo” da La coscienza di Zeno (pp.357358);
•
“Il fumo” da La coscienza di Zeno (pp. 337-342)
•
“La salute di Augusta” da La coscienza di Zeno
(pp.361-365)
•
“La vita è sempre mortale non sopporta cure” da
La coscienza di Zeno (pp.365-367)
Le avanguardie e il Futurismo (pp.48-49)
• Filippo Tommaso Marinetti “Correzione di bozze +
desideri in velocità” (pp.111-113);
2 ore
Ungaretti e la rivoluzione metrica dell’Allegria (pp.380-384)
Testi analizzati dell’autore:
• “Pellegrinaggio” (pp.389-389);
•
“Commiato” (pp. 391-392);
•
“Soldati” (on-line);
•
“San Martino del Carso” (on-line);
•
“I fiumi” (pp.397-400)
Divina Commedia: Paradiso (tramite presentazioni in
power point curate dagli studenti e lettura e commenti dei
versi.
• Canto I;
•
Canto III;
•
Canto VI;
•
Canto XI;
•
Canto XVII;
•
Canto XXXIII ;
La Prima Prova dell’esame di stato
• La tipologia B (ripasso e approfondimento);
•
Compiti in classe ed esercitazioni domestiche su tutte le
tipologie della prima prova dell’esame di stato.
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio
• Ungaretti (parte seconda);
•
Saba;
•
Montale;
Settembre-
12 ore
gennaio
Tutto l'anno
10 ore
•
Il romanzo nel dopoguerra.
Firma degli studenti rappresentanti di classe
. Metodologie didattiche:
Lezioni frontali e interattive, lettura e analisi dei testi a casa e in classe, uso della televisione per la
visione di filmati di critici letterari sui vari autori. Ricerche di approfondimento degli alunni su
argomenti e/o analisi testuali.
4. Materiali e strumenti didattici impiegati
Per l’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione: Letteratura letterature, di ArmelliniColombo, Zanichelli (volumi 2, 3.1 e 3.2)
A integrazione del testo sono utilizzati altri materiali messi a disposizione degli studenti tramite il
registro elettronico (didattica).
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Si sono svolte per il primo periodo quattro prove scritte (due secondo le tipologie previste per la
prima prova d’esame e due con domande aperte su porzioni del programma di letteratura) e
almeno una prova per l’orale (interrogazioni di tipo tradizionale) più alcune valutazioni orali
sull’esposizione di ricerche e approfondimenti. Per il secondo periodo si sono svolte fino a questa
data 3 prove scritte (due secondo le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato e una
con domande aperte su porzioni di programma) e almeno una prova orale. È programmata una
simulazione di prima prova scritta per il giorno 15 maggio (comune a tutte le classi quinte) ed
eventualmente un’ulteriore prova scritta con domande aperte sugli ultimi argomenti di letteratura
italiana.
Le griglie di valutazione per la prima prova d’esame sono quelle adottate dal dipartimento di
lettere di questo istituto.
Le prove effettuate sono a disposizione della Commissione presso la segreteria
Padova 15/05/2017
Firma della docente
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Antioco Cesare Crobeddu
Disciplina: Filosofia
Classe: 5ª AA
A.S.: 2016 2017
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE e progressi registrati rispetto alla situazione di
partenza
Ho conosciuto gli studenti della classe 5ª AA all’inizio di quest’anno scolastico. La
programmazione ha dovuto subire qualche rallentamento (riduzione delle ore settimanali a causa
di festività, conferenze, viaggio di istruzione ecc.), la frequenza alle lezioni è stata abbastanza
regolare.
Nel corso dell’anno una buona parte dei discenti ha evidenziato un adeguato interesse e un
positivo impegno verso la disciplina, anche se talvolta carente di partecipazione. Ma mentre questo
gruppo si è gradualmente differenziato per interesse, impegno e volontà collaborativa, alcuni altri
studenti hanno fatto fatica a mantenere un regolare e proficuo livello attentivo durante le lezioni e
ad organizzare un regolare e metodico studio domestico. Si sono prodotte quindi nella classe
condizioni di fragilità che hanno fatto emergere situazioni eterogenee di profitto. Ciononostante un
certo numero di alunni è cresciuto nella disponibilità al confronto dialettico e nell’attitudine a
problematizzare e rielaborare le conoscenze acquisite. Quasi tutta la classe ha raggiunto gli
obiettivi minimi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, pervenendo ad un livello di profitto
globalmente più che sufficiente e in alcuni casi tra il discreto e il buono.
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze
Conoscenza e utilizzo corretto del lessico specifico, dei concetti e delle
categorie essenziali della tradizione filosofica.
Conoscenza dei principali nodi filosofici di ogni singolo autore o corrente di
pensiero.
Dal criticismo kantiano al Neopositivismo.
Abilità
Utilizzo degli strumenti concettuali assimilati per riconoscere e impostare nuovi
problemi filosofici.
Introduzione di elementi di valutazione critica delle tematiche esaminate che
tengano conto della specificità dei problemi affrontati.
Interazione critica tra le diverse posizioni filosofiche studiate.
Affinamento della coerenza nell’esposizione, del rigore dimostrativo, della
padronanza del lessico specifico del discorso filosofico.
Competenze
Saper affrontare in modo approfondito e problematizzante la filosofia di un
autore o di una corrente filosofica.
Saper individuare affinità, similitudini e differenze nei modi con cui pensatori
differenti affrontano uno stesso problema.
Saper affrontare un testo filosofico compiendo le seguenti operazioni:
riconoscere i termini e i concetti specifici del lessico dell’autore,
individuando le idee centrali presenti nel testo;
ricostruire il percorso argomentativo dell’autore e insererire il testo letto
all’interno del suo pensiero;
saper riassumere sia in forma scritta sia orale le tesi fondamentali
presentate e saper evidenziare le eventuali questioni che si aprono ad un
contesto storico-filosofico più ampio.
Dato un problema già riconosciuto saper ricostruire autonomamente i passaggi
salienti attraverso cui questa questione si è evoluta all’interno del processo
storico.
Saper operare confronti, esprimere giudizi motivati, produrre discorsi filosofici
(in forma orale e/o scritta) utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato, con
coerenza e chiarezza argomentativa.
Competenze trasversali raggiunte
a) Imparare a imparare
Capacità di reperire, organizzare, collegare e recuperare
informazioni da fonti diverse.
b) Competenze sociali e civiche
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi e di
contribuire alla vita della comunità.
c) Spirito
di
iniziativa
e Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità.
intraprendenza
Capacità di risolvere problemi e di agire in modo flessibile e
creativo.
3. CONTENUTI DISCIPLINARI, PERIODIZZAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE
I QUADRIMESTRE
Contenuti
Il criticismo kantiano.
L’Idealismo tedesco: Fichte e Schelling.
Hegel e l’Idealismo assoluto.
La Destra e la Sinistra hegeliana.
Tempi
Settembre-ottobre
Ottobre-novembre
Dicembre-gennaio
Gennaio
II QUADRIMESTRE
Febbraio
Feuerbach: critica alla religione e umanismo.
Febbraio-marzo
La riflessione filosofica ed economico-politica di Marx.
I grandi contestatori del sistema hegeliano: Schopenhauer e Marzo-aprile
Kierkegaard.
Nietzsche: il superuomo e la trasmutazione dei valori.
La Psicoanalisi di Freud.
Il Positivismo e la filosofia di Comte. (*)
Il Neopositivismo: caratteristiche generali. (*)
Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Per le opere dei filosofi ci si è avvalsi soprattutto dei brani più significativi presenti nella sezione
antologica dei libri di testo in adozione.
Nota: gli asterischi (*) indicano contenuti la cui trattazione sarà affrontata o completata entro la fine
dell'anno scolastico.
4. METODOLOGIE ADOTTATE E STRUMENTI UTILIZZATI
a) Lezione frontale.
b) Lettura, analisi e interpretazione di testi in riferimento ai momenti e ai pensatori più significativi
della storia della filosofia, selezionando i brani principali presenti nel libro di testo, analizzati
mediante il metodo storico-teoretico.
c) Lezione dialogata e interattiva: uso metodologico del dialogo problematizzante e di una
pedagogia della domanda e della ricerca; promozione del confronto dialettico e dell’esercizio
all’ascolto attivo.
Strumenti:
Abbagnano N., Fornero G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia.
Dall’Illuminismo a Hegel (volume 2B), Paravia, Milano-Torino 2012.
Abbagnano N., Fornero G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia. Da
Schopenhauer a Freud (volume 3A), Paravia, Milano-Torino 2012.
Abbagnano N., Fornero G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia.
Dalla fenomenologia a Gadamer (volume 3B), Paravia, Milano-Torino 2012.
Brani, articoli in fotocopia tratti da opere filosofiche o riviste specialistiche; mappe concettuali,
brevi sussidi a cura dell’insegnante.
5. VALUTAZIONE E VERIFICHE
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione i seguenti parametri volti a
verificare:
– la conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina;
– il saper organizzare le coordinate storico-teoretiche relative a determinati problemi filosofici;
– il saper confrontare e contestualizzare differenti risposte filosofiche date a problemi analoghi;
– attraverso la lettura, l’analisi di testi e documenti e la ricostruzione del lavoro interpretativo, la
capacità di appropriazione critica e di rielaborazione personale dei contenuti;
– l’attitudine discorsiva e argomentativa;
– la chiarezza espositiva e l’uso appropriato del linguaggio specifico della materia;
– la capacità di sintesi;
– la capacità di giudizio.
Ai fini della valutazione sono state effettuate le seguenti forme di verifica:
a) interrogazioni orali (almeno una per quadrimestre);
b) prove scritte con domande in genere a risposta aperta e spazio prefissato (almeno una per
quadrimestre).
Nella valutazione sono state distinte, inoltre, le seguenti due modalità:
– formativa in itinere: con funzione di feedback per il recupero e l’eventuale ristrutturazione
delle procedure didattiche;
– globale: tesa a cogliere i progressi dello studente nel processo formativo durante l’anno
scolastico, tenendo conto dei fattori via via valutati in itinere.
Nel corso del secondo quadrimestre è stata effettuata una simulazione di Terza prova della
materia, divenuta oggetto di valutazione.
Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte nell’ambito dell’orario curricolare.
Padova, 15.05.2017
Il Docente
Prof. Antioco Cesare Crobeddu
PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA
Il Criticismo kantiano
1. Introduzione alla filosofia kantiana: vita e opere principali del filosofo.
2. Il periodo precritico in rapporto al Razionalismo e all’Empirismo moderno.
3. Introduzione al Criticismo: la Dissertazione del 1770.
4. La Critica della Ragion Pura: struttura dell’opera; i giudizi.
5. Estetica trascendentale:
– lo spazio e il tempo prima di Kant (Newton, Leibniz, Locke e
Hume) e nella concezione kantiana; il concetto di trascendentale;
il fondamento della matematica.
6. Analitica trascendentale:
– la “rivoluzione copernicana”; il fenomeno e il noumeno;
– l’intelletto e le categorie; la deduzione trascendentale delle
categorie: l’Io penso; lo schematismo trascendentale; l’Io
“legislatore della natura”.
7. Dialettica trascendentale: – l’uso kantiano del termine dialettica; la genesi delle idee della
ragione e la ragione come “facoltà dell’incondizionato”;
– la critica della metafisica come scienza: alla psicologia razionale,
alla cosmologia razionale (le quattro antinomie), alla teologia
razionale (le dimostrazioni dell’esistenza di Dio); l’agnosticismo
teoretico;
– l’uso regolativo delle idee.
8. La Critica della ragion pratica:– critica della “ragion pratica” e non della “ragion pura pratica”;
l’autonomia della legge morale e la libertà come condizione di
possibilità della vita morale;
– la massima, l’imperativo ipotetico e l’imperativo categorico (nella
sua triplice formulazione); la formalità della legge e il dovere;
– la teoria dei tre postulati pratici e il primato della ragion pratica.
9. La Critica del giudizio (cenni): – il rapporto tra la terza Critica e le due precedenti in riferimento al
dualismo fra mondo fenomenico della necessità e mondo
noumenico della libertà; la facoltà intermedia del giudizio e il
sentimento;
– il giudizio riflettente (giudizio estetico e giudizio teleologico).
Kant, La “rivoluzione copernicana” (vol. 2B, pp. 210-11).
Kant, L’io penso (vol. 2B, pp. 217-18).
Kant, I postulati della ragion pratica (vol. 2B, pp. 257-60).
J.G. Fichte
1. Introduzione all’Idealismo fichtiano: vita, opere principali, evoluzione del pensiero del filosofo.
La fedeltà a Kant e il superamento del Criticismo.
2. La Dottrina della scienza: – l’Io puro come principio assoluto;
– i tre principi: il momento della libertà, il momento della
necessità e il momento della sintesi;
– l’Idealismo etico e il primato della ragion pratica.
3. La seconda filosofia di Fichte (cenni) in riferimento alle opere: La missione dell’uomo e
Introduzione alla vita beata. Gli sviluppi del pensiero politico (cenni) in riferimento alle opere:
Discorsi alla nazione tedesca.
Fichte, «L’Io pone se stesso» (vol. 2, pp. 408-09).
F.W.J. Schelling
1. Introduzione alla filosofia schellinghiana: vita, opere principali e fasi evolutive del suo
pensiero.
2. Gli inizi fichtiani e il successivo distacco da Fichte con l’interpretazione della natura.
3. L’Assoluto e le vie della ricerca filosofica: la filosofia della Natura; la filosofia dell’Io o
Idealismo trascendentale: filosofia teoretica, filosofia pratica e idealismo estetico (concezione
e funzione filosofica dell’arte).
4. La Filosofia dell’identità (la critica di Hegel).
5. La fase teosofica e la “filosofia positiva”(cenni).
Schelling, L’assoluta identità di spirito e natura (vol. 2B, pp. 440-41).
Schelling, L’attività artistica come effettiva unità di spirito e natura (vol. 2B, pp. 444-45).
G.W.F. Hegel
1. Introduzione alla filosofia hegeliana: vita e opere principali del filosofo. Gli scritti teologici
giovanili (religione popolare e religione positiva), in particolare Lo spirito del Cristianesimo e il
suo destino: grecità, ebraismo e cristianesimo.
2. La critica agli illuministi, a Kant, ai Romantici, a Fichte e a Schelling. Il “cattivo infinito”.
3. “Il Vero è l’Intero”. I momenti del processo dialettico.
4. Finito e infinito. L’identità di Ragione e Realtà e la funzione della filosofia.
5. La Fenomenologia dello Spirito:
– le tappe dell’itinerario fenomenologico come “storia romanzata della coscienza”, dalla
certezza sensibile al Sapere Assoluto;
– i momenti della Coscienza e le figure dell’Autocoscienza (servo-padrone, stoicismo e
scetticismo, coscienza infelice); dalla Ragione al Sapere Assoluto.
6. Il Sistema:
– la struttura dialettica della realtà nel sistema hegeliano e le sezioni del sapere filosofico:
Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello Spirito;
– la Scienza della Logica: l’“Idea in sé”, ovvero “l’esposizione di Dio, come egli è nella sua
eterna essenza prima della creazione della natura e di uno spirito finito”;
– la dottrina dell’essere; la dottrina dell’essenza; la dottrina del concetto;
– la Filosofia della Natura e la sua necessità dialettica;
– la Filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia, psicologia);
– lo Spirito oggettivo: il diritto (proprietà, contratto, diritto contro il torto), la moralità, l’eticità e
i suoi momenti (famiglia, società civile e Stato); la Storia universale;
– lo Spirito assoluto: l’Arte, la Religione e la Filosofia.
Hegel, La Fenomenologia dello spirito (vol. 2B, pp. 495-97).
Hegel, L’eticità e i suoi tre momenti (vol. 2B, pp. 540-42).
Hegel, Il cammino dello spirito verso l’affermazione della libertà (vol. 2B, pp. 542-45).
Dopo Hegel
1. La Destra e la Sinistra hegeliana.
2. Cenni su D.F. Strauss e M. Stirner.
3. L. Feuerbach: la critica all’hegelismo; l’umanesimo materialistico; il meccanismo
dell’alienazione religiosa, l’ateismo e la critica della religione.
Feuerbach, Cristianesimo e alienazione religiosa (vol. 2B, pp. 86-87).
K. Marx
1. Introduzione al pensiero marxiano: vita e opere principali del filosofo.
2. La critica alla filosofia hegeliana. La critica a Feuerbach e il concetto di “ideologia”.
3. I Manoscritti economico-filosofici del ’44: la critica degli economisti classici, la critica
dell’alienazione economica, la dialettica, il comunismo. Il concetto di alienazione in Hegel,
Feuerbach e Marx a confronto. Marx e il socialismo: la polemica con Proudhon e con il
socialismo utopistico.
4. Struttura materiale e sovrastruttura ideologica; la concezione materialistica della storia;
materialismo storico e materialismo dialettico.
5. Il Capitale: valore d’uso e valore di scambio delle merci; la teoria del valore-lavoro; il
pluslavoro e il plusvalore; l’accumulazione originaria; i punti deboli del sistema capitalistico;
la caduta tendenziale del saggio di profitto; la crisi e il crollo del capitalismo.
6. L’eliminazione della proprietà privata, dell’alienazione, della contraddizione: il comunismo
come punto d’approdo della dialettica marxiana.
Marx, Struttura e sovrastruttura (vol. 3B, pp. 139-41).
Marx, La rivoluzione comunista; Il capitale (vol. 3B, pp. 142-44; 144-47).
A. Schopenhauer
1. Introduzione al pensiero del filosofo: vita e opere principali. L’interpretazione fenomenistica
del pensiero di Kant (critica al materialismo, al realismo e all’idealismo).
2. Il mondo come volontà e rappresentazione: caratteri principali del mondo come
rappresentazione, ovvero la prospettiva della scienza; le quattro forme di necessità del
principio di ragion sufficiente che strutturano la rappresentazione.
Il mondo come volontà: la prospettiva della filosofia; il corpo come volontà resa visibile e via di
accesso al mondo come Wille zum leben; caratteri fondamentali e gradi di oggettivazione
della volontà.
3. L’analisi pessimistica della vita umana e la liberazione dal dolore. L’illusione dell’amore.
4. Le tappe della redenzione: l’arte, l’etica (la giustizia; la condanna del suicidio), la bontà (la
com-passione), l’ascesi e la noluntas. L’esito orientalistico del pessimismo di Schopenhauer.
Schopenhauer, Il mondo come volontà (vol. 3A, pp. 34-35).
Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia; l’ascesi (vol. 3A, pp. 35-38).
S.A. Kierkegaard
1. Introduzione al pensiero kierkegaardiano: vita e opere principali. La Kierkegaardrenaissance e l’anticipazione dell’esistenzialismo. La polemica contro l’hegelismo e
l’irriducibilità dell’individuo alla logica.
2. La centralità della categoria dell’esistenza finita del singolo; l’esistenza come possibilità.
3. Aut-Aut: lo stadio estetico e lo stadio etico.
4. Il concetto dell’angoscia e La malattia mortale: angoscia e disperazione come condizioni
ineludibili dell’esistenza umana. Il concetto di etica a confronto in Schopenhauer e in
Kierkegaard.
5. La vita religiosa: la figura di Giobbe e di Abramo; l’irriducibilità tra vita etica e vita religiosa. Il
paradosso e lo scandalo della fede nei confronti della ragione, unico approdo di salvezza per
l’uomo.
Kierkegaard, L’autentica natura della vita estetica (vol. 3B, pp. 59-61).
Kierkegaard, Lo scandalo del cristianesimo (vol. 3B, pp. 63-65).
F.W. Nietzsche
1. Introduzione al pensiero di Nietzsche: vita e opere principali. Interpretazioni della filosofia
nietzschiana: il processo di “nazificazione” e quello di “denazificazione”; fasi o periodi del suo
filosofare.
2. La fase giovanile: La nascita della tragedia; l’elemento “dionisiaco” e l’elemento “apollineo”; le
origini della decadenza della civiltà occidentale. Considerazioni inattuali: la polemica contro
lo storicismo (storia monumentale, antiquaria e critica).
3. Il periodo “illuministico”: la scienza come metodo critico storico e genealogico. La minaccia
del divenire e la critica al rimedio metafisico costruito dalla cultura occidentale.
4. La fase di Zarathustra e le sue dottrine cardine:
– la teoria della “morte di Dio”;
– la teoria del “superuomo” (Übermensch);
– la teoria della “volontà di potenza” (confronto con la “volontà” di Schopenhauer);
– la teoria dell’“eterno ritorno” (amor fati) e le differenti interpretazioni.
5. La critica della morale:
– la Genealogia della morale e il crepuscolo degli idoli etico-religiosi;
– la “morale dei signori” e la “morale degli schiavi”;
– al di là del bene e del male.
6. Il nichilismo, le sue forme e il suo superamento. Il prospettivismo.
Nietzsche, Apollineo e dionisiaco (vol. 3A, pp. 407-08).
Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra (vol. 3A, pp. 431-32).
Nietzsche, Da “Al di là del bene e del male” (vol. 3A, pp. 432-35).
S. Freud
1. La rivoluzione psicanalitica di Freud: vita e opere principali. Dalla pratica alla teoria, dagli
studi sull’isteria alla scoperta dell’inconscio.
2. La struttura descrittiva della psiche nella prima topica. La struttura esplicativa della psiche
nella seconda topica: l’Es, l’Io, il Super-io.
3. L’interpretazione dei sogni; principali modalità del lavoro onirico: lo “spostamento”, la
“condensazione”, la “simbolizzazione”, la “dispersione”. La teoria della psicopatologia della
vita quotidiana (lapsus e atti mancati).
4. La teoria della sessualità; le fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino. Il complesso di
Edipo.
5. La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio della civiltà”. Il meccanismo della sublimazione.
Freud, L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo (vol. 3A, pp. 482-83).
Freud, Lettura analitica di un atto mancato (vol. 3A, pp. 483-85).
Il Positivismo
1. Contesto storico, caratteristiche generali e assunti teorici fondamentali.
2. Il rapporto tra Positivismo e Illuminismo, Positivismo e Romanticismo. Il Positivismo nella
cultura moderna. Cenni sul Positivismo evoluzionistico.
3.A. Comte:
– vita e opere del fondatore del Positivismo. L’analisi comtiana della crisi
culturale, politica e morale del suo tempo;
– La legge dei tre stadi; la dottrina della scienza, ossia il metodo positivo; la
classificazione delle scienze; la sociologia: la statica sociale e la dinamica
sociale.
– L’ultima fase della filosofia comtiana: la divinizzazione della storia dell’uomo
e la religione del Positivismo.
– La concezione della storia in Hegel, Marx e Nietzsche a confronto.
Comte, Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi (vol. 3A, pp. 184-85).
Il Neopositivismo
1. Contesto storico-culturale: il Circolo di Vienna e il suo manifesto programmatico: La
concezione scientifica del mondo.
2. Le dottrine caratteristiche e gli assunti teorici fondamentali.
Firma degli studenti rappresentanti di classe
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Antioco Cesare Crobeddu
Disciplina: Storia
Classe: 5ª AA
A.S.: 2016 2017
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE e progressi registrati rispetto alla situazione di
partenza
Fin dal primo periodo del corrente anno scolastico gran parte degli studenti ha manifestato un
positivo interesse verso la disciplina e, in relazione al livello di partenza, impegnandosi con
costanza, ha raggiunto una discreta autonomia nell’organizzazione delle conoscenze e rafforzato
le capacità espositive e di collegamento causale dei fatti storici. Un altro ristretto gruppo di
studenti, invece, ha avuto un impegno scolastico e in particolare un’organizzazione dello studio a
casa discontinuo, debole o superficiale.
La programmazione disciplinare ha subito qualche rallentamento, come per filosofia, per il venir
meno di diverse ore lezione a causa di motivazioni varie.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati, comunque, quasi tutti gli
studenti sono pervenuti a risultati complessivamente accettabili e in alcuni casi buoni.
2. OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze Conoscere termini, parole-chiave e concetti propri del linguaggio storiografico
(p.e. crisi, progresso, continuità, struttura, trasformazione, rivoluzione,
transizione, imperialismo, totalitarismo ...).
Ricostruire un percorso interpretativo, per grandi tagli tematici, che riassuma il
percorso di evoluzione storica compreso tra la metà dell’Ottocento e la seconda
metà del Novecento.
Saper usare termini e concetti in rapporto agli specifici contesti storici (politicoAbilità
diplomatico, socio-economico, culturale ...).
Saper superare il livello descrittivo informativo della conoscenza storica per il
conseguimento di una maggiore coscienza della complessità degli avvenimenti
in cui agiscono la responsabilità e libertà umane.
Saper utilizzare modelli interpretativi diversi, per leggere ed analizzare uno
stesso percorso storico.
Saper penetrare nello spessore della realtà storica, cogliendo i problemi del
divenire umano nel suo dispiegarsi.
Competenze Saper acquisire un sempre più approfondito concetto di periodizzazione, con il
potenziamento del senso cronologico dei fatti analizzati, in forma diacronica e
sincronica.
Saper esporre in forma chiara e coerente le conoscenze storiche esaminate e
saper sviluppare un’argomentazione valutativa nei confronti dei processi storici.
Saper utilizzare modelli appropriati per inquadrare, confrontare, periodizzare
fenomeni di scala temporale e spaziale diversa.
Saper “leggere” una fonte o un testo storiografico:
riconoscendo se si tratti di una fonte diretta o indiretta;
riconoscendo le parole chiave e individuando le idee centrali presentate;
ricostruendo il percorso argomentativo dell’autore e sapendo riconoscere sia
in forma scritta che orale le tesi fondamentali presentate;
evidenziando le eventuali questioni che si aprono ad un contesto più ampio.
Competenze trasversali raggiunte
d) Imparare a imparare
Capacità di reperire, organizzare, collegare e recuperare
informazioni da fonti diverse.
e) Competenze sociali e civiche
Capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi e di
contribuire alla vita della comunità.
f) Spirito
di
iniziativa
e Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità.
intraprendenza
Capacità di risolvere problemi e di agire in modo flessibile e
creativo
3. CONTENUTI DISCIPLINARI, PERIODIZZAZIONE E TEMPI DI REALIZZAZIONE
I QUADRIMESTRE
Contenuti
L’Europa delle grandi potenze (1850-1890).
Idea di nazione e nazionalismo. Colonialismo e imperialismo.
Industrializzazione e società di massa.
L’organizzazione del movimento operaio.
La nuova espansione economica (1895-1914).
L’Italia liberale nell’età della Sinistra.
La crisi di fine secolo.
L’Europa tra due secoli.
L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra.
L’Italia giolittiana.
La prima guerra mondiale.
L’eredità della grande guerra.
II QUADRIMESTRE
Il nuovo scenario mondiale dopo la Grande guerra.
La rivoluzione russa e la costruzione dell’Unione Sovietica.
Lo stalinismo.
Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso.
Economia e società tra gli anni Venti e gli anni Trenta.
La grande crisi.
L’età dei totalitarismi: il dopoguerra in Italia, l’avvento di Mussolini e la
costruzione dello Stato fascista.
L’ascesa al potere di Hitler e la costruzione dello Stato nazista.
L’Italia fascista.
La guerra di Spagna.
La seconda guerra mondiale.
La Resistenza.
L’Italia dopo la caduta del fascismo.
L’Italia repubblicana.
Dal miracolo economico agli “Anni di piombo”.
Il mondo diviso. (*)
Tempi
Settembre
Settembre-ottobre
Ottobre
Ottobre-novembre
Novembre-dicembre
Gennaio-febbraio
Febbraio
Febbraio-marzo
Marzo
Aprile-maggio
Maggio
Maggio-giugno
Per la lettura di fonti e di testi storiografici ci si è avvalsi prevalentemente dei documenti più
significativi presenti nella sezione antologica dei libri di testo in adozione nella classe.
Uscita didattica a Caporetto:
– visita guidata al Museo della Grande guerra e all’Ossario italiano;
– camminata su una linea di fronte con trincee.
Conferenza sul tema: “L’integrazione europea. il passato, il presente e il futuro” (prof. M. Mistri).
Nota: gli asterischi (*) indicano contenuti la cui trattazione sarà affrontata o completata entro la fine
dell'anno scolastico.
4. METODOLOGIE ADOTTATE E STRUMENTI UTILIZZATI
Per i fenomeni storici considerati fondamentali, l’itinerario si è articolato nei seguenti punti:
lezione frontale o dialogata; discussione guidata; lavori di gruppo;
studio essenziale degli avvenimenti secondo la traccia del libro di testo, previa esposizione
del racconto storico con procedimento narrativo;
incontro con i documenti, cioè con le fonti e i percorsi della storiografia per saggiare possibili
soluzioni ai quesiti avanzati in fase esplicativa o per meglio evidenziare cause e matrici
originarie degli avvenimenti oggetto di studio.
Strumenti e materiali didattici:
Manzoni M., Occhipinti F., Storia Scenari Documenti Metodi. Dalla seconda metà del
Seicento all’Ottocento (vol. 2), Einaudi Scuola, Milano 2012.
Manzoni M., Occhipinti F., Storia Scenari Documenti Metodi. Il Novecento e la storia
contemporanea (vol. 3), Einaudi Scuola, Milano 2012.
Cartografia storica e geografica presente nei libri di testo utilizzati.
Articoli, brani o altro materiale in fotocopia tratto da opere, riviste specialistiche, stampa
quotidiana o periodica; brevi sussidi a cura dell’insegnante.
Materiale audiovisivo e multimediale.
5. VALUTAZIONE E VERIFICHE
Per quanto riguarda le procedure di valutazione, si è tenuto in particolare conto:
della capacità espositiva;
della coerenza;
della capacità di collegamento;
della proprietà di linguaggio;
della capacità critica.
Le verifiche sono state finalizzate ad accertare il possesso conoscitivo, espresso con corretta
terminologia, degli eventi e dei fenomeni storici attraverso la capacità di penetrazione nello
spessore della realtà storica, cogliendo i problemi del divenire umano nel loro dispiegarsi.
Ai fini della valutazione sono state effettuate le seguenti forme di verifica:
c) interrogazioni orali;
d) prove scritte con domande a risposta aperta e spazio prefissato.
Nella valutazione sono state distinte, inoltre, le seguenti due modalità:
– formativa in itinere: con funzione di feedback per il recupero e l’eventuale ristrutturazione
delle procedure didattiche;
– globale: tesa a cogliere i progressi dello studente nel processo formativo durante l’anno
scolastico, tenendo conto dei fattori via via valutati in itinere.
Nel corso del secondo quadrimestre è stata effettuata una simulazione di Terza prova della
materia, divenuta oggetto di valutazione.
Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte nell’ambito dell’orario curricolare.
Padova, 15.05.2017
Il Docente
Prof. Antioco Cesare Crobeddu
PROGRAMMA SVOLTO di STORIA
L’Europa delle grandi potenze (1850-1890)
1. Il difficile equilibrio europeo dopo la costituzione dell’Impero tedesco nel 1871. Il trionfo della
politica di potenza (“Machtpolitik”). La diplomazia e il sistema bismarckiano delle alleanze. Il
disegno di una grande area economico-politica tedesca nell’Europa Centrale. Il congresso di
Berlino (1878). La Triplice alleanza.
2. La politica interna di Bismarck nei confronti dei movimenti politici di massa, i cattolici (il
Kulturkampf) e i socialisti. Il “Nuovo corso” di Guglielmo II: dalla Realpolitik alla Weltpolitik,
pangermanesimo e nazional-imperialismo tedesco.
3. L’Europa tra democrazia e autoritarismo. Il nuovo nazionalismo, le istanze conservatrici e le
teorie razziste; l’antisemitismo e l’antigiudaismo (i Protocolli dei Savi anziani di Sion); il
sionismo (cenni).
4. La Francia del II Impero e la guerra contro la Prussia. La Terza Repubblica; la Comune di
Parigi; la destra nazionalista e la sinistra repubblicana. L’Affaire Dreyfus.
Imperialismo, colonialismo e società di massa
1. L’età dell’imperialismo. L’ampliamento degli imperi coloniali in Africa e in Asia nella seconda
metà dell’Ottocento. Gli interessi economici e le motivazioni politico-ideologiche.
2. Stati Uniti e Giappone: due nuove potenze mondiali.
3. 1900-14: un nuovo ciclo di espansione economica. La razionalizzazione produttiva nel sistema
di fabbrica: il “taylorismo” e il “fordismo”. I nuovi ceti medi. Caratteri fondamentali della Belle
époque.
4. La graduale crisi dello Stato liberale. La società di massa: la produzione in serie e i consumi di
massa, l’istruzione pubblica, i partiti di massa, gli eserciti di massa, i primi movimenti di
emancipazione femminile.
5. La nazionalizzazione del movimento operaio. L’organizzazione del movimento operaio in
Europa e la nascita dei partiti socialisti. La Seconda Internazionale socialista. Le origini del
pensiero sociale della Chiesa: la “Rerum Novarum” di Leone XIII.
Taylor F.W., Per un lavoro scientificamente organizzato (vol. 3, p. 28-29).
Leone XIII, Dalla Rerum Novarum (vol. 2, pp. 470-71).
L’Italia nell’età della Sinistra
1. La caduta della Destra storica e la Sinistra storica al potere: il primo governo Depretis. Il
programma di governo della Sinistra e i limiti delle sue realizzazioni. La politica del
“trasformismo”.
2. La crisi agraria e lo sviluppo industriale. La svolta protezionista di Depretis e i convergenti
interessi del “blocco agrario-industriale”. Le conseguenze sull’economia: l’accentuazione dello
squilibrio tra Nord e Sud.
3. La svolta nella politica estera italiana: la Triplice Alleanza; l’inizio dell’espansione coloniale con
il governo Depretis fino all’eccidio di Dogali.
Depretis A., La strategia del trasformismo (discorso dell’8.10.1982; vol. 2, p. 581).
L’Italia crispina e la svolta giolittiana
1. Crispi al governo: la concezione dello Stato e le funzioni della monarchia. Il movimento operaio
e le organizzazioni cattoliche.
2. Le misure del governo Crispi nei confronti delle agitazioni del movimento operaio e del Partito
socialista italiano. La guerra commerciale con la Francia.
3. La politica coloniale di espansione in Africa. Il Trattato di Uccialli.
4. Il primo ministero Giolitti: caratteri fondamentali. Lo scandalo della Banca romana.
5. La ripresa crispina della politica coloniale in Africa e la sconfitta di Adua.
6. La crisi di fine secolo: la proposta di Sonnino con l’articolo Torniamo allo Statuto. Il governo
Rudinì. I tumulti a Milano, la repressione di Bava-Beccaris.
7. Le “leggi eccezionali” di Pelloux, la reazione del Parlamento e della Corte costituzionale.
L’età giolittiana
5. Il governo Zanardelli-Giolitti dopo l’uccisione di Umberto I. La svolta liberal-democratica: il
sistema di potere giolittiano. I compiti dello Stato liberale, l’atteggiamento nei confronti dei
conflitti di classe, le iniziative di legislazione sociale.
6. Il decollo industriale, il progresso civile. Il dualismo economico: la questione meridionale.
7. Le riforme sociali e politiche attuate nel quarto ministero.
8. Gli indirizzi della politica estera: la guerra di Libia. Il movimento nazionalista italiano.
9. Socialisti e cattolici nell’età giolittiana. Il “Patto Gentiloni” e le sue conseguenze politiche.
Giolitti G., La funzione pacificatrice de governo, al di sopra delle parti (vol. 3, pp. 89-90).
Corradini E., Il nazionalismo, per la grandezza della nazione italiana (vol. 3, pp. 86-87).
La prima guerra mondiale
6. Verso la prima guerra mondiale: la prima e la seconda crisi marocchina. La prima e la seconda
guerra balcanica.
7. Le differenti premesse e cause che portarono allo scoppio della prima guerra mondiale. Cultura
e politica del nazionalismo in Europa.
8. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di
posizione e d’usura. La neutralità dell’Italia. Il fronte degli interventisti e quello dei neutralisti
(l’opposizione alla guerra).
9. L’Italia con le potenze dell’Intesa: la firma del Patto di Londra. I differenti fronti di guerra e la
nuova tecnologia militare. La vita nelle trincee e le carneficine sui diversi fronti nel 1915-‘16.;
La mobilitazione totale della società e il fronte interno.
10. Il pacifismo internazionalista (cenni sui congressi di Zimmerwald e di Kienthal). Gli appelli alla
pace di Wilson e di Benedetto XV. Il genocidio del popolo armeno in Turchia (cenni).
11. Dalla guerra europea alla guerra mondiale: la svolta del 1917. La rivoluzione in Russia e
l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. Le conseguenze militari e politiche di Caporetto.
12. L’ultimo anno di guerra. I Quattordici punti di Wilson. La pace di Brest-Litovsk. Le operazioni
militari sul fronte occidentale nel 1918 e il crollo della Germania. La crisi dell’Impero austroungarico e la vittoria dell’Italia.
13. La nuova carta d’Europa con i Trattati di pace di Parigi. I nuovi equilibri politici del mondo nel
dopoguerra. La nascita della Società delle Nazioni e le sue contraddizioni.
Audoin-Rouzeau S., Becker A., La totale disumanizzazione dello scontro (vol. 3, pp. 137-39).
Selezione di brani da: Lussu E., Un anno sull’altipiano; Remarque E.M., Niente di nuovo sul
fronte occidentale.
Wilson T.W., I Quattordici punti di Wilson (vol. 3, pp. 148-49).
La rivoluzione d’ottobre e la costruzione dell’Unione Sovietica
1. La Russia tra industrializzazione e autocrazia. La rivoluzione russa del 1905. I gruppi di
opposizione allo zar. La “domenica di sangue”. La nascita dei “soviet” e la Duma.
2. Dalla rivoluzione di febbraio al tentativo di colpo di Stato di Korniliov. Le Tesi di aprile. La
rivoluzione d’ottobre. I primi deliberati del Congresso panrusso dei soviet.
3. La chiusura dell’Assemblea costituente e la dittatura del partito unico. L’estinzione dello Stato
nella società comunista. L’uscita della Russia dalla guerra.
4. Il ruolo del Partito comunista nella costruzione dell’Unione Sovietica. La guerra civile, le forze
controrivoluzionarie interne ed esterne. Dal “comunismo di guerra” alla Nep.
5. La nascita della Terza internazionale. Da Lenin a Stalin. La contrapposizione fra «rivoluzione
permanente» e «rivoluzione in un solo Paese». La società sovietica e la dittatura stalinista. La
“collettivizzazione delle campagne” e l’industrializzazione forzata imposta da Stalin (i piani
quinquennali). Il sistema dei gulag.
Lenin N., Le tesi di aprile, tutto il potere ai lavoratori (vol. 3, pp. 175-76).
Bucharin N., «Contadini arricchitevi!» (vol. 3, pp. 181-82).
L’eredità della grande guerra
1. Il dopoguerra: un nuovo scenario mondiale dopo i trattati di pace di Parigi. Le trasformazioni
sociali e le conseguenze economiche. Le lotte operaie nel periodo del “biennio rosso”.
Rivoluzione, controrivoluzione e regimi autoritari in Europa.
2. L’Europa dei vincitori: Francia e Inghilterra; l’autonomia dell’Irlanda. L’Europa degli sconfitti:
Austria e Germania. La Repubblica di Weimar. La crisi della Rhur e la grande inflazione. Il
Piano Dawes e il Piano Young. Gli accordi di Locarno.
3. La nascita del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi di Hitler e il putsch di Monaco.
La costituzione delle formazioni paramilitari delle SA e delle SS.
4. La crisi degli imperi coloniali (il “risveglio dei popoli”) in Medio Oriente e in Asia: rivoluzione
kemalista e nascita della Repubblica di Turchia; la penetrazione ebraica in Palestina: la
formazione del futuro Stato di Israele.
5. Imperialismo e nazionalismo in Asia. Giappone: sviluppo industriale e imperialismo. India: il
movimento nazionalista; disobbedienza civile e lotta per l’indipendenza. Cina: la nascita della
Repubblica; nazionalisti e comunisti; la lunga marcia; la lotta contro l’invasore giapponese; la
nascita della Repubblica popolare cinese.
Il dopoguerra in Italia: dallo Stato liberale all’avvento del fascismo
1. L’Italia nel 1919 e i problemi del primo dopoguerra. La conferenza di Parigi. La “vittoria
mutilata” e l’impresa di Fiume. La nascita dei Fasci di combattimento. Il partito cattolico e
quello socialista. La debolezza dei governi.
2. Il biennio rosso italiano: le agitazioni sociali, l’occupazione delle terre e delle fabbriche. La
nascita del Partito comunista d’Italia. Il fascismo agrario e lo squadrismo.
3. La fine del compromesso giolittiano, le elezioni del ‘21 e la nascita del Partito nazionale
fascista. La crisi dello Stato liberale e la marcia su Roma: i primo governo Mussolini. La
costruzione del regime: provvedimenti politici ed economici, organizzazione del consenso,
apertura al mondo cattolico.
4. Le elezioni del ‘24, il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino”; il discorso di Mussolini del
3 gennaio ‘25. Le “leggi fascistissime”, il partito unico, la costruzione dello Stato corporativo
fascista, un totalitarismo imperfetto. La fascistizzazione del Paese: l’organizzazione della
società, in particolare del mondo giovanile. La ricerca del consenso: la propaganda e il
controllo dei mass-media, della scuola, della cultura. I Patti Lateranensi.
5. La politica economica e la politica sociale: il protezionismo, l’autarchia, il corporativismo, la
stabilizzazione monetaria (“quota novanta”), il programma di bonifiche e di lavori pubblici, la
“battaglia del grano”, la “battaglia demografica”. L’opposizione antifascista e l’apparato
repressivo. L’introduzione delle leggi razziali.
6. Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-imprenditore”. La creazione dell’IMI e dell’IRI.
7. La politica estera e l’imperialismo fascista: l’aggressione all’Etiopia; l’Asse Roma-Berlino e il
Patto Antikomintern. L’occupazione dell’Albania. Il Patto d’acciaio. Apogeo e declino del regime
fascista.
Dal Programma dei Fasci di combattimento, 1919 (vol. 3, pp. 255-56); Lussu E., Mussolini
alla Camera: il discorso del “bivacco” (vol. 3, pp. 359-60)
Cannistraro P.V., La propaganda fascista (vol. 3, pp. 341-42); Le leggi razziali (vol. 3, pp.
345-47).
Tranfaglia N., Il mito di Mussolini (vol. 3, pp. 351-52).
La «grande crisi»: economia e società negli anni Trenta
1. Gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti negli “anni folli” prima della crisi; lo sviluppo economico, la
società dei consumi, i nuovi strumenti di comunicazione di massa. Gli anni dell’intolleranza e
della xenofobia; il caso di Sacco e Vanzetti.
2. La «grande crisi» (1929-1933): le cause strutturali, la causa scatenante e la sua rapida
diffusione. Effetti e le conseguenze della crisi in Europa.
3. Le risposte del presidente Hoover. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello Stato: dal
libero mercato all’intervento dello Stato nell’economia.
4. Gli effetti della crisi in Germania e in Europa.
L’età dei totalitarismi: l’Europa e il mondo fra le due guerre
1. La Repubblica di Weimar di fronte alla crisi economica e all’instabilità politica: l’ascesa al
potere di Hitler. La costruzione dello Stato totalitario nazista. Analogie tra fascismo e nazismo.
Il controllo sulla società tra repressione e ricerca del consenso; l’uso della propaganda. Politica
economica, politica estera e spinta verso la guerra.
2. La politica culturale, il mito della razza e l’antisemitismo di Stato. La notte dei cristalli. I lager
modello estremo del totalitarismo tedesco: campi di concentramento, di lavoro e di sterminio.
3. Il contagio autoritario fascista in Europa e fuori dall’Europa (Giappone).
4. La diffidenza delle democrazie europee verso l’URSS e la politica dell’appeasement. La crisi
della sicurezza collettiva e la nascita dei fronti popolari: il Fronte popolare francese.
5. La Spagna: dalla monarchia alla Repubblica. Il Fronte popolare spagnolo. La guerra civile e
l’ascesa politica del “generalissimo” Francisco Franco. Salazar in Portogallo (cenni).
6. L’Europa verso la catastrofe: l’espansionismo hitleriano e la teoria dello spazio vitale.
Hitler A., I principi del nazionalsocialismo; dalle Leggi di Norimberga (vol. 3, pp. 356-57; 36465).
Mosse G.L., La politica antiebraica della Germania nazista (vol. 3, pp. 362-64).
La seconda guerra mondiale
1. Le origini e le responsabilità. Il Patto di non aggressione Molotov-Ribbentrop. La Blitzkrieg di
invasione e spartizione della Polonia. La “non belligeranza” dell’Italia. L’avanzata sovietica
nell’area baltica. L’attacco tedesco a Danimarca, Norvegia e Francia. La battaglia d’Inghilterra,
guerra aerea e guerra marina.
2. L’Italia in guerra: l’intervento sul fronte alpino contro la Francia. Il fallimentare progetto di una
“guerra parallela”: i Balcani, il Nord Africa e il Mediterraneo. La progressiva incrinatura del
consenso interno al fascismo.
3. L’attacco all’Unione Sovietica: l’Operazione Barbarossa. La Carta atlantica. L’aggressione
giapponese a Pearl Harbor e il coinvolgimento degli Stati Uniti.
4. Il “nuovo ordine” nei Paesi occupati: il collaborazionismo e la resistenza. La tragedia dei popoli
slavi. Il problema ebraico: le fasi progressive della persecuzione, l’emigrazione forzata, il
programma d’annientamento (“soluzione finale”) degli ebrei europei: la Shoah.
5. La svolta nel conflitto nel 1942-‘43: la “grande alleanza” e le prime sconfitte dell’Asse: la
controffensiva americana sul Pacifico, la battaglia di Stalingrado, la controffensiva angloamericana nel Nord Africa, la guerra nel Mediterraneo e nell’Atlantico.
6. Lo sbarco in Sicilia e l’invasione alleata della penisola. Il colpo di Stato di Vittorio Emanuele III:
il crollo del regime fascista. L’armistizio dell’8 settembre. L’Italia divisa: il Regno del Sud e la
Repubblica di Salò. La nascita del CLN e la lotta politica nell’Italia divisa. Togliatti e la “svolta di
Salerno”. Il complesso fenomeno della Resistenza in Italia e in Europa. Le tre guerre di C.
Pavone. Le stragi naziste in Italia e l’insurrezione partigiana.
7. Le vittorie sovietiche e lo sbarco degli alleati in Normandia (operazione Overlord). La
liberazione della Francia. La Germania invasa: la fine del Terzo Reich e della guerra in Europa.
Le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e la resa del Giappone.
8. Le conferenze di Casablanca, Teheran, Yalta, Potsdam e la divisione del mondo secondo
“sfere d’influenza”.
Mussolini B., Un’ora segnata dal destino (vol. 3, pp. 429-30).
Pavone C., La resistenza come guerra civile (vol. 3, pp. 448-50).
Oliva G., La violenza in Italia alla fine della guerra (vol. 3, pp. 450-52).
Hachiya M., Hiroshima, il deserto dopo la bomba (testimonianza, vol. 3, pp. 456-57).
L’Italia repubblicana
1. L’Italia dopo il fascismo: un paese sconfitto. Le forze in campo: il sistema dei Partiti. Dalla
liberazione al referendum istituzionale e alla proclamazione della Repubblica. La crisi dell’unità
antifascista. La Costituzione repubblicana.
2. Le elezioni del 1948 e la sconfitta delle sinistre. L’inizio dell’egemonia della Democrazia
Cristiana. Gli anni del centrismo: la prima legislatura. La ricostruzione economica.
3. L’approvazione del Trattato di pace di Parigi e le scelte internazionali. I problemi sul confine
orientale e la questione di Trieste. Il contrasto fra italiani e slavi.
4. Alla ricerca di nuovi equilibri politici: la seconda legislatura.
Lanaro S., La continuità tra l’Italia fascista e l’Italia repubblicana (vol. 3, pp. 760-62).
Dal miracolo economico agli anni ‘80
1. Il “miracolo economico” italiano. Le trasformazioni sociali.
2. Il governo Tambroni e gli anni del centro-sinistra: programma e riforme.
3. I movimenti di contestazione del ’68 e l’“autunno caldo”. I gruppi extraparlamentari.
4. La crisi del centro-sinistra. Il terrorismo nero e il terrorismo rosso. Il compromesso storico. Il
sequestro Moro e i governi di “solidarietà nazionale”.
5. Politica, economia e società negli anni ’70. Le difficoltà del sistema politico, la crisi economica
e le trasformazioni sociali.
Ginsborg P., Il sistema di potere della Dc (vol. 3, pp. 767-69).
La «guerra fredda»: la divisione del mondo in blocchi contrapposti
1. Le conseguenze della seconda guerra mondiale: il nuovo ordine politico-economico mondiale.
Il processo di Norimberga. L’Organizzazione delle Nazioni Unite e il nuovo ordine. Gli accordi
di Bretton Woods: il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
2. Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione. Il maccartismo.
3. Fine della “grande alleanza”: la guerra fredda e la divisione dell’Europa. Il piano Marshall. La
nascita della CEE e del MEC. Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia. L’Unione Sovietica e le
“democrazie popolari”. La corsa agli armamenti. Lo zdanovismo. La Jugoslavia di Tito. Lotta al
comunismo e guerra civile in Grecia.
4. La destalinizzazione nell’Europa sovietica. La crisi polacca e la crisi ungherese. La
coesistenza pacifica. La primavera di Praga.
5. La Francia della Quarta e della Quinta Repubblica. La Germania divisa: la Repubblica federale
e la Repubblica democratica. La nascita della Comunità economica europea.
6. La ripresa del Giappone. La rivoluzione comunista in Cina. La guerra di Corea.
7. Il processo di decolonizzazione. La guerra d’Indocina e la guerra del Vietnam. L a crisi di Suez
e la guerra d’Algeria.
8. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. Il 1956: la destalinizzazione, la crisi polacca e la
crisi ungherese.
9. La rivoluzione castrista a Cuba. Lo sbarco nella Baia dei porci e la crisi dei missili.
Flores M., Il processo di Norimberga e il crimine di genocidio (vol. 3, pp. 457-59).
Kruscev N.S., Gli errori di Stalin (vol. 3, pp. 509-10).
Marshall G., Per la ricostruzione dell’Europa (vol. 3, pp. 517-18).
Graglia P.S., I primi passi dell’Europa unita (vol. 3, pp. 520-23).
Cittadinanza e Costituzione
1. Le forme di Stato (unitario e federale) e le forme di governo (monarchia e repubblica). Le forme
della democrazia e i suoi nemici (G. Zagrebelsky).
2. La Costituzione italiana.
Firma degli studenti rappresentanti di classe
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Relazione finale del docente: Fabrizio De Rosso
Disciplina LINGUA INGLESE
Classe VAA
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti, anche in riferimento ad impegno, interesse e partecipazione al dialogo
educativo; percentuale di studenti della classe che ha raggiunto gli obiettivi minimi secondo la
programmazione iniziale.
La classe ha sempre mostrato un discreto interesse ma solo pochi studenti hanno partecipato alle
lezioni attivamente e mostrato capacità critica e di rielaborazione personale. Molti studenti hanno
mantenuto un atteggiamento passivo e si sono espressi in lingua straniera solo durante le verifiche
orali e scritte. Quasi tutti gli studenti sanno comunque esprimersi con sufficiente correttezza e
fluenza in lingua straniera, un gruppo ristretto ha maturato capacità linguistiche buone. In generale,
le lezioni si sono sempre svolte in un clima di collaborazione e partecipazione, ma solo in parte
con apporti personali e con proficue discussioni di classe sui temi proposti. L’impegno è stato
generalmente sufficiente, sia nel lavoro individuale che in quello di gruppo. Gli obiettivi minimi sono
stati raggiunti da quasi tutti gli studenti.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Periodo
dell’anno
N. di ore
impiegat
o
The first world war
Settembre/
Ottobre
7
Ottobre
4
Novembre
7
An introduction to WWI – Life in the trenches
“There is nothing worse than war” from A Farewell to Arms by E.
Hemingway (pages 410, 411, 412)
Different attitudes to war; The Soldier by R. Brooke p. 418 –
August 1914 by I. Rosenberg p. 421
J: Conrad’s “Heart of Darkness” – The writer’s task, Exotic
settings, The individual consciousness, The historical context, The
heart of darkness pages 450, 451, 452
Excerpts from the novel : “The Chain- gang” pages 452,453 (first
23 lines); “The death of Kurtz” (photocopy)
The USA in the first decades of the 20th century: the Red Scare,
Prohibition, Muckraking, The Jazz Age. Economy and the Great
Wall Street Crash
“The Great Gatsby” by F. S. Fitzgerald p. 489. The decay of the
American Dream, J. Gatsby and Nick Carraway, Symbolic images
The Great Gatsby by B. Luhrmann
Excerpt from the novel: “Nick meets Gatsby” pages 490, 491, 492
“Eveline” by J. Joyce pages 465,466,467,468 – The Dubliners p.
464 – The origin of the collection, The use of epiphany, A
pervasive theme: paralysis
Novembre/D
icembre
6
Groupwork on “Pictures that made history”.. Presentations
Gennaio
6
“To Kill a Mockingbird” by H. Lee. Main themes.
Dicembre/
Febbraio
8
Febbraio/Ma
rzo
3
Aprile/
9
Excerpts from the novel (photocopies)
To Kill a Mockingbird by R. Mulligan
“The Waste Land” by T. S. Eliot p. 432. The Burial of the Dead
parts 1 and 2 pages 433,434
A comparison between “The Waste Land” and “Desolation Row”
by Bob Dylan
London and Literature – an introduction followed by individual work
and presentation to the class.
Maggio
“London” by W. Blake, “Composed upon Westminster Bridge” by
W. Wordsworth
“1984” by G. Orwell, p. 533.
Aprile/
“Big Brother is watching you” pages 534,535
Maggio
1984 by M. Radford
3. Metodologie didattiche
Lezione frontale
Lavoro di gruppo su materiali originali
Lavoro individuale su materiali originali
Presentazioni
Lezioni partecipate
Discussioni di classe
4. Materiali e strumenti didattici impiegati
File, immagini e video da Internet
Film in lingua originale sottotitolati in inglese
Brani da opere letterarie originali
Libri di testo: “Gateway B2 Exams” e “Performer 3”
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Si rimanda ai quaderni di dipartimento di lingue straniere
Padova, 1 maggio 2017
Firma del docente
Firma degli studenti rappresentanti di classe
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
All. A
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
2. Allegato A
Relazione finale del docente: Cristina Pegorin
Disciplina: MATEMATICA
Classe: VAA
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
6. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti.
La classe all’inizio del quarto anno presentava una preparazione non del tutto sufficiente, con
incertezze diffuse e conoscenze superficiali. Il metodo di studio risultava complessivamente poco
efficace e in generale disorganizzato.
Il percorso di maturazione è stato, nel corso dei due anni, apprezzabile. La classe ha mantenuto
un atteggiamento curioso e collaborativo nei confronti della disciplina, gli studenti sono stati molto
attivi nel lavoro in classe, meno volenterosi e continui nel lavoro personale, ma hanno sempre
reagito positivamente e con impegno alle verifiche proposte.
La preparazione globale è sufficiente. Qualche studente si distingue per impegno continuo e senso
responsabilità lodevole e per aver acquisito conoscenze articolate, abilità procedurali sicure e
precisione nella risoluzione di problemi.
Una parte della classe ha raggiunto una preparazione appena sufficiente, determinata da difficoltà
individuali specifiche e/o da un’applicazione non sempre adeguata allo studio, 4-5 studenti non
hanno raggiunto un livello di preparazione accettabile.
7. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
QUADRIMESTRE
I
Settembre – Ottobre
30
CONTENUTI
Limiti
I
Novembre -dicembre
– gennaio
40
Derivate e
studio di
funzione
II
Febbraio-Marzo
30
Integrali
CONOSCENZE
I teoremi sui limiti
Le forme indeterminate
I limiti notevoli
La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo
I punti di discontinuità di una funzione
Gli asintoti
La derivata di una funzione in un punto
L’interpretazione geometrica della derivata in un punto
Le derivate delle funzioni potenza, logaritmo, esponenziale e delle
funzioni goniometriche
La funzione derivata e le derivate successive
La continuità e la derivabilità
Il differenziale di una funzione
I teoremi di Lagrange, Rolle e Cauchy e la regola di De l’Hospital
I punti stazionari, a tangente verticale, angolosi
I massimi e i minimi relativi e assoluti
La concavità e i punti di flesso
Gli asintoti
La primitiva di una funzione
L’integrale indefinito e le sue proprietà
QUADRIMESTRE
II
Aprile
15
CONTENUTI
Le equazioni
differenziali
II
Maggio
10
Dati e
previsioni
II
Maggio
8
Geometria
CONOSCENZE
L’integrale definito e le sue proprietà
Il teorema fondamentale del calcolo integrale
Gli integrali impropri
Equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti o
che si risolvono mediante integrazioni elementari
Equazioni differenziali a variabili separabili
Equazioni differenziali del secondo ordine
Calcolo combinatorio:
Le disposizioni
Le permutazioni
Le combinazioni
La funzione n! - I coefficienti binomiali
Probabilità:
Teoremi di calcolo di probabilità
Teorema di Bayes
Distribuzioni discrete e continue di probabilità:
- Distribuzione binomiale
- Distribuzione normale
Coordinate cartesiane nello spazio
Equazioni delle rette, dei piani e di alcune superfici notevoli
Firma degli studenti rappresentanti di classe
___________________________________
___________________________________
8. METODOLOGIA DIDATTICA E MATERIALI USATI
L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso lezioni frontali, arricchite dallo
svolgimento di esercizi alla lavagna o tramite gruppi di lavoro. Al termine di ogni lezione è stato
assegnato del lavoro da svolgere a casa, basato sullo studio dell’argomento spiegato in classe e
sulla risoluzione di alcuni esercizi, graduati nella difficoltà. Il lavoro di correzione dei compiti è stato
sistematico e puntuale e ha permesso la verifica quotidiana del lavoro personale svolto dagli
studenti. Il libro di testo (Manuale blu 2.0 di matematica “Bergamini-Trifone-Barozzi) è stato
integrato da esercizi di approfondimento, quesiti e problemi assegnati agli esami di maturità degli
anni precedenti.
9. VERIFICHE e CRITERI di VALUTAZIONE
Le verifiche, strettamente correlate con il complesso delle attività svolte durante il processo di
insegnamento-apprendimento, hanno coinvolto tutte le tematiche affrontate, tenendo conto degli
obiettivi previsti. Le prove scritte somministrate sono state di diverso tipo (monotematiche,
strutturate, sommative) composte sempre di esercizi e/o problemi e/o quesiti teorici.
Verrà eseguita una simulazione di seconda prova d’esame il 16 maggio.
Padova, 15 maggio 2017
Firma della docente
_____________________________
Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“ALVISE CORNARO”
All. A
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
2. Allegato A
Relazione finale del docente: Cristina Pegorin
Disciplina: FISICA
Classe: VAA
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
10. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti.
Nei due anni in cui mi sono occupata dell’insegnamento della fisica in questa classe è stato svolto
un lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze di base, che risultavano scollegate e
poco organizzate e una revisione del metodo di studio specifico della disciplina ancora troppo
superficiale. La classe ha dimostrato, in generale, un interesse abbastanza continuo e un impegno
nello studio autonomo non sempre responsabile, ma crescente, da cui la necessità di verifiche
frequenti al fine di monitorare il lavoro di studio personale.
Nel complesso la maggior parte della classe dimostra di possedere una conoscenza sufficiente
degli argomenti trattati, qualcuno si distingue per aver raggiunto una preparazione approfondita e
sicura che gli permette di eseguire collegamenti ed analizzare in modo corretto le situazioni
problematiche posposte. Questi studenti hanno anche acquisito un metodo studio autonomo ed
efficace.
Alcuni alunni hanno manifestato difficoltà specifiche nello studio della fisica che perdurano nel
tempo e che hanno impedito il raggiungimento di una preparazione del tutto sufficiente, tuttavia per
alcuni è da segnalare che l’impegno non è mancato.
Un gruppo composto da 3-4 studenti si è dedicato allo studio con impegno scarso e discontinuo,
questi alunni hanno raggiunto livelli di preparazione differenti, ma lacunosi, faticano a risolvere
correttamente semplici esercizi, ad individuare le regole e le leggi da applicare, ad esporre con
linguaggio adeguato e in modo esauriente aspetti teorici essenziali.
11. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
QUADRIMESTRE
I
Settembre/Ottobr
e
15 ore
CONTENUTI
Cariche elettriche e
campi elettrici
CONOSCENZE
Fenomeni elementari di elettrostatica - Convenzione sui segni delle
cariche - Conduttori e isolanti - La legge di conservazione della
carica
L’elettroscopio
Unità di misura della carica elettrica nel SI - La carica elementare
La legge di Coulomb
Il principio di sovrapposizione - La costante dielettrica relativa e
assoluta - La forza elettrica nella materia
Elettrizzazione per induzione
Polarizzazione degli isolanti
Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico prodotto da una carica
puntiforme e la più cariche - Rappresentazione del campo elettrico
attraverso le linee di campo - Le proprietà delle linee di campo
Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss
QUADRIMESTRE
CONTENUTI
I
Novembre
15 ore
Il potenziale elettrico
I
Dicembre
10 ore
Circuiti in corrente
continua
I
Dicembre Gennaio
4 ore
La corrente elettrica
nella materia
II
Gennaio Febbraio
15 ore
Il campo magnetico
CONOSCENZE
La densità superficiale e lineare di carica
Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di
carica, da una distribuzione lineare infinita di carica, all’esterno di
una distribuzione sferica di carica e all’interno di una sfera
omogenea di carica
L’energia potenziale elettrica - L’andamento dell’energia potenziale
in funzione della distanza tra due cariche
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura - La differenza di
potenziale - Le superfici equipotenziali
La relazione tra le linee di campo e le superfici equipotenziali Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico
Circuitazione del campo elettrico
La condizione di equilibrio elettrostatico e la distribuzione della
carica nei conduttori - Campo elettrico e potenziale in un conduttore
carico
La capacità di un conduttore e la sua unità di misura nel SI
Potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata
Il condensatore - Campo elettrico e capacità di un condensatore a
facce piane e parallele - Concetto di capacità equivalente
Collegamento di condensatori in serie e in parallelo
L’energia immagazzinata in un condensatore
Intensità e verso della corrente continua
L’unità di misura della corrente nel SI
I generatori di tensione
Elementi fondamentali di un circuito elettrico
Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito
elettrico
Le leggi di Ohm
I resistori
Collegamento in serie e in parallelo di resistori
La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule
Unità di misura per i consumi di energia elettrica
La forza elettromotrice e il generatore reale di tensione
Le leggi di Kirchhoff
L’interpretazione microscopica del moto delle cariche nei conduttori
La velocità di deriva
I processi di carica e di scarica di un condensatore
Fenomeni di magnetismo naturale - Attrazione e repulsione tra poli
magnetici
Caratteristiche del campo magnetico
Le interazioni tra magneti e correnti
Intensità del campo magnetico e sua unità di misura nel SI
La forza di Lorentz
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme
Forza magnetica su un fili percorso da corrente
Legge di Biot-Savart
Le forze tra fili percorsi da corrente
Momento torcente di una spira e di una bobina
Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un
solenoide
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il
magnetismo
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère
Le proprietà magnetiche della materia
QUADRIMESTRE
II
Febbraio - Marzo
15 ore
II
Marzo - Aprile
12 ore
CONTENUTI
L’induzione
elettromagnetica
CONOSCENZE
La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica
La legge di Faraday-Neumann
La forza elettromotrice indotta media e istantanea
La legge di Lenz sul verso della corrente indotta
Le equazioni di
Maxwell e le onde
elettromagnetiche
II
Maggio
8 ore
La relatività ristretta
II
Maggio
4 ore
Meccanica
quantistica
Campi elettrici indotti
La circuitazione del campo elettrico indotto
La corrente di spostamento
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico
Le onde elettromagnetiche: produzione, propagazione e ricezione
Lo spettro elettromagnetico
L’invarianza della velocità della luce
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta
Il concetto di simultaneità e la sua relatività
La dilatazione dei tempi
La contrazione delle lunghezze
Quantità di moto relativistica
Energia relativistica
La composizione delle velocità
Gli spettri atomici
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck
L’effetto fotoelettrico
L’effetto Compton
Firma degli studenti rappresentanti di classe
______________________________
______________________________
12. Materiali e strumenti didattici
Libro di testo (Romeni - FISICA E REALTA’ Campo elettrico – FISICA E REALTA’ Campo
magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti - Zanichelli), appunti dalle
lezioni, materiali e strumenti di laboratorio, fotocopie integrative con esercizi supplementari e
approfondimenti.
Dal libro di testo: (elenco dei capitoli e delle pagine relativi agli argomenti svolti)
Cap 18. Cariche elettriche e campi elettrici da pag. 796 a pag. 828
Cap 19. Il potenziale elettrico da pag. 844 a pag. 846, da pag. 848 a pag. 877
Cap 20. Circuiti in corrente continua da pag. 892 a pag. 916
Cap 21. La corrente elettrica nella materia da pag. 942 a pag. 950 - Carica e scarica di
un condensatore svolte come applicazione delle equazioni differenziali.
Cap 22. Campo magnetico da pag.984 a pag. 1018
Cap 23. L’induzione elettromagnetica da pag. 1034 a pag. 1056 e pag. 1066-1067
Cap 24 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche da pag.1088 a pag. 1103,
da pag. 1106 a pag. 1109, da pag. 1113 a pag. 1118.
Cap 25 La relatività ristretta da pag. 1130 a pag. 1138 e fotocopie tratte da “I problemi
della fisica” – Cutnell, Johnson vol3 cap.21
Cap 26 Oltre la fisica classica da pag. 1176 a pag. 1196
13. Metodologia didattica
L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti:
1) esposizione teorica
2) applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi
3) realizzazione di esperimenti di laboratorio: analisi di fenomeni di induzione magnetica.
14. Tipologia delle prove di verifica
Sono state svolte verifiche scritte in forma mista (quesiti a risposta breve, soluzione di problemi) e
verifiche orali. Sono state effettuate due simulazioni di terza prova nel mese di novembre e marzo.
Padova, 15 maggio 2017
Firma della docente
____________________________
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: LUISA FABRIS
Disciplina SCIENZE
Classe V sez.AA
A.S.2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1- Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti,
La classe ha sviluppato il programma di Scienze con la sottoscritta per tutti i cinque anni.
La maggior parte degli studenti ha frequentato le lezioni con regolarità dimostrando sempre un
buon interesse per la materia.
La programmazione dell’ultimo anno, particolarmente articolata e complessa, richiedeva una
notevole costanza nell’impegno e nell’applicazione allo studio che non tutti gli studenti sono riusciti
a mantenere. Infatti, da parte di alcuni non vi è stata sempre la disponibilità ad un lavoro rigoroso
di studio, assimilazione e rielaborazione di quanto veniva proposto durante le lezioni.
Va detto però che una buona parte della classe si è impegnata con costanza e alcuni studenti
sono riusciti ad ottenere risultati molto buoni con punte di eccellenza. Mediamente il profitto risulta
quasi più che sufficiente.
Si sottolinea il fatto che in laboratorio, ed in generale nelle attività pratiche, gli studenti hanno
mantenuto sempre un comportamento ineccepibile dimostrando di aver compreso l’importanza del
regolamento e dell’attività sperimentale.
La conferma di ciò si è avuta anche in occasione della partecipazione al progetto PNLS
Biotecnologie svolto in parte nel nostro Liceo e in parte presso i Laboratori Universitari del
Dipartimento di Biologia del Fiore di Botta.
2 Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Periodo
Scienze della Terra
I quadrim.
N. di ore
impiegat
o
2
I quadrim.
2
dell’anno
Struttura interna della Terra:
- Suddivisione in base a criteri chimico-mineralogici e in base allo stato fisico dei
materiali
- Calore interno
- Moti convettivi
La Dinamica della litosfera:
La teoria della deriva dei continenti
La morfologia dei fondali oceanici
Gli studi di paleomagnetismo
Espansione dei fondali oceanici
Anomalie magnetiche
La struttura delle dorsali
Età delle rocce del fondale
Tettonica a placche e orogenesi:
La teoria della tettonica a placche
Margini di placca
Caratteristiche generali delle placche
I margini continentali
Come si formano gli oceani
I sistemi arco-fossa
Punti caldi (Isole Hawaii)
Il Meccanismo che muove le placche
I diversi tipi di Orogenesi
Un sistema in continua evoluzione
Atmosfera e Meteorologia:
La composizione dell’atmosfera
La struttura a strati dell’atmosfera
Il bilancio radiative ed energetico della Terra. Effetto serra.
La pressione atmosferica
I venti
I fenomeni meteorologici:
- Il tempo meteorologico
- Le previsioni del tempo
- Cambiamenti climatici(approfondimento)
Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie
Dal carbonio agli idrocarburi:
Il Carbonio elemento della vita (natura dei legami covalenti semplice, doppio e
triplo, anche mediante il concetto di ibridazione).
Gli idrocarburi saturi: Alcani e Cicloalcani
L’Isomeria (Tipi di isomeria: isomeri di struttura, isomeria ottica, isomeria
geometrica, La stereoisomeria nei farmaci)
La nomenclatura degli idrocarburi saturi
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi
Le reazioni di alogenazione degli alcani.
Gli idrocarburi insaturi: Alcheni e Alchini
Nomenclatura di Alcheni e Alchini
L’isomeria geometrica degli Alcheni
Reazioni di addizione elettrofila di alcheni e alchini.
Gli idrocarburi Aromatici
Nitrazione del benzene (sostituzione elettrofila aromatica).
Gruppi funzionali: Alogenoderivati, Alcoli, fenoli ed eteri.
Ossidazione degli alcoli. Esempi di alcoli Importanti (metanolo, etanolo, glicol
etilenico, glicerolo, fenoli)
Aldeidi, Chetoni. Reazione di addizione nucleofila ( formazione emiacetali,
acetali e emichetali)
Acidi carbossilici
Esteri e saponi - Reazione di Saponificazione e ammidi.
Ammine e ammidi
Composti eterociclici
Polimeri di sintesi: polimeri di addizione e di condensazione
Polimeri biologici
Basi della biochimica:
Carboidrati
Lipidi
Amminoacidi, Peptidi e Proteine
Struttura delle proteine e loro attività biologica
Enzimi
Nucleotidi e Acidi Nucleici
Duplicazione del DNA
Codice genetico e Sintesi proteica
Il metabolismo
Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula: anabolismo e
catabolismo, vie metaboliche, ATP, coenzimi NAD e FAD
Metabolismo dei carboidrati: glicolisi (semplificato), fermentazione,
Metabolismo del Lipidi, β-ossidazione (solo significato)
Metabolismo terminale: decarbossilazione piruvato ad acetil-CoA, Ciclo di
Krebs(semplificato), catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione
ossidativa.
Fotosintesi: Fase luce e ciclo di Calvin(generalità sul processo)
I quadrim.
6
I quadrim.
6
I quadrim.
2
I quadrim.
11
I e II
quadrim
5
II
quadrim
7
La regolazione genica in virus e batteri
Genetica dei virus: struttura dei virus, ciclo litico e lisogeno, i retrovirus
La ricombinazione genica nei procarioti: trasformazione, coniugazione e
trasduzione
L’antibiotico-resistenza
Plasmidi e batteriofagi come vettori di DNA esogeno per la trasformazione di
cellule batteriche
Operoni batterici lac e trp
Caratteristiche del genoma eucariotico.
Geni interrotti. Introni ed esoni. Splicing e splicing alternativo.
Mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche.
Che cosa sono le biotecnologie
Una visione d’insieme sulle biotecnologie
La tecnologia delle colture cellulari
La tecnologia del DNA ricombinante: tagliare e incollare il DNA, individuare
sequenze specifiche, copiare il DNA
Amplificare il DNA (PCR) - Sequenziare il DNA
Clonaggio e Clonazione
Biotecnologie in ambito medico, agroalimentare e ambientale
Definizione di OGM
II
quadrim.
8
Cenni su risorse energetiche e sviluppo sostenibile
II
2
quadrim.
8
II
Attività di laboratorio
- Regolamento di laboratorio
- Riconoscimento dei principali elementi tettonici da una carta geografica
- Interpretazione meteorologica di carte sinottiche del tempo
- Costruzione di modelli di molecole organiche
- Determinazione delle sostanze organiche con saggio al coccio
- Legge di Lambert-Beer
- Curva di taratura del Permanganato di potassio
- Saggio di Tollens (riconoscimento delle aldeidi)
- Preparazione del sapone
- Determinazione quantitativa dell'acido citrico in limone (arancia, mandarino).
- Determinazione quantitativa della Vitamina C in arance e kiwi
- Progetto PNLS( Alla ricerca di Alu), tecniche PCR ed Elettroforesi su gel di agarosio
- Determinazione quantitativa dell'albumina nell'albume dell'uovo. (Spettrofotometro)
- Determinazione quantitativa della Clorofilla a (Spettrofotometro)
Argomenti trattati in ambito pluridisciplinare:
- con Fisica : Magnetismo terrestre
L’insegnante
prof.ssa Luisa Fabris
Gli studenti rappresentanti di classe
3 Metodologie didattiche
Per perseguire gli obiettivi si operato in tal modo:
- Ogni argomento è stato proposto e spiegato attraverso lezioni frontali partendo dalla
comprensione del testo e dalle spiegazioni dei contenuti e dei termini scientifici;
- L’apprendimento è stato rafforzato ricercando, ove possibile, un riscontro pratico dei
fenomeni teorizzati con l’attività in laboratorio, la visione di documentari e uso di testi e
riviste scientifiche specializzate;
- E’ stata favorita, per quanto possibile, l’interdisciplinarietà;
- E’ stato possibile analizzare alcune problematiche socio-culturali prendendo spunto dalla
cronaca, dall’analisi di documenti, carte tematiche, grafici e tabelle.
A tale proposito sono stati trattati i seguenti temi di approfondimento:
Documentario: Wegener e la Teoria della Deriva dei continenti.
Scala geocronologica della Terra.
Analisi delle carte meteorologiche
Palloni bomba giapponesi.
Documentario: Natta e il propilene isotattico
Documentari di approfondimento sui polimeri e Storia della plastica
L’epigenetica
Documentario: il genoma umano ( intervista a Watson)
Elettroforesi su gel e PCR
Conferenza sulla Storia della Bomba Atomica (prof.A. PASCOLINI)
Conferenza: Analisi del DNA contro la pirateria alimentare e viaggi della Sindone
raccontati dal DNA” ( prof. BARCACCIA )
Progetto PNLS( Alla ricerca di Alu)
4 Materiali e strumenti didattici impiegati
- Libri di testo in adozione
- Reagenti, strumenti e vetreria del laboratorio di Chimica
- Modellistica molecolare (Aula di Scienze)
- Google earth.
- Collegamenti internet per osservazione di documentari, ricerca ed interpretazione di carte
sinottiche del tempo.
- Appunti da testi e riviste specializzate.
- Computer per presentazioni power point, ricerche(internet), presentazione modelli.
Spazi
- Aula scolastica
- Laboratorio di Chimica
- Laboratorio di Scienze
- Aula Magna
- Aula informatica
- Laboratori Universitari di Biologia ”FIORE DI BOTTA”
5- Criteri e strumenti di valutazione adottati
In accordo con gli altri docenti di Scienze del Liceo sono stati usati i seguenti criteri di valutazione:
Conoscenze generali e specifiche
Comprensione degli argomenti
Rielaborazione e capacità di sintesi
Capacità espressive e linguaggio appropriato e scientifico
Abilità nell’applicazione del metodo scientifico sperimentale
Durante il percorso didattico la comprensione dei concetti e la capacità di rielaborazione personale
è stata accertata con domande a risposte brevi o articolate.
Per il controllo del profitto scolastico i seguenti metodi:
- Interrogazioni orali
- Interrogazione scritte
- Simulazione di terza prova
Padova, 5 maggio 2017
Firma della docente prof.ssa LUISA FABRIS
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
All. A
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Relazione finale del docente: GIORGIO ZANDONA’
Disciplina: Disegno e Storia dell’arte
Classe 5 Aa
A.S. 2016/17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
Si possono distinguere nella classe alcuni livelli di preparazione. Un limitato numero di alunni ha
raggiunto un livello di conoscenza buona/ottima degli argomenti proposti, la maggior parte degli
studenti ha conseguito una conoscenza abbastanza omogenea e approfondita e per alcuni
solamente sufficiente. Gli studenti dimostrano sufficienti capacità di riconoscere gli elementi
peculiari del linguaggio figurativo dei diversi periodi storici; sanno collocare nel tempo le opere,
anche se un numero limitato di studenti sa rapportarle alla situazione sociale, culturale ed
economico in cui sono state prodotte; conoscono la terminologia specifica della materia.
Alcuni alunni rivelano competenze non particolarmente approfondite e le espone in
forma non sempre scorrevole e appropriata.
Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Il ROMANTICISMO
- Théodore Géricault, Eugéne Delacroix, Francesco Hayez,
Constable, Turner;
REALISMO: Gustave Courbet;
MACCHIAIOLI: Giovanni Fattori.
L’architettura del ferro, il restauro architettonico;
LA STAGIONE IMPRESSIONISTA:
Édourad Manet, Claude Monet, Edgard Degas, Pierre-Auguste
Renoir.
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE:
Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh.
FASUVES: Henri Matisse
ESPRESSIONISMO: DIE BRÜKE: Kirchner, Heckel, Nolde, Munch
IL CUBISMO: Picasso, Braque.
Periodo
dell’anno
N. di
ore
Settembre
Ottobre
7
Novembre
5
Dicembre
4
Gennaio
Febbraio
Febbraio
4
5
FUTURISMO: Boccioni, Sant’Elia, Balla
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio
IL DADA: Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray
SURREALISMO: Max Ernst, Joan Mirò, René Magritte, Salvador
Dalì.
Firma degli studenti rappresentanti di classe
4
6
Metodologie didattiche
(in questa sezione vanno indicate anche le attività extra-curricolari – viaggi di istruzione, visite di
istruzione, conferenze, attività di laboratorio, ecc. che hanno contribuito ad approfondire lo studio
di specifici argomenti disciplinari o pluridisciplinari)
… Lezioni frontali.
Materiali e strumenti didattici impiegati
… Testi adottati: Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Zanichelli vol.4 e 5.
video di approfondimento, CD- ROM multimediali.
Criteri e strumenti di valutazione adottati
… Interrogazioni frontali con un piccolo gruppo di allievi (max 3). Le verifiche orali sono state sia
tematiche (limitate a una ristretta rosa di argomenti) sia generali (estese all’intera
programmazione di più unità didattiche).
Prove scritte:
Simulazione di terza prova 12/12/2016
1- Illustra le caratteristiche tipicamente romantiche della Libertà che guida il popolo di Eugéne
Delacroix. (max. 12 righe)
2 – Descrivi le modalità tecnico-espressive di Giovanni Fattori attraverso la lettura della Rotonda di
Palmieri (max. 12 righe)
Test di valutazione.
Le prove effettuate sono a disposizione della Commissione presso la segreteria.
Padova, 15 maggio 2017
Firma del docente
Liceo Statale
“ALVISE CORNARO”
Via Riccoboni, 14 - 35127 PADOVA
049 755.695 fax: 049 850.605
e.mail: [email protected]
p.e.c. [email protected]
web: www.liceocornaro.com
Codice fiscale. 80021490281
LICEO
SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
LINGUISTICO
DOCUMENTO 15 MAGGIO
RELAZIONE FINALE - PROGRAMMA
Relazione finale del docente:
Disciplina: SCIENZE MOTORIE
SEREN RENZO
Classe 5AA
A. S. 2016-2017
Presentazione della Classe:
La classe ha svolto educazione fisica sempre col sottoscritto per tutti i 5 anni di studio e si presenta generalmente
omogenea per interesse e capacità motorie, tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni pratiche e
teoriche. Tutte le argomentazioni sono state assimilate e recepite dall’intera classe.
In relazione alla programmazione disciplinare attuata sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
Conoscenze:
l’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile;
il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare
attività finalizzate e di valutarne i risultati individuandone anche i nessi pluridisciplinari;
il perseguimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento delle capacità
di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari;
l’arricchimento della coscienza sociale attraverso una sempre maggiore consapevolezza di sé e l’acquisizione della
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.
Le finalità citate, coerenti con quelle generali della scuola, definiscono l’ambito operativo specifico dell’Educazione
Fisica indicandone, di fatto, gli obiettivi generali e specifici propri della materia.
educazione alimentare;
cenni anatomo-fisiologici dei principali sistemi ed apparati (scheletrico, muscolare, circolatorio, respiratorio)
- Conoscenza generale ed uso delle principali funzioni organiche, dei principi alimentari e della prevenzione degli
infortuni PRIMO SOCCORSO.
Abilità:
- Resistenza Generale
- Velocità (intesa sia come tempo di reazione motoria, sia come frequenza di movimenti),
- Forza (tono generale e specifico).
- Mobilità - Articolare e capacità di allungamento muscolare
- Equilibrio nelle sue espressioni Statiche - Dinamiche - e di Volo
- Coordinazione spaziotemporale
- Coordinazione Dinamica ( Destrezza )
- Schemi motori complessi, riferiti anche ai grandi giochi sportivi
- Controllo di Postura e Respirazione.
Competenze:
l’approfondimento operativo di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e propensioni
personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili anche all’esterno della scuola (tempo libero, salute, sport);
U.D. - Modulo - Percorso Formativo
Test motori: balzo da fermo, equilibrio, elevazione, destrezza, resistenza
Preatletici generali, skip, doppio skip, balzata, calciata, andature, variazioni sul
tema condizioni di difficoltà esecutiva
Esercitazioni corpo libero ed acrogym in relazione agli esercizi base della
ginnastica artistica riferita ai rotolamenti, sui diversi assi in condizione di
esecuzione in velocità
Giochi sportivi, pallavolo, pallacanestro, pallamano: fondamentali e tecniche di
gioco
Atletica: propedeutici salto in alto e corsa ostacoli
Piccoli attrezzi: funicella, appoggi propedeutici, esercizi in evoluzione e in
combinazione
PRIMO SOCCORSO: tecniche di base, teoria e pratica
Approfondimento:
si/no
SI
SI
Periodo:
I Q/II Q
1/2Q
1/2Q
SI
1/2Q
SI
1/2Q
SI
SI
1/2Q
1/2Q
SI
2Q
L’insegnamento dell’Educazione Fisica in questa classe è stata la diretta prosecuzione ed evoluzione logica di quanto
introdotto nei precedenti anni scolastici con l’acquisizione delle seguenti competenze:
l’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile;
il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare
attività finalizzate e di valutarne i risultati individuandone anche i nessi pluridisciplinari;
il perseguimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento delle capacità
di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari;
l’approfondimento operativo di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e propensioni
personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili anche all’esterno della scuola (tempo libero, salute, sport );
l’arricchimento della coscienza sociale attraverso una sempre maggiore consapevolezza di sé e l’acquisizione della
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.
Le finalità citate, coerenti con quelle generali della scuola, definiscono l’ambito operativo specifico dell’Educazione
Fisica indicandone, di fatto, gli obiettivi generali e specifici propri della materia.
educazione alimentare;
cenni anatomo-fisiologici dei principali sistemi ed apparati.
Padova 3 maggio 2017
_______________________________
In Fede Seren Renzo
Gli alunni
________________________
_________________________
Relazione finale del docente:
Disciplina: SCIENZE MOTORIE
SEREN RENZO
Classe 5AA
A. S. 2016-2017
Presentazione della Classe:
La classe ha svolto educazione fisica sempre col sottoscritto per tutti i 5 anni di studio e si presenta generalmente
omogenea per interesse e capacità motorie, tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle lezioni pratiche e
teoriche. Tutte le argomentazioni sono state assimilate e recepite dall’intera classe.
In relazione alla programmazione disciplinare attuata sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
Conoscenze:
l’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile;
il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare
attività finalizzate e di valutarne i risultati individuandone anche i nessi pluridisciplinari;
il perseguimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento delle capacità
di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari;
l’arricchimento della coscienza sociale attraverso una sempre maggiore consapevolezza di sé e l’acquisizione della
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.
Le finalità citate, coerenti con quelle generali della scuola, definiscono l’ambito operativo specifico dell’Educazione
Fisica indicandone, di fatto, gli obiettivi generali e specifici propri della materia.
educazione alimentare;
cenni anatomo-fisiologici dei principali sistemi ed apparati (scheletrico, muscolare, circolatorio, respiratorio)
- Conoscenza generale ed uso delle principali funzioni organiche, dei principi alimentari e della prevenzione degli
infortuni PRIMO SOCCORSO.
Abilità:
- Resistenza Generale
- Velocità (intesa sia come tempo di reazione motoria, sia come frequenza di movimenti),
- Forza (tono generale e specifico).
- Mobilità - Articolare e capacità di allungamento muscolare
- Equilibrio nelle sue espressioni Statiche - Dinamiche - e di Volo
- Coordinazione spaziotemporale
- Coordinazione Dinamica ( Destrezza )
- Schemi motori complessi, riferiti anche ai grandi giochi sportivi
- Controllo di Postura e Respirazione.
Competenze:
l’approfondimento operativo di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e propensioni
personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili anche all’esterno della scuola (tempo libero, salute, sport);
U.D. - Modulo - Percorso Formativo
Test motori: balzo da fermo, equilibrio, elevazione, destrezza, resistenza
Preatletici generali, skip, doppio skip, balzata, calciata, andature, variazioni sul
tema condizioni di difficoltà esecutiva
Esercitazioni corpo libero ed acrogym in relazione agli esercizi base della
ginnastica artistica riferita ai rotolamenti, sui diversi assi in condizione di
esecuzione in velocità
Giochi sportivi, pallavolo, pallacanestro, pallamano: fondamentali e tecniche di
gioco
Atletica: propedeutici salto in alto e corsa ostacoli
Piccoli attrezzi: funicella, appoggi propedeutici, esercizi in evoluzione e in
combinazione
Approfondimento:
si/no
SI
SI
Periodo:
I Q/II Q
1/2Q
1/2Q
SI
1/2Q
SI
1/2Q
SI
SI
1/2Q
1/2Q
PRIMO SOCCORSO: tecniche di base, teoria e pratica
SI
2Q
L’insegnamento dell’Educazione Fisica in questa classe è stata la diretta prosecuzione ed evoluzione logica di quanto
introdotto nei precedenti anni scolastici con l’acquisizione delle seguenti competenze:
l’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e
relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile;
il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare
attività finalizzate e di valutarne i risultati individuandone anche i nessi pluridisciplinari;
il perseguimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento delle capacità
di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari;
l’approfondimento operativo di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e propensioni
personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili anche all’esterno della scuola (tempo libero, salute, sport );
l’arricchimento della coscienza sociale attraverso una sempre maggiore consapevolezza di sé e l’acquisizione della
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.
Le finalità citate, coerenti con quelle generali della scuola, definiscono l’ambito operativo specifico dell’Educazione
Fisica indicandone, di fatto, gli obiettivi generali e specifici propri della materia.
educazione alimentare;
cenni anatomo-fisiologici dei principali sistemi ed apparati.
Padova 3 maggio 2017
_______________________________
In Fede Seren Renzo
Gli alunni
________________________
_________________________
________________________
_____________________
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato A
Relazione finale del docente: Bertelè Anna
Disciplina INFORMATICA
Classe 5AA
A.S. 2016-17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
15. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti: l’impegno della classe è stato sufficiente e la partecipazione non
sempre attiva da parte di tutti. Circa il 90% della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi
secondo la programmazione iniziale, con qualche studente che ha dimostrato particolare
interesse e/o diligenza.
16. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
Periodo
dell’ann
o
Fondamenti di programmazione Web lato client con Javascript
sett-nov
Utilizzo di R per il disegno di grafici
febmaggio
Utilizzo del foglio elettronico
Reti di computer:
ott-apr
20
Tutto
l’anno
20
modello OSI e TCP/IP
livello applicativo: protocollo http, DNS, cookies, posta
elettronica e i suoi protocolli (SMTP, POP, IMAP)
livello trasporto: protocollo TCP e protocollo UDP
livello rete: indirizzi IP, subnet mask, reti private e pubbliche,
DHCP e indirizzamento dinamico, NAT
Calcolo numerico:
N. di
ore
impiega
to
10
rappresentazione dei numeri nel calcolatore
precisione di macchina
calcolo del limite di una funzione
simulazione di eventi statistici: dado, moneta, carte
calcolo approssimato della radice quadrata
Ricerca degli zeri di una funzione:
o metodo di bisezione
o metodo delle secanti
o metodo delle tangenti
Metodi per il calcolo delle aree:
o metodo Montecarlo
o metodo dei rettangoli
CLIL: Introduction to cybersecurity
maggio
2
Basic principles: integrity, confidentiality and availability
Password management
Malware
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio
CLIL: Introduction to cybersecurity
Cryptography, symmetric and asymmetric encryption
Online security
Wireless security
Metodi per il calcolo delle aree:
metodo dei trapezi (Bezout)
metodo delle parabole (Simpson)
17. Metodologie didattiche
Le lezioni si sono svolte circa al 50% in laboratorio. E’ stato impartito un ciclo di lezioni in
metodologia CLIL.
18. Materiali e strumenti didattici impiegati
Libro di testo, slide e fotocopie fornite dalla docente, piattaforma Moodle.
19. Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le verifiche sono state sia scritte che pratiche, utilizzando i criteri concordati da Dipartimento.
Padova, 10 maggio 2017
Firma della docente
Firma degli studenti rappresentanti di classe
Allegato A
Relazione finale del docente: Silvia Mampreso
Disciplina Insegnamento Religione Cattolica
Classe 5 AA
A.S. 2016-17
In relazione alla programmazione disciplinare coordinata, sono stati perseguiti gli obiettivi definiti
dal Dipartimento disciplinare, rintracciabili nel QDD a disposizione della commissione.
1. Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e obiettivi disciplinari e
trasversali raggiunti, anche in riferimento ad impegno, interesse e partecipazione al dialogo
educativo; percentuale di studenti della classe che ha raggiunto gli obiettivi minimi secondo la
programmazione iniziale.
La classe 5° AA ha raggiunto gli obbiettivi fissati all'inizio dell'anno scolastico.
La percentuale degli alunni che hanno raggiunto gli obbiettivi minimi è del 100%.
2. Contenuti disciplinari, periodizzazione e tempi di realizzazione
Temi trattati entro il 15 maggio
(UD, UdA, argomenti trattati in ambito pluridisciplinare, ecc.)
Periodo
dell’ann
o
La coscienza morale
Dal 17/9
N. di
ore
impieg
ato
4
al 8/10
La dignità della persona umana
22, 29/10 2
Le parti della messa
Dal 5/11
5
al 17/12
La chiesa di Padova e la chiesa odierna
Dal 21/1
al 25/2
4
Esistenza di Dio e testimonianze
Dal 25/3
3
al 29/4
Le religioni e l'ecologia
Dal 6/5
al 13/5
2
Temi programmati, da svolgere dopo il 15 maggio1
Firma degli studenti rappresentanti di classe
1
Soltanto nel caso in cui avrà subito delle variazioni e/o non sarà stata svolta, questa parte del programma dovrà essere riportata in un
documento a parte, firmato dal/dalla docente e dagli studenti, che verrà depositato in segreteria e pubblicato nel sito.
3. Metodologie didattiche
Il metodo di lavoro che si è preferito utilizzare è stato quello del dialogo/ dibattito.
…
4. Materiali e strumenti didattici impiegati
…Abbiamo utilizzato lo schermo in classe per vedere film e video.
5. Criteri e strumenti di valutazione adottati
…La partecipazione al dialogo educativo, l'interesse e l'impegno regolare.
Padova,
Firma del/della docente
Liceo Scientifico Statale “ALVISE CORNARO”
35127 PADOVA - VIA RICCOBONI, 14
(049) 755.695 - 850.605 FAX: 850.605 C.F. 80021490281
Allegato B
Attività pluridisciplinari
I nuclei pluridisciplinari, fondamentali per la strutturazione delle prove a carattere
pluridisciplinare: terza prova e colloquio (artt. 4-5 D.P.R. 323/98), sono stati articolati
nell’azione didattica come risulta dalle schede seguenti, relative, distintamente, ai nodi
affrontati nelle terze prove effettuate, già illustrate nel documento al punto 3, oppure agli
argomenti funzionali al colloquio.
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI CLASSE 5AA ANNO SCOLASTICO 2016/17
Nuclei
Discipline
pluridisciplinari
I luoghi simbolo della Storia,
Grande Guerra
Filosofia,
Storia
dell’Arte,
Italiano,
Inglese
Il Magnetismo
Scienze
Terrestre
Fisica
Contenuti
War Poets, Hemingway
Le dodici battaglie dell’Isonzo, Caporetto, la vita
dei soldati in trincea
Ungaretti
Futurismo, Dada
Origine e studio del CMT, effetti del CMT sulla
CrostaTerrestre per lo studio della Tettonica delle
Placche
Si rimanda alle relazioni disciplinari per le indicazioni relative a: metodologie; materiali e strumenti, didattici; criteri e
strumenti di valutazione.
Firma dei Docenti del Consiglio di Classe
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………