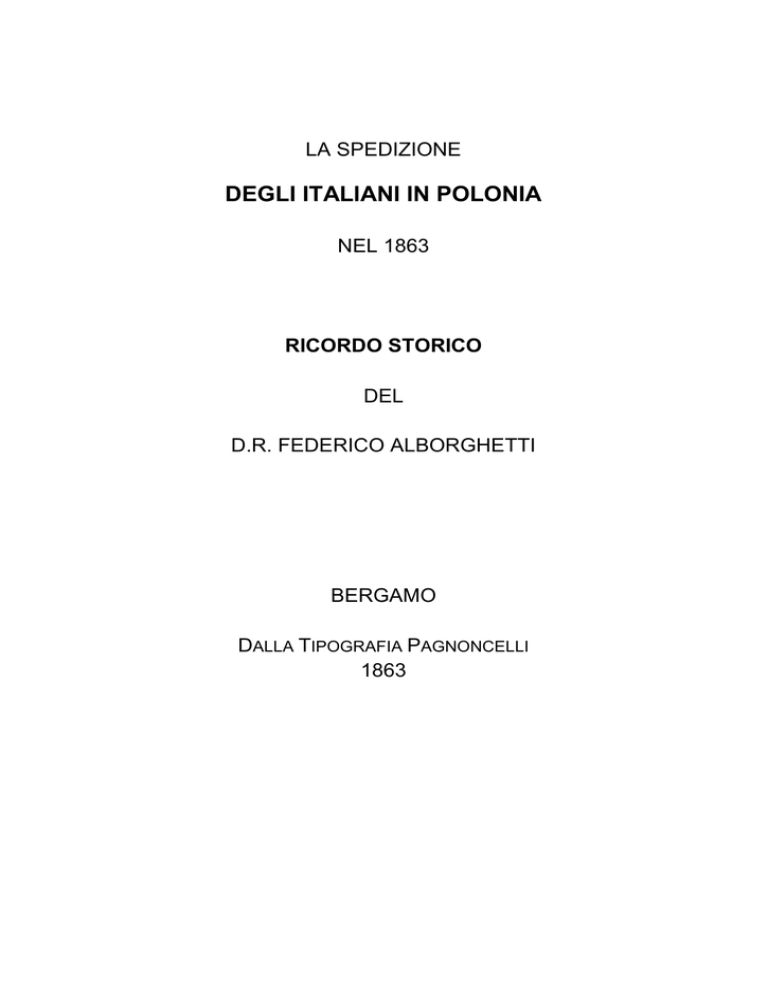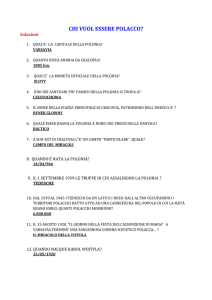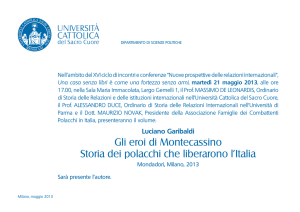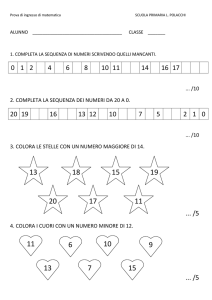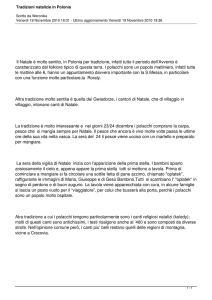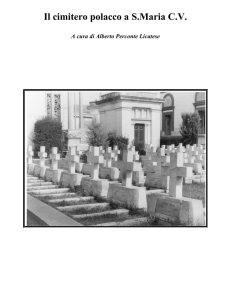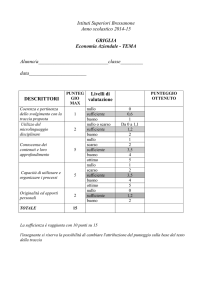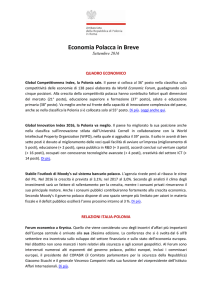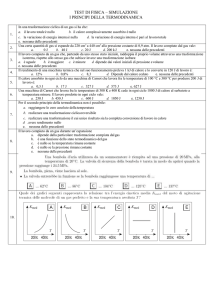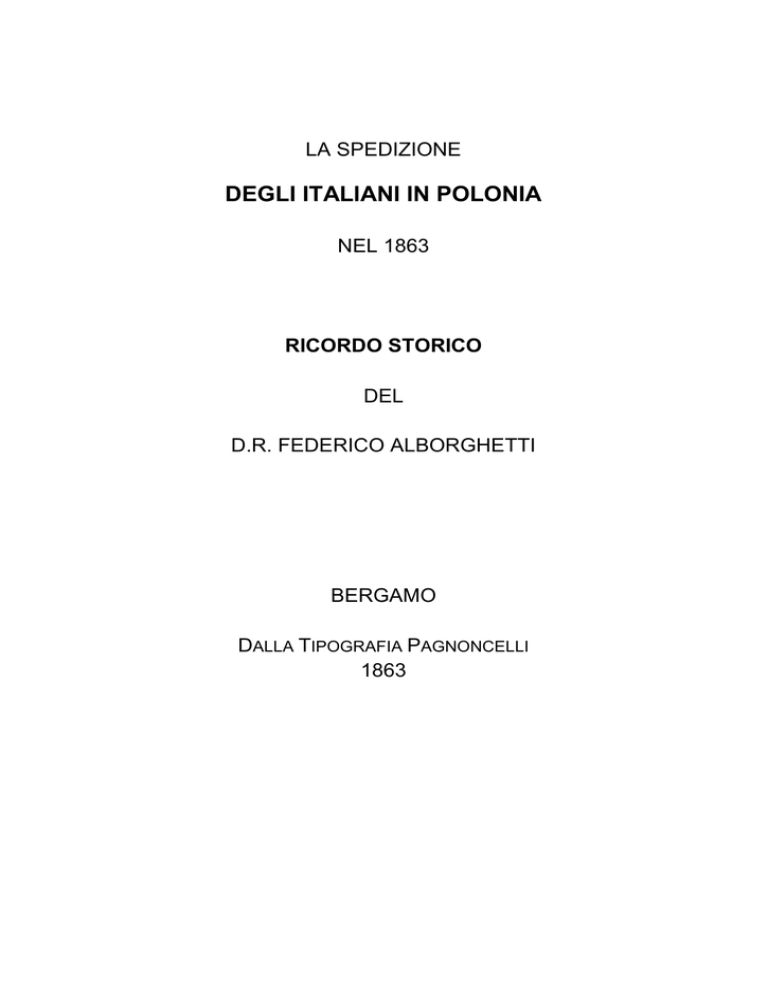
LA SPEDIZIONE
DEGLI ITALIANI IN POLONIA
NEL 1863
RICORDO STORICO
DEL
D.R. FEDERICO ALBORGHETTI
BERGAMO
DALLA TIPOGRAFIA PAGNONCELLI
1863
L’onore di giungere non che in Russia al di là del Serio e del Brembo, e che i giudici dei
compagni di Nullo ignorassero quanto ormai da tutti i giornali era stato rivelato.
Ora debbo adempiere ad una promessa.
Queste poche pagine altro scopo non hanno che di tenere vivo nel popolo quel sentimento
di ammirazione e di affetto, che è nobile ma spesso unico guiderdone a quei generosi che
si fanno martiri della causa della libertà. Ai prodi che suggellano le proprie convinzioni col
sacrificio di sé stessi, il despotismo prepara le catene ed il sepolcro: gli uomini liberi
debbono farne argomento d’onore e di emulazione a confortare la virtù dei presenti, a
preparare quella dei posteri. –
DR. FEDERICO ALBORGHETTI
I Polacchi secondo l’usanza delle altre nazioni di origine Slava hanno dato al proprio
paese il nome di Polska, vocabolo, che nella loro lingua significa pianura, e che senza
dubbio fu ad essi suggerito dalla configurazione del suolo, su cui fissarono stabile dimora.
Infatti quasi tutta la regione che costituiva un tempo la vera Polonia, prima ch’ella venisse
sbranata in diversi stati dalla violenza dei prepotenti, altro non era che una pianura
immensa, la quale si stendeva dalle spiagge del Mar Baltico fino alle rive del Dnieper nella
Volinia, ed alle vette dei monti Carpazii nella Gallizia.
Nazione numerosa e guerriera la Polonia avea saputo col tempo arricchirsi di conquiste,
ed allargare il suo dominio sopra vaste contrade al di là dei proprii confini naturali. Col re
Boleslao avea stesa la mano sulla Russia rossa, e sulla Moravia, cogli Iagelloni s’era
impadronita della Lituania, della Volinia, e della Kiovia, e vi fu un tempo che le schiere
polacche che passeggiavano temute sotto le mura di Mosca e di Smolensko, nella
Moldavia, e nella Livonia, e fin nel cuore della superba Russia! Ma il paese, che va
considerato esclusivamente la patria dei Polacchi, perché da loro soli fino agli antichissimi
tempi occupato ed abitato, è l’ampio bacino innaffiato dalla Vistola, e dagli altri fiumi
minori, che ad essa recano il tributo delle loro acque. Questo paese spartito dalla politica
senz’altra ragione, che quella della forza, senz’altro criterio, che quello della convenienza
dei vincitori, si trova attualmente segnato sulle carte geografiche coi nomi di Gallizia e
Cracovia (Polonia Austriaca) di Granducato di Posen (Polonia Prussiana) di Regno di
Polonia (Polonia Russa).
Veramente i Polacchi non hanno cessato mai di considerare siccome appartenenti alla
propria nazione le vaste provincie, che sono denominate la Lituania, la Curlandia, la
Ukraina, la Volinia, la Podlakia, ed altre parecchie, che conquistate dalle armi dei
Granduchi di Lituania, o incorporate nei dominii della Polonia, mutarono poscia e nome e
padroni e rimasero assorbite nel gigantesco impero della Russia. Ma quei territori ora
congiunti ora staccati in continua vicenda di guerre sanguinose dalla signoria della
Polonia, conservano bensì nel loro grembo degli elementi, che a questa nazione sono
legati di simpatia e di interessi a preferenza che colla Russia, ma, fatta eccezione della
casta dei nobili e dei meno antichi proprietari delle terre, che sono d’origine Polacca, la
massa delle popolazioni è di lingua, di religione, di costumi più affine, e più quindi
affezionata ai Russi.
Dopo la metà del secolo trascorso la Polonia dominava ancora sopra una superficie di 40
mila leghe quadrate di terreno, e vantava una popolazione di oltre quattordici milioni di
abitanti. Eppure aveva già perduto allora molte e floride provincie! Di tanti possedimenti, di
tanta grandezza non rimane che la memoria nelle istorie, e nell’animo dei Polacchi: la
Polonia disparve, e quasi a ludibrio ne fu conservato il nome ad una piccola zona di terra,
la quale non si estende che di 6400 leghe quadrate, e non numera quattro milioni di
abitanti. Come si è detto, il suolo della Polonia è generalmente piano, ed uniforme, e
interrotto soltanto ad intervalli da piccoli monticelli, e da modesti rialzi, i quali invece di
romperlo ne rendono più triste e melanconico il monotono aspetto. La Lituania, la
Curlandia, il centro della Polonia al pari delle vicine provincie della Russia e della Prussia
altro non presentano che interminabili pianure coperte di una sabbia bianchiccia e
profonda, e disseminate irregolarmente di striscie di terreno più elevato, e di natura
argillosa. E dove predomina l’argilla sono innumerevoli i laghi, le paludi, gli stagni, e le
torbaje, mentre il resto delle campagne coperto dalle sabbie frammiste a terriccio vegetale
è solcato dai fiumi a letto largo e poco profondo i quali facilmente straripano , permette la
coltivazione di molti cereali e piante fruttifere, e nutre poi una serie infinita di magnifiche
foreste di betulle, di larici, di pini, di quercie, che hanno sfidato i secoli.
Soltanto nel voivodato di Cracovia, e nell’ora Regno di Gallizia si levano colline e gruppi di
monti, che sono rami della grande catene dei Carpazii. Questa catena di montagne, di cui
molte pendici sono coperte da nevi perpetue, è molto estesa e complicata, e forma un
naturale baluardo, che al Sud ed all’Oriente difende la Polonia, e la divide dall’Ungheria.
La parte meridionale del territorio di Cracovia, e del Regno di Gallizia assume un aspetto
pittoresco per la forma delle montagne tagliate bizzarramente a creste e bastioni, mentre
da Cracovia a Lemberg corre una larga striscia di terra sabbionoso vestita di selve di pini,
e da Lemberg fino alle sponde del Niemen verso levante si protende un altipiano ripieno di
laghi e di paludi.
Un paese tutto piano, ricco a dismisura di acque stagnanti, di torbaje impregnate dagli
scoli delle frequenti pioggie, e di umide e tetre foreste, aperto ai venti nebbiosi, che
spirano da occidente e da tramontana dal Mar Baltico, ed a quelli gelati, che soffiano
dall’interno della Russia attraversando i gioghi nevosi dei monti Urali, chiuso alle aure
calde del mezzo-giorno che si rompono nella catena dei Carpazii, debbe avere, come ha
fatto, un clima freddo, ed umido e malsano soprattutto per gli stranieri. A Cracovia, a
Lemberg, ed a Varsavia non è raro, che nel lungo inverno il termometro di Reaumur
discenda a venti gradi al di sotto del gelo, e nei paesi polacchi in complesso la rigida
stagione è quale si trova nel centro della Svezia e sulle spiaggie australi della penisola
Scandinava, regioni che sono quasi a cinquecento miglia più alte verso il polo boreale. Del
resto il clima della Polonia è variabilissimo, perché la sua atmosfera è liberamente
dominata dai venti: talvolta tutti i suoi fiumi si mantengono gelati dalla fine di Ottobre fino a
quella del Marzo successivo, tal altra invece si ha nei mesi di Gennajo e Febbrajo una
specie di primavera, che fa sbocciare parecchi fiori, ed erompere a sciami le api dai loro
alveari. Nell’anno 1654 nelle campagne circostanti a Cracovia un gelo improvviso
distrusse in una notte tutti i grani già vicini a maturanza. Era il giorno di Pentecoste.
Le impure esalazioni, che si innalzano dalle paludi, dalle torbaje, e dalle dense boscaglie,
le frequenti ed abbondanti pioggie, che apporta il vento d’Occidente, la qualità istessa
delle acque dei laghi e dei fiumi, che qualche volta si tingono per cause ignote di colore
rossiccio, o verdastro-scuro, sono causa di inevitabili malattie non tanto ai Polacchi, che vi
sono abituati, quanto ai forestieri. Parecchie sorgenti, che scaturiscono al piede dei monti
Carpazii generano la deformità del gozzo.
La feracità del suolo è di gran lunga maggiore nei pingui terreni della Ukraina e della
Lituania, che nelle provincie della Polonia propriamente dette. Tuttavia nelle campagne
principalmente di Cracovia, di Sandomir, della Gallizia bassa, e del Posen orientale
crescono rigogliosi ogni sorta di grani del frumento fino al miglio, e se la distribuzione della
proprietà fosse meglio sistemata, molti distretti polacchi, che per mancanza di coltivatori
sono lasciati a selva, vedrebbero prosperare copiose le messi e le piantagioni fruttifere.
Ma i ricchi proprietarii possessori di immense estensioni di terre sono costretti a lasciarne
gran parte incolta, perché i contadini liberi preferiscono di stabilirsi nei possedimenti della
corona. D’onde avviene che in quasi tutte le provincie grandi spazii sono occupati dalle
foreste, o dai maresi, e la fertilità dei campi rimane inutile per la scarsità delle braccia.
Maestosi ammassi di larici e di betulle adornano i boschi dei monti della Gallizua, altri di
pini vestono a grandi tratti le campagne sabbionose; lungo le sponde del Niemen, della
Narew, della Pilica, e d’altri fiumi affluenti della Vistola si ammirano tigli giganteschi: boschi
di quercie secolari, di olmi e di frassini ammantano a larghe zone le pianure della Mazovia,
di Sandomir, di Rawa. Nei recessi ospitali di tante selve sono divenuti rari i cervi ed i daini
per la voracità dei lupi e dei ghiottoni voracissimi, che vi abbondano a torme; ma trovano
modo di moltiplicarsi le volpi, le linci, i cinghiali. I conigli ed i castori, i quali fabbricano le
loro dighe stupende lungo le solitarie correnti della Lituania meridionale.
Altri abitatori delle foreste e delle campagne polacche sono tra i volatili l’aquila, il falcone,
la gru, la pernice la quaglia, lo stornello, ed un piccolo augellino, che viene denominato la
gallina della neve, perché non si lascia vedere che nel fitto inverno; tra i quadrupedi che
vanno errando liberi tra le solitudini, va distinto l’orso, ed una specie di vacca selvatica,
che molti vollero confondere col bisonte armato di corna e di crineira.
Il popolo schiettamente polacco è di origine Slava, e la storia de’suoi padri si confonde nei
tempi antichissimi con quella di tribù innumerevoli di razza Scita o Sarmata, le quali
eternamente in guerra tra loro, o coi proprii vicini, si disputarono per dei secoli le deserte
lande del Settentrione dell’Europa. Come accadde a molte altre nazioni, anche i Polacchi
di trovarono qualche volta soverchiati dalla prepotenza di popoli conquistatori, i quali
rimasero sullo stesso suolo con loro, si confusero insieme, e diedero origine alla
disuguaglianza delle caste. I nobili, i contadini liberi, i servi della gleba rappresentano
ancora nella Polonia, come in altri paesi del Nord, la miscela di popolazioni tutte nate sulla
medesima terra, e rivelano il segreto di quelle continue e sanguinose convulsioni, che non
cessarono di agitarli per serie di anni lunghissima. Il colorito meno bruno, i lineamenti più
regolari, il suono istesso dei nomi della massima parte dei nobili Polacchi fanno dubitare,
ch’essi discendano da colonie di guerrieri innestatisi per violenza in seno alla schiatta
indigena.
Generalmente i Polacchi hanno un tipo caratteristico di statura alta, di complessione
robusta, di colorito vivacce e traente al bruno. Se il loro aspetto è marziale, la fisonomia è
però benevola ed aperta. Rari sono tra loro gli occhi cerulei e le capigliature bionde o
castane; hanno l’apice del naso alquanto rilevato al’insù e saliente l’osso zigomatico. E a
differenza d’ogni altra nazione d’Europa hanno il collo corto e grosso. Gli uomini d’ogni
condizione portano i mustacchi. Celebre poi nel settentrione è la bellezza delle loro donne,
che hanno leggiadria di forme e freschezza di colorito assai più che non le Russe o le
Tedesche, e di queste sanno rendersi rivali invidiate per la gentilezza squisita delle
maniere e per la vivacità amabilissima de conversare.
Ma il naturale vigore fisico dei Polacchi, che sarebbe molto favorito anche dalla
educazione e dalle costumanze nazionali, è sgraziatamente ficcato dalla ricorrenza di
parecchie malattie, che a loro sono famigliari in confronto dei popoli vicini. Sia effetto
dell’aria corrotta dai numerosi e vasti pantani o delle acque potabili poco salubri, o delle
sudicie abitudini della gente minuta, che vive stipata in miserabili tugurii insieme cogli
animali ed in mezzo al letame, egli è certo che in Polonia dominano morbi contagiosi e
maligni, che si conoscono appena nei paesi limitrofi e situati nelle medesime od in peggiori
condizioni di suolo e di clima. Molte malattie comuni ai Russi ed ai Polacchi sono per
questi assai più contagiose e micidiali che non per quelli.
I guasti maggiori nella popolazione polacca sono prodotti dal vajuolo e dalla sifilide. I
contadini, che di regola non si lavano mai la pelle del corpo, e stanno rinchiusi per lunghi
mesi, e mangiano e dormono entro capanne riscaldate dall’alito dei loro bestiami, non si
danno il minimo pensiero di preservarsi dal contagio del vajuolo, ed affrontano quella
terribile malattia colla medesima trascuratezza, che sogliono i Turchi contro la peste. Allo
scoppiare della epidemia non precauzioni, non medici, non medicine: misti alla rinfusa
malati e sani nelle stesse stalle lasciano che il flagello si porti via sei o sette sopra dieci
delle persone colpite, e abbandoni le altre sfigurate in modo orribile. Con eguale
indifferenza permettono alla sifilide di serpeggiare in seno alle famiglie. Per conseguenza
in niun altro paese d’Europa o incontrano tante persone cieche per vajuolo e senza naso
per la sifilide, quanto in Polonia.
Ma un’affezione morbosa tutta speciale o del paese o della schiatta dei Polacchi, il vero
flagello indigeno e quasi esclusivo della loro famiglia è la così detta Plica, per la quale un
umore acre, vischioso e puzzolento trasuda dalla testa, gonfia i capelli, li raggruppa, li
spacca e li impasta insieme, li fa nido di miriadi di schifosi insetti, poi in capo ad un periodo
più o meno lungo, più o meno doloroso, e talvolta pericolosissimo alla vita, libera
l’ammalato lasciandolo calvo per parecchie settimana. Talvolta essa attacca anche le
unghie delle mani e dei piedi.
Codesta pericolosa e ributtante malattia non risparmia né età né sesso, e sebbene si
attenga specialmente alle classi più miserabili dei contadini e dei braccianti, osa di
frequente aprirsi il passo fin entro le famiglie delle persone agiate, e dei superbi signori
della contrada. Essa è contagiosa, si comunica con somma facilità dall’uno all’altro
individuo anche per semplice contatto della pelle o delle vestimenta; qualche volta i
bambini la portano seco nascendo. Gli stranieri che si trattengono in Polonia, non sono
certi di andarne immuni, e non di rado avviene che gli stessi animali coperti di pelo ne
siano attaccati.
I nobili Polacchi non escono quasi mai dai loro palazzi se non in cocchio od a cavallo, e
pur troppo non hanno fin ad ora saputo spogliarsi di quel contegno fiero e disdegnoso, con
cui furono avvezzi a riguardare le altre classi della popolazione, e che fu probabilmente la
causa principale della loro servitù comune sotto gli stranieri. I contadini non potevano
nudrire né simpatia né affetto verso padroni altieri, cui quasi non conoscevano che di
nome, e che lontani dalle loro terre se ne stavano del continuo ad impinguare accidiosi, o
sfoggiare del lusso nelle città. Se parecchie migliaia di nobili e di ricchi possidenti
conservarono un odio tanto implacabile contro il Russo oppressore, quanto era profondo
l’amore della propria libertà ed all’indipendenza nazionale, i milioni condannati a sudare
sulla gleba cercavano indarno una differenza molto sensibile tra un padrone compaesano
ed un padrone forastiero. Se a tenerli divisi dai Russi non fossero rimasti argini
insuperabili la religione e la lingua, i contadini Polacchi avrebbero ripetuto più spesso lo
stolido errore di prestare il proprio braccio alla infame politica dell’Austria e della Russia.
Lo squallore, la miseria, la ignoranza, il sudiciume delle infime classi della popolazione
polacca fanno un triste riscontro alla opulenza, alla civiltà, ed ai nobili sentimenti della
classe aristocratica. Tali disuguaglianze, giova sperarlo, si vanno cancellando nei punti più
risentiti colle lotte sanguinose, che in nome della patria adunano sotto la stessa bandiera il
nobile ed il plebeo: la necessità impone ai signori polacchi di accostarsi e stendere la
mano ai contadini: speriamo che il loro sangue versato insieme per la causa della libertà
sia fecondo di più cordiale fratellanza tra i figli dello stesso paese, e gli eroici difensori
dello stesso principio.
I Polacchi sono di religione cattolica, e nel culto e nelle pratiche di tale credenza si
abbandonano ad un fervore, e a delle superstizioni che li rendono distinti dalle altre
popolazioni Nordiche. Sobrii, pazienti, frugali, indurati agli stenti ed alle fatiche essi
posseggono al pari delle altre schiatte slave quel coraggio passivo, che sa piuttosto
attendere con intrepidezza il pericolo, che affrontato con audacia; nelle prove più ardue,
nelle convinzioni più dilicate spingono la fermezza fino alla ostinazione ed alla immobilità.
Al pari di tutte le altre genti del Settentrione il loro vizio capitale è la ubriachezza, e per loro
sciagura fra tutte le bevande spiritose prediligono l’acquavite. Questa, come l’oppio pei
Chinesi, è il veleno del popolo polacco, poiché abitualmente ne tracanna una quantità
enorme.
La lingua Polacca tutta suoni fischianti è sorella della russa, della boema e delle wenda, e
noi avvezzi agli idiomi dolci e sonori germogliati dal greco e dal latino ci sentiamo
rabbrividire all’aspetto di quelle parole irte di consonanti accumulate intorno ad una
solitaria vocale. Tuttavia in bocca dei Polacchi educati e delle signore soprattutto, quella
lingua di raddolcisce e diviene graziosa, perché ad ogni tratto tra le consonanti
s’interpongono delle mute, che elidono le asprezza e modificano l’armonia del discorso.
Egli è con tale artificio che divengono pronunciabili moltissime parole polacche, le quali
vedute scritte minacciano le convulsioni ai muscoli della bocca.
La Russia, la Prussia e l’Austria, che in forza degli iniqui trattati del 1813 hanno potuto
spartirsi da buone amiche i brani della Polonia, esaurirono le risorse della politica per
snaturare quelle carpite provincie, e per assimilarle ai loro Stati. Tutti gli espedienti, tutte le
arti, tutte le perfidie si spuntarono contro la tenacità di quello spirito nazionale, cui la
natura sa conservare palese o latente nelle fibre di un popolo, quando essa lo ha creato
per vivere distinto e libero nel consorzio delle nazioni. Lo smembramento della Polonia fu
un delitto: coloro che osarono di farsene colpevoli e l’Europa che lo ha lasciato compiere,
non tardarono a sentirne le amare conseguenze. La Polonia è lo spettro di Banco, che
minaccia da quarant’anni la pace del nostro Continente.
I
L’Italia e la Polonia, nobili e sventurate nazioni eredi entrambe di una splendida rinomanza
nella storia del passato, e vittime entrambe di prepotenza di oppressori, come posseggono
incontestabile il diritto alla propria indipendenza, così hanno perduta mai una occasione di
far comprendere all’Europa, che non si rassegnavano a morire. Ma per loro sciagura
quando levavano la voce a domandare giustiza, o quando disperate tentavano di
rivendicare colle rivoluzioni la propria libertà, non potevano opporre che la storia e la
geografia a nemici, che possedevano baionette e cannoni.
E però risultato della lotta ineguale era sempre una nuova stretta di ceppi alle vittime
cadute, e la diplomazia ne’ suoi pensamenti d’ordine superiore ravvisava un male assai
più grave nel disturbo, che l’Italia e la Polonia recavano colle loro pretese alla pace del
Continente, che on nella violenza iniqua, colla quale codeste pretese venivano soffocate; e
posta quindi tra la forza ed il diritto la sentenza savissima, che dei due mali conveniva
scegliere il minore, traeva dal grembo dei Congressi la legge leonina dei trattati, che
sancivano allo spogliatore il godimento della preda.
Allora che l’Austria faceva scannare a fiorini contanti i nobili Galliziani in Lamberga e
Tarnow, e la Russia massacrava le disperse reliquie della insurrezione di Varsavia
popolando di patiboli le misere provincie a lei gettate fra gli artigli dai trattati del 1815,
l’Italia rispondeva ai gemiti della Polonia scuotendo per un istante la catena sul viso ai
proprii tiranni, od inviando qualche esule a pugnare da prode accanto ai prodi nipoti di
Kosciutsko. E quando in Italia il governo dell’Austria, e gli altri minori, che a lei facevano
da satelliti, non sapevano sostenersi con argomenti migliori, che non fossero quelli del
boia e del Santo Offizio, e i popoli per disperazione davan di piglio qua e colà alle armi, i
generosi figli della Polonia raminghi per l’Europa accorrevano a combattere sotto il vessillo
della libertà.
Ma gli sforzi magnanimi poco intesi e peggio assecondati dalle inconscie moltitudini,
maledetti dai ministri dell’altare, che avrebbero dovuto benedirli, avversati dalla
diplomazia, che ostentava tutte le sue tenerezze pei trattati e per la pace dell’Europa,
sorpresi e sopraffatti dalla forza prepotente erano spenti nel sangue prima che nati. Sulle
rive della Vistola, come su quelle più ridenti del Po e del Garigliano, a Varsavia e
Cracovia, come a Milano, a Torino, ed a Napoli la stessa mano di ferro iugulava il diritto, e
lo straniero con beffardo sorriso di compassione salutava l’Italia e la Polonia siccome terre
di morti. Fatua frase di ipocrita poesia, che bruciava incenso ad una politica egoista, nel
mentre questa era pur costretta a guardare con una selva di baionette i temuti cimiteri, e
tremava ad ogni sospiro di vento, che agitasse le ossa di coloro, ch’essa per ischerno
chiamava scheletri di popoli illustri.
L’Italia più fortunata si trovò nel 1859 pronta ed unanime all’appello di guerra, che partiva
dal Piemonte e dalla Francia. Un Principe soldato, una mente eccezionale, eserciti
agguerriti, duci maturati alla scuola delle battaglie, popolazioni entusiaste, connubio fatale
di valore, di senno, di eventi favorevoli poterono compiere il grande miracolo della
indipendenza italica. L’Europa attonita spettatrice di una tempesta, che non aveva
preveduta, vide come splendide fantasmagorie duegentomila Francesi con centomila
Italiani numerare colle battaglie le vittorie contro l’Austria, la sapienza politica di un uomo
trionfare di ostacoli creduti insuperabili, il genio eroico di un altro atterrare con un pugno di
volontari in quattro mesi un Regno, ventidue milioni d’Italiani stringersi con impeto
irresistibile intorno ad un Principe solo, e questo Principe assidersi benedetto e temuto
sulle reliquie di cinque troni atterrati dal popolo.
I fatti si erano compiuti colla rapidità del pensiero; l’Europa legale si trovò sbalordita
innanzi al dilemma di rassegnarsi a subirli, o di combatterli. Discordie negli intendimenti,
impacciata nella sorpresa, spaventata dal dubbio di una guerra senza fine, essa trovò
questa volta, che il male minore era quello di lasciar compiere all’Italia il suo destino; o
meglio forse, dissimulò i livori, e riconobbe il Regno d’Italia. Però le riserve e le restrizioni
tradivano il dispetto.
E per vero i tristi frutti dell’invidia degli stranieri, della rabbia del dispotismo, e della
corruzione seminata a larga mano dai tirannelli nostrani non tardavano a maturare, Roma,
chiusa ai voti dell’Italia dalle baionette francesi, divenne officina d’intrighi e nido di
sfacciata reazione contro il nuovo regno; Malta, Trieste, Venezia, Marsiglia, focolari
impuniti di cospirazioni, che non rifuggono di prezzolare assassini razzolati in ogni trivio
d’Europa; le provincie napoletane, campo designato alle imprese nefande di masnade
d’avventurieri, che colla croce in una mano e col pugnale nell’altra rubano ed ammazzano
invocando i Borboni e la Santa Sede.
In mezzo a tanti mali, che non tormentano l’adolescenza, quale compito rimane al Regno
d’Italia per raggiungere la pienezza della vita? Ecco l’arduo problema, intorno al quale si
affatica e viene a scindersi in due diverse correnti d’opinioni la gran massa della nazione.
A noi non fa d’uopo, dicono gli uni, che d’una prudenza pertinace a conservare quanto
abbiamo conquistato, e d’uno sforzo incessante per apparecchiarci a conseguire la
completa indipendenza. Unico quindi debb’essere e perseverante lo studio del governo
nazionale ad appianare la via, sbarazzarne gli ostacoli, a cementare la coesione delle
diverse parti del Regno, e ciò non potrà ottenersi che adoperando l’autorità della legge e
gli argomenti della forza là soltanto, dove falliscano tutte le probabilità della conciliazione.
Conteniamoci col potente e permaloso alleato in quel riserbo dignitoso che sia egualmente
lontano dalla umiliazione, e dalla arroganza: adagiamoci senza rumore e senza iattanza
nel consorzio delle potenze: non urtiamo di fronte le ardue questioni, che agitano l’Europa,
ma seguiamole con pacata attenzione, onde cogliere il destro di porvi la mano, e trarne
profitto: abbandoniamo in una parola, le sembianze ed il contegno della rivoluzione
serbandone intemerati i frutti e la fede.
Questi i principii, che informano la politica, queste le idee, colle quali si regge il governo;
idee e principii, innanzi ai quali molte prove fallirono, molte intelligenze vennero meno,
molte riputazioni fecero naufragio. Poiché dall’un lato vi sono le moltitudini che avvezze ai
miracoli dell’audacia e della forza, non sanno acconciarsi alla prudenza; dall’altro abbonda
l’elemento giovane inebriato dalla fortuna, a cui sembra egualmente possibile che
conveniente il troncare tutte le difficoltà con un colpo di sciabola. A questo elemento altri
argomenti non mancano per confutare la politica del governo nazionale. E a lui sorto dalla
rivoluzione vanno gridando, che triste ed umiliante confessione d’impotenza è il rinnegare
la propria origine, ed i porprii principii, che invocando oggi la legalità vale quanto il
rinunciare al possesso di Roma e di Venezia, vale quanto sconfessare il diritto che si
aveva di strappare la Toscana al Granduca, l’’Emilia ai Duchi ed al Papa, Napoli e Sicilia
ai Borboni; che una volta ferma la massima di tenere quello che si ha, non si sarebbe mai
fatta l’Italia com’è al presente, e non la si compierà mai quale debb’essere; che come sono
solidali tra di loro i despoti, così solidali debbono essere tra loro i popoli; che infine l’Italia
non potrà né consolidarsi né progredire alla sua meta se non coi mezzi audaci che la
rivoluzione insegna, e che valsero l’annessione delle Marche e dell’Umbria come quella di
Napoli e Sicilia.
Così colla mente fissa all’unico scopo di raggiungere la piena indipendenza della patria, si
dissente e si discute sui modi, e sulla via da tenersi. Di là i trabalzi, che a non lunghi
intervalli minacciarono di far crollare la giovane monarchia di Vittorio Emanuele; di là il non
sempre sincero, ma sempre vivo agitarsi dei partiti, che in nome della patria intendono gli
uni a spingersi troppo innanzi, gli altri a moderare più forse che non convenga. Solite
vicende della società umana, perché il coraggio e la prudenza sono due virtù, che stanno
agli estremi di una lunga catena, della quale un capo tocca la viltà, l’altro la follia.
Ma quando il grido della Polonia, che s’impegnava in un duello all’ultimo sangue contro il
colosso Moscovita, risuonò in tutta Europa siccome l’appello della vittima alle prese col
carnefice, in Italia si risvegliò colla simpatia un sentimento di dovere, perché qui v’era tutto
un esercito di gioventù coraggiosa a cui pesava sull’anima siccome un delitto un giorno di
tregue, e non obliava che sussistevano debiti di sangue da pagare all’eroica Polonia. In
fatto nel lungo e procelloso periodo di trasformazione politica della nostra patria noi
abbiamo trovato costantemente al fianco dei nostri soldati i figli generosi della Polonia, e li
abbiamo veduti combattere per la nostra indipendenza con quella lealtà e con quel valore,
che sono tradizionali in un popolo altrettanto prode quanto infelice.
Non era in questo paese che si potevano mettere in oblio i servigi che avevano reso, e le
ingiustizie che avevano patite i Polacchi fratelli d’armi coi nostri soldati. A.S. Fermo, a
Varese, a Marsala, a Palermo, a S. Maria, al Volturno, e più tardi nelle sanguinose fazioni
contro i briganti degli Abruzzi e della Basilicata non avevano diviso pericoli e glorie coi
nostri combattenti, e non ci avevano pagata a prezzo di sangue la ospitalità loro
accordata? Eppure l’Italia officiale, in un momento di colpevole egoismo scordando quanto
doveva agli ospiti innocenti, li aveva rimunerati cacciandoli dalla scuola di Cuneo, e li
aveva sacrificati ad un equivoco sorriso implorato dalla Francia alla Russia per puntellare il
Ministro Rattazzi.
Era dunque naturale che nel mentre la diplomazia d’Europa s’occupava con inusitata
solennità della questione polacca, ed in Francis, in Inghilterra, in Isvezia, in Italia, in
Ispagna colla stampa e colle adunanze popolari si propugnava la causa della Polonia,
sorgesse nell’animo alla gioventù più intrepida il desiderio di portare sulla Vistola un
soccorso più efficace, che non quello delle note diplomatiche, e dei voti di simpatia.
II
Francesco Nullo uno de’ più valenti ed arrischiati fra quei volontarii Italiani, che nel 1848 in
poi nonn mancarono mai ad una impresa, che si facesse in nome della libertà e della
indipendenza nazionale, era allora in Bergamo sdegnoso ed insofferente quanti altri mai
degli indugi, ai quali si trova incatenata la politica del nostro paese.
Non educato alle discipline militari, ma pieno dell’istinto della guerra, non potente
d’ingegno, ma infiammato da sentimenti generosi, ed intrepido come un cavaliere del
Medio Evo, Nullo non possedeva che quelle poche e maschie idee politiche, che non
vacillano innanzi ai sacrificii, e queste idee avea nell’animo salde come il suo cuore nei
cimenti, come il suo braccio nella pugna. Splendido tipo di quelle individualità eccezionali.
Che a guisa del fulmine non appajono se non quando l’atmosfera è profondamente
commossa dalla tempesta, egli non sapeva contenersi alle tranquille abitudini della vita
casalinga, dalle quali la rivoluzione lo aveva evocato. Impeto generoso di amor patrio lo
aveva balzato ancora giovinetto nelle commozioni politiche, e l’indole sua ardita e
sprezzatrice dei pericoli s’era ingagliardita in continue prove quasi sempre assecondate
dalla fortuna. Poiché semplice soldato nei primi moti del 1848, poi ufficiale dei volontarii
nelle ultime fazioni di quell’epoca disastrosa, quindi capitano sotto fli ordini di Garibaldi nel
1859, s’era acquistato il grado di maggiore, poi di tenete colonnello nell’esercito
meridionale, nelle cui file aveva combattuto da Marsala a Capua. La sua valentia
personale lo aveva fatto distinguere fra quegli audacissimi. Più tardi il suo nome fu ripetuto
nell’infausti episodio di Sarnico, e nella sciagurata tragedia di Aspromonte.
Non è dunque a fare le meraviglie se un uomo della tempera di Nullo commosso dalla
notizia degli avvenimenti, che succedevano nella Polonia, e convinto che pugnando per la
causa d’una nazione oppressa si pugnava per la causa d’Italia, siasi indotto a dare a suo
modo a quell’eroica nazione una testimonianza d’affetto e di gratitudine. Mentre altri le
prodigava più facili e più abbondanti colle poesie, colle concioni, coi voti di di simpatia,
colla borsa, egli pensò a raccogliersi intorno un drappello di amici animosi al par di lui, e di
portare ai Polacchi l’ajuto più efficace della spada.
Entrato in questo divisamento e fattane confidenza coll’amico Luigi Caroli si accinsero
insieme a maturarne prontamente la esecuzione. I primi chiamati a parte del segreto
furono il D.r legale Emanuele Maironi, ed il D.r fisico B……. P….., questi già Medico di
Reggimento nell’esercito meridionale, quegli Capitano nell’esercito istesso. In seguito
s’aggiunsero Mazzoleni Paolo, Marchetti Elia, Sacchi Ajace, Venanzio Alessandro,
Cristofori Giacomo, Arcangeli Febo, Testa Luigi, Giupponi Ambrogio, Pattelli Settimio,
Dillani, Isnenghi, Bellotti, Maggi e Calderini tutti di Bergamo, e tutti già sperimentati per
animo risoluto, e per valore non equivoco nei rischi della guerra. Correva il mese d’Aprile.
Ma alla difficilissima impresa di guadagnare a sì enorme distanza i confini della Polonia, e
di annodare qualche filo di corrispondenza con taluno dei capi di quella insurrezione,
perché fosse designato il posto alla schiera degli Italiani, molti e gravi ostacoli si
affacciavano. La via più breve, ma la più repugnante a tutti per giungere al territorio
polacco era quella di attraversare Venezia, e la lunga linea delle provincie austriache da
mezzodì a settentrione per Trieste, Vienna, e Cracovia. Ma come tenere celato il disegno
fino a che, non si fosse d’un gran tratto inoltrati al di là della frontiera del Mincio vigilata
dagli occhi d’Argo del governo Austriaco? Come trovar modo di scivolare inosservati in
mezzo alla rete della gelosissima polizia austriaca trattandosi di individui noti i più, e Nullo
segnatamente, siccome arditissimo fra quei volontarii Italiani, che dal 1848 in poi s’erano
levati contro l’Austria e l’avevano combattuta senza posa fino al 1859?
Un altro incidente sopravveniva a far vacillare l’ardimentoso progetto. Un compagno d’armi
di Nullo, ed amicissimo suo, il Maggiore Francesco Cucchi, recatosi poco tempo innanzi a
Caprera presso il Generale Garibaldi aveva con esso fatto cenno di ciò che a Bergamo si
aveva in animo di tentare per la causa polacca. Ma con sorpresa avea udito che l’illustre
veterano della libertà non vedrebbe di buon occhio una simile impresa, poiché gli pareva
che scarso e forse non gradito ajuto avrebbe recato alla nazione dei Polacchi, ed era suo
desiderio che giovani intrepidi, come Nullo ed i suoi compagni, serbassero per l’Italia le
ultime prove del loro valore.
Più tardi, e quando il drappello dei fidi amici s’era già molto infervorato nel proposito di
avventurarsi nella impresa, Nullo, che al generale Garibaldi si teneva legati di una
devozione tutta speciale, non sapeva determinarsi a partire senza un consiglio, od almeno
una parola di conforto del suo maestro sui campi di battaglia, e quindi a lui scriveva da
Bergamo espressamente aprendogli l’animo suo. Ma la lettera pervenuta, e trattenuta in
altre mani, non si ebbe risposta. Laonde Nullo o stizzito di un contegno, che credeva di
trovar ben diverso, e che gli riusciva molto strano, o più probabilmente venuto in sospetto,
che non senza motivo il generale Garibaldi affettasse il silenzio, vinse ogni esitazione, e
decise di partire.
Tutto dunque apparve, e si credette appianato innanzi ad animi infiammati da un’idea
generosa e fermamente deliberati. Di danari non fu più oltre questione dappoiché Nullo, e
pochi altri ne aveano del proprio, e per chi non ne aveva provvide largamente la pingue
borsa di un amico. Poco prima della partenza venne a congiungersi coi Bergamaschi un
Cattaneo del Cantone Ticino. Era questi un abile bersagliere vago di liberali imprese, e di
questa più d’ogni altra: pochi mesi addietro avea lasciata l’America, dove teneva il grado di
uffiziale sotto gli ordini del generale Frèmont.
Fu stabilito: si cercherebbe di guadagnare la frontiera di Polonia per la via dell’Austria; la
Città di Cracovia punto di convegno per tutti e pel primo di Maggio; si partirebbe da
Bergamo sulla fine di Aprile con regolari passaporti sotto pretesto di traffici, o di diporto;
divisa la compagnia in piccoli drappelli fino a Cracovia; ogni drappello formato di non oltre
ai quattro individui; Nullo preverrebbe la comitiva a Cracovia.
Dovevano essere in numero di 20; ma due vennero trattenuti da circostanze di famiglia.
Primi a staccarsi da Bergamo furono, dopo Nullo, Pattelli, Marchetti, Venanzio, e Giupponi.
Ultimi Caroli, Maironi, Sacchi, e Cattaneo.
Pervenuti a Peschiera, dove l’Austria fa villanamente spiare e frugacchiare sulla persona
d’ogni viaggiatore nel dubbio, che questi sia lì per introdurre ne’ felicissimi dominii la
rivoluzione involta in un portafogli, o cucita nella suola delle scarpe, subirono il solito
interrogatorio del guarda-confine, ma furono senz’altro lasciati passar oltre.
Soltanto per Luigi Caroli, e per Nullo la cosa non passò liscia, come per gli altri. Caroli
parve al caporale austriaco una figura malintenzionata; aveva due occhi irrequieti che
mettevano dei fondati sospetti sul conto suo; dovette quindi lasciarsi tirare entro uno
stanzino, spogliarsi di tutti gli abiti fino alla camicia, e farsi palpare anche le carni per
convincere quello zelante funzionario, che sotto la pelle non nascondeva nulla, che
minacciasse la salute dell’impero austriaco.
Nullo co’ suoi baffi enormi, col suo piglio soldatesco, e forse più che altro segnalato dal
proprio nome le tante volte ripetuto nei casi di Sarnico e di Aspromonte, mise in suspicione
gli i.r. cagnotti della polizia di Venezia. Non si rifniva di guardare lui ed il passaporto, e
quegli oculati signori sentivano per istinto che colui doveva essere un pesce grosso; ma il
passaporto diceva assai chiaro che si trattava di un negoziante di tele, e udito poi dalla
sua bocca com’egli non fosse che un lontano parente di quel tale Nullo garibaldino il cui
nome loro irritava i nervi, non cercarono più altro, e lo lasciarono andare.
A Vienna non fu loro difficile perdersi inosservati in quell’ammasso di abitazioni e di
abitanti: qualcuno invitato a presentarsi all’ufficio di Polizia fece il sordo e non vi andò per
nulla. Tutti in breve partirono per Cracovia, dove si raccolsero sani e salvi negli ultimi
giorni di Aprile. Durante il tragitto avevano potuto accorgersi dalla fisionomia dei paesani,
e dal brulichio continuo di soldati d’ogni colore, che entravano in un paese inquieto: tutta la
zona di provincie dalla Vistola alle pendici dei Carpazii sentiva il contraccolpo della
rivoluzione della Polonia.
A Cracovia furono colpiti dall’aspetto straordinariamente animato della sacra città slava,
che parea rinata alla antica vitalità Repubblicana, se i ceffi numerosi dei soldati dell’Austria
non fossero stati là a ricordare, che la Repubblica innocente era stata strozzata dall’aquila
bicipite. E cosa strana! Cracovia era gremita di giovani Polacchi venuti dalla Gallizia e dal
Posen, di volontari francesi, alemanni, inglesi, italiani, di agenti e spie delle polizie
austriaca, e russa, le quali probabilmente facevano affari insieme, eppure pochissimi allora
fra tanti stranieri venivano ricercati dell’esser loro. A niuno certo cadrà in mente di
affermare, che quelle vecchie volpi sguinzagliate da due governi, potessero illudersi sul
vero scopo, che conduceva in Cracovia si folta moltitudine di negozianti e di viaggiatori.
Per verità visite, perquisizioni, arresti accadevano del continuo il dì e la notte dentro gli
alberghi, e nelle case dei privati, e queste pratiche costituzionali dell’Austria ringiovanita si
eseguivano coi modi soliti dell’Austria vecchia, cioè con burbanza sbirresca, e con
imponente apparato di gendarmi e soldati con bajonetta in canna, ma era evidente nelle
autorità imperiali la ostentazione di cogliere dei forestieri l’uno su cento così a casaccio e
con solennità studiata. La stessa ipocrisia era legge per le truppe, che in grosse schiere
guardavano la frontiera della Polonia. Un numeroso stuolo di volontarii, che violasse il
confine austriaco verso il teatro della insurrezione non trovava quasi mai ostacolo, perché
gli i.r. soldati non si davano per intesi di nulla; ma questi agguantavano inesorabilmente, e
rinviavano a Cracovia incatenato chiunque tentasse da solo la frontiera. Quando infatti i
volontarii adunati sotto il comando del colonnello Nullo entrarono nel territorio polacco
sommavano a 300 uomini all’incirca, e tutti assai bene vi riuscirono spartiti in frotte di 30 a
50 individui ciascheduna; un Bergamasco per nome Dilani, che staccatosi per le sue
occorrenze dalla propria brigata s’accingeva a passar oltre pochi minuti dopo de’ suoi
compagni, venne trattenuto e fatto prigioniero. Da ciò si vede, che l’Austria volea mettere
in serbo delle buone ragioni, che potessero valerle al caso per farsi un merito colla
Polonia, e per guadagnarne altrettanto colla Russia.
Allora che vi giunse il colonnello Nullo si trovavano già in Cracovia il noto generale polacco
Mierolawsky ed il signor Rochebrune francese, che si faceva chiamare Colonnello, ed era
stato un tempo uffiziale in un reggimento di Zuavi.
Ambedue quei signori s’intrattenevano in Cracovia collo scopo di raccogliere volontarii, e
di porsi alla testa di una spedizione; ma pare che fra loro non regnasse né armonia di
intendimenti, né confidenza alcuna, poiché facevano a gara nel rubarsi i solfati da
comandare. Quanto poi a questi soldati, che la massima parte erano giovanetti polacchi
frammisti a dei volontarj venuti di Francia, e che volevano ordinarsi in battaglione di Zuavi,
non inclinavano che in picciol numero ad obbedire al Mierolawsky, uomo che sembra
trascinato dal destino a fare il guastamestieri in tutte le faccende, nelle quali s’immischia, e
pur troppo s’immischia, in molte.
L’arrivo inaspettato del Nullo cogli Italiani fe’ scomparire le gare fra i due ufficiali: tutti i
volontari polacchi e francesi vollero mettersi sotto la direzione del prode garibaldino, e dei
due generali rimasti ipso facto senza soldati, il Mierolawsky si tenne in disparte, ed il
Rochebrune non si lasciò più vedere.
Fu allora che si pose ai fianchi di Nullo, e seppe cattivarsene la confidenza un altro
uffiziale Polacco per nome Miniewsky, il quale con abnegazione, che fece strabiliare i suoi
amici si dichiarò pronto ad ubbidirgli in qualità di Capo dello Stato Maggiore. Connubio era
questo di lieti auspicii, poiché alla rinomanza, all’impeto cavalleresco, ed alla intrepidezza
di Nullo venivano ad accoppiarsi le maggiori cognizioni strategiche, e topografiche, e
l’influenza locale dell’uffiziale Polacco.
Dalla sua condotta si volle argomentare in seguito che Miniewsky avesse abbandonato in
modestia, perché tali fossero gli ordini che aveva ricevuto dal Comitato nazionale.
Tutti quei giovani condensati nella Città di Cracovia deludevano la vigilanza pur sempre
sospettosa ed iraconda del governo austriaco, ed allestivano i loro apparecchi guerreschi
quasi sotto gli occhi del nemico sia per l’aperta connivenza dei cittadini, sia mescolandosi
e tramutandosi di continuo dall’uno all’altro quartiere della città popolosa, i due Capi Nullo
e Miniewsky, sui quali s’aveva a ritenere rivolta di preferenza l’attenzione degli spioni
imperiali, alloggiavano in case private e non passavano mai dodici ore di seguito nella
stessa abitazione. Tutti gli altri loro compagni d’armi disseminati a brigatelle in diverse
località, si tenevano anch’essi in moto continuo per non offrire campo di indicazioni esatte
sul conto loro, ed attendevano con impazienza l’ordine di spingersi al di là della frontiera. Il
Comitato occulto, figlio del Comitato nazionale di Varsavia, assisteva colle provvidenze
necessarie tutte queste genti.
Esso per mezzo di Miniewsky aveva proposto al colonnello Nullo il comando di una
legione di 500 combattenti, dei quali 400 Polacchi, 70 Francesi, 25 Italiani, con 40 cavalli,
e tre cannoni da campagna. Udite le condizioni, stabiliti gli accordi, Nullo accettò.
Designata alla partenza fu la notte del 1 al 2 Maggio. Parecchie Casse con entro coperte
di lana, sciabole, armi corte da taglio e da fuoco, cappotti, camicie rosse per gli Italiani,
erano state inviate da Cracovia oltre i confini. Si sapeva che in un punto stabilito al di là
della frontiera si erano apparecchiati i fucili e le munizioni per tutta la legione, non ché i
cavalli e i tre piccoli cannoni da campagna. Molti cittadini polacchi che dai modi e
dall’aspetto signorile appartenevano senza dubbio ad una casta elevata, e che usavano di
molta circospezione perché sudditi austriaci o prussiani, apparivano del continuo
frammezzo ai giovani volontarj prodigando loro ogni dimostrazione d’affetto e di cortesia.
Diciamo i giovani volontarii, perché fra i polacchi principalmente erano moltissimi gli
adolescenti, che non toccavano i quindici anni, e v’avea di quelli che erano tuttavia fanciulli
dagli undici ai dodici, o faceano sforzo a reggere il fucile.
Il 29 Aprile, nell’Hotel Dresda procedeva la polizia austriaca ad una minuta perquisizione,
la quale finì coll’arresto immediato di Calderini, Isnenghi, Belotti e Maggi. In quel dì stesso
la mattina per empissimo un altro cagnotto della pubblica sicurezza si presentava all’Hotel
Saxi, dove erano alloggiati Maironi, Marchetti, Caroli, Sacchi, Cattaneo, il conte Laderchi,
ed il suo compagno Parazza di Faenza. Portava ordine che tutti quei signori si recassero
all’indomani all’Ufficio della Polizia per la consegna e l’esame dei loro passaporti.
L’impiegato faceva notare con una urbanità alquanto affettata, che era già la seconda
volta che gli italiani ricevevano un simile invito, poiché al primo si erano dimenticati di
obbedire.
Veramente la tentazione di commettere una seconda disubbidienza sussisteva tutta intiera
anche di fronte al novello invito. Ma pure temendo di peggio, ed affidatisi che
presentandosi con franca disinvoltura alle ingiunzioni di chi comandava, non sarebbero
incappati in altro disturbo, che in quello di improvvisare qualche fanfaluca per uso della
polizia austriaca, Maironi, Laderchi, Parazza, Sacchi, Cattaneo, s’introdussero a cadere
spontaneamente nel laccio. Poiché varcate le soglie del palazzo di Polizia, e subito un
inutile interrogatorio, mentre s’avviavano per uscire si trovarono ai fianchi parecchi
galantuomini vestiti in abito borghese, i quali gentilmente disser loro, che dovevano sotto
la propria responsabilità accompagnarli a Vienna. Una tale responsabilità nel gergo di quei
satelliti significava senz’altro, che chi avesse in animo di fuggire sarebbe stato
immediatamente provveduto di manichini ai polsi e trattato da malfattore.
Fu adunque per lo meglio il fare di necessità virtù, ed incamminarsi alla stazione della
ferrovia con quegli angeli custodi al fianco, che arrivati a Vienna si scambiarono con altri, e
così a Trieste, e Venezia e quindi a Peschiera, dove i prigionieri toccarono la libera
atmosfera del Regno Italico. E qui dobbiamo asserire ad onor del vero, che ci consta non
esser punto né poco esatto quanto venne detto e ripetuto da molti giornali in proposito al
Conte Laderchi. Il Conte Laderchi e l’amico suo Parazza si mossero alla volta della
Polonia non per sentimento religioso, ma per sincero affetto alla causa della libertà, per la
quale essi non temevano di combattere e morire, come si combatte e si muore in Polonia
e in Italia. Questi due giovani distinti per natali e per nobiltà d’animo venivano accettati in
qualità di ufficiali di Stato Maggiore dal Generale Nullo. Il Conte Laderchi ci saprà grado,
non ne abbiamo tampoco il dubbio, se affermiamo esplicitamente ch’egli non andava in
Polonia a fare il missionario, ma il soldato.
Dicemmo che il francese Rochebrune s’era trovato in Cracovia col Nullo. Ora giova
soggiungere che fra loro corsero delle trattative per operare insieme, e pare anzi che
l’uffiziale degli Zuavi si fosse lusingato di avere sotto i suoi ordini il prode italiano co’suoi
connazionale. Ma Il Nullo o perché amasse meglio di rimanere indipendente o perché
fosse già in diversi accordi col Comitato segreto di Cracovia, non accolse le proposizioni
del Rochebrune. Di qua probabilmente ebbe origine il fatto spiacevole, che i volontarii
francesi si ricusarono a partire in compagnia degli italiani e dei polacchi comandati da
Nullo, mentre a questi il Comitato aveva promesso, che si sarebbero mossi insieme.
Corse poi voce tra i volontarii, che non si fosse dimenticato di portar seco una grossa
somma di danaro. Se ciò fosse vero, e se il Rochebrune si tenesse con fucile coscienza
della pecunia non sua noi non sappiamo. Vogliam concedere piuttosto che in Cracovia
non sarà mancata della buona gente, che pagata dai Russi a seminare zizzania fra i
volontarii, non avrà esitato a soffiare calunnie contro i più eminenti ed i più ragguardevoli.
Il distacco dei Francesi, e la perdita dei dieci italiani Maironi, Cattaneo, Sacchi, Calderini,
Maggi, Bellotti, Isnenghi, Dilani, Laderchi, Parazza, arrestati dalla polizia di Cracovia,
parve a Nullo di cattivo augurio, e non seppe dissimulare a’ suoi più fidi il suo dispiacere,
ma d’animo deliberato, com’egli era, non volle per questo frapporre indugio alle mosse, e
così com’era prestabilito, la notte del 1° Maggio egli con tutta la sua gente uscì dalla città,
e pigliò la direzione di tramontana. Maestro attraverso alle tristi pianure, che vanno
rilevandosi con facile pendio dal bacino della Vistola dirimpetto al palatinato di Saudomir.
Camminarono tutta notte, e verso le tre del mattino raggiunsero un’ampia foresta di pini,
dove avevano a prendere riposo, ed armarsi. Era giorno di Domenica. Il Comitato segreto
di Cracovia faceva onore alle sue promesse: poiché in quella foresta stavano pronti fucili,
pistole, armi bianche, e quanto occorreva al bisogno di tutta la legione abbondantemente.
Solo mancavano i cavalli per trascinare i tre cannoni, imperocché i due, che s’avevano
bardati espressamente per essere attaccati ai carri non potevano bastare, e per la
deficienza dell’attelaggio non si potevano far correre all’uopo quelli dello scarso squadrone
di cavalleria.
Il piccolo campo avea subitaneamente pigliato l’allegra e balda fisionomia del teatro di
guerra dove la razza umana spensierata dell’incerto domani si compiace tanto di mescere
tutti gli orrori della tragedia, colle gioje della commedia, e le follie dei baccanali. Nullo da
quel vagheggiato spettacolo battagliero sentiva ingigantirsi l’anima nel petto: quelle
solitudini mute da tanti anni risuonavano ad un tratto degli inni nazionali della Polonia e
dell’Italia.
Turbavano però quelle gioje parecchi disordini, e primo fra tutti era la mancanza d’ufficiali.
Trecento Polacchi non avevano che un alfiere, giovane valoroso e pratico del mestiere
delle armi, ed il colonnello Sasky, prode e colto uffiziale, ma solo, i cui comandi fossero
intesi da’ suoi connazionali. Nel piccolo drappello degli Italiani abbondavano coloro, che
avrebbero saputo sostenere egregiamente la parte di uffiziali, ma di loro niuno sapeva una
sillaba di lingua polacca, pochissimi conoscevano la francese, e Nullo istesso era il più
delle volte costretto a far comprendere i suoi ordini per via di cenni e gesti.
Non tardò a manifestarsi un disordine più grave. Il Sig. Miniewsky respirando l’aura dei
boschi sentì crescersi in petto tutta quella confidenza di sé medesimo, e quella voglia di
fare il generale in capo, che parea dovesse aver lasciato a Cracovia, quando accettava di
porsi sotto gli ordini di Nullo. Il suo contegno si fece altiero, e pesante al segno, che molti
dei Polacchi, e tutti gli Italiani incominciavano a trovarlo isoffribile: il suo merito, che poteva
esser molto e distinto, non sembrava da accettarsi incontestabilmente, giacché lo stesso
Comitato segreto non l’avea riconosciuto superiore a quello di Nullo: si cominciava dunque
a mormorare, e Miniewsky, che di ciò s’era accorto, per farsi valere di più faceva peggio.
Ma Nullo ebbe la prudenza di non fomentare uno screpio, che poteva mettere in pericolo
la salute di tutti, riserbò a miglior tempo di far trionfare il suo diritto, persuase i suoi
compagni della necessità di non dar luogo a dissensioni in sugli esordii dell’impresa, e per
parte sua si accontentò di essere il colonnello della legione straniera forte in tutto di 26
uomini, dei quali diciassette Italiani, sei Francesi, e tre Ungheresi.
Consumata la Domenica nell’armarsi, nel comporre gli ordini delle diverse schiere, nel
riposare i corpi della lunga marcia, al cader del sole si rimisero in viaggio. Le guide,
paesani del luogo forniti dal Comitato di Cracovia, additarono un lungo giro ed assai
vizioso sempre nei piani al di qua della Vistola, e ciò era necessario per passare la
frontiera senza incontrarsi da una parte coi soldati dell’Austria, dall’altra colle colonne
mobili dell’esercito Russo.
Circa le ore due del mattino guadagnarono il territorio polacco: varcarono, come abbiamo
detto, la linea dei confini, a piccole schiere: gli Austriaci non diedero disturbo di sorta: solo
il milite Dilani, ch’era rimasto indietro dalla sua comitiva, venne arrestato e rinviato a
Cracovia. Una selva era il prestabilito luogo di convegno per tutti, ed in breve vi
pervennero stanchi, ed intirizziti dalla fredda ed umida aria della notte carica di masse di
nebbia. Albeggiava.
Si erano collocate le scolte: le diverse compagnie si distribuivano ai loro posti, poiché
Miniewsky voleva facesse in quella selva una fermata di parecchie ore, e ciò contro
l’opinione di Nullo, al quale pareva che si dovesse pigliare il largo, più ch’era possibile,
nell’interno del palatinato di Sandomir, poiché le truppe Russe erano condensate in grosso
numero verso i confini di Cracovia e della Gallizia.
Questa volta però sembra che meglio si consigliasse Miniewsky, il quale aveva capito, che
il procedere più innanzi a marcie forzate con volontarj rotti dal sonno, dalla fatica e dal
digiuno, era un voler pretender troppo.
Ma nel mentre i volontarj si coricavano incominciò un lontano rumore di colpi, poi distinta
si fece udire la fucilata a tramontana del bosco. Sono i Russi. Si grida l’allarme. Un
miserabile contadino, che alzava altissime strida, viene a rifugiarsi nella selva, ed è
tradotto innanzi agli ufficiali. Esso aveva un braccio fracassato da un colpo di calcio di
fucile, e la faccia orribilmente spaccata dalle sciabolate dei Moscoviti, poiché lo avevano
sospettato un esploratore al servizio degli insorti.
Udito che parecchie compagnie di fanti Russi venivano in ricognizione alla volta della
foresta, Miniewsky comandò si partisse immediatamente. Si marciava di buon passo per
sortire all’aperta campagna, dove gli alberi non impedirebbero di scorgere da qual parte,
ed in qual numero si avanzassero i nemici; ma i volontarii, ed i giovanetti specialmente
non reggevano a camminare, tanto erano abbattuti dalla stanchezza. A ciò s’aggiungeva
la fame, poiché dalla prima sosta in poi non si avea potuto a saputo trovar cibo, e troppo in
fretta si erano smaltite le magre provvigioni, che ciascheduno si portava seco da Cracovia.
Ma le boscaglie non si diradavano, e si estendevano nel paese per una tratta immensa,
laonde dopo due ore di cammino si fece un nuovo alto per concedere alquanto di riposo, e
per mandar fuori in diverse direzioni degli stracorridori. Ed ecco ad un tratto si risveglia
non lungi lo spesseggiare delle archibusate, e si veggono spuntare a tiro di palla gli anti
guardi delle schiere Russe, le quali procedevano lentamente, ma guadagnando terreno ad
ogni momento. Miniewsky e Nullo non sapendo se avessero a che fare con un grosso
corpo, o con una squadra volante di nemici, fecero un movimento obliquo verso destra per
evitare un subito scontro: quindi staccarono in ricognizione una compagnia di cento
Polacchi comandata da un Capitano e da un Luogotenente. Non c’incresce d’ignorare i
nomi di questi due vigliacchi, i quali colsero il destro di allontanarsi per sempre, e
passarono con tutta la compagnia nella Gallizia.
Frattanto Miniewsky si raccoglieva sopra una specie di collina poco alta, ed ignuda affatto
di ogni vegetazione, ed impartiva le disposizioni per aspettare su quella eminenza l’assalto
delle truppe Russe. Gli Italiani ebbero l’onore di vedere a loro affidata la bandiera della
Legione. Tutto all’intorno a quel simulacro di banco di sabbia sporgente correva una vasta
landa isterilita senza vestigia di strade, di coltura, o di abitazioni umane. Qua e colà, e
lungo le rive di qualche umile torrente si vedevano larghe macchie di alberi resinosi, e
quell’insieme di natura triste e desolata, di pini e di cipressi dava agli Italiani l’immagine di
un immenso cimitero.
Nullo giudicava la posizione scelta da Miniewky assai pericolosa, ed impossibile a
difendersi, perché troppo esposta da tutti i lati ai colpi del nemico, e ad essere chiusa in
mezzo da’ suoi numerosi battaglioni. Forse egli preferiva secondo la sua audace natura di
avventarsi nel piano, ed urtare uno dei fianchi ai Russi per romperne le file, e passar oltre.
Infatti i Russi non tentarono l’assalto; pure continuarono un fuoco di moschetteria assai
vivo per quasi tre ore, ed avrebbero recati gravissimi danni, se la cacciata dei loro fucili
avesse spinto i proiettili fino alla sommità della collina.
Il solo dubbio però, che potessero colpire avea bastato perché molti dei volontarii Polacchi
novizii affatto ai pericoli delle battaglie si sbandassero. Laonde Nullo, che si rodeva di
starsene inerte col suo drappello a numerare i colpi del nemico, insisteva presso
Miniewsky, perché si levasse da quella sciagurata posizione, dove si sprecava tempo
senza far nulla, e col rischio di rimanere avviluppati. – Abbiamo, diceva co’ suoi, dieci feriti;
il colonnello Sasky è quasi senza soldati, da un momento all’altro può sbucare da questi
boschi un battaglione, che abbia avuto tutto il tempo di contarci ad uno ad uno in questo
maledetto pulpito; io non so che modo sia questo di far la guerra! – Nullo aveva il torto di
credere che nel corpo di Miniewsky vi fosse l’anima di Garibaldi, o di Bixio, o di Medici, o
d’altri di quella stoffa.
Il suo presentimento non l’avea ingannato. Assai vicino al colle s’innalza da un bosco uno
strepito d’armi, di grida soldatesche, poi una fitta fucilata. I pochi lancieri a cavallo, sedici
fra tutti, retrocedono a briglia sciolta: i pochi fanti polacchi, ad onta del coraggio del loro
colonnello Sasky, e de’ suoi sforzi per trattenerli fuggono dalla parte opposta: non
rimangono che i Francesi, gli Italiani, i quali con Nullo alla testa si spingono animosamente
contro il nemico.
Ma il nemico protetto dagli spessi tronchi degli alberi scomparve rapidamente, né si pochi
potevano avere la temerarietà di correrne in traccia negli inesplorati labirinti di una foresta.
Reduci presso Miniewky, il quale s’affaticava a riannodare le smarrite file, e consultarsi
insieme sul partito a cui appigliarsi; si delibera di sloggiare da que’ luoghi, e di cercare una
strada per trovare villaggi, in cui provvedersi di viveri. Quasi tutti da trent’ore non avevano
mangiato.
Le strade, se quelle poteano meritare un tal nome, erano orribili. Bisognava camminare
sopra uno strato di sabbia minutissima e pulverulenta, in cui la gamba fondava sino al
garretto. Ad intervalli il terreno era tagliato da filoni d’una terra rossiccia, inzuppata di
acqua, e tenacissima la quale impaniava i piedi. Si camminava, si camminva ora in una
landa, che si perdeva coll’orizzonte nebbioso, ora in mezzo a foreste di pini, e l’occhio non
era confortato mai dall’aspetto di campi o di case, che dessero segno di creatura umana.
I cavalieri polacchi formavano l’antiguardo. Il centro della colonna, colla quale si tenevano
Miniewsky e Sasky, era tutto di polacchi. Nullo, pregatone da Miniewsky, stava co’ suoi
alla retroguardia, onde tenere in rispetto coloro, e pur troppo erano molti, che
manifestavano intenzione di disertare. Il solo carro che si possedeva, tirato da due cavalli
era carico di fucili e di falci, e sopra queste armi sdrajati, ora nel fango, e mosso da due
povere bestie affrante dalla stanchezza e dalla fame, procedevano a stento: altri cavalli
non si potevano assellare, perché all’uopo mancavano cinghie e funi. Fu peggio quando si
giunse là dove il terreno bruscamente rialzandosi a pendio era mestieri trascinare a forza
di braccia e carri e cavalli. Importava guadagnare tempo ad ogni costo, e bisognava
consumarlo in fatiche improbe ed incessanti. Frattanto gran numero di que’ giovanetti
polacchi vinti dal disagio si lasciavano cadere lungo la strada preferendo a tanti patimenti
l’incertezza di cadere in mano ai Russi: altri si disperdevano tra le selve.
Tutte queste cose scuotevano la fiducia anche negli animi più saldi. Richiesto Miniewsky
del dove si anderebbe a far capo, rispondeva di non saperlo egli stesso. Le mormorazioni,
sintomo foriero d’indisciplina e di disordine, si facevano ad alta voce: era facile a
prevedersi, che in breve la legione si sarebbe disciolta. In que’ frangenti fu mirabile la
costanza di Nullo e de’ suoi compagni italiani e francesi, ed anche al colonnello polacco
Sasky si deve giusta lode di coraggio e di imperturabilità. Caroli, Marchetti, Mazzoleni,
Borgia, Clerici italiani, un alfiere polacco del quale assai ci duole di non aver potuto
rilevare il nome, Didier francese, furono sopra tutti instancabili a coadiuvare Nullo e Sasky
per rinfrancare gli animi dei volontarii, e mantenere l’ordine nelle pur troppo diradate file.
Miniewsky avrebbe fatto assai meglio a rimanersi in Cracovia.
Superata la collina entrarono verso le cinque ore in una cupa boscaglia, e poiché per
momento il più urgente bisogno era di riposarsi e dormire, si fece alto. Ma un destino
inesorabile pesava su quella falange sciagurata. Sonnecchiavano appena i volontari
abbracciati coi loro fucili, quando a breve distanza incominciarono le archiubugiate: pareva
che i soldati della Russia nascessero dalla terra dietro i passi degli insorti. Si corre a
spiare sul limite della foresta, e si veggono le bajonette dei Russi luccicare sopra lunga
linea tra le macchie, ed i cespugli di altro bosco non lontano. Più a tramontana indistinto
rullare di tamburi è segnale che altri nemici vengono a quella volta.
I patimenti, la rabbia, la disperazione reagirono sugli animi affranti. In un baleno con tutti
levati per combattere. Nullo sentì ribollirsi nell’anima le rimembranze di Palermo e di
Milazzo, e scorrendo a cavallo tra le file gridava: salviamo l’onore, combattiamo fino alla
morte! E diceva queste fiere parole a Miniewsky principalmente quasi per rammentargli,
che non avrebbe ubbidito ad un nuovo comando di aspettare il nemico colle armi al
braccio.
Il campo degli insorti era così deposto, che avea alle spalle e sulla destra la fitta ed ampia
foresta, di fronte ed a sinistra un largo fosso o letto di torrente asciutto, di cui la riva
opposta si levava a guisa di argine, e copriva fino all’altezza delle anche i soldati. Al di là
dell’argine correva una tratta di terreno piano ed arenoso della larghezza di circa duegento
metri; più oltre spuntavano le macchie nane di un’estesa boscaglia senz’alberi, in mezzo
alla quale col solito passo lento e sempre sparando si avanzavano i fanti Russi.
Rilevata con un’ardita ricognizione la condizione topografica del terreno, e la posizione del
nemico, il colonnello Nullo si confermò nel suo giudizio, che unico spediente era quello di
sgomentare i Russi coll’audacia, e di aggredirli con una carica impetuosa alla bajonetta.
Egli lo sapeva per esperienza, come tutti i capi di guerriglia sanno per istinto, che le masse
compatte e pesanti degli eserciti regolari non si vincerebbero meglio, che
scompaginandole con urti audaci ed eccentrici alla bajonette. È ben raro che alla furia di
un’aggressione ardita di corpo a corpo resista la geometrica disposizione dei quadrati, e
dei battaglioni.
Miniewsky, che gustava con tanta voluttà il titolo di generale, s’avrebbe a giudicare in
questa occasione un pover uomo di corto insediamento, e di coraggio assai limitato, il
quale forse non avea avuto agio mai di riflettere seriamente, che quando si assume la
terribile responsabilità di fare il generale, non basta provvedersi di buone intenzioni.
Fortunatamente la reputazione del suo paese riposa su ben altre prove d’intelligenza o di
valore! D’altronde per sentimento di giustizia noi dobbiamo dire schiettamente, che
pronunciamo a malincuore un giudizio si sopra fatti e cose, che forse non conosciamo in
tutta la loro luce istorica. Abbiamo udito le accuse contro un uomo, ma non le sue difese, e
desiderando di gran cuore ch’egli ne abbia di inespugnabili, continuiamo a narrare.
Rintanato col grosso delle milizie entro la selva, tutto il moto che si dava a Miniewsky, era
di contemplare col cannocchiale le evoluzioni dei Russi, avvertendo, ben inteso, che un
grosso albero gli facesse scudo alla persona contro le palle, che fischiavano tra le fronde.
Nullo, che cola sua squadra non s’era mosso dagli avamposti, inviò il suo ajutante Caroli a
significargli la sua intenzione di tentare l’assalto alla bajonetta; lo pregava inoltre che
quando lo avesse veduto montare a cavallo al di là dell’argine, desse il comando a’suoi
Polacchi di spingersi bravamente innanzi, e di secondare l’offensiva. Miniewsky non si
mosse dal suo albero, ma rispose che farebbe.
L’eletta schiera degli stranieri, che obbedivano direttamente al colonnello Nullo, si dispose
lungo l’argine al di là del torrente: sulla sinistra si apprestò con una compagnia di Polacchi
il colonnello Sasky, il quale abile ed intrepido veterano si crucciava al pari di Nullo, che i
soldati male ubbidissero all’ordine ripetuto di non sprecare inutilmente i colpi rispondendo
al fuoco dei Russi, e di serbare una scarica improvvisa a bruciapelo quando fossero a
breve distanza dal nemico.
Si fu allora che Nullo parve dominato per un istante da un triste presagio; era sopra
pensiero, e voltosi a’ suoi amici disse crollando la testa – con soldati che non ubbidiscono,
e col generale che ha paura, non si può fare nulla di bene. – Ma poi l’innato ardire gli
ritempra lo spirito, sale a cavallo, salta l’argine, e gridando con voce tonante la carica si
slancia contro i Russi.
Noi scriviamo sulla fede di chi vide ed ha narrato i fatti. Meno gli italiani ed i francesi, i tre
magiari, il colonnello Sasky e quattro Polacchi che furono in un baleno ai fianchi di Nullo,
niun altro comparve al di là dell’argine. Era Miniewsky, che non avea dato il comando, o
mancarono di coraggio i suoi soldati? Lo ignoriamo.
Fosse la sorpresa sulla quale avea fatto assegnamento il Nullo, fosse il disegno di
concentrare gli ordini sparsi per resistere all’urto inaspettato, i Moscoviti cessarono
subitamente il fuoco, e suonarono a raccolta, e quel pugno di prodi rimase per un
momento isolato in mezzo al campo simboli viventi dell’eroismo di quattro popoli, che
dovrebbero pugnare insieme sempre per la causa della libertà. Nullo scorgendo a pochi
passi caduto il giovane Elia Marchetti ferito mortalmente, e Febo Arcangeli colto da una
palla al ginocchio, e veduto si scarso il numero intorno a lui, sentì avvamparsi d’ira e di
dolore, e diede il segnale della ritirata. E quando vide i suoi compagni oltre l’argine al
coperto dalle palle nemiche, volle dare una lezione di coraggio, a chi ne avea di bisogno,
ed accendere coll’esempi una scintilla di valore, in chi titubava. E là sull’argine, alto e ritto
in arcione al cospetto del nemico, percorreva al lento passo del suo cavallo .a fronte del
piccolo campo, e strappava in tutti i volontarii un grido di ammirazione e di entusiasmo,
che face rimbombare la selva. Forse nel momento in cui tanti applausi lo salutavano, egli
accompagnava più coll’anima che coll’occhio Caroli ed altri pietosi, che portavano il
Marchetti agonizzante entro la foresta. La critica enuca e l’invidia indispettita oseranno
domandar della logica e dell’aritmetica a tanta intrepidezza, e colle abiette lenti
dell’egoismo sapranno scorgevi dentro della imprudenza e della vanità. Ma quando l’Italia
e la Polonia ricorderanno Francesco Nullo brillerà agli occhi de’ posteri la splendida figura
del cavaliero colla spada ignuda e solo di fronte ai battaglioni della Russia.
Agli evviva dei volontarii rispose con tremendo fragore il fuoco dei nemici: il cavallo di
Nullo colpito da due palle stramazza a terra. Caroli, Mazzoleni, Clerici e l’alfiere Polacco
accorrono in mezzo a quella tempesta di proiettili a scongiurare Nullo di ritirarsi, e gli
prestano aiuto a disimpacciarsi dal pesante cadavere. Il prode già riavuto dalla scossa
balza in piedi, ed abbracciato ancora dall’alfiere Polacco si volge sorridendo a salutare
colla mano i Russi, quando in un subito i suoi fidi lo vedono impallidire, vacillare un istante
e cadere a terra. Una palla, forata la mano dell’alfiere che lo avea rialzato, lo ebbe colpito
al fianco alla regione del cuore – Mio Dio! Gli dice Caroli, che hai Francesco? – Son morto,
risponde freddamente il Nullo, e lascia cadere la testa sul braccio dell’amico, che lo
baciava in fronte. Era spirato.
Al poco ardire, al disordine che regnavano già prima nella affievolita legione, succede la
costernazione sul drappello degli italiani, e lo scompiglio in tutti. Miniewsky che nella breve
campagna non avea saputo far nulla di bene, perdette del tutto la bussola, e si trovò il più
impacciato fra quei poveri impacciati. I Russi s’avvicinavano rapidamente; niuno dava
ordini, come niuno pensava ad eseguirli; da tutti si gridava che era necessario internarsi
immediatamente nella selva, e cercare rifugio al di là del confine austriaco della Gallizia.
Le palle russe sfracellavano i rami dagli alberi al di sopra delle teste dei volontarii, e non
lungi s’udivano i nitriti delle cavalle dei Cosacchi.
Miniewsky ben deliberato in un solo pensiero, cioè a non cadere nelle mani dei Russi,
diede ordine che già si eseguiva sotto i suoi occhi, quello della ritirata, e si volse ad offrire
a Caroli il comando dei legionarii stranieri; a che il giovane con molto senno rispondeva,
che bisognava pensare a salvarsi non a creare dei comandanti. Quindi pigliata quella
direzione che la corrente dei fuggitivi parea indicasse come la più sicura per accostarsi
alla frontiera austriaca, si allontanarono tutti alla rinfusa, e si volsero verso il villaggio di
Crzikawka seco traendo come meglio potevano, il semivivo Marchetti ed il ferito Arcangeli.
Ma le difficoltà del cammino accresciute dalla confusione presente e dagli stenti già
tollerati, si faceano gravissime. Usciti dalle selve s’erano inoltrati in una landa deserta, e
tutta impregnata di acque stagnanti, che a tratti si apriva in gore paludose, in cui si correva
pericolo di sprofondare. In una di queste gore scivolò col cavallo sul quale veniva
trasportato l’Arcangeli, e vi sarebbe affogato, se Caroli pensando più a salvare il
compagno che al proprio scampo, non si fosse trattenuto a cavarlo da quella palude, e
rimetterlo sulla via.
La schiera sempre più immiserita dalle continue diserzioni dei giovan Polacchi, i quali
conoscendo i luoghi e la lingua del paese, si disperdevano fra i boschi e le paludi, era
ormai ridotta ai pochi italiani e francesi coi tre magiari e qualche decina di nazionali.
Miniewsky stesso e Sasky scomparvero. I rimasti vagavano alla ventura per quelle
solitudini, e non reggevano a proseguire il viaggio che nella fiducia di sfuggire al nemico e
do toccare la Gallizia.
Errarono tutta la notte senza sapere ove si fossero, né a qual meta riuscirebbero: cogli
abiti laceri ed intonacati di fango, affrante le membra pel digiuno e le fatiche, sconfortati,
perduti in deserte regioni a mille miglia dalla patria sì caro pagavano que’ generosi figli
d’Italia e di Francia il loro affetto alla causa della libertà.
Apparve finalmente una collina, che dava segno di soggiorno d’uomini, poiché gli alberi si
vedevano disposti a file simmetriche; ed una colonna di fumo sottile e continua che si
elevava al di sopra delle piante, offriva indizio di capanne o casolari di contadini che
bruciassero legne. Subitamente drizzarono cammino a quella volta, e per accorciarlo
valicarono un esile fiumicello, uno dei tanti che dall’alto piano su cui s’innalzano le cime
dei Carpazii, portano il loro povero tributo alla superba Vistola. E poiché temevano ad ogni
momento di essere sorpresi dai fanti o dai Cosacchi Russi, di cui si sapeva gremita tutta la
zona di Polonia vicina alla Gallizia, s’affrettavano con ultimo sforzo a guadagnare la
collina, d’onde s’avrebbe abbracciato coll’occhio un vasto cerchio di paese.
Erano serbati a nuovi dolori. I boschi alle radici della collina erano un accampamento di
soldati Russi, i quali segnalato appena il piccolo gruppo di armati che sopravvenivano,
incominciarono a sparare, e quei primi colpi destarono una tempesta di fucilate, che
s’incrociavano da ogni lato. Ogni varco si presentava chiuso, troppi i tormenti ed i nemici;
del resto né l’animo né le forze avrebbero bastato a più debole contrasto. Quelle misere
reliquie di una spedizione infelice avevano pagato ad usura il loro debito alla causa della
Polonia, e quando comparve a cavallo un ufficiale Russo, Caroli agitando una pezzuola
bianca fa’cenno ch’egli ed i suoi compagni si arrendevano prigionieri.
L’uffiziale tuonò con voce stentoria un comando, che fece cessare il fuoco. Era il generale
Sakoskoi, e certamente un prode, perché si dimostrò cortese ed umano coi vinti. Egli
impose a’ suoi soldati di rispettare la sventura, e die’ ordine che i prigionieri fossero
scortati immediatamente ad Olkusz. Poi rivolto a loro diceva con nobile compiacenza –
ringraziate la fortuna, ch’io sia sopravvenuto in tempo a salvarvi; non uno di voi sarebbe
scampato al furore delle truppe. – che quelle parole non fossero una vanteria soldatesca
stava a pochi passi di là un terribile argomento, ed era un povero Polacco che moriva
massacrato a colpi di baionetta.
L’Italia che ricorderà con orgoglio questa impresa tanto generosa quanto sfortunata, deve
un sentimento di gratitudine al generale Sakoskoi, che le ha salvato un drappello di prodi e
volle che onori militari fossero resi alla salma di Francesco Nullo. –
Olkusz è piccola, ed immiserita città al Nord-Ovest di Cracovia. I prigionieri vigilati vi
giunsero esausti di forze dopo una lunghissima marcia di 20 ore. Arcangeli venne
ricoverato nello spedale civile: il povero Marchetti moriva tra le braccia di un ufficiale
austriaco: gli altri secondo gli ordini del generale Sakoskoi, furono liberi sotto parola
d’onore entro il recinto della città, che pareva assai lieta di confortarli con infinite
dimostrazioni di benevolenza e di gratitudine.
Ma il generoso contegno del generale Russo, e le testimonianze d’affetto dei cittadini di
Olkusz furono breve illusione per gli infelici, che ancora ignoravano la sorte, che li
aspettava. Trascorsi quattordici giorni un uffiziale russo venne da Varsavia, e per
comando del supremo tribunale militare fe’ loro conoscere, che sarebbero
immediatamente tradotti in quella città. Del resto durante il nuovo viaggio verso la capitale
della Polonia, i modi di quell’uffiziale, e quelli dei soldati che li accompagnavano, non
tradirono punto i biechi intendimenti di coloro, che s’apprestavano a giudicarli. Chiusi nelle
carrozze, non legati, non vestiti del lurido sacco dei prigionieri, non insultati dalla
soldatesca che pure li vigilava con occhio torvo e sinistro, giunsero a Varsavia, e furono
condotti nella cittadella. Se pure non bastava l’idea terribile d’un giudizio militare, quale
triste presentimento non avrebbe risvegliato l’aspetto di quel covile del dispotismo irto di
torri, di bajonette, e di cannoni!
I giorni trascorrevano lunghissimi nell’ansia della incertezza, ma la baldanza giovanile, e
l’animo intrepido non smarrivano per le infauste novelle dei supplizii, che in Varsavia ogni
dì si consumavano sugli sgraziati Polacchi prigionieri, né pei truci ceffi degli aguzzini
Moscoviti, che s’aggiravano nel recinto del castello. Caroli ed i suoi compagni di sventura
italiani e francesi sapevano, che i Ministri di Francia e d’Italia, ed altri personaggi
autorevolissimi non aveano frapposto indugio ad interporre i loro caldi ufficii presso il
Granduca Costantino, ed il generale Berg, perché le voci della clemenza e del perdono
non fossero intieramente soffocate dal rigore delle leggi militari. Si: bisognava parlare di
clemenza e di perdono innanzi ad uomini irritati e potenti, pei quali i nomi di libertà e di
patria non hanno altro significato che di ribellione e di tradimento, e non sanno e non
possono rispondere al diritto dei popoli, che colle palle di piombo e col capestro.
Finalmente il giudizio ebbe luogo, la sentenza fu pronunciata. Era di morte. Ma il
Granduca Costantino si piegava a commutare in altra pena quel decreto di sangue: il
fratello dello Czar usando il diritto di grazia concede ai compagni di Nullo dodici anni di
deportazione nella Siberia. Con mille altri compagni di sventura sono partiti a quella volta
Caroli Luigi, Andreoli Emilio, Venanzio Alessandro, Richard Luigi, Giupponi Ambrogio,
Menli Lucio e Giacomo fratelli, e Clerici Giuseppe.
III
Nel mentre i poveri prigionieri scortati dai Cosacchi attraversano il vasto territorio che da
Pietroburgo si estende fino alle montagne, le quali segnano il confine tra l’Europa e l’Asia,
il nostro pensiero li procede nelle desolate regioni della Siberia, e si studia di abbracciare
con uno sguardo complessivo quell’immenso paese, dove il dispotismo della Russia
manda da due secoli a confondere insieme i loro dolori i rifiuti degli ergastoli e le vittime
della libertà.
Alla distanza di quasi 1300 miglia da Pietroburgo verso Oriente le grandi pianure della
Russia Europea sono chiuse e separate dall’Asia da un naturale baluardo di montagne, le
quali sotto il nome di catena dell’Ural corrono in direzione di tramontana a mezzodì per la
lunghezza di circa mille miglia. Esse stanno colla base adagiata sopra un altipiano della
media larghezza di 60 e 100 miglia, che sorgendo poco lontano dall’avvallamento del Mar
Caspio si protende quasi in linea retta fino ai lidi sconosciuti dell’Oceano glaciale artico. Le
montagne, che si levano non interrotte su questo dorso gigantesco dei due continenti,
sono più o meno alte, e talune coperte di nevi eterne, hanno i fianchi dirupati assai più
verso l’Asia che non dal lato dell’Europa, e nascondono nel loro seno miniere ricchissime
di ferro, di rame, di piombo, d’argento e d’oro. Agli ingrati lavori, che debbono compiersi in
quel clima orribile, e che impugnano la Russia di circa venti milioni di rubli ogni anno, sono
condannati gli infelici prigionieri, i quali vigilati dalle guarnigioni Russe vi finiscono ben
presto di stenti, e di fame una misera esistenza.
La superbia dei Russi non ammette la frontiera segnata dalla natura tra l’Asia e l’Europa:
agli occhi loro la catena dell’Ural non è che la spina dorsale del vasto impero Moscovita, il
quale dalle acque del Baltico abbraccia tutto il Settentrione dell’Europa, dell’Asia, e
dell’America fino al grande Oceano. È una vanità, che si può perdonare ad una nazione,
che domina sulla vigesima ottava porzione del globo, e costituisce la quindicesima parte
del genere umano.
Al di là dei monti Urali è la Siberia, ossia la Russia Asiatica, regione più ampia che non
tutti insieme il continente d’Europa. Infatti la Siberia misura una tratta media di 3700 miglia
da ponente a levane, e di 1500 da mezzodì a tramontana: in tutto una superficie di circa
quattro milioni di miglia quadrate, la quale aperta verso il Nord va a morire con insensibile
pendio nelle inesplorate solitudini dei Mari Polari.
Contano ampia estensione di terre è segregata all’Ovest dall’Europa per la catena
dell’Ural; al Nord è chiusa dai ghiacci eterni dell’Oceano Polare, all’Est dallo stretto di
Behring, e dall’Oceano orientale, che fascia il globo tra l’Asia e l’America; al Sud dalle
molteplici ed inaccessibili montagne Altaiche, Sajaniche, e Dauriche, le quali ricingono le
steppe dei Tartari indipendenti, e l’impero della China.
Innumerevoli e maestose correnti di acqua dolce irrigano inutilmente quei paesi dominati
da una rigida e nebbiosa atmosfera, ed abbandonati allo squallore di una lunghissimo
inverno. I fiumi scendendo dalle montagne altissime dell’Ovest e del Sud, errano in vallate
solitarie, e deserte pianure, alimentano una moltitudine di laghi, di paludi, e di stagni senza
numero e senza nome, ed infine si raccolgono quasi tutti nei bacini principali dell’Obi, del
Ienissei, dell’Irtich, dell’Angara, del Lena, che finiscono a scaricarsi nell’Oceano glaciale.
Quelle larghe e profonde fiumane vanno a cercare i mari lontano migliaja di miglia, e
travolgono masse di acque di molto superiori a quelle del Wolga e del Danubio, che sono
i più grossi fiumi dell’Europa. Le loro sponde non mai animate dall’aspetto di abitazioni
umane o sono nascoste in mezzo a foreste interminabili, o stanno confuse in grembo a
paludi sconfinate e piene di giunchi e di canne, fra cui vivono a stormi i castori, le oche e le
anitre selvatiche, i cigni, ed altre specie infinite d’augelli acquatici.
Stagni di acqua dolce o salmastra, laghi di ogni dimensione e forma, ora disseminati in
mezzo alle lande, ora attorniati da colline di sabbia e da rupi nerastre; di quando in quando
serie capricciose di valli e di monti attristati da una vegetazione malinconica come il cielo
torbido, che vi sta al di sopra; qua e colà ad enormi distanze tra loro le città edificate dai
Russi, e popolate poscia dagli esiliati, e dai mercandanti venuti dall’Europa; al piè delle
montagne e lungo i fiumi le rare e sordide capanne delle tribù indigene, che vivono di
caccia e di pesca; poi praterie, e steppe non mai abbellite da una pianta d’alto fusto, non
mai visitate che dalle renne, dagli orsi, e dai lupi; poi deserti ribelli ad ogni coltura, ed
incrostati da eterno gelo, che si perdono nell’orizzonte: ecco il quadro, che all’occhio del
viaggiatore presenta in generale il suolo della Siberia,
quale diversa fisionomia potrebbero offrire regioni che per nove e talvolta dieci mesi l’anno
sono involte nelle nebbie, e sepolte nel ghiaccio e nella neve? L’inverno incomincia nella
Siberia col mese di Settembre e non di rado il gelo non è ancora disciolto alla fine di
Maggio. Nei pochissimi luoghi, dove si fa qualche tentativo di agricoltura, se il seminato
non è maturo per la seconda metà dell’Agosto si ritiene perduto; bene spesso accade che
sulle messi vicine alla mietitura sopravvenga una nevata, che involge fino all’estate
susseguente. Durante la stagione invernale non è strano che il freddo sia tanto intenso da
congelare il mercurio e lo spirito di vino nelle palle dei termometri, lo che avviene a non
meno di 40 gradi al di sotto dello zero. Quasi dappertutto la terra si trova gelata fino a
quattro metri di profondità, ed anche quando il sole nella breve estate scioglie la crosta
impietrita alla superficie, scavando poco più di una spanna al di sotto si rinviene ancora il
suolo agghiacciato. Del resto nella zona più settentrionale e sulle spiagge del mare Artico
l’inverno è perpetuo; su quella plaga squallida e desolata i raggi del sole sono impotenti a
produrre calore: i ghiacci e le nevi non si fondono giammai.
A sì crudi e lungo inverno succede sul finire di Maggio, od in principio di Giugno l’estate, la
quale per un contrasto inesplicabile arreca un calore improvviso e bruciante, per cui in
poche settimane la terra si copre di erbe e di fiori, le piante si vestono di foglie, i grani si
sviluppano, si maturano, e si raccolgono. Allora nei paesi più meridionali, e meno esposti
al soffio gelato dei venti polari si veggono vicino alle città delle piccole oasi di verdura,
dove crescono rapidamente l’orzo, l’avena, il lino, la canape, i pomi di terra, i cavoli, ed
altri vegetabili, che sfidano per l’industria dell’uomo una natura ingrata. Il moto, e la vita
appajono collo scomparire del ghiaccio e delle nebbie: animali e vegetabili pare s’affrettino
al pari degli uomini a godere di quelle delizie fugaci che il calore del sole arreca per pochi
mesi. Diciamo fugaci, perché col cadere dell’Agosto l’inverno riede inesorabile, e qualche
volta nel cuore del Luglio un vento improvviso di tramontana fa agghiacciare, e morire un
una notte la neonata vegetazione.
Il rigore quasi costante per tutto il corso dell’anno di un’atmosfera freddissima, le impure
esalazioni dei maresi vastissimi, l’umidità delle nebbie folte e frequenti, il rapido salto
dell’inverno all’estate senza le stagioni intermedie della primavera e dell’autunno rendono
il clima della Siberia insalubre per coloro massimamente, che vi sono stranieri, o che
hanno scarsi mezzi per combatterlo, come i poveri nelle città ed i nomadi indigeni nelle
campagne. Lo scorbuto, la scrofola, la rachitide, le febbri miasmatiche sono frequenti in
quello sciagurato paese. Nelle steppe le mandre degli armenti, ed i cavalli in ispecie vanno
soggetti ad una malattia pestilenziale, che ne fa strage, e non risparmia talvolta gli uomini.
Altro flagello non insolito per le tribù semiselvagge è la fame, e questa consiglia non di
rado i poveri Tartari a mangiare col latte di cavalla o di renna una specie di terra argillosa
assai molle, che si chiama midollo di roccia, oppure ad impastare colla farina di segale del
gesso in polvere.
Quanto la natura fu avara coi Siberiani di ricchezze vegetabili, altrettanto fu generosa con
loro di tesori inesausti nel regno minerale ed animale. Metalli nobili ed ignobili, e pietre
preziose abbondano a profusione nelle montagne Uraliche, ed Altaiche, e potrebbero
divenire sorgenti di lucro immenso, se meno scarso fosse il numero delle braccia a
coltivarne la produzione, o meno geloso il governo Russo a mantenerne a suo profitto il
monopolio assoluto. Più di ventimila persone o pagate, o forzate dalla Russia lavorano
costantemente nelle miniere della Siberia: lo stimolo adoperato più di frequente, e con più
larga misura per eccitare l’attività dei minatori è il bastone; ma s’inganna a partito il
despota di Pietroburgo credendo un tale mezzo il più economico: le vergate costano assai
poco a chi fa distribuire anche senza parsimonia, ma non inspirano certamente in chi le
riceve né zelo, né prontezza al lavoro, né moralità.
Fra gli animali domestici più diffusi e più utili alla Siberia va segnalata la renna, di cui si
veggono mandre numerose per tutta l’immensa zona, che si prolunga dai monti della
Mongolia Chinese fino ai lidi dell’Oceano glaciale. Le tribù vagabonde dei Samojedi, dei
Tongusi, dei Coriachi, dei Tsciuti, al pari dei Lapponi d’Europa, appoggiano la loro
esistenza alle renne. Da esse infatti si fanno tirare le slitte, si cava il late per bere, le carni
per mangiare, la pelle per vestirsi, le budella per fare il filo, le vesciche per uso di bottiglie,
le ossa per abbruciare, il pelo e le corna per vendere in cambio di altre merci.
Compagno della renna è il cane di Siberia, che ha l’aspetto, la fierezza del lupo, ma sa
tuttavia rassegnarsi a vivere ubbidiente all’uomo, ed a servirlo sia per tirare anch’esso la
slitta, sia per difendere le renne dagli altri animali feroci. Parecchie orde Siberiane
allevano numerose greggie, e posseggono superbe razze di cavalli, de’ quali la massima
parte hanno il pelo bianco, e molti sono segnati a fascie come le tigri, od a macchie, come
i leopardi. Madre innumerevole di cavalli ed asini selvatici, di alci, di antilopi, di cervi, di
capriuoli scorrono nella sconfinata steppa di Barabin, ed in altre della Siberia meridionale.
Zibellini, ermellini, scoiattoli, marmotte, volpi nere, bianche, ed azzurre, lepri, ed altri
quadrupedi perseguiti accanitamente dagli avidi cacciatori, che ne vendono le preziose
pelli, sono ormai divenuti rari anche nelle recondite provincie più vicine ai mari polari. Così
i castori, di cui erano un tempo popolate le sponde dei grossi fiumi della Siberia, sono
quasi scomparsi dai luoghi accessibili alla ingordigia dell’uomo. Le umide praterie, e le
paludi sono l’ambito soggiorno di torme di innumerevoli di oche, di anitre, di beccaccie, e
d’altra selvaggina di carne dilicata, e di piume finissime, le quali sono merce assai appetita
dai negozianti della Russia e della China, e scambiata dai Siberiani con altri prodotti dei
due limitrofi imperi. I fiumi riboccano di pesci, e specialmente di lucci, di rombi, e di
storioni. Nei laghi si pescano trote enormi. Durante l’estate l’aria è inondata da turbini di
moscherini, e di zanzare molestissime, e da un’altra specie di insetti quasi microscopici, i
quali furono denominati da Linneo furie infernali. Cotali insetti se non si mostrano degli
interamente del titolo spaventoso, con cui li ha designati il celebre naturalista Svedese,
non cessano però di tormentare l’uomo e gli animali al paro, e più forse delle cimici, e delle
vespe che anch’esse infettano la massima parte delle pianure della Siberia.
Ma lo Czar delle belve feroci, e fra tutti gli animali senza conforto il più formidabile e
vorace è l’Orso bianco, il quale si aggira o solitario, o congregato a tornare numerose tra i
ghiacci delle coste settentrionali, e non pare creato che a distruggere spietatamente quanti
viventi terrestri od anfibii incontra nelle sue escursioni. Il suo istinto sanguinario non si
calma, quando è satollo di cibo, ma pare che l’abbondanza della preda lo stimoli ad
uccidere e sbranare per la sola voluttà di vedersi attorniato di cadaveri. Nemico dell’uomo,
di cui non ha timore, è però tanto stolido o temerario da lasciarlo avvicinare , e lo attende
colla gola spalancata e seduto sulle gambe posteriori in atto di sfida, fino a che cade
rovesciato dal colpo di lancia, che gli trafora il torace.
Chi oserebbe supporre che paesi, i quali pajono condannati a perpetua dimora dell’inverno
e della nebbia, abbiano nutrito un tempo mandre numerose di elefanti, di rinoceronti, e
d’altri giganteschi animali erbivori della zona torrida? Eppure in molte contrade della
Siberia lungo le rive dei grandi fiumi, o dentro gli strati terrosi dei piani circostanti alle
larghe riviere, i viaggiatori attoniti trovano dei vasti ammassi di ossa ammonticchiate, e
non di rado degli scheletri intieri di tali quadrupedi di misti colle vertebre e coi cranii di
cetacei, colle scatole di conchiglie marine, e colle reliquie distinte di bufali, di cammelli, di
leoni, ed altre belve dei climi ardenti dell’Asia e dell’Africa. Le isole Lieikoff non sono altro
che un impasto di ghiaja, di ghiacci, e di avanzi ossei d’elefanti, di rinoceronti, di bufali, di
balene, e di foche. Quei frequenti depositi di ossa, e di carcami, e di cadaveri, che
occupano talvolta anche nell’interno delle terre parecchie miglia quadrate di superficie, e
fino a venti metri di profondità, sono la disperazione dei dotti, i quali s’accorderebbero a
supporli colà trascinati e sepolti dalla violenza di un diluvio, se molte altre osservazioni non
facessero dubitare seriamente che gli animali, a cui appartenevano, vissero e morirono nei
luoghi, ove trovarono la tomba.
Pare che la Siberia abbia ricevuti il suo nome da Sibir, città dei Tartari, e residenza del loro
Khan o Capo supremo, quando essi dominavano in tempi anteriori alla conquista Russa
sui paesi situati nella parte occidentale e meridionale, e bagnati dai fiumi Sibirika, Tobol,
Irtyk, Obi, e Inissei. Del resto quei paesi inospitali non hanno storia, che risalga all’indietro
di tre secoli. I geografi antichi si limitarono a sospettare, che al di là dei monti Urali non vi
fosse che mare interminabile di ghiaccio: nel medio evo il celebre Marco Polo aveva udito i
Tartari del mezzodì discorrere vagamente di un gran paese a tramontana, dove
abbondavano preziose pelliccie, e regnavano nebbie perpetue. Nell’anno 1580 un
avventuriero Cosacco di nome Iermak-Timofeyew si spinse con un orda di suoi
connazionali al di là dell’Urla, soggiogò le Tribù Tartare dela Siberia occidentale, prese
possesso delle loro terre, e spalancò all’ambizione della Russia le sconfinate regioni
dell’Asia e dell’America Settentrionale.
La scarsa popolazione oggidì disseminata sul suolo della Siberia giunge appena a tre
milioni di abitanti: quella immensa estensione di terre, che è di due settimi più vasta
dell’Europa contiene meno abitatori, che non la Lombardia. Ma lungi dal formare una
nazione, que’ popoli offrirono uno strano miscuglio di razze diverse, le quali in epoche
differenti, e per opposte vie penetrarono, e presero stanza nel paese, e separate tra loro
da spazii enormi di terre, di acque, e di monti non si avvicinarono mai per collegarsi in
amicizie, né per farsi la guerra. Questo va detto a riguardo delle tribù, che si trovarono
nella Siberia prima della irruzione dei Cosacchi, e della successiva conquista dei Russi;
poiché da quel tempo la razza Europea favorita dalla potenza espansiva e rapace del
colosso Moscovita ha incominciato a farsi strada, e prevalere in tutti i modi sugli indigeni, e
finirà in tempo non lontano a distruggerne colla indipendenza anche il nome.
Le orde Tartare allevatrici di armenti e di mandre numerose di cavalli, le famiglie erranti di
stirpe Mongolica, che vivono di caccia e di pesca, le nomadi Tribù Tonguse calate dai
monti della China, che posseggono migliaja e migliaja di renne, e si esercitano in continua
guerra contro gli animali feroci o proficui, i poveri Samojedi, che abitano le spiaggie dei
mari agghiacciati, i miserabili Kamsciatkadali, che lottano contro gli orrori degli inverni del
polo Artico, formano in tutto un mezzo milione di sudditi, ai quali è soggiorno la solitudine
delle steppe, o le spelonche scavate nella neve e barricate di ghiaccio. Rozzi e barbari,
ma docili ed innocenti essi pagano il tributo al primo caporale Russo, che si presenta in
nome dello Czar ad esigerlo da loro, ed amano la squallida terra, su cui sono nati con
quell’affetto, che portiamo noi al nostro paese rallegrato dal perpetuo sorriso della natura.
Russi, Cosacchi, ed altri coloni emigranti dall’Europa costituiscono il maggior numero degli
abitanti della Siberia. Questi sono i figli dei conquistatori, o degli infelici esiliati, che da due
secoli caccia la Russia a languire in quei deserti: contadini avventurieri, negozianti,
disertori dall’Europa che cercavano scampo, o risorsa su quelle spiaggie remote,
s’aggiunsero a quei primi, e dalla miscela nacque un nuovo popolo, che forse coi secoli
acquisterà forme e sostanza di nazione.
Gli esiliati, che hanno la fortuna di non essere condannati ai lavori delle miniere, gli uffiziali
e gli impiegati del governo Russo, ed i numerosi commercianti, i quali creano industri coi
prodotti del paese, o li scambiano con quelli dell’Europa e della China hanno dato a molti
luoghi della selvaggia Siberia una fisionomia di civiltà avanzata, che forma l’ammirazione
degli stranieri.
In mezzo a lande sterminate di pantano gelato, tra le nebbie perpetue di steppe senza
nome, sulle sponde solitarie di laghi e di fiumi, che per otto o dieci mesi dell’anno sono
coperti di ghiaccio, a distanze di centinaja di miglia fra loro sorgono città e borgate fiorenti
di traffici e di industrie, a cui non mancano né templi, né scuole, né teatri, né botteghe da
caffé, né alberghi, né quant’altro la necessità od il lusso ha saputo creare nelle città
dell’Europa. Casini eleganti, e cocchi, e cavalli, e fiere, e mercati, e superbi abbigliamenti
di case e di persone, e tutto il moto e lo splendore della civiltà moderna s’ammirano su
quella porzione del globo, che l’uomo ha rubato ad una natura matrigna. Essa indispettita
si vendica invano negando il calor del sole, e sprigionando su quei piani i gelidi aquiloni
del Polo Artico.
Togolsk, Tomsk, Irkusk, Ekaterinemburg, Nischnei, Tiumen, Atetuin, Kolywan, Barnaul,
Ienisseisk, ed altri minori sono i centri di popolazione, che hanno nome, ma non sempre
aspetto di città. L’arte e l’industria degli abitanti sfida e vince spesso condizioni di terra e di
cielo, che pajono create soltanto per i lupi e gli orsi: giardini d’inverno alla foggia Russa,
folte pelliccie, stufe eccellenti, cibi succosi, e bevande stimolanti, esercizii ginnastici sul
ghiaccio coi pattini, e sopra la neve colle slitte si oppongono ai rigori del clima: lunghe
carovane di commerciati, di soldati, di esiliati comunicano il movimento dell’una all’altra
città: l’arrivo dei cacciatori, o di campagnoli carichi di selvaggiume e di pelli d’animali serba
vivi i rapporti fra le città, e le campagne.
I prigionieri italiani sono relegati a Toblosk. Dessa è considerata capitale della Siberia, e
sorge là dove il fiume Tobol si congiunge coll’Irtych alla distanza di quasi due mila miglia
da Pietroburgo. È popolata da circa 20 mila abitanti, è sede di un governatore e di un
arcivescovo, ed un attivissimo commercio vi alimenta le industrie, e l’agiatezza. Fatta
eccezione dell’imperatore delle Russie, niun Sovrano in Europa comanda sopra si vasta
estensione di territorio, quanto il governatore di Tobolsk: la sola sua provincia divisa in
dieci compartimenti occupa tanto spazio, quanto la Francia e la Spagna prese insieme.