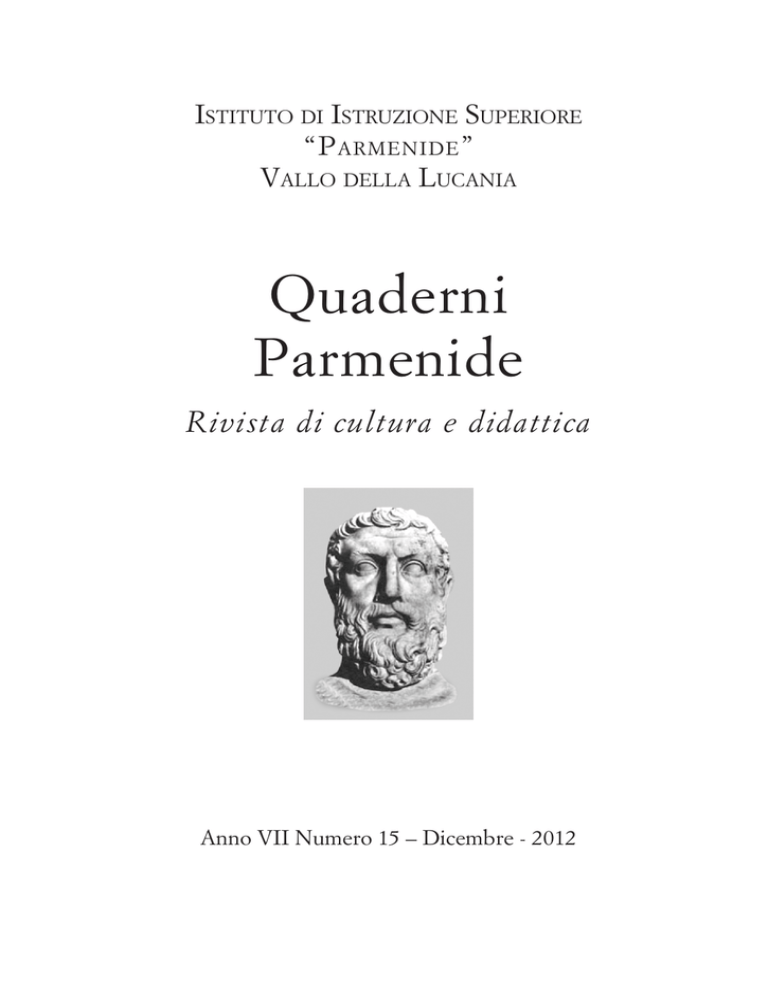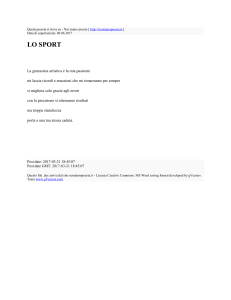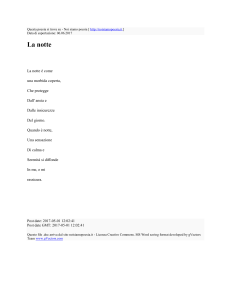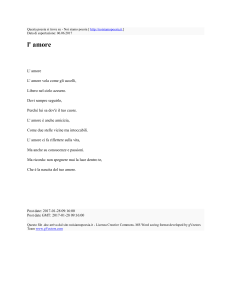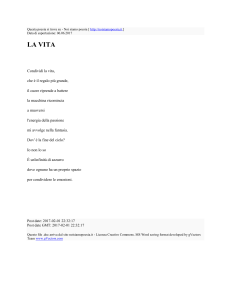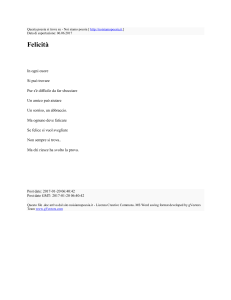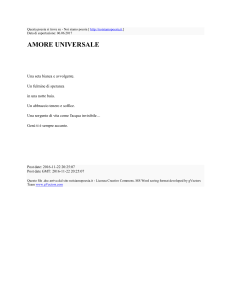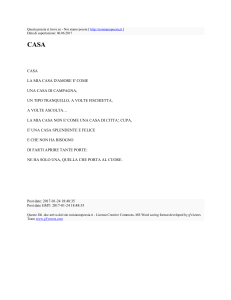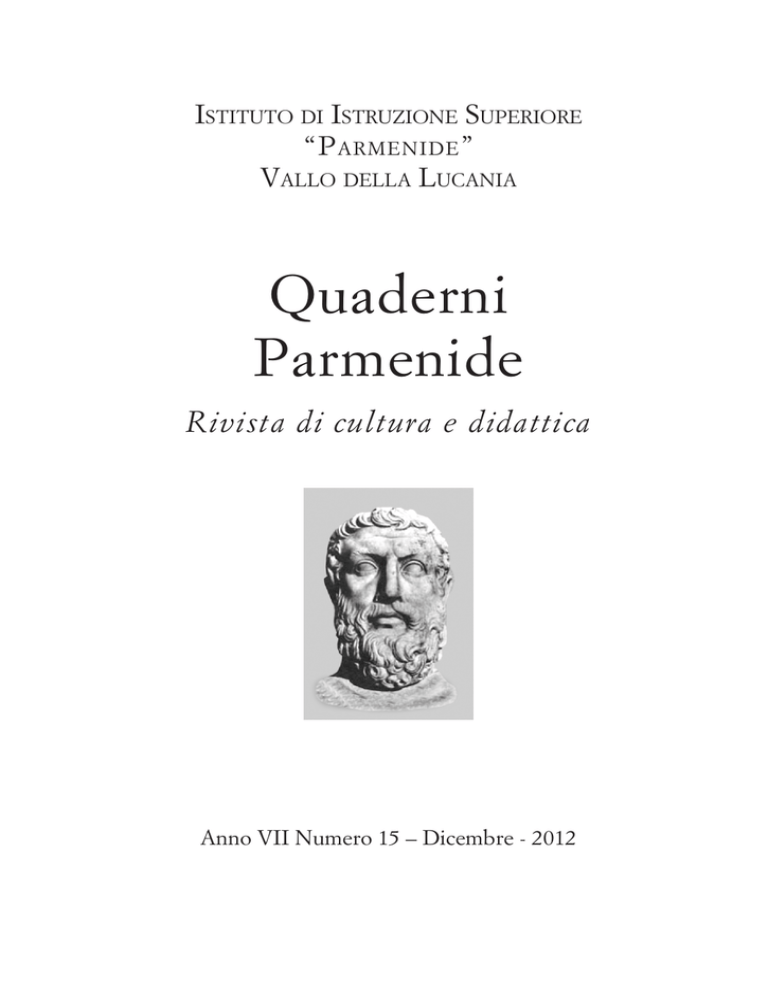
Istituto di Istruzione Superiore
“P armenide ”
Vallo della Lucania
Quaderni
Parmenide
Rivista di cultura e didattica
Anno VII Numero 15 – Dicembre - 2012
QUADERNI PARMENIDE
Rivista semestrale
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide”
Vallo della Lucania
Anno VII – n° 15 – Dicembre 2012
Direttore
Carlo Di Legge
Redazione
Santa Aiello, Eugenia Rizzo
Copyright
Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide”
Via L. Rinaldi, 1
84078 Vallo della Lucania
Tel /fax 0974/4147
www.liceoparmenidevallo.it
[email protected]
Stampa Editrice Gaia Srl - www.editricegaia.it
In copertina: Parigi dalla finestra, Marc Chagall
Indice
Editoriale
Carlo Di Legge
p. 7
Vincenzo Guarracino legge Pascoli
Riflessioni a cura di Mariassunta De Masi e Marilena Ficucella
13
Le mille maschere di Itaca
A cura della classe III A – Liceo classico
17
La poesia ametodica di María Zambrano
A cura di Santa Aiello
29
La pietra perifrastica di Kikì Dimoula
A cura di Clelia Albano
37
DIDATTICA E LABORATORI
Seneca: addolcimento della ragione
A cura di Santa Aiello
47
La poesia oltre la logica. Poesia come φάρμακον
“Il ciclope di Teocrito”
A cura di Eugenia Rizzo
55
Come opprimente lacrimosa acqua assorbita da arida terra
A cura di Alan Consorti
65
Leopardi, nonno del 1900
A cura di Rosalba Feo
69
Poesia e logica: la relatività dei sistemi
A cura di Maria Ruocco
73
Poesia e logica
A cura di Nicola Scarano
77
Logica e poesia/logiche della poesia
Carlo Di Legge
85
Hanno collaborato a questo numero:
Carlo Di Legge
Vincenzo Guarracino
Santa Aiello
Clelia Albano
Eugenia Rizzo
Dirigente Istituto
Poeta, critico, traduttore
Docente dell’Istituto
Docente dell’Istituto
Docente dell’Istituto
Studenti
Giada Benincasa, Mariassunta De Masi e Marilena Ficucella (V A Liceo Pedagogico);
Rossella De Luca (V E Liceo linguistico); Alan Consorti e Rosalba Feo (III A Liceo classico);
Ruocco Maria (III B Liceo classico), Nicola Scarano (I A Liceo classico).
Carlo Di Legge
editoriale
In primo piano, nell’editoriale di questo numero, due argomenti: il movimento di agitazione e protesta dei docenti e la nostra – consueta ma sempre
straordinaria – giornata della poesia. In terzo luogo, darei evidenza alle novità elettroniche che stiamo introducendo nel nostro Liceo.
Ma intendo ringraziare prima ancora quella gran parte dei Docenti, il Direttore dei servizi e il personale non docente, che, in un momento per me
non facile, portano avanti con grande dignità e buoni risultati le imprese
quotidiane e le innovazioni.
Per la scuola italiana il momento è addirittura critico. Vecchi nodi continuano a venire al pettine: pur dovendo distinguere tra il mio ruolo di dirigente dell’amministrazione e quello dei docenti e del personale, debbo ricordare che tutte le posizioni giuridiche si ritagliano e vengono comprese
nell’ordinamento della Costituzione della Repubblica democratica, che comunque salvaguarda, nella parte iniziale, le libertà, tra cui quella di parola.
Chi opera nella scuola sa che le nostre posizioni sono super difese dai sindacati, che hanno contribuito, in maniera molto netta, all’appiattimento delle
carriere e degli stipendi. Ogni volta che si cerca di iniziare un discorso sulla
differenziazione dei docenti (e dei dirigenti, perché no?) sul piano del merito
e dell’impegno, ci si arena sullo scoglio dei criteri, su cui fervono discussioni
bizantineggianti, inconcludenti.
Questa è una nostra colpa, se i sindacati ci rappresentano. Ma stiamo imparando a diffidare dei sindacati come diffidiamo di noi stessi: resta che la
scuola in genere si salva, e non va condannata per pochissimi che (in qualunque istituto; ma anche in qualunque settore del lavoro!) lasciano veramente a desiderare!
Ciò non vuol dire che, se dal punto di vista giuridico ed economico le posizioni dei docenti e del personale si eguagliano, mentre nella realtà possono
editoriale.
7
essere ben diverse, i lavoratori della scuola siano degni di essere trattati come
le anime morte – pesati, acquistati e venduti! Le ultime iniziative governative,
dopo la propaganda populista del ministro Brunetta (che, comunque, aveva
individuato alcuni punti critici), hanno mostrato come sia bassa la stima dei
governanti nella scuola: dopo aver congelato – si sa che il clima economico
prelude forse all’era glaciale, e va bene, anzi va male – gli adeguamenti degli
stipendi al costo della vita ufficiale, per cui il lavoratore della scuola sapeva e
sa che viene a lavorare con il vantaggio di un fisso mensile – indubbio privilegio rispetto ad altre categorie, su questo ci siamo – ma con uno stipendio
reale che decresce di mese in mese di fronte ai ritmi dell’inflazione; dopo
avere ripetutamente indicato all’esecrazione pubblica e alle gogne mediatiche
gli statali dell’istruzione; dopo averli, con ciò, esposti all’invidia pubblica,
per cui si sente che l’importanza della scuola, se nelle cose resta invariata e
cresce, nella considerazione di tutti gli idioti tende a diminuire – i Ministri,
alla ricerca disperata di tagli possibili, ci dicono: voi adesso aumentate il numero delle ore di servizio, mentre i vostri stipendi, che già vengono erosi ogni
giorno, restano uguali! Che è dire: diminuiscono ancora, per legge!
Un atteggiamento che sconfina nello spregio, tanto più che cresce il sospetto
– purtroppo alimentato dai fatti che emergono alla crescente attenzione di tutti
verso tutti – che alcune categorie – vedi la finanza – aumentino o conservino
privilegi, mentre le retribuzioni dei più calano rovinosamente.
Come dirigente in una realtà che considero confortante – con i collaboratori all’altezza delle situazioni, in linea di massima alunni che sanno di dover
studiare e docenti che hanno in chiaro il da farsi in aula – e pur avendo a mia
volta presenti le distinzioni dei compiti e dei ruoli, ho sempre creduto e ritengo sia nell’interesse delle scuole che si crei un clima propizio al lavoro sereno;
dove, proprio perché si è consapevoli delle reciproche differenze e difficoltà,
alunni e personale, docenti e dirigenti sappiano ascoltarsi a vicenda su ciò
che è giusto. Ora questo, beninteso, vale anche rispetto ai rapporti tra scuola
e governi – ma, per (non) dirla col ministro Profumo, il Governo questa volta
forse non ha affatto il merito di aver tastato il polso alla scuola: e perché poi?
Per il gusto della provocazione? Piuttosto, più semplicemente, il governo ci
ha provato con la scuola. Ha innescato una forte reazione di esasperazione,
che minaccia di non esaurirsi.
Non si esaurisce, viceversa, il fascino e l’impatto della poesia sullo spirito.
Anche questo numero reca l’impronta dell’ennesima giornata, che è stata
preparata egregiamente da docenti e alunni, in particolare dalle prof. Santa
8
Carlo Di Legge
Aiello ed Eugenia Rizzo, ma anche Clelia Albano ed altri, ed ha avuto luogo
il lunedì 19 dicembre, in aula magna dell’Istituto e in parallelo dalla I A del
Liceo Classico, che ha organizzato e coordinato due laboratori, su Iliade e
Odissea, con partecipazione di alunni delle classi prime.
La giornata è stata aperta dalla mia breve sintesi sulla relazione che è stata
preparata per questo numero e qui viene riportata integralmente: logica e
poesia/logiche della poesia.
Ha fatto seguito la lezione consueta del prof. Vincenzo Guarracino, nostro
abituale e graditissimo ospite di queste occasioni, che questa volta si è occupato di alcune liriche pascoliane – anche la relazione del prof. Guarracino
viene riportata, in questo caso in sintesi e per appunti – di eventuali incompletezze ci scusiamo.
Hanno continuato gli alunni della III A – Liceo Classico, con la ricerca le
maschere di Itaca, riportando brani e sintesi della versioni del mito di Ulisse
nel tempo; Giada Benincasa (V A - Liceo Pedagogico) con il brano non bisogna cercare, di Maria Zambrano, la notissima filosofa e poetessa spagnola,
tradotto per l’occasione in italiano; a cura della prof. Clelia Albano, e con sua
lettura finale, il suggestivo video e la traduzione delle incisive parole di Kiki
Dimoula, la pietra perifrastica, sul tema dell’assenza.
Aveva aperto la mattinata, con la danza di un ritmo hip hop, l’alunna Stefania Perfetto (V A – Liceo Pedagogico); avevano proseguito due esecuzioni di
pianoforte da parte di Teresa Ruggiero (V B – Liceo Classico), a scandire la
successione delle parti della manifestazione; aveva concluso Dario Speranza
(V B – Liceo Classico) con un pezzo di pianoforte. Tutte queste esibizioni
sono state molto apprezzate.
Tanto la ricerca sulle versioni di Odisseo quanto i temi dell’assenza e del
non dover cercare si possono ritenere altamente significativi nell’ambito poetico, ma anche filosofico e religioso, come ho posto in risalto, nella breve
conclusione.
L’ultimo argomento di cui riferisco qui consiste nelle innovazioni in atto
nell’Istituto. Abbiamo progettato durante la pausa estiva e a inizio d’anno,
conformemente alle disposizioni ma anche allo spirito del tempo e all’esigenza
di una maggiore efficacia ed efficienza, tre punti-chiave per la gestione
telematica e digitale dei dati e degli adempimenti: un nuovo e più potente
server per la gestione elettronica dei dati della segreteria e dei docenti, in funzione degli adempimenti previsti: un nuovo sito web del Liceo Parmenide,
completamente ridisegnato, per far fronte in modo più agile alle esigenza
editoriale.
9
d’immagine, di pubblicità e di informazione nei rapporti della scuola con
se stessa e con l’esterno; infine, la realizzazione della gestione digitale della
pagella e del registro, oltre che dei rapporti con le famiglie.
Tali innovazioni si aggiungono ai nuovi laboratori e ai viaggi di studio che
l’Istituto, con l’impegno di tutti e in particolare di alcune classi, della segreteria, dei proff. Mauro Ruocco e Leonardo Ricci, ha realizzato e realizzerà.
Il server interno della scuola ha iniziato a funzionare a novembre; il nuovo
sito sarà on web ai primissimi giorni di dicembre. Si tratta di un impianto
piuttosto elegante e sobrio nei colori ma anche molto semplice, concepito ai
fini dell’immediata possibilità di fruizione da parte di chiunque voglia entrarvi. Le pagelle elettroniche, come il registro digitale, non potevano essere in
funzione se non in dipendenza dalle precedenti due innovazioni. Il software
viene acquistato e installato nella dotazione elettronica dell’ Istituto a fine
novembre, con il travaso di tutti i dati e gli elenchi di vecchi ai nuovi contenitori. Di questi dati si serviranno i docenti per la prima pagella elettronica, che
si spera sarà visibile già con il primo trimestre, quindi nell’ultima decade del
mese di dicembre.
Dovesse trattarsi della fine del mondo, speriamo anche che, come ad ogni
conclusione, subentri un nuovo inizio! Digitale, ma non solo!
10
Carlo Di Legge
A cura di Mariassunta De Masi e Marilena Ficucella
Vincenzo Guarracino legge Pascoli
Nell’ambito della “Giornata della Poesia” lunedì 19 novembre 2012, presso l’Aula Magna del nostro Liceo, il Prof. Vincenzo Guarracino, poeta, saggista e traduttore, ha presentato il volume “Giovanni Pascoli poesia esèncial”
(Madrid, Pigmalion, 2012), una raccolta delle liriche del poeta di San Mauro
di Romagna tradotte per la prima volta in lingua spagnola, dal professore
medesimo – uscito in occasione del Centenario Pascoliano.
Guarracino ha definito Pascoli “il poeta che ha contribuito notevolmente
al rinnovamento dell’opera italiana nel passaggio tra il XIX e il XX secolo”,
che “sintetizza le grandi domande della modernità più inquieta”. Ricordiamo
che il critico Guarracino ha pubblicato numerosi saggi su Giacomo Leopardi
e che proprio dal poeta recanatese egli è partito per ricercare le origini della
moderna poesia in Italia.
Baudelaire aveva menzionato Leopardi come “stella” del panorama letterario;
infatti Leopardi anticipò il Simbolismo soprattutto con un uso dell’ analogia che anticipa tale elemento nei poeti maudit, da Baudelaire a Mallarmè.
E fa riferimento al terzo e quarto verso della prima famosa quartina delle
Corrispondenze di Baudelaire: “l’uomo va, e foreste di simboli attraversa/
che lo scrutano con occhi familiari e intenti”. (I fiori del male). Ma perché
Guarracino nell’ambito di questa giornata è ritornato su Leopardi? La sua
analisi ci ha suggerito che Leopardi è simbolista come Pascoli e si colloca
nel clima e nel fare poetico tipico dei simbolisti; Pascoli non fu infatti estraneo alla letteratura d’Oltralpe pur se la sua conoscenza si limitava ad Edgar
Allan Poe, di cui tradusse Il Corvo. Dunque Pascoli è da ritenersi, più che
decadente, simbolista, specie per la forza evocativa del lessico. Ne è emerso
un ritratto interessante del poeta romagnolo, il quale, come si è evinto dalla
citazione di alcuni versi di Romagna, attribuiva grande importanza al potere
dell’immaginazione, attraverso cui rievocare la propria infanzia, attraverso
Vincenzo Guarracino legge Pascoli 13
cui cercare l’“altrove”. Problema centrale nella poetica pascoliana, data
dall’esigenza di esprimere l’altrove e l’angoscia o la purezza dell’infanzia,
risulta essere proprio il linguaggio. Nei Primi poemetti, di cui Guarracino
ha citato L’Aquilone, si approfondisce il problema linguistico. Per Pascoli
è fondamentale la precisione lessicale; egli, esperto botanico, rimproverò al
Leopardi la genericità del lessico riferito alla natura (è nota la polemica su
“rose e viole” ne il Sabato del villaggio, di cui Pascoli scrisse in Pensieri e
discorsi, 1914). Pascoli riteneva necessario attribuire il giusto nome alle cose,
alle umili cose, che lo distinsero rispetto, ad esempio, alla tronfia retorica
dannunziana. Era attento alla selezione dei vocaboli sull’asse paradigmatico
e alla loro combinazione, sull’asse sintagmatico; Guarracino ha infatti letto
un verso assai suggestivo proprio per la sapiente selezione e combinazione:
“trascorre le foglie una gioia leggiera”. Vorremmo concludere riferendoci
alla gioia che poco fu presente nella vita del poeta, traumatizzato da frequenti
lutti e che tuttavia seppe trasformare il dolore in potenza creatrice, come a
dire che il fare poetico libera l’uomo dall’angoscia. Non a caso il prof. Guarracino ha concluso l’intervento declamando il X Agosto.
Mariassunta De Masi, Marilena Ficucella
Classe V A Liceo Pedagogico
14
A cura di Maria Assunta De Masi e Marilena Ficucella
A cura degli alunni della III A Liceo classico
Le mille maschere di Itaca
La più antica testimonianza del mondo greco è l’Iliade, ma è nell’Odissea
che si realizza la vera svolta. Non più frastuono di battaglie dal rosso sudore, non più semidei, ma un uomo, con i suoi limiti; il primo personaggio
nel senso compiuto del termine lacera irreparabilmente coscienze umane.
Sebbene Omero (e con Omero abbiamo deciso di indicare l’intera comunità rapsodica greca) ci abbia donato un uomo, un Odisseo, il nostro essere uomini non ha potuto che smembrare e cibarsi delle dilaniate carni
per restituire non uno ma mille Ulisse, mille maschere diverse eppure così
uguali hanno trovato dimora nella celeste Itaca e chissà quante ancora solcheranno il mare Egeo.
Omero
ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·
Euripide
La prima maschera nasce nella culla della civiltà greca, sono gli stessi Greci
a distruggere e creare il loro uomo.
Le mille maschere di Itaca
17
Ingrata razza la vostra, voi che cercate
il favore popolare! Non voglio conoscervi,
voi che non vi fate scrupolo di danneggiare le persone care,
pur di ottenere il favore del popolo
Euripide, Ecuba, vv. 254-257
Il nostro Odisseo diviene personificazione di un sistema corrotto, un mondo di spregiudicate parole e di menzogne.
Il verosimile impera, non la verità.
Il discorso viene stuprato e deriso, nient’altro.
Dante
Una visione parziale, discontinua, poeticamente leopardiana, riesce a
trasformare il più grande rappresentante dei sofisti in un impavido ricercatore di verità. Conoscenza per la conoscenza e non auliche parole di mistificazione. Mai “ignoranza” fu tanto gradita.
“O frati”, dissi “che per cento milia
Perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente,
non vogliate negar l’esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza”
Inf. XXVI, 112-120
Il dado è tratto. Non è più possibile tornare indietro. Le parole di Dante
aprono le porte alla dimenticata cultura antica, ponendo le basi al moderno
culto di Ulisse.
18
A cura degli alunni della III A Liceo classico
Foscolo
Ulisse ora è Foscolo
… onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue fronde
l’inclito verso di colui che l’acque
cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
A Zacinto, vv. 6-11
Dall’Ulisse di Dante, ricercatore di aletheia, di verità, si passa, in Foscolo,
ad un’immagine di uomo ricolmo dell’ansia di ricerca, al sensucht dell’eroe
romantico che, come l’autore, vive “bello di fama e di sventura” la condizione
angosciosa del “diverso esiglio”.
Pascoli
Quello di Pascoli è un Ulisse che sa di non sapere
Era Odisseo: lo riportava il mare
alla sua dea: lo riportava morto
alla Nasconditrice solitaria,
all’isola deserta che frondeggia
nell’ombelico dell’eterno mare.
Nudo tornava chi rigò di pianto
le vesti eterne che la dea gli dava;
bianco e tremante nella morte ancora,
chi l’immortale gioventù non volle.
Ed ella avvolse l’uomo nella nube
dei suoi capelli; ed ululò sul flutto
sterile, dove non l’udia nessuno:
– Non esser mai! non esser mai! più nulla,
ma meno morte, che non esser più! –
L’ultimo viaggio, da Poemi conviviali, vv. 39-52
Le mille maschere di Itaca
19
Oppresso, inerte, dubbioso, tormentato, l’Ulisse di Pascoli non è né eroe
né uomo omerico, ma è un uomo moderno, un uomo che ha combattuto una
guerra senza spade e che ha visto città crollare, un uomo che ha visto il proprio mondo andare in fumo.
D’Annunzio
Nel 1896 un uomo piccolo piccolo, tanto piccolo quanto furono tutti gli altri uomini del suo tempo, cercò di fare suo un concetto non suo, ripescandolo dalla mole di pensieri del forse più grande filosofo tedesco di tutti i tempi.
è uno dei pochi autori italiani del Novecento che ha fame europea, non
fama europea, ma una vera e propria ingordigia che darà sempre più vigore
al concetto di superomismo che prenderà in prestito da Nietzsche.
Gabriele d’Annunzio incentra sulla condizione superumana le sue Laudi,
che verranno pubblicate nel 1903, purtroppo in parte vacanti. D’Annunzio
aveva previsto la stesura completa di sette libri da dedicare alle sette stelle
delle Pleiadi. Riuscì soltanto in quattro: la lode alla Vita o Maya, la lode alla
terra, al mare e agli eroi.
Incontrammo colui
Che i Latini chiamano Ulisse,
nelle acque di Leucade, sotto
le rogge bianche rupi
che incombono al gorgo vorace,
presso l’isola macra
come corpo di rudi
ossa incrollabili e strutto
e sol d’argentea cintura
precinto. Lui vedemmo
su la nave incavata…
L’incontro di Ulisse, da Maia, canto IV
Quale uomo migliore se non proprio Ulisse, dunque? Egli, che era stato già
tutto, diviene simbolo dell’uomo particolare al di sopra di leggi morali e sociali,
fondamentalmente libero, unico nella sua specie, di costruire il proprio destino.
D’Annunzio immagina di incontrare Ulisse in sdegnosa solitudine, mentre
20
A cura degli alunni della III A Liceo classico
naviga nel mar Ionio, con uno sguardo che ha sprezzo per la vita e per il pericoli. è il capo, l’eroe guida di uomini che vogliono condurre la propria vita al di
sopra della mediocrità. A differenza dello sguardo che verrà concesso ai compagni, freddo e ostile, d’Annunzio sarà guardato in modo meno tracotante. è
in questo che il poeta sottolinea la propria volontà di potenza. Con Ulisse in tal
modo muore Dio e si accetta l’eterno ritorno dell’uguale, per sempre.
D’Annunzio spererebbe in un distacco aristocratico ma alla base vi è solo un
uomo, che è in grado di manipolare i valori del popolo, ma che tangibilmente ha
bisogno di quella folla che egli disprezza e del mondo borghese che egli fugge.
Saba
Nella mia giovinezza ho navigato
Lungo le coste dalmate. Isolotti
A fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
Marea e la notte li annullava, vele
Sotto vento sbarcavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
È quella terra di nessuno. Il porto
accende a d altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito
e della vita il doloroso amore.
L’Ulisse moderno di Saba ricerca i suoi orizzonti nel paesaggio dalmata, immagine di terre di bellezza smeraldina. Forte e immediatamente percettibile è
l’affinità del destino di ricerca che unisce il poeta e l’eroe omerico. Lo stesso destino che ha spinto Ulisse attraverso i mari ha reso inquieto e avventuroso l’amore
di Saba per la vita. Non sono questi uomini che si fermano alle facili sicurezze
che il porto può offrire, non sono appagati nel loro quieto vivere e non accettano supinamente la realtà. Si sentono lontani dalla meta e spinti al “largo” da un
indomabile e doloroso amore per la vita. Una vita soffocata nel cieco labirinto
di una verità sempre introvabile. Il vecchio Ulisse è perennemente disponibile
agli impulsi del profondo, ma incapace di concludere la sua ultima avventura
dell’esistenza. Il viaggio dunque non può conoscere soste e tende all’infinito.
Le mille maschere di Itaca
21
Joyce
Come la nostalgica tela ingannatrice della fedele moglie, il corpo del primo
UOMO della letteratura viene squarciato e rivisitato, ricucito da aracnica
mano esperta, ucciso per poter essere ricondotto su mondano suolo e continuare ad ispirare, faro tra possenti onde, rogo sgargiante di arabica fenice.
Il re di Itaca, il prediletto della fiera figlia di Metide, il sofista, il romantico
diventa un uomo “comune”, con una moglie che lo tradisce, che va in biblioteca, cammina per strade solcate da gracidante folla, un uomo come noi.
L’Odissea diviene una pura struttura da seguire e capovolgere, tela da ricomporre, ogni luogo ogni personaggio diventa altro, restando inspiegabilmente
immutato. RICERCA, parola immensa, regale che riassume l’apporto di Joyce
alla questione Ulisse. La ricerca di un figlio, la ricerca di un padre, di sanguinosa libertà, di un senso. James Joyce uccide un greco per restituire un uomo
senza tempo in perenne vana ricerca di se stesso..
Solenne, paffuto Buck Mulligan comparve dall’alto delle scale…
portando un bacile di schiuma su cui erano posati in croce uno
specchio ed un rasoio. Una vestaglia gialla, discinta, gli era sorretta delicatamente sul dietro dalla mite aria mattutina. Levò alto
il bacile e intonò:
– Introibo ad altare Dei.
Fermatosi, scrutò la buia scala a chiocciola e chiamò berciando:
– Vieni su, Kinch. Vieni su, pauroso gesuita.
Maestosamente avanzò e ascese la rotonda piazzuola di rito. Fece
dietrofront e con gravità benedisse tre volte la torre, la campagna
circostante e i monti che si destavano. Poi, avvedutosi di Stephen
Dedalus, si chinò verso di lui e tracciò rapide croci nell’aria, gorgogliando di gola e tentennando il capo. Stephen Dedalus, contrariato e sonnolento, appoggiò i gomiti sul sommo della scala
e guardò con freddezza la tentennante gorgogliante faccia che
lo benediceva, cavallina nella lunghezza, e i chiari capelli senza
tonsura, marezzati color quercia chiaro.
Ulisse, Joyce, incipit
Le cose sono però cambiate: Molly, al contrario di Penelope, è infelice.
Ciascuno dei personaggi del romanzo è la parodia di quelli dell’Odissea. Il
22
A cura degli alunni della III A Liceo classico
peregrinare dell’eroe omerico trova così il suo corrispondente nel vagabondare per Dublino. La figura di Bloom però non ha niente a che vedere con
quella dell’eroe omerico, anzi è l’anti-eroe per eccellenza A conclusione del
romanzo si assiste ad un lungo flash-back nel quale Molly ripercorre tutto
il suo passato ed è significativo che la donna sia nata proprio a Gibilterra
che coincide con i confini dell’Ulisse dantesco. L’Ulisse di Joyce rappresenta
quindi l’uomo moderno che aspira al ritrovamento di quei valori di cui viene
privato dallo squallore e dalla sordida meschinità della vita quotidiana e del
mondo che lo circonda. Joyce, raccontando la vicenda di un uomo qualunque
in un giorno qualunque, tenta di far risaltare l’universalità dell’esperienza
narrata e la associa a tutta l’umanità.
Intermezzo ironico-popolare
Penelope
PEN. Sicofanti! Sicofanti! Site buoni sulo a vinna ficu au mercatu!
Ma non vi siete stancati? Ulisse di qua, Odisseo di là, Omero…
Joyce… BlaBlaBla. Un secolo, due, quattro… per Cerbero, ora basta!
ROX. Chi è questa?
AL. Boh, una baccante!
PEN. Chi è questa?! A me? Ma sta sciaurata! Invece di stare a casa
ad allattare i figli, a cucinare, a tessere! Baccante a me? Beh, forse un
tempo…qualche orgia divina. Ue sciorta, ma che dico?! Oh, perdonami grande Era. Io sono, Penelope, figlia di Icàrio, signora di Itaca…
non so se rendo l’idea.
ROX. Ah… quella che tesseva e scuciva e aspettava mentre il marito svolazzava di talamo in talamo?
AL. Shhh! Ti sente! Quella il telaio te lo fa arrivare in fronte.
PEN. Ahh siii? Di talamo in talamo? Era già tanto se riusciva a
planare nel mio talamo. Ma cosa insegnano a queste moderne? GuarLe mille maschere di Itaca
23
datele, tutte bigotte come Dafne che fugge da Apollo. Rinchiudetele
in un tiaso! Solo Saffo può fare qualcosa!
AL. Alla faccia!
PEN. Eh già! Per venti anni lasciavo essiccare il fiore della mia giovinezza, mai gineceo fu più frequentato! Impara, Afrodite non va mai
in guerra.
ROX. L’antenata delle escort.
PEN. Oh progenie di un centauro! Eris, prendimi, io li spedisco al
Tartaro! Apriti madre Gea, lasciali passare.
G. D’ANN. Calmati buona donna, ignora questi moderni! Non sottraiamo tempi alla dolce Afrodite!
Kavafis
L’Ulisse di Kavafis è una micidiale miscela di reminiscenze omeriche, per
il morboso attaccamento all’avventura, e dantesche, per la curiosità come
primo passo verso la conoscenza.
Itaca
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
24
A cura degli alunni della III A Liceo classico
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. Una mente sterile è un antibiotico, un contraccettivo, un principio attivo
che impedisce di gettarsi verso Itaca.
Itaca è la metafora della vita.
è pellegrinaggio verso se stessi che conduce alla riflessione con se stessi
proprio mentre si è pellegrini. E quello si capisce alla fine, che si è pastori ma
pastori ciclopici.
Bisogna combattere i mostri da titani, bisogna combattere se stessi perché
è la mente umana a originare mostri.
Bisogna ringraziare quei mostri perché é grazie ai mostri che siamo quel
siamo.
Kavafis, insieme a tutti gli altri si sarebbe opposto ai cervelli impacchettati
che provano a venderci come surgelati. E ognuno di loro, Joyce in primis,
credeva che reagire fosse fondamentale. Del perché tutti gli scrittori abbiano
scelto Ulisse crediamo che ormai sia chiaro. Noi lo abbiamo scelto perché
non c’è figura migliore con cui patire un processo contro la cultura totalmente infondato.
Le mille maschere di Itaca
25
Santa Aiello
LA POESIA AMETODICA DI MARIA ZAMBRANO
Quando finisce il gioco dello Jumping e il bimbo esausto si affloscia sulla
molla, tutti i suoi pori sprigionano energia, felicità, emozioni per le tante
cadute, rialzate e salti verso ogni direzione senza un apparente motivo. Come
lo Jumping sono le logiche della poesia vanno in tutte le direzioni e anche
quando sono apparentemente esaurienti celano ancora un’infinita energia
soprattutto quando incontrano la filosofia. E solo l’incontro, fra filosofia e
poesia, fra verità logico-deduttive della ragione e verità intuitive del “cuore”,
produce una nuova forma di conoscenza in grado di cogliere la totalità della
realtà e l’uomo nella sua interezza.1
E, di logiche in logiche, inevitabilmente si naufraga nella logica magnum di
María Zambrano, una delle voci più significative della filosofia contemporanea. Basti pensare alla sua vita, una sorta di via crucis: Valencia, Barcellona,
Parigi, New York, Città del Messico, Michoacán, Porto Rico, Avana, Roma,
Ginevra, Madrid sono le stazioni di María.
Consci della difficoltosa vastità nel tentativo di dire, poiché il dire resta
sempre un mettersi alla prova, un esporsi sul limite di sé, un ex-periri, con
voli pindarici proviamo a delineare, in parte, il pensiero poetico - filosofico
di questa pensatrice spagnola che ha saputo guardare dentro l’esperienza del
vuoto, tenendo insieme il patimento dell’abbandono e le potenzialità inauguranti che il vuoto rilancia e promette.
Solo una ragione “riformata” disposta ad accogliere anche quelle verità non
rischiarate dalla luce dell’intelletto ma, tuttavia, intimamente “sentite”, può
contribuire alla nascita di una nuova conoscenza, più aderente all’interezza
dell’esperire umano. Ecco che allora l’unica forma di conoscenza che possa
Carlo Di Legge, Il signore delle due vie, poetica dell’esperienza originaria, parte II, per una
logica della poesia, Ripostes, pag. 176.
1
LA POESIA AMETODICA DI MARIA ZAMBRANO
29
garantire la “vera oggettività”, intesa come una “presa” dell’oggetto in quanto oggetto, è, per Zambrano, come lei stessa scrive in El realismo español
como origen de una forma de conocimiento2, il realismo come “modo di trattare con le cose”.
Per questo, María Zambrano invita il pensiero ad abbandonare qualsiasi
sistema filosofico, quel “castello di ragioni, muraglia chiusa del pensiero di
fronte al vuoto”, per intraprendere un viaggio fra quelle acque rimaste ancora in gran parte inesplorate, alla ricerca di una “filosofia vivente”, disposta
a confrontarsi con l’essere umano nella sua interezza, disposta, in uno sforzo
intellettuale e viscerale insieme, a dar voce a ciò che resta silente, a celebrare
l’oscurità, l’altro lato dell’esistenza, quello esiliato, muto, nascosto ma profondamente “sentito”.
La vita, infatti, senza pensiero rimane sola e ribelle, mentre il pensiero astratto, puro, “senza vita”, vaga abbandonato non scoprendo altro che se stesso e la propria struttura. E ciò porta l’uomo a vivere in uno stato di delirio:
“se infatti si perde il contatto con la realtà si delira: delira la ragione in una
pura forma senza vita, impassibile e senza tempo; e delira la vita in un vagare
spettrale e senza figura, in una dispersione umiliata e rancorosa”.
Come Heidegger sosteneva che la filosofia doveva tornare alla poesia per
riaversi così la Zambrano sostiene che solo una conoscenza poetica, dalla
“profonda radice d’amore”, nata dalla simbiosi di lucidità intellettuale e di
sapere emotivo, può accogliere anche le verità “dell’altro”.
E, allora, deve esserci un altro pensiero, un pensiero che sia spazio di nascite,
un pensiero che, come un grembo materno, sia in grado di accogliere “l’altro
da sé” in un’unione-nella-differenza, perché: “l’essere è vario non uno”, è “radicale eterogeneità” che per pensarsi richiede mobilità, “continuo spostamento
dell’attenzione” [...]. È allora necessaria la “fede” sia “poetica” che “razionale”
per arrivare a comprendere che l’uno soffre di “incurabile alterità”3.
E sembra di assistere a una danza eraclitea di un’ “armonia dei contrari”,
per mezzo della quale possano coesistere in una “lotta amorevole” tutti i termini in conflitto tra loro senza che né l’uno né l’altro domini definitivamente
la scena dell’esistenza.
María Zambrano indica un sentiero, mostra immagini, figure che possano
2
María Zambrano, El realismo español como origen de una forma de conocimiento, in Pensamiento y poesía en la vida española, Ensayo, Madrid 1996.
3
María Zambrano, La Guida, forma del pensiero, in verso un sapere dell’anima, Cortina, milano 1996, p. 58.
30
Santa Aiello
“innamorare” ed essere seguite; il suo pensiero si fa Guida affinché ognuno
possa, individualmente e personalmente, mettere in forma quel contenuto
impetuoso, caotico, indeterminato e sfuggente che è la vita; la sua parola poetica, mediatrice tra la luce e l’oscurità, tra il linguaggio e il silenzio, tenta di
insinuarsi nelle più profonde caverne delle viscere umane, laddove è rinchiuso e risuona il mistero dell’origine, per rischiararle e risvegliarle cautamente.
Filosofia particolare la sua, in cui pensiero e poesia si nutrono l’un l’altro di
meraviglia, di aprirsi, di lasciar essere.
“Il chiaro del bosco è un centro nel quale non sempre è possibile entrare; lo
si osserva dal limite e la comparsa di alcune impronte di animali non aiuta a
compiere tale passo. È un altro regno che un’anima abita e custodisce. Qualche uccello richiama l’attenzione, invitando ad avanzare fin dove indica la sua
voce. E le si dà ascolto. Poi non si incontra nulla, nulla che non sia un luogo
intatto che sembra essersi aperto solo in quell’istante e che non è mai stato
così. Non bisogna cercarlo. Non bisogna cercare. È la lezione immediata di chiari del bosco: non bisogna andare a cercarli, e nemmeno a cercare nulla da loro.
Nulla di determinato, di prefigurato, di risaputo. E l’analogia del chiaro con il
tempio può sviare l’attenzione [...]. E resta il nulla e il vuoto che il chiaro del
bosco dà in risposta a quello che si cerca. Mentre se non si cerca nulla l’offerta
sarà imprevedibile, illimitata. Giacchè sembra che il nulla e il vuoto o il nulla e
il vuoto debbano essere presenti o latenti di continuo nella vita umana. E che
per non essere divorato dal nulla o dal vuoto uno debba farli in se stesso, debba almeno trattenersi, rimanere in sospeso, nel negativo dell’estasi. Sospendere
la domanda che crediamo costitutiva dell’umano. La funesta domanda alla
guida, alla presenza che si dilegua se la si incalza, alla propria anima asfissiata
dal domandare della coscienza insorgente, alla propria mente cui non si lascia
il tempo di concepire silenziosamente, oscuramente anche, senza che quella si
interponga per domandare il rendiconto alla schiava ammutolita. E il timore
dell’estasi che assale al cospetto della chiarezza vivente fa fuggire dal chiaro
del bosco il suo visitatore, che diventa così un intruso”4.
Qui, nel punto più intimo di questo vuoto spaziale, temporale e identitario
che l’esilio apre e disvela, si avverte la risonanza di una parola essenziale
che Zambrano pronuncia all’inizio della sua narrazione autobiografica, e che
esprime per intero la dimensione dell’abbandono e della nuda presenza: Adsum, ci sono, eccomi, voce e presenza di qualcuno che nell’oscurità del vuoto
Carlo Ferrucci, Postfazione a chiari del bosco, Ed. Impronte Feltrinelli, Milano 1991 (il testo
declamato da Giada Benincasa nella giornata della poesia lo si riporta integralmente).
4
LA POESIA AMETODICA DI MARIA ZAMBRANO
31
si mantiene in contatto con un nucleo luminoso aurorale, inaugurale, quella
“fiamma bianca, certa e lieve […] che galleggia nell’oscurità senza imporsi,
come un dono, e fa sì che l’oscurità, senza essere sconfitta, cessi di regnare e
si ritragga impercettibilmente, senza minaccia di ribellione; come una palpebra socchiusa davanti alla nebbia che si ritira”
Lo scavo interiore che l’esperienza dell’esilio ha portato a termine disegna
i contorni ancora incerti di una radura che si apre davanti allo sguardo, a
uno sguardo rinnovato e reso più puro dal contatto profondo con la propria
finitezza: uno sguardo convertito, capace di cogliere per intero il profilo delle
cose nella penombra della luce aurorale.
In questa radura, in questo orizzonte che si spalanca dalla congiunzione tra
terra e cielo, la patria infine appare, si rivela davanti allo sguardo senza pretese dell’esiliato, che quella patria aveva ormai smesso di cercare, pur senza
mai aver rinunciato alla speranza: “Ormai senza più sete, il suo sguardo non
la intravede nel vuoto lasciato dall’ultimo raggio di sole, né nell’albero caduto che si ostina a rinverdire, né nel ciottolo che, quantunque luccichi un po’,
tutti scansano senza guardarlo, né in nessun’altra parte. Quando ormai si sa
senza di essa, senza alcuna sofferenza, quando ormai non si riceve più nulla,
nulla dalla patria, allora essa gli appare”
Ma proprio nel pieno di questa rivelazione della patria che l’esilio offre, ecco
emergere la paradossalità e l’ambivalenza con cui Zambrano sfida il nostro
bisogno di ancoraggio e di arrivo: “Possiede, la patria vera, la virtù di creare
l’esilio. È il suo segno inequivoco” Un’inversione spaesante, come a dire che la
vera patria non è mai oggetto di una rivelazione intera e definitiva, ma è “sempre incipiente, sempre in atto di nascere”, la vera patria è quella che mantiene
ciascuno in cammino verso se stesso, ovvero verso la propria trascendenza.
Ciò che si profila dunque, a partire dal vuoto dell’esilio, è un viaggio inaugurale verso di sé, un nomadismo esistenziale, il patimento di un’inquietudine
costitutiva che ci rende sempre stranieri a noi stessi, rimpatriati e nuovamente
prossimi all’esilio, varco e soglia per ciò che di noi deve ancora venire. In
quest’oscillare ci si perde e ci si ritrova, ci si eleva e ci si annulla, come onde del
mare o come dune nella notte del deserto: “Un vento ci trasforma / nel silenzio
/ come fossimo / dune di sabbia. / Il vento del tempo / il tempo del perdono. /
Avvolti / sospinti / sospirati / una soglia e poi un’altra / è il nostro abitare”5.
Forse per questo, la Zambrano a differenza di Sofocle non fa morire An
María Zambrano, L’innata speranza: scritti dall’esilio, a cura di Filippo Giuseppe di Bennardo, Palomar, Bari 2006.
5
32
Santa Aiello
tigone. Sepolta viva, si, come in Sofocle, ma non suicida. L’Antigone è un
macro simbolo di equilibrio e di mediazione tra i due contrari per eccellenza
della vita e della morte, dell’essere e del non essere.
Dodici capitoli di monologhi e dialoghi in cui Antigone rivive e ripensa il
suo rapporto con gli altri personaggi della sua storia. I quali, finiscono per
essere meno “altri” e finiscono per diventare più “fratelli”. Ma la tomba di
Antigone è anche il luogo di una nuova forma di luce; una luminosità soffusa e penetrante, che vediamo emanare sempre più nitidamente dall’interno
del suo cuore dalla sua attenzione verso l’“altro”, quanto mai “resistente”,
quanto mai angosciosamente “eterogeneo”, nodi difficili da sciogliere. Ammorbidendo e sciogliendo questi nodi con la forza della sua mitezza, che
questa luce fa maturare quel sogno di radicale trasformazione della condizione umana che è per la Zambrano “correttrice” di Sofocle, ossia la legge
nuova della fraternità.
“No me respondes, hermana. He venido ahora a buscarte. Ahora, no tardarásya mucho en salir de aquí. Porque aquí no puedes quedarte. Esto no es
tu casa, es sólo la tumba donde te han arrojado viva. Y viva no puedes seguir
aquí; vendrás ya libre, mírame, mírame, a esta vida en la que yo estoy. Y ahor
así, en una tierra nunca vista por nadie, fundaremos la ciudad de los hermanos, la ciudad nueva, donde no habrá ni hijos ni padres. Y los hermanos
vendrán a reunirse con nosotros. Nos olvidaremos allí de esta tierra donde
siempre hay alguien que manda desde antes, sin saber. Allí acabaremos de
nacer, nos dejarán nacer del todo. Yo siempre supe de esa tierra. No la soñé,
estuve en ella, moraba en ella contigo, cuando se creía ése que yo estaba
pensando. En ella no hay sacrificio, y el amor, hermano, no está cercado por
la muerte. Allí el amor no hay que hacerlo, porque se vive en él. No hay más
que amor. Nadie nace allí, es verdad, como aquí de este modo. Allí van los ya
nacidos, los salvados del nacimiento y de la muerte. Y ni siquiera hay un Sol;
la claridad es perenne. Y las plantas están despiertas, no en su sueño como
estána quí; se siente lo que sienten. Y uno piensa, sin darse cuenta, sin ir de
una cosa a otra, de un pensamiento a otro. Todo pasa dentro de un corazón
sin tinieblas. Hay claridad porque ninguna luz deslumbra ni acuchilla, como
aquí, como ahí fuera.”
“Non rispondermi, sorella. Sono venuto adesso a cercarti. Adesso non tarderai più molto a uscire da qui. Perché non puoi fermarti qui. Questa non è
la tua casa, è solo la tomba in cui ti hanno gettata viva. E non continuare a
LA POESIA AMETODICA DI MARIA ZAMBRANO
33
essere viva qui, sarai subito libera, guardami, guardami in questa vita in cui
sto io. E adesso si, in una terra vista mai da nessuno, fonderemo la città dei
fratelli, la città nuova, dove non ci saranno né figli, né padri. E i fratelli arriveranno a riunirsi con noi. Non ci dimenticheremo di questa terra dove c’è
sempre qualcuno che comanda da prima, senza saperlo. Lì possiamo nascere,
se ci lasceranno nascere del tutto. Io seppi sempre di quella terra. Non la
sognai, vissi in essa, morivo ivi in essa con te, quando si credeva che io stavo
pensando. In essa non c’è sacrificio e l’amore, fratello, non è circondato dalla
morte. Lì non si può fare l’amore, perché si vive in esso. Non c’è altro che
amore. Nessuno nasce lì, è vero, così come qui in questo modo. Lì vanno
coloro che sono già nati, i salvi dalla nascita e dalla morte. E neanche un sole;
la chiarezza è perenne. E le pianta sono sveglie, non nel loro sonno come
stanno qui; si sente quello che sentono. E uno pensa, senza rendersene conto,
senza andare da una cosa all’altra, da un pensiero all’altro. Succede tutto in
un cuore chiaro privo di tenebre. C’è chiarezza perché nessuna luce abbaglia,
né accoltella, come qui, come lì fuori6.
Questa luce è la stessa luce sfrangiata, baluginante, insieme trattenuta e riverberata, che guida non solo Antigone, ma ogni creatura umana, attraverso i
chiari del bosco dell’esistenza.
E concludiamo con le parole di Rilke, che nell’intimità del logos poetico raccolgono l’interezza di quanto si è tentato di dire:
“Vie della vita. All’improvviso sono i voli
che ci sollevano sulla faticosa terra;
mentre ancora piangiamo le nostre brocche infrante
ci sgorga la sorgente nella mano poco fa ancora vuota”.
María Zambrano, La tumba de Antígona, Siglo XXI, México 1967 (trad. di Rossella De Luca
V E Liceo linguistico).
6
34
Santa Aiello
Clelia Albano
LA PIETRA PERIFRASTICA DI KIKÌ DIMOULÀ
Η ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΕΤΡΑ
Μίλα. Πὲς κάτι, ὁτιδήποτε.
Μόνο μὴ στέκεις σὰν ἀτσάλινη ἀπουσία.
Διάλεξε ἔστω κάποια λέξη,
ποὺ νὰ σὲ δένει πιὸ σφιχτὰ
μὲ τὴν ἀοριστία.
Πές:
“ἄδικα”,
“δέντρο”,
“γυμνό”.
Πές:
“θὰ δοῦμε”,
“ἀστάθμητο”,
“βάρος”.
Ὑπάρχουν τόσες λέξεις ποὺ ὀνειρεύονται
μιὰ σύντομη, ἄδετη, ζωὴ μὲ τὴ φωνή σου.
Μίλα.
Ἔχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας.
Ἐκεῖ ποὺ τελειώνουμε ἐμεῖς ἀρχίζει ἡ θάλασσα.
Πὲς κάτι.
Πὲς “κῦμα”, ποὺ δὲν στέκεται.
Πὲς “βάρκα”, ποὺ βουλιάζει
ἂν τὴν παραφορτώσεις μὲ προθέσεις.
Πὲς “στιγμή”,
ποὺ φωνάζει βοήθεια ὅτι πνίγεται,
μὴν τὴ σῴζεις,
LA PIETRA PERIFRASTICA DI KIKÌ DIMOULÀ
37
πὲς
“δὲν ἄκουσα”.
Μίλα.
Οἱ λέξεις ἔχουν ἔχθρες μεταξύ τους,
ἔχουν τοὺς ἀνταγωνισμούς:
ἂν κάποια ἀπ᾿ αὐτὲς σὲ αἰχμαλωτίσει,
σ᾿ ἐλευθερώνει ἄλλη.
Τράβα μία λέξη ἀπ᾿ τὴ νύχτα
στὴν τύχη.
Ὁλόκληρη νύχτα στὴν τύχη.
Μὴ λὲς “ὁλόκληρη”,
πὲς “ἐλάχιστη”,
ποὺ σ᾿ ἀφήνει νὰ φύγεις.
Ἐλάχιστη
αἴσθηση,
λύπη
ὁλόκληρη
δική μου.
Ὁλόκληρη νύχτα.
Μίλα.
Πὲς “ἀστέρι”, ποὺ σβήνει.
Δὲν λιγοστεύει ἡ σιωπὴ μὲ μιὰ λέξη.
Πὲς “πέτρα”,
ποὺ εἶναι ἄσπαστη λέξη.
Ἔτσι, ἴσα ἴσα,
νὰ βάλω ἕναν τίτλο
σ᾿ αὐτὴ τὴ βόλτα τὴν παραθαλάσσια.
Parla
Dì qualcosa, una qualsiasi.
Soltanto non stare come un’assenza d’acciaio
Scegli una parola almeno,
che possa legarti più forte con l’indefinito.
Dì “ingiustamente” “albero” “nudo”
Dì “vedremo”
“imponderabile”,
“peso”.
38
Clelia Albano
Esistono così tante parole che sognano una veloce, libera, vita con la tua voce
Parla
Abbiamo così tanto mare davanti a noi
Dove noi finiamo inizia il mare
Dì qualcosa
Dì “onda”, che non sta arretra
Dì “barca”, che affonda se troppo la riempi con periodi
Dì “attimo”,
che urla aiuto affogo,
non lo salvare,
Dì, “non ho sentito”
Parla
Le parole hanno inimicizie,
hanno antagonismi
se una ti imprigiona,
l’altra ti libera.
Tira a sorte una parola dalla notte.
La notte intera a sorte
Non dire “intera”,
Dì “minima”,
che ti permette di fuggire.
Minima
sensazione,
tristezza
intera
di mia proprietà
Intera notte
Parla
Dì “astro”, che si spegne
Non diminuisce il silenzio con una parola…
Dì “pietra”,
che è parola irriducibile
Così, almeno
che io possa mettere un titolo
a questa passeggiata lungomare.
La pietra perifrastica è una poesia della raccolta “Το λίγο του Κόσμου”,
L’insignificante del mondo, 1971.
LA PIETRA PERIFRASTICA DI KIKÌ DIMOULÀ
39
L’asciuttezza formale e l’assenza della punteggiatura, nonché il nucleo
tematico principale che è la “pietra”, una monade da cui tuttavia si dislocano molteplici costellazioni di senso, ricorda “Sono una creatura” di Ungaretti, sebbene il tormento che nel poeta è del periodo bellico, in Dimoulà
provenga dal disfacimento postbellico, e si tramuti nella possibilità di fuga
dal dolore creando un dinamismo delle immagini, assente nella lirica ungarettiana, dove invece domina la staticità e l’intransitività. La Dimoulà sembra
tracciare con questa poesia un manifesto di poetica, un invito a rinvenire nel
linguaggio tutta la sua potenzialità liberatoria, una formula che non tenga
l’individuo ancorato alla parola che de-finisce, che de-termina, che preclude
la personale evoluzione insieme all’evolversi della vita. La pietra perifrastica (περιφράζω= riassumo), può riassumere ed unificare la molteplicità
dell’esistenza, può veicolare un contatto, colmare una distanza. Questa poesia è poesia dell’assenza; forse un’assenza concreta, o il sentimento psicologico dell’assenza. L’assenza è un tema ricorrente nelle opere di Kikì Dimoulà.
Assenza come morte, o come lontananza.
“No, non esorcizzo la morte. Aggiungo il mio disgusto per lei al disgusto
che la poesia prova per lei, ma anche per tutto ciò che è stato punito per
essere incerto, breve, nulla di interessante, eccetto il diverso destino che abbiamo meritato. (…) Naturalmente esorcizzo la morte ma nel senso che tento
di conservare con la scrittura tutto ciò che descrivo, come se non fosse morto, come se avesse fatto un lungo viaggio, nella sua forma inalterata”1. Così
risponde K. Dimoulà nel corso di un’ intervista. La logica della sua poesia,
infatti, è volta ad esprimere le immagini della quotidianità, del proprio personale mondo, in una prospettiva tale da sottrarre l’esistenza e la morte, al
chaos. La Dimoulà riesce a creare una perfetta tensione emotiva spesso intessendo la trama delle sue poesie di forti contrasti o suggerendo una sorta di
straniamento al lettore. Lo fa con l’ironia di chi è consapevole della mortalità,
dell’effimero; lo fa da “sfacciata plagiaria”2 abile nel copiare” entrambi il parlare e il cessare di esistere”, quasi a voler significare che la parola è salvezza.
Ha scritto Vrasidas Karalis: “La sua scrittura rivolge la grammatica della
lingua Greca contro il significato delle parole, nel tentativo, in tal modo, di
potenziare il potere emotivo del verso attraverso lo stupore e la sorpresa.
Tutti i suoi versi esprimono la stabilità di un mondo che gli occhi non pos
Intervista a KikìDimoulà, 2011, su Λογοτεχνία Κατεύθυνσης (trad. Clelia Albano).
“The brazenplagiarist” è il titolo di una raccolta di poesie della Dimoula, tradotte in lingua
inglese da Cecile InglessisMargellos e RikaLesser, pubblicata dalla Yale University, 2012.
1
2
40
Clelia Albano
sono vedere, ma che diventa totale tramite la ricostruzione all’interno del
poema come una organica totalità. Questa dimensione di stupore e sorpresa
è diventato un attivo fattore emotivo nella poesia Greca contemporanea. La
poesia della Dimoulà tratta i temi dell’assenza e della dimenticanza come in
un caleidoscopio, dove i colori e le forme si dissolvono e si mescolano allo
scopo di essere ricostruite nell’armonia nascosta e nell’ordine. La sua poesia
trasforma la fluidità in un processo di transustanziazione: l’universo ancora
una volta diviene mondo, l’agonia diviene desiderio, l’assenza appare come
tempo di redenzione. Il linguaggio del poeta riesce a vincere le abitudini e
nega le certezze di una tradizione romantica che manca della visione del tempo perduto come una presenza attiva e continua. La sua poesia, attraverso il
filtro di Eraclito, presenta il mondo migliore di una personale ontologia e lo
determina come materiale sensazionale e fenomeno estetico”3.
Ed Eraclito riecheggia nella volontà della poetessa, di ricercare l’unità nel
molteplice e nel divenire, scavando nella parola fino a raggiungerne l’essenza
che possa stabilire l’armonia dei contrari.
Dimoulà come una rabdomante intercetta nel flusso della vita, nel perpetuo
divenire, ciò che la mente umana non è in grado di vedere perché annebbiata
dalle “vertigini razionalistiche”4; ella chiama le cose ad essere, le invoca dai
luoghi della memoria dove sopravvive, in una dimensione di simultaneità, la
molteplicità dell’esistenza; rinviene la parola irriducibile e totalizzante, dalla
stratificata realtà dei ricordi, dove non vi è distinzione tra i momenti. La
invoca dall’“Ade personale” di ciascuno di noi, scardinando il silenzio e il
potere delle tenebre. Ed è capace di riequilibrare le parole in una simmetria
di analogie tra la memoria e la realtà, tra il microcosmo e il macrocosmo, in
cui esiste la possibilità della “transustanziazione”5 al di là del deterioramento.
“L’anarchia delle parole si vendica della lingua per ogni assenza, per ogni
solitudine, per ogni paura della vita. Terrorizzata dall’esistenza, la Dimoulà
terrorizza la lingua”6.
KikìDimoulà, VrasidasKaralis, Senior lecturer University of Sidney, 2001 (trad. Clelia Albano).
V. Karalis, ibidem.
5
V. Karalis, ibidem.
6
“Αναρχικήτωνλέξεων, παίρνειεκδίκησηαπότηνγλώσσαγιακάθεαουσία, κάθεμοναξιά,
κάθεφόβοτηςζωής. Τρομοκρατημένηαπότηνύπαρξη, ηΔημουλάτρομοκρατείτηνγλώσσα.” Da
ΚικήΔημουλάΣτηντετράγωνηνύχτατηςφωτογραφίας, di Nikos Dimou (trad. Clelia Albano).
3
4
LA PIETRA PERIFRASTICA DI KIKÌ DIMOULÀ
41
didattica e laboratori
A cura di Santa Aiello
SENECA: ADDOLCIMENTO DELLA RAGIONE
Interventi di
Classe V A Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Quando nacque Lucio Anneo Seneca, Roma sovrastava ancora con la sua
potenza la maggior parte del mondo allora conosciuto e conobbe i quattro
imperatori che caratterizzarono il periodo più crudele della storia romana.
Di Tiberio vide la crudeltà, ma non ne fu colpito personalmente, Caligola
gli fu tanto ostile che fu sul punto di farlo uccidere, se l’episodio narrato da
Cassio Dione (LIX 19, 7) ha qualche attendibilità, Claudio gli inflisse l’esilio
in Corsica per volontà della moglie Messalina, mentre la seconda moglie,
Agrippina, ne sollecitò il ritorno e poco dopo Seneca diventò aio di Nerone.
Ma perché queste riflessioni proprio su Seneca? Perché Seneca oltre ad
essere un “classico” ha una capacità di “rinascita” per la sua attualità, universalità, mediazione e perché è figlio di un tempo difficile, proprio come il
tempo in cui viviamo oggi caratterizzato da un’infinita comunicazione, confusione, incertezza immersi in un presente vuoto di significati, e ora come allora, l’uomo era ed è troppo ricco e troppo povero e troppo sapiente. Seneca
ci ricorda che altri sono i valori veri della vita.
Lo ricordiamo per la sua attualità perché questo genere di attualità, che nasce
dalle viscere stesse del nostro presente, può relazionarsi solo con certe Figure
della storia, figure compiute, prospettiche e immortali. E come degli enigmi
hanno bisogno di una nuova interpretazione, perché tutto ciò che appartiene al
passato deve essere rivissuto e chiarito per la nostra vita. L’uomo ha il privilegio
di possedere degli antenati: siamo sempre figli di qualcuno, eredi, discendenti.
Lo ricordiamo per la sua universalità perché ha caratteristiche che riguardano ogni uomo. Seneca è una figura chiara, nitida e duratura della storia
universale al di fuori del paese d’origine. La sua figura ha la corporeità di una
statua e il suo pensiero le fattezze di uno stile e provoca nel lettore mistero
e seduzione perché ci indica una strada che non siamo del tutto convinti di
voler percorrere. Ma questo non deve stupirci, tutti i filosofi antichi danno
SENECA: ADDOLCIMENTO DELLA RAGIONE
47
un’amara medicina fatta di veglia e di astinenza, ossia il risveglio della ragione. Seneca, pur appartenendo alla stessa categoria ha qualcosa di diverso
dagli altri, perché il suo pensiero non ci costringe a nulla, e possiede qualcosa
di musicale, una musica che rassicura, rasserena, addormenta. Quasi come
un medico, un guaritore della filosofia ci porta il rimedio. Un rimedio meno
rigoroso che, più che curare, vuole alleviare: più che svegliarci consolarci.
Lo ricordiamo perché ci attrae e ci attrae perché è un mediatore, specie rara
di uomini. Mediatore tra vita e pensiero, tra l’alto logos della filosofia greca e
la vita umile e miserevole.
Ma, ci piace ricordarlo soprattutto attraverso il pensiero di María Zambrano, entrambi ispanici per nascita ed entrambi “amanti” della filosofia.
E, come la “ragione” di Seneca si presenta come una forma di ragione che,
non è più in antagonismo con la vita ma che, al contrario, si fa strumento per
comprenderla, guidarla e sostenerla, così la “poetica” della Zambrano, non si
isola nella scoperta della propria struttura ma si pone come una cura pronta ad
aiutare l’uomo a vivere e a dar voce e chiarezza alle necessità dell’anima.
Ma, soprattutto, ci piace leggere che la Zambrano attribuisce alla ragione
senechiana l’aggettivo “materna” perché in questo modo, a suo avviso, si
rende maggiormente l’idea di un pensiero che, impietosendosi dello stato di
abbandono della condizione dell’uomo, gli insegna ad accettarla: “Si direbbe
che la ragione si è fatta “madre”, si è riempita di tenerezza materna, per poter
consolare l’uomo in stato di abbandono”1.
Perché, nonostante la scoperta del Logos, la vita continuava ad essere
pesantemente condizionata da una tirannica irrazionalità; “alla malinconia
per lo scorrere del tempo, cosa che sappiamo essere nelle mani della natura,
si è aggiunta ora l’amarezza infinita di sentirsi alla mercé del potere, esercitato nella sua più barbara grandiosità”2.
Sotto l’Impero romano, la condizione umana era ancora più critica di
quando, prima della nascita della filosofia, l’uomo si sentiva soggiogato dalle
imperscrutabili leggi della natura; e, commenta Zambrano, doveva essere terribilmente amaro aver scoperto l’ordine, la figura degli ultimi elementi della
realtà, averla resa trasparente, aver trovato la sua misura, la sua ragione, ed
essere poi costretti a vivere in un mondo senza ragione e senza misura, a vivere in un mondo in cui l’assurdo e il delirio erano la realtà quotidiana.
1
M. Zambrano, Un camino español: Séneca o la rasignación, in “Hora de España” XVII, Barcellona 1938.
2
María Zambrano, Seneca, Bruno Mondadori, Milano 1998.
48
A cura di Santa Aiello
La vita era tornata nuovamente ad essere un incubo, gli antichi e volubili
Dei che la filosofia aveva già sconfitto, sedevano di nuovo al potere, con il
nome di Imperatore.
Nonostante la solitudine e l’amarezza Seneca non si abbandonò alla disperazione ma tornò a diffondere la ragione tra gli uomini, per farli “tornare alla
ragione”. E poiché la ragione pura rivolta alla contemplazione delle idee, così
distaccata dalle cose terrene, non poteva apportare alcun aiuto all’uomo in
quel momento di sconforto, Seneca ricorse ad una “ragione ristretta”, “raddolcita”, pronta a curare le ferite dell’uomo abbandonato a se stesso ed asfissiato dalle tirannie del potere. Uno dei momenti più drammatici della storia,
infatti, è proprio quello in cui la ragione non si adatta alla misura dell’uomo,
e l’uomo rimane solo. Impossibile non notare, a questo punto, una similitudine tra il periodo in cui visse Seneca e l’attuale situazione di crisi in cui verte,
l’uomo contemporaneo.
Proprio per questo motivo oggi Seneca ci viene incontro: stiamo vivendo
un momento analogo di grave crisi storica in cui la scienza ci insegna troppo
e troppo poco al contempo, in cui la ragione, isterilita, non riesce a venirci
in soccorso e a trarci fuori dalla situazione di stallo in cui ci troviamo. …
Abbiamo bisogno della sua amara medicina che ci risvegli e ci faccia accettare una verità che richiede tutto il nostro coraggio, abbiamo bisogno,
a partire dalla nostra confusione e perplessità, di essere persuasi da una
ragione “materna” ad intraprendere una strada che potrebbe portarci più
vicino alla soluzione dei nostri problemi ma che non siamo del tutto sicuri
di voler percorrere.
Ma, in cosa risiede, secondo la Zambrano, la grandezza di Seneca? Nel fatto che, nel suo dispensare consigli, egli si presenta più come un maestro del
genere umano che non come un filosofo nel senso tradizionale del termine,
visto che “la filosofia pura, in realtà, la Ragione, si preoccupa di proseguire il
suo corso, più che di diffondersi”. Seneca incarna una delle figure più positive di uomo, e nonostante la sua persona, in virtù della sua completezza e
della sua saggezza, ci sovrasti, la avvertiamo, allo stesso tempo, come familiare, come un Padre.
Lo sguardo di Seneca non si innalza al mondo Iperuranio, non contempla
le idee, ma si volge, caritatevolmente, verso amici e parenti per consolarli
della morte, della malattia, dell’esilio, della perdita della ricchezza. Eppure,
si domanda retoricamente Zambrano, quando una filosofia si preoccupa di
tutto questo che conosciamo tutti già così bene, è davvero una filosofia? O sta
piuttosto occupando il posto di qualcosa che non è filosofico? [...] No, non si
SENECA: ADDOLCIMENTO DELLA RAGIONE
49
è distratta, anzi è realmente questo il suo compito, la sua ragion d’essere. È la
filosofia, la ragione impietosita della condizione derelitta dell’uomo.
In quel tempo in cui l’uomo, sopraffatto dalla potenza dell’Impero, aveva
abbandonato la Ragione, Seneca lo ammoniva a servirsene ancora per trovare
la giusta misura del vivere, per rassegnarsi a vivere con virtù. Seneca insegnava a sfuggire al desiderio di assoluto che fa troppo spesso dimenticare la
“reale natura delle cose”, che fa credere che siano “nostre le cose in cui ci
muoviamo” quando, invece, dobbiamo essere “pronti a ridare quel che ci è
stato assegnato senza una scadenza precisa e, se siamo convocati, a restituirlo
senza lagnarci”, perché tutte le cose che ci sono state date, siano esse la ricchezza, la bellezza, un figlio o un’amante le abbiamo ricevute in prestito.
La Zambrano, a Marcía, ricorda che è nata mortale ed è madre di creature
mortali e non c’è bisogno di un grande temporale per ridurre in polvere
l’uomo. Tuttavia è crudele perdere un figlio giovane dopo averlo educato,
quando ormai è divenuto sostegno e vanto per la madre e per il padre. …Chi
nega che sia cosa crudele. Ma è cosa umana: per questo sei stata generata,
per perdere, per perire, per sperare, per temere, per tormentare te stessa e gli
altri, per avere paura e desiderio della morte, e, quel che è peggio, per non
conoscere mai la tua reale condizione. La morte è liberazione da tutte le sofferenze, non è né bene né male, tu figlio ha varcato la soglia entro la quale c’è
il limite della schiavitù, lo ha accolto una grande, eterna pace […] I grandi
spiriti non amano indugiare nel corpo ma vogliono vagare alti nell’universo e
contemplare da lassù la misera umanità3.
E solo in virtù della rassegnazione compare la ragione, perché soltanto la
ragione è capace di farcela raggiungere. Perché se non ci venisse in aiuto la
ragione, la rassegnazione sarebbe impossibile, lascerebbe il posto a ciò che
risiede nel profondo ancora prima di lei, a ciò che forza e motiva la rassegnazione, la disperazione”
Rassegnarsi significa non voler alterare in nessun modo l’ordine del mondo,
per strano che possa sembrare; guardarsi senza rancore, avere smesso di vedersi e sentirsi finalmente come qualcosa che è. Significa estirpare, se c’è
mai stata, la tentazione dell’io, della libertà. È come una specie di debolezza
davanti al cosmo: cadere sconfitti senza serbare rancore. Rassegnarsi a vivere,
infine, significa accettare il movimento della vita e “sapersi muovere nella
relatività senza posa che è la vita umana”. Per questo Seneca ha orrore del
dogma, dell’assoluto: la vera misura delle cose si percepisce solo accordando,
Seneca, Consolazione a Marcia in M. Zambrano, Seneca, cit. alla nt. 3, pag. 61
3
50
A cura di Santa Aiello
di volta in volta, il movimento interiore con quello esteriore, è una “questione d’orecchio”, un talento musicale: è un’arte.
La morale si è trasformata in estetica e, come ogni estetica, ha qualcosa di
incomunicabile.
Per questo suo aderire all’uomo concreto, Seneca si rivela come un Padre.
Un padre, volto com’è a modellare il lato ribelle e non ancora formato del
figlio fa leva, da una parte, sull’oggettività della legge vigente nel mondo,
“nella cultura, nel diritto, nella scienza, nel sapere e nella morale, nella religione”, e dall’altra parte fa riferimento “all’intimità del figlio, alla parte eretica, eterodossa e nemica dell’oggettività vigente che possiede ogni uomo in
formazione”. Per questo, Seneca, il sapiente, è un padre molto virile e molto
materno insieme.
Paternità in cui si fonde la maternità, per il sapere che in essa è racchiuso,
fatto della più ermetica intimità, per la persuasione con cui scorre nelle viscere umane. La ragione in questi padri diventa materna, per la sua stessa
rinuncia al proseguimento dialettico, per il suo rifiuto di perseguire l’idealità
[...]. Da logicamente ideale, diventa divinamente materialista, se con materialismo intendiamo l’attaccamento materno al concreto, all’uomo reale, la
rinuncia all’astrazione per non separarsi dalle viscere umane.
…Seneca rende viva, operante, quella forma di sapere che, senza temere
la discesa nella notte oscura del senso, illumina il sentire originario in cui
convergono corpo e spirito, passione e ragione, divenendo, così, mirabile
testimone di quella “ragione poetica”, “materna”, “mediatrice” che, secondo
le parole della stessa Zambrano, si muove nella penombra dell’essere e del
non essere, del sapere e del non sapere, nel luogo in cui si nasce e si dis-nasce,
che è il più appropriato, il più proprio al pensiero filosofico4.
4
M. Zambrano, La “Guida”, forma del pensiero in verso un sapere dell’anima, Cortina, Milano
1996, pag. 58
SENECA: ADDOLCIMENTO DELLA RAGIONE
51
A cura di Eugenia Rizzo
LA POESIA OLTRE LA LOGICA. POESIA COME φάρμακον
“IL CICLOPE DI TEOCRITO”
ΚΥΚΛΩΨ
Οὐδὲν πὸτ τὸνἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο,
Νικία, οὔτ᾽ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ, οὔτ᾽ἐπίπαστον,
ἢταὶ Πιερίδες· κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶἁδύ
γίνετ᾽ἐπ᾽ἀνθρώποις, εὑρεῖν δ᾽ οὐῥᾴδιόν ἐστι.
Γινώσκειν δ᾽ οἶμαίτυ καλῶς, ἰατρὸν ἐόντα
καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλημένον ἔξοχα Μοίσαις.
Οὕτω γοῦν ῥάϊστα διᾶγ᾽ὁ Κύκλωψ ὁ παρ᾽ἁμῖν,
ὡρχαῖος Πολύφαμος, ὅκ᾽ἤρατο τᾶς Γαλατείας,
ἄρτι γενειάσδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε.
Ἤρατο δ᾽ οὐ μάλοις οὐδὲῥόδῳ οὐδὲ κικίννοις,
ἀλλ᾽ὀρθαῖς μανίαις, ἁγεῖτο δὲ πάντα πάρεργα.
Πολλάκι ταὶὄϊες ποτὶτωὐλίον αὐταὶἀπῆνθον
χλωρᾶς ἐκ βοτάνας· ὃ δὲ τᾷ Γαλατείᾳἀείδων
αὐτόθ᾽ἐπ᾽ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσας
ἐξ ἀοῦς, ἔχθιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος,
Κύπριδος ἐκ μεγάλαςτό οἱἥπατι πᾶξε βέλεμνον.
Ἀλλὰ τὸ φάρμακον εὗρε, καθεζόμενος δ᾽ἐπὶ πέτρας
ὑψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα·
Ὦ λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν φιλέοντ᾽ἀποβάλλῃ,
λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, ἁπαλωτέρα ἀρνός,
μόσχω γαυροτέρα, φιαρωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς, φοιτῇς δ᾽ αὖθ᾽
οὔτως ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἔχῃ με, οἴχῃ δ᾽ εὐθὺς ἰοῖσ᾽ὅκκα γλυκὺς
ὕπνος ἀνῇ με, φεύγεις δ᾽ὥσπερ ὄϊς πολιὸν λύκον ἀθρήσασα;
Ἠράσθην μὲν ἔγωγε τεοῦς, κόρα, ἁνίκα πρᾶτον
ἦνθεςἐμᾷ σὺν ματρὶθέλοισ᾽ὑακίνθινα φύλλα ἔξ ὄρεος δρέψασθαι,
ἐγὼ δ᾽ὁδὸν ἁγεμόνευον. Παύσασθαι δ᾽, ἐσιδών τυκαὶὕστερον,
οὐδέ τί πᾳ νῦν ἐκ τήνω δύναμαι·
LA POESIA OLTRE LA LOGICA. POESIA COME φάρμακον “IL CICLOPE DI TEOCRITO”
55
τὶν δ᾽ οὐ μέλει, οὐ μὰ Δί᾽, οὐδὲν.
Γινώσκω, χαρίεσσα κόρα, τίνος οὕνεκα φεύγεις·
οὕνεκά μοι λασία μὲν ὀφρὺς ἐπὶ παντὶ μετώπῳ ἐξ ὠτὸς τέταται
ποτὶθὥτερον ὦς μία μακρά, εἷς δ᾽ὀφθαλμος ἔπεστι, πλατεῖα δὲῥὶς
ἐπὶ χείλει. Ἀλλ᾽ ωὑτὸς τοιοῦτος ἐὼν βοτὰ χίλια βόσκω,
κἠκ τούτων τὸ κράτιστον ἀμελγόμενος γάλα πίνω
τυρὸς δ᾽ οὐ λείπει μ᾽ οὔτ᾽ἐν θέρει οὔτ᾽ἐν ὀπώρᾳ, οὐ χειμῶνος
ἄκρω· ταρσοὶ δ᾽ὑπεραχθέες αἰεί.
Συρίσδεν δ᾽ὡς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδε Κυκλώπων, τίν τε, φίλον
γλυκύμαλον, ἀμᾷ κἠμαυτῷἀείδων
πολλάκι νυκτὸς ἀωρί. Τρέφω δέ τοι ἕνδεκα νεβρώς,
πάσας μηνοφόρως, καὶ σκύμνως τέσσαρας ἄρκτων.
Ἀλλ᾽ἀφίκευσο ποθ᾽ἁμέ, καὶἑξεῖς οὐδὲν ἔλασσον,
τὰν γλαυκὰνδὲ θάλασσαν ἔα ποτὶ χέρσον ὀρεχθεῖν· ἅδιον ἐν
τὤντρῳ παρ᾽ἐμὶντὰν νύκτα διαξεῖς.
Ἐντὶδάφναι τηνεί, ἐντὶῥαδιναὶ κυπάρισσοι,
ἔστι μέλας κισσός, ἔστ᾽ἄμπελος ὁ γλυκύκαρπος,
ἔστι ψυχρὸν ὕδωρ, τό μοι ἁ πολυδένδρεος Αἴτνα
λευκᾶς ἐκ χιόνος ποτὸν ἁμβρόσιον προΐητι.
Τίς κα τῶνδε θάλασσαν ἔχειν καὶ κύμαθ᾽ἕλοιτο;
Αἰ δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτερος ἦμεν,
ἐντὶ δρυὸς ξύλα μοι καὶὑπὸ σποδῷἀκάματον πῦρ· καιόμενος
δ᾽ὑπὸτεῦςκαὶτὰνψυχὰνἀνεχοίμαν καὶ τὸν ἕν᾽ὀφθαλμόν, τῶμοι
γλυκερώτερον οὐδὲν.
Ὤμοι, ὅτ᾽ οὐκ ἐτεκέ μ᾽ἁ μάτηρ βράγχι᾽ἔχοντα,
ὡς κατέδυν ποτὶ τὶν καὶ τὰν χέρα τεῦςἐφίλησα,
αἰ μὴ τὸ στόμα λῇς, ἔφερον δέ τοι ἢ κρίνα λευκά ἢ μάκων᾽ἁπαλὰν
ἐρυθρὰ πλαταγώνι᾽ἔχοισαν· ἀλλὰ τὰ μὲν θέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν
χειμῶνι, ὥστ᾽ οὔ κά τοι ταῦτα φέρειν ἅμα πάντ᾽ἐδυνάθην.
Νῦν μάν, ὦ κόριον, νῦν αὐτίκα νεῖν γε μαθεῦμαι,
αἴκά τις σὺν ναῒ πλέων ξένος ὧδ᾽ἀφίκηται, ὧς εἰδῶ τί ποθ᾽ἡδὺ
κατοικεῖν τὸν βυθὸν ὔμμιν,
Ἐξένθοις, Γαλάτεια, καὶἐξενθοῖσα λάθοιο, ὥσπερ ἐγὼ νῦν ὧδε
καθήμενος, οἴκαδ᾽ἀπενθεῖν·
ποιμαίνειν δ᾽ἐθέλοις σὺν ἐμὶνἅμα καὶ γάλ᾽ἀμέλγειν
καὶ τυρὸν πᾶξαι τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα.
Ἁ μάτηρἀδικεῖ με μόνα, καὶ μέμφομαι αὐτᾷ· οὐδὲν πήποχ᾽ὅλως
ποτὶ τὶνφίλον εἶπεν ὑπέρ μευ, καὶ ταῦθ᾽ἆμαρἐπ᾽ἆμαρὁρεῦσά με
56
A cura di Eugenia Rizzo
70
λεπτὸν ἐόντα.
Φασῶτὰνκεφαλὰν καὶτὼςπόδας ἀμφοτέρωςμευ
σφύζειν, ὧς ἀνιαθῇ, ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι.
Ὦ Κύκλωψ Κύκλωψ, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι;
Αἴκ᾽ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις καὶ θαλλὸν ἀμάσας ταῖς ἄρνεσσι
φέροις, τάχα κα πολὺ μᾶλλον ἔχοις νῶν.
Τ’ὰν παρεοῖσαν ἄμελγε· τί τὸν φεύγοντα διῴκεις;
Εὑρησεῖς Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον᾽ἄλλαν. Πολλαὶσυμπαίσδεν
με κόραιτὰν νύκτα κέλονται,
κιχλίζοντι δὲ πᾶσαι, ἐπεί κ᾽ αὐταῖς ἐπακούσω.
Δῆλον ὅτ᾽ἐν ταῖγαῖ κἠγών τις φαίνομαι ἦμεν.
Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα
μουσίσδων, ῥᾷον δὲ διᾶγ᾽ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν.
Contra amorem, Nicia, nullum aliud remedium est,, nec illitum, ut mihi videtur, nec quod inspergitur, quamPierides: ho minibus leve et suave (remedium)
est, sed facile non est id invenire.
Quodte, cum medicus sis et novem Musis carissimus, bene cognosce reputo.
Sic igitur optime apud nos vitam degebat Cyclops, Polyphemus antiquus, cum
Galateam amaret modo pubescens circum os temporaque.
Nec pomis, nec rosa, nec cincinnis amabat, sed veris insaniis, omnia ab eo levi
momento aestimabantur.
Saepe ipsae oves e virenti pabulo redibant in ovile. Ille autem Galateam canens, prima luce, cupiditate flagrabat in litore algoso, cum odiosissimum vulnus
sub corde teneret, quod magnae Cypridis telum illi in iecur intulerat. Sed remedium invenit, in alta rupe sedens, ad mare spectans, talia canebat:
“Candida Galatea, cur illum spernis qui te amat, coagulo candidior visu, ove
tenerior, vitulo recenti elatior, uva acerba nitidior? Sic vagaris eo loco, cum me
dulcis somnus teneat, abis statim proficiscens, cum me dulcis somnus relinquat,
fugis ut ovis quae lupum canum vidit. Amore tui ardere coepi, puella, cum folia
hyacinthina volens decerpere de monte cum mea matre primum venisses atque
ego vobis praeirem. Cum in te intuitus sim etiam postea, nullo modo prorsus
inde nunc possum desistere te amare. Sed id tua minime interest, per Iovem.
Intelligo, gratiosa puella, cur fugias: quod hirsutum supercilium supra totam
frontem extenditur ex aure ad alteram, ut unum longum, unus oculus subest,
patulus est meus nasus super labrum. Cum ego talis sim, oves mille pasco, et ex
iis mulgens optimum lac bibo. Caseus mihi non deest nec aestate nec autumno,
nec media hieme. Crates semper nimis gravatae. Ut nemo sic Cyclopum, scio
LA POESIA OLTRE LA LOGICA. POESIA COME φάρμακον “IL CICLOPE DI TEOCRITO”
57
me calamum inflare, canens te, qui es meum dilectum malum praedulce, simul
cum me, saepe intempesta nocte. Tibi undecim hinnuleos alo, omnes collare
gestantes et quattuor catulos ursorum. At ad me perveni et nihil minus habebis,
Sine caeruleum mare se illidere in litore.
Pernoctabis apud me suavius in antro. Lauri illic sunt, molles cupressi, hedera
nigra est, vitis dulcem fructum ferens, gelida aqua, divinam potionem quam arboribus abundans Aetna mihi dimittit e candida nive. Quis velit mare aut fluctus habere pro his rebus? Et si ego ipse tibi esse videor hirsutior, e quercu ligna
sunt mihi et ignis qui extingui non potest sub cinere; Patiar etiam meam animam a te incendi et unum oculum quo mihi nihil dulcius. Heu mihi, propterea
quod mater me non genuit pinnas habentem, ita ut ad te versus immergerer et
tibi dexteram oscularer, nisi os cupis, tibi ferrem aut candida lilia aut tenerum
papaver rubra crepitacula habens. Sed haec florent aestate, illa hieme, ita ut non
possim tibi haec ferre ad unum omnia. Nunc profecto, puellula, nunc statim
natare discam, si quis advena navi vehens huc perveniat, sic videbo quidnam
dulce sit vobis profundum incolere. Utinam exeas, Galatea, et, cum exiveris,
obliviscaris domum redire, ut ego nunc hic sedens, velis pascere una mecum et
lac mulgere et caseum facere, coagulum acre iniciens.
Mater mea sola mihi iniuriam infert et illae irascor: numquam prorsus tibi
dixit verbum mihi propitium, cum videret haec facta me infirmum reddere diem
ex die.
Dicam caput et pedes mihi palpitare, sic moerore afficietur, cum ego ipse moestus sim. Cyclops, Cyclops, Quo evolavisti mente? Si ad canistra plectenda eas et,
cum germen colligeris, id agnis feras, celeriter habeas multum plus consilii. Cur
fugientem insequeris? Alteram Galateam invenies, etiam fortasse pulchriorem.
Multae puellae adhortantur me ut ludam cum eis nocte, omnes effusius rident,
cum eas auscultem. Manifestum est me quoque in terra aliquid pondus habere”.
Ita Polyphemus suum amorem canendo pascebat, et melius vivebat quam si
aurum expendisset.
Il Ciclope appartiene alla serie degli Idilli di Teocrito, autore vissuto nel
periodo della fioritura poetica alessandrina (300-260 a.C.), che, per l’influsso
esercitato in età moderna, ha eguagliato, se non addirittura superato, Callimaco. Se è vero che Callimaco fu dotato, come afferma Albin Lesky, di una
“superiorità intellettuale” con cui dominava anche i gesti cortigiani, Teocrito
fu colui che riuscì e riesce ancora oggi a toccare meglio il nostro sentimento.
Il termine idillio compare per la prima volta negli scolii a Teocrito, e, in latino, è usato per la prima volta, per quanto ne sappiamo, da Plinio il Giovane,
58
A cura di Eugenia Rizzo
per indicare poemetti brevi. L’origine del termine è riconducibile al diminutivo di eidoò, piccola descrizione, ma l’espressione, all’inizio, pare non avesse
nulla a che fare con la poesia pastorale. Solo in seguito acquistò quella sfumatura che le è rimasta fino a noi.
Il componimento è incentrato sull’assunto di ordine logico generale,
o priamel, per il quale la poesia è il φάρμακον, il migliore “rimedio”,
οὔτ᾽ἔγχριστον, … οὔτ᾽ἐπίπαστον, “né in unguento … né in polvere”, per
lenire lo stato di malattia indotto in un individuo da un amore non corrisposto. Questo concetto, unito alla realistica constatazione che, comunque,
trovare un tale rimedio non è facile, è espresso già nei primi quattro versi del
componimento che hanno carattere introduttivo, e nei quali compare indicato anche il nome del destinatario: Νικία, Nicia, di Mileto, al quale sono indirizzati anche gli idilli 13 e 28 e l’epigramma 8. Ai versi 5 e 6, apprendiamo,
inoltre, che Nicia è, ἰατρὸὸ, “medico” ed è “caro oltremodo alle Muse”: egli
può, dunque, confermare, alla luce della sua competenza, e meglio di chiunque altro, la validità della tesi precedentemente enunciata.
Ai righi 7-8, inizia la narrazione vera e propria, in terza persona singolare, con
lo stilema oὕτω, e la presentazione dei protagonisti della vicenda: il Κύκλωψ,
definito ὡρχαῖος, “l’antico”, ma che, al tempo dei fatti qui narrati, ci appare
ἄρτι γενειάσδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε, “da poco la barba gli
spuntava attorno alla bocca e sulle tempie”, e Γαλάτεια, Galatea, la ninfa di
cui lui è innamorato. Si tratta naturalmente di una passione non corrisposta.
Da qui scaturisce la frenesia d’amore del Ciclope descritta nei versi 10-18, che
lo induce a trascurare anche le sue abituali attività di pastore, trovando unico
conforto alla ferita che, nel petto, gli ha inferto Cipride, nel canto.
Ed il canto del Ciclope si dispiega per ben 60 versi, da v.19 a v.79, con toni
lirici e sofferti, attraverso immagini attinte dal mondo pastorale a cui Polifemo
appartiene: così Galatea è λευκοτέρα πακτᾶς, “più candida del latte cagliato”, ἁπαλωτέρα ἀρνός,, “più morbida di un agnello” μόσχω γαυροτέρα,
“più altera di un vitello”, φιαρωτέρα ὄμφακος ὠμᾶς, “più brillante dell’uva
acerba”. Il linguaggio è dunque altamente analogico e metaforico.
Galatea respinge colui che la ama e fugge lontano, ὥσπερ ὄϊς πολιὸν
λύκον ἀθρήσασα, “come la pecora che ha visto un grigio lupo”. Polifemo sa
bene che il motivo di tale rifiuto è la propria bruttezza fisica, in particolare le
sembianze del volto, su cui si stende un unico, irsuto sopracciglio che copre
l’unico occhio, ed un largo naso che copre il labbro.
Alla luce di una sua logica ingenua ed al tempo stesso fortemente materialistica, egli crede di poter compensare tali difetti tramite l’ostentazione della
LA POESIA OLTRE LA LOGICA. POESIA COME φάρμακον “IL CICLOPE DI TEOCRITO”
59
prosperità: le mille bestie da pascolo, con i prodotti che ne derivano, come
cacio e latte; le undici cerbiatte e i quattro orsacchiotti.
Ma egli possiede anche una capacità sconosciuta agli altri ciclopi: l’arte di
suonare la zampogna, e di accompagnare il suono con il canto amoroso.
Polifemo non si capacita inoltre di come mai Galatea possa preferire
l’inquietante ambiente marino al rassicurante mondo della terraferma.
Quest’ultimo ha da offrire, in luogo del mare e le onde, δάφναι, i lauri,
ῥαδιναὶ κυπάρισσοι, gli ondeggianti cipressi, ἔστι μέλας κισσός ὸ, l’edera
scura, ἔστ᾽ἄμπελος ὁ γλυκύκαρπος, la vite dai dolci frutti, e ψυχρὸν ὕδωρ,
l’acqua fresca che discende dalle nevi dell’Etna, tutti elementi che appartengono ad una natura boschiva ed incontaminata.
Il suo stesso aspetto irsuto è indicativo del fatto che è anch’egli una creatura di quella natura, paragonabile al legno di quercia, ed alimenta al suo
interno una passione inestinguibile simile ad un fuoco che continua ad ardere
sotto la cenere. L’affermazione che per Galatea sacrificherebbe persino il suo
prezioso occhio contiene un’allusione ironica a quella che sarà la sua sorte
descritta nell’Odissea.
Visto che, però, Galatea non vuol saperne di raggiungerlo sulla terraferma,
egli rimpiange di non essere stato generato con le branchie, perché, in tal
caso, si tufferebbe per raggiungerla recandole in dono gigli bianchi o teneri
papaveri dai rossi petali. Ma la pedanteria con cui, poi, Polifemo sottolinea
che non potrebbe offrire contemporaneamente alla sua bella fiori che sbocciano in stagioni diverse è umoristica.
Ironicamente tragica è l’immagine di questo gigante che nutre la speranza
della venuta di uno straniero che possa insegnargli a nuotare: lo straniero che
approderà nell’isola, Odisseo, non sarà certo disposto ad insegnargli il nuoto.
Perduto nel suo sogno d’amore, Polifemo accarezza la speranza che Galatea
voglia condividere la sua rozza vita di pastore e, infantilmente, si mostra adirato nei confronti della madre, che, ninfa marina come Galatea, non spende
neanche una buona parola in suo favore. Egli si propone, dunque, di impietosirla enfatizzando il suo stato di malessere. Alla fine il φάρμακον di cui egli
si avvale produce i suoi benefici effetti: il Ciclope, scuotendosi dal suo stato
di prostrazione, comincia a pensare che sarebbe meglio tornare alle abituali
occupazioni e rivolgere le proprie attenzioni a qualche altra ragazza, più disponibile di Galatea. Egli infatti dice rivolto a se stesso: Εὑρησεῖς Γαλάτειαν
ἴσως καὶ καλλίον᾽ἄλλαν, “un’altra Galatea troverai, forse anche più bella”,
espressione che ci ricorda quella della nota favola di Esopo: omfakeò eisin
“è acerba”, con cui la volpe bolla l’uva che non riesce ad afferrare. L’idillio
60
A cura di Eugenia Rizzo
termina con una riflessione dell’autore che riprende l’assunto iniziale, secondo la caratteristica composizione ad anello o Ringcomposition: “Polifemo
curava col canto la sua malattia d’amore meglio che se avesse speso denari in
medicine”.
I toni della musa teocritea sono vari e, tra questi, si possono distinguere il
bucolico che può essere definito oggettivo e il bucolico calato nella parodia,
ed entrambi sembrano appartenere a questo componimento7.
Il tema affrontato compare anche nell’idillio 6, Bukoliastai, in cui due pastori cantano di Polifemo e Galatea, ma, per un umoristico capovolgimento della storia, qui è Polifemo che fa la parte dello scontroso. Comunque
l’amore è al centro di molti componimenti teocritei, anche se, come fa notare
Rosenmeyer, Teocrito non appartiene alla schiera di quei poeti che valutano
l’amore come una passione nobilitante o purificatrice. Anzi, egli individua
numerosi espedienti per neutralizzare le ragioni del sentimento d’amore e
quello preferito consiste nel contrapporre il sesso e il puro e semplice innamoramento.
Infatti, in questo Idillio, al verso 75, nel momento in cui ormai la passione sembra aver concluso il percorso della sua insensatezza per incanalarsi
nell’alveo della logica e del buon senso comune, il Ciclope rammenta a sé
stesso, con un’espressione quasi brutale, che ci sono altre vacche da mungere: Τ’ὰν παρεοῖσαν ἄμελγε· τί τὸν φεύγοντα διῴκεις; “mungi quella che
ti è vicina; perché insegui chi fugge?”
Virgilio ha imitato questo carme nella seconda ecloga, ma non ne ha ripreso
il carattere sottilmente ironico, ha, anzi, eliminato di fatto il tono umoristico del suo modello, sostituendo il Ciclope con un comune pastore di nome
Coridone e rinnovando la passione per il giovane Alessi.
Nella trattatistica filosofica antica e nei poemi didascalici, il tema dell’amore
era largamente dibattuto al punto che, nella Vita di Epicuro, si affermava che
il saggio non si innamorava e che l’amore non era una grazia del cielo.
Lucrezio, nel IV libro del De Rerum Natura, rifiutava l’amore per i danni
che esso provocava ai sensi, alla sensibilità e alla capacità di giudizio.
Nella poesia pastorale il tema amoroso è in stretta connessione con la musica, tanto è vero che il Ciclope inizia a cantare proprio perché è innamorato. Si tratta probabilmente della vecchia teoria platonica per la quale eros
fornisce un alimento che aiuta l’uomo nel comporre musica, sia essa intesa
nell’accezione di “filosofia” o di “poesia pastorale”.
Tra le varie chiavi di lettura attraverso cui è possibile proporre questo testo
alla classe, una da perseguire potrebbe essere proprio quella psicologica –
LA POESIA OLTRE LA LOGICA. POESIA COME φάρμακον “IL CICLOPE DI TEOCRITO”
61
letteraria, che consiste nell’illuminare, nell’ambito del contesto poetico, il
sentimento amoroso, nel ricercare come esso si traduca in linguaggio, quali
siano gli impulsi profondi che guidano la scrittura.
è interessante anche sottolineare le corrispondenze o il contrasto tra la realtà interiore ed un dato tipo di paesaggio e di atmosfera: l’innamoramento,
per di più non corrisposto e che non sfocia, dunque, nella passione erotica,
si può controllare entro dei precisi limiti che consentono di non dissolvere il
clima di pace meridiana.
L’amore che non sfocia nel suo appagamento fisico viene quindi mantenuto
in uno stato di sospensione che allieta l’otium senza eliminarne i benefici.
La storia di Polifemo e Galatea, come potremmo definirla con un termine
frequente tra i giovani, è, purtroppo per Polifemo, unilaterale, ma è in grado
tuttavia di ravvivare l’otium dell’esistenza, senza comunque implicare la fine
dell’otium. Il canto, al contrario, è avvertito come completo appagamento
dell’anima. La sfera spirituale, alla fine, prevale su quella fisica: il φάρμακον
non è l’amore carnale, considerato come una distrazione, ma μουσίσδων “il
cantare”, “il comporre versi”.
62
A cura di Eugenia Rizzo
A cura di Alan Consorti III A Liceo Classico
COME OPPRIMENTE LACRIMOSA ACQUA
ASSORBITA DA ARIDA TERRA
INTERPRETAZIONE DELLA POETICA LEOPARDIANA
Interpretare, svestirsi del proprio essere e farlo defluire con lento scorrere
di Crono in altro vissuto, in estranee esperienze, in apparenza lontane o prossime, pura umana convenzione, e congiungerle come opprimente lacrimosa
acqua assorbita da arida terra.
Non esiste, e non può esistere una versione univoca, universale, perché
ogni congiunzione, anche distratta e fugace è unica e irripetibile. Le foglie
del grande albero nel volgere del tediante perpetuo volo delle etadi, pur se
copiose, non saranno mai perfettamente uguali, mai identiche.
Quando poi il pensiero diviene così profondo e ancestrale come nella poesia leopardiana, le risposte non possono che essere molteplici, tante quante
le umane stirpi. Candore e umiltà1, chiavi di volta nel sistema leopardiano,
come sottolineato da Divo Barsotti, rendono accessibile il tortuoso sentiero
che conduce al giogo leopardiano non solo ad eruditi e a menti temprate da
insaziabile studio, ma ad ogni essere vivente e pensante su questo misero
globo, e perché no in futuro anche su altri luoghi percossi da comun sorte.
Si può leggere e fagocitare Leopardi in diversi modi, come testimoniato da
Tina2 sul web, certo il congiungimento sarà diverso, secondo alcuni incompleto, ma pur sempre una fusione, il defluire di un essere in un altro con successivo impellente inevitabile cambiamento irreversibile di entrambe le parti.
Del resto, alla luce del pensiero moderno, possiamo affermare che oggigiorno non esista un unico Leopardi, ma infiniti, tanti quanti le persone che
ha sfiorato, sfiora e sfiorerà. Chi crede che a Leopardi possa accostarsi, possa
avvicinarsi solo chi ha alle spalle anni di sudata retorica non fa che limi
Divo Barsotti, La religione di Giacomo Leopardi, San Paolo Edizioni, 2008.
Tina, che si fa chiamare in rete, Iside 99 – diciannovenne webmaster del sito web www.geocities.com/lericordanze.
1
2
COME OPPRIMENTE LACRIMOSA ACQUA ASSORBITA DA ARIDA TERRA
INTERPRETAZIONE DELLA POETICA LEOPARDIANA
65
tarne il pensiero, perché la continua ricerca, l’irrefrenato chiedersi alla base
di tale “filosofia” non può che scatenare nel lettore il costante interrogarsi
sull’interrogato, come vestale favella mai assopita in presenza di virginee sacerdotesse, così finché la vita resterà tumultuosa querela di ineffabile verità,
l’interpretazione leopardiana potrà ardere nella volgare olimpica sede presente in ogni uomo.
Sia nel titanico spirto, naturale tendenza ad essere consapevole naufrago
in tumultuoso mare, sia in ingenua frivola esistenza, non potrà mancare
l’istante di sorda lancinante richiesta alla muta luna. Proprio questo pensiero
dominante, questa mostruosa pretesa di verità impretendibile, rende eternità
all’opera leopardiana.
In ultima analisi appare così assurdo che l’intera poesia in esame e la nostra
intera esistenza, sia come singoli soggetti che come specie, sia resa eterna e si
riassuma in una concatenazione di domande da ineffabile risposta, immutabile ricerca senza porti.
66
A cura di Alan Consorti III A Liceo Classico
A cura di Rosalba Feo III A Liceo Classico
LEOPARDI, NONNO DEL 1900
Giacomo Leopardi visse il complesso dell’epoca d’oro. Maledì Recanati
e la sua gente, decidendo alla fine, snervato, che fosse meglio ammuffire al
suono delle litanie di Adelaide, sua madre. Mise a pesare l’odio per i Recanatesi e l’odio per quelle parole andate a male. Fu propenso a fossilizzarsi con i
libri, ricucendone così tante volte i tarli da sentirsi di carta, da essere bianco
ma di quel bianco che sa di pallore, con la schiena di creta, l’acido alle ginocchia e niente al cuore.
Il fratello di sua madre, Carlo, che si trovava in Vaticano ventisette ore su
ventiquattro, che caldeggiava affinché Giacomo prendesse altre strade, lo indusse a non tritarsi le ossa su Tasso. Fu un riciclo della famiglia Antici. Glielo
regalarono per il suo quinto o sesto compleanno, cestinando “La Gerusalemme Liberata” dalla loro libreria nel tentativo di inscatolare Gesù Cristo.
Carlo Antici credeva che il cremisi delle vesti cardinalizie avrebbe fasciato
Giacomo alla perfezione. In breve tempo egli diventò una molla, stiracchiato
a destra e a manca. In cuor suo non chiedeva che la pietà di ammollarsi in un
diluvio di poesia. Visse il complesso dell’epoca d’oro perché cominciò con
l’emulazione degli antichi, stemperandosi man mano da quella copia angusta
e chiusa, sbattendo le porte in faccia all’Ottocento.
Si cavò fuori versi melodici anacronistici così da poter competere con i migliori fonosimbolici. Lo stesso Luigi Giussani, critico letterario, lo annovera
tra i parolieri più musicali.
“E mi sovvien l’eterno e le morte stagioni e la presente e viva, e il suon di
lei” (Infinito vs. 12)
Mezza teoria lo rese romantico, poiché si illuse, poiché le rivendicazioni del
1821 gli dilatarono il petto e si disilluse.
L’intrinseco nichilismo dei suoi verso lo serializza accanto a Schopenhauer
e ai grandi del Novecento, la sua alienazione è pari a quella di Kierkegaard.
LEOPARDI, nonno del 1900
69
“Noia e nulla sono la stessa cosa” scriveva nello Zibaldone, “sono figlia
e madre l’una dell’altra”, in ginocchio di fronte al letto, con i calli alle dita
sporche, aspettando che la candela si spegnesse. Fu precursore e padre anche
in tal senso, pur non essendolo mai di carne.
“Ov’ei precipitando il tutto obblia” tra l’altro a favore delle tesi del filosofo
Emanuele Severino.
Sebbene si cominci a parlare di monologo interiore solo a partire dal
Novecento, il “Canto Notturno di un Pastore Errante d’Asia”, accorpa una
meditazione interiore che non ha eguali. “E tu certo comprendi il perché
delle cose e vedi il frutto del mattin, della sera, del tanto infinito andar del
tempo […] dico fra me pensando: A che tante facelle? Che fa l’aria infinita?”
Avrebbe senso, dunque, rider loro in faccia, quando scolasticamente si include nel girone dei “coscienti”, solo James Joyce, solo Virginia Woolf.
Inoltre Leopardi sembra essere lo specchio ante litteram di Italo Svevo.
Entrambi sostenevano che la scrittura fosse lo “sfogo della nevrosi”.
Se non fosse stato poeta sarebbe stato pittore, con quelle sue macchie di impressioni che cuciva all’orlo delle poesie. Soffocava la sua filosofia senz’ossa
negli scheletri di cartapesta che costruiva come preamboli: gli idilli. Fu indisposto tutti i giorni, ferocemente, nei confronti di qualsiasi limite, di qualsiasi
siepe. E fu consapevole dell’amarognola condizione che spetta a qualsiasi
letterato. …Sapeva che la scrittura fosse diversa e contraria e nociva alla vita.
Ella lo avrebbe sempre limato, rendendolo abulico tutti i giorni, disgraziato
tutti i giorni, malato tutti i giorni. E mentre agli occhi di Monaldo appariva
come il più grande dei perdigiorno, egli non sapeva che suo figlio avrebbe
perso tutti i giorni ad ammassare la più malsana delle liriche. Tolstoj, ad esempio, non fu un perdigiorno. Impugnò le armi nel Caucaso, girà l’Europa,
giocò a tennis, inventò le religioni. Leopardi cieco, gobbo, torturato da una
depressione psicotica, intonacato a Recanati, non fu meno grande di lui. Visse
il complesso dell’epoca d’oro, vedendo l’oro negli occhi degli altri credendo
di essere invertebrato quand’egli era gigante.
Fonti principali: “Leopardi” (Pietro Citati) Trattazione (Emanuele Severino) Commenti di Luigi Giussani.
70
A cura di rosalba feo III A Liceo Classico
A cura di Maria Ruocco III B Liceo Classico
POESIA E LOGICA: LA RELATIVITà DEI SISTEMI
La poesia è da sempre considerata come un mezzo necessario alla ricerca
dell’incondizionato, in quanto permette al sentire umano di esprimere la sua
natura con una particolare veemenza e una potenza espressiva che solo in
essa possono essere condensate.
La poesia, questo dilaniante ma anche amorevole mezzo di ricerca, è in
ogni luogo; tanto che lo stesso poeta italiano Gabriele D’Annunzio affermò
che i versi sono nell’aria e chi si cimenta nella composizione lirica ha soltanto
il compito di cercarli.
Il poeta, dunque, deve far si che la poesia venga accresciuta solo dall’”aria”
poiché in essa è contenuto il suo cibo. Egli diviene in questo modo scrittore
che descrive l’animo, un essere senza coscienza che nel momento stesso in cui
genera un verso arricchisce l’umanità per sempre. Detto ciò, come un fiore
selvatico, una domanda nascerà nel lettore:” è possibile affermare che quanto
viene definito poetico possa essere definito anche logico?”.
La logica è una disciplina che ha per oggetto il λόγος, ossia un singolo giudizio
oppure un complesso ragionamento. Il cosiddetto ragionamento perfetto fu
teorizzato da Aristotele, il quale affermò che esso si identifica con il Sillogismo
che è un discorso formato da due premesse e una conclusione. Lo Stagirita,
dunque, pose alla base della logica e dei prodotti che da essa derivano una forte
componente razionale dalla quale nessun pensatore poté più prescindere.
Perciò, se la logica è vincolata a ciò che la ragione conosce seguendo considerazioni oggettive mentre l’io-lirico è vincolato solo alla soggettività dei
suoi versi sembrerebbe impossibile affermare che tra le due vi sia un collegamento, perché l’una nasce dalla riflessione, l’altra dallo stato del cuore
e dalla disposizione dell’animo; infatti Blaise Pascal scrisse: “è inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi princípi, per darvi
il proprio consenso, quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ra
POESIA E LOGICA: LA RELATIVITà DEI SISTEMI
73
gione un sentimento di tutte le proposizioni che essa dimostra, per indursi
ad accettarle”. Eppure lo stesso Aristotele, nella Poetica, collocò la poesia ad
un livello superiore alla storia, quasi vicino alla filosofia perché essa ha per
oggetto l’universale. E così, è proprio l’universale, questo “alto sentire”, che
accomuna due realtà all’apparenza divergenti; ciò potrebbe apparire strano
perché è difficile pensare che un elemento che crea un presupposto di antiteticità o divergenza sia nello stesso tempo un elemento unificatore, ma se si
riflette bene anche questa perplessità risulta infondata.
I greci nell’armonia che regola il moto degli astri videro poesia prima che le
leggi scientifiche, Darwin osservò l’istinto di sopravvivenza in natura prima
di giungere alla formulazione della teoria della selezione naturale della specie, i motivi più complessi che hanno spinto uomini di ogni tempo alla poesia
avevano una forte componente razionale tanto da destare sconcerto a causa
della loro perfezione; si potrebbe continuare così ancora per molto, ma per
molto ancora i risultati sarebbero sempre uguali tra di loro perché nella poesia c’è una logica e nella logica c’è una poesia.
La definizione del rapporto tra le due però non è sempre regolare, non è
sempre la stessa; infatti, come i colori, come le sfumature, come i gusti essa
muta al cambiare del soggetto che giudica tale rapporto. Così ad una bambino apparirà logico anche il muoversi del vento tra le foglie mentre ad un
adulto sembrerà un evento insignificante, quasi come se anche questo non
fosse un dono di natura. Sono gli uomini a determinare il significato delle
cose, anche dei rapporti, dei legami, delle leggi; non esistono cose antitetiche
o coincidenti, la poesia potrebbe essere più logica della logica stessa per un
uomo che in questa ritrova la sua vita, ritrova se stesso.
Perciò il rapporto tra queste due forme va analizzato secondo punti di vista
diversi e, come in una partita a scacchi, le considerazioni che succedono la
prima scelta saranno frutto ma soprattutto conseguenza di questa; astraendo
questo ragionamento, in quanto sarebbe difficile prendere in considerazione
tutti i vari punti di vista poiché questi sono tanti quanti sono gli uomini presenti
sulla terra, è possibile affermare che la logica e la poesia divergono se analizzate
in un’ottica universale, ma sono simili se considerate in un’ottica particolare.
Infine, trascendendo da ogni rigore razionale, è possibile affermare che la
poesia quanto la logica, molte volte, in alcuni uomini, si prefigura come indispensabile perché in essa, forse più che in ogni altra cosa, l’uomo riesce a
trovare un significato che non si fermi in superficie e un perché al dolore, alla
gioia e a tutte le varie e indefinite sfumature del destino umano in un mondo
devastato dagli egoismi.
74
A cura di MARIA RUOCCO III A Liceo Classico
A cura di Nicola Scarano I A Liceo Classico
POESIA E LOGICA
La poesia esclude la logica? È intorno a questo quesito che si articola la
riflessione che segue.
Ne Lo Zingarelli è possibile leggere sette definizioni del termine “poesia”; di queste, ve ne sono due che hanno una rilevanza particolare ai fini di
quest’analisi:
– arte e tecnica di esprimere in versi […] esperienze, idee, emozioni, fantasie e sim. […]
– (fig.) evasione dalla realtà, abbandono a sogni e utopie.
Nel tentativo di rispondere alla domanda poc’anzi accennata, può rivelarsi
utile analizzare la massima opera di colui che è considerato il padre della letteratura italiana: la Divina Commedia. La principale chiave interpretativa di
tale opera non può che non essere l’allegoria.
Cos’è l’allegoria ? Il termine deriva dal greco e significa “dico altre cose”;
ne Lo Zingarelli l’allegoria è definita come la “figura retorica che consiste
nella rappresentazione di idee e concetti mediante figure e immagini con significato diverso da quello letterale”.
Attraverso l’analogia, i concetti che apparentemente sembrano essere illogici ed estranei alla realtà, al contrario, si dimostrano basati su precisi schemi
logici. Per dimostrare la veridicità di questo assunto, basti prendere in esame
soltanto il primo canto della prima cantica della Divina Commedia: l’Inferno.
Prima di addentrarsi nell’analisi specifica del canto, si consideri l’intera opera nel suo complesso e si noti quanto è inerente alla Divina Commedia la
domanda con la quale si è aperta la discussione; è lecito, infatti, domandarsi
se sia logico o meno che un uomo, in anima e corpo, si avventuri in un viaggio nell’Aldilà. Apparentemente sembrerebbe esatta la definizione di poesia
che Lo Zingarelli propone, secondo la quale “poesia” è anche estraniazione
POESIA E LOGICA
77
dalla realtà. Sennonché un elemento fondamentale di questo caposaldo della
letteratura italiana mantiene il lettore “con i piedi per terra”, come si suol
dire: l’allegoria. Tale figura retorica non soltanto conferisce al viaggio, che
inizialmente era apparso irrazionale, una logica di fondo, ma lo dota anche
di un significato profondo e sublime. Qual è la suddetta logica di fondo?
Dante, essendo “pien di sonno”, si è smarrito in una “selva oscura”, dalla
quale riesce ad uscire soltanto grazie all’intervento di Virgilio che, accanto a
Beatrice e poi a San Bernardo, lo accompagnerà nel viaggio nel mondo ultraterreno: chi è vittima del peccato abbandona “la verace via” e si smarrisce in
una dimensione corrotta dalla quale può uscire ricorrendo alla ragione che
porta alla salvezza mediante un processo di purificazione. Tale schema logico
potrebbe così essere espresso:
il “sonno” di cui è vittima comporta lo smarrimento di Dante nella
selva : Virgilio consente a Dante di salvarsi, ma soltanto dopo un
viaggio durato sei giorni = il peccato comporta lo smarrimento
dell’uomo : la ragione consente di salvarsi, ma soltanto dopo un
processo di purificazione.
Più nello specifico, in seguito si potrà constatare quanto la figura retorica
dell’allegoria doti di una schema logico ciò che, invece, potrebbe apparire
irrazionale.
Dante Alighieri incontra Virgilio quando, essendo stato ostacolato nel suo
cammino dalla lupa, ultima in successione delle tre fiere (dapprima la lonza,
in seguito il leone, infine la lupa), sta precipitando verso il basso.
Ma perché le tre fiere? Esiste una logica che sottende questo incontro? In
verità, nella poesia in sé, non si spiegherebbe tale spiacevole difficoltà. La
causa dell’apparizione delle tre belve deve essere ricercata nel significato allegorico. Dante così descrive le tre fiere: la lonza è “leggera e presta molto”, ovvero agile e molto veloce; il leone procede “con la test’alta” (inutile parafrasare); la lupa “di tutte brame sembiava carca ne la sua magrezza”, cioè nella
sua magrezza sembrava carica di tutte le voglie. Dunque, si osservi lo schema:
la lonza : velocità, agilità = la lussuria (o l’incontinenza) : impulsività, velocità nel commettere il peccato
il leone: procede a testa alta = il superbo: incedere a testa alta
78
A cura di Nicola Scarano I A Liceo Classico
la lupa : magrezza = avidità e avarizia : inappagamento, desiderio
insaziabile
Dunque, l’impedimento di Dante nel suo percorso simboleggia l’ostacolo
dei tre peccati (lussuria, superba ed avidità) nel cammino verso la salvezza.
Inoltre, per quanto riguarda la lupa, Dante sostiene che “molte genti fè
già viver grame”. Ma è possibile che una belva faccia vivere miseramente gli
uomini? Sicuramente no. Infatti, l’autore non si riferisce alla fiera, ma al suo
significato allegorico. Se la figura della lupa fosse priva di una logica, basata
sull’allegoria, il verso cinquantunesimo non avrebbe, pertanto, significato.
In un primo momento, il poeta non riesce ad identificare Virgilio; ciononostante, gli domanda aiuto, sia esso “ombra od omo certo”. A tale grido, Virgilio risponde di non essere un uomo, ma di esserlo stato. Ricorda, inoltre, i
propri natali e il motivo per il quale divenne tanto celebre (“poeta fui, e cantai
di quel giusto figliuol d’Anchise che venne di Troia, poi che ‘l superbo Iliòn fu
combusto”). Soltanto allora Dante comprende che il suo interlocutore è Virgilio. Ma perché proprio Virgilio? Esiste una logica alla base di questa scelta?
La scelta di Virgilio come guida per i due regni dell’aldilà è sia intellettuale che affettiva: da una parte, infatti, Virgilio fu uno dei più celebri autori
della tradizione letteraria latina, tanto che, a suo tempo, fu considerato una
divinità degna di onori, preghiere, riti sacri; fu un modello di sapienza, non
soltanto per i suoi contemporanei, ma anche per i posteri; è, infatti, l’allegoria
della ragione. Dall’altra parte, Virgilio è il poeta più caro a Dante, colui che
più di tutti ha contribuito alla sua formazione come scrittore; del resto, egli
stesso scrive “O de li altri poeti onore e lume vagliami ‘l lungo studio e ‘l
grande amore che m’ha fatto cercar lo tuo volume. Tu se’ lo mio maestro e ‘l
mio autore; tu se’ solo colui da cu’ io tolsi lo bello stilo che m’ha fatto onore”.
In queste righe, oltre a ratificare la preminenza di Virgilio sugli altri autori,
Dante sottolinea anche l’influenza che le opere di Virgilio hanno avuto su di
lui, consentendogli di apprendere lo stile tragico, illustre, solenne che gli ha
permesso di raggiungere notorietà.
Anche in questo caso, pertanto, è possibile dare forma ad uno schema che
manifesti la logica di tale scelta e chiarisca la funzione di Virgilio.
Virgilio : guida nel cammino nel mondo ultraterreno = Ragione :
elemento necessario nel cammino verso la salvezza
POESIA E LOGICA
79
Dante menziona poi un veltro (101-111). Sempre ne Lo Zingarelli si legge
la seguente definizione del termine “veltro”: “cane forte e veloce, da inseguimento e da presa […]”. Virgilio ne esprime le principali caratteristiche:
– “non ciberà di terra né peltro”;
– “sua nazion sarà tra feltro e feltro”;
– “di quella umile Italia fia salute”;
– “la caccerà per ogni villa”, riferendosi alla lupa.
Il significato letterale appare oscuro ed illogico: un cane che non si ciba
della terra e di una lega costituita da piombo e simile all’argento; un cane che
nasce tra un tessuto modesto, povero; un cane che dovrebbe essere la salvezza dell’Italia; infine, un cane che respinge una lupa dalle varie città. In verità,
la figura del veltro è costruita su uno schema logico che, al pari degli esempi
precedenti, dipende dall’allegoria. Tutto diviene all’improvviso più chiaro:
il veltro simboleggia un’entità superiore, la cui identificazione è tutt’oggi
oggetto di dibattito; probabilmente si tratta di Arrigo VII di Lussemburgo,
ma è stata proposta anche l’ipotesi di Cangrande della Scala, Gesù Cristo e
Dante stesso. La logica può essere sintetizzata nello schema che segue:
peltro : lega di un certo pregio = denaro : ricchezza, potere economico
terra = beni materiali, relativi cioè al mondo terreno
veltro : personaggio provvidenziale = non cibarsi di terra, né peltro : non essere avido di potere, né ricchezza
Secondo l’ipotesi più accreditata, l’espressione “tra feltro e feltro” alluderebbe al fatto che il veltro sarebbe dovuto nascere in umiltà, essendo il feltro
un tessuto non molto pregiato (anche se, a parere dei primi commentatori,
l’espressione sarebbe equivalente a “tra cielo e cielo”). La logica, pertanto,
è costruita sulla figura retorica della metonimia; lo schema può essere così
rappresentato:
feltro
tessuto poco
pregiato umiltà
Il personaggio provvidenziale, inoltre, avrebbe ristabilito l’ordine in Italia
80
A cura di Nicola Scarano I A Liceo Classico
mettendo in fuga la lupa, ovvero ponendo fine all’avarizia, alla cupidigia ed
al desiderio di potere che dilaniavano la penisola. Dunque, mediante l’analisi
del significato allegorico, l’espressione che poco prima risultava insensata,
appare ora più chiara: la diffusa avarizia avrà fine grazie all’intervento del
personaggio provvidenziale di cui si parlava in precedenza.
veltro : personaggio provvidenziale = scacciare la lupa : mettere
fine all’avarizia, al desiderio di potere
Si potrebbe obiettare e sostenere che la poesia è del tutto estranea alla logica riflettendo sul verso sessantesimo; Dante scrive: “mi ripigneva là dove ‘l
sol tace”. Ma esiste un luogo dove il sole rimane in silenzio? Se così fosse,
di conseguenza, esisterebbe anche un luogo dove il sole parla. Indiscutibilmente, si tratta di una personificazione; ma questa, comunque, non è una
giustificazione: rimane il fatto che ciò che esprime la poesia è finzione e non è
possibile nella realtà (giacché la poesia ammette che il sole parli, la realtà no).
Eppure, anche in questo caso, per quanto paradossale possa apparire, il
verso è basato sulla logica. Ancora una volta, infatti, l’allegoria svolge un importante ruolo di intermediazione tra poesia e realtà: il sole è l’allegoria della
grazia divina; dove la grazia divina è assente, c’è il peccato, ovvero l’oscurità.
Sole : Grazia divina = oscurità : peccato
Alla luce di tale analisi, si può, infine, affermare che la poesia non prescinde la logica. Anzi, in alcuni casi, essa ne dipende addirittura. Se, infatti,
l’immagine del veltro fosse priva di una logica di fondo, come si è già dimostrato, esso non avrebbe alcun senso, dal momento che il significato letterale è assurdo. È, inoltre, possibile sostenere che, considerati gli esempi
proposti, nella maggior parte dei casi, la logica è da ricercarsi nelle figure retoriche, senza il cui utilizzo una poesia risulterebbe poco profonda e, talvolta,
anche priva di senso compiuto. Dunque, il significato di “poesia” proposto
dal dizionario Lo Zingarelli, come “estraniazione dalla realtà”, può essere accettato non perché i contenuti della poesia siano alieni dalla razionalità, ma
perché le forme ed i modi con i quali la poesia esprime i contenuti (che non
sono privi di razionalità, né sono alieni dalla realtà, ribadisco) sono distanti
dai modi e dalle forme consuete di esprimersi; in verità, ritengo che la grandezza della poesia risieda proprio in questo.
POESIA E LOGICA
81
Carlo Di Legge
LOGICA E POESIA / LOGICHE DELLA POESIA.
Cosa s’intende per logica? Secondo antichi e moderni, l’insieme delle procedure attraverso le quali è possibile ragionare in modo corretto e produttivo,
e senza le quali non sarebbe possibile farsi intendere, né produrre qualcosa
di sensato. Il Devoto-Oli afferma che in logica antica si trattava dello “studio
delle leggi e delle funzioni che caratterizzano la struttura del pensiero in sé”,
mentre nel pensiero contemporaneo “la logica è intesa come una disciplina
di carattere matematico che studia le forme del ragionamento deduttivo… in
quanto argomenti in cui la validità delle conclusioni consegue da quella delle
premesse indipendentemente dal contenuto delle proposizioni”.
Cosa vuol dire? Lo vediamo subito, parlando di poesia. Ma allora posso trovare una logica anche nella poesia, o la poesia, per i suoi caratteri espressivi di
emozioni, prescinde dalla logica? Se la poesia è luogo privilegiato dell’emozione
e delle passioni – ammesso che lo sia – anche nell’espressione di passioni e di
emozioni trovo una forma di logica, oppure quelle ne prescindono?
Dunque la domanda diventa due domande: se la poesia rappresenti
l’espressione di emozioni; se l’espressione di emozioni presenti una forma
logica, oppure ne prescinda.
La poesia, per tradizione, esprime emozioni. Ma v’è diversi tipi di poesia,
che vengono raggruppati, per dire in modo molto sommario, nelle forme epica e lirica. Presupponendo che si sappia, in genere, di cosa si tratta, considero
per la forma epica la forma omerica che ci è stata tramandata, per esempio, e
apro a caso l’Iliade: mi trovo a XI, 544-569 della versione di Rosa Calzecchi
Onesti – la descrizione d’una scena di battaglia, in cui Ettore e Aiace Telamonio imperversano senza mai scontrarsi direttamente. Leggo “Allora il padre
Zeus dall’alte vette spavento scagliò contro Aiace,/che si fermò stupefatto,
poi gettò indietro lo scudo,/tremò, guardandosi attorno tra il folto come una
fiera,/voltandosi indietro, ginocchio stento alternando a ginocchio”.
LOGICA E POESIA / LOGICHE DELLA POESIA
85
Seguono due elaborate analogie, che sintetizzo: “Come fulvo leone da un
chiuso di bovi/scacciano i cani e gli uomini dei campi/ … così allora dai
Teucri Aiace, avvilito in cuore,/s’allontanava, a malgrado; tremava per le
navi” (548-57); e 558-69: “E come un asino, quando all’orlo del campo resiste ai fanciulli,/testardo, e molti bastoni sopra di lui son spezzati,/ma esso
entra a mietere il grano folto; i fanciulli/lo battono coi bastoni, ma la forza
è bambina,/e a stento lo spingono fuori, quando è sazio di grano;/così il
grande Aiace di Telamone allora/ … continuamente inseguivano, colpendo
con l’aste lo scudo./Aiace ogni tanto si rammentava della forza infuocata,/e
si voltava indietro e rintuzzava le file/dei Teucri domatori di cavalli, ma poi
tornava a fuggire;/eppure a tutti impediva di andare alle navi veloci”.
Adesso domando se la poesia omerica non trasmetta l’emozione che intende comunicare, e cioè l’emozione dell’infuriare della battaglia, insieme a
quella dello spavento, dello scoraggiamento, del continuo riprendere animo
e forza e sentirsi dominato dal timore e dalla prudenza – diviso com’era,
Aiace, tra i due sentimenti: la passione e furia del combattimento, e il timore
per le navi, che non venissero lasciate allo scoperto. Sembra evidente, sebbene la scelta dei brani non consenta di intendere in tutta la forza la scena,
ritratta nel testo completo in modo assai più violento ed efficace, che la poesia omerica trasmetta forti, o anche brutali emozioni.
Se invece di puntare l’attenzione alle denotazioni emotive, tuttavia, guardo ai nessi logico-sintattici che strutturano il testo, mi pare di intravedere
sùbito la grande chiarezza del testo, che si presta – per un parlante che sia
in possesso di un patrimonio linguistico medio – ad essere inteso presto, o
con poco studio, o con immediatezza. La logica del testo qui suggerisce, con
evidenza, che l’agire e il subire si alternano, tra le parti: Aiace, sopraffatto
dal pensiero del rischio che potrebbero correre le navi, si ritira, ma a tratti
rinviene e fa fronte ai Troiani e ai loro alleati, che allora vengono trattenuti
e fermati in combattimento; i Troiani, nel momento in cui vedono il nemico
ritirarsi, tutt’altro che rassegnati rispetto alla sua forza, riprendono vigore e
lo incalzano, mentre lo fronteggiano difendendosi con efficacia rispetto ai
suoi soprassalti di forza e di orgoglio. Il tutto offre l’impressione di un episodio di lotta di estremo accanimento e ferocia, come di contendenti che stiano
giocando una posta molto alta – l’onore del guerriero famoso, da un lato;
quello, la propria vita e quella delle persone che stanno a cuore, dall’altro.
La logica sottintesa è, dicendo in modo un po’ sommario, che Giove infonde
spavento ad Aiace, secondo lo schema A (Giove) → (infonde spavento) B (ad
Aiace); o che, più precisamente, il timore implica che Aiace esiti e si ritiri, non
86
Carlo Di Legge
senza fermarsi e combattere (P → Q, leggendo “P” = il timore, “Q” = Aiace
esita e/o si ritira, non senza fermarsi a combattere; “→” = implica).
Una logica che possiede un senso, quello del vettore, dunque – il senso
consiste nel trasferirsi del sentimento dominante, il timore, all’azione di Aiace. Lo schema, reso in forma elementare, ovviamente può essere reso più
complesso, in corrispondenza del testo omerico, che non è tanto semplice.
Per logica della poesia può intendersi altro, in questo caso dell’epica omerica?
Di certo, sì: se invece che la logica formale intendo quello che Giambattista
Vico intese per logica poetica, vengono in evidenza le due grandi analogie,
quella con il leone e quella con l’asino, che risultano addirittura scolpite,
rispettivamente, in 548-57 e 558-69. Si dovrebbe allora leggere che come il
leone, in questa circostanza, si comporta in questo modo, così Aiace, a causa
del timore che Giove gl’infonde …, eccetera; ma credo che non ve ne sia bisogno, visto che il testo è così evidente da risultare chiaro e distinto. Dunque,
l’analogia, che per eccellenza è il luogo (tropo) del parlare e pensare poetico
dei primi uomini delle prime nazioni.
Come funziona l’analogia, motore della logica poetica, secondo Vico? Detto
in breve, e tralasciando le implicazioni, anche filosofiche e teologiche, la struttura dell’analogia si fonda “su una somiglianza di relazioni” per cui stabilisco
relazione tra due coppie di termini come in Giovanni, XV, 5 “Io sono la vigna
voi siete i tralci”, e la relazione istituita sarà del tipo “A: B = C: D” ovvero la
vigna A sta ai tralci B come Cristo-vita-e-circolazione (C) sta ai fedeli-singoli
atomi vivi dell’insieme (cfr. M. Corti, I percorsi dell’invenzione, ed. Einaudi,
Torino 1993, pp. 52-56).
Per la verità, l’ultima analogia è tratta non dal linguaggio poetico ma da
quello religioso – a buon diritto, devo precisare; ma, per chi voglia attenersi
al poetico, e sulla base di un esempio che precede, l’analogia è presto fatta:
difatti si dirà che Aiace: Leone = Teucri: cani e uomini dei campi.
Quale differenza passa tra le due logiche, quella formale e quella analogica? All’apparenza nessuna, dal momento che, come si è visto, in entrambi i
casi le si può basare sulle immagini, senza le quali non avrebbe alcun senso
il paragone; in realtà la forma del genere (P → Q) viene usata ancor oggi
nella logica contemporanea delle proposizioni ed è definita valida sempre
(sebbene non sempre vera), nella forma che segue: (P → Q. P) → Q, che
si può anche leggere se (il primo implica i secondo, ed è il primo) allora
il secondo. Questa forma non riguarda in alcun modo la presenza di contenuti, è sempre valida; e, come abbiamo visto, è anche forma logica strutturante del linguaggio dell’Iliade, come di qualunque poesia.
LOGICA E POESIA / LOGICHE DELLA POESIA
87
Dunque le due forme di logica menzionate – quella aristotelico-stoica e
quella analogica – sono entrambe presenti nella poesia: ma, mentre la prima
riguarda il livello formale, che, ho detto, s’interessa delle strutture di forma
sempre valida, a prescindere dal contenuto, la seconda, l’analogia, non può
prescindere dal contenuto, e quindi dal significato; l’analogia insignificante
non sarebbe più analogia – cosa ci sarebbe di somigliante, dal momento che
i significati non si vedono, e ogni somiglianza è legata al significato? – ma i
versi costituirebbero tutt’al più una provocazione, o una evocazione, o voluto
non-senso, come in certi versi surrealisti.
Con ciò non ho detto che, restando in esempio, alcuni versi non sarebbero
poesia. Ma come definire la poesia, allora? Si vedano questi versi di René
Daumal:
Il profeta
Il bambino che parlava in nome del sole
andava per le strade del villaggio morto,
i topi correvano verso i suoi piedi nudi
quand’egli si fermava ai crocicchi.
Il bambino chiamò con una voce colma di galee,
di vele bianche e di pesci volanti,
e gli uomini mutati in pietra
si risvegliarono stridendo (…)
(Il “Grand Jeu”, tr. it. Adelphi, Milano 1967, p. 175).
Qui, in clima surrealista (sebbene con qualche differenza – questi artisti del
Grand Jeu rifiutano, per programma, l’inconscio), la sintassi logica è senz’altro
verosimile: Daumal presenta nessi consueti, dal punto di vista della struttura
della proposizione – del tipo “il bambino che … /andava per le strade del …/”;
e tuttavia il sentore della stranezza si fa vivo alla seconda quartina, perché il lettore si domanda cosa sia, a che cosa si riferiscano le espressioni
“voce colma di galee, vele bianche e pesci volanti,” e
“uomini mutati in pietra/si risvegliarono stridendo”;
se lo domanda, e non risponde perché vi siano chiarissimi significati – anzi,
88
Carlo Di Legge
rispondere per evidenti significati significa spostare nell’incomprensibile tutto il senso – ma perché le immagini usate, tutt’al più, evocano analogie vacillanti e suggestioni belle, ma incerte; e forse proprio qui, nel fascino allusivo,
sta il vero senso della poesia di Daumal.
Ma, almeno, essa conserva i nessi logici che sono abituali nell’uso quotidiano
del linguaggio, sebbene se ne serva per far emergere un contesto di straniamento del senso. Questo, insomma, riguarda il versante semantico o del
significato, ma non la logica usata, che appare usuale.
Si leggano, invece, il terzo e quarto verso della prima famosa quartina delle
Corrispondenze di Baudelaire: “l’uomo va, e foreste di simboli attraversa/che
lo scrutano con occhi familiari e intenti”. (I fiori del male, tr. it. Feltrinelli,
Milano 20086, p. 43). Qui subentra un momento illogico, in un contesto
logico: infatti, mentre tutta la poesia rispetta un andamento consueto, pur
nella enorme significatività e consapevolezza di ciò che sta dicendo, adesso
dovrebbe essere: l’uomo guarda i simboli (con l’occhio della mente, sia pure:
il simbolo è e non è nella natura, in senso pieno); invece Baudelaire dice in
piena consapevolezza che i simboli guardano l’uomo, appunto, dalla natura.
Mi trovo allora di fronte a un tipo di logica che è fondata non sulla irreversibilità – per cui è vero che A guarda B, ma non può essere vero che B
guarda A, perché, alla lettera, il simbolo non ha occhi per guardare – ma sulla
reversibilità.
Anche questo tipo di logica compare ripetutamente e consapevolmente nei
linguaggi umani, tra cui in quello della poesia.
La logica aristotelica si fondava su due valori di verità, quindi può essere
chiamata bivalente. Ma una logica di quest’ultimo genere, di cui ho appena
offerto un esempio, offre la simmetria di proposizioni che sono asimmetriche: tutto quel che il linguaggio ordinario vieta – spesso in poesia è lecito, e
del tutto vero, o né vero né falso.
Nel linguaggio ordinario, dove valgono i due valori di verità, è sempre vero
che mio padre è mio padre e che io sono suo figlio, mentre è sempre falso che
mio padre è mio figlio, e che io sono padre di mio padre.
Ma in poesia può darsi che ciò non sia sempre vero né sempre falso, secondo quel che intendo, e secondo un forza superiore alla mia consapevolezza
– come in teologia: come intendere qui l’ unità delle tre persone? Forse che
il figlio è anche padre? In che senso?
Questo configura un’altra logica, che chiamo simmetrica, con Matte Blnco,
perché ciò che è vietato nella logica ordinaria – ovvero la relazione padreLOGICA E POESIA / LOGICHE DELLA POESIA
89
figlio è asimmetrica nella logica ordinaria, perché non reversibile – diventa
possibile nella logica della poesia (e di altri linguaggi, ribadisco), che pertanto consente la simmetria: A sta con B nella relazione R, ma anche B – assurdamente – sta nella stessa relazione R con A.
Non che la poesia divenga il regno dell’assurdo, ma è il regno della verità
e della realtà in senso più esteso di quanto non contempli il mondo vero e
reale di tutti i giorni: è il mondo senza fine, il mondo dei sentimenti e delle
emozioni.
Pertanto in poesia le due logiche sono compresenti, si presentano in combinazioni infinitamente diverse: si presenta in tal senso la struttura bi-logica
del pensiero linguaggio, assieme alle risplendenti analogie.
E così Borges può scrivere, un po’ da critico un po’ da poeta, come solo lui
sapeva fare, nel suo elegantissimo linguaggio, che “la tecnica dell’anacronismo
deliberato e delle attribuzioni erronee … ci invita a scorrere l’Odissea come
se fosse posteriore all’Eneide, e il libro Le jardin du Centaure di Madame
Henri Bachelier, come se fosse di Madame Henri Bachelier”.
Riferire tali operazioni a una tecnica le confina nella luce della ragione; ma,
a volte, nella vera poesia fa irruzione una diversa e oscura luce, che non appartiene alla ragione, secondo una logica che, tuttavia, mi colpisce, come se
di abbagliante luce si trattasse:
“Di tunnel in tunnel di abbagliamento in oscurità
tendo una mano. Mi ritorna vuota.
Allungo un braccio. Stringo una spalla d’aria”.
(Vittorio Sereni)
90
Carlo Di Legge