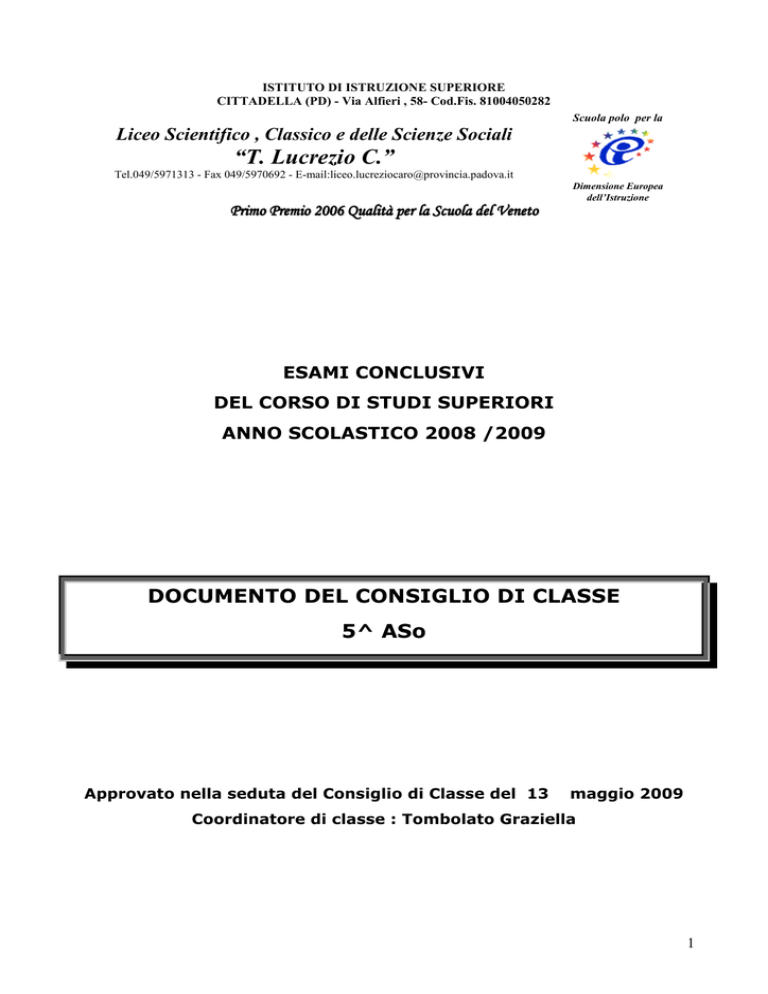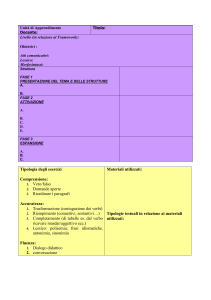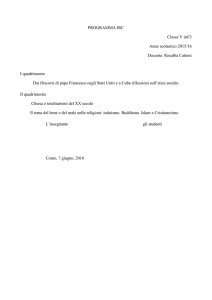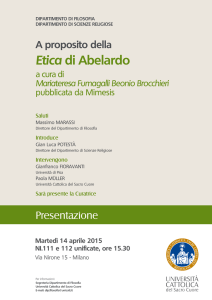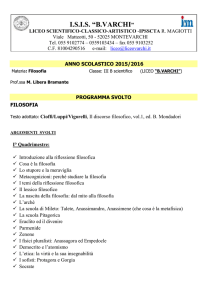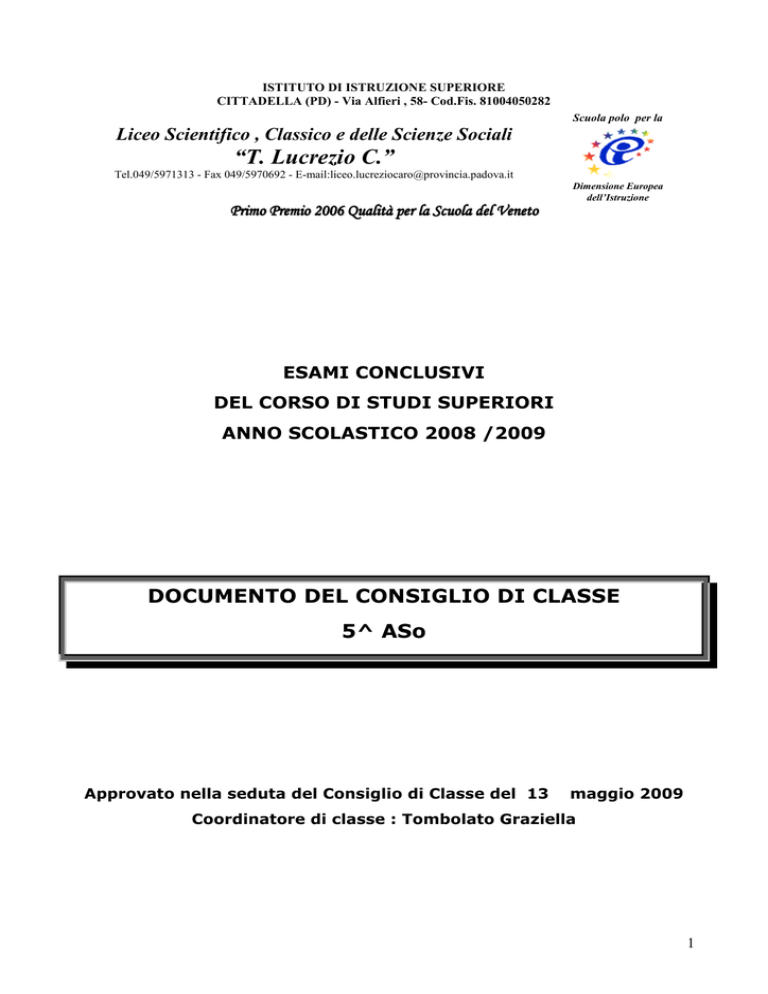
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CITTADELLA (PD) - Via Alfieri , 58- Cod.Fis. 81004050282
Scuola polo per la
Liceo Scientifico , Classico e delle Scienze Sociali
“T. Lucrezio C.”
Tel.049/5971313 - Fax 049/5970692 - E-mail:[email protected]
Dimensione Europea
dell’Istruzione
Primo Premio 2006 Qualità per la Scuola del Veneto
ESAMI CONCLUSIVI
DEL CORSO DI STUDI SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2008 /2009
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5^ ASo
Approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 13
maggio 2009
Coordinatore di classe : Tombolato Graziella
1
PROFILO DELLA CLASSE
1.1Elenco delle materie e dei docenti
MATERIA
DOCENTE
ITALIANO
FIOR FIORELLA
SCIENZE SOCIALI
TOMBOLATO GRAZIELLA
LINGUA LETTERATURA FRANCESE
VALENTIN MANUELA
LINGUA LETTERATURA INGLESE
VITTURELLI DANIELA
MATEMATICA – FISICA
BOLZONELLA PAOLO
STORIA FILOSOFIA
BOTTECCHIA CATERINA
DIRITTO ECONOMIA
MASTROMARINO ANTONIO
SCIENZE
MENDO DANIELA
STORIA DELL’ARTE
CASAROTTO VALENTINA
EDUCAZIONE FISICA
TAFFARA ROBERTO
RELIGIONE
STECCANELLA ASSUNTA
1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Elenco alunni (femmine
ANTONELLO GLORIA
BATTAGLIA ALESSANDRA
BEGHETTO AGATA
BENELLA ALBERTA
BERNARDI ALESSIA
BON ANNA
BUSATTA ELEONORA
CAUZZO VALENTINA
DALLA BONA SARA
FACCIN MARIA
FRISON IRENE
GUERRA GIULIA
MANFIO GIULIA
MARAGNO MARTINA
MARTINI VALENTINA
, maschi) Totale 21 alunni
16
17
18
19
20
21
PIEROBON ELISA
SCAPIN SILVIA
SCARABOTTOLO MARTA
SGARBOSSA GLORIA
ZANCHIN RAFFAELLA
ZOCCARATO GLORIA
1.3 Rappresentanti di classe studenti: Benella Alberta, Zanchin Raffaella
Rappresentanti di classe genitori: Cauzzo Nico
Frison Paolo
1.4
Storia della classe
CONTINUITA’ DIDATTICA
3^
4^
ITALIANO
BRAGA
FIOR
SCIENZE SOCIALI
TOMBOLATO
TOMBOLATO
LINGUA LETTERATURA INGLESE
CORRADI
SETTIMO
LINGUA LETTERATURA FRANCES
LOREFICE
DE AGOSTINI
STORIA – FILOSOFIA
BACCHIN
GUASTELLA
MATEMATICA – FISICA
MENEGAZZO
BIVIANO
SCIENZE
MENDO
MENDO
STORIA DELL’ARTE
GASPARINI
CASAROTTO
EDUCAZIONE FISICA
BUSÀ
BUSÀ
DIRITTO-ECONOMIA
DE VIVO
DI GIORGIO
RELIGIONE
STECCANELLA
STECCANELLA
Alunni
iscritti
Terza
Quarta
Quinta
22
21
21
Iscritti da
altra classe
o ripetenti
2
/
/
5^
FIOR
TOMBOLATO
VITTURELLI
VALENTIN
BOTTECCHIA
BOLZONELLA
MENDO
CASAROTTO
TAFFARA
MASTROMARIN
STECCANELLA
Promossi
Promossi con debito
formativo/sospensione
Non
promossi
21
20
3
1
1
2
1.5
Commento riassuntivo
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 ASo
La classe quinta ASO comprende 21 studentesse; la composizione del gruppo
ha subito nel corso dei cinque anni qualche variazione rilevabile nel prospetto
precedente.
Durante quest’anno scolastico la classe ha vissuto una fase critica, attribuibile
alla difficoltà di adeguarsi alle nuove modalità di studio, richieste dagli
insegnanti. Alla sostanziale diligenza e volontà di apprendere delle
studentesse, rilevata nei precedenti quattro anni di scuola, si è sovrapposto un
senso di fatica e sfiducia generalizzato, che ha inciso notevolmente sia sul
rendimento che sul clima di classe.
Nella seconda parte dell’anno c’è stato un graduale miglioramento nel senso
che le studentesse hanno acquisito più consapevolezza della propria
responsabilità anche nel manifestare il disagio e nell’affrontare i conflitti.
Rimane la sensazione di una certa fragilità (e apatia) di base, dovuta in parte
alla storia della classe che ha subito nel quinquennio, continui cambi di docenti,
come risulta dal prospetto 1.4; in particolare per quanto riguarda l’anno in
corso sono cambiati gli insegnanti di sette discipline (francese, inglese,
matematica, storia, filosofia, diritto ed educazione fisica).
Altra possibile causa della fragilità che contraddistingue il gruppo,può
dipendere dal fatto che le attuali due classi quinte del Liceo sociale hanno fatto
da “apripista” nella strutturazione dell’indirizzo che si è rivelato di una certa
complessità per il numero di materie previste dal curriculum di studi e per la
peculiarità della materia di indirizzo Scienze Sociali, articolata in quattro ambiti
disciplinari: psicologia, pedagogia, sociologia e antropologia.
Le energie psichiche richieste alle studentesse per reimpostare, ad ogni inizio
anno, la relazione con numerosi nuovi insegnanti hanno probabilmente inciso
negativamente sul rendimento della classe, in termini di profitto.
2
SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE
Risultati dello scrutinio finale della classe 4^ (alunni promossi)
Materia
Alunni
promossi
con 6
Alunni
promossi
con 7
Alunni
promossi
con 8
Alunni
promossi
con 9/10
Italiano
Sc. Sociali
Inglese
Francese
Storia
Filosofia
Matematica
Biologia
Scienze
Integr.
Arte
Ed.ne Fisica
Diritto
6
8
15
13
1
6
11
8
6
11
6
3
4
12
12
8
7
5
2
7
3
3
8
3
1
5
2
2
/
/
/
/
/
1
/
/
/
4
5
12
11
2
8
4
1
1
2
Alunni con
sospens.
giudizio
1
1
3
3.
INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE
STAGE CURRICOLARE
Nel corso sperimentale del Liceo di Scienze Sociali, il curriculum di studi prevede nelle classi
terze, quarte e quinte l’attuazione di un periodo di stage obbligatorio.
Le attività svolte durante lo stage hanno permesso agli alunni di confrontarsi con le diverse realtà
ed emergenze sociali del territorio, di affinare le abilità tecnico-pratiche relative alle discipline di
indirizzo, anche in termini di fattiva collaborazione con le agenzie presenti nel Comune e nel
territorio (Asl, ospedale, associazioni di volontariato, terzo settore).
Gli obiettivi specifici hanno riguardato la capacità di interpretare le relazioni sociali avendo
consapevolezza della complessità della persona umana e la capacità di inserirsi in modo attivo con
istituzioni, persone o gruppi, oltre che lo sviluppo e l’incremento di capacità di socializzazione,
progettuali e di orientamento in itinere.
Nella progettazione dello stage formativo si è tenuto conto:
dell’importanza di questa esperienza, così come viene evidenziato nel Piano dell’Offerta
Formativa del nostro Istituto, in cui si afferma che essa “rappresenta il richiamo alla dimensione
pratico-operativa, coniuga il sapere e il fare ovvero le conoscenze e la loro messa in gioco in
settori della realtà sociale, consente all’allievo/a una riflessione su se stesso ovvero sulle proprie
capacità relazionali e lo orienta rispetto alle future scelte di studio e di lavoro”;
della convinzione, espressa dai docenti del Dipartimento di Scienze Sociali, che questa
esperienza debba, ove possibile, differenziarsi durante l’ultimo anno di studio, per offrire agli
alunni/e la possibilità di misurarsi con ambiti diversi della realtà sociale, in base agli studi
compiuti, agli approfondimenti e alle predilezioni personali;
delle possibilità/opportunità offerte dal territorio.
Durante il terzo anno scolastico, le allieve si sono occupate dell’infanzia attraverso
l’osservazione dei bambini in un setting educativo quale quello delle scuole dell’infanzia ponendo
particolare attenzione agli aspetti relazionali e relativi allo sviluppo socio-affettivo rintracciandovi
le conoscenze di tipo psicopedagogico acquisite.
Incontri di approfondimento in preparazione allo stage di terza:
20/01/07 incontro con la prof.ssa Cuman: finalità e modalità di realizzazione di uno stage
curricolare
27/01/07
incontro con insegnante della scuola dell’infanzia: obiettivi e didattica della scuola
dell’infanzia
Nel quarto anno il percorso ha riguardato l’osservazione dei bambini nelle scuole primarie
ponendo particolare attenzione alle metodologie d’insegnamento e alle conoscenze relative allo
sviluppo cognitivo, emotivo, morale, motorio.
Incontri di approfondimento in preparazione allo stage di quarta:
28/11/07 Applicazione della teoria delle Intelligenze Multiple nella didattica scolastica
10/12/07 Incontro con insegnante di sc. Primaria: organizzazione didattica per moduli
4
23 / 1/2008 Partecipazione al Convegno Importanza formativa del gioco
Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato ad un viaggio d’istruzione a Torino per visitare il
SERMIG (servizio missionario giovani-fraternità della speranza).
Nel quinto anno lo sguardo è stato ampliato a situazioni di più vasta portata dell’ambito sociale
nell’ottica dello sviluppo della capacità di lettura della complessità.
Le allieve hanno potuto così completare, nel corso del triennio, l’esperienza diretta dei vari livelli
di ricerca e dei vari ambiti conoscitivi delle scienze sociali mantenendo una coerenza con le
tematiche affrontate nello studio teorico.
ARTICOLAZIONE DELLO STAGE CURRICOLARE RELATIVO ALLA CLASSE
QUINTA
Come negli anni precedenti lo stage formativo si è articolato in tre fasi: preparazione teorica,
percorso di osservazione e stesura delle relazioni sull’esperienza.
Vista la rilevanza dell’impegno, della congruenza con la progettazione del Consiglio di Classe e
del consistente numero di ore dedicate all’attività, nonché dell’importanza dei problemi affrontati,
sembra auspicabile dedicare, durante l’Esame di Stato, uno spazio adeguato all’esposizione dei
lavori.
Il percorso è stato effettuato dalle classi quinte dell’indirizzo di Scienze sociali in diverse tappe
distribuite nell’arco dell’anno scolastico:
Incontri preparatori allo stage secondo il seguente calendario:
il 17/09/2008 Docenti dell’Università di Forlì, corso di Economia Sociale
il 16/10/2008 Informagiovani sui bisogni del territorio in ambito sociale
il 22/10/2008 Incontro con il Responsabile del settore sociale ASL 15 di Cittadella
Stage curricolare:
dal 3 al 10/11/2008 effettuazione stage presso le strutture del territorio. Giornata di restituzione
attraverso presentazione dell’esperienza individuale al gruppo classe.
Elaborazione della relazione finale sull’esperienza di stage
Incontri di approfondimento su tematiche specifiche:
il 16/01/2009 Introduzione alla metodologia della ricerca
il 22/01/2009 Incontro sul tema dell’antropologia e del suo ruolo nella società contemporanea
Gli ambiti di realizzazione dello stage sono stati diversificati in modo da consentire la continuità e
l’integrazione delle esperienze osservative già effettuate negli anni precedenti, sia dal punto di
vista metodologico sia da quello contenutistico.
Scopo dello stage curricolare del quinto anno è l’orientamento per le scelte future: a tal fine si è
optato per una scelta personale e libera delle strutture presso le quali effettuare lo stage, nel rispetto
delle attitudini, motivazioni e competenze teoriche acquisite nell’arco dell’intero percorso
formativo.
Attività a cui ha partecipato tutta la classe nel corso di quest’anno scolastico
- Partecipazione al progetto CHI RI-CERCA TROVA
Attività a cui ha partecipato parte della classe
- Partecipazione al progetto OLIMPIA E …….DINTORNI
- Partecipazione ai giochi matematici KANGOUROU
- Partecipazione alla giornata SCUOLA APERTA prevista dal Progetto ORIENTAMENTO IN
ENTRATA
- Partecipazione al convegno la creatività delle nuove generazioni: una scommessa
educativa
5
Attività pluridisciplinari
PROGETTO IL MIO DIRITTO …I DIRITTI DEGLI ALTRI
4.OBIETTIVI TRASVERSALI
Educativi:
- Rispetto del Regolamento di Istituto
- Sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva
- Apertura a mettersi in discussione per giungere,attraverso il confronto, a una migliore
definizione di sé
- Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri
atteggiamenti
- Motivazione ad affrontare le attività di orientamento in uscita e a prepararsi all’Esame di
Stato
- Consapevolezza delle proprie capacità,attitudini e preparazione
- Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori
della solidarietà
- e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della Costituzione
italiana ed europea.
Didattici:
- Affinare la capacità di autovalutazione e di riflessione critica e autonoma
- Avviare allo sviluppo della capacità di analizzare, sintetizzare ed elaborare informazioni
espresse in linguaggi diversi da quello testuale
- Avviare all’individuazione della complessità dei problemi, della loro natura
pluridisciplinare, per isolarne gli aspetti fondamentali e definirne i confini
- Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche diversi da
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare
- Affinare la capacità di lavorare in equipe
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta,un
discorso usando una terminologia appropriata e il lessico specifico attinente le varie
discipline.
7
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
7.1
Criteri adottati
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al POF e per quelli specifici relativi
ad ogni disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni
finali dei docenti
7.2
Numero di verifiche effettuate nell'anno scolastico e tipologie di prove
Materia
Interrogazioni Compiti scritti Compiti scritti
(tema, analisi
(n. medio per
(problemi,
del testo, saggio casi esercizi)
studente)
breve ecc)
Italiano
Scienze Sociali
Inglese
Francese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Disegno-Arte
3
4
3
3
3
3
2
2
5
4
1
1
Prova
strutturata o
semistrutturata
Simulazione
terza prova
5
1
2
4
2
2
2
7
4
1
3
1
2
2
1
6
6
6
Diritto
4
8
2
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME
8.1
La struttura della prova
Sono qui di seguito riportati i criteri generali per lo svolgimento delle simulazioni di terza prova
scritta :
•
Numero di simulazioni per l'intero anno scolastico : 3
•
Periodi di effettuazione: 1DICEMBRE 6APRILE 6MAGGIO
•
Durata della prova: 3 ORE
•
Numero di materie: 4
•
Tipologia dei quesiti: B
8.2
Prove effettuate
1 DATA: 1-12-08 Tipologia B MATEMATICA FRANCESE INGLESE FILOSOFIA
2 DATA: 9- 4- 09 Tipologia B FISICA FRANCESE STORIA DIRITTO
3 DATA: 6- 5 -09 Tipologia B MATEMATICA DIRITTO FILOSOFIA FRANCESE
.8.3
Valutazione delle prove
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate.
8.4
Risultati delle simulazioni
(Medie in quindicesimi)
<10
10-11
1° prova
12
7
2° prova
11
8
3° prova
11
8
12-13
2
1
1
14-15
Media globale
9,5
9,9
9,7
Medie delle singole discipline nelle simulazioni (in quindicesimi)
Prima simulazione:
MATEMATICA
FRANCESE
INGLESE
FILOSOFIA
Alunni
presenti
Media in quindicesimi
12,2
9,9
7,1
9,3
21
Seconda simulazione:
Media in quindicesimi
FISICA
10,4
FRANCESE
10,5
STORIA
8,9
DIRITTO
9,7
Alunni
20
presenti
Terza simulazione
MATEMATICA
DIRITTO
FILOSOFIA
FRANCESE
Alunni
presenti
Media in quindicesimi
8.4
9,5
9,9
10,8
20
7
Allegato 1: Testi terze prove
PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D’ESAME
Data 1 dicembre 2008
Tipologia B: quesiti a risposta singola.
Rispondi ai quesiti utilizzando al massimo 10 righe per quesito
INGLESE
1) Charles Dickens once wrote: “My satire is against those who see figures and averages, and
nothing else – the representative and most enormous vice of this time”. Explain what aspect/s
of Victorian society he is criticising.
2) Write down one main argument for and one main argument against imperialism during the
Victorian Age.
FRANCESE
!) Les préjugés sont présents dans la vie quotidienne. Donnez une définition de ce terme et
expliquez son importance relativement au racisme. (50 mots environ)
2)Expliquez le terme “éducation négative” de Rousseau (50 mots environ)
3)Quels sont les points les plus importants dans l’éducation des jeunes filles présentés dans
l’Emile?Partagez-vous l’idée de Rousseau à propos de cette éducation? Justifiez votre réponse!
(60 mots environ)
FILOSOFIA
1) Ogni soffrire non è null'altro se non inappagato e contrariato volere: lo stesso dolore del
corpo, quando questo vien ferito e distrutto, è in quanto dolore unicamente possibile per il
fatto che il corpo non è se non la volontà medesima fattasi oggetto.
(A. Schopenhauer, II mondo come volontà e rappresentazione)
In che senso il dolore è via d'accesso al noumeno secondo Schopenhauer?
2)Razionalità e casualità nella filosofia di Hegel e in quella di Schopenhauer.
MATEMATICA
1) Della seguente funzione determina il campo di esistenza, le intersezioni con gli assi, la
positività e le eventuali simmetrie:
x2 + 1
f(x) = ————
x2 – 1
2) Applicando la definizione di limite, verifica il seguente limite:
5
lim
——— = 0
x→ ± ∞
2x – 1
3) Dopo averne individuato la forma indeterminata, calcola il seguente limite:
x2 + 1
lim
————
x→ – ∞
x2 – 1
SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA:
DATA 6 APRILE 2009
Tipologia B: quesiti a risposta singola.
Rispondi ai quesiti utilizzando al massimo 10 righe per quesito.
FISICA
1) Il fisico scozzese Robert Wattson (1892 – 1973) costruì, nel 1935, il radar, primo sistema
elettronico di rilevazione e radiolocalizzazione, attualmente in uso in ambito militare e civile.
8
Sei in grado di descrivere il principio di funzionamento di tale strumentazione?
2) Mediante i famosi esperimenti coi piani inclinati, Galileo Galilei (1564 – 1642) smentisce la
concezione aristotelica secondo la quale su un corpo deve agire una forza perché esso possa
rimanere in moto a velocità costante.
Su quali fondamentali punti si basava il ragionamento dell’illustre studioso italiano ?
DIRITTO-ECONOMIA
1)La nostra Costituzione pone al centro dell’ordinamento il Parlamento. Secondo te quali sono
le ragioni che motivano tale affermazione?
2)Spiega la concezione tradizionale dell’equilibrio sul mercato dei capitali e descrivi le ragioni
per cui Keynes era radicalmente in disaccordo con tale teoria.
FRANCESE
1) Le Déserteur de Boris Vian a été écrit dans une période « chaude » de l’histoire
française. Décrivez les circonstances historiques de l’époque et dites quel message
l’auteur voulait transmettre par sa chanson. (50 mots environ)
2) La guerre d’Algérie a profondément marqué l’histoire française. Qui étaient les
protagonistes de ce conflit et comment ce pays est-il arrivé à son indépendance ? (50
mots environ)
3) Dans son célèbre roman Voyage au bout de la nuit, Céline raconte le sort de Ferdinand
Bardamu lors de la Première guerre mondiale. Résumez l’extrait que vous avez lu en
classe et dégagez son attitude face à la guerre. (50 mots environ)
STORIA
1)Riassumi le tappe fondamentali del passaggio dalla fase legalitaria del fascismo al regime.
2) Illustra i tratti fondamentali della concezione che il fascismo aveva della donna e della
famiglia.
TERZA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:
DATA 6 maggio 2009
Tipologia B: quesiti a risposta singola.
Rispondi ai quesiti utilizzando al massimo 10 righe per quesito
FRANCESE
1) Dans les extraits que vous avez lu de L’Etranger de Camus, le caractère du protagoniste
se profile très nettement. Décrivez Meursault et expliquez sa conformité à la pensée
existentialiste que Camus représente. (70-100 mots)
2) Présentez le poème Barbara de Jacques Prévert du point de vue de son contenu. La
bipartition du poème est marquée par un vers-charnière important (« Quelle connerie la
guerre »);que signifie-t-il ? (70-100 mots)
3) Le rôle du Président de la République est plus important en France qu’en Italie.
Comment le Président de la République Française est-il élu et quelles sont ses
fonctions ? (70-100 mots)
9
DIRITTO
1.
Il Governo per potersi insediare ed operare deve godere della fiducia del Parlamento.
Spiega in quali occasioni e con quali atti formali si manifesta tale rapporto di fiducia tra
Parlamento e Governo.
2.
Secondo Keynes la Banca Centrale e il Governo agendo, rispettivamente, sul tasso di
interesse o/e sulla spesa pubblica sarebbero in grado di sostenere la domanda globale e
quindi elevare il reddito globale; descrivi, con le parole, come argomentava la sua tesi.
FILOSOFIA.
1. “È legato all'essenza del loro compito che tutte le costruzioni tipico-ideali debbano
tramontare, ma che al tempo stesso nuove siano sempre indispensabili”. Spiega questa
affermazione di Max Weber richiamando alcune caratteristiche dell'idealtipo weberiano.
(10 righe di risposta)
2. Indica quali sono le differenze tra il tempo spazializzato della fisica e la durata secondo
Bergson. (10 righe di risposta)
3. “Per esempio, un oscuro desiderio è diventato a poco a poco una passione profonda.
Vedrete che la debole intensità di questo desiderio consisteva innanzi tutto nel fatto che
esso vi sembrava essere isolato e come come estraneo a tutto il resto della vostra vita
interna. Ma, piano piano, esso ha penetrato un maggior numero di elementi psichici,
tingendoli, per così dire, del proprio colore; ed ecco che ora il vostro punto di vista
sull'insieme delle cose vi sembra mutato”.(Bergson, Saggio sui dati immediati della
coscienza) Spiega queste parole di Bergson facendo riferimento alla sua concezione dei
fenomeni psichici. (10 righe di risposta),
MATEMATICA
1) Stabilire se le seguenti funzioni verificano le ipotesi del teorema di Cauchy e, in caso
affermativo, trovare i punti dell’intervallo che verificano il teorema:
x3
f(x) = —— + 3 x , g(x) = x3 + 2 x
in [ -1, 3 ]
3
2) Applicando il teorema di De L’Hospital calcolare il seguente limite:
ex + 3
lim
—————
x→+∞
4 + 3 e3x
10
GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE E INGLESE, FILOSOFIA E
STORIA
1.
2.
3.
4.
Conoscenza, completezza e pertinenza delle informazioni da 1 a 5 punti
Capacità di analisi e sintesi da 1 a 4 punti
Coerenza argomentativa da 1 a 3 punti
Correttezza formale ed uso di un linguaggio specifico da 1 a 3 punti
Scorretta,
lacunosa e non
pertinente
Parziale e
approssimativa
Essenziale
Chiara e
abbastanza
approfondita
Precisa,
completa e
pertinente
1
2
3
4
5
Conoscenza,
completezza e
pertinenza
delle
informazioni
Totalmente carente
Poco efficace
corretta
Puntuale ed
efficace
1
2
3
4
Capacità di analisi
e sintesi
Contraddittoria e
disorganica
corretta
Scorrevole ed organica
1
2
3
Coerenza argomentativa
Impreciso e non
appropriato
Globalmente corretto e
appropriato
Scorrevole e appropriato
1
2
3
Correttezza formale ed
uso di un linguaggio
specifico
GRIGLIA di VALUTAZIONE DIRITTO – ECONOMIA,
INDICATORI
DESCRITTORI
Pertinenza, completezza
e
correttezza delle
conoscenze:
1
Conoscenze non
pertinenti o
scorrette.
Capacità di
elaborazione e di
sintesi:
0,5
Non individua alcun
concetto chiave.
Competenze
espositive e padronanza
del
lessico specifico.
2
3
Conoscenze lacunose o Conoscenze essenziali e
frammentarie e
sostanzialmente
imprecise.
corrette.
4
Conoscenze
esaurienti
e corrette.
1,5
Individua i
concetti chiave, dandone
una esposizione molto
schematica.
2
Articolata e
coerente.
1,5
Linguaggio
corretto con lessico
essenziale.
2
Esposizione chiara e
corretta, svolta con
lessico specifico.
1
Disorganica o coglie
solo alcuni concetti
chiave.
1
Linguaggio
impreciso e lessico
carente.
0,5
Linguaggio
scorretto.
5
Conoscenze
approfondite e
corrette.
2,5
Completa, organica e
puntuale.
2,5
Esposizione
fluida e precisa, con
padronanza
del lessico
specifico.
IL VOTO COMPLESSIVO E’ ESPRESSO IN DECIMI.
Se la trattazione non è svolta il voto è l.
Tabella di corrispondenza decimi - quindicesimi:
DECIMI
1
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,4-7,2
7,3-7,9
8,0-8,8
8,9-9,6
10
QUINDICESIMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA/FISICA
Indicatori
Gravemente
insufficiente
3-4
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
5
6
7
8
9-10
6-7
8-9
10
11-12
13-14
15
conoscenze
inesistenti o
molto
scorrette e
lacunose
conoscenze
imprecise e
frammentarie
non colto o
travisato il
senso della
questione
proposta
trattazione
divagante o
solo
marginalmente
attinente
alla questione
proposta
trattazione
attinente alla
questione che
non viene però
approfondita in
tutti i suoi
risvolti
Argomentazione Contraddittoria
e
inconcludente
poco fondata e
in parte
incoerente
schematica ma
coerente
disarticolata e
farraginosa,
non sa
individuare i
concetti
chiave
Totale
mancanza di
padronanza
nel linguaggi
specifici,
esposizione
confusa e
frammentaria
imprecisa e
generica, coglie
solo
parzialmente i
concetti chiave
chiara, ma
schematica, sa
individuare i
concetti chiave
linguaggio
approssimativo
e talvolta
scorretto,
esposizione
difficoltosa e a
volte involuta
linguaggio
semplice, ma
corretto,
esposizione
schematica, ma
essenziale
Punteggio
X/10
Punteggio
Y/15
Descrittori
Completezza e
correttezza delle
conoscenze
Pertinenza alla
questione e
capacità di
cogliere ì
problemi
Capacità di
elaborazione e
sintesi
Padronanza dei
linguaggi
specifici
e competenze
espositive
conoscenze non
conoscenze
approfondite
chiare e corrette
ma
in sostanza
corrette
conoscenze
approfondite
conoscenze
molto
approfondite,
prodotto anche
di un percorso
individuale di
ricerca e
rielaborazione
critica
trattazione
trattazione che
trattazione che
puntuale della
esaurisce in
non solo
questione
modo esaustivo
esaurisce in
proposta
la questione
modo esaustivo
proposta
la questione
proposta, ma
allarga
problematica
mente
i suoi termini
ordinata e
rigorosa e
rigorosa e
coerente
fondata
aperta alla
problematizza
zione
critica
articolata e
completa ed
organica e aperta
coerente, sa
organica, coglie alla problematizza
individuare i
i concetti
zione
concetti chiave
chiave, li
critica e
e fare
relaziona con
all'intreccio
collegamenti
elasticità
interdiscipIinare
padronanza
esercitata
esercitata
nell'uso dei
padronanza
padronanza
linguaggi
nell'uso dei
nel l'uso dei
specifici,
linguaggi
linguaggi
esposizione
specifici,
specifici,
chiara e
esposizione
esposizione
efficace
fluida e precisa fluida, rigorosa,
elegante
12
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE: FIORELLA FIOR .................................................... anno scol. 2008-2009
Materia: ITALIANO
Classe: V A sociale
Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativi-cognitivi
generali che sono stati riportati nella programmazione comune del consiglio di classe
e ai quali il presente programma svolto fa riferimento.
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, nella quale ho insegnato anche lo scorso anno scolastico, è composta di 21
studentesse che nel complesso hanno cercato di impegnarsi, in base alle loro possibilità, nel
seguire in modo costante il percorso proposto per questa disciplina.
La situazione di partenza, dal punto di vista delle conoscenze, era discreta e si è mantenuto
un livello di discreta collaborazione e partecipazione alle attività disciplinari proposte durante
l’anno.
La classe si è mostrata sufficientemente motivata nell’apprendimento della disciplina e ha
cercato di rispondere alle sollecitazioni che l’insegnante ha proposto durante lo svolgimento
del programma.
Le maggiori difficoltà sono state incontrate nello svolgimento dei compiti scritti, soprattutto
nella trattazione approfondita dei contenuti proposti dalle tracce. Il livello di preparazione
può essere distinto in tre fasce: un gruppo di studentesse preparate e interessate alle
tematiche proposte, un secondo gruppo di allieve con conoscenze e competenze che si
attestano su un giudizio discreto e un terzo gruppo che ha conseguito risultati appena
sufficienti sia nella produzione scritta che orale.
CONOSCENZE
a) conoscere le linee essenziali della letteratura italiana dalla fine del 1700 al 1900,
relativamente ai principali autori e generi affrontati;
b) conoscere le opere letterarie e i testi più significativi dei periodi letterari presi in esame
nel corso dell'anno;
c) conoscere caratteristiche tipologiche e strutture formali delle opere letterarie considerate;
d) conoscere le principali vicende biografiche degli autori trattati, le linee evolutive del
pensiero e della produzione;
e) conoscere il contesto storico e culturale degli autori trattati;
f) conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato.
LETTERARIE
LINGUISTICHE
COMPETENZE
a) saper contestualizzare i testi letterari affrontati nel corso dell’anno;
b) saper riconoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche di un testo;
c) saper analizzare gli elementi metrici e stilistici, riconoscere le principali
figure retoriche, individuare le parole chiave, le tematiche;
d) acquisire il senso storico dell'evolversi della lingua e della cultura.
a) saper utilizzare progressivamente un linguaggio adeguato ad
esprimere i diversi contenuti appresi;
b) saper produrre testi di diversa tipologia, facendo in modo che
siano completi, coerenti e coesi;
saper rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti appresi
utilizzando un lessico appropriato.
CAPACITÀ
13
a) saper esprimere i contenuti utilizzando un lessico appropriato e specifico;
b) saper produrre testi di diversa tipologia, facendo in modo che siano corretti e completi;
c) saper collocare il singolo autore o movimento in rapporto con quanto lo ha preceduto e
individuare gli aspetti che lo legano con gli sviluppi successivi;
d) saper analizzare, sintetizzare e confrontare i testi, gli autori e i movimenti trattati nel
corso dell’anno;
e) saper rielaborare in modo critico e autonomo i testi, stabilendo collegamenti in senso
interdisciplinare.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
1
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO (ripasso
generale)
J.Winckelmann: lettura del brano: La statua di Apollo: il
mondo antico come paradiso perduto.
Le idee e la visione del mondo di UGO FOSCOLO: la
vita e le opere;
studio di brani tratti dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: lo
sconforto per la situazione della patria, l’innamoramento,
effetti dell’amore sullo spirito umano, l’insensatezza della
storia, la morte di Jacopo;
I Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello
Giovanni, Dei Sepolcri,
le Grazie: il velo delle Grazie.
2
Il ROMANTICISMO in Europa e in Italia: caratteri
fondamentali della società e della cultura del periodo;
lettura e analisi di Madame de Stael: sulla maniera e
l’utilità delle traduzioni, Giovanni Berchet: la lettera
semiseria di Crisostomo e la poetica romantica.
ALESSANDRO MANZONI: vita e opere;
dalle Lettere: la differenza tra lo storico e il poeta, le
ragioni del Romanticismo lombardo;
dalle Odi: il 5 maggio;
dagli Inni Sacri: la Pentecoste;
dalle Tragedie: la morte di Adelchi, la morte di
Ermengarda;
I Promessi Sposi
3
La visione poetica di GIACOMO LEOPARDI: vita e
opere;
studio di passi tratti dallo Zibaldone: il conflitto tra ragione
e natura, il desiderio di felicità, una felicità materiale, la
poesia d’immaginazione e la poesia filosofica;
dalle Lettere: A Pietro Giordani: la disperazione e la morte;
dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un
islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere;
dai Canti: Ultimo canto di Saffo, Il passero solitario,
L’infinito, Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia, Il sabato del villaggio.
PERIODO
Settembre
1 ora
Settembre
Ottobre
9 ore
Ottobre
5 ore
Novembre
11 ore
Dicembre
11 ore
Gennaio
14
4
NATURALISMO, SIMBOLISMO, VERISMO:
Edmond e Jules de Goncourt: prefazione a Germinie
Lacerteux; Emile Zola: il manifesto del Naturalismo:
prefazione a La fortuna dei Rougon;
cenni alla narrativa scapigliata e pedagogica;
GIOVANNI VERGA: vita e opere;
da Eva: la prefazione;
da Nedda: una scena di corteggiamento;
da Vita dei campi: la prefazione all’amante di Gramigna,
Fantasticheria, Rosso Malpelo,
da I Malavoglia: la prefazione: i vinti nella lotta per
l’esistenza, la famiglia Toscano, Il naufragio della
Provvidenza, ‘Ntoni si ribella, ‘Ntoni tradisce l’ideale
dell’ostrica;
dalle Novelle rusticane: la roba, libertà;
da Mastro Don Gesualdo: la morte di Gesualdo.
GIOSUE’ CARDUCCI: vita e opere;
dalle Rime nuove: Comune rustico, Traversando
Maremma toscana, Pianto antico;
dalle Odi Barbare: Nevicata, Mezzogiorno alpino.
5
7
Febbraio
10 ore
Marzo
6 ore
la
L’ETA’ DEL DECADENTISMO: contesto storico e linee
generali della cultura europea e italiana del periodo;
Marzo
2 ore
GIOVANNI PASCOLI: vita e opere;
dal Fanciullino: la poetica;
da
Myricae:
Temporale,
Il
lampo,
Lavandare,
Novembre,L’assiuolo, X Agosto;
da I canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino
notturno
Marzo
6 ore
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere;
da Terra vergine: Dalfino;
da Il Piacere: Il verso è tutto; la filosofia del Dandy;
da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.
6
Gennaio
4 ore
IL PRIMO NOVECENTO: caratteristiche del periodo,
ideologie, e forme letterarie (cenni di carattere generale)
LA NARRATIVA DEL NOVECENTO: caratteristiche del
romanzo del Novecento con cenni ad autori europei; il
romanzo in Italia
LUIGI PIRANDELLO: vita e opere; lettura e analisi dei
brani tratto dal saggio L’Umorismo: il contrasto vita-forma,
il sentimento del contrario;
lettura e analisi delle novelle tratte da Novelle per un
anno: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato;
lettura del brano La conclusione del romanzo, tratto da
Uno, nessuno, centomila;
Il fu Mattia Pascal. Lettura e analisi de I primi due capitoli:
le premesse, la vita di Mattia Pascal, la lanterninosofia, la
conclusione.
ITALO SVEVO: vita e opere; lettura di brani da La
coscienza di Zeno: la doppia introduzione: la prefazione e il
preambolo, il vizio del fumo: il sintomo della malattia, lo
schiaffo del padre morente, la conclusione del romanzo.
L’ERMETISMO
E
LA
NUOVA
POESIA:
concetti
Aprile
5 ore
Aprile
2 ore
Aprile
1 ora
Maggio
6 ore
Maggio
4 ore
da
15
8
fondamentali del nuovo modo di far poesia.
GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere; analisi delle
poesie: I Fiumi, Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del
Carso da L’Allegria di naufraghi; analisi di La madre da
Sentimento del Tempo.
EUGENIO MONTALE: la sua visione poetica e le nuove
tecniche poetiche; analisi di poesie tratte da Ossi di
seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le
Occasioni: la casa dei doganieri; da Satura: Ho sceso
dandoti il braccio….;
Divina Commedia di Dante Alighieri
Lettura, parafrasi e commento dei canti I-III-VI-XIXII-XV-XVII del Paradiso
concludere
Maggio
4 ore
Maggio
4ore
giugno
ripasso
durante
l’anno per
14 ore
Sono state dedicate 15 ore allo svolgimento dei compiti di produzione scritta.
Totale: 120
CRITERI METODOLOGICI
Lo studio della letteratura è stato proposto partendo da un’introduzione generale sul
contesto storico-culturale caratterizzante ogni movimento letterario, per arrivare poi ad una
conoscenza più ravvicinata delle tematiche e degli autori attraverso la lettura commentata di
testi significativi.
Il contributo degli alunni è stato importante nella strutturazione della lezione in classe,
soprattutto per l’acquisizione della capacità di riflettere sulle tematiche proposte e
l’avviamento ad uno studio sempre più autonomo.
Gli studenti sono stati stimolati alla riflessione in classe, in modo da poter acquisire la
capacità di confrontarsi su tematiche letterarie e culturali, soprattutto per comprenderne la
modernità e l’attualità. Si è cercato di creare rapporti interdisciplinari con le materie che
hanno maggiore collegamento con la letteratura italiana, in modo che le allieve potessero
acquisire una mentalità aperta e flessibile. Lo svolgimento del programma ha tenuto conto
delle difficoltà delle alunne nel padroneggiare appieno tutte le competenze previste per
questa disciplina e per questo motivo le spiegazioni sono state precise e puntuali,
rispettando anche dei tempi adeguati per l’assimilazione dei contenuti e delle conoscenze.
Come rinforzo del lavoro scritto sono stati proposti temi di svolgimento a casa.
MATERIALI DIDATTICI
M. Magri, V. Vittorini, Fare letteratura, Paravia (voll. 2B, 3A,3B,3C)
Un testo della Divina Commedia a scelta dello studente
Fotocopie, visione di video e dvd, giornali e riviste
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate due prove scritte, due verifiche scritte valide per l’orale e una
interrogazione orale per il 1° quadrimestre; tre prove scritte, tre prove scritte valide per
l’orale e e due interrogazioni orali nel secondo quadrimestre.
Le verifiche proposte sono state a risposta sintetica e/o commento ai testi. Tali prove hanno
permesso di valutare le conoscenze acquisite e/o le abilità.
Per quanto riguarda i compiti scritti, le studentesse hanno avuto a disposizione tre e talvolta
anche 4 ore; sono state proposte le prove previste dai nuovi esami di stato (testo
argomentativo, articolo di giornale, saggio breve, analisi del testo).
Le verifiche orali hanno permesso di sondare l'acquisizione dei contenuti e il grado di
rielaborazione critica; la capacità di espressione e di commento autonomo ai testi.
I criteri per lo scritto sono stati i seguenti: la correttezza formale e l’uso di un lessico
adeguato al contesto; l’ adeguatezza rispetto alla traccia assegnata, la coesione e l’ ordine di
svolgimento; l’originalità dell'impostazione e la capacità critica.
Per l'orale: la correttezza nell’uso lessicale, la completezza nell’esposizione dei contenuti, la
fluidità d’esposizione, la capacità di rielaborazione personale, la capacità di far collegamenti.
16
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di
valutazione si rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F.
Cittadella,lì 15.05.2009
La docente
Fiorella Fior
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
_________________________________________
__________________________________________
17
Griglia orale triennio – ITALIANO
Scala di riferimento
Punteggio
Prestazione nulla
30
Gravemente insuff.
40
Insufficiente
50
INDICATORI
Conoscenza
Nessuna
dei contenuti
(autore, opera,
contesto storico –
letterario)
Comprensione
Molto limitata e
frammentaria
Poco specifica e
superficiale
Confusa.
Molto limitata: con
fraintendimenti e
contraddizioni.
Incapacità ad
orientarsi. Mancata
comprensione della
richiesta.
Mancante
Scarsa
comprensione della
richiesta. Risposta
appena abbozzata.
Collegamenti
stentati e privi di
senso
Esposizione
Confusa e
disorganica.
Faticosa, poco
chiara, con uso di
vocaboli scorretti o
non appropriati.
Autonomia
Nessuna
Scarsa
del testo letterario
Analisi
del testo letterario
Confronto e
contestualizzazione
Sufficiente
60
DESCRITTORI
Succinta, ma
corretta.
Essenziali
informazioni
specifiche.
Discreto
70
Buono
80
Ottimo
90 – 100
Molte informazioni
specifiche
Ampia, sicura, quasi
completa
Completa e
approfondita
Superficiale e/o
Essenziale, che
Adeguata, che
Sicura, quasi
Completa e
parziale, che non
tralascia alcuni
tralascia particolari
completa.
approfondita.
ricostruisce il senso
particolari.
secondari.
essenziale.
Condotta in modo
Condotta sugli
Sostanzialmente
Precisa, che
Dettagliata, che
faticoso e che non aspetti principali del
precisa, con
risponde a quasi
denota sensibilità
rileva importanti
testo
omissioni poco
tutte le richieste
estetica
elementi
rilevanti
Collegamenti
Collegamenti
Collegamenti
Collegamenti ampi, Collegamenti ampi,
superficiali, non
schematici, ma
almeno in parte
motivati con
con elementi critici
adeguatamente
corretti
adeguatamente
argomenti
personali
motivati
motivati
significativi
Incerta, lessico solo Controlla intercalari
Sicura, chiara e
Sciolta, senza
Disinvolta. Lessico
a volte specifico.
e pause. Lessico
coerente. Lessico esitazioni. Buon uso
e registro
generico (adeguato,
appropriato.
del lessico specifico. appropriati e vari.
ma non sempre
appropriato).
Limitata (sono
necessarie frequenti
sollecitazioni).
Sufficiente
(necessita di alcune
sollecitazioni)
Rielaborazione che
riesce a prevenire
alcune richieste
dell'insegnante
Costruzione di un
percorso autonomo,
con elementi di
riflessione personale
Rielaborazione
sicura, personale,
originale
18
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- ITALIANO TRIENNIO
TIPOLOGIA “A”/ANALISI TESTUALE
Pertinenza rispetto alla
richiesta (analisi)
Correttezza linguistica e
coerenza testuale
Mancata comprensione
della richiesta
Gravi e numerosi errori,
gravi errori lessicali e
mancanza di progressione
Mancante
Contraddittoria
Corrispondenza
sporadica,
fraintendimenti,
omissioni
Presenza di errori,
punteggiatura e lessico
incerti, progressione
confusa
Collegamenti intra-intercontestuali stentati e non
giustificati
Parziale o molto
approssimativa, non
ricostruisce il senso
essenziale
Limitata al senso centrale
Corrispondenza limitata e
disorganica
Errori sporadici, linguaggio
generico, progressione poco
chiara
Collegamenti sporadici e
superficiali
Corrispondenza limitata,
ma coerente
Progressione chiara, anche
se semplice, errori
occasionali
Essenziale, ma con
elementi di
specificazione correlati
Adesione precisa,
omissioni e
fraintendimenti poco
rilevanti
Frequenti inferenze
denotano autonomia nel
metodo d’analisi
Ampia, precisa, svela il
senso profondo con
inferenze interessanti
Comprensione
complessiva del testo
Confusa, priva di senso
compiuto
Contestualizzazione
Giudizio
Voto in
decimi
Approfondimento
Negativo
Voto in
quindicesimi
1-3
1-5
4
6-8
Insufficiente
5
9
Esposizione schematica
ma corretta nei
collegamenti
Sufficiente
6
10
Progressione chiara, sintassi
corretta
Esposizione schematica
con un ampliamento
significativo
Discreto
Adesione precisa e, in
parte, approfondita
Morfosintassi sicura,
articolazione e lessico
precisi
Esposizione autonoma,
elaborata criticamente
Buono
Adesione precisa e
approfondita di tutte le
richieste
Discorso articolato e
strutturato, lessico specifico
e stile personale
Contestualizzazione
ampia che giustifica le
interpretazioni personali
Ottimo
Gravemente
insufficiente
19
6,5-7,5
8
9/10
11-12
13
14-15
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- ITALIANO TRIENNIO
TIPOLOGIA “B”/SAGGIO BREVE
Rielaborazione
Aderenza al problema
Mancata focalizzazione
del problema
Corrispondenza
sporadica / tesi non
chiara
Comprensione dei
documenti, dati, utilizzo
dei documenti
integrativi
Assente
Approssimativa con
fraintendimenti ed
omissioni
Correttezza linguistica e coerenza alla
forma testuale prescelta: destinatario,
contesto comunicativo, registro
linguistico, scopo
Gravi e numerosi errori, scelte lessicali
incongruenti, mancata progressione
Errori, uso della forma contraddittorio,
progressione confusa
Giudizio
Mancanza di elementi
significativi
Idee superficiali,
collegamenti stentati
Collegamenti
sporadici, idee non
significative
Voto in
decimi
Voto in
quindices
imi
Negativo
1-3
1-5
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Insufficient e
5
9
6
10
Corrispondenza limitata
e disorganica/ tesi
esplicitata in modo
confuso
Parziale, manca la
ricostruzione del quadro
essenziale
Errori sporadici, lessico, destinatario, scopo
generici, progressione non chiara
Corrispondenza
limitata,
ma coerente/ tesi chiara
Approssimazioni e
omissioni non toccano i
temi essenziali
Tipologia e progressione chiare, errori
occasionali
Esp o si zio ne schematica
di almeno u n e le me n to
significativo
Sufficiente
Adesione coerente alle
principali articolazioni tesi e
argomentazioni chiaramente
esplicitate
Limitata all’essenziale, ma
con conoscenze e
documenti integrativi
Tipologia e progressione articolate,
sintassi corretta, progressione e tipologia
fluide
Esposizione
schematica con
qualche ampliamento
significativo
Discreto
Adesione precisa e, in
parte, approfondita
Precisa, articolata,
giustificata dalle
conoscenze personali
Morfosintassisicura, tipologia adatta
all’articolazione
Scelta autonoma degli
elementi significativi,
problematizzazione
Buono
Adesione precisa e
approfondita a tutte le
richieste della traccia
Accompagnata da sicuri
quadri di riferimento
critico
Testo piacevole ed efficace, stile
creativo
I n t e g r a
problematicamente
documentazione e
conoscenze personali
Ottimo
20
6,5-
11-12
7,5
8
9-10
13
14-15
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- ITALIANO TRIENNIO
Pertinenza alla traccia
Conoscenza dei
contenuti
Correttezza linguistica e
coerenza testuale
TIPOLOGIA “C”/TEMA STORICO
Rielaborazione
Giudizio
Voto in
decimi
Mancano i collegamenti
Negativo
Mancata comprensione
della richiesta
Scarsa o assente
Gravi e numerosi errori
morfologici, lessicali, di
progressione
Corrispondenza sporadica
alla traccia
Approssimativa, confusa
su date, avvenimenti,
concetti-chiave
Errori morfologici, lessico
incerto, progressione confusa
Collegamenti stentati e non
giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Corrispondenza limitata e
disorganica
Parziale, confusa, quadro
cronologico e culturale
incompleto
Alcuni errori , uso di un
lessico generico, progressione
non chiara
Collegamenti sporadici e
superficiali
Insufficient e
5
9
Corrispondenza limitata,
ma coerente
Limitata all’essenziale,
con alcuni elementi
correlati
Progressione chiara, anche se
semplice, errori occasionali
Esposizione schematica ma
corretta nei collegamenti
Sufficiente
6
10
Adesione coerente con la
traccia e le sue
articolazioni
Limitata all’essenziale,
con alcuni elementi
correlati esattamente
Articolazione essenziale,
sintassi semplice ma corretta
Esposizione schematica con
qualche ampliamento
significativo
Adesione precisa e, in
alcune articolazioni,
approfondita
Con riferimenti precisi,
articolati e giustificati
Morfosintassi corretta,lessico
specifico, articolazione fluida
Esposizione autonoma,
elaborata criticamente
Buono
Adesione precisa e
approfondita a tutte le
richieste della traccia
Ampia, personale e
precisa di nozioni, fonti e
interpretazioni
Discorso articolato e
strutturato, lessico specifico e
stile personale
Co nt e st ua li zza zio ne
ampia che giustifica le
interpretazioni personali
Ottimo
Discreto
1-3
Voto in
quindicesim
i
1-5
6,5-7,5
8
9-10
11-12
13
14-15
21
GRIGLIA DI VALUTAZIONE- ITALIANO TRIENNIO
Pertinenza alla traccia
Mancata comprensione
della richiesta
Conoscenza dei
contenuti
Scarsa o assente
TIPOLOGIA “D”/TEMA DI ATTUALITA’
Correttezza linguistica e
coerenza testuale
Rielaborazione
Gravi e numerosi errori
morfologici, lessicali, di
progressione
Mancano i collegamenti
Giudizio
Negativo
Voto in
decimi
1-3
Voto in
quindicesimi
1-5
Corrispondenza sporadica
alla traccia
Approssimativa, confusa
su concetti-chiave
Errori morfologici, lessico
incerto, progressione confusa
Collegamenti stentati e non
giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Corrispondenza limitata e
disorganica
Parziale, confusa, quadro
culturale incompleto
Alcuni errori , uso di un
lessico generico, progressione
non chiara
Collegamenti sporadici e
superficiali
Insufficiente
5
9
Corrispondenza limitata,
ma coerente
Con lacune che non
toccano i temi essenziali
Progressione chiara, anche se
semplice, errori occasionali
Esposizione schematica ma
corretta nei collegamenti
Sufficiente
6
10
Adesione coerente con la
traccia e le sue
articolazioni
Limitata all’essenziale,
con alcuni elementi
correlati esattamente
Articolazione essenziale,
sintassi semplice ma corretta
Esposizione schematica co n
q ua lc he ampliamento
significativo
Discreto
Adesione precisa e, in
alcune articolazioni,
approfondita
Riferimenti precisi,
articolati e giustificati
Morfosintassi corretta,lessico
specifico, articolazione fluida
Esposizione autonoma,
elaborata criticamente
Buono
Adesione precisa e
approfondita a tutte le
richieste della traccia
Ampia, personale e
precisa di nozioni, fonti e
interpretazioni
Discorso articolato e
strutturato, lessico specifico e
stile personale
Co nt e st ua li zza zio ne
ampia che giustifica le
interpretazioni personali
Ottimo
6,5-7,5
11-12
8
13
9-10
14-15
22
RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE E PROGRAMMA SVOLTO
BOTTECCHIA CATERINA
Filosofia e Storia
V AS A.S
2008-2009
La discontinuità didattica, già indicata nel documento del consiglio di classe, ha imposto alle studentesse metodi di
lavoro e compiti disomogenei, implicando in particolare quest'anno un notevole sforzo di adattamento a richieste per la
classe assolutamente nuove. Si è reso necessario un compromesso tra gli obiettivi didattici minimi previsti per
l'indirizzo di studi e la storia della classe nell'intenzione di accompagnare gradualmente le discenti ad affrontare le
difficoltà dell'esame di stato, privilegiando l'acquisizione e l'affinamento di competenze e capacità rispetto alle
conoscenze. All'inizio dell'anno si sono dedicate esclusivamente al ripasso 5 ore di filosofia e 4 di storia con indicazioni
metodologiche e lessicali e suggerimenti per migliorare l'efficacia del metodo di studio, più volte ribaditi nel corso
dell'anno. La classe VAS, dal canto suo, ha mostrato in generale una certa riluttanza ad assumere responsabilità ed a
contribuire attivamente alla costruzione del percorso didattico. All'atteggiamento in classe, talvolta collaborativo, più
spesso passivo, soprattutto nella prima parte dell'anno scolastico, ha corrisposto uno studio domestico discontinuo, poco
autonomo e nozionistico che ha reso più difficile il recupero delle lacune pregresse. Conseguentemente la
programmazione ha subito revisioni e lo svolgimento del programma è stato rallentato. Particolarmente faticoso e solo
parzialmente riuscito il lavoro teso a migliorare le capacità di metacognizione ed autovalutazione delle studentesse che
in diverse occasioni hanno preferito sottrarsi alle prove di verifica piuttosto che rischiare un insuccesso e lavorare sui
propri processi attribuitivi. Nella seconda parte dell'anno l'atteggiamento della classe è divenuto un po' più collaborativo
ed è cresciuto l'impegno a casa, che tuttavia non sembra ancora, nella maggior parte dei casi, organizzato in base a
criteri chiari, costanti e produttivi.
I risultati raggiunti sono abbastanza omogenei: nonostante i moltissimi esercizi, sia obbligatori sia facoltativi, svolti in
classe ed assegnati per casa, nella maggior parte dei casi l'esposizione orale risulta ancora frammentaria e caratterizzata
da un linguaggio elementare o povero, a volte addirittura scorretto, le risposte alle domande non sono sempre del tutto
pertinenti. Le ore di compresenza (diritto-storia e scienze sociali-filosofia) sono state dedicate alla trattazione
interdisciplinare di alcuni temi ed autori o a esercizi di recupero o approfondimento.
Rimane problematica la situazione di 3 allieve che non hanno raggiunto risultati sufficienti in nessuna delle due
discipline.
Poche sono state le ore di sportello didattico richieste.
Per quanto concerne filosofia, in relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i risultati di seguito
riportati.
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono alcuni autori e correnti della filosofia contemporanea e alcuni dei
termini tecnici più importanti. Per i dettagli si rimanda alla tabella sottostante.
COMPETENZE E CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico le alunne esprimono con minor ambiguità il proprio punto di vista e i contenuti appresi,
dimostrando attenzione alle scelte lessicali e sufficiente correttezza logico-argomentativa; forniscono la risposta
pertinente a una domanda posta; costruiscono inferenze corrette; esprimono semplici valutazioni su quanto ascoltato e
letto; sanno concettualizzare; sintetizzare; problematizzare; risolvere problemi.
In relazione alla programmazione curricolare di storia, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari.
CONOSCENZE:
L’Italia e l’Europa nella seconda metà dell'Ottocento e nel Novecento; per i dettagli si rimanda alla tabella sottostante.
COMPETENZE E CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico le alunne sanno individuare e descrivere le fondamentali interazioni tra i soggetti storici
singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le principali denominazioni istituzionali, gli intrecci politici,
sociali, culturali, religiosi, di genere e ambientali; comprendono e utilizzano in modo abbastanza corretto il lessico
specifico della disciplina.
METODI E MEZZI
La lezione frontale e la lezione dialogata, supportate da schemi e accompagnate dall’analisi di testi guidata
dall’insegnante o in piccoli gruppi, sono stati i metodi più frequentemente utilizzati.
Avendo rilevato carenze nell'impostazione generale del manuale di filosofia adottato (Brandolini, A., Debernardi, M.,
Leggero, R., Simposio. Autori, testi, opere, volume 3, edizioni Laterza, 2005 (filosofia), che propone interpretazioni
fortemente anomale (per non dire errate) anche di concetti di base che sono parte degli obiettivi minimi della disciplina,
durante le lezioni ho costruito mappe concettuali e schemi di sintesi, proposto definizioni che potessero guidare le
studentesse nel lavoro domestico. Ho sempre collegato con particolare attenzione le nuove spiegazioni a quelle
precedenti, ripetendo più volte i passaggi più facilmente fraintendibili da chi fosse rimasta assente.
Si è fatto ricorso al lavoro di gruppo per lo studio della condizione dei soldati durante la Prima Guerra Mondiale e, in
qualche caso, all'approfondimento personale, seguito da esposizione alla classe. Molti sono gli esercizi, obbligatori o
facoltativi, che sono stati assegnati. Il manuale di storia adottato è AA. VV., Le regole del gioco, storia, economia e
società, volume 2, edizioni Laterza, 2005 (storia).
A disposizione della commissione una cartellina con documenti e letture non riportati dai manuali adottati.
SPAZI
aula
23
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Coerentemente con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento e da quella individuale, sono state effettuate
verifiche orali e scritte; entro la fine dell'anno scolastico si prevede che ciascuna alunna abbia almeno 5 valutazioni per
filosofia (2 delle quali derivanti dalla simulazione della terza prova), 5 valutazioni per storia (1 delle quali derivante
dalla simulazione della terza prova).
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le simulazioni di terza prova effettuate.
Griglia di valutazione per la correzione delle prove utilizzata per filosofia e storia:
1. Conoscenza, completezza e pertinenza delle informazioni da 0,5 a 3,5 punti;
2. Capacità di analisi e sintesi da 0,5 a 2,5 punti;
3. Coerenza argomentativa da 0,5 a 2 punti;
4. Correttezza formale ed uso di un linguaggio specifico da 0,5 a 2 punti.
scorretta,
lacunosa e
non
pertinente
parziale e
approssimativa
essenziale
chiara e
abbastanza
approfondita
precisa,
completa e
pertinente
0,5
2
2,5
3
3,5
totalmente
carente
poco efficace
corretta
puntuale ed
efficace
0,5
1
2
2,5
Conoscenza,
completezza e
pertinenza delle
informazioni
Capacità di
analisi e sintesi
Coerenza
argomentativa
Contraddittoria e
disorganica
0,5
Correttezza formale ed
uso di un linguaggio
specifico
Corretta
Approfondita ed organica
1
2
impreciso e non
appropriato
globalmente corretto e
appropriato
scorrevole ed
appropriato
0,5
1
2
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (FILOSOFIA):
Contenuti
tempi
Il Romanticismo
Temi e parole chiave: tensione verso l'infinito, esaltazione della natura e della storia, della fede e del
sentimento, la concezione dell'uomo come attività creatrice e l'identificazione tra Dio e Io, l'amore. Il
rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d'accesso alla realtà e all'assoluto. L'impegno
politico.
3 ore
Hegel
Linee fondamentali del sistema hegeliano: la risoluzione del finito nell'infinito, “tutto ciò che è reale è
razionale”, la funzione della filosofia; la dialettica come legge che regola il farsi dinamico dell'assoluto e
procedimento di conoscenza della realtà; l'importanza del momento speculativo e il concetto di
Aufhebung.
Dell'Enciclopedia delle Scienze filosofiche la tripartizione in Logica, Filosofia della Natura e Filosofia
9 ore
24
dello Spirito: che cosa studiano?. Lo Spirito Soggettivo: cos'è?; lo Spirito Oggettivo: cos'è?; il diritto
astratto; la moralità: cosa sono?; l'eticità, con particolare attenzione alla distinzione tra società civile e
Stato; la concezione etica dello Stato; lo Spirito Assoluto: l'arte, la religione e la filosofia e le loro forme di
conoscere l'assoluto. La coincidenza di filosofia e storia della filosofia; la filosofia della storia: la
razionalità della storia; il fine della storia, i mezzi della storia, l'astuzia della ragione.
Della Fenomenologia della Coscienza solo il suo essere storia romanzata delle vicissitudini della
coscienza e il riconoscimento reciproco tra le autocoscienze: la dialettica servo-padrone.
Lettura e analisi di testi tratti dall'Introduzione alle lezioni sulla Storia della filosofia (manuale, pp. 496500; pp.511-512 -dalla riga 30; p.525 ).
Schopenhauer
Le critiche a Hegel; il mondo come “volontà” e “rappresentazione”; la vita come oscillazione continua tra
dolore e noia; l'amore come la più grande delle illusioni; le vie di liberazione dal dolore e la noluntas.
Lettura e analisi di testi (fotocopia docente).
4 ore
Destra e Sinistra hegeliane: cosa sono? La differenza di fondo nel concepire i rapporti tra filosofia e
religione e nell'interpretare “tutto ciò che è reale è razionale”. Feuerbach: Dio come proiezione dell'uomo.
1 ora
Marx
Globalità dell’analisi di Marx, centralità della prassi; critiche alla società liberale e problema
dell’alienazione del lavoratore salariato; materialismo storico e dialettico; critiche alla religione; la
missione del proletariato.
Lettura e analisi di testi (fotocopia docente).
4 ore
Kierkegaard
Filosofia come giornale intimo di un'esistenza irripetibile, la filosofia a servizio del singolo, la possibilità,
il dubbio, la disperazione, l’angoscia, il passaggio dalla morale alla fede, il peccato, lo scandalo e il
paradosso, vita estetica, etica e religiosa.
Lettura e analisi di testi (fotocopia docente).
4 ore
Nietzsche
Cenni biografici; valorizzazione della ricerca più che del suo risultato e asistematicità della filosofia, “La
nascita della tragedia”: spiegazione del titolo, apollineo e dionisiaco, Socrate e la menzogna della verità,
la morte di Dio, il nichilismo attivo, il superuomo e l'eterno ritorno.
Lettura e analisi di testi tratti da La nascita della tragedia (pp. 410-418; 433-434 manuale), La Gaia
Scienza (p. 46 manuale).
5 ore
Bergson
Dal Saggio sui dati immediati della coscienza: superamento delle tradizionali distinzioni tra soggetto e
oggetto, tempo spazializzato e durata; l'errore comune di deterministi e sostenitori del libero arbitrio nella
storia della filosofia, la durata fondamento della libertà.
Lettura e analisi di testi (fotocopia docente).
4+1* ore
L'Esistenzialismo come clima culturale:
Individuazione di temi di indagine tipici della filosofia esistenzialista senza porre l'accento sulle risposte
diverse dei singoli pensatori: l'uomo, l'esistenza, la possibilità, l'angoscia, l'insensatezza, l'assurdo, la
solitudine di fronte alla morte; l'impegno dell'intellettuale; la libertà.
Lettura e analisi di testi di Jaspers, Sartre, Heidegger, Abbagnano.
2+1* ore
Rousseau:
cenni biografici; Discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza: lo stato di natura come ipotesi
metodologica per una critica dell'esistente, il passaggio alla società civile e politica e la nascita della
proprietà; il Contratto sociale ed i caratteri della volontà generale; l'educazione negativa e come “libertà
ben guidata”.
2 ore *
Il Positivismo:
Lineamenti generali del Positivismo;
Comte e la legge dei tre stadi, la dottrina della scienza; la sociologia come fisica sociale, scienza al vertice
dell'ordinamento delle scienze.
Spencer: il rapporto tra religione e scienza; l'evoluzione dell'universo come processo necessario in cui si
passa dall'omogeneità indefinita e incoerente all'eterogeneità definita e coerente.
2 ore*
Durkheim
La sociologia come scienza autonoma del fatto sociale; il carattere collettivo, esterno e coercitivo del fatto
sociale; solidarietà meccanica e solidarietà organica tra individuo e gruppo sociale; il problema
dell'anomia.
2 ore*
Weber: differenza tra scienze della natura e scienze dello spirito; causazione adeguata e causazione
accidentale; l'idealtipo come strumento di conmprensione dei fenomeni sociali e storici il carattere
euristico dell'idealtipo.
2 ore*
25
Lettura di passi tratti da La casa dei bambini di Montessori
1 ora*
Introduzione a Bruner
1 ora*
Lettura di passi tratti da Dopo Dewey: il processo si apprendimento nelle due culture
1 ora*
Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio: 31 + 42
Le ore indicate con * sono state svolte in compresenza con la docente di scienze sociali.
(N. B. le ore ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla somma di quelle qui indicate sono state dedicate allo
svolgimento di prove di verifica, a esercizi di miglioramento del metodo di studio o di rafforzamento delle
abilità filosofiche in genere senza fare necessariamente riferimento agli autori studiati nel corso di quest'anno
scolastico.)
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (STORIA):
Contenuti
tempi
I principali problemi dell’Italia unita. I governi della Destra Storica e gli obiettivi del
completamento dell'unità nazionale e del pareggio del bilancio, la piemontesizzazione, la
Questione Romana. I governi della Sinistra Storica: l'abolizione della tassa sul macinato, la
Legge Coppino, il trasformismo, la Triplice Alleanza e il Codice Zanardelli, l'inizio della
politica coloniale italiana.
La Francia di Luigi Napoleone: la Repubblica e il Secondo Impero: la ricerca di Grandeur e il
consenso alla politica reazionaria.
L’unificazione tedesca e la Guerra Franco-Prussiana; la nascita del Reich. Conseguenze della
Guerra Franco-Prussiana in Italia.
La Comune: cos'è? Perché è importante?
7 ore
“Dalle praterie ai grattacieli”: l’America settentrionale nell’’800; la Dottrina Monroe: che cos'è?;
la Guerra di Secessione: estremi cronologici, cause, schieramenti, chi vinse?
1,5 ore
L'Italia di Giolitti, in particolare la gestione delle tensioni sociali.
La società di massa e la nascita di nuovi partiti. Socialdemocrazia,socialismo rivoluzionario e comunismo:
cosa sono? Esponenti più importanti.
Questione Sociale; la Rerum Novarum.
2,5 ore
Situazione internazionale tra il 1870 e la Prima Guerra Mondiale, in particolare il militarismo,
l'imperialismo (definizione del fenomeno, differenze con il colonialismo) e il nazionalismo della
Germania guglielmina; le tensioni politiche e sociali, l'Affaire Dreyfus, la politica dell’equilibrio della
Gran Bretagna.
1 ora
Periodizzazione del Novecento.
B. Bongiovanni, La periodizzazione del Novecento
1 ora
La Prima Guerra Mondiale: premesse, casus belli, lo scoppio del conflitto, alleanze, il fallimento della
guerra-lampo e la guerra di posizione, il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia, l'intervento
dell'Italia, la “grande strage” degli anni 1915-1916, il 1917, Caporetto e Vittorio Veneto, l'intervento degli
U.S.A., la “mobilitazione totale”, la vita dei soldati, le donne durante e dopo la guerra.
I trattati di pace e la ridefinizione dell’equilibrio geopolitico europeo, la perdita di centralità dell'Europa, i
mutamenti sociali e nella mentalità collettiva, le difficoltà economiche seguiti alla Grande Guerra.
E. J. Leed, Le comunità di agosto; E. Canetti, Il bambino e la guerra; P. Fussell, Il mondo dei trogloditi;
E. Jünger, All'ombra della morte; A. Gibelli, I prigionieri di guerra; E. Forcella, A. Monticone, Il
fenomeno dell'autolesionismo; A. Gibelli, Guerra e follia, Thébaud, La Guerra e le donne.
6 ore
La Rivoluzione Russa e l'Unione Sovietica fino a Stalin: la caduta degli zar; i bolscevichi al potere; la
Terza Internazionale, il comunismo di guerra, la NEP, Stalin e il “socialismo in un solo paese”, i piani
quinquennali e l'industrializzazione forzata, il culto della personalità, la campagna contro i kulaki, le
grandi purghe e i processi agli oppositori, continuità e rotture tra leninismo e stalinismo.
Lenin, Le tesi di aprile; Carr, Il posto di Stalin nella storia della Russia; Malia, Il posto di Stalin nella
storia della Russia.
4 ore
Il primo dopoguerra in Germania e la Repubblica di Weimar: costituzione, tensioni sociali e fragilità
politica della Repubblica di Weimar.
1 ora
Ascesa del Fascismo in Italia e del Nazismo in Germania: analogie e differenze nella nascita e
nel consolidamento dei due regimi.
Il Fascismo in Italia trova i suoi presupposti nella crisi dello stato liberale e nelle conseguenze
5 ore
26
della Prima Guerra Mondiale; il Fascismo movimento; dalla marcia su Roma al delitto Matteotti
e alla secessione dell'Aventino; l’istituzione del regime e le leggi fascistissime; l’organizzazione
dello stato fascista, la costruzione del consenso e la repressione del dissenso, i rapporti con la
Chiesa, la politica estera del fascismo e il rapporto con la Germania di Hitler.
Programma dei fasci di combattimento;
Il Discorso del 3 gennaio del 1925 di Mussolini;
Il Concordato.
Il Nazismo in Germania: l'ideologia nazista, in particolare razzismo e antisemitismo; nascita e
consolidamento del regime; la psicologia delle masse, la funzione della propaganda di regime e il culto
della personalità.
Hitler, Razza ariana e razze inferiori; La missione tedesca sulla terra; Spazio vitale e espansione a est
(dal Mein Kampf)
Lo sterminio degli Ebrei d'Europa: dalle leggi di Norimberga alla “Soluzione finale”.
Il concetto di totalitarismo e quello di genocidio.
P. Longerich, Tappe e processi decisionali della “soluzione finale”, Un discorso di Hinrich Himmler del
1943; Brunetau, La liquidazione dei kulaki, V. Grossman, Il partito di fronte alla carestia ucraina.
3 ore
La Guerra Civile in Spagna e la mobilitazione degli antifascisti.
La Seconda Guerra Mondiale: premesse, lo scoppio del conflitto, alleanze, l'Italia dalla non belligeranza
all'intervento, il predominio delle forze dell'Asse fino al 1942, l'intervento degli U.S.A., le principali
battaglie, lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania, il coinvolgimento delle popolazioni civili,
la Resistenza, le bombe di Hiroshima e Nagasaki.
Il collasso dell’Italia e la caduta del regime fascista, il governo Badoglio, la cobelligeranza italiana, la
RSI, la liberazione.
I trattati di pace e la ridefinizione dell’equilibrio geopolitico europeo.
4 ore
Sviluppo della popolazione europea tra il XIX ed il XX secolo: cause ed effetti. Posizione di Malthus
sullo sviluppo della popolazione e sulla maniera di frenarlo.
*
1870-1914 formazione di un mercato mondiale; la società di massa: definizione e caratteristiche; suffragio
universale, partiti di massa, sindacati, Questione Femminile, Questione Sociale.
*
Seconda Rivoluzione Industriale: innovazione tecnica e sviluppo economico; J. Shumpeter; Seconda
Rivoluzione Industriale e rapporti tra mercato e finanza;
*
Introduzione alla crisi del 1929: legge degli sbocchi di Say e posizione R. Malthus; critica di J. M. Keynes
della legge degli sbocchi di Say.
*
Crollo della borsa di New York del 1929: “Genesi e conseguenze di una crisi annunciata” di M. Flamant e
J. Singer-Kerel, ed D’Anna.
*
L’Organizzazione delle Nazioni Unite: dalla Società delle Nazioni all’ONU; gli organi, le finalità
e gli interventi dell’ONU; l’ONU e la tutela dei diritti umani: la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo.
*
M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo; La Carta del lavoro dello Stato
Fascista; P. Calamandrei, Discorso agli studenti milanesi del 1955 sui principi della
Costituzione italiana e della Libertà”; Italia 1946: la nascita del nuovo stato sociale.
*
Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio: 44
Le ore indicate con * sono state svolte in compresenza con il docente di diritto ed economia.
(N. B. le ore ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla somma di quelle qui indicate sono state
dedicate allo svolgimento di prove di verifica, a esercizi di miglioramento del metodo di studio o di
rafforzamento delle conoscenze, competenze e capacità previste come obiettivi.)
Manuali adottati: Brandolini, A., Debernardi, M., Leggero, R., Simposio. Autori, testi, opere, volume 3, edizioni
Laterza, 2005 (filosofia); AA. VV., Le regole del gioco, storia, economia e società, volume 2, edizioni Laterza , 2005
(storia).
Cittadella, 13 maggio 2009
La docente
Caterina Bottecchia
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE _____________________________________
27
RELAZIONE FINALE
anno scolastico 2008/09
Materia: SCIENZE SOCIALI
DOCENTE: TOMBOLATO GRAZIELLA
classe 5 ASO
In relazione alla programmazione curricolare, si è previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi
disciplinari in termini di:
Finalità e Apprendimenti
Fin dal primo anno di corso l'indirizzo ha mirato al raggiungimento delle seguenti finalità:
- favorire una maturazione della personalità attraverso una migliore conoscenza di sé ed una
progressiva consapevolezza rispetto alla propria formazione;
- indurre una presa di coscienza della diversità e della disuguaglianza e sviluppare
atteggiamenti di rispetto e d'interesse ed, eventualmente, di intervento;
- sviluppare una gamma d'interessi legati alle discipline;
- valorizzare il senso del lavoro comune salvaguardando le peculiarità e le differenze; addestrare ad una impostazione multidisciplinare dei problemi e al trasferimento delle
conoscenze teoriche nell'esperienza sociale quotidiana e nello stage.
Lo scopo ultimo è rappresentato, oltre dal raggiungimento di una reale autonomia da parte degli
studenti, da un autentico interesse per i temi culturali e dell'indirizzo e da una effettiva capacità
d'essere protagonisti
.
Obiettivi trasversali e abilità di studio
Fin dal primo anno di corso l'Indirizzo ha curato le abilità di studio legate all'uso e alla produzione
di testi, inoltre ha puntato l'attenzione sia sugli aspetti socio-affettivi sia su quelli cognitivi che,
come si sa, sono fortemente intrecciati nell'atto del conoscere.
Anche durante quest’ultimo anno della scuola secondaria superiore è stato curato l'aspetto della
motivazione, della corretta comunicazione e del coinvolgimento degli studenti sulla base di una
esplicitazione dei criteri di scelta e di metodo da parte dell'insegnante. Inoltre si è cercato di
sviluppare l'aspetto costruttivo e produttivo del pensiero potenziando capacità riorganizzative,
valutative e problematiche allo scopo di favorire chiarezza e precisione nei confronti del sapere, ma
anche elasticità e prudenza di giudizio. A questo scopo si è rivelata particolarmente utile
l'esperienza di stage (e la rielaborazione delle due esperienze precedenti alla Scuola dell’Infanzia e
Primaria) che ha richiesto una forte capacità osservativa, comunicativa, organizzativa e di iniziativa
nel risolvere i problemi.
Obiettivi specifici della disciplina quest’anno sono stati:
- Completare il controllo sul proprio protagonismo per favorire una più ampia apertura verso
l’esterno – autonomia e responsabilità -, così da potersi relazionare in modo positivo sia
nell’istituzione scolastica (compagni, professori ecc. ) sia all’esterno ( stage e in tutte le
situazioni che lo hanno richiedono ).
- Completare l’atteggiamento riflessivo rispetto al lavoro che si sta svolgendo sapendo che
ogni analisi e rielaborazione personale è da confrontare, accostare ad altre in modo da
possedere mappe di saperi sempre più complesse e articolate.
Il contesto di sfondo
La progettazione delle scienze sociali nell’ultimo anno di corso ha portato a conclusione un
percorso quinquennale che, in modo graduale e ricorsivo, si è proposto di condurre la classe verso
una conoscenza più approfondita del Sé, delle dinamiche relazionali e del ‘mondo’. La gradualità è
stata scandita da un biennio, che aveva come obiettivo principale la costruzione di un abito mentale
aperto e sensibile ai temi del soggetto e della società, e un triennio,che avviava uno studio più
sistematico e attento all’analisi dei processi e dei problemi con il supporto più esplicito dei saperi
disciplinari. Parallelamente la didattica creava occasioni diverse e plurime di crescita autonoma di
ogni allievo/a, processi di autonomizzazione dall’insegnante, di responsabilizzazione, ma anche di
ricerca e valorizzazione delle qualità personali, allo scopo di dare ad ognuno/a più occasioni per
28
esprimere i personali talenti. Per quest’ultimo aspetto lo stage formativo ha rappresentato una
chance strategica.
Organizzazione e selezione dei contenuti
Parte dei contenuti disciplinari del quinto anno è stata assorbita dal tema comune del Consiglio di
classe, Il mio diritto, i diritti degli altri, tuttavia le discipline di indirizzo hanno proseguito una
parte di analisi sistematica su temi-autori che aiutassero a decifrare la contemporaneità o che ne
fossero una radice prossima per temi affrontati o per chiave interpretativa offerta. I temi e gli autori
sono stati scelti o come risposta a problemi emergenti della contemporaneità o come esponenti di
soluzioni contrastive o come produttori di nuove domande.
Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: circa 160 ore da settembre 2008 a giugno
2009; ore effettivamente svolte: 149
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
MODULO / U. D.
Periodo /
Ore
Psicologia
Motivazione e apprendimento:
• Il ruolo della motivazione nell’apprendimento
• Il metodo della scoperta
• Effetto Pigmalione in classe
La creatività e le sue applicazioni:
• Pensiero convergente e divergente
• Processo creativo e benessere psicologico
• Pensiero creativo e ruolo dell’insegnante
L’adolescenza:
• L’età dei cambiamenti
• La sessualità nell’adolescente
• Compiti di crescita dell’adolescenza
• La costruzione dell’identità secondo Erik Erikson
L’età adulta:
• Le teorie sull’arco vitale
Terza età:
• Il processo di invecchiamento: aspetti neurobiologici dell’invecchiamento
• Il ciclo di vita della famiglia
• Evoluzione e modificazione della personalità
• Condizione anziana e pensionamento
• Invecchiamento ed attività lavorativa
• Il disadattamento senile
7 ore
7 ore
6 ore
La comunicazione:
• Comunicazione verbale e non verbale
• La pragmatica della comunicazione: gli assiomi
• La comunicazione persuasiva
• Televisione, multimedialità, educazione
5ore
Scuole di pensiero psicologiche:
12 ore
29
•
•
•
•
•
•
•
Comportamentismo
La scuola culturale (Vygotskij)
L’epistemologia genetica (Piaget)
La scuola sistemico-relazionale (Watzlawick)
La teoria freudiana (Freud, Winnicott, Bowlby)
Visione del film su FREUD “Passioni segrete”
Il Cognitivismo (Bruner)
Pedagogia
Analisi testuale di brani rappresentativi dei pilastri del pensiero pedagogico dal
XVII° al XX° secolo:
Comenio:
• La questione del metodo e i principi della didattica
• Lettura del cap. XVII della Didactica magna in Tassi, Itinerari pedagogici,
Zanichelli 2002 (pag. 24-29)
Locke:
• Il pensiero pedagogico: l’educazione del gentleman
• Lettura di passi da Pensieri sull’educazione in Tassi, Itinerari pedagogici,
Zanichelli 2002 (pag. 66,67)
Rousseau:
• Fini e metodi educativi
• L’educazione naturale: educazione negativa, educazione positiva
• Lettura di passi da Emilio in Tassi, Itinerari pedagogici, Zanichelli 2002
(pag.96-102)
Montessori:
• La concezione educativa nella pedagogia montessoriana: sviluppo
psicologico ed autoformazione
• Lettura di passi da La scoperta del bambino: Dalla psicologia della
misurazione della pedagogia modificatrice della personalità, La casa dei
bambini laboratorio didattico della pedagogia montessoriana, L’ambiente
scolastico condizione di liberazione del bambino segreto
• Visione del film M.MONTESSORI UNA VITA PER I BAMBINI
Dewey:
• Il pragmatismo americano e la scuola progressiva
• Scuola attiva e scuola progressiva
• Democrazia, spirito scientifico ed educazione
• Lettura da Democrazia ed educazione: L’interesse in educazione e il
coinvolgimento dell’alunno nell’apprendimento in TASSI Itinerari
pedagogici pag 230
• Lettura da Esperienza ed educazione: Dall’esperienza diretta alle
materie di studio in TASSI Itinerari pedagogici pag.231
Bruner:
• Cognitivismo e post-attivismo
• Gli studi sui processi cognitivi
• Natura, cultura e formazione della personalità
• La critica alla scuola attiva
Letture di passi da Lo sviluppo cognitivo: “Sviluppo e cultura”; Dopo
Dewey:” Il processo di apprendimento nelle due culture” “Il processo
educativo in prospettiva post-attivista”; Verso una teoria
dell’istruzione: “Il superamento della concezione studiale”. Tratti dal
Vol.3 di Itinerari Pedagogici, Tassi
5ore
5ore
5 ore
5ore
4 ore
8 ore
30
Antropologia
Oggetto, metodo di studio e strumenti dell’antropologia
Cenni di storia dell’antropologia:
• L’evoluzionismo di Taylor
• L’antropologia culturale americana (Boas)
o Scuola “Cultura e Personalità” M.Mead
“Sesso e
temperamento”Lettura di passi
• L’antropologia sociale (Malinowsky)
• Materialismo culturale (Harris)
• L’ecologia culturale
• L’antropologia interpretativa o simbolica (Geertz)
Sociologia
Metodologia della ricerca sociologica
• Metodi di ricerca attivi
• Il campionamento
Storia del pensiero sociologico:
• L’Illuminismo: i precursori (Montesquieu, Rousseau)
• Il Positivismo :
Comte e la legge dei tre stadi
Durkheim: solidarietà meccanica e organica, la coscienza collettiva
• La Sociologia ottocentesca:
Marx:la teoria delle classi sociali , la coscienza di classe, la lotta di classe, il
concetto di Materialismo Storico, limiti e valori della dottrina marxiana
Weber: il sociologo della Borghesia, classi e ceti sociali, stile di vita, l’etica
protestante e lo spirito del capitalismo, Weber e l’idealtipo
• Rottura del modello razionalistico e critica del modello deterministico:
Goffman e la Drammaturgia Quotidiana, la Scuola di Palo Alto e la
Sociologia Fenomenologica
Le Sociologie
Sociologia della famiglia
L’istituzione familiare
Tipologie della famiglia
Famiglia e Rivoluzione industriale
La famiglia nucleare contemporanea
La posizione della donna nella famiglia e nella società
Giovani e famiglia
La condizione giovanile nella società contemporanea
Lettura: V. Andreoli, Tra consumo e narcisismo
Sociologia dell’Istruzione
Istruzione, educazione, formazione
La scuola e il processo di socializzazione
Rapporti tra scuola e società: cenni di storia del sistema scolastico
L’avvento dell’istruzione di massa
Compiti e caratteristiche dell’istituzione scolastica nella società
contemporanea
Il problema delle disuguaglianze all’interno del sistema scolastico
Istruzione e globalizzazione
Lettura: Zimbardo, Il bullismo: cause e antidoti
Sociologia della Comunicazione:
La comunicazione interpersonale
Comunicazione e mass media
8 ore
2ore
3ore
4ore
4ore
4ore
4ore
9ore
8ore
7ore
31
Caratteristiche della comunicazione di massa
Diritto all’informazione
Effetti dei media
Internet: una rivoluzione della comunicazione
Sociologia dello Sport
Effetti dello sport sul comportamento sociale
Funzione sociale dello sport
Origine e sviluppo dello sport
Età contemporanea: dallo sport d’élite allo sport di massa
Lo sport spettacolo
Sport e violenza
Sport e mass media
Sport e politica
Lettura: J. Huizinga Cultura del gioco e cultura dello sport
7ore
Progetto: Il mio diritto, i diritti degli altri
Diritti dell’uomo
Diritti dell’Infanzia
4ore
Compresenza con Filosofia:
Approfondimenti legati ai pedagogisti e sociologi dell’Ottocento e Novecento:
Comenio, Rousseau, Locke, Weber,
Incontri di Approfondimento
•
•
.
La metodologia della ricerca
Orientamento in uscita
Ruolo dell’antropologia nella società contemporanea
10ore
2ore
2ore
2ore
5. METODI
Alternanza di lezioni frontali e lezioni interattive, discussioni in classe, ricerche in biblioteca,
ricerche in rete.
Analisi di comunicazioni individuali e sociali ; analisi di giornali, riviste, pubblicità; realizzazione
di mappe concettuali.
6. MEZZI e SPAZI
Libro di testo, articoli di giornali o riviste, registrazioni audio e video, Film, Computer.
Testi in adozione:
PSICOLOGIA “I MOTIVI DEL COMPORTAMENTO UMANO” Zanichelli
SOCIOLOGIA : “MANUALE DI SOCIOLOGIA” bULGARINI
A disposizione della commissione una cartellina con documenti e letture non riportate nei
manuali adottati
8. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione si è effettuata in itinere e in conclusione di ogni modulo attraverso colloquiinterrogazione in forma orale e scritta.
In preparazione all’esame di Stato si sono effettuate prove conformi alle tracce degli anni precedenti
e una simulazione di seconda prova.
Per le valutazioni orali e della seconda prova, si sono adottate le seguenti griglie:
32
voto
CONOSCENZA
- dei contenuti
- dei principali
concetti
- della terminologia
specifica di leggi e
principi della
disciplina
Conoscenza scarsa rifiuta la prova o
dimostra di ignorare
completamente gli
argomenti.
1-3
4-5
6
CAPACITÁ
- comprensione
- analisi
- sintesi
- elaborazione logico-critica -
Applicazione errata - manifesta notevoli difficoltà nell'applicare
le scarse conoscenze.
Espressione scorretta - utilizza un lessico scarno e inadeguato, o
non riesce a esporre gli argomenti, neanche nella forma scritta.
Difficoltà nella relazione - dimostra notevoli difficoltà nel
rapporto con compagni e insegnanti durante le diverse attività
didattiche, e nel cogliere e interpretare adeguatamente i diversi
codici comunicativi; si estranea e si dimostra passivo nei lavori
di gruppo.
Comprensione marginale - non capisce
né a livello lessicale né a quello
contenutistico, la richiesta sul da farsi.
Analisi confusa - non è in grado, neppure
se guidato di orientarsi e individuare gli
elementi essenziali di un testo.
Sintesi inconsistente - non sa cogliere gli
elementi fondamentali di un messaggio
orale o scritto.
Elaborazione assente - non ha autonomia
di giudizio.
Comprensione approssimativa - capisce
in modo parziale ciò che viene richiesto e
non è in grado di attivarsi correttamente.
Analisi superficiale - sa individuare e
collegare pochi elementi, solo se guidato.
Sintesi frammentaria - coglie solo alcuni
degli elementi significativi, ma non sa
organizzarli secondo uno scopo, se non
guidato.
Elaborazione confusa - non valuta in
modo adeguato.
Comprensione corretta - comprende in
modo adeguato la richiesta e sa valutare
come operare, anche se in modo
meccanico.
Analisi essenziale - sa individuare gli
elementi essenziali dei diversi argomenti,
e le loro relazioni.
Sintesi coerente - sa cogliere gli elementi
più significativi di un argomento
semplice e sa collegarli, anche se in
modo elementare, secondo le indicazioni
fornite.
Elaborazione sufficiente - effettua
valutazioni personali se orientato.
Comprensione aderente - comprende in
modo corretto e rapidamente una
richiesta complessa ed è in grado di
valutare autonomamente come operare.
Analisi articolata - sa distinguere, e
cogliere le rispettive relazioni, tra gli
elementi principali e secondari di un
argomento.
Sintesi significativa - sa individuare i
livelli di articolazione di un argomento
anche complesso, organizzandoli in
nuclei significativi secondo le
indicazioni fornite.
Elaborazione aderente - valuta in modo
personale.
Comprensione puntuale - intuisce
rapidamente una richiesta anche
complessa ed è in grado di valutare in
modo autonomo, preciso e creativo come
operare.
Analisi penetrante - è in grado di
distinguere tutti gli elementi di un
argomento complesso, nelle loro
relazioni e articolazioni.
Sintesi originale - sa cogliere i diversi
nuclei più significativi di un argomento,
organizzandoli secondo uno o più scopi.
Elaborazione sicura - interpreta in modo
critico.
Conoscenza limitata
- dimostra di
possedere una
conoscenza
lacunosa,
frammentaria e/o
superficiale degli
argomenti.
Applicazione incerta - applica solo in modo incerto, nelle
diverse attività, le conoscenze, le metodologie e i principi logici
della disciplina.
Espressione approssimativa - non utilizza il lessico appropriato
ed espone gli argomenti in modo disorganico, solo se guidato.
Insicurezza - dimostra difficoltà nell'esprimere pienamente e nel
comprendere le istanze proprie e altrui durante le diverse
attività; si attiva solo se guidato e incoraggiato per raggiungere
gli scopi prefissati, anche nelle attività di gruppo.
Conoscenza
sufficiente dimostra di
possedere una
conoscenza minima
ma adeguata ed
essenziale degli
argomenti.
Applicazione appropriata - dimostra di saper applicare, anche se
in modo semplice e se guidato, i contenuti, i metodi e i
procedimenti appresi.
Espressione chiara - è in grado di esporre, nelle forme orale e
scritta, anche se in modo semplice e lineare, i contenuti appresi
con una certa autonomia e un lessico appropriato.
Comunicazione adeguata - sa come usare e interpretare
sufficientemente i diversi codici comunicativi, anche se in
modo automatico e non sempre consapevole; è in grado di
inserirsi adeguatamente, rispetto alle richieste, nelle attività di
gruppo, manifestando atteggiamenti empatici.
Conoscenza
approfondita possiede una
conoscenza completa
e articolata dei
diversi argomenti.
Applicazione sicura - è in grado di applicare le conoscenze, in
modo corretto e ordinato, nei diversi contesti delle attività
svolte.
Espressione precisa - espone in modo articolato, sia nella forma
orale che in quella scritta, utilizzando una terminologia
appropriata.
Comunicazione efficace - sa come attivarsi per comunicare
efficacemente nei diversi contesti, e per raggiungere gli scopi
prefissati, interpretando in modo corretto i messaggi; è in grado
di interpretare adeguatamente le dinamiche comunicative anche
nelle attività di gruppo, partecipando attivamente e con
interesse.
Conoscenza rigorosa
- possiede una
conoscenza
completa, coordinata
e approfondita degli
argomenti.
Applicazione autonoma - sa come fare per applicare, anche in
nuove situazioni, contenuti, metodi e procedimenti appresi, con
competenza, precisione e autonomia.
Espressione articolata - sa come esporre in modo sicuro,
organico e articolato, utilizzando un lessico appropriato e
complesso.
Comunicazione sicura - sa come padroneggiare,
consapevolmente, una gamma di intenzioni espressive e di
situazioni interazionali, adeguandole ai diversi contesti, per il
conseguimento delle mete programmate; sa come fare per
interpretare, gestire ed orientare in modo originale le dinamiche
e le attività di gruppo.
7-8
9-10
COMPETENZA
- applicazione
- espressione
- competenza comunicativa
33
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI “TITO LUCREZIO CARO” – CITTADELLA (PD)
Materia
Punteggio
(in quindicesimi)
Conoscenza e pertinenza
degli argomenti
Conoscenza completa ,
approfondita e corretta
6
Conoscenza adeguata e
abbastanza approfondita
5
Conoscenza essenziale e corretta
Conoscenze superficiale e
generica
Conoscenze frammentarie e
lacunose
4
3
Conoscenze inadeguate e
incomplete
1
Sostanzialmente preciso,
appropriato e corretto
Linguaggio pressoché corretto
anche se talvolta generico e con
qualche imprecisione
3
Linguaggio inadeguato e con
errori
1
Sa effettuare analisi e sintesi
corrette e autonome
3
Sa effettuare analisi e sintesi,
anche se talvolta parziali e
imprecise
Non sa effettuare analisi e sintesi
corrette
2
Sviluppo organico
nell’argomentazione anche in
modo personale
Elaborazione coerente e
abbastanza organica, anche se
talvolta imprecisa
Elaborazione e organizzazione
incoerente
3
(max punti 6)
Uso del linguaggio specifico
(max punti 3)
Capacità di analisi e di sintesi
(max punti 3)
Competenze
(max punti 3)
DECIMI
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
QUINDICESIMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2
1
2
1
6.56/7
11
77.5
12
88.5
13
9
10
14
15
N.B. : Produzione nulla: 1/15.
Per produzione non pertinente al quesito si valutano soltanto competenza linguistica e linguaggio
specifico.
Cittadella 13 maggio 2009
Firma del docente
Firma dei rappresentanti
34
MATEMATICA
Prof. Paolo Bolzonella
Relazione finale e programma svoltoClasse 5^AS- Anno scolastico 2008/2009
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
Lo studio della matematica ha importanti riflessi formativi, di carattere
generale o specifico, sulla qualità dei processi di pensiero. Un primo effetto è
il grande contributo che dalla matematica può venire allo sviluppo della
capacità di astrazione; in secondo luogo, lo studio della matematica può
ASPETTI FORMATIVI
portare un contributo essenziale a sviluppare e a rafforzare la capacità di
pensiero ipotetico-deduttivo; in terzo luogo, lo studio della matematica può
contribuire a rendere più evidenti le differenze fra due fondamentali forme
dell'attività cognitiva, la razionalità e la fantasia.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate.
Costruire procedure di risoluzione di un problema.
Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli
matematici atti alla loro rappresentazione.
Acquisire sicurezza espositiva, facendo propria la terminologia specifica della
materia.
Operare con il simbolismo matematico.
Applicare le regole della logica in campo matematico.
OBIETTIVI
RAGGIUNTI
La classe, complessivamente, ha raggiunto una preparazione di base,
concernente l’acquisizione delle regole della logica matematica e la loro
concreta applicazione nella risoluzione di problemi, apprezzabile. La capacità
di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite può essere giudicata, in
generale, discreta. L’atteggiamento, verso lo studio della disciplina, si è
dimostrato positivo e l’interesse soddisfacente. I progressi sono stati, in
ultima analisi, graduali ma sensibili, tenendo conto delle limitate conoscenze
pregresse. Il metodo di studio può essere giudicato regolare e ordinato.
CONTENUTI
DISCIPLINARI E
SCANSIONI
CRITERIO
METODOLOGICO
SUSSIDI DIDATTICI
STRUMENTI PER LA
VALUTAZIONE
•
•
•
•
1° QUADRIMESTRE
Funzioni
Limiti
Derivate
Teoremi sulle derivate
•
•
•
2° QUADRIMESTRE
Massimi, minimi e flessi
Studio di funzioni
Integrali
L’insegnamento della matematica è stato condotto per problemi; dall’esame di
una data situazione problematica l’allievo è stato portato, prima a formulare
un’ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante il
ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato
ottenuto in un organico quadro teorico complessivo.
Sono stati evitati approcci prevalentemente basati su esposizioni teoriche e
sulla ripetizione di concetti, che sono invece da ritenersi acquisiti mediante
l’analisi dei casi e la sollecitazione di processi induttivi.
Libro di testo:
M.Bergamini – A.Trifone – “I limiti” – Zanichelli
M.Bergamini – A.Trifone – “Le derivate e lo studio delle funzioni” – Zanichelli
La tipologia delle prove scritte svolte dalla classe è stata a stimolo chiuso e
risposta chiusa, cioè prove oggettive o strutturate, in maniera tale da evitare
ambiguità
di
interpretazione
degli
stimoli
ed
evitare
errori
nell’interpretazione dell'esito delle prove.
35
La verifica è avvenuta anche tramite interrogazioni, intese come discussioni
aperte anche all'intera classe.
Le prove scritte effettuate sono state almeno tre a trimestre.
CRITERI PER LA
VALUTAZIONE
ATTIVITA'
SVOLTE
PROVE SCRITTE
Comprensione del testo e impostazione
Conoscenze specifiche della disciplina
Sviluppo calcoli e procedimento
Completezza della risoluzione
Formalismo e qualità dell’esposizione
Originalità ed eleganza
PROVE ORALI
Conoscenza degli argomenti trattati
Precisione lessicale
Coerenza espositiva
Capacità di collegamento
Rielaborazione critica
Partecipazione ai Giochi matematici “Kangourou” (19.3.2009).
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
MODULO/UNITA’ DIDATTICA
MOD.1: Funzioni e limiti
U.D.1: Funzioni e loro proprietà
Concetto di funzione reale di variabile reale
Grafico di una funzione
Funzioni: classificazione e dominio di esistenza
Determinazione del dominio di una funzione
Funzioni monotone, composte, inverse, periodiche
U.D.2: Limiti
Definizioni di limite di una funzione
Definizione sintetica di limite
Operazioni sui limiti
Teoremi sui limiti
U.D.3: Funzioni continue e calcolo dei limiti
Continuità di una funzione
Funzioni composte e continuità
Teoremi sulle funzioni continue
Forme indeterminate
Limiti fondamentali
Calcolo dei limiti
Infinitesimi e infiniti
Applicazione della teoria degli infinitesimi e degli infiniti al calcolo dei limiti
Discontinuità di una funzione
Asintoti di una funzione
Asintoti verticali di f(x)
Asintoti orizzontali di f(x)
Asintoti obliqui di f(x)
Grafico probabile di una funzione
MOD.2: Derivate e studi di funzioni
U.D.1: Derivata di una funzione
Definizione di derivata prima e suo significato geometrico
Derivata di una funzione in un punto
Derivata destra e derivata sinistra
36
Regole di derivazione
Derivata di una somma di funzioni
Derivata di un prodotto di funzioni
Derivata del reciproco di una funzione
Derivata del quoziente di due funzioni
Regola per determinare la derivata di una funzione composta
Derivate di ordine superiore
Tangente in un punto ad una curva di data equazione
Normale in un punto ad una curva di data equazione
U.D.2: Teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange o del valore medio
Teorema di Cauchy
Teorema di De l'Hospital
Forme indeterminate
U.D.3: Massimi, minimi e flessi
Funzioni crescenti e funzioni decrescenti
Massimi e minimi relativi e assoluti
Concavità o convessità di una curva in un punto
Flessi a tangente orizzontale, obliqua, verticale
Punti angolosi e cuspidi
U.D.4: Studio delle funzioni
Studio di una funzione
MOD.3: Integrali
U.D.1: Integrali indefiniti
Proprietà dell'integrale indefinito
Integrali immediati
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
U.D.2: Integrali definiti e loro applicazioni
Integrale definito e suo significato geometrico
Proprietà dell'integrale definito
Calcolo dell'area di un dominio piano
FISICA
Prof. Paolo Bolzonella
Relazione finale e programma svolto
Anno scolastico 2008/2009
Classe 5^AS-
RELAZIONE FINALE DI FISICA
Gli aspetti formativi dello studio della fisica riguardano lo sviluppo
ed il
consolidamento di un atteggiamento di curiosità, la maturazione del pensiero
ipotetico, lo sviluppo di un atteggiamento attivo e flessibile nel modo di porsi di
ASPETTI FORMATIVI
fronte alla realtà, lo sviluppo della capacità di riconoscere, al di sotto della varietà
degli aspetti e dei fenomeni che il mondo della natura ci presenta, invarianze o
identità strutturali non immediatamente evidenti.
Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi
significativi, le relazioni e riuscendo a collegare premesse e conseguenze.
OBIETTIVI DI
Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli.
APPRENDIMENTO
Trarre deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali.
Comprendere i collegamenti della fisica con le altre discipline.
37
OBIETTIVI
RAGGIUNTI
CONTENUTI
DISCIPLINARI E
SCANSIONI
CRITERIO
METODOLOGICO
SUSSIDI DIDATTICI
STRUMENTI PER LA
VALUTAZIONE
CRITERI PER LA
VALUTAZIONE
La classe, nel complesso, ha dimostrato una discreta conoscenza degli argomenti
trattati e capacità di collegamento.
Ha inoltre raggiunto un sufficiente livello per quanto concerne l'analisi dei
fenomeni fisici e nel prospettare soluzioni a problemi, di carattere teorico e
pratico, proposti.
La capacità di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite è da considerarsi
modesta.
1° QUADRIMESTRE
Grandezze fisiche
Cinematica
2° QUADRIMESTRE
Dinamica
Meccanica dei fluidi
L'insegnamento della fisica ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale
degli allievi. I contenuti relativi hanno mirato perciò all'aspetto qualitativo e non a
quello quantitativo. Gli argomenti sono stati organizzati e proposti in ordine di
difficoltà crescente e con particolare riguardo agli argomenti più interessanti ed
attuali.
L’analisi dei fenomeni, approfondita con il dibattito in classe ed effettuata sotto la
guida dell'insegnante, ha gradualmente e con continuità sviluppato negli allievi la
capacità di schematizzare fenomeni via via più complessi.
Libro di testo:
G.Ruffo – “Lezioni di fisica” – Zanichelli
La verifica dell'acquisizione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi
formativi è avvenuta tramite interrogazioni, intese come discussioni aperte anche
all'intera classe e tramite prove scritte a stimolo chiuso e risposta aperta, cioè
prove semistrutturate.
Le prove effettuate sono state almeno due a quadrimestre.
Comprensione del testo o dell'argomento trattato.
Elaborazione delle informazioni ricevute.
Formalismo e qualità espositive.
Capacità di collegamento.
Rielaborazione critica.
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
MODULO/UNITA’ DIDATTICA
U.D.1: GRANDEZZE FISICHE
Grandezze fondamentali e grandezze derivate
Sistemi di unità di misura
Prefissi per la unità di misura
Grandezze scalari e grandezze vettoriali
Somma e differenza fra vettori
Prodotto fra vettori
Scomposizione di un vettore
Errori di misura
Media aritmetica di più misure
Errore assoluto, errore relativo ed errore percentuale
Calcolo dell'errore nelle misure indirette
Relazioni tra grandezze: funzioni e diagrammi
U.D.2: CINEMATICA
38
Sistemi di riferimento
Velocità media
Velocità istantanea
Accelerazione media
Accelerazione istantanea
Moti particolari
Moto rettilineo uniforme
Moto uniformemente accelerato
Rappresentazioni grafiche dei moti
Moto di caduta dei gravi
U.D.3: DINAMICA
Concetto di forza e leggi della dinamica
Prima legge della dinamica
Seconda legge della dinamica
Dimensioni e unità di misura delle forze
Teorema dell'impulso
Terza legge della dinamica o principio di azione e reazione
Legge di gravitazione universale
Concezione tolemaica e teoria eliocentrica
Leggi di Keplero
Forza peso
Differenza tra massa e peso
Densità e peso specifico
Composizione di moti uniformi con moti accelerati
Moto dei proiettili
Risultante di più forze
Composizione di forze parallele concordi
Composizione di forze parallele discordi
Momento di una forza rispetto a un punto
Coppia di forze
Condizioni di equilibrio
U.D.4: MECCANICA DEI FLUIDI
Legge di Pascal
Legge di Stevino
Principio di Archimede
Applicazioni del principio di Archimede
Pressione atmosferica
Fluidodinamica
Portata di un condotto ed equazione di continuità
Fluidi reali
Viscosità
Prof. Paolo Bolzonella
___________________________________
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
______________________________________________________
39
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia
Francese
Classe 5 ASO
a.s. 2008/2009
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZA:
Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte delle alunne:
o
o
o
possiede una conoscenza più approfondita delle strutture morfosintattiche della L2 e un lessico
sufficientemente ampio e vario per poter esprimere in modo corretto e appropriato quanto richiesto
dai temi proposti.
hanno una conoscenza generalmente soddisfacente di temi dell’attualità socioculturale;
posseggono informazioni sugli aspetti salienti della cultura francese, attraverso l’approccio di testi
letterari e non.
COMPETENZE:
Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte delle alunne:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
comprende una varietà di messaggi orali, in maniera globale o analitica, di interesse generale e
relativi al settore specifico dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali;
sa stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione adatta al contesto e alla
situazione su argomenti vari e di carattere socioculturale.
comprende globalmente e analizza testi autentici anche di tipo letterario in lingua francese;
relaziona oralmente in modo sufficientemente corretto su testi autentici in lingua francese;
riconosce aspetti formali e stilistici dei testi letterari e usa alcuni strumenti di base di analisi
testuale;
riconosce le strutture formali e linguistiche delle differenti tipologie testuali;
produce semplici testi sufficientemente corretti anche di tipo argomentativo;
prende appunti in lingua francese e riassume in modo sufficientemente coeso e coerente un testo;
indica in lingua francese alcuni significati, sinonimi e contrari di uno stesso vocabolo.
CAPACITÀ:
Alla fine dell’ano scolastico, la maggior parte delle alunne è in grado di:
o
o
o
riorganizzare i contenuti, in modo semplice e aiutandosi con schemi e appunti, sintetizzare le
conoscenze acquisite;
esprimere valutazioni e giudizi personali sufficientemente corretti;
operare qualche collegamento con le altre discipline, soprattutto quelle dell’indirizzo.
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D./ Approfondimento
Ripasso di alcuni argomenti grammaticali: Passé composé, imparfait,
pronoms COD et COI, pronoms relatifs, impératif affirmatif et négatif, la
coniugazione dei verbi con particolarità ortografica, ripasso delle regole di
pronuncia: alcune nozioni fonetiche.
L’uso corretto del dizionario.
Civilisation: Le racisme.
“Non, l’homme blanc n’est pas un être supérieur” come esempio di testo
argomentativo.
Brano di Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille
Modulo di letteratura: XVIIIe siècle: Les philosophes des Lumières.
Montesquieu, Voltaire, Rousseau: leurs idées politiques
Lettura di brani tratti da :
D’Alembert: article “Collège” de l’Encyclopédie
Montesquieu, Les Lettres Persanes (« Comment peut-on être Persan ? »)
Periodo /ore
9
3
5
40
Strutture grammaticali : l’uso del congiuntivo, casi particolari. Il condizionale
passato.
6
Modulo di letteratura: XIXe et le XXe siècles: Le roman
La figure du héros.
Lettura di brani di opere del XIX secolo:
Gustave Flaubert, L’éducation sentimentale («Une apparition », « Un
homme éperdu »)
Stendhal, La Chartreuse de Parme («Le bonheur en prison », « Il n’y
comprenait rien du tout »)
Emile Zola, L’Assommoir («Une existence impossibile”)
Lettura di brani del XX secolo :
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (« La Madeleine »)
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (« Une étrange fête »)
Albert Camus, L’Etranger (« Un homme étranger à lui-même », « Le
procès »)
10
Modulo di letteratura: la guerre
Esempi letterari sul tema della guerra.
Arthur Rimbaud, “Le Dormeur du Val”
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit («Ferdinand ou l’antihéros » )
Boris Vian, Le Déserteur
Jacques Prévert, « Barbara »
8
10
Civiltà: La decolonizzazione in Indocina e in Africa e la guerra
d’Indipendenza algerina
Strutture grammaticali: le passé simple, le participe présent et le gérondif
Letteratura: documenti significativi in lingua francese per l’Educazione.
Lettura di alcuni passi dell’Emile ou de l’éducation (livre troisième, XLVIII) di
Jean-Jacques Rousseau con particolare attenzione all’educazione femminile
e all’educazione negativa.
Accenni all’influenza di Jean Piaget per la teoria dell’apprendimento
linguistico: “Schèmes d’action et apprentissage du langage”
6
Jean-Paul Sartre et l’Existentialisme: lettura di un brano filosofico tratto da
L’Existentialisme est un humanisme
Civilisation: Les institutions françaises : Le Président de la République, le
gouvernement et le parlement, les plus importants partis politiques
11
Approfondimenti a gruppi : lettura di alcuni brani tratti dal Candide di
Voltaire, analisi della poesia Liberté di Paul Eluard.
Strutture grammaticali: approfondimenti
Progetto dell’indirizzo delle scienze sociali “Il mio diritto- i diritti degli altri”
“La liberté d’expression. Le premier des droits de l’homme.”
« L’égalite des femmes. Hommes/femmes : la marche vers l’égalité
continue »
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (fino
al 13/05/09); sono state dedicate 7 ore allo svolgimento delle verifiche
scritte ed orali.
4
Totale ore effettivamente
svolte 73
(Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,
attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc….):
2. METODOLOGIE
L’approccio adottato per il conseguimento degli obiettivi è stato prevalentemente quello comunicativo. Per
quanto possibile, si è usato il più possibile la lingua francese durante le lezioni per le interazioni verbali e
scritte. Per favorire la produzione orale, sono state utilizzate tecniche di simulazione, drammatizzazione e
conversazioni nell’ambito della vita quotidiana. A volte dei documenti orali registrati sono serviti da spunto
per portare le alunne ad esprimersi su vari argomenti e naturalmente anche per valutare la comprensione
orale. Per la comprensione scritta sono stati utilizzati in modo sempre più continuo testi autentici e sono
41
state applicate le tecniche di lettura di tipo estensivo ed intensivo. Per favorire la produzione scritta, le
alunne sono state guidate alla redazione e rielaborazione di testi.
Alcune alunne si sono avvalse degli sportelli didattici per approfondire gli argomenti trattati in classe o per
chiedere dei chiarimenti.
Per alcuni argomenti sono stati proposti lavori di gruppo anche per responsabilizzare le allieve e per dare la
possibilità alle alunne che erano in difficoltà a confrontarsi con le compagne.
3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc….):
Libro di testo in adozione :
- E. DE GENNARO, Nouveau Forum, Modules de langue et civilisation, Il Capitello.
- Integrazione con fotocopie e appunti forniti dall’insegnante.
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Libro di testo. CD audio e/o DVD. Registratore e/o
videoregistratore. Si è cercato di utilizzare anche l’aula informatica per visitare siti di esercitazioni o di
interesse per l’apprendimento della lingua, e per fare delle ricerche per la tesina. Naturalmente, anche il
dizionario bilingue e materiale autentico facevano parte dei materiali didattici.
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (specificare prove scritte, verifiche orali, test
oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio ecc…..):
Le prove sono state anche multicomprensive e prevedevano quindi valutazioni
differenziate, a seconda delle abilità. Sono state svolte 5 prove scritte e mediamente tre
prove orali nel corso dell’anno oltre alle varie valutazioni in itinere, a scelta tra le
seguenti tipologie:
Verifica della comprensione (di produzioni orali e testi scritti):
completamento di testi e griglie, domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa;
Verifica della produzione orale:colloquio, simulazione di interazione comunicativa, traduzione simultanea, esposizione,
relazioni, discussioni, esposizioni anche in vista dell’esame orale in lingua francese;
Verifica della produzione scritta : risposte a questionari, trasformazione, riformulazione, traduzione, stesura,
brevi composizioni di carattere generale su traccia, simulazioni di terza prova.
Per le attività integrate: riassunti, parafrasi di brevi testi, schede di lettura, analisi su traccia di testi letterari o
di altro tipo.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche
effettuate:
tre simulazioni della Terza prova.
IL DOCENTE
__________________________________________________
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
______________________________________________________________________________
42
RELAZIONE FINALE DI INGLESE
Classe 5^A Scienze Sociali
Ins. Daniela
Vitturelli
PREMESSA
Fin dall’inizio dell’anno scolastico sono state evidenziate numerose lacune di tipo linguistico che hanno fortemente influito
sul profitto globale della classe nel primo quadrimestre. Il fatto che le alunne, nell’arco del quinquennio, abbiano subito
un cambio di insegnante di inglese praticamente ogni anno, ha comportato un continuo adeguamento a metodologie e
aspettative nuove, il che può averne inizialmente compromesso la motivazione ed il livello di interesse e partecipazione.
Tuttavia, la classe ha dimostrato di essere consapevole delle diffuse carenze nella disciplina e si è generalmente
impegnata per tentare di superare le stesse e di raggiungere un livello di comunicazione orale e scritta adeguati. La
programmazione iniziale aveva previsto il consolidamento di quelle strutture morfo-sintattiche ritenute strumenti
indispensabili per l’esposizione di contenuti anche di tipo letterario. Su questo punto si è lavorato in modo approfondito e
costante e, alla data odierna, la maggior parte delle alunne ha raggiunto un livello espositivo globalmente sufficiente.
Tuttavia, la necessità di un monitoraggio continuo dei suddetti argomenti linguistici, con assidue esercitazioni in classe e
a casa, ha provocato una inevitabile riduzione del programma di letteratura. Si è infatti ritenuto prioritario il superamento
delle carenze linguistiche, dal quale dipende l’efficacia comunicativa in lingua straniera su argomenti di varia tipologia.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
In relazione alla programmazione curriculare per quest’anno scolastico sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
(Per lo specifico dei contenuti si rimanda alla voce: “Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione”)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
strutture grammaticali e morfo-sintattiche a livello intermedio;
tratti salienti della storia e della civiltà inglese e, in parte, statunitense dalla fine del 18° secolo alla prima metà del
‘900;
alcuni aspetti del sistema letterario straniero e sviluppo di tematiche di tipo sociale.
COMPETENZE
comprensione orale: comprendere il senso globale di messaggi orali attinenti a vari contesti, ma comprendere in
modo analitico i messaggi relativi ad argomenti trattati in classe, operare inferenze, distinguere i vari livelli di
formalizzazione del linguaggio, registri, lessico specifico per le scienze sociali;
produzione orale: esporre, argomentare, narrare vari tipi di testi orali attinenti ad argomenti precedentemente trattati
in classe, utilizzando quindi un linguaggio ed uno stile sufficientemente corretti, appropriati ed efficaci; sostenere una
conversazione idonea al contesto e alla situazione comunicativa.
comprensione scritta: comprendere in modo sia globale che analitico vari tipologie di testo, estrapolare le
informazioni principali, dedurre il significato di vocaboli sconosciuti dal contesto, dall’etimo e dalla forma.
produzione scritta: seguendo indicazioni date, produrre testi scritti di varia tipologia (descrizioni, narrazioni, riassunti,
esposizioni) attinenti ad argomenti trattati in classe; scrivere in modo sufficientemente corretto dal punto di vista
ortografico, grammaticale, lessicale ed organizzato dal punto di vista del contenuto.
CAPACITÀ
riconoscere i vari aspetti formali e stilistici di testi di letteratura inglese, riconoscere le strutture e le convenzioni dei
vari generi letterari, analizzare contenuti e forma dei testi cercando di formulare giudizi motivati, effettuale
collegamenti disciplinari e interdisciplinari in maniera abbastanza autonoma.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Per la verifica dell’apprendimento individuale, a tutt’oggi sono state eseguite mediamente 6 prove scritte e 3 prove orali.
Una delle prove ha coinciso con una simulazione di terza prova d’esame.
Sono state utilizzate le allegate griglie di valutazione, approvate dal Dipartimento di Lingue.
La tipologia delle prove somministrate è stata la seguente:
Prove scritte: test sullo sviluppo delle conoscenze morfosintattiche e lessicali e sulle competenze di
writing su traccia, anche di tipo letterario, quesiti a risposte singole; trattazione sintetica di un
argomento.
Prove orali: discussioni, relazioni, esposizioni di lavori individuali e di gruppo, interventi dal posto,
interrogazioni formalizzate.
STRUMENTI
- LIBRO DI TESTO:
Literary Landscapes – G. Thomson , S. Maglioni ed. Black Cat-Cideb
- fotocopie per approfondimenti grammaticali o per scelte antologiche diverse da quelle proposte dal libro di testo.
- utilizzo di PC, proiettore, lavagna luminosa, lettore DVD, registratore, lettore CD e aula video.
- Internet.
43
MODALITÀ DI LAVORO
Si è sempre impostato, per quanto possibile, l’acquisizione della lingua e dei suoi contenuti su basi operative e
interattive, tenendo conto del livello di partenza della classe, delle competenze, interessi e motivazione. Per questo
motivo si è tentato di limitare il più possibile la lezione tipo frontale che non ha occupato più del 30% circa del tempo
a disposizione in classe, ed è stata utilizzata per:
Illustrare ed esemplificare strutture complesse o di particolare importanza nell’apprendimento linguistico, soprattutto
tramite l’analisi dell’errore, per sganciare gli alunni da una dipendenza marcata dalle strutture linguistiche
dell’italiano;
Introdurre concetti extralinguistici (storici, letterari, ecc.) complessi;
Dare indicazioni metodologiche per il lavoro in classe e a casa
Per il resto del tempo, il ruolo dell’insegnante è stato di volta in volta quello di guida (organizzatore e supervisore),
consulente e monitor. Si è tentato di coinvolgere il più possibile le alunne in attività quali:
Dialogo con il docente
Attività di ascolto
Lavori di gruppo
Discussione/conversazione in classe
Sollecitazione di interventi su argomenti letterari.
L’uso della lingua straniera è stato decisamente prevalente.
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
Non sono stati effettuati corsi di recupero, poiché l’intera classe necessitava di attività di rinforzo e consolidamento.
All’inizio del 2° quadrimestre si è quindi deciso di dedicare un congruo numero di ore al ripasso grammaticale di quelle
strutture fondamentali per le quali molte alunne avevano avuto una valutazione insufficiente alla fine del primo
quadrimestre. Alla fine di tale ripasso, risultato comunque utile anche alle alunne con valutazione positiva, quasi tutte le
studentesse hanno recuperato le insufficienze del primo quadrimestre.
Inoltre, è sempre stato attivo lo sportello didattico di inglese.
ORE DI LEZIONE SVOLTE (comprensive delle verifiche)
Totale delle ore di lezione effettivamente svolte alla data odierna: 51
Primo quadrimestre: 24 ore
Secondo quadrimestre: 27 ore
Sono previste ulteriori 5/6 ore fino alla fine della scuola.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Prerequisiti
MODULO SULLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Potenziamento competenze linguistiche
Consolidamento e potenziamento degli strumenti linguistici e stilistici per affrontare la produzione di
una trattazione sintetica.
Raggiungimento degli obiettivi linguistici minimi previsti per le prime tre classi del corso di studi.
Conoscenze
1.
Tempi
2.
3.
4.
5.
11
Modulo 0
Unità Didattiche
Ripasso dei seguenti tempi verbali: simple past, present perfect simple e continuous, confronto
tra il present perfect ed il simple past, past continuous, past perfect simple e continuous.
Connettivi: “and” and “but”-type linkers.
Ripasso del futuro: future simple, present continuous, going to.
Condizionali: 1st – 2nd – 3rd type conditional, if I were … if I had done…
Come strutturare un saggio breve o una trattazione sintetica di tipo letterario e non.
ore
MODULI DI LETTERATURA
La scelta antologica ha tenuto conto della specificità dell’indirizzo e, particolarmente, del progetto “Il mio diritto, i diritti
degli altri” presentato a settembre 2008. Pertanto, i brani tratti dalle opere selezionate sono stati analizzati tenendo conto
delle problematiche etico-sociali emerse nei periodi di riferimento.
E’ stato inoltre approfondito un tema del suddetto progetto inerente i “diritti negati” tramite la visione di un filmdocumentario in lingua inglese, legato al modulo 2 di letteratura, e alla successiva riflessione e discussione in classe in
inglese.
Module 1
Unità didattiche
THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
1.
Attività di ripasso degli ultimi argomenti trattati nel precedente a.s.
44
Prerequisiti
Conoscenze
Tempi
Module 2
Unità didattiche
Prerequisiti
Conoscenze
Tempi
2. Contesto storico, sociale, culturale
3. La letteratura vittoriana: il romanzo
4. La letteratura vittoriana: il teatro
5. Uno sguardo all’America: Walt Whitman
Conoscenza dello sviluppo letterario del periodo romantico
Analisi di testi poetici, narrativi e teatrali: concetti chiave
U.D. 1
Tratti salienti del periodo Romantico
U.D. 2
The Age of Empire
The Arguments For and Against Imperialism
United States: birth of a nation, slavery, American way of life
U.D. 3
- Victorian Literature
Charles Dickens: brano da Hard Times
U.D. 4
- Victorian Literature
Oscar Wilde: brano da The Importance of Being Earnest
U.D. 5
- Poetry in America: Walt Whitman: da Leaves of Grass:
“I hear America singing”
“For you, O Democracy”
15 ore
THE MODERN AGE (1901-1945)
1. Contesto storico, sociale, culturale
2. Il modernismo nel romanzo
3. Il modernismo nella poesia
Conoscenza dello sviluppo letterario del periodo vittoriano
Analisi del testo poetico, teatrale e narrativo: concetti chiave
U.D. 1
A Time of war: World Wars I and II, consequences, the Holocaust, cultural transformations
U.D. 2
Modern Literature: the modern novel, stream of consciousness fiction.
J. Conrad: brano da Heart of Darkness: “The voyage down the Congo river”
Visione del film-documentario della CNN “A War against Women”
J. Joyce: brano da Dubliners: “Eveline”
Si prevede, inoltre, di svolgere il seguente argomento entro la fine di maggio:
U.D. 3
Modern Literature: poetry
T.S. Eliot: tre sezioni di The Hollow Men
27 ore
LA DOCENTE
________________________________________________
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
_____________________________________________________
45
RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO
Docente: Mendo Daniela
2008/2009
Materia: scienze opzione
Classe:__5 A sociale
In relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini
di:
CONOSCENZE
Bioetica
Rapporto bioetica e società
Neurobiologia cellulare
Neuroscienze
Processi di apprendimento
Memoria
Memoria e apprendimento
Emozioni
Mente e cervello
Sonno
COMPETENZE
Comunicare, concettualizzare, problematizzare,
Per comunicare:
codificare
decodificare
per problematizzare:
individuare il problema
prospettare possibili soluzioni
scegliere sulla pluralità di elementi di analisi
per concettualizzare:
riconoscere ( in un fenomeno, problema, modello..) i concetti implicati
distinguere tra fenomeno e concetto
saper generalizzare
CAPACITÀ
Saper comunicare, concettualizzare, problematizzare
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI
Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe
Monte ore realizzato al quindici di maggio
Ore
47
Monte ore preventivato fino alla fine della scuola Ore
Ore 66
53
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Modulo organizzato in unità di apprendimento
(elencate in ordine cronologico)
Bioetica ( h. 6 primo quadrimestre)
Rapporto bioetica e società
( h. 9 primo quadrimestre)
( h. 4
Diritti
primo quadrimestre)
Neurobiologia cellulare
( h. 2 secondo quadrimestre)
Competenze disciplinari
Sa analizzare testi scientifici individuandone le tesi, il
percorso argomentativo, il contesto di riferimento
Sa ricostruire il percorso compiuto e le diverse
procedure adottate
Sa analizzare il problema nella sua complessità
Sa ripercorrere la storia della bioetica
Sviluppa la consapevolezza del rapporto problematico
che lega le scoperte scientifiche alle loro applicazioni,
da un lato, e ai risvolti etico-sociali dall'altro
Sa individuare le necessità e le norme che da queste
sono scaturite
Sa analizzare il problema nella sua complessità
Sa descrivere le differenze tra il neurone e una qualsiasi
altra cellula
Sa descrivere come i neuroni producono stimoli e li
trasmettono
46
( h. 10
Neuroscienze
secondo quadrimestre)
( h. 2
Neuroni specchio
secondo quadrimestre)
Processi di apprendimento
( h. 4 secondo quadrimestre)
Memoria ( h. 4 secondo quadrimestre)
Memoria e apprendimento
( h. 5 secondo quadrimestre)
Emozioni ( h. 2
secondo quadrimestre)
Mente e cervello ( h. 3 secondo quadrimestre)
Sonno ( h. 3 secondo quadrimestre)
Descriver i campi di ricerca e i livelli di conoscenza
indagati dalla disciplina
Ripercorre le tappe di sviluppo della disciplina
Sa analizzare come l’informazione sensoriale deve
essere ricombinata in modo idoneo con l’attività motoria
per produrre un comportamento adeguato
Sa descrivere una delle più sensazionali scoperte degli
ultimi anni
Riconosce le varie implicazioni di tale scoperta
Sa descrivere i processi di apprendimento come forma
continua di differenziazione e come mutamento di
comportamento adattativi condizionato
dall’informazione
Sa differenziare l’apprendimento associativo da quello
non associativo
Classifica i vari esempi di l’apprendimento associativo
Sa descrivere questa funzione cerebrale complessa
come la capacità di immagazzinare le informazioni
scaturite dall’esperienza e di recuperare gran parte di
esse
Descriver la biologia dei ricordi
Sa riportare le fasi principali dello studio delle basi
molecolari della memoria
Sa classificare e descrivere i vari tipi di memoria
Sa valutare l’impatto della scoperta della proteina che
detiene il potere di controllo dei recettori esposti e
funzionanti
Sa descrivere come i sentimenti soggettivi e gli stati
fisiologici a essi associati sono aspetti essenziali della
normale esperienza umana
Sa definire la differenza
Sa individuare le differenze a livello di attività
cerebrale tra il sonno e la veglia
Sa spiegare perché gli animali dormono
Nuclei multidisciplinari
All’interno del progetto di indirizzo: IL MIO DIRITTO, I DIRITTI DEGLI
ALTRI,è stato sviluppato il tema : la bioetica e i diritti
Articolazione dell'attività
Fase introduttiva Presentazione dell’argomento
Sistematizzazione delle
conoscenze
Verifica sommativa di fine
modulo ( 1h)
Recupero approfondimento
Periodo
Primo quadrimestre
METODI
Strategie e organizzazione sociale del lavoro
Problem posing / brain-storming\ Lavoro individuale
Problematizzazione dell’argomento / lezione frontale\ lezione circolare\
Studio individuale
Lavoro individuale / domande individuali
Verifica finale scritta relativa alle unità didattiche che concorrono a completare il modulo è
stata costituita costituita da diverse tipologie di item ( a risposta multipla, a completamento,
esercizi, vero/falso, accoppiamento di termini a definizioni) per una valutazione veloce
dell'apprendimento. Una seconda parte è stata utilizzata per saggi brevi, trattazioni sintetiche
anche in vista della terza prova all’esame di stato
È stato riservato uno spazio anche al colloquio orale sotto forma di discussione guidata dal
docente o di riflessione orale su problemi sperimentali e teorici oppure sotto forma di
interrogazione su traccia
Sono state attivate strategie diverse, durante la lezione, di recupero per gli studenti che nel
modulo non hanno ottenuto la sufficienza. Sono stati valutati anche eventuali lavori domestici
e/o approfondimenti personali
MATERIALI DIDATTICI:
Appunti di lezione
Prodotti multimediali
Articoli e testi scientifici vari
47
Griglia di valutazione per le domande aperte
Conoscenza, completezza e
pertinenza delle
informazioni 35%
Capacità di analisi e sintesi
25%
scorretta, lacunosa
e non pertinente
0.5
totalmente carente
0.5
parziale e
approssimativa
1
Essenziale
2
poco efficace
1
Coerenza argomentativa
20%
contraddittoria e disorganica
0.5
Correttezza formale ed uso
di un linguaggio specifico
20%
impreciso e non appropriato
0.5
chiara e
abbastanza
approfondita
2.5
Corretta
2
Corretta
1
globalmente corretto e
appropriato
1
precisa, completa
e pertinente
3.5
puntuale ed
efficace
2.5
approfondita ed organica
2
scorrevole ed appropriato
2
Griglia di valutazione domande chiuse
Comprensione (40%)
Conoscenza
contenuti(30%)
Punteggio totale complessivo
70
Rielaborazione (30%)
Totale
/70
Punteggio minimo per la sufficienza 40
Cittadella,____________________
…………………..
Firma del Docente
______________________________
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
______________________________________
48
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia opzionale: Storia dell’Arte Classe 5 ASO a.s. 2008/2009
Prof.ssa Valentina Casarotto
La parte della classe che ha scelto come materia opzionale Storia dell’arte si è dimostra motivata ed interessata verso la
disciplina, disponibile all’ascolto ed al dialogo. Il comportamento è in genere corretto ed educato. Nel mese di
settembre, attraverso le prime lezioni dialogiche, sono state accertate e implementate le nozioni fondamentali relative
alla metodologia specifica con cui affrontare lo studio della materia. Il programma svolto l’anno precedente permetteva
di affrontare con agilità la prima parete del programma (il Rococò e il Neoclassisicmo), per dare maggior spazio alla
trattazione dell’Ottocento e delle Avanguardie, che risvegliano l’interesse degli studenti.
La partecipazione degli studenti è sempre stata improntata a uno scambio proficuo, cosa che ha reso le lezioni più
dinamiche e interattive, il tutto sostenuto da un buon grado di studio e di critica.
Nella programmazione della disciplina ho inserito approfondimenti anche esterni al libro di testo quali:
- La cultura giapponese nell’arte dell’Ottocento
- I grandi fotografi nell’arte: Bragaglia, Stiegliz, Curtis
- Tamara de Lempicka, una donna fuori dagli schemi
- Laboratorio futurista (in occasione della Giornata dell’Arte, in collaborazione con la prof.ssa di Lettere A.
Lovisetto)
Questi temi e argomenti hanno dato un contributo trasversale alla lettura critica delle opere e, grazie al continuo
esercizio di riconoscimenti, gli studenti hanno migliorato alcune competenze quali l’individuazione delle tecniche
artistiche, dei riferimenti culturali e storici interni ed esterni all’opera, e delle caratteristiche stilistiche proprie dei
diversi movimenti artistici, italiani e stranieri, pregressi e coesistenti nel medesimo secolo.
Le lezioni sono sempre state tenute con materiale multimediale, con massiccia proiezione di immagini delle opere e di
tutto il materiale iconografico ad esso collegate.
A integrazione ho proposto di visionare a casa dei documentati o della filmografia sia a carattere biografico che a
carattere storico, per rendere più piacevole l’acquisizione del senso storico artistico dei periodi trattati.
Le prove di verifica, interrogazioni e test, sono state programmate e concordate con gli studenti con sufficiente anticipo,
con chiara definizione degli obiettivi da conseguire, e nella valutazione è stata rispettata la griglia della disciplina
contenuta nel POF.
La classe ha raggiunto un livello buono di conoscenze e competenze, con alcune punte di eccellenza.
Il vivo interesse per la disciplina è perdurato per tutto l’anno, anche se la materia non è stata inserita tra quelle inerenti
la prova d’esame. Alcuni studenti hanno richiesto la mia partecipazione per dotare le “tesine” di una adeguata parte
iconografica inerente l’argomento prescelto.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZA:
-
Conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico, dal Settecento alla metà
del Novecento.
Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche studiate (pittura,
scultura, architettura), la storia dell’arte e la critica d’arte.
Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione dell’opera d’arte
COMPETENZE:
Esposizione analitica, sintetica e complessiva delle conoscenze inerenti le espressioni artistiche studiate, la
storia dell’arte e la critica d’arte .
- Superamento dell’approccio superficialmente valutativo dell’opera d’arte, dipendente solo:
a) dal livello di apprezzamento estetico personale;
b) da criteri inerenti la verosimiglianza dell’immagine
CAPACITÀ:
-
Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli:
descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con un utilizzo
appropriato della terminologia specifica),
stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità),
contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento artistico),
storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato ambito sociale di
produzione e di fruizione),
49
-
iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base dell’individuazione di una
struttura simbolica o allegorica)
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D.
Il primo Settecento: inquadramento storico generale
F. Juvarra, L. Vanvitelli, G. Tiepolo
Il vedutismo veneto: A. Canaletto, B. Bellotto
La scena di vita: P. Longhi.; il ritratto settecentesco: Rosalba Carriera
Il Neoclassicismo:
inquadramento storico generale, la vita e le opere di
La riscoperta del mondo classico. G. B. Piranesi, A. Canova
La pittura : J. L. David, F. Goya, D. Ingres
Il Romanticismo: inquadramento storico generale, cenni sulla vita e sulle opere di
T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez
Approfondimento: I pittori visionari del nord: W. Blake, J.H. Fussli, C. D.
Friedrich
Il Realismo: inquadramento storico generale, cenni sulla vita e sulle opere di
La nascita della fotografia: Nadar
G. Courbet, F. Millet
Approfondimento: Il giapponismo nell’arte dell’Ottocento
L’Impressionismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
E. Manet,
C. Monet
P. A. Renoir
E. Degas
Il Neoimpressionismo: G. Seurat
Il Postimpressionismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
P. Gauguin
V. Van Gogh
P. Cezanne
H. de Toulouse Lautrec
I fenomeni artistici del secondo Ottocento:cenni sui movimenti, sulla vita e sulle
opere dei Macchiaioli: S. Lega, G. Fattori
G. Boldini a Parigi
La Scultura: A. Rodin;
Art Nouveau: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
G. Klimt
Approfondimento: Una donna fuori dagli schemi: Tamara De Lempicka
Le avanguardie artistiche del Novecento: inquadramento storico generale
L’Espressionismo: i Fauves e Die Brucke, H. Matisse
Caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
E. Munch, O. Kokoscka, E. Schiele, O. Dix, G. Grozs
Il Cubismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
L’esperienza artistica di Picasso
Il Futurismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
U. Boccioni, A. Sant’Elia, E. Prampolini, G. Dottori:
Approfondimento: La fotografia futurista dei fratelli Bragaglia
Il Dadaismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
M. Duchamp, Man Rey, F. Picabia, La fotografia americana: Alfred Stieglitz
Il Surrealismo:caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere d i
M. Ernst; J. Mirò; R. Magritte, S. Dalì
Ore
Periodo /ore
2h
1h
1h
Settembre/ Ottobre
2h
2h
3h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2h
1h
2h
2h
1h
1h
1h
Novembre
Dicembre
Gennaio
1h
1h
1h
Febbraio- Marzo
1h
1h
2h
2h
2h
Aprile
1h
2h
50
L’astrattismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
V. Kandinskij; P. Klee
De Stijl: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
P. Mondrian. L’esperienza del Bauhaus
La “Scuola di Parigi”:
M. Chagall, A. Modigliani
La Metafisica: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
G. De Chirico, G. Morandi
L’architettura del Novecento: cenni sulla vita e sulle opere di
Le Corbusier, F. L. Wright
L’arte dopo la Seconda guerra mondiale, cenni sulla vita e sulle opere di
L’Informale: J. Pollock
La Pop art: A. Warhol
La fotografia della frontiera americana: E. Curtis
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico, comprese le
interrogazioni
1h
2h
Entro il 15 Maggio
1h
1h
2h
1h
Dopo il 15 Maggio
1h
1h
57
Ore
PROGRAMMA SVOLTO
DOcente: Valentina Casarotto
Materia: Storia Dell’Arte
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D.
Il Primo Settecento: i caratteri generali
F. Juvarra, La reggia di Stupinigi
L. Vanvitelli: La reggia di Caserta
G. Tiepolo: la decorazione di Palazzo Labia, del castello di Wurzburg, la
decorazione delle ville venete.
La scena di vita: Pietro Longhi: la lezione di Geografia, Il Cavedenti.
Il vedutismo e la camera ottica
A. Canaletto: Le vedute di Venezia: SS. Giovanni e Paolo, Il ritorno del
Bucintoro al Molo nel giorno dell’Ascensione, Il Molo, La libreria e sullo sfondo
la chiesa della Salute.
F. Guardi: Molo con la Libreria verso la Salute; Rio dei Mendicanti,
Il ritratto settecentesco: Rosalba Carriera
L’illuminismo e il neoclassicismo: inquadramento storico generale
La riscoperta del mondo classico: gli scavi archeologici e le statue antiche
G. B Piranesi: Le carceri, Fondamenta del Mausoleo di Adriano, progetti per
abside di S. Giovanni in Laterano
A. Canova: i disegni, Il Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina
Borghese, Le Grazie, Monumento Funebre a M. Cristina D’Austria.
J. L. David: i disegni, il Patroclo, Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat,
Le Sabine, Leonida alle Termopili, Il ritratto di Bonaparte al San Bernardo
J. A. D. Ingres: Accademia di Nudo, il Bagno turco, L’apoteosi di Omero, Il
sogno di Ossian, La grande odalisca, i ritratti
Esercitazione: Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, i papi, i monumenti
d’Italia e la tutela. La nascita dei musei veneti.
Il Romanticismo: caratteri generali
T. Géricault: Corazziere Ferito Che Abbandona Il Campo Di Battaglia, Cattura
di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La Zattera Della Medusa, I
Ritratti Degli Alienati.
E. Delacroix: la barca di Dante, la moglie di Abraham Benchimol
la Libertà che guida il popolo, San Michele che vince il demonio a Saint-Sulpice.
F. Hayez: Aiace d’Oileo, Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani,
Pensiero malinconico, Il bacio, il ritratto di Massimo d’Azeglio.
L’esperienza di F. Goya: Le Majas, 3 Maggio 1808, Saturno divora i figli.
(fotocopie)
Approfondimento: I pittori romantici visionari del Nord: J. H. Fusseli: L’incubo;
Periodo /ore
Settembre
Ottobre
Novembre
51
W. Blake: Tiger Tiger, C. D. Friedrich: il viandante (fotocopie)
Il Realismo e G. Courbet: Lo spaccapietre, l’atelier del pittore, Fanciulle sulla
riva della Senna, Jo la bella ragazza irlandese.
Il fenomeno dei Macchiaioli.
G. Fattori: Campo Italiano della Battaglia ai Magenta, Soldati Francesi Del ’59,
La Rotonda di Palmieri, In Vedetta, Bovi Al Carro, Lo Staffato; S. Lega: Il canto
dello stornello
Approfondimento: la cultura giapponese e l’impressionismo (appunti da
Artedossier)
L’impressionismo. Caratteri generali.
La fotografia: l’invenzione del secolo; F. Nadar;
E. Manet: Colazione sull’erba 1863;1866, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères;
C. Monet: Impressione: Soleil Levant, I Papaveri, La Grenouillère, Le Serie
Della Cattedrale Di Rouen, I Covoni, Lo Stagno Delle Ninfee; Palazzo Ducale a
Venezia;
E. Degas: La Lezione di Danza, L’assenzio, La Prugna, La Tinozza
P. A. Renoir: Studi Di Nudo, La Grenouillère, Moulin De La Galette, La
Colazione Dei Canottieri, Bagnante Seduta;
Il pointillisme
G. Seurat: Un Bagno a Asnières, Una Domenica Pomeriggio Alla Grande Jatte,
Il Circo;
Tendenze post-impressioniste:
P. Cézanne: Le nature morte, La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La
montagna Saint-Victoire;
P. Gauguin: L’Onda, Il cristo giallo, Come sei gelosa?, Da dove veniamo?, Chi
siamo? Dove andiamo?
V. Van Gogh: La casa gialla, I mangiatori di patate, gli autoritratti, Il ponte di
Langlois, Veduta di Arles con iris in primo piano, La pianura della Crau con le
rovine di Montmajour, Campo di grano con corvi;
H. de Toulouse-Lautrec: al Moulin Rouge, I manifesti,
L’art-nouveau e la belle époque.
Le Arts and Crafts di W. Morris, L’Art Nouveau e il gusto borghese.
G. Klimt: La Giovinezza, Idillio, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I,
Tipologie di Ritratti e decorazioni, La Culla, La Danae
Approfondimento: Tamara de Lempicka: una donna fuori dagli schemi
I Fauves: caratteri generali
H. Matisse: Donna con Cappello, La Stanza Rossa, Pesci Rossi, Signora In Blu,
ritratto di M. Maeght.
L’espressionismo: caratteri generali
Il gruppo Die Brucke: E. L. Kirchner, Cinque donne per la strada;
E. Munch: La modella parigina, La fanciulla malata, Sera del corso Karl
Johann, Il grido, Pubertà;
O. Kokoschka: Ritratto di Carl Moll, La sposa nel vento, veduta della torre dei
Mannelli;
E. Schiele: Donna Dai Capelli Neri, Torso nudo inginocchiato, Autoritratto,
Abbraccio;
O. Dix, G. Grozs: la critica alla società tra le due guerre
L’inizio dell’arte contemporanea.
Il Cubismo: caratteri generali
P. Picasso: Testa di donna, I Poveri in Riva Al Mare, Pasto Frugale, Famiglia di
Acrobati con scimmia, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard,
natura morta con sedia impagliata, i tre musici, Guernica, Nobiluomo con Pipa.
La stagione italiana del Futurismo: caratteri generali
F.T. Marinetti e l’estetica futurista;
U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo I-II; Forme uniche della continuità
dello spazio;
Antonio Sant’Elia: La centrale elettrica, La città nuova, Stazione d’aeroplani e
treni ferroviari con funicolari ed ascensori
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, velocità d’automobile;
Le copertine di E. Prampolini: La rivista illustrata del popolo
Gerardo Dottori: Trittico della velocità, Il via.
Giornata dell’arte: Laboratorio Futurista: letture e immagini in occasione
del centenario (Prof.sse V.Casarotto/ A. Lovisetto)
Il Dada: caratteri generali
Dicembre-Gennaio
Febbraio
Marzo – Aprile
52
M. Duchamp: LHOOQ, Fontana,
Man Ray e la fotografia astratta: Le violon d’Ingres, Le caveau
La fotografia americana: Alfred Stiegliz
Il Surrealismo: caratteri generali
M. Ernst: La vestizione della sposa, La puberté proche…
J. Mirò: Montroig. La chiesa e il paese; Il carnevale di Arlecchino, Blu III,
R. Magritte: L’uso della parola, La bella prigioniera, Le passeggiate di Euclide,
La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali.
S. Dalì: Stipo antropomorfo, Giraffa infuocata, Venere di Milo a cassetti,
Costruzione molle con fave bollite: paesaggio di guerra civile; Apparizione di un
volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape, Mae
West.
L’astrattismo: Der Blauer Reiter: caratteri generali
V. Kandinsky: Il cavaliere azzurro, La varietà della vita, Mornau paesaggio
estivo, Senza titolo 1910, Composizione VI, Alcuni cerchi;
P. Klee: Adamo e la piccola Eva, Il fohn nel giardino di Marc, I burattini, Fuoco
nella sera, Ragazzo in costume, Monumenti.
De Stijl e P. Mondrian: Il crisantemo, Mulino di sera, Mulino di sole, L’albero
Rosso, L’albero Blu, L’albero Orizzontale, L’albero Grigio, Melo In Fiore;
Composizione n. 10 molo e oceano; composizione in rosso blu e giallo;
Il razionalismo architettonico
W. Gropius: Nuova sede del Bauhaus,
Le Corbousier: Villa Savoye, Notre-Dame-du-Haut;
F. L. Wright: Robie House, Casa sulla Cascata, Solomon Guggenheim Museum
La Metafisica: caratteri generali
G. De Chirico: i disegni, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, villa romana, il
Trovatore, Piazza d’Italia con statua e roulotte
G. Morandi: i disegni e le acqueforti, Natura morta metafisica, Natura morta di
oggetti in viola, nature morte
La “Scuola di Parigi”:
M. Chagall: Parigi dalla Finestra, L’anniversario, Re David in blu
A. Modigliani: Nudo disteso con capelli sciolti, i ritratti dell’alta società, Jeanne
Hebuterne,
Due esperienze artistiche del Dopoguerra:
l’arte informale in America: Jackson Pollok e l’Action Painting: Foresta
incantata, Pali Blu,
La Pop-Art e Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottle, Marilyn Monroe,
Campbell’s Soup I;
La fotografia della frontiera amercana: E. Curtis
Cittadella, ……………
Maggio
Giugno
Firma del Docente
Valentina Casarotto
Firma dei rappresentanti __________________________________
___________________________________
53
Materia: Diritto-Economia
Docente: Mastromarino Antonio
classe: 5^ Aso
Libro di testo adottato:
E. Malinverni – B. Tornari “Diritto economia e società.” Ed. Scuola e Azienda
Monte ore di lezione curricolare per l’intero anno scolastico: 66
1. Presentazione della classe
All’inizio dell’anno scolastico molti allievi dimostravano lacune importanti nella conoscenza di nozioni di base. Questo
era conseguenza del fatto che in questa materia la classe ha avuto 5 insegnanti diversi durante i 5 anni di studi. Stante
tale situazione, il raggiungimento degli obiettivi elencati di seguito (irrinunciabili) richiedeva agli allievi un particolare
impegno.
Durante il primo quadrimestre l’impegno nello studio è stato discontinuo e mediamente non adeguato. Questo ha reso
faticosa la didattica e lento l’apprendimento. Nel secondo quadrimestre gli allievi hanno mostrato maggiore impegno
nello studio a casa e maggiore concentrazione durante la lezione.
Il rendimento della classe è abbastanza modesto e alquanto omogeneo; riguardo al raggiungimento degli obiettivi
indicati la maggior parte degli allievi è pervenuta ad un livello sufficiente per le conoscenze, appena sufficiente per le
competenze. Resta problematica la situazione di un piccolo numero di allievi.
Per i contenuti ed i relativi tempi di realizzazione preventivati, si è resa necessaria una revisione; le variazioni sono
consistite in una riduzione degli argomenti ed in un mutamento della successione nella loro trattazione. Ad esempio
l’analisi macroeconomica keynesiana è stata anticipata, per sottolinearne le affinità con la grave crisi finanziaria
mondiale che andava verificandosi nelle stesse settimane. La variazione aveva l’intento di sollecitare la curiosità degli
allievi ed il loro impegno, cosa che parzialmente è avvenuta. Analogamente, si sono abbassati gli obiettivi di
conoscenze e competenze inizialmente fissate.
L’ora in compresenza con l’insegnante di storia ha ovviamente supportato le due materie, in quanto ha trattato
argomenti quali: la crisi di Wall Street, l’ONU la Dichiarazione dei diritti universali, i principi della Costituzione
Repubblicana, che si integrano bene nel programma disciplinare delle due materie. Poi data la difficoltà propria della
materia, la quale dispone di una sola ora alla settimana per lo svolgimento del programma specifico di diritto ed
economia, d’accordo con l’insegnate di storia e filosofia, si è scelto di impegnare alcune ore di compresenza per
l’attività di recupero.
Pochissime sono state le ore sportello didattico richieste. Agli allievi che hanno chiesto lo sportello si è fatto per lo più
ripasso, con qualche approfondimento.
2. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in
termini di:
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
o
la nozione di stato e i suoi elementi costitutivi;
o
la funzione legislativa;
o
la funzione esecutiva;
o
la funzione giurisdizionale;
o
il Presidente della Repubblica;
o
la Corte Costituzionale;
54
o
la contabilizzazione della ricchezza nazionale: il PNL, il RNL, il PIL e i loro caratteri distintivi;
o
l’equazione del reddito globale nell’ipotesi di una economia chiusa agli scambi internazionali;
o
la funzione del consumo, dell’investimento e del tasso di interesse nell’equilibrio macroeconomico;
o
i caratteri e i contenuti essenziali dell’attività finanziaria pubblica;
o
i tratti essenziali dello stato sociale;
o
le cause e conseguenze economiche e sociali del crollo della borsa di New York del 1929;
o
l’organizzazione e le principali funzioni dell’ONU;
o
la Dichiarazione universale dei diritti umani.
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno spiegare:
la centralità del Parlamento nell’Ordinamento Costituzionale;
la funzione propulsiva del Governo nell’Ordinamento dello Stato;
l’esigenza di indipendenza della Magistratura ai fini dell’imparzialità della sua azione;
la funzione di garanzia e di equilibrio costituzionale svolta dal Presidente della Repubblica;
le funzioni di salvaguardia della Costituzione e di equilibrio tra i Poteri dello Stato svolta dalla Corte
Costituzionale;
la funzione programmatica della Costituzione italiana;
i punti essenziali della teoria Keynesiana;
gli effetti sul reddito globale di una variazione nelle singole componenti della domanda;
la connessione tra teoria economica keynesiana e stato sociale.
CAPACITA’:
Svolgere semplici processi di analisi e sintesi dei contenuti studiati utilizzando il lessico specifico;
collocare gli istituti giuridici e i modelli economici studiati nel contesto storico in cui sono si sono affermati;
applicare le conoscenze acquisite per interpretare aspetti di politica economica reale;
applicare le conoscenze acquisite in un contesto pluridisciplinare.
PROGRAMMAZIONE SVOLTA
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomento sintetico
Stato e forme di governo
Sviluppo analitico
Tempi
o
o
o
o
o
o
o
la nozione di Stato;
gli elementi costitutivi dello Stato;
la Costituzione italiana;
le forme di governo repubblicane
la composizione del Parlamento;
l’iter legislativo;
i sistemi elettorali proporzionale e maggioritario.
4 ore
La funzione esecutiva
o
o
la composizione del Governo;
le funzioni del Governo.
2 ore
La funzione
giurisdizionale
o
o
o
la giurisdizione e i suoi principi;
l’organizzazione della Magistratura;
la sentenza.
1 ore
La funzione legislativa
2 ore
55
Il Presidente della
Repubblica nel nostro
ordinamento
o
o
o
La Corte Costituzionale
o
o
o
modalità di elezione;
funzioni;
responsabilità del Presidente della Repubblica.
1 ore
composizione e garanzie dei suoi membri;
competenze;
i procedimenti di sindacato di costituzionalità in via principale ed in
via incidentale.
Il valore della produzione
o La contabilità nazionale;
nazionale
o il PNL, il RNL, il PIL;
o l’equazione del reddito globale;
o l’analisi del reddito globale.
Richiamo alle leggi di domanda e di offerta e all’equilibrio di mercato
1 ore
L’equilibrio
macroeconomico
6 ore
L’interventismo dello
Stato e le politiche
economiche
o la funzione di consumo;
o la domanda aggregata;
o il moltiplicatore keynesiano;
o investimenti e tasso di interesse;
o mercato monetario e tasso di interesse.
Aspetti generali. L’attività finanziaria pubblica; le risorse finanziarie dello
stato; bilancio pubblico e legge finanziaria; finanza interventista e “deficit
spending”.
5 ore
1 ora
1 ore
Moduli interdisciplinari con storia (compresenza).
Argomento sintetico
Sviluppo analitico
Tempi
La formazione del
mercato mondiale come
condizione di
possibilità della crisi
del 1929; il crollo della
Borsa di Wall Street e
le sue conseguenze*
Sviluppo della popolazione europea tra il XIX ed il XX secolo: cause
ed effetti. Posizione di Malthus sullo sviluppo della popolazione e
sulla maniera di frenarlo; 1870-1914 formazione di un mercato
mondiale; 2^ rivoluzione industriale: innovazione tecnica e sviluppo
economico; 2^ rivoluzione industriale e rapporti tra mercato, industria
e finanza; introduzione alla crisi del 1929: legge degli sbocchi di Say e
posizione R. Malthus; critica di J. M. Keynes alla legge degli sbocchi
di Say; crollo della borsa di New York del 1929: “Genesi e
conseguenze di una crisi annunciata” di M. Flamant e J. Singer-Kerel,
ed D’Anna (4 h).
L’Organizzazione delle Nazioni Unite: dalla società delle nazione
all’ONU (2 h); gli organi, le finalità e gli interventi dell’ ONU (2 h); l’
ONU e la tutela dei diritti umani: la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo (2 h)
M. Weber “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”.
12 ore
“La carta del lavoro” dello Stato Fascista;
P. Calamandrei: “Discorso agli studenti milanesi del 1955 sui principi
della Costituzione italiana e della Libertà”;
Italia 1946, la costituzione repubblicana e la nascita del nuovo stato
sociale.
2 ore
L’ONU*
La natura del
capitalismo*
La Costituzione
repubblicana *
6 ore
2 ore
Ore effettivamente svolte fino al 13 maggio: 51
Le ore ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla somma di quelle indicate nel prospetto sono state dedicate allo
svolgimento di prove di verifica, a esercizi di miglioramento del metodo di studio o di rafforzamento delle conoscenze,
competenze e capacità previste come obiettivi; alla partecipazione ad attività culturali interdisciplinari di istituto. Le ore
di lezioni rimanenti fino alla fine dell’anno scolastico saranno dedicate a precisare alcuni argomenti già spiegati e,
soprattutto, al ripasso.
3. Metodi:
La trattazione degli argomenti è stata svolta mediante lezioni frontali, uso di presentazioni in power point, discussioni in
classe e schematizzazioni alla lavagna.
I moduli interdisciplinari con storia sono stati sviluppati mediante analisi di documenti inerenti gli argomenti elencati.
56
Si è cercato costantemente di evidenziare il legame tra quegli eventi storici e la realtà odierna, e si sono sollecitati gli
allievi ad elaborare ed esporre in classe valutazioni personali.
4. Mezzi:
Considerata la situazione di partenza ho ritenuto non opportuno seguire in tutto il libro di testo. Per le parti “Presidente
della Repubblica” e “Corte Costituzionale” è stato necessario fare uso di fotocopie, perche non sono trattate nel testo in
adozione. Per tutta la parte economica del programma, allo scopo di accorpare, dare unitarietà, sintetizzare e
semplificare il materiale, è stato necessario ricorrere a fotocopie di altri testi o di mie slide elaborate in power point. Il
materiale usato è allegato in fotocopia.
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Data la esiguità del tempo attribuito alla mia materia, la valutazione è consistita principalmente in interrogazioni scritte,
ma si è valutato anche impegno, partecipazione, attenzione, progressi, disposizione al dialogo educativo. Nel
predisporre i test scritti si è cercato di graduarne la difficoltà di esecuzione, inizialmente agli allievi sono state
somministrate prove strutturate, successivamente verifiche scritte impostate sul modello della tipologia B prevista dalla
normativa riguardante la 3^ prova dell’esame di stato. Nel secondo quadrimestre, oltre alle prove scritte, ogni allievo ha
avuto un voto orale.
GRIGLIA di VALUTAZIONE TERZA PROVA: DIRITTO –
ECONOMIA, TIPOLOGIA B (risposta breve; singolo quesito)
INDICATORI
DESCRITTORI
Pertinenza,
completezza e
correttezza delle
conoscenze:
1
Conoscenze non
pertinenti o
scorrette.
2
Conoscenze
lacunose o
frammentarie e
imprecise.
3
Conoscenze
essenziali e
sostanzialmente
corrette.
4
Conoscenze
esaurienti
e corrette.
5
Conoscenze
approfondite e
corrette.
Capacità di
elaborazione e di
sintesi:
0,5
Non individua
alcun concetto
chiave.
1
Disorganica o
coglie solo alcuni
concetti chiave.
1,5
Individua i
concetti chiave,
dandone una
esposizione molto
schematica.
2
Articolata e
coerente.
2,5
Completa,
organica e
puntuale.
Competenze
espositive e
padronanza del
lessico specifico.
2,5
1
2
1,5
Esposizione
Linguaggio
Esposizione
Linguaggio
fluida e precisa,
impreciso e lessico
chiara e corretta,
con padronanza
corretto con lessico
carente.
svolta con lessico
del lessico
essenziale.
specifico.
specifico.
0,5
Linguaggio
scorretto.
IL VOTO COMPLESSIVO E’ ESPRESSO IN DECIMI.
Se la trattazione non è svolta il voto è l.
Tabella di corrispondenza decimi - quindicesimi:
DECIMI
1
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
QUINDICESIMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cittadella, 13/05/2009
6,4-7,2 7,3-7,9 8,0-8,8 8,9-9,6
11
12
13
14
10
15
prof. Antonio Mastromarino
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
___________________________________________________________
57
Programmazione Annuale
ANNO SCOLASTICO
2008/2009
DOcente: Steccanella Assunta
Materia: Insegnamento Religione Cattolica
Classe: V Aso
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe
33
Ore effettivamente svolte al 13/05/09
23
Modulo / U.D.
Modulo 1: il mio diritto – i diritti degli altri
1. A partire dai dati sociologici forniti dal testo “Uno sguardo sul mondo –
il mondo visto da sud” approccio alle profonde differenze
socioeconomiche riscontrabili nell’attuale panorama mondiale.
2. I paesi del primo mondo e le loro responsabilità: confronto con le
politiche economiche di sostegno ai paesi poveri in particolare rispetto
al debito pubblico e alla violazione dei diritti umani connessa con
l’imposizione della restituzione.
3. Il lavoro minorile e i diritti dell’infanzia.
4. Il diritti umani: lettura e confronto con alcuni articoli della dichiarazione
ONU del 10/12/1948.
5. La struttura della dichiarazione e le quattro libertà fondamentali che ne
costituiscono l’ossatura.
Unità svolta con il supporto delle seguenti fonti: A.A. V.V., Uno sguardo sul
mondo – il mondo visto da sud. 2007-2008, EMI, Roma 2008; E. TOFFANO
Ore
Nove ore
MARTINI, …e noi guardiamo il cielo. 2, ed. Cleup, Padova 2001;
MARINONI G. – CASSINOTTI C. – AIROLDI G., La domanda dell’uomo.
Corso di religione cattolica per il triennio, Marietti, Genova 1997;
visione del film “Iqbal”; dispense del docente.
Modulo 2: Chiesa e società
1. La dottrina sociale della Chiesa: Solidarietà e sussidiarietà.
Fonti della dottrina sociale della chiesa (Rivelazione e diritto naturale)
2.
Fonti: MARINONI G. – CASSINOTTI C. – AIROLDI G., La domanda
Tre ore
dell’uomo. Corso di religione cattolica per il triennio, Marietti, Genova
1997.
Modulo 3: Le divisioni delle Chiese cristiane
In parallelo con il programma di sociologia sulle teorie di Max Weber,
ripasso sulle divisioni nelle chiese cristiane. I principi della Riforma:
sola gratia, sola fides, sola scriptura. La teologia della giustificazione.
1.
Un’ora
Fonti: MARINONI G. – CASSINOTTI C. – AIROLDI G., La domanda
dell’uomo. Corso di religione cattolica per il triennio, Marietti, Genova
1997.
1.
4.
Modulo 3: Le sfide del nostro tempo
Valori religiosi e valori laici: pluralismo etico o una base comune?
Confronto con le due diverse prospettive.
2. Matrimonio religioso e matrimonio civile.
3. Unioni di fatto.
Il controllo delle nascite e la proposta morale della Chiesa: I metodi
contraccettivi artificiali e naturali.
5. Il corpo secondo l’antropologia cristiana.
Sei ore
58
Fonti: MARINONI G. – CASSINOTTI C. – AIROLDI G., La domanda
dell’uomo. Corso di religione cattolica per il triennio, Marietti, Genova
1997; dispense del docente.
2.
Modulo 4: “Venga il Tuo regno”
1. L’idea evangelica di Regno come pienezza di relazioni.
Il sogno della pace nel mondo: la responsabilità individuale per la sua
costruzione.
Unità svolta con il supporto di: visione del cortometraggio di D. Zanon “La
partita”; visione del film di F. Capra “La vita è meravigliosa”; confronto con la
classe.
Quattro ore
Griglia di valutazione e descrittori:
Non sufficiente: Conoscenze frammentarie, assenza e disturbo nella partecipazione al dialogo educativo, interesse
assente rispetto alla globalità dei contenuti proposti, non ha conseguito le abilità richieste.
Sufficiente: Conoscenze essenziali, interesse selettivo, alterna partecipazione al dialogo educativo, impegno
discontinuo, insicurezza nell’utilizzo delle abilità richieste.
Discreto: Conoscenze globalmente acquisite, interesse costante, partecipazione al dialogo educativo nella dimensione
dell’ascolto, impegno continuo, possiede le abilità richieste in modo soddisfacente.
Buono: Conoscenze complete, interesse e impegno costanti, partecipazione costruttiva al
dialogo educativo, utilizzo appropriato del linguaggio specifico.
Ottimo: Conoscenze ampie e complete con approfondimenti personali, interesse e impegno costanti, capacità di
effettuare collegamenti interdisciplinari, partecipazione creativa e propositiva al dialogo educativo, ottima padronanza
del linguaggio specifico.
Cittadella, 7 maggio 2009
Il docente
Assunta Steccanella
Studenti
_____________________________________________
59
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof. Roberto Taffara
Materia Educazione Fisica Classe 5a ASO a.s. 2008/09
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
•
•
•
•
CONOSCENZA:
Il concetto di capacità condizionali e coordinative
La funzione dei fondamentali individuali degli sport di squadra trattati
La funzione dei fondamentali di squadra delle discipline sportive trattate
I regolamenti delle discipline sportive trattate
•
•
•
•
COMPETENZE:
Con quali mezzi potenziare le capacità condizionali e coordinative
Come eseguire i gesti tecnici dei fondamentali individuali degli sport di squadra trattati
Come eseguire i gesti tecnici delle discipline individuali trattate
Come eseguire i principali movimenti sul campo degli sport di squadra trattati
•
•
•
•
CAPACITA’:
Potenziare le capacità condizionali e coordinative
Eseguire i gesti tecnici dei fondamentali individuali degli sport di squadra trattati
Eseguire i gesti tecnici delle discipline individuali trattate
Eseguire i principali movimenti sul campo degli sport di squadra trattat
• CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi ed
Eventuali approfondimenti
Moduli e Percorsi formativi
Periodo / ore
SCHEMI MOTORI DI BASE
Rielaborazione degli schemi motori di base in relazione alle nuove esigenze funzionali
degli allievi.
Sviluppo di schemi motori complessi, di coordinazioni particolari e di gesti motori
propedeutici e collegati all’apprendimento degli elementi fondamentali individuali
delle varie discipline sportive.
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati utilizzati sia esercizi a corpo libero che
con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi; andature di coordinazione generale
Questi argomenti sono stati
trattati durante tutto l’anno
scolastico, inseriti in parti di
lezione: nel riscaldamento,
nella prima parte della
lezione o nella parte ludica.
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO
CIVICO
Attraverso l’uso di esercizi di preacrobatica e ai grandi attrezzi, si è cercato di far
conseguire all'adolescente la consapevolezza dei propri mezzi.
Altri sistemi adottati sono stati: l’organizzazione di giochi di squadra che implichino il
rispetto di regole e l'assunzione di ruoli; l'affidamento, a rotazione, di compiti di giuria
e arbitraggio; l'organizzazione di giochi tradizionali o popolari e di gruppo;
60
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Sono stati trattati i seguenti Giochi Sportivi:
Pallavolo, Pallacanestro, Calcio, Rugby e Softball
e i seguenti Sport Individuali:
Atletica Leggera
L’insegnamento dei giochi sportivi di squadra è avvenuto attraverso il consolidamento degli elementi tecnici
individuali fondamentali e via, via con il perfezionamento delle tattiche di gioco di base
Pallavolo: perfezionamento dei fondamentali appresi nei primi quattro anni del corso
di studi: il palleggio, il bagher, il servizio, la posizione in campo, i ruoli, i movimenti
di prima e seconda linea, la ricezione, l’attacco e la difesa. Sono stati dati cenni sullo
spostamento del palleggiatore a destra e i cambi d’ala in prima linea;
dal 26/09/08
al 17/10/08
Pallacanestro: perfezionamento dei fondamentali appresi nei primi quattro anni del
corso di studi: il palleggio, il passaggio, il tiro, gli arresti, i movimenti principali in
fase di gioco, il rimbalzo e il tagliafuori.
dal 24/10/08
al 19/12/08
Rugby: la filosofia del gioco, il passaggio, la ricezione, il placcaggio, la posizione in
campo, i ruoli, l’attacco e la difesa.
dal 09/01/09
al 23/01/09
Calcio: perfezionamento dei fondamentali appresi nei primi quattro anni del corso di
studi: il passaggio, il tiro, lo stop, il controllo della palla.
dal 30/01/09
al 06/02/09
Atletica Leggera: programma gare e regolamento di: corse e concorsi, corse piane e a
ostacoli, salti e lanci;
perfezionamento delle tecniche di esecuzione delle varie discipline apprese nei primi
quattro anni del corso di studi, con particolare attenzione a quelle inserite nel
programma dei Giochi Sportivi Studenteschi.
Il salto in alto: la caduta, il valicamento, lo stacco, i passi speciali, la rincorsa con
cinque passi e il cambio di ritmo, la rincorsa con sette passi.
Il getto del peso: la posizione finale, il lancio, la traslocazione
al 13/02/09
al 05/06/09
Il salto in lungo: la caduta, la chiusura, la tecnica dei passi in volo, lo stacco, la
rincorsa.
Le staffette: la 4 x 400 e la 4 x 100: il cambio nella 4 x 100
Le corse a ostacoli: il passaggio dell’ostacolo; la tecnica della prima gamba e della
gamba di stacco; il ritmo della corsa a ostacoli
Softball: il passaggio dal gioco propedeutico della “palla base” al softball; il
regolamento semplificato
al 13/02/09
al 05/06/09
Attività di condizionamento: per tutto l’anno scolastico, a cadenza mensile sono state svolte lezioni di
condizionamento muscolare (arti inferiori, arti superiori, muscolatura posturale); le indicazioni che sono state date agli
allievi sono state di ripetere periodicamente le esercitazioni autonomamente.
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico
Totale ore: 56
61
2. METODOLOGIE (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc….):
Le proposte didattiche sono state individuali, a coppie, a terziglie, a piccoli gruppi o a squadre.
Il metodo di correzione è stato sia individuale che analitico. In alcuni casi gli studenti sono stati invitati a individuare gli
errori tecnici commessi dai loro compagni.
Per la didattica si è utilizzato sia il metodo globale che quello analitico. Non sono state necessarie attività di recupero o
di sostegno né attività integrative
3. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio,
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc….):
attrezzature, spazi,
Le lezioni si sono svolte in palestra o nell’adiacente pista di atletica. Le attrezzature utilizzate sono state quelle
specifiche delle singole discipline con, talvolta, degli utilizzi di recupero. In alcuni casi sono stati usati sussidi
audiovisivi.
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (specificare prove scritte, verifiche orali, test
oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di laboratorio ecc...):
Tutte le prove di verifica sono state pratiche. In alcuni casi le prove sono state individuali, in altre di gruppo. Spesso si è
usato il metodo dell’osservazione diretta per valutare l’operato dei singoli studenti. Tutte le valutazioni saranno
effettuate tenendo conto della situazione di partenza.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche
effettuate:
Non vi sono esempi di prove né verifiche scritte depositati in segreteria.
Data, 15 maggio 2009
Firma del Docente
__________________________
I rappresentanti di classe
________________________________________________
62
IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 63 E' STATO
PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 5^
NELLA SEDUTA DEL 13 maggio
COORDINATORE DI CLASSE PROF. TOMBOLATO GRAZIELLA
CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA
ITALIANO
STORIA – FILOSOFIA
SCIENZE SOCIALI
MATEMATICA – FISICA
LINGUA LETTERATURA FRANCESE
LINGUA LETTERATURA INGLESE
SCIENZE opzione
STORIA DELL’ARTE
DIRITTO-ECONOMIA
RELIGIONE
EDUCAZIONE FISICA
DOCENTE
FIOR FIORELLA
BOTTECCHIA CATERINA
TOMBOLATO GRAZIELLA
BOLZONELLA PAOLO
VALENTIN MANUELA
VITTURELLI DANIELA
MENDO DANIELA
CASAROTTO VALENTINA
MASTROMARINO
ANTONIO
STECCANELLA ASSUNTA
TAFFARA ROBERTO
FIRME
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALBERTO BORTOLASO
______________________________________
63