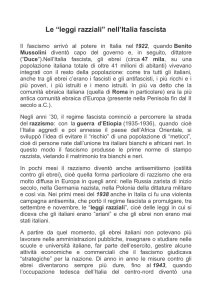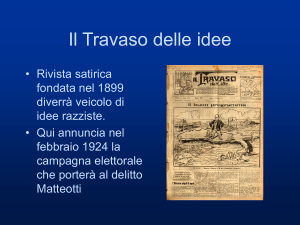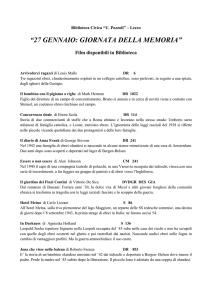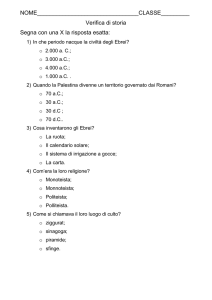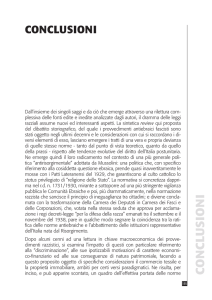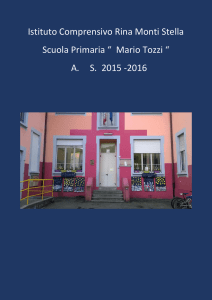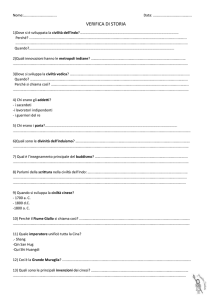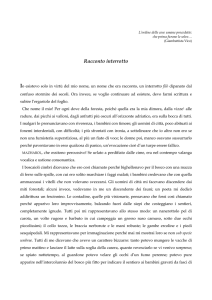Gioele Dix
QUANDO TUTTO QUESTO
SARÀ FINITO
Storia della mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali
1
La radio accesa a tutto volume
All’inizio di settembre del 1938 io ero un bambino di dieci
anni che si preparava a entrare in prima media. Ero elettrizzato, perché mi piaceva la scuola, ma anche preoccupato, perché tutti dicevano che le medie erano difficili. Le medie al Carducci di Milano, poi.
«Non ce la farai mai, Vittorio, vedrai che ti cacceranno
via.»
Questo me lo diceva il mio amico Lele Pardo del terzo
piano. Parlava così soltanto per invidia, perché l’avevano
mandato a scuola un anno dopo di me e quindi gli toccava
andare ancora alle elementari in piazzale Bacone.
Ma una sera mio padre tornò a casa scuro in volto, scagliò sul tavolo il “Corriere della Sera” che aveva in mano
e si rifugiò in camera da letto a parlare fitto fitto con mia
madre. Malgrado le voci fossero attutite dalla porta chiusa,
capii che stavano litigando, i loro toni erano concitati e le
urla appena compresse per cercare di non allarmarmi. Una
discussione accesa fra la tiepida simpatizzante socialista e
il fin troppo caldo simpatizzante della destra estrema. Sì,
perché questa è la verità: mio padre era fascista, e non certo per convenienza o per conformismo. Va detto a suo merito, ammesso che fosse un merito, che ci credeva veramente. Era addirittura un fascista della prima ora, un cosiddetto
11
“antemarcia”, ossia faceva parte di quella ristretta cerchia
di fedeli ed entusiasti sostenitori di Mussolini che lo seguivano sin da prima della marcia su Roma. Gli piacevano
le sue idee, il suo linguaggio, e non ne faceva mistero. Forse
avrebbe avuto qualcosa da ridire sui metodi degli squadristi, più che altro perché in fondo era un uomo buono e pacifico, eppure prevaleva in lui l’ammirazione per il duce. Ne
era rimasto affascinato ai tempi in cui era un giovane ufficiale dell’esercito italiano in trasferta a Parigi e non aveva
più cambiato idea. Ne condivideva gli ideali e i valori: la
Patria, l’Onore, l’Ordine.
Chissà come doveva sentirsi quella sera dopo aver avuto
conferma dal giornale che il suo amatissimo Capo del Governo aveva permesso che il Parlamento approvasse una
legge, con tanto di controfirma del Re in persona, che declassava gli italiani di razza ebraica, e dunque anche lui,
uno dei suoi fedelissimi, a cittadini di serie B.
Mio padre non era il solo a sentirsi caduto in trappola ed
è certo che in quella calda serata di inizio settembre in molte case di Milano, Roma, Trieste, Livorno, Napoli si stesse consumando lo stesso nostro dramma: un marito, ebreo
fascista tradito dal suo Capo, che tenta l’ultima disperata
autodifesa, e una moglie che gli inveisce contro e non gli
perdona la complicità con l’orrore.
Io facevo la spola fra il corridoio e la culla piazzata in salotto, dove il mio fratellino appena nato dormiva indifferente a tanto trambusto. Finalmente uscirono dalla stanza
e mia madre si mise nervosamente ad apparecchiare la tavola per la cena. Anche mio padre le diede una mano con
posate e bicchieri, fatto assolutamente eccezionale. Forse
cercava di stemperare la tensione, provando a farsi perdonare per quella insana passione politica diventata ormai
irragionevole.
Cenammo in silenzio, poi mio padre mi diede l’annuncio.
«Credo che non ti iscriveremo al Carducci.»
«Perché?»
«Perché non possiamo.»
12
«E perché?»
Non ebbi alcuna risposta, né da lui, né tantomeno da mia
madre. Quell’impotente sordità divenne un’abitudine. Ogni
volta che facevo domande ai miei genitori su ciò che stava
accadendo, loro semplicemente non rispondevano. Oggi li
capisco: non sapevano come spiegare.
E così andò a finire che, dopo parecchi tentativi a vuoto,
io non chiesi più nulla. Fra noi si creò una sorta di patto del
silenzio che – a pensarci bene – è rimasto immutato codice
di famiglia per molti anni, anche dopo la fine della guerra.
Constatazione dei fatti, ma mai una parola sulle ragioni.
Inutile dire che per me, in quel momento, la conseguenza più grave delle leggi razziali fu di dover rinunciare alla
scuola media Carducci, dando una soddisfazione inattesa
al mio amico Lele Pardo del terzo piano.
Ero certo che mi avrebbe irriso, invece il suo comportamento fu particolarmente affettuoso. Forse i suoi genitori gli avevano spiegato qualcosa, beato lui. Sta di fatto che
non fece mai cenno alla mia mancata iscrizione.
Il giorno seguente mio padre decise di restituire la tessera di iscrizione al partito fascista. Il suo rigore e il suo senso del dovere gli imposero di recarsi subito alla sede più
vicina e mostrare con orgoglio quanto gli stesse a cuore il
rispetto delle regole, a maggior ragione in un caso come
quello, in cui gli si ritorcevano contro.
Ma l’atto concreto di restituzione non avvenne, perché
mio padre tornò a casa con la sua tessera ancora in mano.
Evidentemente nessuno al partito aveva accettato le sue
“dimissioni”. Né io, che ero troppo piccolo, né mia madre,
che avversava le sue scelte ideologiche, né mio zio Enrico,
il fratello al quale era pur legatissimo, abbiamo mai saputo che cosa accadde fra lui e i suoi camerati in quell’occasione. Per mio padre fu una ferita troppo lacerante e non
trovò necessario fornirci spiegazioni. Aprì il cassetto della scrivania e cacciò la tessera sul fondo. Lì è rimasta per
quarantacinque anni, fino al giorno della sua morte.
13
L’entrata in vigore delle leggi razziali cambiò radicalmente la vita degli ebrei italiani. Tutti i dipendenti statali, impiegati, dirigenti, docenti, militari furono sollevati dai loro
incarichi e cacciati senza alcuna indennità, e anche l’esercizio di molti altri mestieri e professioni fu ostacolato: permessi revocati, licenze ritirate. Ognuno ebbe i suoi guai, sia
chi gestiva un’attività commerciale, sia chi esercitava la libera professione. Qualcuno fu costretto a lasciarsi declassare o a lavorare clandestinamente. E poi seguirono molti
altri divieti, ingiusti, insensati, ridicoli: divieto di possedere una radio, di assumere domestici ariani, di pilotare
aerei, di iscriversi a club sportivi, di produrre vini e olio
d’oliva, di operare come guide turistiche, di allevare piccioni viaggiatori.
Io allora avevo poco più di dieci anni. La mia autonomia
di giudizio e la mia libertà di azione erano inesistenti. Non
posso dire come mi sarei comportato se fossi stato adulto.
Ho ricordi frammentari, oltre che falsati dai giudizi che vi
ho sovrapposto in seguito. Tuttavia non riesco a spiegarmi perché la maggior parte degli ebrei non si sia resa conto
della gravità di quello che stava succedendo. Forse perché
non è da tutti possedere la lucidità necessaria per leggere
la realtà mentre la si sta vivendo. Da ciò deriva la mia ammirazione per quei pochi che capirono e agirono in tempo. Nella nostra famiglia ci fu uno zio professore universitario che già nel 1935 considerò pessima l’aria che tirava e
decise di andarsene con tutta la famiglia in America. Così,
non solo si salvò dalle tragiche conseguenze finali, ma evitò anche un sacco di umiliazioni intermedie, a cominciare
da quella toccata a molti docenti suoi colleghi, ossia farsi
scippare della cattedra, perdere qualsiasi diritto di retribuzione, di anzianità, di pensione ed essere costretti a sopravvivere dando ripetizioni clandestine a qualche studente asino delle medie inferiori. Certo, va detto che lo zio Enzo era
molto facoltoso, mentre la maggior parte di noi, alla faccia
dei luoghi comuni sugli ebrei pieni di soldi, non poteva
permettersi di affrontare cambiamenti tanto costosi. E poi
14
trasferirsi era troppo complicato anche sul piano affettivo,
si sarebbero dovuti abbandonare i genitori anziani, le persone care, gli amici di una vita, il nostro amato paese. Per
emigrare, o sei molto ricco o sei molto povero, perché non
devi avere nulla da perdere.
Un’altra per così dire fregatura fu per tanti quella di essere italiani prima ancora che ebrei, e dunque convinti che
nulla sarebbe stato preso veramente sul serio. Perché si sa
come siamo fatti in Italia, le leggi le rispettiamo sì e no, un
modo di accomodare e accomodarsi lo si trova comunque
e persino una dittatura da noi può essere bonaria, o perlomeno può sembrare che lo sia. Ricordo di aver sentito con
le mie orecchie molti correligionari teorizzare, più o meno
sussurrando: “Tanto poi a Mussolini gli passa”, “È soltanto una bolla di sapone”, “Gli italiani non ci staranno perché
non sono razzisti”. Questo corrispondeva effettivamente al
sentimento popolare diffuso, ma nel frattempo l’apparato
burocratico dello Stato si impegnava a produrre norme, regolamenti, adempimenti, certificati, divieti che man mano ci
isolavano. E che quelle leggi fossero pericolosamente razziste lo si capì al momento dell’invasione tedesca. I numerosi censimenti di ebrei, con relativa compilazione di elenchi
dettagliati contenenti nomi cognomi e indirizzi, divennero
strumenti preziosi al servizio della feroce determinazione
dei nazisti quando decisero di venire a prelevarci casa per
casa e accompagnarci in treno verso i loro forni crematori.
Cominciai a prendere confidenza con parole inusuali. Ebreo,
ebraico, ebraismo, israelita, israelitico, rabbino, sinagoga,
comunità. Le sentivo pronunciare in casa con insolita frequenza e ben presto divennero familiari. Capii che mi riguardavano, che erano parte sempre più preponderante di
me, di noi, e che tutti avremmo dovuto farci i conti. Quasi
contemporaneamente cominciai a fare caso anche all’uso
che altri, estranei a me e alla mia famiglia, facevano di alcune di quelle stesse parole, ebreo, sinagoga, rabbino, ma
con tono del tutto diverso, una questione di sfumature, un
15
che di maligno nell’intenzione che le trasformava in vocaboli offensivi. Ma la più temibile, quasi tossica, era per me
una parola del tutto nuova: giudeo. Mi faceva trasalire e mi
procurava improvvise palpitazioni, oppure misteriosi vuoti
allo stomaco. Quei sintomi di ipersensibilità lessicale, così
lontani nel tempo, possono sembrare di poca importanza,
perché si dice che nella vita contano solo i fatti. E invece anche le parole contano, contano eccome, e nessuno può capirlo meglio di un bambino che sta imparando a esprimersi, quale io ero allora. Fu proprio l’assunzione di un nuovo
vocabolario, sia da parte nostra che del mondo circostante, a ridefinire la nostra identità, a costringerci a fare i conti con quello che eravamo. Qualche anno dopo, durante il
mio esilio in Svizzera, un anziano signore ebreo di Basilea,
che proveniva dalla Polonia e ne aveva viste di tutti i colori, mi disse una frase che mi è rimasta impressa: “Anche
se ti dimenticassi di essere ebreo, ci sarà sempre qualcuno
pronto a ricordartelo”.
Nel giro di poche settimane la comunità ebraica di Milano riuscì a mettere in piedi una scuola in grado di accogliere tutti gli alunni cacciati da elementari, medie, ginnasi
e licei pubblici. Fu un miracolo di generosità e di efficienza, quasi tutte le classi furono coperte, con qualche necessario adattamento. Anche gli insegnanti erano tutti ebrei, a
loro volta espulsi, prevalentemente dalle università. Io mi
ritrovai in una strana prima media in cui le espressioni le
imparavi da un docente che insegnava algebra alla facoltà di matematica pura e scienze le studiavi con un professore di astrofisica. Un lusso. O uno spreco, a seconda dei
punti di vista.
Dato che la scuola era dall’altra parte della città rispetto
alla zona di piazzale Loreto in cui abitavamo, presi confidenza con il tram. Ci passavo sopra più di un’ora e mezza
al giorno fra andata e ritorno. Finii per apprezzare i vantaggi di quel tempo apparentemente sprecato, in cui invece potevo finire i compiti e ripassare prima delle interrogazioni. Anche se il vero spasso era osservare le persone:
16
come si vestivano, come si comportavano, di che cosa parlavano. Seduto su quelle panche cominciai a coltivare la mia
già fertile immaginazione, attribuendo a parecchi dei personaggi abituali che vedevo salire e scendere tutte le mattine
complicate vicissitudini, amori non corrisposti, fallimenti
finanziari. E intanto, dietro ai vetri, guardavo scorrere Milano, la grande città che ancora non conoscevo. Forse non
l’avrei mai sentita così mia se non fossi stato costretto da
ragazzino a quella lunga, quotidiana peregrinazione.
Insomma, a dispetto della grave situazione che stava maturando, io ero sereno, mi piaceva andare tutti i giorni in
quella scuola improvvisata, un po’ fuori dagli schemi, in cui
per fare alcune materie ti mischiavi con altre classi, in cui i
professori parlavano spesso complicato, ma non erano severi. Oggi una scuola così verrebbe considerata d’eccellenza, addirittura esclusiva. Definizione adattissima anche nel
nostro caso, dato che eravamo stati esclusi da tutte le altre.
Ciò che io non potevo capire, essendo un bambino, era
il senso di quell’estromissione, di cui la cacciata dall’istruzione pubblica era soltanto uno degli effetti più eclatanti.
E neppure potevo sapere quanti danni avrebbe provocato,
non tanto nei giovani, rapidi per natura a adattarsi, quanto
negli adulti, per i quali la reclusione in quella sorta di ghetto immateriale provocò progressivamente sconforto, senso di inutilità e depressione, anche grave. Nulla di cui allora potessi rendermi conto. Ma scavando nella memoria
riemerge un frammento inquietante.
Una sera, dopo che per me era già scoccata l’ora della
buonanotte imposta dalle severe regole di mia madre, mentre ancora mi rigiravo nel letto in attesa del sonno, udii i
miei genitori bisbigliare fra loro e commisi l’inconfessabile peccato di alzarmi, percorrere a piedi scalzi il corridoio
e appoggiare l’orecchio alla porta della loro stanza. Rimasi
a origliare trattenendo il respiro, ma al primo scricchiolio
sospetto del pavimento scappai e andai a cacciarmi sotto le
coperte. Non avevo capito bene di che parlassero, ma mi rimase impressa una parola più volte ripetuta, di cui non co17
noscevo il significato: suicidato. Il giorno dopo in casa non
si parlava d’altro che della morte improvvisa di Alfredo, il
cugino prediletto di mia madre. Io non l’avevo mai conosciuto perché viveva a Roma, però sapevo che era violinista di professione e che tutti in famiglia andavano fieri del
suo talento artistico. Arrivarono diverse telefonate e mia
madre pianse ogni volta, ma soltanto dopo aver messo giù
la cornetta, per pudore. Dopo poche settimane la sua foto
incorniciata comparve sul comò in camera da letto e il suo
volto sorridente mi diventò familiare. I miei genitori non
mi avevano dato alcuna spiegazione sulla sua morte, convinti, come al solito, che per proteggermi fosse necessario
nascondermi la verità, e io naturalmente non avevo chiesto
nulla. Ma c’era quella misteriosa parola che mi rigirava in
testa, come la traccia inquietante lasciata dal passaggio di
un lontano temporale. Soltanto alla fine della guerra venni a sapere la verità: Alfredo si era tolto la vita la sera stessa in cui gli era stato comunicato che per motivi razziali era
stato espulso dall’orchestra sinfonica dell’EIAR, della quale
faceva parte, con orgoglio, da più di dieci anni.
Si sa che, di fronte alle avversità, c’è chi è capace di reagire e chi al contrario si avvilisce, chi il dolore sa farselo scivolare addosso e chi purtroppo soccombe, non è un mistero e nemmeno una colpa. Quel giovane musicista non fu
in grado di reggere l’urto, il suo equilibrio si spezzò e decise di farla finita.
Ma per fortuna non tutti gli ebrei persero il lavoro, c’è
chi riuscì a conservarlo, seppur in maniera indiretta. Per
esempio mio padre, che era direttore di un importante setificio della provincia di Como. Era un mago della seta,
appassionato e competente, perché aveva cominciato a lavorare in quel campo dal gradino più basso, come garzone di bottega, all’età di undici anni. Ebbene, il proprietario
dell’azienda non prese nemmeno in considerazione l’ipotesi di privarsi della sua preziosa collaborazione soltanto
perché era considerato indegno di comandare maestranze
ariane. Perciò lo licenziò, finse di assumere un nuovo di18
rettore e continuò a far dirigere lo stabilimento a mio padre, pagandolo fino all’ultima lira. In nero.
Ricordo nitidamente una visita che facemmo alla fabbrica
qualche mese dopo il suo finto licenziamento. Io arrivai con
mia madre che teneva Stefano in braccio, eravamo vestiti di
tutto punto e trovammo il personale schierato ad accoglierci. Già, perché non solo il sciur Maurizio era benvoluto, ma
soprattutto nessuno si era sognato di mettere in dubbio la
legittimità del suo ruolo, né tanto meno di denunciare l’anomalia di un direttore fuorilegge perché giudeo. Mio padre
era raggiante quel giorno e mi condusse per i reparti illustrandomi il funzionamento dei macchinari e spiegandomi le lavorazioni con dovizia di particolari e di dettagli tecnici. Mi parlava con tono serio, trattandomi da adulto, e io
davo continuamente segno di comprendere e apprezzare, assentendo con la testa, nel timore di fargli fare brutta figura.
A quell’età probabilmente sognavo di seguire le sue orme
e forse lo avrei fatto se gli eventi successivi non ci avessero
costretto a cambiare i nostri programmi, sia a breve che a
lungo termine. Alla fine della guerra la condizione professionale di mio padre era radicalmente cambiata e io, anche
per le decisive pressioni di mia madre, scelsi di continuare
a studiare e di iscrivermi all’università. Niente seta, niente
telai, niente mercanti. Ho continuato a osservare quel mondo soltanto attraverso i suoi occhi, ma qualcosa ho ereditato: il culto laico per le cravatte. Ciò che oggi viene indegnamente definito come un accessorio, per lui era l’elemento
essenziale dell’abbigliamento di un uomo.
“Hai visto quello lì? Non portava neanche la cravatta”
era l’immancabile commento quando voleva indicarmi una
persona di poco conto. E sono convinto che non avesse mai
digerito l’idea del suo beneamato duce di imporre la camicia nera come divisa. Passi il colore poco elegante, passi pure il primo bottone chiuso, ma portarla senza cravatta
era un vero insulto al buon gusto. Fascista sì, ma distinto.
In ogni caso, il clima di serenità che si respirava quel
giorno durante la visita in fabbrica non aveva nulla a che
19
fare con le idee di segregazione propagandate dai razzisti
dell’ultima ora. Quelle leggi Mussolini alla fine le aveva fatte sue, tradendo la fiducia anche di molti ebrei che gli erano devoti, come mio padre, ma è difficile che non sapesse
che la gran parte degli italiani non le condivideva. Non soltanto fra la gente comune, ma persino fra coloro che avrebbero dovuto farle applicare.
Mi torna alla mente un altro piccolo, illuminante episodio.
In un tardo pomeriggio di fine aprile – o forse sarà stato maggio, quello di cui sono certo è che era finito il buio
dell’inverno e la mia stanza era inondata di luce – suonò il
campanello di casa.
Io adoravo come tutti i bambini precipitarmi ad aprire la
porta, ma il nostro corridoio era troppo lungo e – maledizione – fui preceduto dalla nostra governante. Mia madre
esigeva che la chiamassi così, anche se per me era Ornella,
una ragazzona alta e gentile che abitava con noi e si occupava di tante cose: fare le pulizie, lavare, stirare, cucinare,
ma soprattutto giocare con me a dama o a rubamazzetto,
anche se sempre più di rado purtroppo, per colpa del gran
daffare che le procurava il mio fratellino nato da poco. Insomma, raggiunsi l’anticamera quando ormai era troppo
tardi: Ornella mi aveva battuto sul tempo e aveva già spalancato la porta d’ingresso.
«Buonasera, chiedo scusa per il disturbo, c’è la signora?»
«Se vuole accomodarsi, gliela chiamo subito.»
Vidi entrare un carabiniere di una certa età, grassottello, occhiali, baffetti neri sottili che sembravano disegnati a china e un grande riporto che notai perché la corrente
creatasi con la finestra spalancata del salotto glielo scompigliò leggermente.
Dalla radio accesa in cucina proveniva una musica di
operetta, che incanalandosi lungo il corridoio giungeva
come riverberata, conferendo alla scena un che di allegramente grottesco.
L’uomo mi guardò con aria benevola. «E tu chi sei, come
ti chiami?»
20
«Mi chiamo Vittorio.» E intanto mi domandavo: che ci
sarà venuto a fare un carabiniere qui da noi?
Non potevo sapere che il suo compito era quello di controllare che il comportamento della famiglia di razza ebraica
abitante nell’appartamento di viale Abruzzi 72, scala A, secondo piano, porta a sinistra dell’ascensore, fosse conforme alla legge.
Vediamo un po’: domestica ariana e possesso di radio.
Alla faccia della conformità. Complimenti a tutta la famiglia, deve aver pensato il militare.
«Buonasera, maresciallo, come sta?»
La voce stentorea di mia madre lo fece sobbalzare. «Molto bene quando la vedo signora!» e le sorrise, tentando di
essere seduttivo.
Lei gli offrì un caffè, lui rifiutò ma lei insistette. Tutta la sua
maestria e la sua teatralità furono messe in campo per stordire di chiacchiere il sottufficiale fino al momento dei saluti.
«Ci venga ancora a trovare, magari al sabato quando c’è
anche mio marito.»
«No, ci mancherebbe, non vi darò altro disturbo.»
Quando era oltre la porta, già sul pianerottolo, il maresciallo si voltò e, rivolto a mia madre, le disse a bassa voce:
«Mi saluti sua... nipote... Perché è sua nipote, vero?... Intendo quella ragazza alta che è venuta ad aprirmi...».
«Sì, certo, gliela saluto senz’altro» rispose mia madre
con prontezza.
Dopo una pausa, il sottufficiale aggiunse: «E io dirò ai
vostri vicini di non tenere la radio accesa a tutto volume,
d’accordo?».
Senza attendere risposta, scese rapidamente le scale e
si dileguò.
L’Italia fascista non era pronta a diventare razzista e
antisemita.
Non ancora.
21