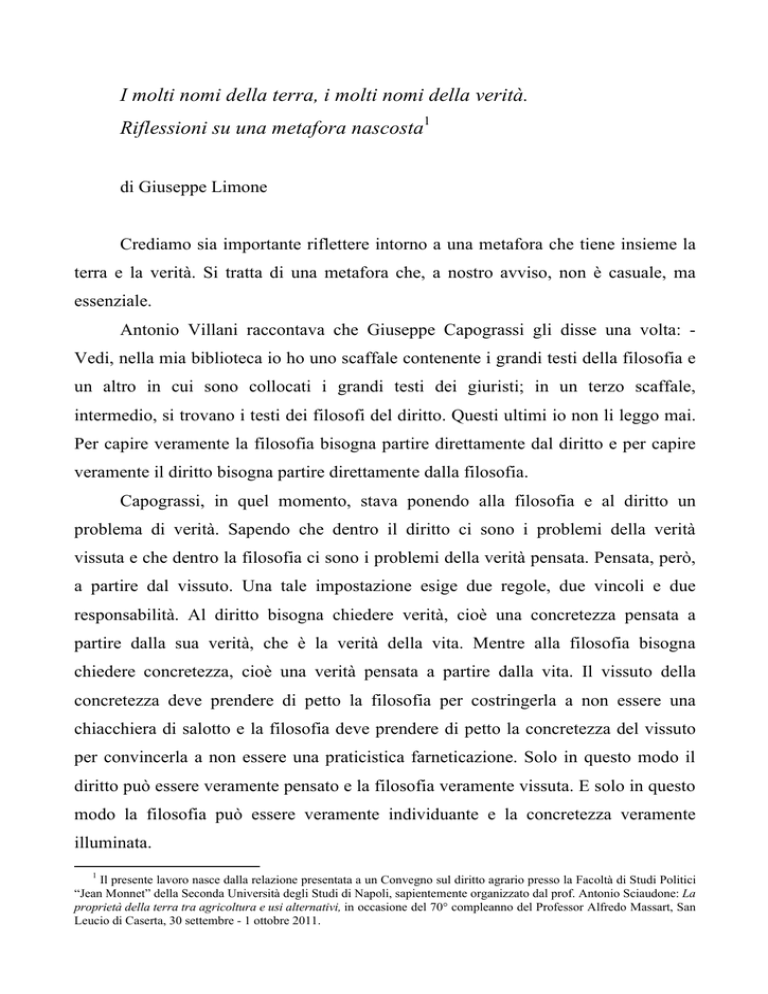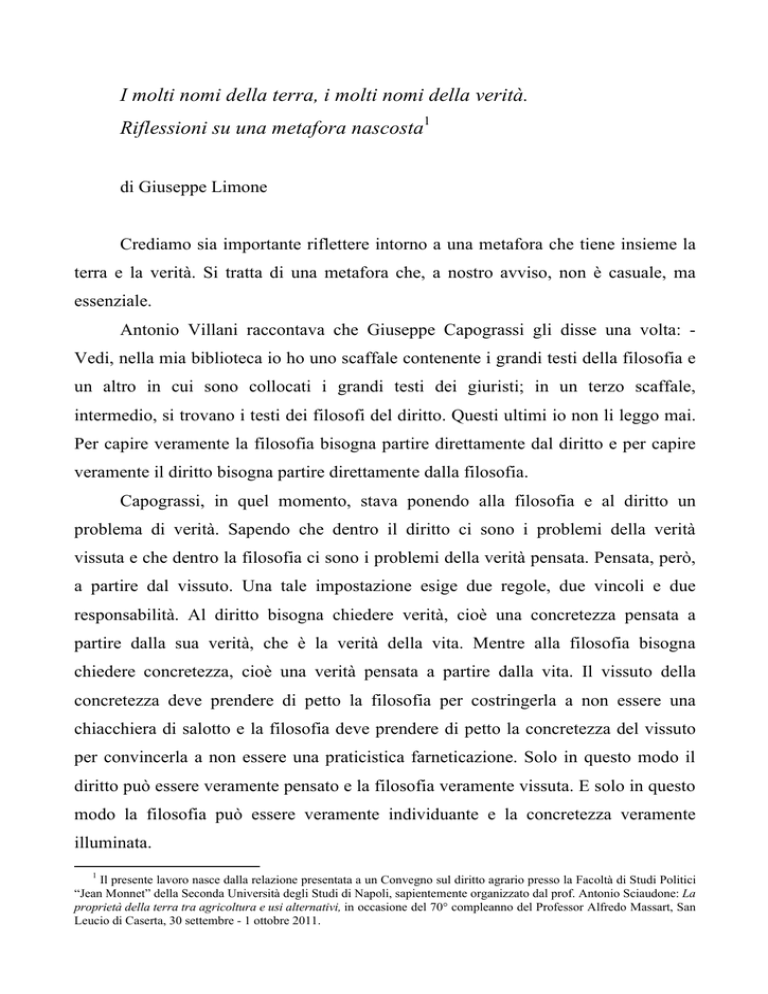
I molti nomi della terra, i molti nomi della verità.
Riflessioni su una metafora nascosta1
di Giuseppe Limone
Crediamo sia importante riflettere intorno a una metafora che tiene insieme la
terra e la verità. Si tratta di una metafora che, a nostro avviso, non è casuale, ma
essenziale.
Antonio Villani raccontava che Giuseppe Capograssi gli disse una volta: Vedi, nella mia biblioteca io ho uno scaffale contenente i grandi testi della filosofia e
un altro in cui sono collocati i grandi testi dei giuristi; in un terzo scaffale,
intermedio, si trovano i testi dei filosofi del diritto. Questi ultimi io non li leggo mai.
Per capire veramente la filosofia bisogna partire direttamente dal diritto e per capire
veramente il diritto bisogna partire direttamente dalla filosofia.
Capograssi, in quel momento, stava ponendo alla filosofia e al diritto un
problema di verità. Sapendo che dentro il diritto ci sono i problemi della verità
vissuta e che dentro la filosofia ci sono i problemi della verità pensata. Pensata, però,
a partire dal vissuto. Una tale impostazione esige due regole, due vincoli e due
responsabilità. Al diritto bisogna chiedere verità, cioè una concretezza pensata a
partire dalla sua verità, che è la verità della vita. Mentre alla filosofia bisogna
chiedere concretezza, cioè una verità pensata a partire dalla vita. Il vissuto della
concretezza deve prendere di petto la filosofia per costringerla a non essere una
chiacchiera di salotto e la filosofia deve prendere di petto la concretezza del vissuto
per convincerla a non essere una praticistica farneticazione. Solo in questo modo il
diritto può essere veramente pensato e la filosofia veramente vissuta. E solo in questo
modo la filosofia può essere veramente individuante e la concretezza veramente
illuminata.
1
Il presente lavoro nasce dalla relazione presentata a un Convegno sul diritto agrario presso la Facoltà di Studi Politici
“Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli, sapientemente organizzato dal prof. Antonio Sciaudone: La
proprietà della terra tra agricoltura e usi alternativi, in occasione del 70° compleanno del Professor Alfredo Massart, San
Leucio di Caserta, 30 settembre - 1 ottobre 2011.
Parlando in questa sede della terra e del diritto agrario noi abbiamo l’occasione
per scoprire quanta verità ci sia nella terra e quanta terra ci sia nella verità. Verità e
terra rivelano, oggi più che mai, uno straordinario fondo comune che si mostra
attraverso le stesse metafore che riguardano, contemporaneamente, l’una e l’altra. Non
a caso, oggi viviamo nello stesso tempo un declino del significato della terra e un
declino del significato della verità. Un declino della terra e un declino della verità.
Il rapporto tra terra e verità è un rapporto essenziale. Esso può essere scoperto
a partire da quelle metafore che Hans Blumenberg ha chiamato metafore radicali,
ossia metafore prime, indeducibili, a partire dalle quali possono comprendersi i
significati profondi della vita. Tali metafore non sono ornamentali, perché
costituiscono i modelli primi a partire da cui si capiscono i significati.
Vorremmo dedicare questo nostro itinerario di riflessione a Pinocchio, perché
fortemente crediamo che nel Pinocchio di Collodi appare qualcosa che ha da fare con
la verità.
Qual è il rapporto intrinseco tra la verità e la terra? E che cosa si sommuove –
nel diritto agrario – che i giuristi possono cogliere nei suoi strati profondi? Sembra,
nei tempi post-moderni che ci tocca di vivere, che parlare della terra sia cosa arcaica,
così come sembra cosa arcaica parlare della verità. Può indovinarsi, invece, in questo
nodo, una parentela antica di destini che ci guarda dal futuro.
Quali sono, infatti, i modi fondamentali con cui si guarda alla verità? Diremmo
che ci sono tre modi di guardarla, così come ci sono tre modi di guardare alla terra. Si
tratta di modi fra loro interconnessi.
Diceva in un celebre apologo Norbert Elias: se immaginiamo di costruire una
casa di cento piani e se immaginiamo di essere arrivati al centesimo piano,
domandiamoci che cosa succederebbe se la scala crollasse e se noi ci abituassimo a
stare a quel centesimo piano come se fossimo lì sempre stati. Chi vivrà a quel
centesimo piano, a questo punto, crederà che quello sia l’unico punto di vista da cui
poter guardare il mondo o che almeno sia il punto di vista più progredito, che
sostituisce quindi i punti di vista precedenti come più arcaici e arretrati. L’errore che
si commette in questo modo di pensare riguarda il fondamento. Il fondamento non è
qualcosa di cui ci si possa dimenticare stando all’ultimo piano. Esso non è una forma
arretrata della costruzione in cui siamo collocati. Dobbiamo saper comprendere che il
fondamento
è
la
struttura
di
base
che
sincronicamente
accompagna –
necessariamente accompagna – tutti i piani della costruzione ed è, perciò, presente in
ogni punto del piano in cui si è collocati. In ogni piano, cioè, anche se ce ne fossimo
dimenticati, noi siamo accompagnati dal fondamento. Ove mai ci dimenticassimo
dell’esistenza del fondamento, ove mai ne trascurassimo l’importanza, il fondamento
si vendicherà.
Guardiamo a questi tempi nostri, che sempre più si presentano come l’epoca dei
derivati finanziari. Potremmo dire, allo stesso modo, che noi viviamo nei tempi dei
derivati “notiziari”. Nel caso dei derivati finanziari siamo davanti al problema del
rapporto con la terra e col lavoro; nel caso dei derivati notiziari, davanti al problema
del rapporto con la verità, ossia con la verità di un fatto di cui si sia data notizia. Sia
nell’uno che nell’altro caso, siamo davanti al problema di un rapporto col fondamento.
Il fenomeno logico da osservare è il medesimo. Si dà prima un derivare, poi un
separarsi, poi un astrarsi e, infine, un ipostatizzarsi da parte di ciò che, all’epilogo del
percorso, intende liberarsi dalla rappresentazione del fondamento, dal quale ritiene di
aver preso definitivo congedo. In un primo passo, nel derivare di una cosa da un’altra
permane la traccia attuale della sua derivazione; in un secondo passo, accade il
separarsi di una cosa dall’altra da cui deriva, là dove incomincia a spuntare il
significato di una certa autonomia, costituente una presunzione relativa di ciò che si
rappresenta; in un terzo passo, accade il fenomeno dell’astrarsi, che intende
prescindere da ciò da cui si è astratto, costituendo una presunzione assoluta di
rappresentazione; in un quarto passo, accade il fenomeno dell’ipostatizzarsi, in cui ciò
che si auto-ipostatizza si auto-concepisce come una realtà che vive di vita propria,
indipendente dalla realtà fondamentale rappresentata; in un quinto passo, accadono
tutti gli infiniti fenomeni di ulteriori rappresentazioni ipostatizzate. Molteplici sono i
territori in cui questo medesimo fenomeno logico è leggibile. Si considerino, per
esempio, nel campo politico, il fenomeno del nuncius, operante come puro portavoce,
il fenomeno della rappresentanza con vincolo di mandato, il fenomeno della
rappresentanza senza vincolo di mandato, il fenomeno del dominio senza vincolo di
rappresentanza. E si consideri, ancora, nel campo dei titoli, il fenomeno del titolo di
credito condizionato dalla sua base giustificativa, del titolo di credito astratto, della
moneta, del derivato finanziario, e così via. La riflessione potrebbe riguardare gli stessi
titoli che intendono documentare un livello di formazione personale e professionale.
Infinite possono essere, nelle varie esperienze settoriali, le forme strutturate di presa di
distanza dal fondamento. L’itinerario logico-rappresentativo è, in ogni caso, il
medesimo. Esso corre, in sintesi, lungo quattro nodi fondamentali: a un primo stadio, si
dà una rappresentatività sotto condizione dell’esibizione del fondamento; a un secondo
stadio, si dà una rappresentatività sotto la presunzione relativa dell’esistenza del
fondamento (salvo prova contraria); a un terzo stadio, si dà una rappresentatività sotto
la presunzione assoluta dell’esistenza di un fondamento, in una condizione in cui
sostanzialmente si prescinde dall’esistenza del fondamento; a un quarto stadio, si dà
una qualità strutturale che prescinde totalmente dalla stessa rappresentatività di un
fondamento.
I derivati finanziari sono titoli che rappresentano titoli che rappresentano titoli,
pur dovendo rappresentare, in ultima istanza, nient’altro che la ricchezza che nasce
dal lavoro e dalla terra, da cui ritengono invece di essersi definitivamente distaccati; i
derivati notiziari, d’altra parte, sono notizie che rappresentano notizie che
rappresentano notizie, pur dovendo rappresentare, in ultima istanza, nient’altro che la
verità dei fatti da cui si sono, a un certo punto, distaccate; allo stesso modo, i derivati
certificativi di formazione sono certificati che rappresentano certificati, pur dovendo
rappresentare, in ultima istanza, il livello reale di formazione personale e
professionale da cui si sono, a un certo punto, definitivamente distaccati. Derivati
finanziari, derivati notiziari e derivati certificativi di formazione possono essere
guardati in modo isomorfo, sia nelle loro pretese che nel loro fondamento. Tutti
pretendono, infatti, di essere auto-consistenti rispetto al fondamento da cui pur
dovrebbero trarre validità. Essi intendono, in realtà, “funzionare” come se il
fondamento non esistesse più. Quel fondamento deve essere, nel livello della sua
rappresentazione, perennemente richiamato e presupposto, né mai può essere a
quell’altezza sostituito. Sostituire il fondamento è come dimenticarlo: in realtà, è
perderlo. Tale “dimenticanza” è sostenibile finché questo fondamento – dimenticato e
poi, per una inevitabile necessità funzionale, improvvisamente riapparso – farà
crollare tutti i piani che da quel fondamento traevano consistenza. Qui la bolla
scoppia. Sia nel luogo della terra sia nel luogo della verità. Qui il fondamento
(costituito dalla terra e/o dalla verità) reclama imperiosamente la sua originarietà,
vendicandosi di essere stato dimenticato. Lo scoppio della bolla nasce dalla perdita
della relazione col fondamento, la quale si consuma quando nessuna regola più
governa l’ultimo livello della rappresentazione. Qui la verità del fondamento appare
nella sua vera natura: come vincolo all’arbitrio di ciò che, pur dovendo rappresentare
quel fondamento, pretende di non rappresentarlo più. Ciò che si è definitivamente
astratto diviene, nelle nuove condizioni rivelative, impotente. La potenza
dell’astrazione si converte, a un certo punto, nell’impotenza della sua vacuità.
La verità, fin dai tempi antichi, aveva da fare, così come la terra, con l’essere.
Già nella Metafisica di Aristotele si affermava che c’è tanto di verità quanto c’è di
essere. Amedeo G. Conte, illustre logico italiano, ha scritto che noi usiamo il termine
“vero” in due sensi fondamentali: nel senso del vero de dicto e nel senso del vero de
re2. Nel primo senso si intende la verità come corrispondenza fra ciò che si dice e la
realtà di cui si dice, mentre nel secondo senso si intende la verità come conformità
della cosa al modello di cui intende essere l’incarnazione. Proviamo, a questo punto, a
tener conto, da un lato, della prospettiva di Amedeo Conte sul significato della parola
“vero” e, dall’altro lato, della prospettiva di Martin Heidegger sull’essere, sul soggetto
e sull’ente. Potremmo dire, in questo orizzonte di riferimenti, che la verità si esprime in
tre forme. Nel senso della verità come corrispondenza, nel senso della verità come
veracità, ossia come autenticità, e nel senso della verità come quell’essere – come
2
A.G. Conte, Filosofia del vero, in Bruno Montanari (a cura), Normatività e conoscenza, Scripta WEB, Napoli
2006.
quell’energia dell’essere – che precede e sottende il soggetto, sia in quanto questo
soggetto si esprime nella forma della verità come autenticità, sia in quanto si esprime
nella forma della verità come corrispondenza. Io sono vero, se sono vero, in tre sensi:
nel senso in cui dico una verità come corrispondenza a qualcosa, nel senso in cui
esprimo la mia verità come autenticità, e nel senso in cui in me si dà un’energia
dell’essere che mi precede e mi sottende, senza che io possa disporne a piacimento.
Nella prima forma di verità si dà la corrispondenza o non corrispondenza con ciò che
dico; nella seconda forma, si dà la veracità come sincerità o non sincerità in ciò che
dico o faccio; nella terza forma, si dà quell’energia che già da sempre mi è stata
trasmessa, che mi precede e mi sottende, a cui appartengo e di cui per definizione non
posso disporre e non dispongo.
A ben riflettere, a questi tre modi di verità corrispondono, secondo una
metafora nascosta che occorre – a nostro avviso – disoccultare, tre modi di guardare
alla terra. Posso vedere la terra come semplice area da picchettare, secondo un
modello di corrispondenza amica o nemica con ciò che la circonda; posso vedere la
terra come area feconda, in cui esprimere la mia capacità di lavorarla e di farla
fruttificare, assumendone il rischio e la responsabilità; posso, infine, vedere la terra
come forza che mi è stata trasmessa, che non posso riprodurre, di cui non dispongo,
perché è essa a disporre di me. Nella prima forma, vedo la terra come dominio e
delimitazione dei confini, come regolamento dei conti con ciò con cui essa confina;
nella seconda forma, vedo la terra come luogo col quale si mescola il mio lavoro,
esprimendo frutti alla luce; nella terza forma, vedo la terra come energia, propria del
creato, che mi è stata tramandata, di cui debbo saper aver cura. Tre forme di verità
dell’essere si pongono, così, in corrispondenza biunivoca con tre forme di relazioni
fra l’uomo e la terra. Tre forme di terra, tre forme di verità.
Se ben si osserva, le relazioni molteplici di un soggetto con un oggetto possono
rivelarsi nei molteplici significati del possessivo. Quanti sono i significati del dire
“mio”? Si osservi. Posso dire “il mio libro”, nel senso della proprietà; “il mio libro”,
nel senso dell’esserne l’autore; “mio figlio”, o “mio padre”, o “il mio gruppo”, nel
senso dell’appartenenza, e così via. In queste forme sono espresse, in realtà,
connotazioni diverse della relazione con l’oggetto. Altro è la relazione di proprietà o
di dominio, altro la relazione di generazione e di autore, altro la relazione di
appartenenza a qualcosa. Si tratta, a ben vedere, di tre relazioni di verità. In tale
contesto, molte e diverse fra loro possono essere le relazioni simboliche con la terra.
Così, se dico “la mia terra”, posso intendere la terra su cui ho la proprietà oppure la
terra che lavoro oppure la terra a cui appartengo. Si tratta di tre diverse relazioni
simboliche, espressive di tre diverse relazioni, precisamente corrispondenti alle tre
forme di verità di cui precedentemente abbiamo parlato.
Se guardiamo, a questo punto, alla storia delle idee che vive nei giuristi che
guardano alla terra, possiamo cogliere l’itinerario di un sommovimento profondo di
cui il filosofo deve saper capire il significato e formulare il referto. Guardiamo, in
proposito, ad alcuni movimenti che accadono sottotraccia. Vediamo nel XIII secolo la
figura di Henry de Bracton, il quale distingueva, com’è noto, fra gubernatio e iuris
dictio, là dove la gubernatio individuava la terra come area del potere di chi governa
e la iuris dictio la terra come l’area nella quale i sottoposti al potere costituivano –
con i loro diritti – non soltanto luogo di decisione competente, ma argine e misura di
quel potere. Nell’ambito di una sola terra, intesa come area di dominio,
reciprocamente si relazionavano e si condizionavano, così, il potere di chi governava
e i poteri – i diritti – di chi vi era governato. Si pensi, d’altra parte, all’evento della
Rivoluzione francese e alla sua volontà di articolare sovranità e individui, là dove i
diritti degli individui proprietari si relazionavano e si misuravano con il potere della
sovranità. Se, infine, vediamo il percorso che si compirà dall’Ottocento al Novecento,
fino ai nostri giorni, se guardiamo cioè agli scritti di Salvatore Pugliatti, di Costantino
Mortati, di Paolo Grossi, di Antonio Carrozza e di tanti altri3che si sono occupati da
3
Preferiamo qui richiamare, fra gli altri, i seguenti scritti: S. Pugliatti, Interesse pubblico e interesse privato nel
diritto di proprietà, Relazione presentata al Primo Congresso Nazionale di Firenze del 1935, in AA. VV., La proprietà
nel nuovo diritto, Giuffrè, Milano 1954; Id., La proprietà e le proprietà, in AA.VV., La proprietà nel nuovo diritto, cit.;
P. Grossi, La proprietà nell'officina dello storico, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,
Giuffrè, Milano 1988; A. Carrozza, Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario, Giuffrè, Milano
1975; Id., Rivisitando la proprietà agraria, Discorso accademico al Congresso dell' A.I.C.D.A. in Lecce (17-19 ottobre
1991), in La proprietà fondiario-agraria. Nel 50° anniversario del libro terzo del codice civile, a cura di G. Angiulli,
Atti del Convegno di Lecce (17-19 ottobre 1991), Edizioni ETS, Pisa 1993; Id., Uno sviluppo agricolo «sostenibile» per
giuristi del problema della terra, in questo percorso – all’interno della polarità che si
costituisce fra la terra e i diritti degli individui – noi cogliamo da un lato, il
progressivo affermarsi dell’idea del lavoro (si pensi all’importanza che aveva già
acquisito il lavoro nella filosofia settecentesca di John Locke) e, dall’altro lato,
l’affermarsi dell’appartenenza dei singoli uomini alla terra più di quanto la terra a
quei singoli uomini appartenga. Si noti. L’emergere pubblico dell’idea del lavoro
qualitativamente rovescia l’idea della proprietà individuale della terra, perché
inserisce nell’idea della proprietà e del suo arbitrio quella di fecondità: della possibile
fecondità della terra e della nostra responsabilità verso di essa, anche in
considerazione del rapporto con gli altri. Emerge con forza, qui, attraverso l’idea del
lavoro, il problema della responsabilità sociale, della produzione sociale, del ciclo
biologico e del rischio a cui ci si espone lavorando. Attraverso queste idee, insieme
combinate, si rivela intrinseco alla terra quel mondo della vita – quella Lebensform,
quel mondo comunitario – che precede i soggetti e viene alla luce come sostanza
della terra. È stato Paolo Grossi a osservare con illuminante intuizione che nel
modello dei diritti civici della terra è presente l’idea contro-individualistica per cui
non è la terra ad appartenere agli uomini perché sono gli uomini – nelle forme di vita
delle comunità – ad appartenere alla terra4.
Il compito del pensiero filosofico è quello di cogliere ciò che accade in
filigrana nella storia delle cose e delle idee. Lo stupido vede il complicato; il talento
vede nel complicato gli intrecci del complesso; il genio riesce a vedere il semplice
che sottotraccia vive nel complesso. Il compito della filosofia è il lavoro del talento
che si fa pensiero ed è chiamato a farsi genio, illuminazione.
Un primo referto sui movimenti della storia che ci scorre sotto gli occhi è stato
tracciato da Martin Heidegger in un breve scritto dal titolo Lettera sull’umanismo,
pubblicato nel 1947, che qui noi cercheremo di guardare anche sotto altra luce,
cogliendovi l’emergere dell’immagine della terra come metafora nascosta. Heidegger,
il territorio: profili giuridici, Relazione presentata al XXI Incontro del Centro Studi di estimo e di economia territoriale
- CE.S.E.T. - su Lo sviluppo sostenibile del territorio, Perugia, 8 marzo 1991, in “Rivista diritto agrario” I (1991), p.
531; A. Sciaudone, Il fondo rustico nella proprietà e nell'impresa, ESI, Napoli 1996.
4
Cfr. P. Grossi, La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico, cit.
individuando il senso del cammino che sta accadendo sotto la scorza delle cose,
capisce a fondo che bisogna oltrepassare quella logica del soggetto e dell’oggetto, al
cui interno è nata e si è sviluppata la modernità. Nella modernità, infatti, si dà un
oggetto guardato da un soggetto e si dà un soggetto che lo guarda, lo circoscrive, lo
domina. Il soggetto, perciò, proietta il suo oggetto come oggetto, come ob-jectum,
come cosa davanti a sé gettata, che egli può ad arbitrio guardare e manipolare. Ma, in
realtà, la modernità nasconde, per Heidegger, l’essenziale. Nasconde il fatto che, alle
spalle del soggetto, si dà quell’essere che proietta quello stesso soggetto che, a sua
volta, proietta – getta davanti a sé – l’oggetto. Nella prospettiva heideggeriana, perciò,
lo stesso soggetto è, come il suo oggetto, un esser-gettato.
Domandiamoci però, a questo punto, sullo scritto di Heidegger a partire dalla
metafora nascosta che a nostro avviso vi lavora: quella della terra. Che cos’è mai
questo Essere che ci precede e ci proietta, sostenendoci nel nostro essere-al-mondo?
L’Essere è qui quel fluire, quello scorrere, quel durare che ci precede e di cui non
possiamo dire che cosa è, perché, se lo dicessimo, lo cosificheremmo in un ente, che
non sarebbe più l’Essere perché sarebbe un qualcosa troppo presto configurato in una
forma di solidificazione. L’Essere – questo essere – non è semplicemente la “realtà”
che ci appare davanti. Esso è quel fluire, quello scorrere, quel durare che ci precede e
ci sottende, a cui apparteniamo. A guardar bene, si tratta dello stesso punto di vista di
cui sta parlando in termini storico-giuridici Paolo Grossi quando afferma,
configurando il rapporto fra la terra e gli uomini che la possiedono, che bisogna
guardare all’appartenenza degli uomini alla terra e non della terra agli uomini. Dentro
questa prospettazione traluce nient’altro che quella figura radicale che Heidegger ha
disegnato, mostrando come non sia l’essere ad appartenere all’uomo, ma l’uomo
all’essere.
La domanda, secondo la metafora della terra, non riguarderà pertanto il
possesso degli uomini sulla terra, ma l’appartenere degli uomini alla terra e alle loro
comunità. Anche nel percorso del diritto e delle idee che i giuristi vi scoprono, perciò,
si coglie il farsi avanti di una verità di cui la terra è portatrice. Vi si percepisce un
andare verso la verità che è un progressivo regredire a ciò che le apre il varco. Il
fluire in quanto fluire da sempre precede il soggetto, così come la terra in quanto terra
da sempre precede il singolo uomo.
Qui Heidegger introdurrà, a proposito del rapporto che si scopre fra l’essere e il
soggetto, fra l’essere e il suo esser-ci come essere umano, tre parole fondamentali.
Occorrerà che il pensare, nel quale l’uomo esperisce l’auto-rivelarsi dell’Essere dentro
di lui, abbia, per il pensatore tedesco, il rigore della meditazione, la cura delle parole e
la parsimonia nel loro impiego. In realtà, quando Heidegger parla del pensare, sta
parlando della capacità operosa che l’Essere nell’uomo compie. Infatti, come il
pensatore tedesco afferma fin dalle prime righe di Lettera sull’umanismo, l’agire è il
portare a compimento. Nell’uomo vive, in realtà, la stessa capacità operosa che nella
terra vive. Heidegger parla dell’Essere in quanto si dà nell’esser-ci, nell’uomo,
nell’aprirsi interiore della sua radura, là dove l’Essere assegna all’uomo il suo Da: il
suo essere là collocato. L’Essere assegna – stando nell’uomo – a ogni uomo il suo
luogo, il suo Da. A ben riflettere, l’Essere è, lungo lo scorrere di una metafora nascosta
e comune, esattamente come la terra, che assegna a ogni uomo il suo Da, il suo luogo.
Così come l’Essere, la terra «némei»: distribuisce. Assegna, attribuisce, affida. Non è il
soggetto a distribuire, ma è l’Essere, attraversando il soggetto, a farlo. In questa luce,
l’Essere è alétheia: la verità come l’auto-svelarsi dell’essere. E, nella nostra metafora, è
la terra che si trasmette come energia che si dà in frutti.
In questa prospettiva, che cos’è per Heidegger il linguaggio? È il pensare nella
sua capacità di farsi espressione. Ed è, nella metafora che qui proponiamo come cifra
ermeneutica ulteriore, la capacità operosa della terra nel suo farsi lavoro e, attraverso
il lavoro, espressione di fecondità. Come l’Essere si fa pensiero e linguaggio, così la
terra si fa capacità operosa e lavoro che feconda. Il lavoro, portando alla luce la
capacità operosa che nella terra agisce, si ricongiunge con la terra che gli sta alle
spalle, così come il linguaggio, portando alla luce il pensiero che nell’essere agisce, si
ricongiunge con l’essere che gli sta alle spalle, facendolo emergere come quella verità
che è alétheia, evento dello svelarsi. Mentre l’Essere, come la terra, è verità che si
auto-rivela e trabocca – attraverso l’opera dell’uomo – nella sua possibile fecondità, il
compito dell’uomo è l’atto di responsabilità esercitato perché questa possibile
fecondità – attraverso il linguaggio del pensiero e il lavoro della terra – venga alla
luce. In questo senso, il lavoro è esperienza di responsabilità verso la capacità
operosa in cui si dà la terra, così come il linguaggio è esperienza di responsabilità
verso il pensiero in cui l’Essere si dà. Il pensiero sta all’Essere, come il linguaggio sta
al pensiero; la capacità operosa sta alla terra, come il lavoro sta alla capacità operosa.
Il linguaggio feconda il pensiero; il lavoro feconda la capacità fruttifera della terra.
Ma questa capacità di fecondazione non è solo potere: è responsabilità. Il linguaggio
non solo può fecondare il pensiero: ha la responsabilità di farlo; il lavoro non solo
può fecondare la capacità fruttifera della terra: ha la responsabilità di farlo. Il
linguaggio e il lavoro debbono esercitare la loro responsabilità per salvaguardare –
nel pensiero e nella capacità della terra – il rinnovarsi della loro fonte generatrice.
Dove l’Essere e la terra si danno come possibile fecondità, l’opera dell’uomo si dà
come responsabilità perché quella fecondità possa emergere alla luce. Ciò che la
fecondità rende possibile, la responsabilità deve far emergere alla luce. Accade, qui,
lo stesso evento che accade nel rapporto tra il fondamento e il piano che dall’alto lo
rappresenta. Quel fondamento impone – permanentemente e nascostamente – a quel
piano le sue regole. Quando quel piano si spoglia di quelle regole, si apre una bolla;
quando lo spogliarsi da quelle regole mette in contraddizione quel piano con il suo
fondamento, quella bolla scoppia. Pretendere di spogliarsi dalle regole poste dal
fondamento significa, all’ultimo epilogo, lo scoppio della bolla come deflagrazione
della responsabilità. Ciò che, per nichilistica ybris, si è astratto dal suo fondamento
spogliandosi di ogni regola, implode a un certo punto nel suo nulla.
Nella metafora che stiamo qui praticando, l’esperienza del circoscrivere la
terra, dominandola, equivale all’esperienza della prima forma di verità: la verità come
corrispondenza. Al secondo livello, l’esperienza del fecondare e far fruttificare la
terra equivale alla seconda forma di verità: la verità come espressione autentica di sé.
Proseguendo in questo regredire alle proprie spalle, l’esperienza della terra come di
ciò che ci è stato tramandato, di cui non disponiamo ma semplicemente siamo
custodi, equivale alla terza forma di verità. Alla verità come alétheia. Alla verità
come farsi luce dell’Essere nel pensare.
Ai tre significati della terra come luogo in cui si definiscono confini, come
luogo in cui agisce un lavoro che feconda e come luogo da cui emerge una energia
alla luce, corrispondono i tre significati della verità come mettere in corrispondenza,
come far venire a maturazione il linguaggio che apre e come consentire all’Essere –
nel pensare – di venire alla luce. Nel momento del lavoro si esercita la propria
responsabilità verso la terra e la sua capacità operosa, così come nel linguaggio si
esercita la propria responsabilità verso l’Essere e il suo darsi nel pensiero.
Come dallo stesso scritto di Heidegger appare chiaro, il pensare, nel suo essere
libero, non può essere però avventuriero nei confronti dell’essere di cui è portatore,
perché deve saper essere, nella sua capacità d’avventura, esercizio di responsabilità
verso l’Essere dal cui seno viene alla luce. Il pensare è responsabile verso l’Essere,
come il linguaggio verso il pensare e come la verità-corrispondenza verso l’Essere e
il pensare. Allo stesso modo, l’attività di dominio sulla terra deve essere responsabile
verso il lavoro che la feconda, così come questo lavoro deve essere responsabile
verso la capacità operosa della terra e verso l’energia che in essa si dà. Nella metafora
che stiamo qui praticando, tutta la ricchezza che esonda dal dominio della terra, per
quanto se ne separi, non può prescindere dal lavoro che a quella ricchezza sottostà e
dà senso. Il titolo finanziario che si è completamente staccato dal lavoro che vi
sottostà, si è staccato da quel fondamento che è la sua verità. Il soggetto che crede di
dominare l’Essere, dimenticando di appartenere all’essere di cui è espressione, si
auto-inganna, perché perde il rapporto con la verità di cui è il portatore, anzi il
custode e il pastore. D’altra parte, il soggetto che crede di dominare la terra fino a
separarsene e a viverne senza, dimenticando di appartenere alla terra di cui è
espressione, allo stesso modo si auto-inganna, perché perde il rapporto di
responsabilità con la terra di cui è il custode e il pastore. In questa luce, ogni titolo
che, libero da ogni regola, pretenda prescindere dal lavoro sottostante è il materiale e
flagrante tradimento della sua verità. Tradire questa verità – la verità come lavoro –
significa perdere quel fondamento e generare quella bolla in cui è nascosta e
imminente la catastrofe, là dove questa improvvisamente si rivela la controprova
sperimentale della misconosciuta verità.
Quando Paolo Grossi, occupandosi delle proprietà comunitarie, sottolinea il
fenomeno per cui in esse si rivela l’appartenere del soggetto alle generazioni che si
succedono nel tempo, sta facendo emergere, in realtà, l’appartenere dell’uomo alla sua
strutturale responsabilità verso la terra, verso la relazione interumana, verso l’equilibrio
ecologico, verso il creato. Qui il rapporto con la terra diventa rapporto con la verità del
fondamento, con la verità del lavoro, con la verità della salute alimentare, con la verità
dell’equilibrio fra gli uomini, con la verità del rispetto dell’Essere da cui siamo emersi.
La terra diventa, in questa luce, metafora di un problema di verità.
La verità – perciò – vincola. Attraverso la responsabilità. A pena di catastrofe.
La modernità ha creduto di poter fare a meno del fondamento, della verità. Ciò non le
era affatto impedito, né vietato. Essa era ben libera di farlo. L’evento della catastrofe
semplicemente ricorda a quella libertà di essere uscita dal segno, dimenticando la
propria verità. Se la libertà sconfina dai suoi limiti, cioè delira, non è un giudice
esterno a ricordarle quei limiti, ma un evento strutturale a essa intrinseco: la catastrofe.
Dentro la catastrofe deflagra una prova sperimentale di verità. Il tema del relativismo,
così doviziosamente pubblicizzato dal moderno, ha dimenticato questo limite, che non
è arbitrario, ma è oggettivo e duro. La verità non è altro che il limite entro il quale si
esprime, a sue spese, una qualsiasi libertà. Il declino della verità e il declino della terra
rivelano perciò, secondo la metafora nascosta qui indagata, una parabola comune. La
morte della verità e la morte della terra si rivelano una medesima cosa. Là dove la
modernità ha creduto di separarsi dal fondamento, ha consumato la sua irreversibile
crisi. Venendo a mancare il fondamento, la casa crolla. Il fondamento dimenticato si
vendica: sia nel caso della verità come verità filosofica che nel caso della verità come
lavoro, sia nel caso della verità come essere che nel caso della terra come verità. La
catastrofe non è, in questa chiave, un incidente di percorso, perché già da prima
strutturalmente appartiene allo stesso itinerario che si è senza memoria compiuto.
Esiste – qui – un quid che ci precede e ci sottende, che non possiamo manipolare a
piacimento, costituendo il vincolo primo e insuperabile per ogni nostro – conoscitivo e
comportamentale – cammino.
La terra non ci è data solo per dominarla, ma per fecondarla. Ciò, in una
necessaria relazione di responsabilità con la salvaguardia delle sue risorse e in una
necessaria relazione di responsabilità con la salvaguardia degli altri con cui nel
pianeta conviviamo. A questo punto, possiamo anche definire la nostra terra come
luogo caratterizzato da confini e la nostra verità come corrispondenza, ma lo faremo
nell’esercizio di quella responsabilità che ci consente di permanere nella verità che ci
conserva. La catastrofe non è altro che la cicatrice in cui si rivela la tradita
responsabilità.
Martin Heidegger nella parte conclusiva della sua Lettera sull’umanismo, ha
scritto: «il pensiero a venire non può […], come pretendeva Hegel, abbandonare il
nome di “amore per la sapienza” e divenire la sapienza stessa nella forma del sapere
assoluto. Il pensiero sta scendendo nella povertà della sua essenza provvisoria. Il
pensiero raccoglie il linguaggio nel dire semplice. Il linguaggio è così il linguaggio
dell’essere come le nuvole sono le nuvole del cielo. Con il suo dire, il pensiero traccia
nel linguaggio solchi poco vistosi. Essi sono ancora meno vistosi dei solchi che il
contadino, a passi lenti, traccia nel campo»5.
All’inizio di questo percorso abbiamo parlato di Pinocchio. Il Pinocchio di
Collodi non è soltanto un romanzo di formazione, perché forse disegna anche un
segreto apologo sulla modernità. Proviamo a guardare Pinocchio come quell’adulto
che noi stessi siamo e che dobbiamo rimisurare nell’orizzonte della verità che ci
contiene. Mi viene in mente una barzelletta che non mi ha mai abbandonato per la sua
capacità di illuminare. Un uomo andò da un sarto per farsi fare un vestito importante.
Il sarto, nel confezionarglielo, lo sbagliò. Nel momento in cui il cliente doveva
misurarselo, il sarto, essendosi accorto dell’errore, addestrò il cliente a muoversi
5
M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 1995, pp. 103-104.
secondo i movimenti che gli consentissero di non far apparire gli errori della
confezione. Quando il cliente, perfettamente addestrato, uscì dal laboratorio del sarto,
tutti, guardando quella figura di uomo così goffa nel camminare, in modo ammirato
esclamarono: – Guarda quello lì come è storto, ma ha trovato un sarto così bravo da
fargli un vestito a pennello!
La modernità si è espressa con l’artificio, studiando e realizzando ogni
movimento attraverso lo spezzettamento in parti. Ha sostituito così al movimento
reale il movimento stroboscopico. L’uomo reale ha dovuto, perciò, per realizzare i
suoi movimenti, conformarsi ai movimenti spezzettati e artificiosi che per lui erano
stati disegnati nella forma di una macchina di parti separate e montate.
La modernità ha realizzato il suo artificio in più modi connessi: ha spezzettato
in parti, ha derivato una parte dalle altre rendendola rappresentativa di tutte, ha
costruito rappresentazioni e rappresentazioni di rappresentazioni. La modernità, da un
lato, ha frantumato in parti l’intero e, dall’altro lato, ha astratto una parte dall’intero
pretendendo che questa parte potesse prescindere dall’intero che essa rappresentava.
Da un lato, ha spezzato ciò che è vivo, come se, anche dopo la spezzatura,
continuasse a esser vivo, e dall’altro lato, ha astratto da ciò che è vivo, come se
quell’astrazione potesse continuare a vivere senza possedere più quella vita. Al colmo
dell’illusione, la verità della vita si rivela come crollo. I titoli dell’ultima generazione
rappresentativa si sono completamente staccati dalla base di cui dovevano essere
rappresentazioni. Alla fine, gli uomini hanno dovuto adattarsi al movimento di titoli
astratti, anche se questi titoli non rappresentavano più nulla. Essi simulavano
l’esistenza di una base, anche se questa base non esisteva più.
L’uomo reale, per essere naturale, ha dovuto diventare artificiale: ha dovuto
modellarsi sui movimenti di una macchina di pezzi, assunta come punto di
riferimento unico ed essenziale. Egli è stato costretto, così, a diventare copia della sua
copia. Essendosi radicalizzata la fede nell’artificio, il risultato si è concentrato nel
destino comico che ci ha travolti. Nel quale la vera cosa tragica consiste nel fatto che
non ci accorgiamo più della sua comicità.
Pinocchio, diventato bambino in carne e ossa, guarda la sua carcassa di
burattino, che egli vede ormai quasi alla terza persona, e dice: – Come ero buffo
quando ero burattino e come sono felice oggi di essere una persona vera! Quanto
tempo occorrerà perché l’uomo post-moderno possa, uscito dalla sua bardatura,
guardarsi come Pinocchio guardava alla sua marionetta? L’uomo contemporaneo
potrà salvare se stesso dalla comicità in cui è tragicamente crollato solo se riuscirà a
recuperare una relazione con la perduta terra, col perduto lavoro e con la perduta
verità.