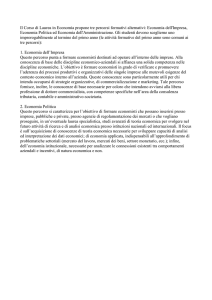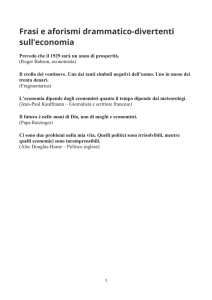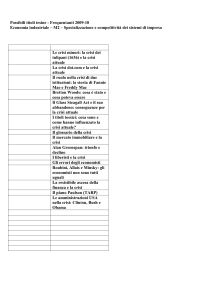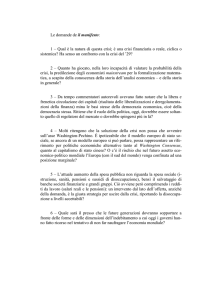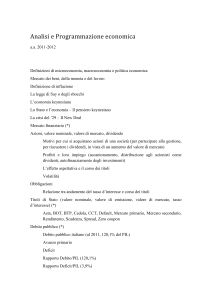Corso di Laurea in Economia e Scienze Sociali Il Dibattito sulla quota del lavoro in Italia: un’analisi Carlo Scalisi [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.] D o c e n t e T u t o r : C a r l o D e v i l l a n o v a D i p a r t i m e n t o d i A n a l i s i I s t i t u z i o n a l e e M a n a g e m e n t P u b b l i c o Matricola 1353424 1
1. Introduzione
Nel
giugno
2010
un
certo
numero
di
docenti
e
ricercatori
universitari italiani di discipline economiche e statistiche ha prodotto
un documento, indirizzato ai principali protagonisti della vita politica
italiana, nella fattispecie Governo e Parlamento italiano, sindacati ed
altre forze sociali e per opportuna conoscenza al Presidente della
Repubblica
italiana,
intitolato
semplicemente
“Lettera
degli
Economisti”, dove veniva argomentata una nuova interpretazione
delle
cause
della
recessione
che
l’economia
mondiale
ha
sperimentato nel triennio 2007-2010 e che, per molti parametri
economici, continua ad esistere tuttora.
Contrariamente a quanto i maggiori studiosi e, in un primo
momento,
le
più
importanti
istituzioni
economiche
avevano
affermato, quest’ultima crisi economica è stata causata da una
domanda insufficiente espressa dal lato dei consumatori, motivata
in larga misura da “un allargamento del divario mondiale tra una
crescente produttività del lavoro e una stagnante o addirittura
declinante capacità di consumo degli stessi lavoratori” (Lettera degli
Economisti, 2010).
Secondo i firmatari, le ragioni della recessione che l’economia
globale stava (e sta) attraversando erano da attribuire non tanto ad
una combinazione di eventi economici infausti dal lato dell’offerta in breve, crescita e crisi del mercato immobiliare, meccanismi di
concessione del credito deviati, cartolarizzazione e leva finanziaria ma ad uno scompenso sistematico nella capacità di consumo degli
individui, identificati principalmente nella persona dei lavoratori
dipendenti.
2 La colpa è da attribuire ai governi dei paesi occidentali ed all’Unione
Europea
tutta,
per
liberista”
che
trova
avere
le
promosso
sua
un
fondamenta
“insostenibile
profilo
nel
stesso
Trattato
dell’Unione e per la “politica economica restrittiva dei Paesi membri”
colpevoli di aver incoraggiato in maniera sistematica il disavanzo
commerciale con l’estero.
La Germania in particolare viene attaccata per la sua tendenza ad
effettuare
avanzi
commerciali
con
l’estero
(presumibilmente
l’estremo oriente) di notevole entità, non contribuendo così allo
sviluppo economico di altri paesi europei che invece soffrono di
deficit commerciali cronici.
Anche l’attuale governo italiano non è immune alle critiche degli
economisti firmatari, colpevole di una politica economica troppo
restrittiva e di aver voluto abbattere il debito pubblico tramite le
privatizzazioni d’interi apparati statali; l’opposizione, dal canto suo,
non
è
stata
neppure
capace
di
proporre
linee
d’intervento
alternative.
In chiusura del documento, gli economisti propongono una serie di
politiche fiscali ed interventi vari su diversi piani dell’economia con
l’obiettivo di “evitare la distruzione dell’Unione” di cui elenchiamo i
principali:
-
emissione di moneta da parte della BCE senza annessa
“sterilizzazione”
-
finanziare la ripresa economica principalmente tramite spesa
pubblica, a sua volta sostenuta da maggiore debito
-
rallentare
e
se
necessario
interrompere
ed
invertire
il
processo di privatizzazioni cominciato in Italia negli anni ‘90
3 -
regolamentare il mercato finanziario in maniera tale da
disincentivare le transazioni a breve termine e restringere
l’accesso del piccolo risparmio e dei fondi pensione allo stesso
-
limitare il libero scambio fra i paesi dell’Unione, sia a livello di
merci che di capitali
La lettera pubblicata nel giugno 2010 dal Sole 24Ore ha suscitato
sin da subito un certo dibattito fra studiosi d’economia, professori
universitari ed altri esperti, riguardo le premesse teoriche della
lettera, le constatazioni sullo stato attuale dell’economia espresse e
sulle proposte d’intervento elencate alla fine.
In particolare, la lettera è stata criticata in maniera aspra ed a tratti
apertamente ridicolizzata dai redattori di NoiseFromAmerika, un
blog d’economia e politica curato da economisti italiani che lavorano
e/o insegnano negli Stati Uniti, in un post apparso il 21 giugno
2010, una settimana dopo la pubblicazione del documento (Bisin e
Boldrin, 2010). In questo post, tutte le proposizioni principali della
lettera vengono prese in esame e sistematicamente “smontate”,
tirando in ballo vecchie teorie economiche come quella del
sottoconsumo/sovrapproduzione, che, a detta degli autori del post,
sono alla base della disamina della cause della crisi proposta dai
firmatari della lettera.
Il modo in cui le critiche vengono proposte è probabilmente fin
troppo aspro e pecca di grande sufficienza nella maniera in cui
vengono “demolite” le tesi della lettera, a tratti dando ai firmatari
della lettera quasi il ruolo di una “fazione nemica” ai redattori del
post, le cui proposizioni teoriche diverse sono ragione sufficiente per
aggiudicarsi quasi l’odio degli autori.
Le critiche espresse, seppur in un tono sconveniente, da Bisin e
Boldrin sono comunque condivisibili e mostrano delle falle nei
4 fondamenti teorici della Lettera, specie quando fanno notare come
una crisi del consumo, a detta dei firmatari della Lettera una causa
della crisi, sia quanto di più lontano da quello che è realmente
successo negli USA nel lustro pre-recessione (Bisin e Boldrin, 2010).
La Lettera degli Economisti ha suscitato un certo dibattito in
ambiente accademico ma non è riuscita a generare riflessioni serie
nell’ambiente politico e nei sindacati, i quali erano peraltro i
principali destinatari del documento.
A difesa del documento, si può citare una conferenza congiunta
Fondo
Monetario
Internazionale
(FMI)
–
Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO), documentata da Devillanova
(2010), in cui le posizioni espresse supportano indirettamente
alcune delle considerazioni presenti nella lettera.
Partendo dal dato assai preoccupante della disoccupazione nel
mondo, l’IMF indica gli squilibri della domanda aggregata come
possibile
determinante,
in
particolar
modo
la
crescente
disuguaglianza nei paesi occidentali che potrebbe spiegare la
crescita scarsa e l’aumento del ricorso all’indebitamento ed, in
ultima analisi, la crisi dei mutui subprime.
L’IMF sostiene anche che sia meglio evitare il fisco restrittivo in un
primo momento, senza però incoraggiare maggiore intervento
statale come viene auspicato nella Lettera. Infine, seppure rilevando
come
la
globalizzazione
abbia
contribuito
all’aumento
della
disuguaglianza, l’IMF auspica maggior coordinazione delle politiche
economiche e di scambio dei paesi, ma sicuramente non propone
una diminuzione del libero scambio, come sostengono invece i
firmatari della Lettera.
La lettera attribuisce l’origine della crisi ad un’insufficienza della
domanda mondiale, una situazione causata da un aumentare della
5 produttività
mondiale
peggioramento
dei
del
profili
lavoro
salariali
accompagnato
dei
lavoratori
ad
dei
un
paesi
occidentali, una combinazione di eventi che, a detta dei firmatari,
ha sensibilmente diminuito la capacità di spesa dei consumatori.
Gli economisti firmatari sostengono dunque che la quota del lavoro,
ossia quella parte di Prodotto Interno Lordo (PIL) che va ai
lavoratori, sia diminuita nell’ultimo decennio (anni ’00) mentre la
produttività del lavoro aumentava, in Europa come negli Stati Uniti.
La quota del lavoro è costituita dal rapporto fra il costo del lavoro
totale (salario unitario reale per forza lavoro impiegata) ed il valore
aggiunto prodotto nell’economia, vale dire il PIL. Altre quote
distributive che sono generalmente oggetto di studio sono quella dei
profitti e quella del “capitale”, ossia rendite su immobiliari ed asset
finanziari.
Per lungo tempo, gli economisti hanno creduto che le quote
distributive restassero costanti nel tempo, tramite un meccanismo
di aggiustamento attuato mediante i prezzi relativi dei fattori: al
diminuire del costo relativo di un fattore, ad esempio il lavoro,
rispetto ad un altro, come il capitale, aumenta il suo impiego,
sempre relativo, e se questa variazione di impiego si muove in
maniera proporzionale alla variazione di prezzo relativo, la quota del
primo fattore, in questo caso il lavoro, resta costante nel tempo.
Tuttavia, questa convinzione d’invariabilità è stata messa in
discussione dalle variazioni, certe e osservabili, che la quota ha
subito nel tempo, di cui discuteremo in seguito.
Alcune determinanti delle variazioni della quota del lavoro e di altre
quote distributive nel tempo sono l’evoluzione delle tecnologia, che
determina l’impiego relativo dei fattori produttivi, le variazioni dei
prezzi relativi di quest’ultimi, che similarmente ne influenzano
6 l’utilizzo, ed il grado di concorrenza esistente in un mercato, che
modificano la ripartizione delle rendite fra capitale e lavoro.
L’affermazione della Lettera che vuole la quota del lavoro in grande
diminuzione nell’ultimo decennio è stata al centro di un altro filone
di
dibattito
partito
da
un
post
pubblicato
sempre
su
NoiseFromAmerika da Giulio Zanella, poco tempo dopo la diffusione
della lettera, dal titolo “Gli economisti e i fatti” (Zanella, 2010).
A questo post sono seguite svariate repliche, in cui veniva dibattuta
la metodologia di calcolo dei dati utilizzata da Zanella, diversa da
quella applicata nella “lettera” (Stirati, 2010; Stirati, 2011).
Questa discussione sulla metodologia può essere interessante per i
tecnici ma risulta un po’ sterile per chi non ha almeno qualche
rudimento di economia e contabilità nazionale. Ad ogni modo, verrà
esaminata in seguito.
L’obiettivo di questo paper è un altro: si vuole analizzare, sulla base
della letteratura economica esistente, l’evoluzione della quota del
lavoro, o labor share, in Italia, ragionando anche sulle variazioni
delle sue componenti, vale a dire studiando l’andamento dei profili
salariali dei lavoratori italiani negli ultimi anni. Da quest’analisi si
cercherà quindi di venire a capo del dibattito che è sorto dopo la
pubblicazione
della
lettera
degli
economisti
e,
se
possibile,
determinare chi ha torto o ragione.
Il resto del paper è organizzato nella seguente maniera: la prima
parte esamina e riassume la letteratura economica esistente che ha
trattato l’argomento di recente; la seconda cerca di mettere insieme
i dati comuni rilevati dai vari autori degli articoli esaminati in
precedenza, evidenziando dove necessario le discordanze e le
differenze nell’interpretazione. In ultimo, vengono proposte le
conclusioni dell’analisi effettuata in precedenza sul fenomeno.
7 2.
Letteratura
economica
recente:
un
quadro
d’insieme
2.1. Evoluzione quota del lavoro
Roberto Torrini (Banca d’Italia) ha prodotto un certo numero di
studi e ricerche sul tema, sia da solo sia in collaborazione con altri
colleghi in Banca d’Italia.
Cominciamo con un articolo pubblicato su “Politica Economica”
nell’agosto dello scorso anno dal titolo “L’andamento delle quote
distributive in Italia” che tratta appunto l’evoluzione delle quote del
PIL italiano, in particolare la quota del lavoro, o labor share, negli
ultimi trenta anni (Torrini, 2010).
Negli ultimi anni si è verificato un certo aumento dell’attenzione
rivolta alle quote distributive del PIL, sia del lavoro che dei profitti e
delle rendite, fenomeno giustificabile data l’importanza che questi
dati assumono per le parti sociali, in quanto danno un’idea, seppur
un po’ abbozzata, della distribuzione della ricchezza prodotta dal
paese.
Gli andamenti essenziali della quota del lavoro negli ultimi trenta
anni del secolo scorso vengono subito presentati: la quota del
lavoro è cresciuta velocemente negli anni settanta, si è ridotta per
tutti gli anni ottanta fino ad arrivare, nei primi anni novanta, ai
livelli di fine anni sessanta.
Negli anni novanta la quota è diminuita ulteriormente, come
conseguenza dei mutamenti istituzionali di quegli anni, vale a dire
l’introduzione di nuovi meccanismi di determinazione dei salari e di
nuove regole di governo del mercato del lavoro, che causarono una
8 diminuzione dell’occupazione, un rallentamento della crescita del
costo del lavoro e in virtù di ciò un contenimento della labor share.
Al contempo, i governi di quegli anni intrapresero un esteso
programma di privatizzazioni di interi settori statali con l’obiettivo di
tagliare il consistente debito pubblico che gravava sul paese; un
rapporto debito/PIL sostenibile era infatti uno dei requisiti per
adottare a fine millennio la moneta unica.
Queste privatizzazioni ebbero l’effetto di moderare ancora di più la
dinamica della quota del lavoro attraverso il contributo dei settori
dell’economia privatizzati alla definizione della quota del lavoro di
tutto il paese: in questi settori, infatti, “i salari unitari aumentano
meno della media del settore privato dell’economia e la produttività
cresce a tassi comparativamente elevati” (Torrini, 2010).
Dal 2000, la tendenza si inverte e la labor share aumenta grazie ad
una
crescita
importante
dell’occupazione
ed
una
produttività
stagnante, che resterà tale per tutto il decennio.
Torrini accenna qua a quello che ha costituito l’argomento principale
del dibattito nato fra Zanella e Stirati, vale a dire il calcolo del
valore aggiunto, che si può effettuare prendendo il PIL calcolato al
costo dei fattori oppure ai prezzi di mercato; la differenza sta
principalmente nel fatto che il primo è al netto di imposte indirette e
sussidi alla produzione ed al consumo. Torrini fa notare come
generalmente si utilizzi questa definizione di valore aggiunto, ossia
al costo dei fattori, per il calcolo delle quote distributive. E’ prassi
comune in letteratura utilizzare il valore al costo dei fattori perché,
essendo al netto d’imposte indirette e contributi, ha il vantaggio di
separare la dinamica del carico fiscale dall’andamento del prodotto
interno.
9 L’altro argomento al centro del dibattito prima citato è l’inclusione o
meno dei lavoratori autonomi nel calcolo del costo del lavoro,
poiché esistono dati precisi e facilmente reperibili soltanto per i
lavoratori
dipendenti.
Senza
volere
addentrarsi
troppo
nell’argomento, dal momento che verrà ripreso in esame quando ci
si occuperà del dibattito fra Zanella e Stirati, basta dire che un
modo per ovviare a questo problema è quello di attribuire ai
lavoratori autonomi un reddito pari a quello medio dei lavoratori
dipendenti. Anche questa è la prassi comune in letteratura, per il
semplice motivo che, scegliendo di includere solo i lavoratori
dipendenti, si ha a che fare con due variabili: il rapporto tra le
retribuzioni totali ed il valore aggiunto prodotto ed il rapporto fra
lavoratori dipendenti ed occupazione totale, una situazione che
rende le stime poco affidabili.
Com’è stato accennato in precedenza, le principali determinanti
dell’evoluzione della quota sono la tecnologia utilizzata, il prezzo
relativo dei fattori produttivi e il grado di monopolio presente in un
mercato.
La proprietà di invariabilità della quota è stata fortemente messa in
discussione dalle variazioni a cui abbiamo assistito nell’ultimo
trentennio.
Vale comunque la pena notare come questi aggiustamenti di
impieghi relativi di fattori, in seguito ad una variazione dei prezzi
degli stessi, richiedano un certo periodo di tempo, generalmente
nell’ordine di qualche anno. Secondo alcuni analisti, infatti, le
variazioni osservate dalla quota del lavoro in questi ultimi decenni
non sono altro che i processi di aggiustamento del rapporto fra
fattori utilizzati e che quindi, in linea di principio, i valori della quota
prima e dopo questi lunghi periodi di adjusting debbano essere
10 sostanzialmente simili. Ad una prima occhiata, questa tesi è
corroborata dal fatto che i livelli della labor share, ad inizio anni
novanta, siano tornati a quelli di inizio anni settanta, prima dello
shock salariali che ha interessato quel decennio.
Non convince però appieno una simile spiegazione: le variazioni
della quota sono state troppo importanti negli anni settanta ed
ottanta e si fatica a credere che l’impiego di un fattore rispetto ad
un altro possa avvenire con la semplicità e l’automatismo quasi, che
i propositori di questa teoria assumono.
Altri fattori che influenzano il livello delle quote sono il grado di
monopolio esistente in un mercato e la ripartizione delle rendite
monopolistiche fra capitale e lavoro, condizioni che vengono
influenzate da fattori istituzionali come il grado di statalizzazione
dell’economia, la presenza e forza di altre forze sociali, l’esistenza di
un mercato unico sovranazionale, etc.
In ultimo, va notato come la quota del lavoro abbia una tendenza
anticiclica, cresce quando l’economia segue un trend recessivo.
Questa proprietà è presto spiegata notando come, durante una fase
recessiva, il denominatore del rapporto che costituisce la quota del
lavoro, ovvero il valore aggiunto prodotto nell’economia, diminuisca,
facendo aumentare il valore della frazione; al contempo, nel breve
periodo, il costo del lavoro non diminuisce perché le imprese non
riescono ad adeguare la forza lavoro impiegata alla diminuita
produzione altrettanto velocemente. Nel lungo periodo, tuttavia, la
quota lavoro ritorna ai valori precedenti la recessione; ovviamente,
vale il viceversa in caso di fasi espansive dell’economia.
Il grafico seguente, tratto dall’articolo, mostra l’andamento negli
ultimi sessanta anni delle quote distributive, la quota del lavoro
(misurata al costo dei fattori), la quota dei profitti e la quota delle
11 rendite immobiliari, che indicano rispettivamente quanto del PIL va
ai profitti e alle rendite da locazione di immobili (Torrini, 2010).
Notiamo come la quota delle rendite abbia seguito un trend
crescente durante tutto il periodo d’interesse mentre la quota dei
profitti sia scesa di livello dal 1950 fino al 1985, proprio mentre
quella del lavoro aumentava.
Viene effettuato anche un confronto fra la quota del lavoro che
include solo lavoratori dipendenti con la quota calcolata inserendo
nel computo anche gli autonomi (utilizzando per loro la retribuzione
media dei dipendenti): a parte un peggioramento più marcato negli
anni ottanta del valore calcolato con solo lavoratori dipendenti,
dovuto
presumibilmente
all’aumento
dell’incidenza
del
lavoro
autonomo, il livello delle due quote segue un andamento quasi
identico, un risultato confermato in un grafico proposto da Zanella
(2011).
Che cosa ha determinato questa precisa evoluzione della quota del
lavoro nell’ultimo quarantennio?
12 La crescita della quota negli anni settanta è stata determinata,
come detto in precedenza, da una rapida espansione dei salari,
diffusa in buona parte dei paesi dell’Europa occidentale, che ha
innalzato improvvisamente il costo del lavoro, gonfiando la quota
corrispettiva sul PIL, a tutto svantaggio di quella dei profitti. Solo in
un secondo momento, le imprese hanno adeguato la domanda di
lavoro ai nuovo salari maggiorati, contenendo l’espansione della
labor share, e cercando di sostituire il fattore lavoro con il capitale.
Secondo alcuni studiosi, il solo aggiustamento dell’utilizzo del lavoro
messo in atto dalle imprese a seguito dello shock salariale non
basta a spiegare la rapida espansione ed il successivo crollo della
quota del lavoro durante gli anni ottanta. Probabilmente, gli estesi
processi di liberalizzazione, attuati da molti governi di paesi
occidentali in quegli anni nel tentativo di ridurre gli ingenti debiti
pubblici, hanno contribuito alla diminuzione notevole della quota del
lavoro. Inoltre, gli anni ottanta sono stati testimoni di un aumento
importante del rendimento medio del capitale a livello mondiale,
fattore che indubbiamente ha contribuito alla sostituzione del
fattore lavoro con quello capitale.
E’ interessante notare che, quando la quota del lavoro è cresciuta,
sia per un aumento del salario reale, sia per un aumento
dell’occupazione, la quota dei profitti si è ridotta in un primo
momento, a testimonianza di una diminuzione della redditività delle
imprese; una volta operata da queste ultime una riconfigurazione
del costo del lavoro tramite una diminuita domanda di lavoro, i
profitti sono tornati a crescere, e così la quota.
In chiusura, viene analizzato l’andamento della quota dei profitti
all’interno di alcuni settori specifici dell’economia, nella fattispecie il
manifatturiero, e lo mette a confronto prima con tutto il resto del
13 settore privato e in seguito con tre settori che hanno sperimentato
ingenti
misure
di
privatizzazione
durante
gli
anni
novanta,
l’energetico, i trasporti e le telecomunicazioni e l’intermediazione
finanziaria.
L’evoluzione della quota dei profitti nel manifatturiero ha seguito
pressappoco lo stesso andamento del resto del settore privato,
seppure le oscillazioni del primo siano state molto più marcate.
Il
grafico
seguente
invece
mostra
la
quota
dei
profitti
nel
manifatturiero e nei tre settori privatizzati presi in esame, ponendo
come anno base il 1990.
Si nota subito come dal 1992 la quota dei profitti sia cresciuta in
maniera
importante
nei
settori
privatizzati,
mentre
nel
manifatturiero aumentava debolmente per poi ristagnare.
In questi settori, il passaggio della proprietà da pubblica a privata
ha
attuato
un
processo
di
riconfigurazione
delle
rendite
monopolistiche prima presenti, che garantivano profili salariali
14 innaturalmente
alti
ai
lavoratori
e
determinavano
livelli
di
produttività inferiori rispetto ad altri comparti del privato.
Dopo la privatizzazione, il contenimento del costo del lavoro e
l’aumento della produttività media hanno determinato l’aumento
della quota dei profitti osservato sopra.
Riassumendo: la convinzione che la quota del lavoro rimanga
costante nel tempo è stata messa in discussione da variazioni di
livello della quota stessa su un periodo di tempo piuttosto esteso,
oscillazioni riconducibili sia a variazioni nelle componenti della quota
(profili salariali) sia a fattori istituzionali esterni (programmi di
privatizzazione
e
ristrutturazione
di
settori
dell’economia
statalizzati).
2.2. Profili salariali: dinamica e distribuzione
Un’altra componente della quota del lavoro che va analizzata è il
salario unitario reale dei lavoratori. Tralasciamo per il momento le
questioni riguardanti l’occupazione e la forza lavoro.
La
Banca
d’Italia
concentrandosi
su
ha
un
trattato
il
fenomeno
tema
negli
resosi
più
anni
che
passati,
evidente
recentemente, il divario generazionale che si è creato nell’ultimo
trentennio nei profili salariali dei lavoratori (Rosolia e Torrini, 2007).
I fattori più importanti che influenzano l’evoluzione dei salari lungo
la vita lavorativa degli individui sono la crescita della produttività di
tutta l’economia e l’accumulo di esperienza lavorativa (Rosolia e
Torrini, 2007).
15 L’oggetto di ricerca dell’articolo in esame è il “generation gap” che si
è venuto a creare fra le diverse coorti di lavoratori che sono entrati
nel mercato del lavoro italiano, sin dalla fine degli anni settanta.
Sulle basi dei dati INPS sulle retribuzioni di circa 70.000 lavoratori
del settore privato non agricolo, gli autori analizzano l’evoluzione
dei salari di partenza e dei profili salariali dei lavoratori italiani sul
periodo 1975-2004, non disponendo tuttavia di dati sulla “quantità”
d’istruzione
ricevuta
dai
lavoratori;
questo
sarebbe
un
dato
interessante da includere, visto l’aumento importante nel periodo di
studio del numero di lavoratori in possesso di un diploma di scuola
superiore o di un titolo superiore.
Nel periodo d’interesse, si può assistere ad un costante aumento del
salario ingresso dei lavoratori di età 21-22 (presumibilmente in
possesso soltanto del diploma) fino al 1992, anno dal quale è
cominciato un deterioramento mai interrotto.
Un’osservazione analoga può essere fatta per le coorti di lavoratori
di età di 25-26 anni (si suppone già laureati): crescita più o meno
costante fino al 1992 e poi ristagno se non diminuzione fino al 2004
Si potrebbe ragionare che un deterioramento di questo tipo possa
essere stato bilanciato nel tempo da profili salariali più “rigidi”, ossia
caratterizzati da una crescita della retribuzione rispetto all’età
lavorativa più veloce di prima.
Così non è stato: ad una prima occhiata, si nota come le coorti di
lavoratori più giovani abbiano profili salariali più “piatti” di altre
coorti inseritesi nel mondo del lavoro prima. Guardando con più
attenzione,
si
nota
pure
come
questo
peggioramento
abbia
interessato solo chi cominciava a lavorare per la prima volta in quel
periodo, la seconda metà degli anni novanta: i lavoratori più anziani
non hanno sperimentato nessuna caduta importante dei salari.
16 L’analisi econometrica effettuata dagli autori con variabili di
controllo per l’età, il periodo e la coorte conferma i risultati di una
prima analisi visiva.
Gli autori affermano quindi che dopo un periodo di crescita durato
fino ai primi anni novanta, i salari iniziali hanno subito un tracollo,
arrivando a perdere fino al 12% rispetto alla prima coorte del
periodo analizzato e fino al 20% rispetto alle coorti di fine anni
ottanta (Rosolia e Torrini, 2007).
Da cosa è stato determinato questo considerevole peggioramento?
Vengono proposte tre linee di interpretazione, che si basano
rispettivamente su problemi di selezione avversa, su fattori sociodemografici e su interazioni di domanda ed offerta di lavoro.
La prima spiegazione mette in relazione alcune riforme del mercato
del lavoro dei primi anni novanta che hanno aumentato il grado di
flessibilità nel processo di assunzione con l’ingresso nel mondo del
lavoro di individui sotto qualificati, a cui veniva attribuito un salario
modesto proprio per la loro mediocre preparazione. L’ingresso di un
ingente numero di lavoratori meno qualificati avrebbe dovuto
diminuire il salario medio d’ingresso ed aumentarne la dispersione.
Seppur il primo dato sia indiscutibile (è infatti l’oggetto dello
studio), il secondo non viene confermato dalle statistiche, motivo
per cui questa linea d’interpretazione non è sostenibile.
La seconda si basa invece su caratteristiche come l’età anagrafica e
lavorativa, il livello d’educazione ed una serie di variabili sociodemografiche come lo stato civile, il numero di componenti del
nucleo famigliare, il numero di percettori di reddito, la residenza, la
dimensione della città, etc.
Viene subito rilevato come il peggioramento dei salari iniziali degli
anni novanta sia conciso con un aumento dell’istruzione dei
17 lavoratori che si immettevano per la prima volta nel mondo del
lavoro, in linea di massima quindi più efficienti delle coorti
precedenti.
Attraverso una regressione econometrica basata su dati più
completi della Banca d’Italia, gli autori dimostrano come il declino
dei salari iniziali sia robusto rispetto ai parametri elencati sopra, e
come queste caratteristiche possano essere ottimi proxy per valori
inosservabili (vedi abilità).
La terza ed ultima traccia d’interpretazione ragiona sull’offerta
relativa di lavoro ed in particolare sull’offerta di lavoratori con
almeno un diploma di scuola superiore, ipotizzando che un aumento
troppo
marcato
dell’offerta
di
questi
ultimi
non
sia
stato
accompagnato da una domanda adeguata, diminuendo il salario
medio.
Tuttavia un’altra analisi econometrica rifiuta anche questa tesi
d’interpretazione.
Vedendo la grande incidenza che i contratti di lavoro a termine
hanno assunto in Italia nell’ultimo quindicennio, in particolar modo,
presso i lavoratori giovani, rimane il dubbio che questa evoluzione
del mercato del lavoro non possa spiegare il deterioramento dei
salari d’ingresso dei lavoratori.
Lo studio ragiona su dinamiche di domanda e offerta di lavoro e
dell’ingresso di lavoratori poco qualificati che avrebbero potuto
abbassare il salario d’equilibrio.
Quello che potrebbe essere successo, invece, è una creazione
progressiva di automatismi nell’attribuzione di contratti a termine a
lavoratori giovani, collegati a retribuzioni modeste, modalità di
impiego a tempo ridotto che venivano scelte per trovare spazio in
un mercato del lavoro sempre più rigido.
18 In presenza di queste tipologie di occupazione, non c’è spazio per
accumulare esperienza (“expertise”) nel lavoro che si svolge, perché
il sistema di impiego non permette al lavoratore di restare il tempo
sufficiente in una posizione per sviluppare economie d’esperienza.
Con il diffondersi del lavoro a termine, la capacità di sviluppare
conoscenza e capitale umano nel tempo, che è positivamente
associata a profili salariali “ripidi” ed a maggiore forza contrattuale,
si è andata indebolendo progressivamente, in particolar modo fra i
lavoratori giovani.
Questa spiegazione del fenomeno richiederebbe ulteriori studi per
provarne la bontà ma resta comunque uno spunto interessante di
riflessione.
In conclusione, gli autori indicano fattori istituzionali come possibili
cause di questo deterioramento dei salari, in particolare la rigidità
del mercato del lavoro italiano. In un contesto ipotetico dove le
retribuzioni dei lavoratori più giovani sono flessibili al ribasso (come
quello italiano), uno stimolo negativo all’economia, invece di
aumentare la disoccupazione giovanile, non farebbe altro che
modificare al ribasso soltanto i salari dei lavoratori giovani, data la
natura duplice del mercato del lavoro, appunto l’esistenza di un gap
generazionale. Di nuovo, la rigidità del mercato del lavoro italiano
ha sicuramente giocato una parte importante nella creazione di un
gap generazionale, ma resta comunque l’impressione che siano
state le evoluzioni al suo interno (vedi incidenza lavoro a tempo
ridotto) più che la natura stessa a contribuire maggiormente.
In presenza di una crescita costante dei salari, questo gap
generazionale sarebbe un problema meno preoccupante, ma come
sappiamo da Torrini (2010) la produttività del lavoro in Italia è
stagnante se non in declino da quindici anni e cosi anche i salari
19 medi reali (Bassanetti et al. (2005), Torrini (2005)) rendendo
l’esistenza di questo divario un problema serio per la crescita del
mercato del lavoro italiano.
Passiamo adesso ad un altro lavoro pubblicato su Politica Economica
la scorsa estate che studia il percorso evolutivo seguito dalle
retribuzioni in Italia negli ultimi 25 anni ad opera di A. Rosolia
(2010).
L’obiettivo di ricerca è analizzare la composizione e la distribuzione
dei salari dei lavoratori italiani, per come si è modificata nell’ultimo
quarto di secolo, date le trasformazioni che ha subito il nostro
mercato del lavoro. Come indica Rosolia, “Tra il 1980 e il 2004 la
quota delle donne sul totale degli occupati dipendenti è passata dal
20 al 40 per cento” e “il numero di occupati stranieri residenti in
Italia è più che raddoppiato nel corso dell’ultimo quindicennio”, due
delle evoluzioni più evidenti del mercato. Ricordiamo anche che
l’ultimo decennio del secolo ha prodotto alcune riforme mirate ad
aumentare la flessibilità e l’elasticità dell’impiego in Italia, che
hanno determinato l’ingresso nel mondo del lavoro di individui le cui
qualificazioni, in mancanza di contratti a termine o a tempo ridotto,
non avrebbero consentito loro di trovare un impiego.
Lo studio è basato su i dati WHIP (Work Histories Italian Panel)
dell’INPS, un campione rappresentativo dei lavoratori presenti
nell’archivio dell’istituto, con circa 150.000 osservazioni all’anno e
dati su retribuzione complessiva lorda, periodo di versamento di
contributi durante l’anno, tipologia contrattuale ed orario di lavoro,
etc. Mancano dati sull’istruzione.
Il grafico seguente mostra come sia stata importante l’incidenza del
lavoro a tempo ridotto a partire dai primi anni novanta.
20 Oltre ad un indice della retribuzione per dipendente, la figura riporta
una misura della retribuzione settimanale, calcolata dividendo il
monte retributivo annuale per il numero di settimane lavorate e
correggendo quelle lavorate a tempo parziale con il fattore 5/8
(Rosolia,
2010).
l’andamento
delle
Questa
misura
retribuzioni
approssima
secondo
i
assai
conti
meglio
nazionali,
a
testimonianza della grande importanza assunta dal lavoro a termine
nell’ultimo ventennio in Italia.
Il dato dei salari espressi per dipendente, che non tiene quindi
conto del lavoro a tempo ridotto, comincia a peggiorare proprio in
corrispondenza del lancio delle riforme che hanno introdotto queste
nuove tipologie di contratto; la retribuzione settimanale ed il valore
dei conti nazionali espresso in ULA continua invece il suo trend
crescente cominciato nella seconda metà degli anni ottanta.
L’indice Gini per le retribuzioni annuali segnala un aumento della
disuguaglianza fino al 2004 circa seguito da un leggero calo;
prevedibilmente la crescita della dispersione è stata meno marcata
per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori maschi.
21 La disuguaglianza nel Sud e nelle isole, assai più alta che al Nord
all’inizio degli anni novanta, è diminuita fino ad assestarsi allo
stesso livello del Nord Italia.
Segue una serie di grafici che illustrano l’evoluzione dei differenziali
retributivi rispetto a variabili socio-demografiche come sesso,
nazionalità, età, etc.
I differenziali retributivi calcolati sia rispetto al dato annuale sia a
quello annualizzato (più robusto rispetto a situazioni di lavoro a
tempo ridotto) mostrano un divario costante al 40% fra uomini e
donne se calcolato annualmente, ma in grande diminuzione se
annualizzato, arrivando al 5% nel 2005.
Il dato calcolato per nazionalità indica un ampliamento del divario
retributivo fra italiani stranieri, sia per retribuzione annuale che
settimanale.
Come evidenziato da Rosolia e Torrini (2007), il divario retributivo
fra giovani e meno giovani si è ampliato nell’ultimo quindicennio,
una tendenza appena meno pronunciata nel caso di retribuzioni
annualizzate, a testimonianza dell’aumentata natura provvisoria
dell’occupazione giovanile, che potrebbe spiegare il peggioramento
del divario retributivo.
Il differenziale fra Nord e Sud d’Italia è rimasto più o meno
costante,
leggermente
meno
accentuato
per
retribuzioni
annualizzate, mentre il divario fra retribuzioni per i lavoratori
dell’industria e dei servizi è aumentato a vantaggio dei primi
utilizzando il dato annuale, mentre vede i secondi in una posizione
più favorevole se usiamo dati annualizzati, a testimonianza della
grande incidenza che il lavoro a tempo determinato ha assunto nel
settore dei servizi.
22 Ma come è cresciuta in questo periodo la distribuzione delle
retribuzioni? Elaborando i dati WHIP, Rosolia dimostra come dal
1986 al 2004 ci sia stata “una compressione della distribuzione delle
retribuzioni al di sotto della mediana, per effetto della crescita
maggiore di quelle al di sotto del 20° percentile, e un ampliamento
della dispersione delle retribuzioni sopra la mediana” (2010).
Questo equivale a dire che è cresciuta la quota di percettori di
redditi modesti, grazie all’ingresso sul mercato di molti lavoratori
stranieri, ed è aumentata la disuguaglianza fra chi riceve redditi più
alti, in parte grazie alla crescita dei percentili più elevati al Nord.
Se
integriamo
i
dati
di
un
rapporto
del
2008
dell’OECD
sull’ineguaglianza, vediamo però come quest’ultima sia cresciuta in
maniera preoccupante in Italia dai primi anni novanta ad oggi,
posizionando ad un livello assai più alto della media dei paesi OECD
(OECD, 2008).
Altro dato significante è che la ricchezza sia distribuita in maniera
ancora più ineguale del reddito: il 10% più ricco del paese detiene il
42% della ricchezza totale mentre il decile più alto dei percettori di
reddito detiene il 28% del reddito disponibile totale.
In definitiva, la caduta delle retribuzioni pro-capite in Italia
nell’ultimo quindicennio viene spiegata in gran parte dal diffondersi
dell’occupazione a tempo determinato, che ha aumentato la
frammentarietà dell’impiego. Il dato della retribuzione unitaria, che
incorpora bene questi cambiamenti istituzionali nel mercato del
lavoro, indica, infatti, una sostanziale stazionarietà dei salari in
Italia.
Tuttavia, il mercato del lavoro italiano è stato interessato da grandi
cambiamenti per quanto riguarda la composizione della forza
23 lavoro, che è mutata rispetto a parametri come sesso, provenienza
geografica, nazionalità, etc.
2.3. Breve sunto del dibattito sulla quota
Dopo aver analizzato il fenomeno della quota del lavoro tramite la
letteratura economica che lo ha trattato di recente, passiamo al
dibattito vero e proprio.
Avevamo
accennato
prima
alla
discussione
nata
dopo
la
pubblicazione della Lettera degli Economisti e di un post di Giulio
Zanella fra quest’ultimo ed Antonella Stirati, sviluppatosi sotto
forma
di
botta
e
risposta
pubblicati
rispettivamente
su
NoiseFromAmerika (NFA) e Economia e Politica fra Giugno 2010 e
Maggio 2011.
Vediamo di farne un breve riassunto.
In risposta alla Lettera, Zanella pubblica un post dal titolo “Gli
economisti e i fatti” (Zanella, 2010). Dopo una “breve premessa
metodologica” in cui illustra il metodo di ricerca degli studiosi delle
scienze sociali, passa ai fatti economici alla base della spiegazione
della crisi secondo i firmatari della Lettera: produttività del lavoro
crescente e capacità di spesa insufficiente, quest’ultima determinata
da reddito disponibile stagnante se non decrescente.
Come sono collegati i due dati?
Usando dati Eurostat, dove la quota del lavoro è calcolata al netto di
imposte e contributi a carico del lavoratore ed include il solo lavoro
dipendente, si vede bene come questa sia stata in declino da metà
anni settanta circa fino al 2000; nell’ultimo decennio è invece
aumentata in Italia.
24 Contrariamente a quanto asserito dagli economisti nella Lettera, la
produttività del lavoro è ristagnante in Italia da circa 15 anni,
mentre è cresciuta nelle rimanenti economie occidentali, stando alle
statistiche OCSE, sicuramente attendibili. Un simile risultato viene
anche
proposto
da
Perri
(2010),
riguardo
l’andamento
della
produttività in Italia.
La capacità di consumo dei lavoratori dipendenti è cresciuta in
maniera proporzionale alla produzione interna in buona parte dei
paesi occidentali, e meno che proporzionalmente in Italia, dove
invece i salari sono cresciuti in maniera più che proporzionale
rispetto alla produttività del lavoro.
È innegabile che la quota del lavoro sia diminuita nel nostro paese
negli ultimi trenta anni; come mai?
Altre quote distributive del prodotto sono la “capital share”, che
include i redditi percepiti tramite rendite su asset immobiliari,
finanziari, profitti ed interessi, e la “government share”, quella parte
di PIL che viene trattenuta dal governo sotto forma di imposte e
tasse su produzione ed importazioni, al netto dei trasferimenti.
La prima è storicamente molto alta in Italia e non è variata di molto
nell’ultimo trentennio, a testimonianza della grande incidenza nel
nostro paese del lavoro autonomo, che contribuisce al computo
della capital share. Vale la pena notare come un livello basso di
capital share sia indice di un alto tasso di concorrenza all’interno di
un’economia; non è una sorpresa che gli USA abbiano un livello
molto modesto di capitale share.
Secondo Zanella però la diminuzione della quota del prodotto che va
ai lavoratori è avvenuta in Italia a tutto vantaggio della government
share, in parole povere sono stati i nostri governi ad espropriare i
25 lavoratori dipendenti di una parte sempre più grande del loro
reddito.
Il grafico seguente mostra l’aumento vertiginoso seguito dalla
government share negli ultimi 25 anni.
La tesi della Lettera degli Economisti viene completamente rigettata
e la cura proposta da questi ultimi (più intervento statale) viene
bocciata in pieno.
A questa critica cosi totale è seguita una risposta da parte di
Antonella Stirati, una delle firmatarie della Lettera, su Economia e
Politica, pubblicata nel novembre 2010 (Stirati, 2010).
Stirati critica il metodo di computo della quota del lavoro di Zanella,
che aveva tralasciato nel calcolo i lavoratori non dipendenti, ossia
gli autonomi.
Secondo la Stirati, il mancato inserimento dei lavoratori autonomi
falsa completamente il risultato, specialmente in virtù della grande
26 quota di lavoratori autonomi presenti in Italia, i cui redditi
afferiscono sia al fattore lavoro che a quello capitale.
Oltretutto, la procedura utilizzata da Zanella devia da quella
standard utilizzata in letteratura che, come abbiamo visto in Torrini
(2010), consiste nell’includere i lavoratori autonomi nel computo
della quota, attribuendo loro una retribuzione pari a quella media
del lavoro dipendente comprensiva di imposte e contributi.
Includendo anche i lavori autonomi, si ottengono per tutti i paesi
valori della quota assai più alti di quelli proposti da Zanella, anche
se, nel periodo in esame, il rapporto lavoro dipendente/lavoro
autonomo sia diminuito (Stirati, 2010).
La conclusione più in netto contrasto con il contenuto della lettera,
quella che voleva spiegare la diminuzione della quota del lavoro con
un aumento notevole della government share, viene rifiutata
modificando di nuovo il calcolo della labor share, utilizzando questa
volta il PIL al costo dei fattori, come del resto è prassi comune in
letteratura, separando così la dinamica dell’imposizione fiscale da
quella della produzione interna.
Come abbiamo visto in Torrini (2010), la quota del lavoro calcolata
con il PIL al costo dei fattori incorpora i contributi e le imposte
indirette che costituiscono, nella definizione di Zanella (2010), la
government share. Anche se calcolata in questa maniera, la quota
scende di circa il 10 % per l’Italia nel periodo osservato ed è
comunque diminuita per quasi tutti i paesi d’interesse.
In sostanza, Stirati rigetta le conclusioni del posto di Zanella
semplicemente rifacendosi ai metodi di calcolo della quota che sono
prassi consolidata in letteratura. Va notato come tace quasi
completamente sull’andamento della produttività del lavoro.
27 A questo post Zanella ha risposto nel gennaio 2011 con un altro
intervento su NFA in cui rispondeva alle critiche mossegli da Stirati.
Zanella obietta che la sua mancata inclusione del lavoro autonomo
sia stata compiuta con piena consapevolezza delle problematicità
che comporta, ma convinto che includerla avrebbe creati errori di
stima ancora più gravi. Infatti il reddito dei lavoratori autonomi,
anche noto come reddito misto, è sia reddito da lavoro che da
capitale e non è possibile operare una scomposizione chiara e
precisa: le due pratiche che Zanella illustra, quella afferente al Real
Business Cycle, e quella di attribuire la retribuzione media del
lavoro dipendente, sono secondo l’autore difettose per motivi
diversi.
Per togliersi dall’imbarazzo, Zanella decide di non includere il lavoro
dipendente nella convinzione che quando, nella lettera degli
economisti, si mostrava preoccupazione per la diminuzione dei
redditi da lavoro, l’attenzione era rivolta principalmente ai lavoratori
dipendenti
perché
sono
questi
ultimi
ad
“avere
un'elevata
propensione al consumo e quindi a rendere la "domanda effettiva"
dipendente dalla quota dei redditi da lavoro in un modello
keynesiano” (Zanella, 2010).
Alla
seconda
obiezione
mossa
da
Stirati,
Zanella
risponde
rivendicando l’utilizzo del PIL ai prezzi di mercato, sulla base del
fatto che le imposte indirette non sono appendici statiche che
vengono “attaccate” al bene prodotto ma sono parte integrante del
valore del bene, nella fattispecie quella parte che viene appropriata
dallo stato, lasciando il resto come retribuzioni ai fattori di
produzione. Serve dunque un dato che includa sia il valore aggiunto
dei beni prodotti sia la compensazione sotto forma di imposta che lo
stato richiede dai questi beni, e in ultima analisi rientra davvero nel
28 valore del bene perché incorporato nel prezzo finale che il
consumatore paga. Questo dato è appunto il PIL al prezzo dei
fattori.
Zanella propone un paio di grafici dove calcola l’andamento della
quota del lavoro con o senza inclusione di lavoratori autonomi e
utilizzando sia il PIL al prezzo di mercato che il PIL al costo dei
fattori.
In quello sotto vediamo come la diminuzione della quota sia coincisa
con un aumento delle imposte nette su produzione ed importazioni,
a sostegno della tesi che vede i punti persi dalla quota del lavoro
nel quarantennio “sottratti” dalla government share, ossia dallo
stato.
A questo post segue la risposta di Stirati, pubblicata nel giugno
2011 su Economia e Politica che (per il momento) chiude la
discussione (Stirati, 2011).
29 In un breve post, l’autrice richiama il dibattito nato sull’andamento
della quota e difende le sue scelte di calcolo aggiungendo nuove
motivazioni.
La quota corretta che include il lavoro autonomo va utilizzata
perché, se non lo si facesse, escludendo gli autonomi, si avrebbe a
che fare con due variabili e non più una: il rapporto tra salario e
prodotto medio per lavoratore ed il rapporto tra lavoro dipendente e
occupazione totale.
Come sappiamo da Torrini (2004) l’incidenza del lavoro dipendente
è aumentata notevolmente negli ultimi 30 anni in quasi tutti i paesi
occidentali, ed un simile fenomeno pregiudica indubbiamente la
precisione della stima della quota se i lavoratori autonomi sono
tralasciati dal computo della forza lavoro; la crescita del rapporto
lavoro dipendente/lavoro autonomo diminuisce in entità la caduta
osservata dalla labor share e falsa il risultato finale.
Infine, Stirati fa notare le complicazioni che nascono dall’utilizzo dal
PIL al prezzo di mercato spiegando come le imposte indirette, che
entrano in questa definizione, in quanto parte del PIL, posso
“gonfiarne” artificialmente il valore: a parità di redditi distribuiti, un
aumento delle imposte indirette aumenta di pari importo il valore
del prodotto interno lordo, ma non questo non corrisponde con un
aumento della ricchezza del paese, tuttalpiù una diminuzione del
reddito disponibile dei contribuenti.
Onde evitare complicazioni contabili, è bene utilizzare sempre il PIL
calcolato al costo dei fattori, che, essendo al netto di imposte e
sussidi, è un dato più facilmente interpretabile.
3. Che cosa è successo veramente?
30 3.1. Disamina delle varie posizioni
Cerchiamo adesso di fare un po’ di chiarezza sulle varie posizioni e
su cosa sia successo veramente alla quota del lavoro negli ultimi
quarant’anni.
L’analisi di Torrini (2010) sulla labor share è stata compiuta
utilizzando il PIL al costo dei fattori e includendo il lavoro autonomo,
attribuendo a ogni lavoratore il reddito medio del lavoro dipendente,
metodi di calcolo standard in letteratura.
Il suo studio riporta dei risultati analoghi a quelli su cui è fondata la
Lettera degli Economisti: dopo un aumento negli anni settanta,
dovuta alla crescita dei salari, la quota ha seguito un trend
decrescente per i due decenni successivi, per attestarsi a livelli
modesti a fine secolo. Dal 2000 in poi, la quota del lavoro è
ricominciata a salire, complice una produttività del lavoro stagnante
unita ad una crescita dell’occupazione (Torrini, 2010).
La tendenza crescente della quota nell’ultimo decennio è stata
confermata anche in un recente studio della Banca d’Italia (2011),
secondo cui, fra il 2002 ed il 2010, la quota del lavoro, calcolata
nello stesso modo di Torrini (2010), ha subito un aumento del
2.6%.
La relazione è stata richiamata da Zanella (2011) in un ultimo post
riguardante l’andamento della quota del lavoro. Zanella ragiona
sulla solidità dell’impianto teorico della lettera degli economisti, che
voleva spiegare lo scoppio della crisi del 2007-2010 con una
diminuzione importante dei redditi dei lavoratori dipendenti ed un
conseguente decremento dei consumi e della domanda aggregata.
31 La relazione della Banca d’Italia conferma ufficialmente l’aumento
della
quota
del
lavoro
nell’ultimo
decennio
e
pregiudica
pesantemente la solidità della tesi della lettera degli economisti: le
retribuzioni dei lavori dipendenti non sono diminuite affatto ma la
disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è aumentata, da
un valore dell’indice Gini di 27,3 nel 1995 a 32 nel 2006 (CIA
Factbook,
2011)
(valori
più
aggiornati
non
sono
purtroppo
disponibili).
La quota del lavoro è aumentata in Italia in corrispondenza di un
periodo di scarsa crescita del prodotto interno se non aperta
recessione, come nel 2009, quando ad un aumento della quota in
quasi tutti i settori, è coincisa una diminuzione del PIL del 5%.
La quota del lavoro è, infatti, un parametro anticiclico; in un periodo
di recessione come quello osservato nel 2008-2010, il suo valore
aumenta sempre perché diminuisce il denominatore del rapporto,
ossia il PIL prodotto nell’economia.
Diamo quindi per certo che la quota sia aumentata nell’ultimo
decennio e che, se la tesi principale della lettera degli economisti è
che la diminuzione dei redditi disponibili dei lavoratori ha causato la
crisi, questa vada rifiutata in toto.
Che cosa è successo prima dell’ultimo decennio?
I dati presentati da Torrini (2010) mostrano una riduzione durata
vent’anni della quota, terminata solo alla fine del secolo.
Questa riduzione è stata causata in parte da un lento processo di
aggiustamento della domanda di lavoro da parte delle imprese,
dopo che nel decennio precedente il costo del lavoro era aumentato
in misura importante. Oltre alla contrazione della quota causata da
questa dinamica di contrazione, i grandi processi di smantellamento
del welfare state, cominciati negli anni ottanta, hanno modificato la
32 distribuzione delle rendite tra lavoro e profitti nei settori privatizzati,
a tutto vantaggio dei profitti, contribuendo alla diminuzione della
labor share, come evidenziato da Torrini (2010).
Gli anni novanta sono stati testimoni di una nuova diminuzione della
quota del lavoro dovuta all’introduzione di riforme che hanno
aumentato la flessibilità e la provvisorietà dell’impiego in Italia,
aumentando la provvisorietà del rapporto di lavoro, come un
recente studio ha illustrato (Anastasia et al., 2011).
È opportuno segnalare come uno studio di Rosolia (2010) dimostri
che le retribuzioni durante l’ultimo decennio del secolo e fino ai
primi anni del nuovo abbiano avuto una tendenza duplice.
Le retribuzioni annuali seguono un trend decrescente a partire dal
1992 circa mentre le retribuzioni settimanali, calcolate tenendo
conto della possibilità di impiego a tempo ridotto, crescono fino al
2004.
A parità di livello retributivo, un’occupazione a termine contribuisce
meno di una a tempo pieno al calcolo della quota del lavoro,
semplicemente per durata inferiore in cui si percepisce uno
stipendio.
La crescente incidenza dell’impiego a tempo ridotto unito al profilo
decrescente seguito dalle retribuzioni in Italia ha indubbiamente
determinato la diminuzione della quota negli anni novanta e
l’aumento corrispondente della quota dei profitti, in seguito alla
contrazione del costo del lavoro determinata da questa tendenza di
moderazione salariale.
Come segnalano Marino e Torrini (2008), l’occupazione è aumentata
significativamente in Italia negli anni novanta, ma non abbastanza
da risollevare il valore della quota del lavoro.
33 Il fisco ha giocato un certo ruolo nella composizione del reddito
disponibile
dei
consumatori,
utilizzando
un
trattamento
preferenziale per i contribuenti con carichi familiari, la cui aliquota
media è addirittura diminuita. La restituzione del drenaggio fiscale
operato dallo stato ha visto di nuovo favoriti i lavoratori con famiglia
a carico, attribuendo loro detrazioni fiscali assai maggiori degli
individui senza carichi familiari.
Il carico fiscale complessivo non è aumentato però in maniera
sufficiente
da
sostenere
la
tesi
di
Zanella,
secondo
cui
la
diminuzione della quota del lavoro è avvenuta a vantaggio della
government share, la parte di prodotto costituito da imposte e
contributi. La crescita del carico fiscale per individui senza carichi,
infatti, è stata compensata dalla diminuzione di quello per i
contribuenti con famiglia a carico.
Nel lungo periodo, una diminuzione della quota del lavoro è
avvenuta in molti paesi occidentali ed il tentativo di Zanella di
dimostrare il contrario, per quanto rispettabile da un punto di vista
intellettuale, non è sostenibile. La lettera degli economisti, seppur
debole nella sua costruzione teorica e poco condivisibile nelle
proposte di intervento, segnala un fenomeno economico ormai
indiscutibile e che ha interessato larga parte del mondo occidentale.
Quello che ha causato la diminuzione negli ultimi trent’anni del
secolo prima e l’aumento nel decennio successivo della quota lavoro
è sostanzialmente una dinamica stagnante della produttività del
lavoro in Italia, assai al di sotto dei livelli europei, unita ad una
crescita della produzione altrettanto modesta.
Come giustamente segnala Perri (2011), in Italia la produttività non
cresce
da
quindici
anni
ed
attribuisce
la
causa
al
tipo
di
34 specializzazione della nostra economia, pregiudicata da un basso
livello di capitale per addetto e dalla dimensione ridotta delle
imprese.
E’ questa la ragione vera dietro l’andamento della labor share in
Italia
nell’ultimo
quindicennio,
la
dinamica
insufficiente
della
produttività e del PIL italiano, uniti ad un aumento dei salari non
giustificato da una crescita dell’economia adeguata.
L’incidenza sempre maggiore di tipologie di impiego a termine o a
tempo ridotto, ultimamente l’unica via di accesso al mondo del
lavoro per i lavoratori più giovani ha pregiudicato la capacità
contrattuale di quest’ultimi, e contribuito al rafforzamento di un gap
generazionale fra lavoratori giovani e meno giovani, a tutto
svantaggio dei primi (Rosolia e Torrini, 2007).
Questo fenomeno si è accompagnato ad un peggioramento dei
profili
salariali
di
questi
stessi
lavoratori,
che
preoccupa
ulteriormente in presenza di crescita stagnante, se non piena
decrescita, come nel caso italiano.
3.2. Conclusioni
Nel momento in cui questo documento è stato redatto, l’Italia è
stata al centro di attacchi speculativi fondati sui dubbi sulla
sostenibilità del suo ingente debito pubblico, e sulle aspettative di
crescite della sua economia.
Il governo è tutt’ora al lavoro sull’approvazione di una manovra
finanziaria per tagliare il debito, provvedimento di legge più volte
modificato nelle parti sostanziali nel corso dell’estate.
35 Non entrando nel merito della manovra, si vuole qui però segnalare
come sia fondamentale per la credibilità del paese e per la
sostenibilità del debito che il governo lanci provvedimenti atti a
rilanciare una crescita seria e duratura della sua economia, crescita
che il paese non sperimenta da almeno un decennio.
La crescita del paese va assicurata rilanciando la produttività del
lavoro italiano, l’unico intervento serio che può risollevare la
dinamica della quota del lavoro e garantire un aumento delle
retribuzioni collegato ad un reale aumento del valore delle risorse,
in questo caso il lavoro, da retribuire.
La crisi economica del 2007-2010 non è stata quasi sicuramente
causata da un’insufficienza del consumo espresso dai lavoratori, ma
non c’è dubbio che l’economia italiana non può essere rilanciata se
non si ravviva la dinamica del consumo da parte dei lavoratori, se
non si interviene per assicurare che la produttività del lavoro si
allinei a livelli europei.
36