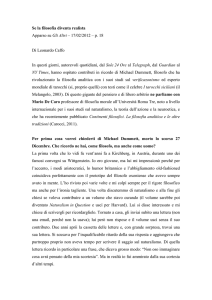MAURIZIO FERRARIS
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
Qualcuno trova paradossale che io sia approdato al realismo dopo aver
partecipato al Pensiero debole. In primo luogo, si potrebbe osservare che non
c’è nulla di paradossale che nell’arco di un trentennio si possano cambiare
le proprie idee (non dimentichiamoci che il Pensiero debole è del 1983). In
secondo luogo, non si è trattato di un capovolgimento totale, ma piuttosto
di un modo di precisare una medesima istanza che personalmente ho
sempre avvertito come prioritaria: non ricevere le filosofie come dogmi,
ma confrontarle con la realtà, appunto. In terzo luogo, come sottolineo nel
Manifesto, ma come è stato notato da molti, nel Pensiero debole ci sono
contributi tutt’altro che “debolisti” (si pensi a Eco e a Marconi), e la stessa
idea di “pensiero debole” è qualcosa di talmente indeterminato che l’accusa
di averla abbandonata appare di una paradossalità ancora più squisita di
quella che mi viene imputata.
Ma, lasciando da parte le questioni privatissime, c’è un problema più
importante, e davvero rilevante dal punto di vista teorico, di cui vorrei
parlare in questo scritto. Ed è questo: non credo che nel passaggio dal
postmoderno al realismo ci sia davvero un cambio di prospettiva, che so,
dall’incendiario al pompiere. Le cose vanno diversamente: aderire al
postmoderno, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta,
significava seguire un progetto di emancipazione radicale. Rifiutare il
postmoderno in nome del realismo, negli anni Novanta e in seguito, ha
significato continuare a seguire un progetto di emancipazione radicale,
proprio nella misura in cui, per contro, il postmoderno si era trasformato
in populismo. Cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”? Solo questo: la
piena consapevolezza di venire dopo il postmoderno, ossia di avere
attraversato (e sperabilmente superato) l’antirealismo prevalente nella
seconda metà del secolo scorso, tanto in area analitica quanto in area
continentale. In questo senso, i suoi tratti fondamentali sono tre, e sono
accomunati, piuttosto che da una critica liquidatoria dell’antirealismo, dal
tentativo di conservarne le istanze emancipative evitando gli effetti
indesiderati, e in particolare la curva entropica che ha portato il
Bollettino Filosofico 27 (2011-2012): 119-126
ISBN 978-88-548-6064-3
ISSN 1593-7178-00027
DOI 10.4399/97888548606438
119
120
Maurizio Ferraris
postmoderno a dire addio alla verità e a dichiarare guerra alla realtà,
attuando in modo indiscriminato il principio secondo cui “non ci sono fatti,
solo interpretazioni”: un rilancio della decostruzione aggiornato ai tempi;
una collocazione dell’ermeneutica in una sede propria; e una prospettiva di
filosofia cosmopolitica.
Decostruzione
Ha scritto Primo Levi in I sommersi e i salvati: «L’intera storia del breve
“Reich Millenario” può essere riletta come guerra contro la memoria,
falsificazione orwelliana della memoria, falsificazione della realtà,
negazione della realtà, fino alla fuga definitiva dalla realtà medesima». La
realtà non è semplicemente una categoria psicologica, è anzitutto un
elemento imprescindibile per l’etica e la politica. E non si dimentichi che
anche i sospettosi eroi del postmoderno che hanno insistito sul carattere
costruito della realtà lo facevano in nome della realtà e della verità. In fin
dei conti, se Nietzsche, Freud, Marx hanno scritto quello che hanno
scritto, è stato in nome della verità. Ma sotto questo profilo esiste davvero
una incidenza della filosofia sulla politica?
Credo che convenga incominciare proprio da qui. Prendiamo il caso di
Nietzsche, un grande del pensiero e insieme un perenne inciampo per la
filosofia. Molto probabilmente Hitler ha letto Nietzsche molto meno di
quanto non lo abbia letto Thomas Mann, che non è affatto diventato nazista
e anzi ha dovuto abbandonare la Germania mentre gli bruciavano i libri in
piazza. Le teorie di Nietzsche sono anche la elaborazione concettualmente
e stilisticamente sofisticata di una angoscia piccoloborghese che aveva tante
manifestazioni ideologiche in una miriade di giornalisti, agitatori politici,
opinionisti di varia natura, con cui Hitler entrò invece in contatto, e che
del resto aveva un così ampio ascolto proprio perché esprimeva uno stato
d’animo diffuso. Poi Hitler salì al potere, e a questo punto in tutte le
università tedesche si tennero corsi su Nietzsche. Nel riuso di regime pezzi
importanti della teoria di Nietzsche vennero scartati perché non funzionali
(ad esempio, non era antisemita, era tendenzialmente antistato, e aveva
bizzarre teorie come l’eterno ritorno), ma altri (il nichilismo, la volontà di
potenza, l’istinto gerarchico) lo erano perfettamente, prestandosi a una
fruizione selettiva che approfittava del prestigio di un grande filosofo
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
121
proprio come Hitler si era avvalso del prestigio di grandi generali come
Ludendorff e Hindenburg.
Venendo ai postmoderni, il caso mi sembra più singolare, appunto
perché non abbiamo a che fare con una fruizione selettiva, bensì con una
realizzazione perversa. Né Lyotard né Derrida si sarebbero mai
riconosciuti in Bush e in Berlusconi. Anzi, li hanno criticati esattamente
come i loro colleghi realisti Chomsky o il Putnam degli ultimi vent’anni.
Come è successo? Credo che dipenda dal fatto che i postmoderni erano di
sinistra, ma buona parte dei loro autori no: erano (sino alla caduta del
Muro, che comportò lo sdoganamento di Marx, diventato inoffensivo)
impolitici come Freud o conservatori come Nietzsche, Heidegger e
Schmitt, e in effetti è molto più facile adoperare il teorico della volontà di
potenza, il rettore di Friburgo nel ’33 e il giurista del Führer per sostenere
posizioni di destra piuttosto che di sinistra. Si possono fare tutte le capriole
ermeneutiche del mondo, ma se questi tre pensatori, peraltro ricchissimi e
affascinanti, erano di destra, un motivo ci sarà stato. Quanto ai populisti,
certo Karl Rove, il consigliere di Bush, non aveva bisogno di Baudrillard
per sostenere che l’amministrazione USA creava la realtà. Forse non lo
aveva mai letto e ne ignorava persino il nome. Ma sicuramente un
giornalista o un commentatore minimamente acculturato avrebbe potuto
sostenere che la dottrina di Rove non era una insopportabile apologia della
menzogna, ma era anzi in linea con le più avanzate (e left-wing) teorie
sociologiche e filosofiche.
Insomma, di certo la teoria della causalità diretta è insostenibile, perché
postula un meccanismo di contagio e una importanza dell’ideologia che è
tipica del mondo visto con gli occhiali da miope di noi professori. Secondo
me, invece, è sostenibilissima la tesi della giustificazione retrospettiva, che
però non è una cosa da poco, perché ha almeno due conseguenze. Una,
diretta ma forse meno importante, è la legittimazione pubblica: faccio
queste cose non perché mi conviene, ma perché fior di filosofi, oltretutto
della parte politicamente avversa, hanno scritto che è giusto fare così.
L’altra, indiretta e secondo me più importante, è la delegittimazione degli
avversari: con che strumenti la sinistra può criticare la destra se
quest’ultima è giustificata proprio dagli ideologi della sinistra?
Lo scopo fondamentale del nuovo realismo, così, è la possibilità di
recuperare gli argomenti per la critica, dopo la delegittimazione
postmoderna. La parola “critica” dovrebbe mettere in chiaro che se ci si
appella alla realtà non è per Realpolitik, ma, proprio al contrario, perché si
122
Maurizio Ferraris
tratta di non abbandonare la critica e la decostruzione, sebbene sotto altre
forme, adatte al mutato momento storico e non ridotte a una pura
scolastica. È sacrosanto decostruire: in natura non esistono i granduchi, i
padri-padroni e gli angeli del focolare, loro sono socialmente costruiti. Qui
ritrovo la mia generazione, e proprio per questo trovo singolare che ci sia
chi osserva, come se fosse una obiezione, che io stesso ero un seguace del
pensiero debole. È indubbiamente così, e quello che facevo allora lo faccio
adesso, cercando di non ripetere gli errori di decenni fa.
Ermeneutica
Quanto
all’ermeneutica.
Nella
“pretesa
di
universalità
dell’ermeneutica” di cui si parlava nel secolo scorso c’erano due cose che
non andavano, a mio parere. La prima era, appunto, l’idea che ci fosse
ermeneutica in ogni momento dell’esistenza. La seconda era, invece, che
questa ermeneutica universale fosse qualcosa a cui avesse uno specifico
accesso soltanto il filosofo. Spesso i profani pensavano che gli ermeneutici
avessero speciali tecniche di interpretazione, ignote al resto del mondo.
Non era così. Di interpretazione ne sapevano come il resto del mondo,
magari anche meno, e il plus filosofico consisteva semplicemente nel dire
che dovunque, anche quando non ce lo si aspetta, c’è interpretazione.
Ciò detto, nessun realista nega l’importanza dell’ermeneutica nelle
pratiche sociali e conoscitive. Quello che appare inaccettabile è la
formulazione di Nietzsche “Non ci sono fatti, solo interpretazioni”. Perché
anche qui, sulle prime appare come una grande promessa di
emancipazione, l’idea di una umanità che si libera dalle ombre della
caverna platonica, dai falsi idoli e dalle illusioni. Ma poi si rivela per quello
che è, un perfetto strumento reazionario, la traduzione filosofeggiante e
scettica del “La ragione del più forte è sempre la migliore”, l’idea che chi
ha il potere, per ingiusto e disumano che sia, può imporre le sue
interpretazioni, con la forza dei suoi avvocati o dei suoi eserciti o dei suoi
soldi. Ci si immagini in un tribunale in cui, invece che “La legge è uguale
per tutti”, si trovasse scritto “Non ci sono fatti, solo interpretazioni”.
Come ci si sentirebbe? Molto peggio di Josef K, se si è onesti. Ma sono
sicuro che altri, i furbetti e i furfanti che popolano le cronache dei giornali,
o, soprattutto, i criminali di guerra di ogni tempo, si sentirebbero
sollevati.
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
123
Non dimentichiamolo: c’è un filo continuo che dal disprezzo dei fatti,
dal considerarli banali e modificabili, porta alla negazione dei fatti. “Non ci
sono fatti, solo interpretazioni” significa, se le parole hanno un senso, che
Auschwitz è solo una interpretazione. Anche senza giungere a posizioni
estreme, il costruzionismo comporta spesso delle estensioni indesiderate.
È per esempio molto facile che si confonda il “socialmente costruito” con il
“soggettivamente costruito”. Il che, ovviamente, è un errore. Non c’è
dubbio che l’economia e la politica siano costruzioni sociali, ma è
altrettanto indubbio che non dipende dalla volontà di un singolo soggetto
di trasformarle. Molto spesso la portata presuntamente rivoluzionaria
dell’ermeneutica è consistita proprio in questo: promettere una specie di
rivoluzione interiore, per cui un professore o un lettore o chicchessia,
interpretando, magari nella sua stanza e in totale sconnessione con
l’esterno, fosse un alfiere e un combattente dei tempi nuovi. Sartre aveva
detto che tra guidare un esercito e ubriacarsi in solitudine alla fine non c’è
differenza, e l’ermeneutica radicale sembra averlo preso in parola.
Ripeto: i realisti sanno bene che un pezzo importantissimo nel mondo,
e cioè la sfera sociale, non può darsi senza interpretazione, e che
l’interpretazione può essere ricerca della verità e non immaginazione al
potere. Il problema, semmai, e per restare all’endiadi della immaginazione
al potere, non è l’immaginazione, ma il potere, l’ossessione postmoderna
secondo cui non c’è verità, ma solo conflitto, interesse, prevalenza del più
forte, e che “interpretare” significhi essenzialmente scendere in guerra, o
quantomeno in campo. Ora, rifiutare questo uso aberrante della
interpretazione non vuol dire in alcun modo ridurla a immaginazione;
significa, al contrario, mostrare il nesso essenziale che l’interpretazione ha
con la verità e la realtà. L’argomento avanzato da qualcuno per cui il nuovo
realismo ridurrebbe l’interpretazione alla immaginazione, è, lui sì, un po’
troppo fantasioso, visto che gli oggetti sociali – un elemento centrale nella
ontologia realista – sono oggetti allo stesso titolo che gli oggetti naturali,
ma richiedono interpretazione.
E ovviamente realismo non è scientismo, una posizione in cui i realisti,
da Bilgrami a De Caro, da Gabriel a Bojanic, senza ovviamente dimenticare
Putnam o Eco, non si riconoscono affatto. Per quel che mi riguarda, la
prova macroscopica di questo è la differenza che ho proposto di tracciare
fra ontologia ed epistemologia, tra quello che c’è e quello che sappiamo a
proposito di quello che c’è. Il che non significa che la filosofia può rifiutare
le conquiste della scienza. Ma su questo i realisti vecchi e nuovi sono in
124
Maurizio Ferraris
buona compagnia: anche gli epistemologi anarchici cercano i migliori
medici. E, detto fra noi, fanno benissimo, non si vorrebbe mai che le loro
convinzioni filosofiche, se applicate con troppo scrupolo, li portassero a far
la fine di Don Ferrante, che dopo aver negato la peste perché non è né
sostanza né accidente si ammala e se ne va all’altro mondo maledicendo le
stelle come un eroe di Metastasio.
Globalizzazione
Un ultimo punto, al di là delle polemiche di retroguardia. Il nuovo
realismo è anche, guardando all’avvenire, la proposta di una filosofia
globalizzata. Mi spiego. A mio parere, la distinzione tra analitici e
continentali è essenzialmente una differenza tra pubblici della filosofia.
Difficilmente troverete un filosofo continentale intento a spaccare il
capello in quattro in un seminario di ricerca, e altrettanto difficilmente
troverete un filosofo analitico intento a parlare di grandi temi in un festival
filosofico, dove la stragrande maggioranza degli oratori è di formazione
continentale, più un certo numero di scienziati, psicoterapeuti e religiosi.
Questo, vorrei che fosse chiaro, non dice ancora nulla su una eventuale
superiorità degli analitici o dei continentali, non più di quanto la
constatazione della diversità dei pubblici di Boulez e dei Beatles possa
essere considerata un punto a favore dell’uno o degli altri. Abbiamo
semplicemente a che fare con delle circostanze storiche.
Perché gli analitici, espressione del sistema universitario angloamericano, di college raramente urbani e legati alla tradizione universitaria
medioevale, costituiscono una comunità coesa e un po’ monastica, dove le
persone dialogano tra loro con regole precise e a partire da un certo
numero di argomenti che cambiano col tempo ma sono quelli all’ordine
del giorno. Da questo punto di vista, la tradizione analitica non ha molto a
che fare con i media (sui giornali si parla pochissimo di filosofi, gli
americani sono sempre stupiti di come sono trattati da noi, per esempio),
ma è un media in se stesso, con una discreta rilevanza pubblica e
soprattutto con una netta predominanza rispetto ai continentali per quanto
riguarda il prestigio accademico. Anzi, questa rilevanza rischia di essere
crescente nel momento in cui le grandi università americane diffondono i
loro tutorial attraverso il mondo, trasformando di fatto le altre università
in Cepu più o meno grandi.
Che cosa c’è di nuovo nel “nuovo realismo”?
125
I continentali, invece, sono eredi piuttosto dei philosophes
dell’Illuminismo (quando sono chiari) e dei predicatori protestanti (quando
giocano sull’oscurità), ossia di intellettuali molto aperti allo spazio
pubblico, e i loro luoghi naturali di manifestazione sono i mass media. Da
questo punto di vista, vale la pena di osservare un punto. Dummett aveva
notato che Frege e Husserl, solitamente considerati come i capostipiti delle
due tradizioni di pensiero, non erano poi così distanti, un po’ come le
sorgenti del Reno e del Danubio. Certo, ma che cosa è cambiato, che cosa
ha approfondito il divario nei decenni successivi? Che cosa ha fatto sì che a
un certo punto le due tradizioni sembrassero lontane come le foci del Reno
e del Danubio? Essenzialmente, la crescente importanza dei media, che
hanno trovato un elemento di attrazione nella filosofia, e che hanno dato
spazio ai filosofi, con una ovvia preferenza per le formulazioni meno
esoteriche, e magari più provocatorie, d’accordo con il principio per cui la
notizia è sempre l’uomo che morde un cane, mai l’inverso. È qui che si è
creata la divaricazione tra i filosofi analitici (prevalentemente universitari)
e i filosofi continentali (prevalentemente mediatici).
Da tutto questo si possono imparare almeno due cose. La prima è che
non può esistere, da sola, una “filosofia pura”, iper-teoretica e astratta.
Non può esistere in una tradizione come quella italiana, che ha smantellato
per sempre i propri centri di eccellenza; ma non esiste nemmeno nel
mondo anglosassone, dove le esigenze di una filosofia più varia, facile,
provocatoria, politica e di immediata gratificazione sono state soddisfatte
giusto accanto alla filosofia, nei “cultural studies”, nei dipartimenti di
letteratura comparata, e simili. La seconda è che non può nemmeno
esistere, da sola, una “filosofia impura”, e non è nemmeno interessante.
Perché è vero che Aristotele se rinascesse oggi parlerebbe di soap operas;
ma parlerebbe anche di logica, di metafisica e di fisica quantistica. L’ideale
sarebbe quello di una filosofia capace di ricoprire tutti i ruoli, dalla filosofia
pura alla filosofia pop, senza dimenticare l’importanza della conoscenza
storica, e della cultura in generale. È possibile qualcosa del genere? E quali
sarebbero le condizioni perché ciò potesse avvenire?
Ecco perché la domanda che bisognerebbe porsi, a mio parere, è se la
tradizionale contrapposizione analitici/continentali possa ancora tenere, e
se non sia necessario piuttosto introdurre un terzo criterio, quello della
filosofia “globalizzata”. Di che cosa si tratta? Ai miei occhi questa filosofia
costitutivamente bilingue, cioè con produzioni in lingua nazionale e in
inglese, come tale oggettivamente più ricca del solo monolinguismo
126
Maurizio Ferraris
inglese, o della frammentazione delle sole lingue nazionali, potrebbe porsi
all’incrocio di tre elementi. 1. Una competenza scientifica, che nella
fattispecie di una disciplina con forte componente umanistica come la
filosofia, significa anche una competenza filologica e storica. A cui si dovrà
però aggiungere la competenza rispetto alle scienze (naturali e sociali) e a
temi di discussione quali il problema mente-corpo, l’ontologia del mondo
naturale, il problema dell’equa distribuzione dei beni materiali o la natura
dell’inconscio. 2. Una competenza teorica, dove l’elemento analitico (o più
propriamente accademico) fornisce la forma, mentre l’elemento
continentale (o più propriamente extra-accademico) fornisce i contenuti.
Se c’è un ambito in cui il detto “i concetti senza intuizione sono vuoti, le
intuizioni senza concetti sono cieche” si applica alla perfezione è proprio la
sfera dei rapporti analitico-continentali. 3. Una pertinenza pubblica. Le
persone sono disposte ad accettare un linguaggio tecnico o addirittura
incomprensibile se la contropartita è la cura del cancro. Ma questo non è
ciò che può offrire la filosofia. Dunque, fa intrinsecamente, e non
accidentalmente, parte della filosofia la capacità di rivolgersi a uno spazio
pubblico, consegnando a quello spazio risultati elaborati tecnicamente, ma
in forma linguisticamente accessibile.
Forse siamo in vista di una sintesi, dopo molti conflitti culturali e
scontri di civiltà che hanno caratterizzato l’incontro fra ambienti filosofici
diversi nel secolo scorso (su tutti, basterà considerare le vicende della
decostruzione in America). In una lingua che sarà l’inglese, o qualcosa del
genere, circoleranno dei contenuti fortemente ibridati (analitici,
continentali, di scienze cognitive, di storia della filosofia). Con ogni
probabilità ciò che chiamiamo, con quello che – ripeto – è una
terminologia radicalmente inadeguata, “filosofia analitica”, avrà una
prevalenza accademica (ossia tendenzialmente imporrà dei formati di
valutazione e di ranking, come in effetti sta già avvenendo), mentre la
“filosofia continentale” avrà una prevalenza pubblica. Ma non è affatto
detto che queste due anime non potranno convivere nelle stesse persone, o
quantomeno nella stessa università. Se questa circostanza dovesse
realizzarsi, come spero, si sarebbe forse superata l’incommensurabilità di
paradigmi, che ha spesso afflitto la filosofia. Non si darà più il caso del
filosofo X considerato un genio da certi e un imbecille da certi altri e –
apparendo improbabile che il filosofo X possa essere considerato un genio
da tutti – si perverrà almeno a un certo grado di consenso per cui il filosofo
X sarà considerato quasi universalmente un imbecille.