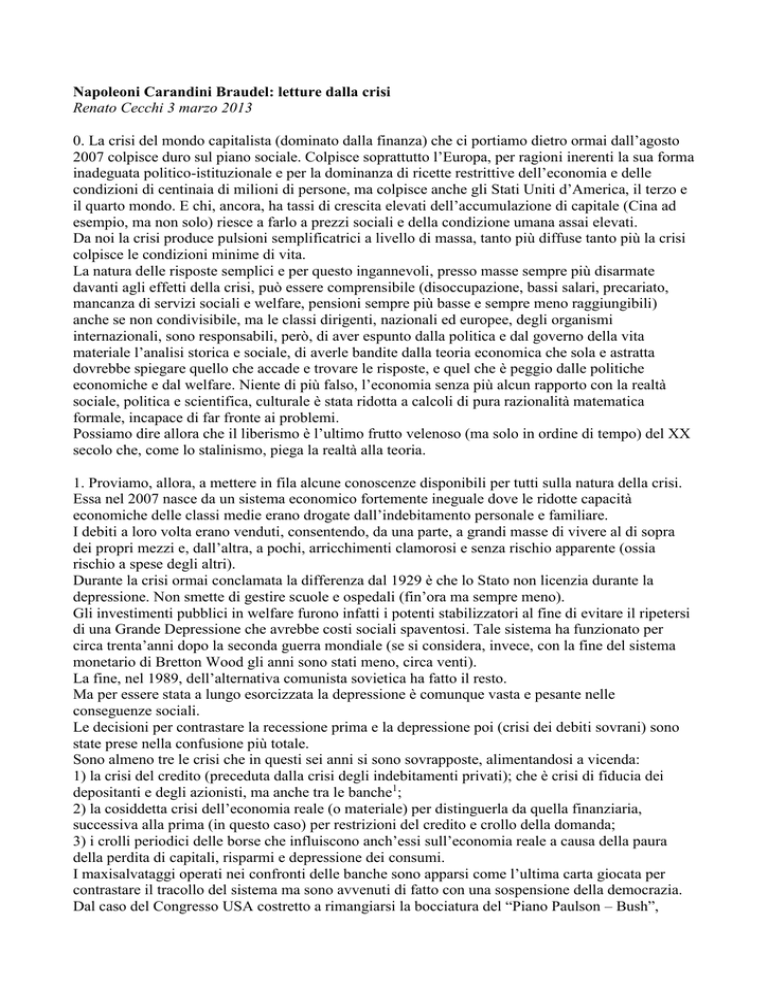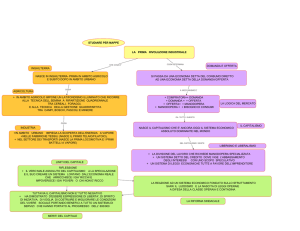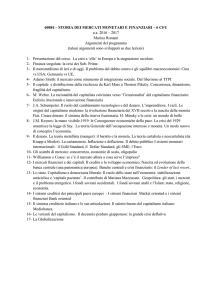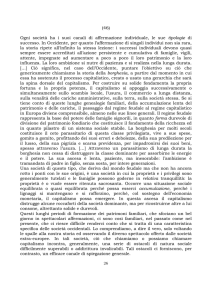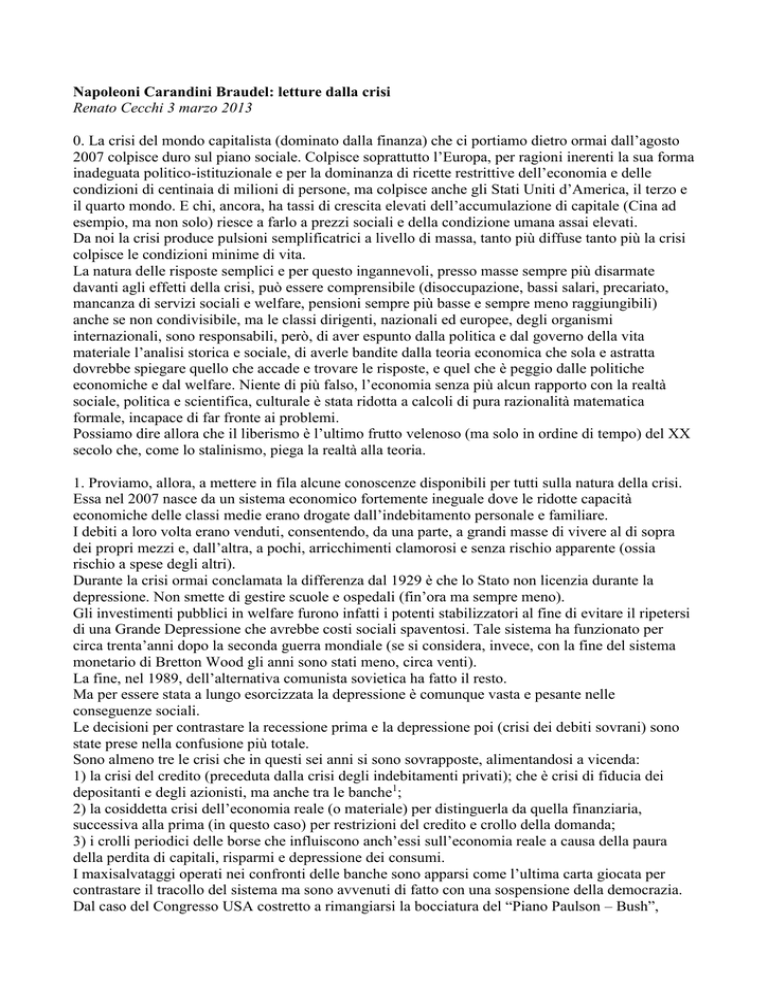
Napoleoni Carandini Braudel: letture dalla crisi
Renato Cecchi 3 marzo 2013
0. La crisi del mondo capitalista (dominato dalla finanza) che ci portiamo dietro ormai dall’agosto
2007 colpisce duro sul piano sociale. Colpisce soprattutto l’Europa, per ragioni inerenti la sua forma
inadeguata politico-istituzionale e per la dominanza di ricette restrittive dell’economia e delle
condizioni di centinaia di milioni di persone, ma colpisce anche gli Stati Uniti d’America, il terzo e
il quarto mondo. E chi, ancora, ha tassi di crescita elevati dell’accumulazione di capitale (Cina ad
esempio, ma non solo) riesce a farlo a prezzi sociali e della condizione umana assai elevati.
Da noi la crisi produce pulsioni semplificatrici a livello di massa, tanto più diffuse tanto più la crisi
colpisce le condizioni minime di vita.
La natura delle risposte semplici e per questo ingannevoli, presso masse sempre più disarmate
davanti agli effetti della crisi, può essere comprensibile (disoccupazione, bassi salari, precariato,
mancanza di servizi sociali e welfare, pensioni sempre più basse e sempre meno raggiungibili)
anche se non condivisibile, ma le classi dirigenti, nazionali ed europee, degli organismi
internazionali, sono responsabili, però, di aver espunto dalla politica e dal governo della vita
materiale l’analisi storica e sociale, di averle bandite dalla teoria economica che sola e astratta
dovrebbe spiegare quello che accade e trovare le risposte, e quel che è peggio dalle politiche
economiche e dal welfare. Niente di più falso, l’economia senza più alcun rapporto con la realtà
sociale, politica e scientifica, culturale è stata ridotta a calcoli di pura razionalità matematica
formale, incapace di far fronte ai problemi.
Possiamo dire allora che il liberismo è l’ultimo frutto velenoso (ma solo in ordine di tempo) del XX
secolo che, come lo stalinismo, piega la realtà alla teoria.
1. Proviamo, allora, a mettere in fila alcune conoscenze disponibili per tutti sulla natura della crisi.
Essa nel 2007 nasce da un sistema economico fortemente ineguale dove le ridotte capacità
economiche delle classi medie erano drogate dall’indebitamento personale e familiare.
I debiti a loro volta erano venduti, consentendo, da una parte, a grandi masse di vivere al di sopra
dei propri mezzi e, dall’altra, a pochi, arricchimenti clamorosi e senza rischio apparente (ossia
rischio a spese degli altri).
Durante la crisi ormai conclamata la differenza dal 1929 è che lo Stato non licenzia durante la
depressione. Non smette di gestire scuole e ospedali (fin’ora ma sempre meno).
Gli investimenti pubblici in welfare furono infatti i potenti stabilizzatori al fine di evitare il ripetersi
di una Grande Depressione che avrebbe costi sociali spaventosi. Tale sistema ha funzionato per
circa trenta’anni dopo la seconda guerra mondiale (se si considera, invece, con la fine del sistema
monetario di Bretton Wood gli anni sono stati meno, circa venti).
La fine, nel 1989, dell’alternativa comunista sovietica ha fatto il resto.
Ma per essere stata a lungo esorcizzata la depressione è comunque vasta e pesante nelle
conseguenze sociali.
Le decisioni per contrastare la recessione prima e la depressione poi (crisi dei debiti sovrani) sono
state prese nella confusione più totale.
Sono almeno tre le crisi che in questi sei anni si sono sovrapposte, alimentandosi a vicenda:
1) la crisi del credito (preceduta dalla crisi degli indebitamenti privati); che è crisi di fiducia dei
depositanti e degli azionisti, ma anche tra le banche1;
2) la cosiddetta crisi dell’economia reale (o materiale) per distinguerla da quella finanziaria,
successiva alla prima (in questo caso) per restrizioni del credito e crollo della domanda;
3) i crolli periodici delle borse che influiscono anch’essi sull’economia reale a causa della paura
della perdita di capitali, risparmi e depressione dei consumi.
I maxisalvataggi operati nei confronti delle banche sono apparsi come l’ultima carta giocata per
contrastare il tracollo del sistema ma sono avvenuti di fatto con una sospensione della democrazia.
Dal caso del Congresso USA costretto a rimangiarsi la bocciatura del “Piano Paulson – Bush”,
all’opacità dei vari conflitti di interesse non solo in concorso con le crisi ma anche caratteristici
delle risposte alla crisi.
Da questo contesto possono trarsi alcuni insegnamenti di merito e di metodo per l’analisi della
situazione presente e futura.
Primo: i mercati, sia pure in modo turbolento, si adattano alle situazioni, mentre i singoli attori
economici molto meno, hanno tempi di reazione più lenti. Consumatori e famiglie hanno
scarsissima capacità di adattamento.
Secondo: l’interdipendenza tra mercati amplifica gli squilibri sospingendoli verso impensabili
(prima) concatenazioni causali che sono presto fuori controllo.
Terzo: in un contesto di liberismo totale dei mercati le misure di salvaguardia degli stessi adottate
nell’emergenza, anche quando sembrano aver fatto tesoro degli errori passati, possono aggravare il
problema in quanto ad inadeguatezza e intempestività, anche riducendo la libertà politica ed
economica.
Quarto: l’azione dei governi nazionali e le politiche sovranazionale (es. Commissione Europea,
FMI, Ocse, ecc.) si concentrano su ciò che eufemisticamente viene chiamato “effetto di secondo
livello”, ossia gli aumenti salariali che i lavoratori potrebbero tentare di rivendicare per compensare
l’aumento dei prezzi, ovviamente per scoraggiarli e combatterli.
2. Facciamo ora un rapido confronto con la crisi speculativa del 1929 e con la successiva
depressione. J.K. Galbraith in “Il Grande crollo” ne individua le ragioni in cinque debolezze della
economia USA fondamentalmente malsana, non incidentalmente ma strutturalmente, su cui hanno
interagito le “bolle” speculative. Premettiamo che condividiamo l’analisi di G. Carandini, che la
speculazione è la ricerca del massimo profitto connaturata alla natura stessa dell’accumulazione
capitalista.
Esse sono:
1) la cattiva distribuzione del reddito (p.167)
2) la cattiva struttura societaria (pag. 168)
3) la cattiva struttura bancaria (pag. 169)
4) lo stato dubbio della bilancia dei pagamenti USA (pag. 170)
5) il misero stato dell’informazione economica (pag. 172).
Senza voler fare alcun parallelo tra le due crisi (quella del 1929 e quella del 2007) è utile però
cercare di rilevare gli elementi comuni e le diversità per una migliore orientamento alla
comprensione. Soprattutto che cosa sia, nella situazione attuale, che sta agendo come moltiplicatore
di una crisi innestata dall’indebitamento di massa in USA, dalle bolle immobiliari che di
quell’indebitamento sono la massa principale, dalle speculazioni dei fondi di investimento e degli
hedge found, la speculazione prima al rialzo e poi al ribasso dei titoli in particolare di quelli
pubblici. Crisi che ha però, come nel 1929, altre ragioni più profonde.
Vediamo allora quali esse possano essere:
a) la cattiva distribuzione del reddito;
b) la cattiva struttura e opacità degli intrecci societari e delle multinazionali;
c) la cattiva struttura bancaria dopo l’eliminazione della separazione fra banche di raccolta del
risparmio e istituti di investimento;
d) lo stato dubbio della bilancia dei pagamenti USA, ma in senso diverso dal 1929, con un
eccesso spropositato di debito da importazioni finanziato con il risparmio cinese;
e) debito pubblico incontrollato, ma non per investimenti, tenuto in piedi con il sostegno al
dollaro che gode ancora del privilegio di essere la moneta di riferimento, sorretto,
paradossalmente, ma non troppo, dalla Cina;
f) un eccesso di indebitamento privato delle famiglie;
g) ragioni che attengono al declino dell’impero, come ad esempio errori spaventosi nella lotta
al terrorismo che hanno consentito lo sviluppo di guerre cosiddette “asimmetriche” senza
soluzione, in varie parti del mondo;
h) la concomitanza della crisi ambientale (compreso il problema energetico), l’effetto serra, i
cambiamenti climatici accelerati, la crisi di sopravvivenza di tante specie animali e vegetali;
i) l’insieme di questi fatti da luogo ad un caos sistemico alla cui comprensione sono
assolutamente inadeguate le informazioni economiche e soprattutto gli strumenti di analisi
delle interrelazioni tra le condizioni economiche con quelle sociali ed ecologiche, politicoistituzionali;
j) infine l’appropriazione da parte di pochi, ad esclusivi fini privati, della più grande
accumulazione capitalista che la storia ricordi, della conoscenza (scienza) come forza
sociale produttiva (come il lavoro), determinando serie contraddizioni nei processi di
mutamento sociale.2
3. Nel capitolo precedente (La produttività tra miti e realtà) avevamo visto come il meccanismo di
innovazione e investimento, in regime capitalistico, non garantisce di per se la crescita
dell’accumulazione, contribuendo al generarsi di crisi cicliche attraverso il meccanismo delle
sproporzioni settoriali e il sottoconsumo. A tale proposito con C. Napoleoni notavamo:
“ In realtà, per cogliere la rilevanza sia delle sproporzioni sia del sottoconsumo per l’insorgere delle
crisi, bisogna che questi due fatti siano considerati non isolatamente, ma come due componenti di una
medesima situazione le quali, per usare la solita immagine marshalliana, agiscono nella
determinazione della crisi come le due lame di un paio di forbici.”
Qui, è evidente, facciamo riferimento alle origini delle crisi legate al funzionamento
dell’accumulazione e della crescita del plusvalore generato nelle attività produttive (capitale
industriale), in particolare come evidenziatesi dalla prima rivoluzione industriale in poi. Vedremo
poi con G. Carandini come le crisi possano generarsi, e in forma assai più grave e incontrollata, dal
versante non del mercato della produzione capitalistica ma da quello dell’accumulazione, in
particolare di quella legata al capitale finanziario.
Per ora ci interessa notare con Napoleoni che:
“La situazione di sottoconsumo [come quella in cui stiamo assistendo in questa parte della crisi attuale,
ndr] […] può non essere accompagnata da deficienza di domanda solo a patto che vi sia una
conveniente domanda di mezzi di produzione, solo a patto cioè che l’ammontare degli investimenti sia
tale da riempire il divario tra la domanda per consumi e la produzione corrispondente alla piena
capacità. Ora è proprio nella determinazione di questo ammontare di investimenti che diviene rilevante
la tendenza alle sproporzioni. E infatti, quando l’ammontare degli investimenti è una parte molto
rilevante della domanda effettiva, i rapporti <<giusti>> tra le varie industrie, ossia i rapporti che
assicurino le compatibilità tra la composizione dell’offerta e la composizione della domanda,
dipendono principalmente, non tanto dai fabbisogni di consumo della società, quanto dalle esigenze,
dello stesso processo accumulativo. Ciò significa che le decisioni relative ai singoli atti di investimento
dovrebbero essere coordinate tra di loro sulla base delle caratteristiche che viene globalmente
assumendo lo stesso processo generale di investimento.
La correttezza di ogni atto di investimento, e perciò anche la sua profittabilità, vengono così a
dipendere principalmente da tutti gli altri atti d’investimento che si svolgono nel sistema, e ciò,
ripetiamo, in misura tanto maggiore quanto più lontano è il processo accumulativo dal legame con il
consumo. Ma è appunto nei confronti di questo tipo di coordinamento che il mercato si manifesta come
uno strumento del tutto insufficiente. Il coordinamento a posteriori di decisioni decentralizzate
presenta infatti dei limiti abbastanza ristretti nell’accertamento della convenienza degli investimenti:
tale convenienza è accertabile, nell’ambito del meccanismo di mercato, solo se gli investimenti
assorbono una quota relativamente modesta della domanda effettiva, solo se, quindi, l’accumulazione è
prevalentemente orientata non da se stessa ma dai fabbisogni derivanti dallo sviluppo del consumo. Ma
ciò significa che, nelle situazioni di mercato, il basso consumo non solo non è accompagnato da un
ampio volume di investimenti, ma anzi determina un ammontare di investimenti abbastanza basso da
rendere deficiente la domanda complessiva.
Si potrebbe allora mettere la conclusione in questi termini: il sottoconsumo è generatore di crisi perché
la tendenza alle sproporzioni, cioè l’<<anarchia>> insita nel mercato impedisce un sufficiente
ammontare di investimenti; ovvero (il che significa la stessa cosa da un altro punto di vista) la
tendenza alle sproporzioni genera la crisi perché il sottoconsumo tramuta sistematicamente in realtà
tale tendenza.
Il punto essenziale, dopo questa conclusione, consiste nell’accertare di quale specie di crisi
propriamente si tratti.”
Ma, prosegue Napoleoni3:
“Abbiamo visto […] che, secondo l’indicazione di Marx, il capitalismo è caratterizzato dal porre il
capitale come inizio e come fine del processo economico; ma ora risulta chiaro che questa natura del
processo capitalistico non può realizzarsi per il fatto stesso che tale processo si svolge sotto il
condizionamento del mercato [anche Napoleoni, perciò, distingue tra processo capitalistico,
accumulazione, e mercato come Braudel e Carandini, ndr]. E allora il problema non è più tanto quello
di determinare in che cosa consista la crisi finale, o crollo, del processo capitalistico, quanto quello di
scoprire in qual modo, data la crisi iniziale che il mercato impone al capitale [e viceversa, vedi
Carandini, ndr], sia stata tuttavia storicamente possibile un’economia capitalistica di mercato.”
Infatti,
“…lo <<schema>> capitalistico non si è mai realizzato nella sua purezza. Inizialmente, infatti, le
forme precapitalistiche e le vecchie classi connesse a queste forme, ancorché fossero spodestate dalle
loro posizioni di realtà economicamente, socialmente e politicamente dominanti, mantenessero
tuttavia, attraverso il loro consumo improduttivo, una rilevanza materiale sufficiente a conferire al
consumo del prodotto sociale una struttura ben diversa da quella dello schema. In secondo luogo, a
partire da una certa fase dello sviluppo storico del capitalismo, un’incidenza analoga, ma
quantitativamente molto più rilevante, sul consumo hanno avuto fenomeni redistributivi dovuti ai
successi delle lotte sindacali e politiche dei lavoratori.”
E’ questo che il capitalismo finanziario della fase neoliberista appena trascorsa, ma non passata,
cerca di scrollarsi di dosso, alla ricerca di uno stato “puro” dello <<schema>> che gli consenta
eccezionali livelli di accumulazione mai visti prima, anche mettendo in crisi gli stessi assetti
statali,nazionali e sovranazionali. Ma poco importa, purché prevalga la concezione di uno stato di
<<natura>> che il capitale e le sue classi dominanti rivendicano per se medesimi. Ma così ritorna,
non solo la crisi per gli eccessi di appropriazione ineguale e speculativi, ma anche la crisi dovuta al
sottoconsumo insita nello schema puro della logica capitalista:
“Cosicché si deve concludere che, nella vita storica del capitalismo, ha avuto un’importanza decisiva il
consumo improduttivo, e specialmente quello dovuto all’innalzamento dei salari al di sopra del livello
minimo di sussistenza: tale consumo ha tolto la difficoltà implicita nello schema capitalistico puro. In
altri termini, la tendenza al sottoconsumo, che in quello schema sarebbe stata bloccante, è stata
efficacemente contrastata prima dal consumo improduttivo delle vecchie classi e poi (ma in un senso
ben più profondo e duraturo) dal consumo improduttivo delle stesse classi lavoratrici.”
“La presenza del consumo improduttivo rende dunque non catastrofica la tendenza alle sproporzioni.
Il che significa che quelle crisi, che nell’ambito del puro schema del capitalismo di mercato sarebbe
stata subito dirimente , si trasforma per opera del consumo improduttivo, semplicemente in crisi
ciclica: la quale dunque consiste nel periodico riaffiorare di quegli elementi di crisi che il consumo
improduttivo riesce altrimenti ad imbrigliare.”
Questo, afferma Napoleoni, non fa che mettere in evidenza il conflitto
“…tra il carattere sociale della produzione capitalistica [e anche del mercato, Braudel, Carandini, ndr]e
il carattere privato dell’appropriazione…” 4
del surplus e della ricchezza.
4. Torniamo ora alla incapacità del liberismo (neo o meno che sia) di gestire la crisi. A proposito dei
pregiudizi ideologici del <<laissez faire>> o del neoliberismo di scuola anglosassone e degli eccessi
speculativi del capitalismo (due fenomeni distinti ma speculari), G. Carandini afferma:
“Uno dei temi centrali […] è la distinzione fra economia di mercato e accumulazione [corsivo nel
testo, ndr]…” . Prosegue “ il grande crollo dei mercati finanziari americani nel 1929 è una vicenda che,
considerata in se ma anche nei suoi precedenti storici, rafforza quella distinzione sia dal punto di vista
teorico che da quello pratico.”
“Si è visto che l’economia di mercato costituisce la base, in continua espansione, degli scambi tra
domanda e offerta, una base intesa da alcuni economisti come fattore autoregolato di equilibrio, come
<< un dio benevolo>> che, con <<mano invisibile>>, bilancia attraverso la libera concorrenza ogni
eccesso sia della produzione che del consumo. Ma, vista da un’altra prospettiva, limita e livella anche i
profitti e, con essi, le possibilità di accumulazione. Sulle base del mercato si innalza il capitalismo
dell’accumulazione vera e propria, che viola la concorrenza, manipola i prezzi, crea arbitrariamente
situazioni di monopolio, insomma assicura le condizioni per scambi ineguali che sono le vere fonti di
guadagno, e che il semplice gioco del mercato concorrenziale non consente se non in misura molto
ridotta. Sono quelle le condizioni che fruttano gli alti profitti e l’abbondante accumulazione, derivanti
da molteplici tipi di transazioni fra le quali – ed è quel che più ci interessa – ogni sorta di ardite
speculazioni affaristiche.
Le periodiche crisi economiche dipendono a volte dalla sola base di mercato, cioè da sproporzioni fra
la domanda e l’offerta per sovrapproduzioni o sottoconsumi [e anche, come abbiamo visto con
Kalecki, per l’andamento ciclico degli investimenti e le sproporzione tra settori, ndr], e la teoria
economica si è largamente occupata dell’argomento, spesso però accecata dai pregiudizi ideologici del
laissez faire liberista, che tende a sopravvalutare le capacità auto regolatrici del mercato. Ma sovente le
crisi derivano dagli eccessi del capitalismo, dalle sue avventure e dai troppi rischi che corre
inseguendo altissimi profitti, o dalle avventate speculazioni in cui si getta e che possono travolgere il
mercato. La scienza economica si è assai meno occupata di questi eventi [con la eccezione di Rudolph
Hilferding e John Kenneth Galbraith, ndr], intenta com’è a ricercare le cause degli equilibri piuttosto
che quelle dei capitomboli.”5
Proprio Galbraith, ne “Il Grande crollo”6, sviluppando la tesi che la libera impresa va “soggetta a
ricorrenti grandi eccessi speculativi, dovuti a forme di incontrollata euforia nel mondo degli affari,
che conducono inevitabilmente a crolli finanziari”, fa riferimento a tre noti episodi avvenuti nel
corso di due secoli a partire da ben cinque secoli fa: in Olanda tra il 1630 e il 1636, in Francia tra il
1716 e il 1720 e infine in Inghilterra nel 17207.
Prosegue Carandini,
“Ciò che accomuna questi episodi del passato con quel che avvenne nel 1929 e poi in successive
occasioni […] fino alla crisi del 2008 [iniziata nell’agosto del 2007 e tutt’ora in atto, ndr], è
sicuramente l’eccezionalità di eccessi speculativi di altissimo livello che si accompagnarono a vaste
recessioni.
Quel che invece li rende più prosaicamente emblematici e analiticamente significativi non è la loro
eccezionale dimensione, quanto l’esempio che offrono di una pratica che è molto diffusa e frequente
nel mondo del capitalismo anche a livelli assai più modesti. La pratica cioè di creare speciali occasioni
(ieri nuovi territori ricchi di risorse, oggi magari le innovazioni tecnologiche) e speciali strumenti (ieri
le grandi compagnie, oggi i nuovi mezzi della finanza creativa) capaci di sottrarre i prezzi e i guadagni
al loro corso normale, diciamo di <<mercato>>, spingendoli verso l’alto per attirare capitali in cerca di
un investimento proficuo.”8
5. Guido Carandini nella sua opera di ricostruzione della Civiltà capitalista ci propone un nuovo e
assai proficuo paradigma con cui poter analizzare non solo i processi storici ma anche le crisi
capitalistiche. Interessante, a questo proposito, il riferimento al ruolo della “Teoria” economica che:
“…malgrado la contraria ed esauriente prova empirica fornita dalla Grande crisi [1929, ndr],
l’economista di Yale [Irving Fischer di cui parla Galbraith in “Il grande crollo” BUR 2002, ndr]
manteneva ferma la convinzione – destinata ad avere nei successivi anni Settanta notevoli sviluppi
teorici nella scuola della nuova macroeconomica classica di Robert Lucas e Thomas Sargent – secondo
la quale nel mercato agiscono forze e aspettative <<razionali>>. Che perciò le deviazioni da tali forze
e aspettative sono imputabili a comportamenti insani psicologicamente che, in quanto tali, sono
sottratti a ogni previsione scientifica fondata.” 9
Viene da chiedersi se questa visione sempre smentita dai fatti
“…non sia dovuta a un’errata interpretazione di fondo del sistema capitalistico. Un’interpretazione
cioè che, […] non vuole riconoscere la fondamentale distinzione, rispetto all’economia di mercato,
delle condizioni in cui si muove il capitalismo aggressivamente alla caccia di elevati profitti, e dunque
dedito proprio alla speculazione ovunque essa sia alla sua portata.” Prosegue: “Sono invece proprio la
capacità e la possibilità che posseggono solo alcuni agenti, collocati in speciali condizioni privilegiate
rispetto ad altri, che rendono la speculazione possibile e fruttuosa, e tale da costituire la fonte
principale, in tutto il corso storico del capitalismo, del cumulativo accumulo della ricchezza che ne
costituisce la caratteristica principale.”10
E’ pertanto possibile che questa visione abbia dato e dia luogo ad una errata concezione del
capitalismo e della sua analisi basandola sulla distinzione tra società, politica ed economia che è
incapace di comprendere il rapporto intimo proprio tra accumulazione e crisi, poiché
“…quella definizione del capitalismo era carente e imprecisa in quanto derivava anch’essa dal
tradizionale tipo di analisi […], basato sull’astratta distinzione e separazione delle tre sfere della
società, della politica e dell’economia che, nel caso del capitalismo, noi riteniamo impropria.
Infatti, […], quel tipo di analisi comporta in via generale l’esame separato a) della situazione sociale
dei protagonisti – in quanto singoli o classi rappresentate nei partiti – che dominano la vita associata o
che in essa sono subalterni; b) delle loro azioni nel governo dello Stato, in quanto ne indirizzano (o ne
subiscono) le decisioni circa le regole della vita collettiva; c) dei loro comportamenti nella gestione
economica.
Ma nel capitalismo emancipato dai residui medievali dalle tre successive rivoluzioni contro
l’assolutismo monarchico, questi diversi fattori non agiscono separatamente perché formano
congiuntamente il <<sistema>> che definiamo la potenza, dalla quale dipendono le condizioni
dell’accumulazione del capitale. [ I ] “…suoi sviluppi e …le sue crisi. Entrambi i quali, secondo il
nostro paradigma analitico, non possono essere fatti dipendere, a seconda dei casi o delle idee dello
studioso, da ragioni sociali o da ragioni politiche o da ragioni economiche separate l’una dall’altra in
certa misura autonome. Accumulazione e crisi dipendono invece dal buono o cattivo funzionamento
del <<sistema>> della potenza, che riunisce e coordina sia gli elementi sociali che quelli politici e
quelli di mercato in ogni dato contesto storico. […] il funzionamento <<buono>> lo abbiamo definito
<<fisiologico>> e quello cattivo <<patologico>>, in riferimento, appunto, alla sua capacità di
promuovere o di ostacolare i processi di accumulazione.” 11
Ciò significa, in parole povere, che se nel sistema capitalista possono aversi crisi cicliche dovute al
funzionamento stesso del meccanismo dell’accumulazione / investimento di capitale o per sfasature
temporali nel meccanismo di mercato tra domanda e offerta, oppure possono darsi anche crisi più
gravi legate alla potenza del capitale alla ricerca del massimo profitto rispetto al profitto medio
consentito dal mercato ed in particolare al prevalere del capitale finanziario su quello produttivo,
ciò non dipende da single decisioni in ambito politico, sociale od economico, ma da scelte
complessive agite su questi tre piani contemporaneamente che sono risolvibili solo con decisioni e
scelta che agiscano su questi stessi tre piani. Stando così le cose non si deve attendere alcun crollo
della civiltà capitalista, essa finirà storicamente come tutte le cose umane, ma è altrettanto certo che
essa subirà cambiamenti, volta per volta modi di essere, agire, istituzioni e regole vantaggi e
svantaggi per i vari soggetti, tali da mutarne caratteristiche e connotati, fino a diventare un’altra
cosa, a seconda delle circostanze storiche epolitiche. Generando allo stesso tempo grandi problemi,
guai e dolori. Ed è anche per queste ragioni che va compreso il rapporto tra economia di mercato e
capitalismo:
“Il capitalismo per crescere, sosteneva Braudel, deve elevarsi al di sopra del modesto livello
dell’economia di mercato.”
[Infatti ] “ i maggiori profitti e la loro accumulazione erano sempre derivati, oltre che da attività
produttive di alto livello, anche da ogni forma possibile di speculazioni e da avventure di ogni tipo.” “
era proprio al livello dei grandi affari e non a quello dei piccoli mercanti e del commercio ambulante
che il capitalismo realizzava gli alti profitti, con intraprese che erano necessariamente ispirate proprio
alla brama <<immoderata>> del guadagno…”12
Prosegue:
“…nei sette secoli della sua evoluzione la civiltà capitalista …[si è affermata] …e diffusa nel mondo
intero con una grande varietà di strategie , raramente <<frugali>> e pacifiche e al più delle volte avide
e violente perché normalmente basate su qualche forma di sopraffazione”. A partire dalla
ineguaglianza nelle conoscenze e negli scambi.
“Conviene allora distinguere due versioni ..[dello “spirito” del capitalismo], riconducendole al duplice
livello del sistema capitalistico che Braudel ha messo in luce” … “Secondo il quale il capitalismo
dell’<<accumulazione>> deve essere considerato il livello superiore del capitalismo di un’<<economia
di mercato>> che del primo ha sempre costituito la fondamentale base, proprio come era avvenuto nei
suoi esordi quando, come sostiene lo stesso Braudel, 13<< al di sopra dei mercati, delle botteghe, del
commercio ambulante si colloca, nelle mani di brillanti attori, una potente sovrastruttura degli scambi.
E’ il livello dei meccanismi più importanti, della grande economia, necessariamente del capitalismo
che non esisterebbe senza di questa>>.
Secondo Braudel la ricerca storica ha mostrato che il livello dei <<mercati>> è quello della spietata
concorrenza in cui si fanno modesti guadagni e scarsa accumulazione, mentre quello
dell’<<accumulazione>> è il livello della <<grande economia>>, quello cioè in cui si realizzano i
grandi profitti e la vera accumulazione del capitale. Perché al posto della concorrenza si affermano il
monopolio, la manipolazione dei prezzi e le speculazioni finanziarie, e inoltre lo sfruttamento più
remunerativo possibile della forza lavoro fino agli estremi del lavoro coatto e dello schiavismo.” 14
È solo a questo livello, per esempio, che possiamo comprendere il significato della politica FIAT
verso il lavoro sia in Italia che negli Usa, che altrimenti non si spiegherebbe con le sole necessità di
risparmio concorrenziale sul costo del lavoro, avendo quest’ultimo una incidenza, ormai, quasi
irrilevante sui costi complessivi.
Dunque:
“si può […] ragionevolmente sostenere che al di sopra dello spirito del capitalismo caratteristico
dell’<<economia di mercato>> […] ce n’è un altro corrispondente al livello dell’<<accumulazione>>
vera e propria, che è sovente ispirato agli opposti principi [rispetto a quello di morigeratezza e casti
costumi esaltati per es. da B. Franklin, ndr] della smodatezza, della sfrenatezza e dell’aggressività,
essendo quelli i più adatti ed efficaci nel perseguire il fine sociale del capitalismo: la perenne ricerca
del massimo profitto per una massima accumulazione del capitale.
Non la frugalità ma l’ingordigia è il principio guida degli affaristi: <<greed is good>> è il motto e lo
<<spirito>> di Wall Strett.”15
Ma perché accumulazione e <<avidità è buona>> possano dominare occorrono consenso e
condizione sociale equilibrata.16
1
Vedi a questo proposito A. Gramsci, Lettere dal carcere, Einaudi 1975, vol. III, Quaderno 15 (II) - 1933
(Miscellanea), paragrafo <5> pagg. 1755-17569.
2
Braudel, La dinamica del capitalismo, il Mulino 2011, pag. 67
3
C. Napoleoni, Il futuro del capitalismo crollo o sviluppo?, Editori Laterza 1970, da pag. XXXVII ultimo capoverso, a
pag. XXXIX terzo capoverso compreso.
4
Idem, pag. XXXIX
5
G. Carandini, Racconti della civiltà capitalista, Editori Laterza , 2012, pagg. 402 - 403
6
John Kenneth Galbraith, Il Grande crollo, BUR 2006
7
Vedi G. Carandini, op. cit. pag.g.403 e 404 (da J.K. Galbraith, Breve storia dell’euforia finanziaria, pp. 26-52)
8
G. Carandini, op. cit. pag. 404
9
G. Carandini, op. cit. pag. 408
10
G. Carandini, op. cit. pag. 409
11
G. Carandini, op. cit. pagg. 416-417
12
G. Carandini, op. cit. pag. 443
13
G. Carandini, op. cit. pag. 454
14
F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), 1979, Einaudi 1982, Voll. II, I giochi dello
scambio, pag. 54
15
G. Carandini, op. cit. pag. 455
16
F. Braudel, La dinamica del capitalismo, il Mulino 2011, pag. 70