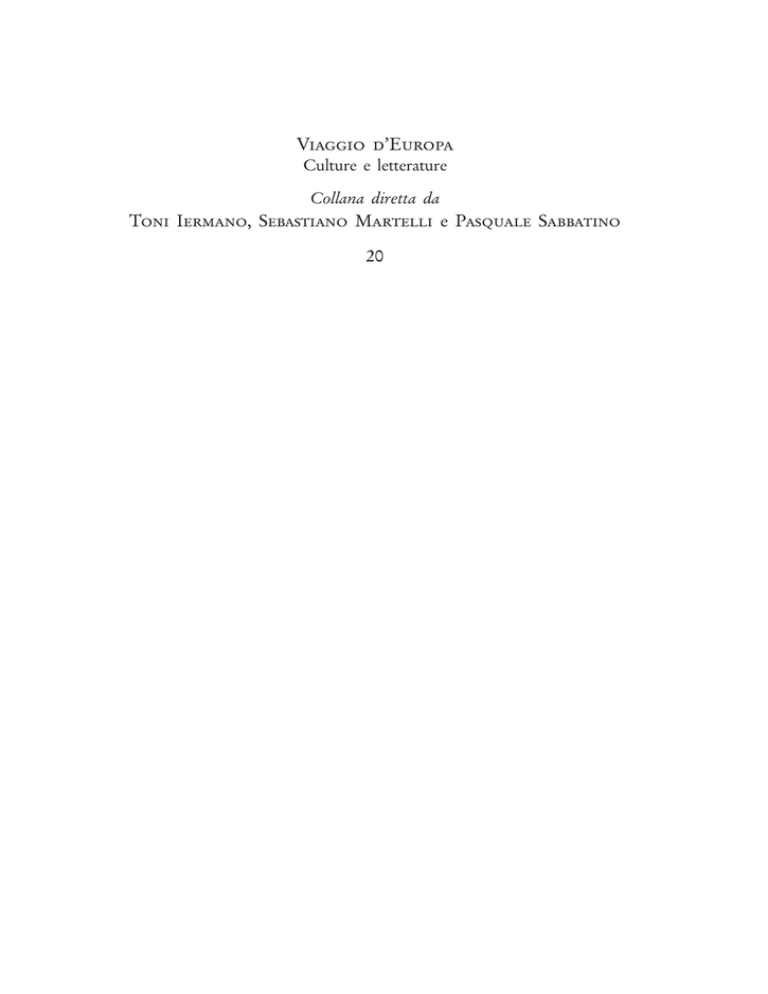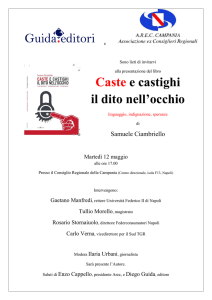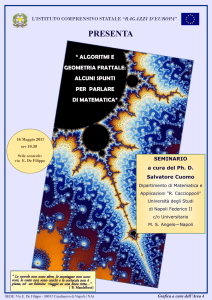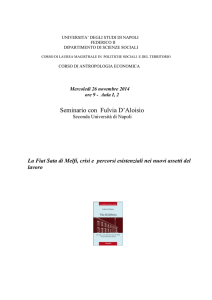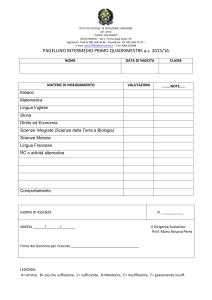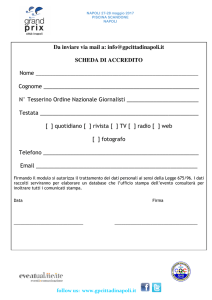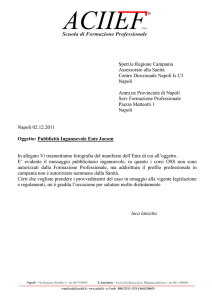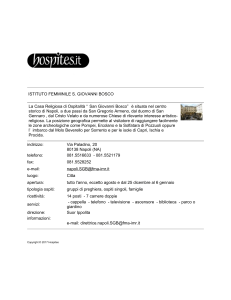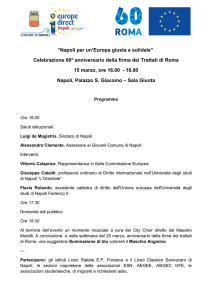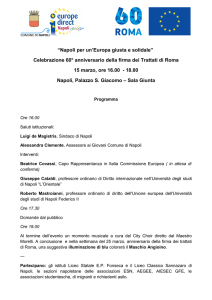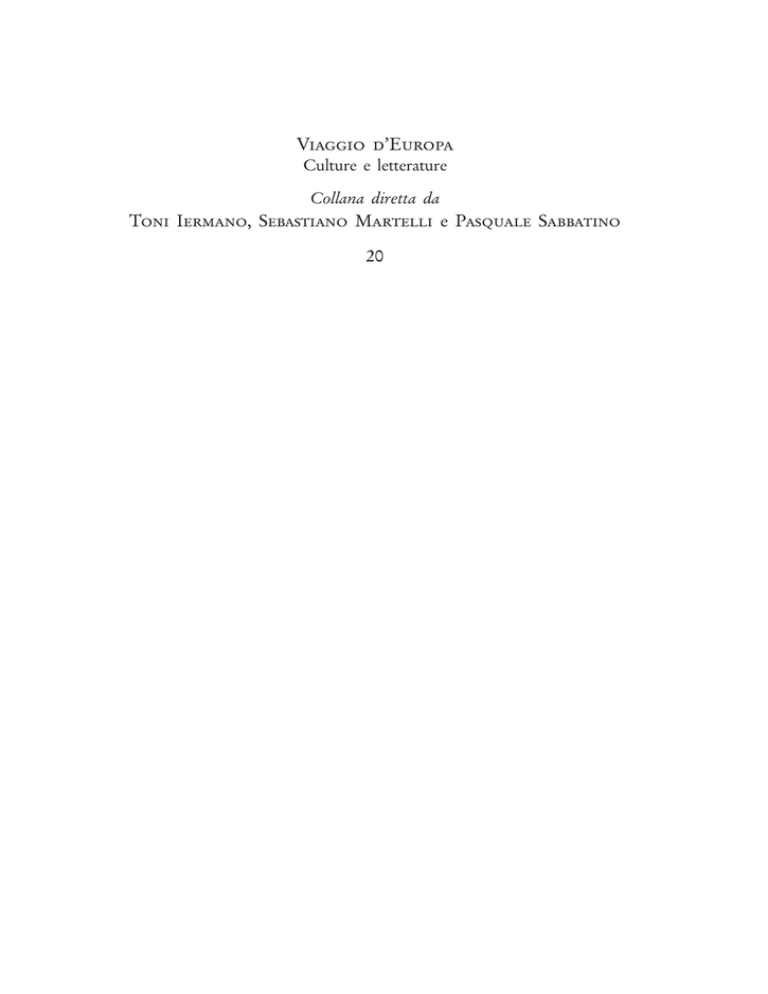
Viaggio d’Europa
Culture e letterature
Collana diretta da
Toni Iermano, Sebastiano Martelli e Pasquale Sabbatino
20
Nella stessa collana:
1. Giuseppina Scognamiglio, Ritratti di donna nel teatro di Carlo Goldoni, 2002.
2. Pompeo Garigliano, Pentimerone, a cura di Angelo Cardillo, 2002.
3. Dante Della Terza, Pasquale Sabbatino, Giuseppina Scognamiglio, «Nel
mondo mutabile e leggiero». Torquato Tasso e la cultura del suo tempo, 2003.
4. Giuseppina Scognamiglio, Per il capolavoro ripassi domani. Studi sull’ultima
narrativa pirandelliana, 2004.
5. Peppino De Filippo e la comicità nel Novecento (Napoli, 24-26 marzo 2003), a
cura di Pasquale Sabbatino e Giuseppina Scognamiglio, 2005.
6. Giornalismo letterario a Napoli tra Otto e Novecento. Studi offerti ad Antonio
Palermo, a cura di Pasquale Sabbatino, 2006.
7. La «bella scola» federiciana di Aldo Vallone. Storia dialettica della letteratura
meridionale e critica dantesca nel secondo Novecento, a cura di Pasquale Sabbatino, 2007.
8. Ioan Berardino Fuscano, Stanze sovra la bellezza di Napoli, a cura di Cristiana Anna Addesso, 2007.
9. Pasquale Sabbatino, Le città indistricabili. Nel ventre di Napoli da Villari ai
De Filippo, 2007.
10. Olga Zorzi Pugliese, Castiglione’s the Book of the Courtier, 2007.
11. Domenico Giorgio, Percorsi autobiografici. Da Boccaccio a Peppino De Filippo, 2007.
12. Annibale Ruccello e il teatro nel Secondo Novecento, a cura di Pasquale Sabbatino, 2009.
13. Vincenzo Caputo, La «bella maniera di scrivere vita». Biografie di uomini
d’arme e di stato nel secondo Cinquecento, 2009.
14. Il critico e l’avventura. Giornate di studio dedicate ad Antonio Palermo, a cura
di Pasquale Sabbatino, 2009.
15. Le rappresentazioni della camorra. Lingua, Letteratura, Teatro, Cinema, Storia,
a cura di Patricia Bianchi e Pasquale Sabbatino, 2009.
Nuova serie
diretta da
Toni Iermano, Sebastiano Martelli e Pasquale Sabbatino
16. Il racconto del Risorgimento nell’Italia nuova tra memorialismo, narrativa e
drammaturgia, a cura di Toni Iermano e Pasquale Sabbatino, 2012.
17. Enzo Striano. Il lavoro di uno scrittore tra editi e inediti, a cura di Pasquale
Sabbatino e Apollonia Striano, 2012.
18. Domenico Morelli, Ricordi della scuola napoletana di pittura dopo il ’40 e
Filippo Palizzi, a cura di Vincenzo Caputo, 2012.
19. La nuova scienza come rinascita dell’identità nazionale. La Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis (1870-2010), a cura di Toni Iermano e Pasquale Sabbatino, 2012.
IL VIAGGIO A NAPOLI
TRA LETTERATURA
E ARTI
a cura di
Pasquale Sabbatino
Questo volume è stato pubblicato con il contributo dell’Università degli Studi di
Napoli «Federico II», Dipartimento di Filologia Moderna «Salvatore Battaglia».
Sabbatino, Pasquale (a cura di)
Il viaggio a Napoli tra letteratura e arti
Collana: Viaggio d’Europa. Culture e letterature, 20
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012
pp. 712; 24 cm
ISBN 978-88-495-2552-6
© 2012 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
00185 Roma, via dei Taurini 27
Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: [email protected]
I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun
volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall’art. 68,
comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra siae, aie, sns e cna,
confartigianato, casa, claai, confcommercio, confesercenti il 18 dicembre 2000.
Barbara Delle Donne
IL SOGNO MEDITERRANEO.
LA PERCEZIONE DI NAPOLI E DINTORNI
NEI VIAGGIATORI INGLESI
Il viaggio a Napoli si è vestito da sogno per molti visitatori, sogno
mediterraneo, appunto, che tenteremo di indagare attraverso gli strumenti
messi a disposizione dalla geografia della percezione, branca della più ampia e multiforme disciplina geografica.
Probabilmente perché il turismo di massa ha reso la pratica di viaggio un’esperienza consueta, abituale, quasi banale, oggi sono i viaggi del
passato a colpire maggiormente l’immaginario collettivo, dal momento
che conservano il fascino dell’avventura e della scoperta, ovvero dell’incontro con la diversità per lo più negato in un’epoca, come quella attuale, in cui la distanza geografica è praticamente annullata dalla quantità e dalla facilità delle comunicazioni. A destare maggiore interesse sono
i viaggi degli ultimi due-tre secoli che, avendo lasciato tracce più chiare
ed evidenti, consentono una più agevole indagine geografica.
Il viaggio si rende strumento di selezione della conoscenza dello spazio e moltiplicatore delle informazioni acquisite su aree più note e, dunque, più visitate, rispetto ad altre che lo sono meno o non lo sono per
niente. Sia che ci si sposti materialmente, sia che lo si intraprenda con la
fantasia attraverso la lettura, il viaggio aiuta a creare o diffondere notizie, miti, conoscenze geografiche inerenti i luoghi attraversati o descritti,
rendendosi in tal modo artefice dell’attecchire e del proliferare di idee
geografiche comuni ai più, che facilmente si rivelano attraverso abbinamenti automatici e stereotipati tra terre, genti, aggettivazioni fisse e generalmente condivise. Il rischio che si corre nel peggiore dei casi è quello
di scadere nel luogo comune; altrimenti, sotto la guida di autorevoli scrittori e celebri viaggiatori, è possibile prenda forma un linguaggio geografico universale che, offrendo agevoli chiavi di lettura dei diversi paesaggi,
o più semplicemente suggestionando il grande pubblico con le descrizioni di località da visitare assolutamente, va a costituire patrimonio culturale collettivo.1
1
G. Scaramellini, Raffigurazione dello spazio e conoscenza geografica: i resoconti
374
Barbara Delle Donne
Fin quando la geografia, così come indica l’etimologia stessa del termine gewgrafia, fu mera descrizione della Terra, la dipendenza del sapere geografico dal viaggio e dal resoconto di viaggio fu pressoché totale: le figure del viaggiatore e del geografo coincidevano, il geografo era
di fatto il viaggiatore che, allontanandosi dalla propria area di appartenenza, esplorava nuove terre, le osservava e le descriveva. Quando, intorno alla seconda metà dell’Ottocento, queste due figure cominciarono
a separarsi, tale scissione portò giovamento alla disciplina, poiché consentì al geografo di mettere ordine nella immensa mole di informazioni
che gli erano pervenute e continuavano a giungergli dai resoconti di viaggio, di classificarle in maniera sistematica e metodica, rendendole più facilmente consultabili, più semplicemente fruibili, a tutto vantaggio della
materia che, di conseguenza, migliorò il proprio contributo al panorama
culturale generale. Nella seconda metà del Novecento, la scuola americana spostò l’attenzione dai luoghi ai processi, si concentrò sulla più
astratta idea di spazio, scegliendo di affidarsi a metodi quantitativi per
l’impostazione dell’analisi geografica: perdendo d’interesse i luoghi, anche il viaggio ed il resoconto di viaggio smarrirono la loro dignità di documento di conoscenza geografica. Ed è qui che la geografia della percezione può intervenire ed offrire l’opportunità di affrontare la questione
da un punto di vista diverso, suggerendo di non rinunciare completamente ai rapporti di viaggio come fonte di documentazione geografica,
ma di affiancare alla loro lettura anche una riflessione relativa agli elementi sociali e culturali che sopraggiungono a modificare la percezione
e l’interpretazione dei luoghi da parte dei viaggiatori.2
La percezione a cui si fa riferimento attiene ad una serie di articolati
processi della psiche umana che, solitamente oggetto d’indagine della psicologia, aiuta in questo caso a definire una geografia personale in cui,
più del mondo reale con le sue componenti oggettive, a contare è il sistema di valori dell’individuo, in base al quale va a delinearsi uno spazio immaginario e soggettivo, costruito su percezioni, ricordi, simboli,
ovvero su filtri culturali che poco ineriscono alla geografia tradizionale.
Le relazioni di viaggio, al pari di altri testi letterari, si prestano a dar
luogo a questo tipo di lettura: conquistatori, esploratori e viaggiatori d’odi viaggio, in Geografie private, a cura di E. Bianchi, Milano, Unicopli, 1985, pp. 27123.
2
I. Luzzana Caraci, Dall’esperienza del viaggio al sapere geografico, «Geotema»,
A.Ge.I., 1997, 8, pp. 3-12.
Il sogno Mediterraneo
375
gni genere hanno prodotto descrizioni, racconti, carte delle terre visitate
che, in origine, il sapere geografico considerò come fonti di dati e notizie su cui formulare le proprie argomentazioni. Inoltre, se in principio
fu il contorno di favola ed avventura che spesso li accompagnava a farne
una fortunata forma letteraria con un buon e sempre più vasto riscontro di pubblico, in seguito i resoconti di viaggio si fecero strumento di
circolazione di idee culturali, politiche, filosofiche e scientifiche. Ciò vale
per tutte le relazioni di viaggio, anche per quelle non dichiaratamente
stilate con evidenti fini scientifico-descrittivi, dal momento che, entrando
in contatto diretto con terre e società dapprima sconosciute, i viaggiatori
ne hanno prodotto una lettura, una interpretazione ed una descrizione
personali, che si configurano sia come rappresentazioni codificate (scritti,
carte), che come preziose testimonianze della temperie culturale e della
sensibilità di un’epoca.3
In effetti, il viaggiatore è colui che è entrato in contatto con la realtà
che raffigura ma le sue descrizioni non sono mai fedeli ritratti dei luoghi attraversati, quanto piuttosto trascrizioni soggettive della realtà, condizionate da una serie di fattori legati tanto alla sfera biografica e personale dell’individuo (aspetti peculiari della sua esistenza, come condizioni
di salute, stati emotivi, esperienze personali), quanto alla storia (dati relativi all’epoca in cui è vissuto che possono averlo condizionato in quanto
membro di una collettività). Per questo motivo, vanno individuate in ciascuna testimonianza le distorsioni intrinseche dettate dall’interpretazione
soggettiva cui la realtà viene di fatto sottoposta: una volta colte, e per
fornire una lettura il più obiettiva possibile, è utile affiancarvi un’analisi
più dettagliata, magari utilizzando fonti tradizionali di indagine geografica, e servirsene per quel che di fatto sono, ovvero l’inventario delle immagini che uno scrittore si forma di un’area, di una città, in base alle
proprie esperienze personali e idee preconcette. In tal senso, la geografia della percezione ha messo in luce come la formazione dell’immagine
di un Paese sia condizionata da un complesso intreccio tra «percezione
diretta del luogo, formazione culturale del soggetto percepiente e l’insieme delle sue immagini codificate, preesistenti all’esperienza diretta che
modificano il significato delle informazioni ricevute dal mondo reale».4
In questo senso, i resoconti di viaggio apportano un rilevante contri3
G. Scaramellini, Raffigurazione dello spazio e conoscenza geografica, cit., pp. 38-64.
Id., La geografia dei viaggiatori: raffigurazioni individuali ed immagini collettive
nei resoconti di viaggio, Milano, Unicopli, 1993, p. 38.
4
376
Barbara Delle Donne
buto alla lettura del paesaggio, perché si pongono a supporto e completamento delle fonti cui la geografia tradizionalmente attinge per la ricostruzione nel tempo e nello spazio di ambienti preesistenti. Caratteri di
imparzialità sono di certo il più delle volte assenti nelle immagini rimandate, eppure le testimonianze dei viaggiatori stranieri, soggettive o
convenzionali, consentono comunque di ampliare il campo di lettura della
realtà geografica in quanto, osservando il paesaggio da punti di vista diversi, favoriscono l’acquisizione di certi aspetti meno noti ma complementari a quelli generalmente rilevati da chi fa ricerca per professione.5
Naturalmente, c’è poi da considerare che il valore dell’apporto di conoscenza che può derivare dalle descrizioni di un viaggiatore non sia racchiuso tanto nel viaggiare – nel fatto in sé – quanto nel saper viaggiare:6
anche osservazioni prodotte da viaggiatori comuni, infatti, possono risultare utili al sapere geografico ed alla conoscenza scientifica, a patto
che essi sappiano rivolgere correttamente la propria attenzione alle giuste componenti spaziali, così come già Kant raccomandava al viaggiatore,
ammonendolo allo studio della geografia.7
Guardare al modo in cui i viaggiatori del passato hanno attraversato,
percepito ed interpretato Napoli, la città nella quale spendiamo il nostro
quotidiano, ci offre una prospettiva multiforme, in certi casi anche alienante, dal momento che ci consente di rilevare elementi obliati dal tempo,
celati dall’incuria o, nei casi peggiori, addirittura cassati dalla devastazione
antropica ai danni dell’ambiente naturale.
Tra i numerosi personaggi che l’hanno attraversata, sono alcuni dei
più celebri viaggiatori inglesi a Napoli tra Settecento ed Ottocento ad
essere scelti per l’applicazione esemplificativa del processo cognitivo che
s’innesca quando un visitatore occasionale entra in contatto con una realtà
diversa da quella di appartenenza. Essi cominciarono ad arrivare a Napoli e nei dintorni a partire dalla seconda metà del Seicento: a quei tempi,
nelle proprie descrizioni, rimandavano l’immagine migliore possibile che
potesse esser prodotta della nostra terra, ovvero quella tradizionalmente
espressa dallo stereotipo classico della Campania felix, di un’area, cioè,
5
G. Corna Pellegrini, Geografia e percezione dell’ambiente: un rapporto da approfondire per la conoscenza e la programmazione del territorio, «Rivista Geografia Italiana», 1980, 87, pp. 1-5.
6
F. Cardon, Il Manuel du voyageur di Kaltbrunner, «B.S.G.I.», 1880, 5, pp. 488-90.
7
I. Kant, Immanuel Kants physische Geographie, Kant’s gesammelte Schriften, Berlino, W. De Gruyter, pp. 151-436.
Il sogno Mediterraneo
377
dotata di un clima assai mite e di una natura rigogliosa, in cui tutto sembrava elargito con facilità e con generosa abbondanza.8
A partire dalla seconda metà del Settecento, complici il crollo del
blocco continentale e la Restaurazione ad opera dei Borbone, il numero
di inglesi che giunsero nella nostra regione aumentò notevolmente. La
propensione al viaggio, la moda del viaggio nella nostra Penisola pareva
ispirata più da un’esigenza vitale dello spirito che dettata dalla ragione,
per cui l’apporto che ne derivò fu legato più alla storia del costume che
a quella del pensiero. La maggior parte di essi ripercorrevano le tappe
principali del Grand Tour, principiando l’itinerario tradizionale durante
la stagione invernale con l’intenzione di sostare nei luoghi obbligati del
viaggio in Italia. Thomas Gray, a Napoli nel 1739, raccontò di aver visitato i siti più noti della città e dei suoi dintorni:
Abbiamo trascorso nove giorni a Napoli, la più estesa e famosa città, così
come i più deliziosi d’Italia sono i suoi dintorni. Abbiamo navigato nel
mare di Baia, sudato nella Solfatara e svenuti nella grotta del Cane, come
fanno tutti gli stranieri, assistito alla processione di Cristo, visto il re e la
regina, visitato la città sotterranea (che è meravigliosa e della quale racconterò un’altra volta) ed infine siamo rientrati a Roma per fermarci altre due settimane.9
Da Thomas Gray a Charles Dickens, in un arco di tempo lungo poco
più di un secolo, è tutto un pullulare di descrizioni dei luoghi di visita
canonica: Napoli, il Vesuvio e i Campi Flegrei, Pompei ed Ercolano, Paestum e Sorrento. Ciascun autore produsse descrizioni soggettive nelle
quali è possibile leggere la relazione tra il personaggio itinerante e percepiente e lo spazio da lui visitato e assimilato: in base al proprio sistema
di valori, ogni soggetto procedette ad un’operazione di trasformazione
dei luoghi e del paesaggio con cui entrò in contatto, adattandoli al proprio stato d’animo, al vissuto, alla storia, alle proprie aspettative.
Dalla lettura che i viaggiatori inglesi fecero della società napoletana,
dall’interpretazione che offrirono del paesaggio campano emergono visibilmente i condizionamenti dettati sia da gusti ed interessi personali, sia
dalla sensibilità culturale dell’epoca cui appartennero: insieme concorsero
8
G. Porcaro, Napoli, il suo mare e il porto, vista da viaggiatori illustri, Napoli,
Fiorentino, 1964.
9
T. Gray, Letters of Thomas Gray, with an introduction by J. Berensford, Oxford,
University Press, 1925, p. 72.
378
Barbara Delle Donne
alla formazione dell’immagine soggettiva che della nostra terra essi andarono formandosi.
Così ragionando, cercheremo di passare in rassegna i diversi fattori
che per gli inglesi si posero alla base dei loro differenti modi di percepire ed interpretare Napoli.
Come primo elemento che interviene ad influenzare la percezione può
essere annoverata l’area di provenienza del viaggiatore, ovvero l’insieme
delle caratteristiche ambientali, naturali e climatiche – in questo caso –
dell’Inghilterra. Vivendo in un’area caratterizzata da un clima certamente
non dei più favorevoli, gli inglesi appena giunti a Napoli restavano piacevolmente impressionati dalla mitezza della temperatura, nella misura in
cui questa costituiva un elemento componente del paesaggio cui non
erano abituati e che, perciò, li colpiva per l’eccezionalità, conformemente
a quanto accade in ogni soggetto che, fruitore occasionale di un luogo,
resta affascinato dai caratteri palesemente diversi dello spazio che attraversa e che, dunque, propende ad indicare come straordinari (non ordinari, appunto). John Ruskin, a Napoli nel 1818, scrisse nel proprio diario che nella sua Inghilterra il clima non era così nemmeno in estate:
Son salito sulla collina di Posillipo. C’era uno strano effetto su Sant’Elmo
che avrei fatto di tutto per conservare: il suo bel contorno scuro contro
le striature del cielo blu e delle nuvole bianche, distese, e ad un tratto la
sua massa illuminata dal sole, come gli altri luoghi, in modo da conferire
colore e forma […]. Faceva tanto caldo, non riuscivo a camminare con
indosso il mio cappotto, sulla via del ritorno, mi fermai dieci minuti sulla
spiaggia, dove il calore era più grande di quanto si possa ottenere dal nostro mare in estate.10
È così che prende corpo quell’idea di sogno mediterraneo, fatto di un
clima mite, di una natura rigogliosa, dell’amore per i colori, di straordinari paesaggi, di insolite manifestazioni naturalistiche, di aree monumentali.
Nel Settecento accanto alle notazioni di carattere climatico c’erano
pure osservazioni relative all’ambiente naturale, all’arte, all’archeologia;
nell’Ottocento queste scomparvero, dando vita ad una percezione deformata e stravolta della natura che non era quel che era ma quel che ap-
10
J. Ruskin, The Diaries of John Ruskin, a cura di J. Evans e J. Howard Whitehouse
1835-1847, Oxford, Claredon Press, 1956, p. 143.
Il sogno Mediterraneo
379
pariva, non tanto nelle diverse percezioni ma nelle differenti descrizioni.
Quando contenute nelle opere più note della letteratura di viaggio, queste ultime divulgano (e di fatto impongono) itinerari, immagini, sensazioni che poi si ritrovano negli scritti successivi, in un meccanismo di
affiliazione del pubblico a certe immagini e di diffusione di notizie e idee
stereotipate; delle aree non menzionate, perché escluse dalla considerazione di autori e viaggiatori, non si hanno notizie e, quando se ne hanno,
raramente sono verificabili.
Altro elemento condizionante la percezione è la formazione culturale,
responsabile del sentimento di aspettativa che si crea nel viaggiatore. Napoli era una tappa, sovente quella finale, di un più ampio viaggio in Italia; gli inglesi si preparavano a conoscere il nostro Paese documentandosi sui testi dei classici in cui erano contenute descrizioni di paesaggi e
luoghi completamente mutati a tanti secoli di distanza: l’antico splendore
cantato dai poeti greci e latini era presente ormai soltanto nella pagina
scritta. Motivo per cui, giunti a Napoli, molto spesso la sensazione che
accompagnava i viaggiatori al cospetto di tanta diversità era di una cocente delusione. Dopo aver visitato Paestum, John Ruskin scrisse d’esserne rimasto profondamente deluso ed aggiunse che Napoli era una
«brutta, sporca, spoglia, noiosa, ripugnante città».11 In verità va aggiunto
che il mal tempo che accompagnò il suo sopralluogo ed uno stato di salute cagionevole non predisposero al meglio l’autore nel suo soggiorno
partenopeo, a conferma di quanto i condizionamenti della sfera privata,
come in questo caso rappresentano le condizioni di salute, possano intervenire ad alterare fortemente la percezione ed il ricordo di un luogo.
La temperie culturale della propria epoca è un altro fattore altamente
condizionante la percezione di un luogo. Come nel caso del poeta romantico Percy B. Shelley, il quale, a Napoli nel 1818, si soffermò a cogliere della città certi aspetti affini alla cultura romantica, come il paesaggio sublime, la natura emozionante e la monumentalità delle antiche
rovine. La selezione degli elementi del paesaggio reale è condizionata dall’idea pregressa che si possiede del luogo, la quale porta a riconoscere
del tutto soltanto la parte che gratifica questa immagine precostituita.
Shelley andò, infatti, alla ricerca delle zone d’ombra, delle aree selvagge
ed incontaminate, lontane dai contesti urbani, nelle quali poter perseguire
e soddisfare quel desiderio di evasione e di introspezione tipico dei ro-
11
Ivi, p. 166.
380
Barbara Delle Donne
mantici: del Vesuvio lo colpì il suggestivo spettacolo della lava incandescente, di Pompei l’atmosfera pregna di classicità ed il paesaggio incantevole, del Lago d’Averno la rigogliosa vegetazione, di Paestum i sublimi
monumenti e del golfo di Baia lo affascinarono le «rocce alte e gli scoscesi isolotti con archi e portali erti sul mare, ed enormi caverne dove
s’ode l’eco delle streghe accompagnata debolmente dal mormorio di una
languida marea».12
Il richiamo ipnotico della lava incandescente, in particolare, dettava
nella sensibilità dell’uomo preromantico e romantico un imperativo categorico: correre i rischi di una visita ravvicinata, meglio se in circostanze
difficili, per rendere omaggio al Vesuvio, il sovrano del paesaggio partenopeo.13 Così fu, per esempio, per Charles Dickens, a Napoli nel 1845,
che ebbe modo di ascendere il Vulcano, sperimentando una delle più
forti, tremende, magnifiche emozioni della propria vita:14 scelse di arrampicarsi sulle pendici a pomeriggio inoltrato, in una rigidissima giornata, con i ripidi fianchi innevati fino alla fascia del fuoco, ritrovandosi
a ridiscenderne in piena notte, percorrendo uno strato di ghiaccio su cui
più di un membro del gruppo precipitò rovinosamente. Nelle sue parole
la descrizione del paesaggio vesuviano:
Mentre siamo saliti al buio, la luna, investendo la sommità delle nevi con
una fascia di luce che ha poi riversata come un fiume nella valle sottostante, ha rischiarato d’un tratto la candida distesa del dosso e il mare immerso laggiù ai suoi piedi, Napoli piccola in lontananza ed ogni paesino
di queste terre. Tutto lo scenario è immerso nel suo incantevole lume,
quando tocchiamo la spianata, la regione del fuoco, che è un cratere spento
fatto di grandi masse di materia bruciata somiglianti a blocchi di pietra
portati da una tremenda cascata, di mezzo ai quali, tra spaccature e crepacci, sale un fumo cocente e solforoso. Da un altro cocuzzolo intanto,
l’attuale cratere che sorge quasi perpendicolare da un lato, si levano grosse
lingue di fuoco che arrossano la notte, la oscurano col fumo, la segnano
di pietre incandescenti e di ceneri ardenti che volano nell’aria come piume
12
P.B. Shelley, With Shelley in Italy. A Selection of the Poems and Letters of Percy
B. Shelley relating to his life in Italy, a cura di Anna Benneson McMahan, Londra, Fischer Unwin, 1907, pp. 76-89.
13
I. Caciolli, Impressioni italiche di Charles Dickens, «Quaderni della Ri-Vista», Firenze, University Press, 2007, pp. 139-51.
14
Lettera a Emile De La Rue, in C. Dickens, Lettere da Genova, Napoli e altre
città, a cura di L. Angelini, Milano, Archinto, 1987, p. 41.
Il sogno Mediterraneo
381
e ricadono come piombo. Quali parole possono mai descrivere il tenebrore e la grandezza di una simile scena?15
L’impressione che gliene derivò fu indimenticabile, tanto da far prevalere il sentimento di fascinazione su quello – pur comprensibile – di
sgomento al cospetto di una mole tanto incombente e minacciosa. Annotò Dickens:
Vediamo il Vesuvio sparire gradatamente dalla nostra vista, ma al ritorno
lo cerchiamo di nuovo con gli occhi, con la medesima immutata curiosità: in lui, infatti, che se ne sta in attesa di cogliere il suo terribile momento, vediamo il crudele arbitro della sorte dell’intera amenissima regione.16
Altra caratteristica condizionante è quella del sistema di valori, dell’etica del viaggiatore. Come nel caso, ancora una volta, di Dickens che,
al di là della bellezza della città e dei suoi dintorni (come appena descritto nel caso della visita al Vesuvio), colse certi aspetti degradati tipici
del tessuto sociale e del comportamento dei napoletani – gli stessi che
ancora infastidiscono alcuni di noi – e che riguardavano le condizioni di
vita, lo spirito invadente e lassista della gente, l’edilizia dei quartieri popolari, le strade. In una lettera alla Contessa di Blessington, Dickens sintetizzò l’impressione sulla città in termini caustici:
Napoli mi ha ampiamente deluso. È pur vero che il tempo è stato brutto
per gran parte della mia permanenza là, ma se non vi fosse stato il fango,
vi sarebbe stata la polvere. E se anche avessi avuto il Sole, avrei comunque avuto anche i Lazzaroni, che sono così cenciosi, così luridi, abietti,
degradati, immersi e imbevuti nella più totale impossibilità di riscatto, che
renderebbero scomodo anche il Paradiso, semmai dovessero arrivarci. Non
mi aspettavo di vedere una bella Città, ma qualcosa di più piacevole della
lunga monotona sfilza di squallide case che si stendono da Chiaia al Quartiere di Porta Capuana; e mentre ero piuttosto preparato all’idea di una
popolazione miserabile, mi aspettavo comunque di vedere qualche straccio pulito ogni tanto, qualche gamba che ballasse, qualche viso sorridente,
abbronzato dal sole. La realtà, invece, è che, se penso a Napoli in sé per
15
Golfo di Napoli, «Le vie del mondo. Viaggi d’Autore», (Milano, T.C.I.), 1996, 4,
pp. 54-55.
16
C. Dickens, Impressioni di Napoli, a cura di S. Manferlotti, Napoli, Colonnese,
2005, p. 53.
382
Barbara Delle Donne
sé, non mi resta un solo ricordo piacevole. La regione intorno, non c’è
bisogno che lo dica, mi ha incantato. Chi potrebbe dimenticare Ercolano
e Pompei?17
A colpirlo fu il modo misero del popolino di tirare avanti la propria
esistenza: i lazzaroni che si ammassavano per le vie della città a qualsiasi
ora del giorno, gli imbroglioni che pullulavano ad ogni angolo erano per
lui la testimonianza di uno squallido e spregevole degrado di tutte le abitudini sociali; ne scrisse all’amico John Forster in questi termini:
La condizione della gente comune qui è abietta e sconvolgente. Temo che
l’idea del pittoresco sia associata ad una tale miseria e degradazione che
occorrerà inventare un nuovo tipo di pittoresco, più adatto ad un mondo
che progredisce. Se si eccettua Fondi, non vi è nulla al mondo di più sordido di Napoli.18
Di certo va considerato che nel breve soggiorno napoletano di Dickens,
avvenuto in febbraio, imperversarono proibitive condizioni meteorologiche che resero addirittura sconsigliabile il proseguimento del viaggio verso
Sud. S’è già affermato quanto il favore del tempo sia fortemente condizionante la percezione del luogo attraversato, tant’è vero che la giornata
di sole che accompagnò la sua escursione nel Golfo portò Dickens ad
accordarsi per una volta ai diffusi toni celebrativi della città:
Attorno a noi si distende la più bella regione del mondo. Sia che si volgano i passi verso la spiaggia del Misero col suo splendido anfiteatro d’acqua e, passando per la Grotta di Posillipo, si giunga alla Grotta del Cane
e di lì a Baia; sia che si prenda la via opposta che mena al Vesuvio e a
Sorrento, è un susseguirsi di viste deliziose.19
Dickens raccontò Napoli – e l’Italia – come gli apparve, senza sentimentalismi, seguendo impressioni e sensazioni unicamente personali; il suo
sguardo vittoriano lo portò ad evidenziarne soprattutto le contraddizioni.
Ciò è tanto più particolare e rilevante se si pensa che, generalmente,
in quel periodo, continuavano ad essere rimandate sempre le stesse ste17
C. Dickens, Lettere da Genova, Napoli e altre città, a cura di L. Angelini, cit.,
pp. 162-63.
18
Ivi, p. 134.
19
C. Dickens, Impressioni di Napoli, cit., p. 41.
Il sogno Mediterraneo
383
reotipate immagini di Napoli, immagini di cartolina, che consentivano
agli inglesi di ri-conoscere l’area partenopea già prima di giungervi: il Vesuvio con il suo fumante pennacchio, le singolari manifestazioni dei Campi
Flegrei, il Golfo, castel Sant’Elmo, i vicoli brulicanti di varia umanità.
Questo affidarsi ad altrui descrizioni ed il compiacersi, quasi il sentirsi
rassicurati da racconti pregressi sono sentimenti che si vestono di paradosso se riferiti ad un viaggiatore, il quale, al contrario, dovrebbe essere
spinto e motivato da una forte curiosità per la terra a lui ignota e che si
appresta a visitare. Invece sembrava proprio che gli inglesi fossero appagati da questa possibilità di ri-conoscere i luoghi partenopei dalle descrizioni altrui, sulle quali si documentavano con grande attenzione.
Come nel caso di Lady Blessington che, nel 1823, dichiarò d’aver capito d’esser giunta a Napoli avendo individuato il profilo del Vesuvio
con l’Isola di Capri, o come anche Mariana Starke che, nel 1836, giungendo a Napoli dal mare, scrisse:
Nulla è più strabiliante della città vista dal golfo, dal quale tutti i suoi edifici si presentano alla vista, disponendosi in crescendo a formare un anfiteatro sovrastato dall’imponente castel Sant’Elmo.20
Affiora dalle descrizioni un sentimento di apprezzamento meramente
estetico, così come si evince dall’uso ricorrente degli aggettivi “bello”,
“suggestivo”, “stupefacente” che raccontano con evidenza la propensione
ad una valutazione formale di tipo soggettivo. Questa percezione semplificata e stereotipata dei luoghi sancisce la differenza di sensibilità che,
in ogni tempo, ha guidato i viaggiatori occasionali (gli outsiders) a cogliere solo gli aspetti più superficiali del paesaggio, tralasciandone elementi più profondi e radicati, da quella che, invece, muove gli abitanti
di una città (gli insiders) ad individuare, in certe componenti dei propri
luoghi, i cardini di quel sentimento di appartenenza che si traduce in patrimonio identitario e culturale.21
A ciò si lega un’ultima forma di influenza, quella derivante dalla documentazione dei viaggiatori sulle guide turistiche. Limitandosi al conte-
20
M. Starke, Travels in Europe, for the Use of Travellers on the Continent, Parigi,
Galignani, 1836, p. 27.
21
C. Caldo, Monumento e simbolo. La percezione geografica dei beni culturali nello
spazio vissuto, in Beni culturali e geografia, a cura di C. Caldo e V. Guarrasi, Bologna,
Pàtron, 1994, pp. 15-30.
384
Barbara Delle Donne
nuto dei resoconti, essi si lasciavano condizionare non solo nella scelta
dei luoghi da visitare ma anche nel modo in cui vederli e percepirli. Come
nel caso della già citata Mariana Starke che, nella guida che redasse, indicò una serie di località meritevoli d’essere viste, con numerose notazioni a margine relative all’arte, all’archeologia, alla storia e a consigli
d’ordine pratico. I viaggiatori che la seguirono pedissequamente si limitarono a visitare di Napoli soltanto i luoghi da lei menzionati, snaturando di fatto il senso del viaggio che da strumento di conoscenza si trasformò in meccanismo di selezione preventiva. Per rendersene conto è
sufficiente riflettere sull’influenza che, tra tutte e su tutte, ebbe la relazione di viaggio compilata da Goethe, in Italia tra il 1786 e il 1788, edita
solo trent’anni più tardi, nel 1816: un’autorità esercitata sia sui viaggiatori, che si lasciarono affascinare dalle sue descrizioni ripercorrendo i luoghi citati dal Tedesco, sia su altri e successivi scrittori e relatori di viaggio che ne imitarono soprattutto la forma.
Attraverso la lettura dei differenti fattori di condizionamento, intervenuti, per motivi diversi, a suggestionare la percezione che i viaggiatori
inglesi ebbero di Napoli e dei suoi dintorni, si è tentato di ripercorrere
implicitamente, seppur in maniera breve ed esemplificativa, le fasi di quel
processo cognitivo teorizzato dalla geografia della percezione, che interviene a modificare l’impressione e l’interpretazione dei luoghi da parte
dei viaggiatori: esse sono la sensazione, la percezione, la pertinenza, la
conoscenza e la formazione dell’immagine.
Se la geografia si interessa alla biunivoca relazione tra uomo ed ambiente naturale, nella quale l’ambiente naturale influenza il comportamento dell’individuo e l’individuo a sua volta modifica la natura, la
geografia della percezione attribuisce valore all’influenza che l’uomo
esercita sul mondo reale, oltre che con il proprio, manifesto comportamento, anche attraverso processi interiori di conoscenza e soggettivizzazione dell’ambiente fisico, elaborati in base alla più generale esperienza che dell’intero ambiente circostante egli possiede.22 Poiché in ogni
soggetto prende forma una visione personale dell’ambiente in cui vive
ed agisce e che ne influenza le decisioni ed i comportamenti, è ammissibile che, oltre allo spazio oggettivo e fisico, identificabile come il
segno del denotato, ne esista un altro, percepito, connotato, i cui mol-
22
M. Bonnes-Dobrowolny, L’emergenza della psicologia ambientale: verso un nuovo
ambientalismo?, «Rivista di Psicologia», 1978, 1-2, pp. 97-107.
Il sogno Mediterraneo
385
teplici elementi e significati variano al variare del singolo soggetto percepiente.23
Ai consueti campi di studio della geografia, costituiti da natura ed
uomo, si affianca, dunque, l’attenzione per l’attitudine dell’individuo che,
essere pensante, forgia nella propria mente lo spazio reale, attraverso
un’instancabile attività di produzione di immagini, espressioni di quanto
percepito, vagliato ed elaborato col suo stare al mondo. Poiché in base
a tali immagini il soggetto opera le proprie scelte ed orienta le sue azioni,
esse divengono chiavi di lettura fondamentali per comprenderne il comportamento; per l’indagine geografica acquisisce, così, valore l’elemento
soggettivo, per quel suo costituirsi come strumento conoscitivo suscettibile di ampliare e nel contempo approfondire i modi di lettura tradizionali del rapporto uomo-ambiente. Attraverso l’attività cognitiva, ovvero
il processo col quale l’individuo interiorizza e prende coscienza dell’ambiente, il soggetto percepisce, elabora, valuta, memorizza, apprende e, anche, si esprime ed opera in base a quanto acquisito, in una continua interazione tra conoscenza, variabili personali e stimoli socio-culturali.24
Tutte le fasi di tale processo cognitivo sono finalizzate alla formazione
delle immagini, ovvero delle rappresentazioni dell’ambiente elaborate dalla
mente in base all’esperienza pregressa ed alle informazioni provenienti
dall’esterno. Di certo, il primo canale di conoscenza è la sensazione: sono
i sensi, infatti, che ci mettono in collegamento con quanto è attorno a
noi, sono questi la fonte primaria di una informazione copiosa e composita, proveniente dal contatto diretto con ciò che è altro da noi, dalla
comunicazione interpersonale e dai mass media. La fase successiva, quella
della percezione, è assai importante perché destinata a tradurre in cognizione gli stimoli sensoriali provenienti dall’ambiente, conferendo ad
essi un significato individuale. Attraverso operazioni uniche e personali,
le informazioni vengono filtrate dal soggetto secondo un processo di discernimento dettato dalla pertinenza che le caratterizza: in altre parole,
dopo aver identificato e valutato gli oggetti dell’ambiente esterno, egli è
portato a trattenere unicamente quanto sia correlato con le proprie personalità, emozione e finalità, guidato com’è dalla mente che tende ad
23
F. Perussia, La percezione dell’ambiente: una rassegna psicologica, in Geografia e
percezione dell’ambiente, a cura di R. Geipele, M. Cesa-Bianchi, Milano, Unicopli, 1980,
pp. 45-78.
24
J.R. Gold, Introduzione alla geografia del comportamento (ed. it. a cura di M.
Arca Petrucci e S. Gaddoni), Milano, FrancoAngeli, 1985, p. 28.
386
Barbara Delle Donne
estrarre dallo spazio reale solo ciò che reputa utile per l’individuo. Se la
valutazione della pertinenza delle informazioni è frutto dell’esperienza
personale acquisita nel tempo, l’altra fase, quella della conoscenza, è, fin
dall’infanzia, frutto dell’attività esplorativa dell’individuo e delle influenze
che gli derivano dalla cultura della società cui appartiene; in particolare,
essa si articola in due momenti chiave relativi, l’uno, all’acquisizione in
senso personale dell’informazione che proviene dall’ambiente, l’altro, alla
scelta che detta il comportamento e l’azione. Quest’ultima genererà un
nuovo stimolo, cui seguirà una nuova risposta, in una sequenza infinita
e dinamica di interrelazioni tra individuo ed ambiente percepito. L’approdo finale di questo processo cognitivo è la formazione dell’immagine,
che va delineandosi attraverso la continua traduzione in linguaggio soggettivo di processi più o meno consapevoli, personali e collettivi, biografici e storici:25 l’individuo, interiorizzando l’ambiente in cui vive, dà
origine ad immagini che si costituiscono come «variabili che intervengono tra stimolo e risposta a suggerire l’esistenza di un mondo della
mente soggettivo nel quale affonda le sue radici il comportamento individuale».26
Si giunge così alla differenza tra lo spazio percepito, lo spazio vissuto
e lo spazio immaginato: il primo attiene ai significati che gli vengono attribuiti da chi lo pratica e ne parla; il secondo rimanda alle sovrapposizioni nello spazio di caratteristiche culturali relative a ciascun gruppo
umano; il terzo, quello immaginato, appartiene all’idea che chi è preposto alle scelte e agli interventi (politici, pianificatori, urbanisti) si forma
di quel contesto.27 Un’amica outsider in visita a Napoli, stupita ebbe a
dichiarare che in città «c’erano anche palazzi normali e non solo vecchi
e con i panni stesi». Questa percezione stereotipata, questa immagine iconografica non è completamente da condannare in quanto superficiale e
parziale di un paesaggio che, invece –come è noto- è assai più ricco, composito ed articolato: sarebbe piuttosto corretto accettarla e tenerla da
conto nella misura in cui è una delle tante immagini possibili di Napoli,
per altro una delle icone più diffuse dai mezzi di comunicazione, in qualche maniera anche la più semplice da rimandare, perché capace col suo
25
F. Perussia, La percezione dell’ambiente, cit., p. 67.
J.R. Gold, Introduzione alla geografia del comportamento, cit., p. 17.
27
D. Tommasini, La costruzione dell’immagine turistica dell’Alto Adige-Südtirol, in
Il paesaggio tra ricerca e progetto, a cura di M.C. Zerbi, Torino, Giappichelli, 1994, pp.
123-46.
26
Il sogno Mediterraneo
387
insito folklore di colpire con maggiore immediatezza una grandissima
quantità di persone. È questo un esempio di percezione indiretta, di processo cognitivo filtrato dall’intervento di altri soggetti o di mezzi di informazione pubblica che spesso operano sull’immagine al punto tale da farle
perdere aderenza al reale, influenzando, talvolta distorcendo, il modo di
guardare il mondo e di leggere il paesaggio. Al contrario, chi di Napoli
abbia una percezione diretta, è messo in condizione di interagire senza
filtri con l’ambiente, di selezionare all’istante l’informazione, attribuirle
valore e caricarla di un significato affettivo e simbolico che crea un legame.28
Nella valutazione dello spazio geografico è contemplata, dunque, la
possibilità che la medesima realtà possa essere diversamente percepita da
chi la vive o da chi soltanto la guarda: per poter comprendere il paesaggio nella sua complessità occorre vagliarne sia il carattere oggettivo,
osservando la realtà, che quello soggettivo, rilevando l’influenza che essa
ha sui sentimenti delle persone. I giudizi di outsiders e insiders, insieme,
si delineano quindi come valide chiavi di lettura per un esaustivo esame
del reale.29 Queste immagini di cui si compone il paesaggio, e che più di
altre ne sono un’espressione chiara ed immediata, sono state indicate da
Turri con il termine «iconemi»,30 intesi come «unità elementari della percezione», elementi cioè che rappresentano il tutto e che del tutto esprimono i tratti maggiormente indicativi. La percezione che si ha di un paesaggio non è mai caotica o casuale, ma guidata dalla ragione, la quale,
selezionando gli elementi componenti, attribuisce ad essi una collocazione
più o meno funzionale nel contesto, in base alla loro importanza. Attraverso la percezione, il soggetto accorda priorità a certe immagini, le
fissa nella mente e nella memoria, rendendole unità fondamentali dell’intera visione. L’iconema è, appunto, un segno che acquisisce valenza
simbolica e funzionale per il soggetto che l’ha percepito, elaborato e selezionato, per farne l’immagine più rappresentativa, più facilmente memorizzabile, che gli appare nel sogno, gli affiora nel ricordo, denotando
in un unico, minimo quadro un intero e complesso contesto. I «palazzi
vecchi coi panni stesi» possono rappresentare, quindi, un leit motiv di
28
D. Tommasini, La costruzione dell’immagine turistica…, cit., p. 129.
G. Scognamiglio, Campi Flegrei tra natura e cultura. L’immagine del mito, «Quaderno per l’ambiente», 1999, pp. 9-23.
30
E. Turri, La lettura del paesaggio, in Il paesaggio tra ricerca e progetto, a cura di
M.C. Zerbi, cit., pp. 35-62.
29
388
Barbara Delle Donne
Napoli, un’immagine che rimanda alla città, con immediatezza, come pure
potrebbe fare, in maniera più aulica, il Vesuvio, unità percettiva del tutto,
peculiare, irripetibile, appartenente cioè solo e soltanto a Napoli. Naturalmente non deve restare l’unica immagine, altrimenti lo stereotipo,
quando ha anche la capacità di orientare gli atteggiamenti e le azioni, rischia di trasformarsi in pregiudizio.31
Per concludere, una considerazione che volutamente non si procede
ad approfondire perché la sua trattazione richiederebbe una serie di riflessioni non direttamente collegate al tema odeporico qui affrontato: il
pensiero che il senso profondo del viaggio che gli stranieri compivano a
Napoli e dintorni fosse quello di vivere il sogno mediterraneo, ispirato
dall’amore per i colori, la natura, il paesaggio, se da una parte implicitamente ci condanna per aver sciupato un patrimonio di straordinarie ricchezze naturali e culturali, inchiodandoci eticamente alle nostre responsabilità, dall’altra potrebbe costituire, per i cittadini e le amministrazioni
più sensibili, l’ispirazione necessaria per provare a conferire alla città l’identità perduta, attraverso onerosi e pazienti interventi di recupero e valorizzazione.
31
C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, Bologna, il Mulino, 2005, p. 45.