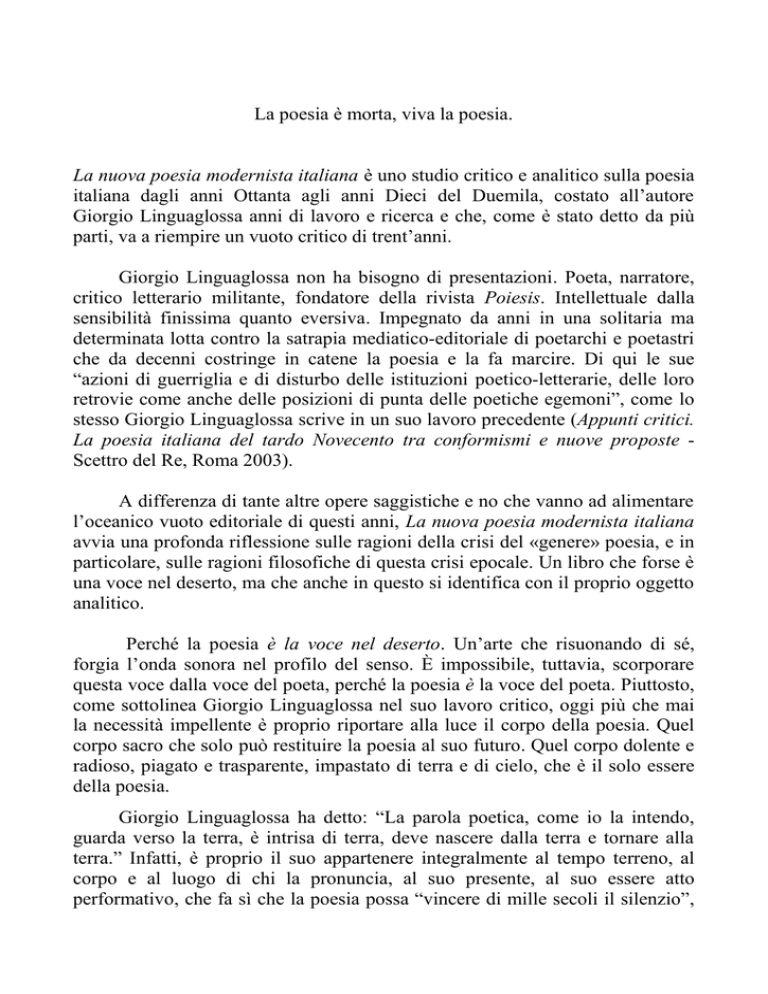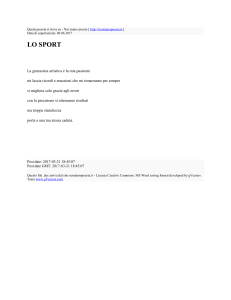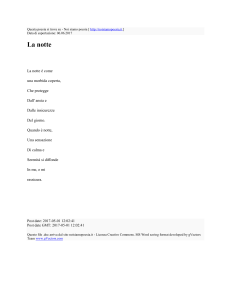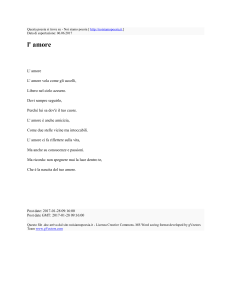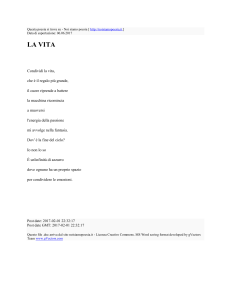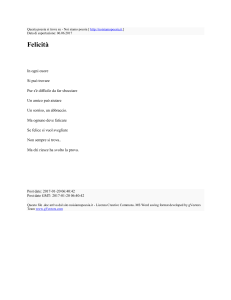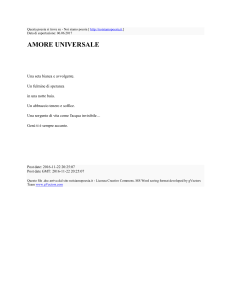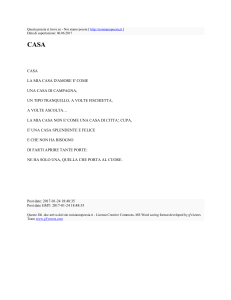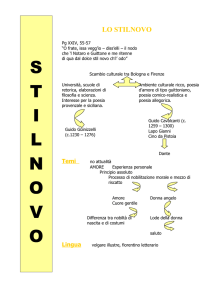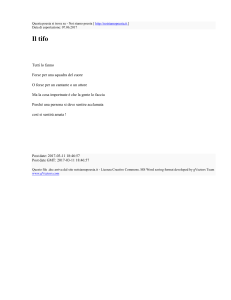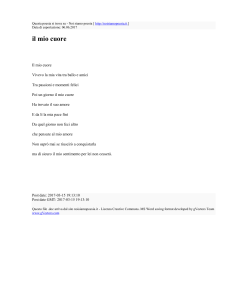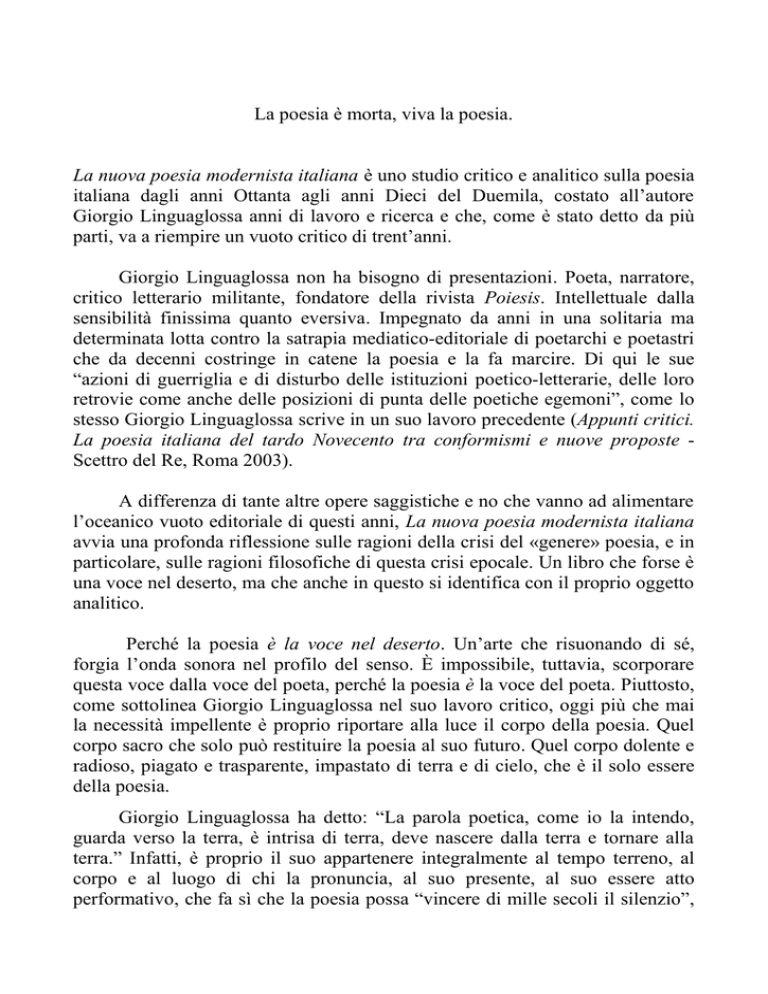
La poesia è morta, viva la poesia.
La nuova poesia modernista italiana è uno studio critico e analitico sulla poesia
italiana dagli anni Ottanta agli anni Dieci del Duemila, costato all’autore
Giorgio Linguaglossa anni di lavoro e ricerca e che, come è stato detto da più
parti, va a riempire un vuoto critico di trent’anni.
Giorgio Linguaglossa non ha bisogno di presentazioni. Poeta, narratore,
critico letterario militante, fondatore della rivista Poiesis. Intellettuale dalla
sensibilità finissima quanto eversiva. Impegnato da anni in una solitaria ma
determinata lotta contro la satrapia mediatico-editoriale di poetarchi e poetastri
che da decenni costringe in catene la poesia e la fa marcire. Di qui le sue
“azioni di guerriglia e di disturbo delle istituzioni poetico-letterarie, delle loro
retrovie come anche delle posizioni di punta delle poetiche egemoni”, come lo
stesso Giorgio Linguaglossa scrive in un suo lavoro precedente (Appunti critici.
La poesia italiana del tardo Novecento tra conformismi e nuove proposte Scettro del Re, Roma 2003).
A differenza di tante altre opere saggistiche e no che vanno ad alimentare
l’oceanico vuoto editoriale di questi anni, La nuova poesia modernista italiana
avvia una profonda riflessione sulle ragioni della crisi del «genere» poesia, e in
particolare, sulle ragioni filosofiche di questa crisi epocale. Un libro che forse è
una voce nel deserto, ma che anche in questo si identifica con il proprio oggetto
analitico.
Perché la poesia è la voce nel deserto. Un’arte che risuonando di sé,
forgia l’onda sonora nel profilo del senso. È impossibile, tuttavia, scorporare
questa voce dalla voce del poeta, perché la poesia è la voce del poeta. Piuttosto,
come sottolinea Giorgio Linguaglossa nel suo lavoro critico, oggi più che mai
la necessità impellente è proprio riportare alla luce il corpo della poesia. Quel
corpo sacro che solo può restituire la poesia al suo futuro. Quel corpo dolente e
radioso, piagato e trasparente, impastato di terra e di cielo, che è il solo essere
della poesia.
Giorgio Linguaglossa ha detto: “La parola poetica, come io la intendo,
guarda verso la terra, è intrisa di terra, deve nascere dalla terra e tornare alla
terra.” Infatti, è proprio il suo appartenere integralmente al tempo terreno, al
corpo e al luogo di chi la pronuncia, al suo presente, al suo essere atto
performativo, che fa sì che la poesia possa “vincere di mille secoli il silenzio”,
come scrive il Foscolo. Perché la poesia è materia, grumo di fuoco e ghiaccio,
alito del soprassalto. Corpo mortale, prima ancora che simbolo immortale.
Ruggine del sangue, prima ancora che musica. Il dio della poesia è Efesto e non
Apollo.
La nuova poesia modernista italiana ci ricorda anche che la lingua è la
carne della poesia. Perché la poesia è posseduta dalla lingua in filigrana. La
poesia graffia e rimpolpa la lingua. La tende fino allo spasimo dell’invenzione.
Brandisce l’ambiguità del codice come un’arma. Accende la parola oscura per
illuminare barbagli di verità. La lingua della poesia non realizza sogni, ma
nominandoli li evoca. Non suscita rivoluzioni, ma incarnando le parole del
desiderio, rende possibili le rivoluzioni. E allora, il poeta deve comunicare le
parole del messaggio sotterraneo e insospettato della poesia attraverso la
migliore forma possibile. La forma dell’acqua che scorrendo riempie i pozzi
che la poesia ha scavato. Il poeta deve scoprire e far risuonare le pieghe della
lingua. “È nei margini che si trovano i poemi”, ha scritto il grande Osip
Mandel’stam.
La vibrazione sonora della parola, la musica – intesa nella doppia
accezione di legame musaico interno e ritmo del verso – e la lingua sono il
corpo della poesia. La poesia, dunque, è un’arte plurale. Ma la poesia non si
scrive, si compone. Ancora di più quando interagisce con le altre arti, come la
pittura o la musica, rivivendo le proprie radici arcaiche. Ecco perché la poesia
sonora come performance non esiste. Perché la poesia autentica è già
geneticamente sonora. Risuonando già di se stessa, la poesia non richiede di
essere messa in musica per suonare. Non chiede di essere urlata per riempire i
vuoti di senso della scrittura.
Giorgio Linguaglossa con la sua analisi ribadisce che la poesia è arte del
corpo. Nella sua semiotica empirica, non può in nessun caso essere ridotta
all’esercizio di un codice muto o di una lallazione narrativa. Nessun poeta può
negare alla poesia il dialogo – la communio – con l’altro da sé. Perché il dialogo
e la communio con l’altro da sé sono la ragione della stessa esistenza della
poesia. È questo il mistero della poesia autentica. Essere sempre se stessa,
anche quando è altro da sé. Questo il miracolo eucaristico che rende universale
la poesia. Essere ostia e pane azzimo quando si nutre dell’altro e quando l’altro
si nutre di essa.
I secoli seguenti al Quindicesimo hanno irrimediabilmente segnato la
poesia. L’hanno ferita, mutilata. Fino al punto che le sue ferite e le sue cicatrici
sono oggi la forma della sua bellezza e della sua potenza. Fino al punto che,
come dice Giorgio Linguaglossa, oggi la poesia non è più. Non può più essere
vibrazione sonora, senza essere prima segno muto. Non può più essere oralità,
senza essere prima scrittura. Tuttavia, come ha scritto il linguista Claude
Hàgege, la poesia non può mai rinunciare, nemmeno oggi, ad essere oratura.
Ad essere il dire che si fa scrittura.
La nuova poesia modernista italiana solleva due problemi cruciali di
“epistemologia della poesia”. Attualmente la critica legge solo due delle forme
della poesia. La forma della lingua e la forma della musica, sia pure nella sua
qualità di modello, sia pure trasformando spesso la prosodia in simulazione e in
questo modo costringendo l’analisi critica entro i limiti della reticenza. Sulle
altre forme – il suono/vibrazione e quindi lo stile orale, il segno/seme e quindi
l’aspetto della critica semantica –non vuole e soprattutto non sa dare risposte.
Per questa ragione, la critica anteriore alla La nuova poesia modernista italiana
è, letteralmente, “critica letteraria”, ma non è ancora “critica poetica”.
Questa “omertà” della critica è accoratamente denunciata nell’opera di
Giorgio Linguaglossa. Perché questa reticenza si rivela un grave danno alla
possibilità della poesia di raggiungere i propri obiettivi. Gli obiettivi di una
poesia ontologica, nel senso “linguaglossiano” della locuzione. Nel Manifesto
della Nuova Poesia Metafisica, pubblicato nel 1995 sul n. 7 di Poiesis, Giorgio
Linguaglossa scrive di una poesia che sappia «entrare dentro l’oggetto»,
richiamandosi alla metafora tridimensionale del discorso poetico a suo tempo
fatta da Osip Mandel’stam per la poesia russa. La «poesia ontologica» è dunque
la poesia fondata sull’ente «parola». Un ente non modificabile né interpolabile
da parte del soggetto. La teorizzazione di una poesia ontologica – citando
ancora Linguaglossa – prova a stabilire un dialogo e a gettare un ponte con i
lettori del tempo presente e futuro. Prova a dare una speranza di leggibilità alla
poesia, ricostruendo un nuovo patto di onestà tra la poesia e il mondo. In altri
termini, la poesia ontologica prova a ripartire dal grado zero in cui la poesia è
precipitata oggi in Italia. Ecco che allora la poesia, nella sua originaria e
ontologica accezione, se non può avvalersi di una critica poetica attrezzata e
indipendente, diventa una poesia sorda e atona. Ecco che allora, in assenza del
“sismografo dei tempi” di una critica poetica curiosa e sensibile, il minimalismo
balbuziente della poetarchia paratelevisiva finisce con l’imperare.
Emanuele Severino ha scritto che “nella sua essenza la filosofia
contemporanea è la distruzione inevitabile della tradizione filosofica e
dell’intera tradizione dell’Occidente”. Ma anche la poesia, come rivela l’incipit
del libro di Giorgio Linguaglossa, è ormai giunta alla stessa fase terminale del
pensiero filosofico. La distruzione inevitabile della sua tradizione occidentale.
E, nella nostra epoca, forse mai come prima, filosofia e poesia sono impegnate
nelle stesse problematiche e impantanate nelle stesse paludi. La fine della
modernità. La modernità liquida. L’ontologia dell’oltreuomo. Il rapporto tra
filosofia e poesia si è fatto oggi tanto stretto e stringente, fino a sovrapporre
oggetti e linguaggi. Fino a condurre una comune ricerca del senso. È
impossibile che la critica poetica non riconosca questo debito simbiotico senza
suicidarsi. Senza morire di eutanasia critica, come recita il titolo del libro di
Mario Lavagetto.
L’opera di Giorgio Linguaglossa – caso più unico che raro – prova a
capire come la poesia si faccia struttura attraverso la lingua della filosofia.
Attraverso il confronto con l’oggetto. In altre parole, prova a capire come la vita
si faccia intelligibile attraverso il linguaggio. Se esiste un canone poetico della
scrittura filosofica è perché la poesia appartiene allo stesso orizzonte di senso e,
dunque, di indagine della filosofia. Entrambe esprimono un modo di essere al
mondo e una modalità di ricerca della verità. I poeti come i filosofi si
dispongono oggi in uno sconfinato spazio aperto. All’interno di un nomos
nomade senza proprietà, misure e confini. Lo spazio della vita nella sua erranza
infinita. Nel suo smisurato horror vacui.
Ma la poesia è ragione del sentimento e sentimento della ragione. È
l’esercizio della speranza attraverso la lingua, anche quando pronuncia la
disperazione e l’orrore. Perché mette in scena l’orrore per prevenirlo. In questo
senso e solo in questo senso, la poesia vive la storia e la politica. In questo
senso e solo in questo senso, la poesia è sempre politica. Perché il poeta senza
la polis semplicemente non esiste. E non esiste il senso del suo dire, a meno di
trasformare in un soliloquio – in molti casi in un ventriloquio – la parola che
geneticamente è dialogo.
Questo libro ci restituisce una speranza. La speranza che la poesia possa
tornare a vivere. Meglio, la speranza che la poesia viva già oggi per un pubblico
che ancora non c’è ma che, prima o poi, la poesia farà nascere.
3 ottobre 2010
Luigi Fabio Mastropietro
(direttore editoriale AltroVerso)