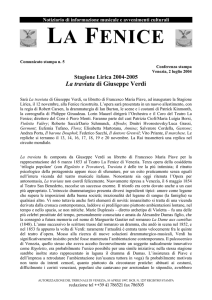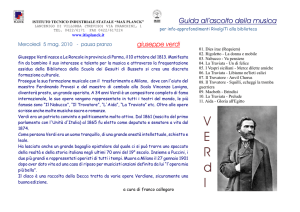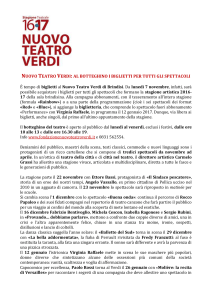28 - Trieste Artecultura - maggio 2014
Nello specchio del tempo e della scena
La strenua umanità de La traviata
di Pierpaolo Zurlo
Così come ci sono opere senza tempo, che paiono non invecchiare mai,
esiste anche un altro tipo di opera:
quella che non diventa mai madre e
che nemmeno nasce come figlia. È
questo l’eclatante caso di una delle più
celebri partiture (se non “la” più celebre) del repertorio: La traviata, andata
in scena con grande successo al Teatro
Lirico “G.Verdi”. Sembrano nascere,
queste composizioni, (quasi) dal nulla,
senza un antecedente e prive d’un conseguente: rappresentano il momento
massimo di tensione espressiva, quasi
al calor bianco, e bruciano tutta la loro
sorgiva carica d’emotività rimanendo
poi sospese in un austero isolamento,
pregno di significato. Ce n’è pochi, di
questi capolavori, nella storia della musica (per il teatro) occidentale: L’Orfeo
di Monteverdi, Le nozze di Figaro e il
Don Giovanni di Mozart, il Tristan und
Isolde di Wagner, il Boris Godunov di
Mussorgsky. E questa, per l’appunto.
Con Le nozze di Figaro, altra creazione controversa, condivide anche un
ulteriore aspetto, non di secondaria
importanza: il fatto che sia stata ideata per andare in scena in abiti moderni, condizionando in questo modo tutto l’aspetto – alquanto vetusto – della
ricezione dell’opera d’arte da parte del
pubblico, abituato (allora) a vedere a
teatro tutto un armamentario di parrucche, pepli, cimieri, colonne, templi
e tutto il restante catalogo di arcaismi
varii che contribuivano a distanziare
l’oggetto d’arte dall’uditorio. Ne La
traviata è invece il pubblico a guardarsi rappresentato in scena, allora come
oggi. E proprio su questo peculiare
aspetto ha agito l’ormai “classica” regia di Henning Brockhaus, creata di
concerto con lo scenografo ceco Josef
Svoboda (1920-2002) nel 1992: un’enorme parete di specchi che s’alza nel corso del Preludio e che rimane inclinata
per tutta la durata degli accadimenti,
facendo vedere le scene di riflesso e
consentendo al pubblico di percepire
visivamente i cantanti come fossero
sospesi in una storia che non è più
la loro. Tranne poi farla raddrizzare
– la parete – nella struggente scena
dell’ormai prossima fine di Violetta, a
ridosso del finale, per colmarsi dell’intero teatro, che in essa si specchia,
completamente illuminato e muto,
inerte testimone d’una piccola tragedia umana che sembra a questo punto
essere frutto diretto della sua (nostra)
più totale indifferenza. Di quell’indifferenza che può trasformare una piccola
tragedia umana (realmente accaduta,
tra l’altro) in una metafora di portata
universale: quella che ai “valori” (morali) d’una società – che nel caso de La
traviata è quella borghese di metà XIX
secolo – oppone il fatale e feroce isolamento di chi quei valori infrange.
Per quanto singolare possa sembrare, fu proprio quest’aspetto, l’estrema
modernità ed attualità dell’opera, a siglarne l’insuccesso (a Venezia, a La Fenice, il 6 marzo 1853) e poi il successo,
a poco più d’un anno di distanza (sempre a Venezia, ma nel più piccolo Teatro San Benedetto, il 6 maggio 1854).
Anche se andò in scena con abiti retrodatati al 1700 circa, come da libretto,
il lessico musicale che Verdi utilizza in
quest’opera è talmente eversivo rispetto alle consuetudini dell’epoca da non
poter lasciare indifferenti pubblico e
28 - Trieste Artecultura - maggio 2014
critica. In modo singolare chi ne percepì immediatamente l’estrema novità
fu, paradossalmente, chi la recensì
sull’Italia Musicale: che era il giornale
del concorrente editoriale di Ricordi,
il Lucca, e quindi pregiudizialmente
sfavorevole, almeno in teoria. Eppure,
così si può leggere: « La traviata è la
migliore o almeno la più progressiva
delle opere moderne (…) perché a noi
assistendo a quest’opera ne par come
d’assistere al dramma stesso di Dumas, tanto che non sembra nemmeno
musica (corsivo nostro). (…) Verdi è
inventore di un nuovissimo genere di
musica, egli ha moltiplicato i suoi mezzi e vuole che essa sia capace di esprimere non solo i pensieri e i sentimenti
in generale, ma anche tutte le loro modificazioni ». Un anno dopo, quando
l’opera ebbe il successo travolgente che
ancor oggi le si tributa, divenne quel
che è: un’opera borghese a sfondo verista. Distanziandosi, ma pur legandosi
alla Luisa Miller (1849) che la precede
di poco: opera borghese, quella, ma a
sfondo romantico; e da Stiffelio (1850),
anch’esso d’ambientazione moderna e
fortemente anticipatore di molte delle
peculiarità vocali de La traviata.
Non “figlia” loro, però: altra declinazione, ma nuova e irreversibile, d’un
29 - Trieste Artecultura - maggio 2014
medesimo sguardo che si china pietoso
sulla difficoltà del vivere moderno. Ed
è proprio quest’umana pietas a rendere ancor oggi questo « sogeto (sic)
dell’epoca » (come in un improbabile
italiano Verdi stesso scrive a Cesare
De Sanctis il 1 gennaio 1853) vitale e
credibile in ogni suo dettaglio. Anche
in quelli più violentemente attaccati, a
suo tempo: come l’implacabile – e a
volte chiassoso – ritmo ternario che
pervade l’intera partitura e che oggi si
può legittimamente leggere per come
Verdi lo intendeva, e cioè indifferente,
superficiale specchio musicale d’un’epoca indifferente e superficiale. Che contrasta pesantemente, nei suoi apparentemente allegri (in realtà solo frivoli)
ritmi di walzer più o meno veloci e
polke varie, con il fragile equilibrio di
silenzi, squarci laceranti a piena orchestra e cullante diradarsi di strumenti
isolati che appartiene all’altra musica,
quella delle emozioni e dei sentimenti.
Della verità, in ultima analisi.
Questi aspetti strumentali, che
poi costituiscono l’ossatura principale
dell’opera, sono quelli che l’abile direttore, Gianluigi Gelmetti, è riuscito
a rendere in tutta la loro struggente
bellezza, giocando sui contrasti, sui colori, sulle densità, fin dalle primissime
misure: dirigendo con impeto, quando
serviva, e con incalzante semplicità,
quando necessitava, per non sgualcire
la trasparente, inconsistente dolcezza
delle ampie campiture melodiche che
rendono così incisiva quest’opera. Dando alla pagina da cui sembra germogliare (ma a ritroso) tutta la narrazione –
il “Prendi quest’è l’immagine de’ miei
passati giorni” che è anche l’epilogo
dell’opera – quell’austerità minacciosa
e raccolta che lascia comprendere che
chi muore in scena non è una peccatrice (come alla società borghese avrebbe
sicuramente fatto piacere pensare) ma
un eroe. E che degli eroi ha la nobiltà.
E che Violetta Valéry, alter-ego di
Marie Duplessis (al secolo Alphonsine
Rose Plessis) morta nel 1847 a soli 23
anni, sia per Verdi una nobile figura non
vi è alcun dubbio: ha sorpreso perciò la
lettura forzatamente volgare, da postribolo o lupanare più che da cortigiana,
impressa dal regista – fortunatamente
nel solo primo atto – alla protagonista,
Jessica Nuccio. Che ha assecondato questa visione ma è stata senz’altro molto
più a suo agio nei due successivi atti,
dove ha compiutamente costruito una
credibile figura a tutto tondo, passando – e qui sta la grande difficoltà di
quest’opera – dai delicati toni discorsivi
a quelli più intensamente drammatici
con un disinvoltura raffinatissima.
Per quanto si possa comprendere
come l’atteggiamento “caricato” del primo atto costituisca forte, volutamente
accentuato motivo di contrasto con
quello più umano che segue, rimane
sempre purtroppo un inesplicabile fastidio nel veder alterata una figura che
mantiene sempre, anche nei momenti
di maggior, apparente frivolezza, un distacco, una misteriosa malinconia che
la lettura registica non ha minimamente lasciato definirsi.
29 - Trieste Artecultura - maggio 2014
Migliore – e più pertinente – la
resa d’insieme data nel secondo e nel
terzo atto, favorita anche dal cruciale e,
per Violetta, funesto scontro fra lei e
Germont padre, uno straordinario Vitaliy Bilyy che ha donato timbro vocale
pieno e incisivo ad una difficile figura,
sottraendola abilmente alle pastoie della
prevedibile, dignitosa leziosaggine borghese. Ogni pagina che Verdi scrisse
per questo protagonista, ché tale risulta
essere alla fine Giorgio Germont, venne
curata, riscritta, migliorata proprio per
dare massimo risalto e profonda, mesta
autorità a questa voce d’un mondo costantemente atterrito dal “dire” degli
altri e che solo alla fine dell’opera, con
Violetta morente, è in grado di “cantare” il suo dolore nel constatare il danno
procurato. Vitaliy Bilyy, con un’ottima
pronuncia tra l’altro, ha saputo costruire
un Germont ragguardevole per profonda
maturità vocale ed interpretativa. Cosa
invece non avvenuta al giovane, forse
troppo giovane, Merunas Vitulskis, che
ha esibito un bel timbro ed una buona
presenza di palcoscenico, ma ha mancato di definire quell’amara duplicità che è
la dannazione del suo personaggio, risultando stentoreo e deciso anche laddove
il suo ruolo vocale, per come l’ha scritto
Verdi, richiederebbe indecisione, mezzetinte e ossessiva infantilità. Intensa la
scena del giuoco di carte, nel secondo
atto, ma troppo caricata la cabaletta “O
mio rimorso, o infamia”, che è – al contrario – tormentata e assai poco eroica,
avendo come argomento il cruccio per il
danaro che langue.
Spettacolo sontuoso, in tutto l’insieme e in quasi tutti i suoi dettagli,
con un coro elegante e vigoroso, i bei
costumi di Giancarlo Colis, le piacevoli coreografie di Valentina Escobar e
una regia che ha saputo trascinare il
pubblico ad un trionfo di applausi. Pienamente e tutti meritati.