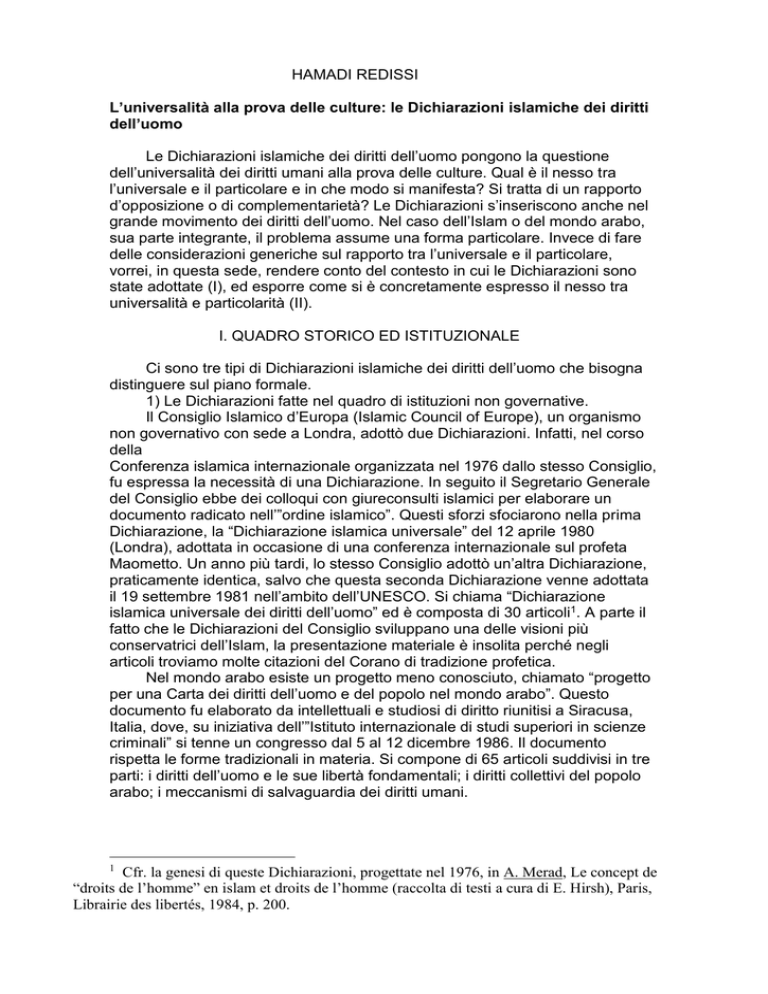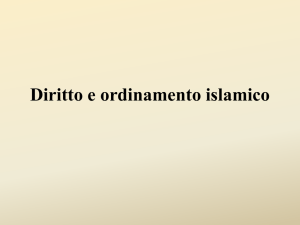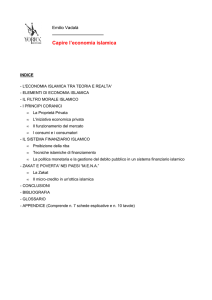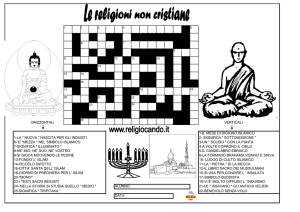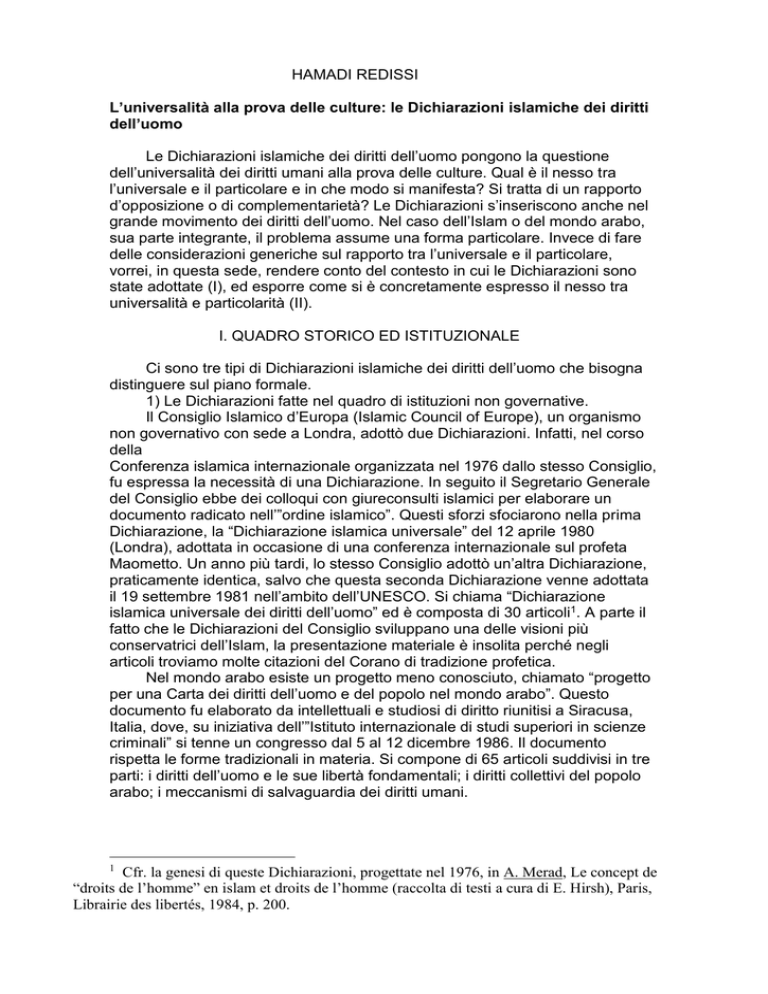
HAMADI REDISSI
L’universalità alla prova delle culture: le Dichiarazioni islamiche dei diritti
dell’uomo
Le Dichiarazioni islamiche dei diritti dell’uomo pongono la questione
dell’universalità dei diritti umani alla prova delle culture. Qual è il nesso tra
l’universale e il particolare e in che modo si manifesta? Si tratta di un rapporto
d’opposizione o di complementarietà? Le Dichiarazioni s’inseriscono anche nel
grande movimento dei diritti dell’uomo. Nel caso dell’Islam o del mondo arabo,
sua parte integrante, il problema assume una forma particolare. Invece di fare
delle considerazioni generiche sul rapporto tra l’universale e il particolare,
vorrei, in questa sede, rendere conto del contesto in cui le Dichiarazioni sono
state adottate (I), ed esporre come si è concretamente espresso il nesso tra
universalità e particolarità (II).
I. QUADRO STORICO ED ISTITUZIONALE
Ci sono tre tipi di Dichiarazioni islamiche dei diritti dell’uomo che bisogna
distinguere sul piano formale.
1) Le Dichiarazioni fatte nel quadro di istituzioni non governative.
Il Consiglio Islamico d’Europa (Islamic Council of Europe), un organismo
non governativo con sede a Londra, adottò due Dichiarazioni. Infatti, nel corso
della
Conferenza islamica internazionale organizzata nel 1976 dallo stesso Consiglio,
fu espressa la necessità di una Dichiarazione. In seguito il Segretario Generale
del Consiglio ebbe dei colloqui con giureconsulti islamici per elaborare un
documento radicato nell’”ordine islamico”. Questi sforzi sfociarono nella prima
Dichiarazione, la “Dichiarazione islamica universale” del 12 aprile 1980
(Londra), adottata in occasione di una conferenza internazionale sul profeta
Maometto. Un anno più tardi, lo stesso Consiglio adottò un’altra Dichiarazione,
praticamente identica, salvo che questa seconda Dichiarazione venne adottata
il 19 settembre 1981 nell’ambito dell’UNESCO. Si chiama “Dichiarazione
islamica universale dei diritti dell’uomo” ed è composta di 30 articoli1. A parte il
fatto che le Dichiarazioni del Consiglio sviluppano una delle visioni più
conservatrici dell’Islam, la presentazione materiale è insolita perché negli
articoli troviamo molte citazioni del Corano di tradizione profetica.
Nel mondo arabo esiste un progetto meno conosciuto, chiamato “progetto
per una Carta dei diritti dell’uomo e del popolo nel mondo arabo”. Questo
documento fu elaborato da intellettuali e studiosi di diritto riunitisi a Siracusa,
Italia, dove, su iniziativa dell’”Istituto internazionale di studi superiori in scienze
criminali” si tenne un congresso dal 5 al 12 dicembre 1986. Il documento
rispetta le forme tradizionali in materia. Si compone di 65 articoli suddivisi in tre
parti: i diritti dell’uomo e le sue libertà fondamentali; i diritti collettivi del popolo
arabo; i meccanismi di salvaguardia dei diritti umani.
1
Cfr. la genesi di queste Dichiarazioni, progettate nel 1976, in A. Merad, Le concept de
“droits de l’homme” en islam et droits de l’homme (raccolta di testi a cura di E. Hirsh), Paris,
Librairie des libertés, 1984, p. 200.
2) Le Dichiarazioni redatte da cittadini privati in nome proprio come la
Dichiarazione islamica di Abu al-Hassen Bani Sadr, primo Presidente della
Repubblica Iraniana2. Ci sono numerosi altri documenti che non sono delle
dichiarazioni vere e proprie3.
3) Le Dichiarazioni redatte da organizzazioni internazionali, adottate
dall’Organizzazione della Conferenza Islamica e dalla Lega degli Stati Arabi,
due organizzazioni internazionali. La prima è la cosiddetta “Dichiarazione dei
diritti dell’uomo nell’Islam” (non da confondere con la Dichiarazione islamica
universale dei diritti dell’uomo), adottata alla XIX Conferenza dei Ministri degli
Affari Esteri tenutasi al Cairo dal 31 luglio al 5 agosto 1990. La seconda si
chiama “Carta araba dei diritti dell’uomo”. Essendo queste due Dichiarazioni le
più importanti, vorrei delineare le circostanze in cui furono adottate.
A) La Dichiarazione dei diritti dell’uomo nell’Islam - OCI, 1990
L’Organizzazione della Conferenza Islamica, la cui prima riunione dei capi
di Stato si svolse a Rabat nel 1969, diventò, nel 1972, un’organizzazione di
cooperazione internazionale dopo l’adozione della sua Carta. E’ la prima
organizzazione internazionale a scegliere la religione come criterio di adesione.
Riunisce gli Stati di diversi continenti al fine di “consolidare la solidarietà e
rinforzare la cooperazione fra Stati membri”. I suoi organi principali sono la
“Conferenza dei re, capi di Stato e di governo”, la “Conferenza dei Ministri degli
Affari Esteri” (MAE: l’organo che ha adottato la Dichiarazione) e il
“Segretariato”4 . A questo punto vorrei descrivere, in breve, le diverse tappe
dell’adozione di questa Dichiarazione:
1978: Un seminario tenutosi a Niamey (Niger) sul tema “Le libertà e i diritti
dell’uomo nell’Islam” adotta un documento intitolato “Dichiarazione di
Niamey sulle libertà e i diritti dell’uomo e il loro posto nell’Islam”.
1979: Il Segretario Generale presenta le raccomandazioni di questo
seminario alla X sessione della Conferenza dei MAE che le adotta e decide
l’istituzione di una commissione consultiva composta da esperti nominati dagli
Stati per preparare un “documento” (wathiqa) in merito (ris. 9/10 della
Conferenza dei MAE). Allo stesso tempo, il Segretario rende noto una “bozza
per una Dichiarazione dei diritti e doveri dell’uomo nell’Islam”, composta da 31
articoli5.
-
A. Bani Sadr, Le Coran et les droits de l’homme, Paris, Maisonneuve & Larose, 1989 (la
seconda parte contiene una carta in cui è stato adottato lo stesso metodo di quello del Consiglio, che
Islamico, che consiste nell’integrare dei riferimenti religiosi negli articoli).
2
Ad esempio il progetto di Costituzione islamica elaborato dall’Accademia delle Ricerche
Islamiche del Cairo, pubblicato dalla rivista Al-Azhar, aprile 1979; il modello di costituzione
islamica del Consiglio Islamico d’Europa, 1983... Cfr. altri testi: A. E. Mayer, Islam and Human
Rights. Westview Press, Boulder & San Francisco, Pinter Publications, 1991. (Il libro analizza
rapidamente la Dichiarazione del 1981, ma contiene una buona presentazione dei soggetti di
confronto tra Islam e diritti umani). Islamo-Christiana, 1983, no. 9, contiene delle traduzioni della
Dichiarazione del 1981 e uno dei numerosi progetti che hanno precorso la Dichiarazione del Cairo.
3
4
Cfr. B.Taoufik, L’OCI, AFDI, 82, 265-291.
5
Pubblicata dalla rivista della Lega Musulmana Mondiale (in arabo), Mecca, dic. 1979.
1980: L’XI Conferenza dei MAE, nella sua risoluzione 19/11, chiede al
Segretario Generale di istituire una commissione composta da “studiosi di
diritto
islamico” al fine di studiare il “documento” già redatto, e che ha
il compito di
dargli una copertura religiosa. La commissione di
giureconsulti islamici si rinunisce per elaborare un nuovo documento da
sottoporre agli Stati.
-
1980-1989: Il “documento” circola, varie volte, tra le commissioni di
esperti, i
rappresentanti degli Stati che fanno delle osservazioni, e i tre
organi principali.
Nel dicembre, a Teheran, si tiene l’ultima riunione della commissione di
studiosi di
diritto, incaricata di stilare la versione definitiva del
“documento”. Quest’ultima
riunione è doppiamente importante per
quanto riguarda la forma. In primo luogo,
nel corso della riunione, il
Segretariato propone di modificare il titolo del
“documento”,
chiamandolo “Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo”. In
seguito,
alcuni Stati sembrano porre delle riserve sulla natura giuridica della
Dichiarazione. Ad esempio, si è detto che la delegazione indonesiana
avesse
pronunciato delle riserve sull’articolo 28 della bozza, che
recita: “Gli Stati membri convengono di prendere tutte le misure necessarie
per attuare le disposizioni di
questa Dichiarazione”. L’Indonesia
condiziona il suo accordo all’emendamento
seguente: “gli Stati
membri convengono ... in quanto queste disposizioni siano in
accordo
con le loro leggi interne”. Infine, la Dichiarazione è adottata al Cairo alla
XIX sessione della Conferenza dei MAE (ris. 49/19-P).
La Dichiarazione non è un trattato internazionale. L’articolo 28 incriminato,
che esisteva nella maggior parte delle versioni precedenti, sparì dalla versione
definitiva della Dichiarazione in 25 articoli: la risoluzione 49/19 presa dalla
Conferenza dei MAE che adottò la Dichiarazione si accontentò di dire che la
Dichiarazione “rappresenta degli orientamenti generali per gli Stati”6. La
Dichiarazione fu, nonostante ciò, adottata da un organo principale, la
Conferenza dei MAE, competente a prendere tali decisioni (art. 5 della Carta),
sebbene questo organo non eguagli in dignità la Conferenza al vertice dei re,
capi di Stato e di governo, istanza suprema dell’Organizzazione. Del resto ci si
aspettava che la Conferenza dei capi di Stato tenutasi un anno dopo, nel 1991,
a Dakar (Senegal), approvasse questa Dichiarazione. Ciò non si è verificato,
però non è escluso che la Conferenza lo farà un giorno! In questa occasione si
svolsero varie manifestazioni, organizzate da ambienti sensibili ai diritti umani. Il
9 dicembre 1991, alla vigilia della riunione di Dakar, la Commissione
internazionale dei giuristi (Ginevra) pubblicò un comunicato stampa molto
severo. Facendo della legge religiosa (Shari’a) la fonte “automatica e
dogmatica” dei diritti dell’uomo, la Dichiarazione “1. Rompe il consenso tra
culture su cui si basano gli strumenti internazionali. 2. Giustifica la
discriminazione delle donne e le persone non musulmane. 3. Limita ancora
maggiormente i diritti acquisiti in certi paesi islamici. 4. Avalla le pene corporali,
incompatibili con l’integrità fisica e la dignità dell’uomo”.
6
Versione araba. OCI, doc. (LEG.DR.TXT)-M3.
La Dichiarazione ha, finora, un valore politico, filosofico e ideologico. Un
valore politico perché è riuscita a riunire Stati islamici molto diversi tra di loro:
mentre gli uni hanno una popolazione prevalentemente islamica, altri Stati,
specie africani, sono islamici solamente di nome o perché la religione del loro
capo di Stato è l’Islam (il Gabon, il Senegal ...). Gli uni sono sunniti (in
riferimento alla tradizione dominante dell’Islam), gli altri sono sciiti (l’Iran) o
hanno una minoranza sciita (l’Irak, il Bahrein...); gli uni sono monarchie
conservatrici (i Paesi del Golfo), gli altri sono delle Repubbliche laiche (in
particolare la Turchia). Infine, gli uni hanno aderito, in maniera selettiva, agli
strumenti internazionali più importanti relativi alla salvaguardia dei diritti umani,
mentre altri sono reticenti a questo riguardo (l’Arabia Saudita)7. E’ naturale che
queste differenze pongano il problema dell’armonizzazione delle legislazioni
con la Carta. Per quanto riguarda il valore filosofico, non bisogna minimizzarlo
perché il movimento a favore dell’islamizzazione dei diritti umani ha delle
profonde radici intellettuali e politiche. Infine, c’è un valore ideologico poiché le
Dichiarazioni che emanavano dagli ambienti intellettuali e politici hanno
proceduto, dagli anni ‘80, di pari passo. Per meglio dire: le Dichiarazioni degli
ambienti intellettuali costituirono l’armatura intellettuale delle Dichiarazioni
statali nel senso che, ad esempio, la Dichiarazione del Consiglio islamico
d’Europa del 1981 integra negli articoli stessi il loro fondamento religioso
(Corano e tradizione profetica), il che non vale per le numerose bozze dell’OCI
che sono sfociate nella Dichiarazione del Cairo.
B) La Carta araba dei diritti dell’uomo
Viene adottata dalla Lega degli Stati arabi, un’organizzazione
internazionale, creata nel 1945 e composta, attualmente, da 22 Stati arabi.
- 1968: Il Consiglio della Lega, l’organo principale paragonabile alla Conferenza
dei
MAE dell’OCI, istituisce la “Commissione permanente araba dei
diritti dell’uomo”, in seguito ad una raccomandazione del Segretario Generale
delle Nazioni Unite che invita gli Stati a celebrare il 20 anniversario della
Dichiarazione del 1948. Questa Commissione sarà, d’ora in avanti, parte
integrante della struttura dell’organizzazione.
- 1970: Il Consiglio approva una risoluzione al fine di elaborare una
Dichiarazione araba
dei diritti dell’uomo.
- 1971: La Commissione elabora la prima bozza intitolata “Dichiarazione dei
diritti del
cittadino negli Stati e Paesi arabi”. Numerose risoluzioni
approvate in questa
direzione, sono rimaste senza esito.
- 1985: Dopo essere stata richiamata, la Commissione elabora un’altra bozza
intitolata
“Carta araba dei diritti dell’uomo”.
- 1994: Non ci si aspettava che, nel mese di settembre, il Consiglio della Lega
avrebbe
adottato la Carta (di 43 articoli)8. Ma a dire il vero, in fondo
non ha fatto altro
che riprendere la bozza del 1985, senza fare
modifiche notevoli.
7
Cfr. tavola allegata sulle adesioni alle convenzioni internazionali.
8
Cfr. Revue arabe des droits de l’homme, 2 anno, no. 2 ott. 1995, p. 213.
A differenza della Dichiarazione del Cairo, la Carta araba è un trattato
aperto alla firma e ratifica degli Stati arabi (artt. 42-43). Il suo contenuto più
universale si allontana ugualmente da quello della Dichiarazione del Cairo. E’
proprio quello che spiega probabilmente la sua adozione, dato che parte degli
Stati arabi (tutti membri dell’OCI) laici e moderni vollero manifestare, in fondo, il
loro disaccordo con la Dichiarazione del Cairo, sebbene il preambolo della
Carta riaffermi il suo legame, tra l’altro, con la Dichiarazione del Cairo. Una
clausola di stile, come vedremo in seguito. Sette Stati arabi, di cui sei dei più
conservatori, l’inserirono per esprimere la loro volontà di non essere legati dalla
Carta, incompatibile con la Dichiarazione del Cairo e con la loro legge interna9.
Il consenso del Cairo non esiste più. Tutto si verificò come se gli Stati che non
volevano fare della Shari’a la fonte del diritto, avessero riattivato la Carta araba
del 1985 dopo aver firmato la Dichiarazione del Cairo.
L’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Kuweit, l’Oman, il Sudan e lo
Yemen.
9
II. UNIVERSALITA’ E PARTICOLARITA’
La Carta costitutiva della Lega (1945) e quella dell’OCI (1972) non
contengono nessun riferimento ai diritti dell’uomo. Allora come bisogna
spiegarsi questo ritorno alla ribalta del discorso dei diritti umani? In primo luogo,
il fatto che i rapporti internazionali si strutturano sempre più sul rispetto dei diritti
dell’uomo ha costretto gli Stati a dimostrare la volontà di adottarli. Ne risulta che
le Dichiarazioni tendono ad inglobare i diversi tipi di diritti esistenti negli
strumenti internazionali nonché i diritti delle varie generazioni facendone il
catalogo, però dal punto di vista islamico o arabo. In secondo luogo, l’adozione
di Dichiarazioni rientra nel quadro generale di una sfida teorica in cui
l’universalità è opposta alla particolarità. Nel caso dell’Islam, si presenta sotto la
forma seguente: bisogna islamizzare la modernità o modernizzare l’Islam?
Infine, invece di sviluppare delle considerazioni generiche, vorrei esporre come
si pone concretamente il problema nelle Dichiarazioni. Notiamo che, dal punto
di vista strutturale, le Dichiarazioni islamiche private non si distinguono da
quelle pubbliche, proprio come le Carte arabe pubbliche e quelle private. Invece
esiste una maggiore differenza tra le Dichiarazioni islamiche d’un lato e quelle
arabe, dall’altro. Le Dichiarazioni islamiche sono, fondamentalmente,
particolaristiche, mentre le Carte arabe sono più equilibrate. Nel primo caso, il
nodo gordiano è la Shari’a, nel secondo caso l’”arabità”. Dunque “prendiamo il
nemico di petto”, come diceva Kant, e cerchiamo di districare il nodo.
SHARI’A E DIRITTI UMANI
Nel 1989, a Teheran, si svolse la riunione della Commissione dei giuristi
incaricati di stabilire la versione definitiva della Dichiarazione. Nel suo discorso
inaugurale, l’Ayattolah Yazdi, Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura della Repubblica Iraniana, affermò che “la Commissione ha il
compito di tradurre la legge divina in una legge positiva poiché la visione
islamica dei diritti umani si distingue per ... la sua completezza”10. Secondo i
redattori della Dichiarazione la Shari’a poteva avere almeno due sensi.
a) In senso ampio, essa è la via, la Parola, i Comandamenti di Dio - una
specie di visione islamica del mondo (Weltanschauung). In questo caso, Islam,
religione, civiltà e tradizione storica e Legge sono identici. Le Dichiarazioni di
carattere islamico consacrano il primo senso nel Preambolo ed in un certo
numero di disposizioni: la valorizzazione apologetica della nazione islamica, “la
migliore delle comunità”, l’idea di vicariato, soggezione e servitù a Dio, l’obbligo
di ubbidienza, l’equilibrio tra fede e scienza, l’Islam come “religione naturale”, la
vita come “dono divino”, l’etica religiosa attiva (ordinare il bene e vietare il
male).
b) In senso ristretto, la legge positiva, l’insieme dei diritti accordati, degli
obblighi e divieti prescritti all’uomo dalla religione. Questo secondo senso è
decisamente più problematico dato che ci troviamo davanti ad un catalogo di
diritti ritenuti “essere parte integrante della religione”, la cui fonte divina e la cui
incompatibilità con l’universalità sono costantemente oggetto di un dibattito. Più
precisamente: quali sono i diritti e doveri enunciati dalla Shari’a ed in che sono
OCI, rapporto della Commissione di esperti giuristi sui diritti dell’uomo nell’Islam.
Teheran, 26-28 dicembre 1998, allegato I, ICFM, 19-19/LEGD.2.(HRIS-89/REP.I), p. 5.
10
compatibili con gli standards internazionali e conformi agli strumenti positivi
internazionali?
Che dice la Shari’a riguardo ai diritti umani? E’ difficile dare una risposta.
Gli specialisti che si sono occupati della questione, Schacht, Goldziher e
Coulson, ammettono tutti che è una costruzione storica. Essenzialmente il
Corano enuncia alcune regole giuridiche nel campo del diritto civile
(matrimonio, eredità, filiazione...) e penale (legge del taglione, divieto dell’usura
e del furto...). La tradizione del Profeta e dei primi quattro successori è
intervenuta a rinforzare questi deboli rudimenti, a precisare le regole antiche o
ad aggiungerne di nuove. Per mezzo dell’interpretazione, la dottrina e la
giurisprudenza hanno costruito la Shari’a come un corpo di regole che il potere
politico ha consacrato come diritto oggettivo.
Stando così le cose, la Shari’a non può coprire l’intera gamma dei diritti
positivi moderni in cui i diritti sono rigorosamente delimitati e sempre più
frazionati. Ad esempio, la Shari’a non concede veramente dei diritti politici. La
Dichiarazione del Cairo nemmeno, e probabilmente per gli stessi motivi. Essa
dedica un solo comma al diritto alla partecipazione politica (art. 23b). La
Dichiarazione del Consiglio islamico, che è decisamente più radicale, arriva fino
al punto di non legittimare il diritto alla rivolta contro il tiranno (taghut) che non
applica la legge (art. 12). L’impressione di vuoto e le divergenze di
interpretazione giuridica sono state colmate dalla manipolazione semantica del
termine Shari’a nella Dichiarazione del Cairo, che, purtroppo, non è sempre
stata tradotta fedelmente nella versione francese del testo. A seconda dei casi,
essa si riferisce sia formalmente alla lettera della Shari’a in quanto tale, sia alle
sue qualifiche giuridiche (ahkam al-Shari’iya), sia ai suoi principi (mabadi’), sia
infine alla legge (char’). Il termine stesso shar’ è equivoco: può designare la
legalità come può designare la Legge religiosa. Ad esempio, la versione
francese dell’art. 19 parla di “uguaglianza davanti alla legge”, la versione araba
“davanti allo shar’“.
Volendo riassumere il rapporto tra Shar’ia e diritti dell’uomo all’interno
della Dichiarazione, si può fare la classificazione seguente:
1. Diritti compatibili con lo standard minimo sulla base dei documenti e del
consenso internazionali, indipendentemente dalla loro fonte (la Shari’a o il diritto
internazionale): la protezione della vita, il diritto alla personalità giuridica,
all’onore, alla reputazione personale, all’educazione, al lavoro, alla protezione
della specie umana, al rispetto dell’ambiente, al diritto dei popoli a disporre di
loro stessi...
2. Diritti profondamente in contraddizione con i principi, i documenti
internazionali ed il consenso interculturale. Questi sono decisamente più
numerosi. La Dichiarazione afferma la legge del taglione (art. 2a), ammette
l’attentato all’integrità fisica e, per conseguenza, le sanzioni penali di carattere
fisico nell’Islam dette hududs (art. 2d)11; discrimina la donna assegnandole dei
diritti e dei doveri limitati conformemente alla Legge religiosa (art. 6); istituisce
la religione islamica come religione naturale dell’uomo, cui vieta di cambiare
religione o di diventare ateo (art. 10). Vieta il tasso d’usura (art. 14).
11
Nella tradizione giuridica le sanzioni penali dette limiti (hududs) prendono nome dal fatto
che queste sanzioni tracciano dei limiti e sono loro stesse delle sanzioni limite imperativamente
attuate.
3. Diritti condizionati dalla Shari’a, cioè esercitati o in accordo con la Shari’a o
in maniera tale da non essere in contrasto con essa. Di alcuni diritti si dichiara
che sono in “accordo” con i principi della Shar’ia (diritti del fanciullo, art. 7) o che
il loro godimento non deve essere in contrasto con “i principi della Shar’ia”
(libertà di circolazione: art. 12 e libertà d’espressione: art. 21).
Insomma: la Shari’a struttura la Dichiarazione, fonda i diritti, è la
condizione del loro esercizio, è il limite da non oltrepassare e il punto di
riferimento in materia d’interpretazione (art. 24).
L’ ”ARABITA’ ” FRA UNIVERSALITA’ E PARTICOLARISMO
Credo che non sia necessario sviluppare più a lungo considerazioni
generali sull’”arabità”, se è un carattere etnico, una cultura o un’ideologia.
L’”arabità”, come si evince dalla Carta, si riferisce ai seguenti elementi:
1) Una certa idea della nazione araba, o di ciò che si potrebbe definire un
umanesimo arabo classico: “una nazione che crede nella dignità dell’uomo, dal
momento che Dio l’ha privilegiato o onorato facendo proprio della terra araba la
culla delle religioni e il luogo delle civiltà e che ha contribuito all’instaurazione di
princìpi e valori umani” (preambolo). Ciò implica, fra l’altro, il diritto dei cittadini
di vivere in un clima culturale che promuova la fierezza d’appartenere alla
nazione araba” (art. 35), il diritto d’acquisire un’altra nazionalità senza perdere
la propria (art. 24).
2) Una rivendicazione dei diritti nazionali. La Carta di Siracusa consacra
una parte intera a questi diritti. Meno prolissa, ma altrettanto ferma, la Carta
della Lega li enuncia in primo luogo e nella prima sezione in un solo articolo: il
diritto dei popoli di disporre di loro stessi e delle loro ricchezze e la condanna
del razzismo, del sionismo, del colonialismo e della dominazione straniera (art.
1a e b). Lo si constata ugualmente nella relazione stabilita tra i diritti dell’uomo
e la pace, enunciata nel preambolo e nel riferimento alla “sicurezza araba” che
giustifica agli occhi dei redattori certi limiti alla libertà di riunione e di
manifestazione pacifica (art. 28).
Ora, in che questa Carta differisce dalla Dichiarazione del Cairo e in che
obbedisce allo standard dei diritti umani?
In primo luogo, la Carta riafferma nel preambolo il suo attaccamento ai
princìpi della Carta dell’ONU, la Dichiarazione del ‘48 e i Patti sui diritti civili,
politici, economici, sociali e culturali, e nello stesso tempo alla Dichiarazione del
Cairo. Ma questo riferimento è puramente formale, per tre ragioni. Prima di
tutto, nessun diritto enunciato nella Carta si riferisce alla Shari’a. In secondo
luogo, il preambolo si riferisce allo stesso tempo ai princìpi eterni di fraternità e
di eguaglianza istituiti dalla Shari’a e dalle altre religioni monoteiste. In terzo
luogo, la Carta, pluralista in materia religiosa, garantisce la libertà di fede
religiosa (art. 26), la libertà di culto e di espressione religiosa (art. 27) e il diritto
delle minoranze a godere della loro cultura (art. 37).
Inoltre, la Carta riprende, in modo conciso ma chiaro, i diritti fondamentali
e i diritti delle diverse generazioni per tutti “senza distinzioni di razza, sesso,
lingua ed ogni altra forma di discriminazione”: i diritti civili, politici, economici,
sociali e culturali. Sottolineiamo la responsabilizzazione dello Stato, che deve
curare che “nessuna persona che vive sul suo territorio sia oggetto di torture,
trattamenti umilianti e degradanti” (art. 13a). Notiamo parimenti che la pena
capitale è ammessa in caso di crimini gravi (art. 10) e vietata per i crimini politici
(art. 11).
Infine, la Carta si adopera a proteggere i diritti in due maniere. In primo luogo, vieta
agli Stati di limitare i diritti dell’uomo basandosi sulla legge, le convenzioni o la
consuetudine, o ancora arguendo dal fatto che la Carta non li enunci, o infine facendo
valere la regola della reciprocità fra Stati contro uno Stato che non li rispetti. Le sole
restrizioni ammesse sono convenzionali (stato d’emergenza, ordine pubblico ...) e,
anch’esse circondate da garanzie (sezione II, art. 3-4). In secondo luogo, essa istituisce
un meccanismo di protezione dei diritti. In effetti, la terza sezione (artt. 40-41) è riservata
alla creazione di un Comitato di esperti la cui funzione consisterebbe nell’esaminare
secondo una procedura giurisdizionale i rapporti periodici degli Stati. Il Comitato dovrà, in
seguito, indirizzare un rapporto alla Commissione permanente dei diritti dell’uomo in seno
alla Lega (creata nel 1968)12.
La Carta è all’avanguardia doppiamente, rispetto alla Dichiarazione del Cairo e alle
legislazioni interne degli Stati e della Lega. Elaborata in forma di trattato, avrà
probabilmente poche possibilità di entrare in vigore. E ammesso pure che questo accada,
è difficile vedere come degli Stati che non rispettano i diritti dell’uomo potrebbero
ammettere il controllo del Comitato di esperti e della Commissione permanente della Lega.
12
Notiamo che la Carta di Siracusa prevede, oltre a un Comitato che possa esaminare i ricorsi dei privati,
la creazione di una Corte araba dei diritti dell’uomo (artt. 55-51).