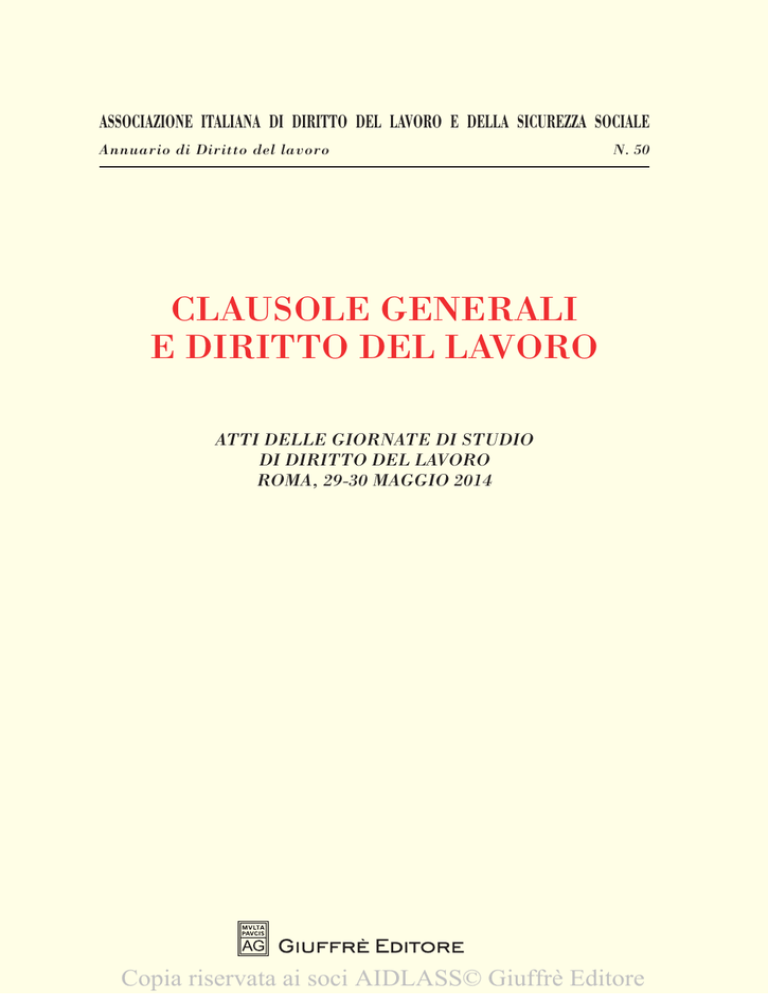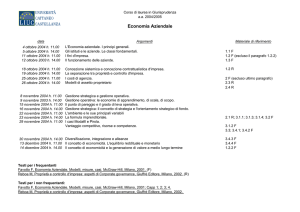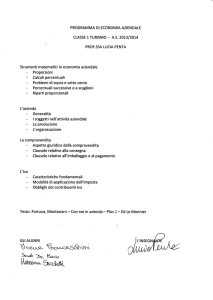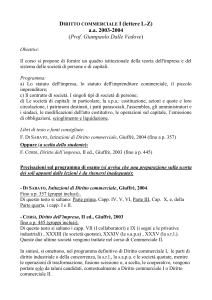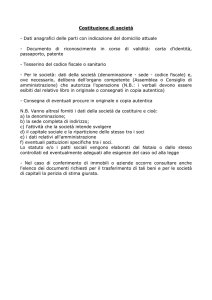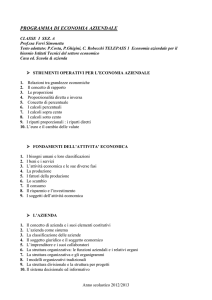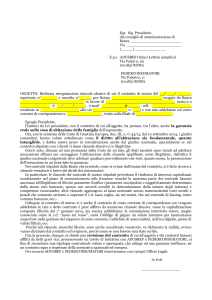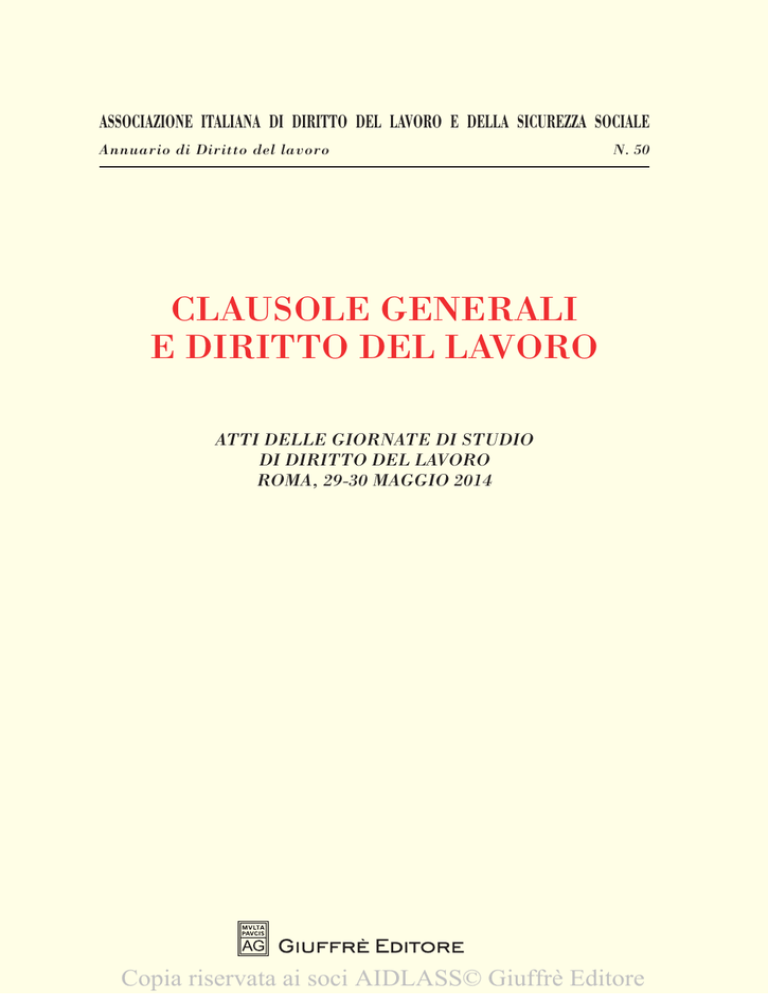
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE
Annuario di Diritto del lavoro
N. 50
CLAUSOLE GENERALI
E DIRITTO DEL LAVORO
ATTI DELLE GIORNATE DI STUDIO
DI DIRITTO DEL LAVORO
ROMA, 29-30 MAGGIO 2014
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ELENCO DEI PARTECIPANTI
Abbate Maurizio
Aimo Mariapaola
Albi Pasqualino
Alessi Cristina
Altavilla Renata
Alvino Ilario
Angelini Luciano
Aramini Federica
Arragoni Denise
Aversa Nilia
Azzoni Marco
Balducci Cataldo
Balletti Emilio
Bano Fabrizio
Barbieri Marco
Basenghi Francesco
Battisti Anna Maria
Bavaro Vincenzo
Bellardi Lauralba
Bellavista Alessandro
Bellomo Stefano
Berti Valerio
Bertocco Silvia
Bettini Maria Novella
Biagiotti Alice
Biasi Marco
Bolego Giorgio
Bollani Andrea
Bonanomi Gianluca
Bonardi Olivia
Borelli Silvia
Borghi Paola
Borghi Paola
Boscati Alessandro
Calafà Laura
Calcaterra Luca
Campanella Piera
Canavesi Guido
Cangemi Vincenzo
Cannati Giuseppe
Caragnano Roberta
Carinci Franco
Carinci Maria Teresa
Carta Cinzia
Casale Davide
Casillo Rosa
Castelli Arianna
Cerbone Mario
Cerreta Michele
Cester Carlo
Chapellu Daniele
Chiaromonte William
Chieco Pasquale
Ciucciovino Silvia
Comande’ Daniela
Corazza Luisa
Corrias Massimo
Corti Matteo
Cristofolini Chiara
Crotti Maria Teresa
D’Andrea Antonella
D’Aponte Marcello
D’Onghia Madia
De Angelis Luigi
De Camelis Raffaella
De Falco Fabrizio
De Felice Alfonsina
De Luca Michele
De Luca Tamajo Raffaele
De Marco Cinzia
De Mozzi Barbara
De Pasquale Giuliana
De Rosa Maddalena
De Salvia Azzurra
Del Frate Maria
Del Punta Riccardo
Delfino Massimiliano
Delogu Angelo
V
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Di Carlo Tiziana
Di Carlo Elena
Di Carluccio Carmen
Di Corrado Giovanni
Di Noia Francesco
Falcioni F.
Fagnoni Scilla
Falco Wanda
Faleri Claudia
Feltre Annalisa
Ferrara Maria Dolores
Ferraresi Marco
Ferrari Vincenzo
Ferrari Paola
Ferraro Fabrizio
Ferraro Francesco
Ficari Luisa
Filì Valeria
Filippi Marta
Foglia Laura
Fontana Giorgio
Forlivesi Michele
Franza Gabriele
Gabriele Alessia
Gaeta Lorenzo
Gambacciani Marco
Gambardella Angela
Gargiulo Umberto
Garilli Alessandro
Garofalo Carmela
Garofalo Domenico
Gentile Riccardo
Ghinoy Paola
Giasanti Lorenzo
Giordano Francesco Saverio
Giorgi Elena
Gottardi Donata
Gramano Elena
Grandi Barbara
Greco Maria Giovanna
Guarriello Fausta
Imberti Lucio
Imperio Michele
Izzi Daniela
Laforgia Stella
Lama Roberto
Lamberti Fabiola
Lamberti Mariorosario
Lassandari Andrea
Lattanzio Filippo
Lazzari Chiara
Lazzeroni Lara
Lilla Olga
Lima Alessandro
Loi Piera
Loy Gianni
Lozito Marco
Ludovico Giuseppe
Lunardon Fiorella
Magnani Mariella
Magnifico Silvia
Mainardi Sandro
Mameli Veronica
Marasco Francesco
Marin A.
Marinelli Massimiliano
Marinelli Francesca
Martelloni Federico
Martone Michel
Marzani Marco
Mattarolo Maria Giovanna
Mcbritton Monica
Meiffret Francesco
Menghini Luigi
Mezzacapo Domenico
Mieli Giorgio
Mocella Marco
Montanari Anna
Monterossi Luisa
Mormile Paolo
Mugneco Joanna
Muratorio Alessia
Naseddu Luca
Natullo Gaetano
Negri Giulia
Nicolosi Marina
Nicosia Gabriella
Nunin Roberta
Nuzzo Valeria
Occhino Antonella
Olivelli Filippo
Olivelli Paola
Pacchiana Parravicini Giovanna
Palladini Susanna
Pallini Massimo
Pandolfo Angelo
VI
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Panizza Giovanni
Pasqualetto Elena
Passalacqua Pasquale
Pederzoli Chiara
Persiani Mattia
Perulli Adalberto
Peruzzi Marco
Pessi Roberto
Pessi Annalisa
Pilati Andrea
Pino Giovanni
Piovesana Anna
Pistore Giovanna
Poli Davide
Ponte Flavio Vincenzo
Pozzaglia Pietro
Proia Giampiero
Prosperetti Giulio
Putignano Nicola
Raimondi Enrico
Rampazzo Angela
Ranieri Maura
Ratti Luca
Razzolini Orsola
Ricci Maurizio
Riccobono Alessandro
Romei Roberto
Ronchi Adelaide
Rosati Assia
Rota Anna
Ruggeri Domenico
Russo Marianna
Salimbeni Maria Teresa
Salvalaio Manuela
Santoni Francesco
Santoro Passarelli Giuseppe
Santucci Rosario
Saracini Paola
Scarpelli Franco
Schiavetti Flavia
Sena Eufrasia
Serrano Maria Luisa
Sgarbi Luca
Sigillò Massara Giuseppe
Siotto Federico
Sitzia Andrea
Speziale Valerio
Spinelli Carla
Squeglia Michele
Stolfa Francesco
Talarico Milena
Tampieri Alberto
Tebano Laura
Testa Felice
Timellini Caterina
Tomba Caterina
Topo Adriana
Tosi Paolo
Trojsi Anna
Tullini Patrizia
Valcavi Gian Paolo
Valente Lucia
Valenzi Ilaria
Vallauri Maria Luisa
Varone Carlamaria
Varva Simone
Ventura Alessandro
Villa Ester
Vimercati Aurora Adriana
Vinciguerra Maria
Viscomi Antonio
Zampini Giovanni
Zilio Grandi Gaetano
Zoli Carlo
Zoppoli Antonello
Zoppoli Lorenzo
VII
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Parte Prima
RELAZIONI E INTERVENTI
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Giovedì 29 maggio 2014 - mattina
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
DIRITTO DEL LAVORO E NOZIONI
A CONTENUTO VARIABILE
di GIANNI LOY
Ai salici di quella terra
Appendemmo le nostre cetre
(Salmo 136.2)
SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La dogmatica delle clausole generali nella elaborazione di Luigi
Mengoni. — 3. Il seguito del dibattito. — 4. Una più ampia nozione di clausola
generale all’interno dello schema elaborato da Mengoni. — 5. Un interesse che
prosegue ed evolve. — 6. Le fonti di integrazione delle clausole generali tra regole
interne e regole esterne al diritto positivo. — 7. L’ermeneutica delle clausole generali
e l’incontenibile potere del giudice. — 8. Ermeneutica delle clausole generali ed
arbitrio giudiziale. — 9. Ermeneutica delle clausole generali: sindacato di Cassazione
e funzione della giurisprudenza. — 10. Le clausole generali nell’antinomia tra certezza
del diritto ed evoluzione del sistema. — 11. Clausole generali e tensione tra i poteri
dello Stato. — 12. Conclusioni. — 13. Conclusioni (due).
1. Premessa.
Nel 1985, in occasione delle giornate di Studio organizzate
dalla Scuola superiore di studi universitari di Pisa, in onore di Ugo
Natoli, Luigi Mengoni ha portato un fondamentale contributo alla
sistemazione teorica delle clausole generali. Nel farlo, proprio in
quell’occasione, affermava che “la materia delle clausole generali
attende ancora una sistemazione teorica definitiva sia sul piano
dell’elaborazione di appropriati modelli argomentativi, sia sul
piano dogmatico (1). Quell’affermazione, a quasi 30 anni di distanza, può essere ritenuta ancora valida. Nonostante alcuni sviluppi, sulla sistemazione teorica non sono stati fatti significativi
(1)
Mengoni, 1986, 8.
5
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
passi avanti rispetto alla costruzione di Mengoni che, proprio sul
piano analitico, continua a costituire un imprescindibile riferimento anche per la più recente dottrina.
L’interesse della materia, già a partire dagli anni ’60, era
determinato soprattutto dal contributo che la teoria delle clausole
generali avrebbe potuto apportare nel superamento di un giuspositivismo che pretendeva codici completi ed esaustivi, norme precise in grado di individuare fattispecie determinate e discipline
dettagliate (2).
Le clausole generali consentivano, e consentono, grazie alla
loro elasticità, da un lato un’apertura verso le nuove esigenze di
una società in trasformazione, un adeguamento del sistema giuridico alla luce delle trasformazioni economiche e sociali, e dall’altro
lato l’ingresso nel sistema giuridico di contenuti meta giuridici.
L’interesse di Mengoni per le clausole generali deriva proprio dal
grado di apertura, da queste consentito, all’ordinamento giuridico.
Non a caso il contributo di Mengoni, come è stato recentemente
ricordato, costituisce “un messaggio denso di umanità che va oltre
il diritto e si apre ai valori etici: non sempre comunemente apprezzati, pur essendo nel loro complesso la precondizione della convivenza” (3).
In quegli anni, si parlava di una nuova “legislazione per
principi” (4), veniva enfatizzata la “stagione delle clausole generali” e vi era la consapevolezza del fatto che l’adozione delle
clausole generali avrebbe potuto comportare profonde conseguenze sul sistema, sulle regole dell’interpretazione, sul potere dei
giudici, cioè una profonda modifica, se non un ribaltamento, degli
equilibri che il positivismo giuridico riteneva consolidato.
Molta acqua è passata sotto i ponti. Quell’aspettativa, all’epoca, non ha visto la luce, ma il sistema ha continuato ad
evolvere, grazie al fatto che le tensioni innovative hanno trovato
anche altri canali di espressione. Il differente contesto muta anche
la prospettiva dell’analisi, recentemente ritornata d’attualità,
mantenendo, però un punto in comune, qualificante, relativo agli
effetti indotti dall’utilizzo delle clausole generali ma anche, come si
(2) Gentili, 2010, IX ss.
(3) Rusciano, 2011, 988.
(4) Rodotà. 1967, 89 ss.
6
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
vedrà, di altri strumenti analoghi caratterizzati dall’indeterminatezza.
L’espansione delle clausole generali e delle nozioni a contenuto
variabile nel diritto, va compresa alla luce del più ampio fenomeno
della crisi del mito della certezza e della razionalità del diritto, a
causa di una complessa serie di fenomeni, tra i quali Weber
evidenzia le caratteristiche e le forme assunte dalla produzione
capitalista (5), nonché l’emersione di un modello di società pluralista che sfocia spesso nel conflitto tra i gruppi sociali e che,
contemporaneamente, si manifesta nella perdita di centralità del
diritto di derivazione statuale, espresso attraverso il modello della
legge generale ed astratta nella forma del comando sanzione. La
crisi di tale modello regolativo è causa dell’evoluzione delle tecniche regolative di fronte alla complessità del reale. Una delle manifestazioni più evidenti della crisi regolativa della legge, incapace
di cogliere la complessità dei fenomeni economici e sociali, è
rappresentata dall’iper-regolazione, dall’eccesso di giuridificazione (6), col rischio, evidenziato da Habermas (7), della colonizzazione della realtà.
Negli stessi termini di confronto tra complessità della realtà
economica e sociale e regolazione giuridica, possono essere lette le
teorie sistemiche e autopoietiche del diritto che concepiscono il
diritto, lo Stato, e l’economia come sistemi operativamente chiusi
e cognitivamente aperti, secondo le quali la regolazione della realtà
non è altro che autoregolazione del sistema giuridico (8).
Un altro evidente risultato della crisi regolativa della legge è
rappresentato dalla proliferazione dei soggetti normativi: la legge
da sostanziale si fa procedurale e, al fine di devolvere le funzioni
normative, si limita ad individuare soggetti e procedure, attraverso le quali saranno definiti i contenuti normativi. La proceduralizzazione del diritto è un epifenomeno della stessa crisi regolativa che, come si è detto, ha portato all’espansione delle clausole
generali e delle nozioni variabili nel diritto: è la difficoltà di
regolare complessi fenomeni economici e sociali attraverso norme
di carattere sostanziale, che porta a lasciare spazio alle norme
(5)
(6)
(7)
(8)
Weber, 1999, 196 ss.
Sul tema della giuridificazione nel Diritto del lavoro: Vardaro, 1984; Giugni, 1986.
Habermas, 1986, 204 ss.
Teubner, 1992.
7
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
procedurali. Nel diritto del lavoro, in particolare, questa tecnica
regolativa si è consolidata attraverso la devoluzione alla contrattazione collettiva delle funzioni normative della legge, attraverso
forme diverse, spesso descritte come deregolamentazione. Ogni
qualvolta la legge non possa, a causa della complessità degli
interessi coinvolti, definire una norma sostanziale, si devolve il
potere normativo al contratto collettivo, individuando i soggetti e
le procedure.
Nei sistemi giuridici proceduralizzati la legittimazione e la
razionalità del diritto si pongono in termini del tutto inediti e,
secondo Habermas, sono i diritti di legittimazione democratica e
l’affermazione di spazi deliberativi democratici (9) a costituire il
fondamento dell’ordinamento giuridico.
Nel dibattito sulle clausole generali sono da evidenziare due
aspetti fondamentali di contesto. Il primo riguarda il fatto che il
dibattito sulle clausole generali e l’adozione di questa tecnica da
parte del legislatore ha travalicato l’alveo del diritto privato, per
lungo tempo sede privilegiata del dibattito, per interessare altre
discipline. Per un verso, è accresciuta la consapevolezza in materie,
come il diritto costituzionale, già direttamene coinvolto nel processo, ma si è estesa anche a settori tradizionalmente resistenti,
proprio perché caratterizzati da un principio rigidamente formalistico, come il diritto amministrativo, dove le norme a contenuto
elastico, anche per l’influsso della disciplina dell’Unione europea,
sembrano trovare oggi un terreno particolarmente fertile.
In secondo luogo, sono cambiate le voci critiche. I nostri
colleghi giuslavoristi che, sulla scia dell’interesse suscitato nell’ultimo scorcio degli anni ’80 del secolo scorso, hanno approfondito la
materia, hanno dovuto dar conto delle critiche mosse dai settori
più conservatori del formalismo giuridico che paventavano, con
l’avvento delle clausole generali, il superamento del metodo, quello
deduttivo, incentrato sulla sussunzione. Temevano, cioè, il venir
meno di quella vagheggiata certezza e completezza che l’ordinamento avrebbe potuto e dovuto garantire.
La più attenta dottrina, in quegli anni, avvertiva il carattere
strutturale del cambiamento che si stava producendo nell’economia e nella società: non si trattava semplicemente di uscire dalla
(9) Habermas, 1996, 490.
8
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
fase della legislazione dell’emergenza, ma di trovare nuove soluzioni per nuovi bisogni (10) anche sul piano del modello legislativo
e delle tecniche di governo del conflitto. Si trattava di invertire la
rotta rispetto ad un interventismo legislativo eccessivo e non più in
grado di governare le trasformazioni in atto nell’economia reale.
Possibili strumenti sono stati individuati nella de-regolazione,
nella delega alla contrattazione collettiva, nell’apertura a forme
alternative di soluzione dei conflitti, sino alla sperimentazione di
strumenti preventivi di regolazione, quali la certificazione.
Questa attenzione all’evoluzione del reale, tuttavia, che per
alcuni giuristi si è trasformata in un vero e proprio innamoramento
per l’economia e per le sue capacita, suppostamene taumaturgiche,
ha visto come contraltare il fatto che il prestatore di lavoro, con la
progressiva erosione del garantismo, in nome delle sempre più
impellenti esigenze di flessibilità e di competitività dell’impresa, ha
ripreso la sua tradizionale fisionomia di soggetto debole ed isolato.
Ancor più debole in quanto, mentre gli vengono sottratte alcune
delle tradizionali tutele legislative, a partire da quella, fondamentale, della stabilità, gli vengono riconosciuti, in quanto persona,
cittadino o prestatore di lavoro, nuovi diritti, quelli della terza
generazione, e vengono anche perfezionati i diritti sociali della
seconda generazione. Ciò almeno sulla carta, o meglio, soprattutto
nelle “Carte” dei diritti proclamate prevalentemente a livello sovranazionale. Il prestatore di lavoro viene così esposto alla duplice
privazione: di ciò che non ha più e di ciò che non ha ancora.
Posto che il sistema, affetto dalla patologia, ormai endemica,
dell’ineffettività, non è in grado di rispondere alla richiesta di
sicurezza (11) proveniente da questi “nuovi” soggetti, una parziale
risposta proviene proprio dall’utilizzo delle clausole generali presenti nel dettato costituzionale, la cui ampiezza consente, e non da
oggi (12), di offrire una almeno parziale risposta a questi nuovi
bisogni. L’attività giudiziale, superata la remora relativa alla sua
funzione creativa del diritto, dimostra, anche grazie al ricorso alle
norme elastiche o ai principi generali, di possedere strumenti idonei
alla soddisfazione di diritti che, altrimenti, potrebbero rimanere
largamente frustrati.
(10)
(11)
(12)
Treu, 1985, 387 ss.; Id., 2013.
Loi, 2000.
Tullini, 1990, 87.
9
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Attualmente, mi pare che le preoccupazioni di tipo sistematico
all’utilizzo di nozioni aperte siano state superate dai fatti. Semmai,
una ferma opposizione all’utilizzo delle clausole generali deriva,
oggi, dalle teorie ispirate all’analisi economica, che concepisce le
clausole generali “come semplice ausilio rispetto alla razionalità
limitata degli agenti e come possibile rimedio ai c.d. fallimenti del
mercato” (13). L’idea di poter governare società complesse ricorrendo a clausole generali è ritenuta “altamente illusoria”. Il vuoto
derivante dal venir meno dei valori organicamente condivisi, è
inevitabile che “venga tendenzialmente riempito dalle compatte
concezioni tecnocratiche piuttosto che dalle sfrangiate concezioni
moralistiche” (14). Il riferimento, ovviamente, non è solo alle
clausole generali in senso stretto, bensì a tutte le situazioni in cui
l’interprete disponga di un significativo potere valutativo sul significato della norma.
Tralasciando, per il momento, ulteriori approfondimenti (15) si
osserva che le teorie ispirate al vecchio formalismo giuridico e
quelle sostenute dalla Laws & Economics hanno in comune l’idea
di una giurisprudenza solo dichiarativa dove il giudice debba: o
limitarsi alla ricerca dell’unica soluzione corretta indicata dal
legislatore, o svolgere una funzione meramente notarile (16) delle
transazioni che dovrebbero, sostanzialmente, essere governate dall’economia.
La differenza sta nel fatto che, a fronte della pretesa funzione
solo dichiarativa della giurisprudenza, cui è bene incominciare a
riconoscere anche il patronimico, potere giudiziario nell’ambito
della teoria della separazione dei poteri, la funzione creativa apparterrebbe: nella visione tradizionale al potere legislativo, nella
visione di Laws & Economics al sistema economico.
Nella strategia generale sottesa al dominio, senza voler per il
momento anticipare giudizi di merito, l’importanza del possesso di
palla è evidente. Un potere giudiziario che riesca a ritagliarsi uno
spazio nel processo di creazione del diritto diventa un ostacolo sia
alle pretese di governo assoluto del principe, preoccupazione
dell’origine, che alle pretese monopolistiche dell’economia, preoc(13)
(14)
(15)
(16)
Denozza, 2009, 31 ss.
Denozza, 2011, 16.
Per i quali si rinvia, alle due differenti posizioni di Persiani, 2000, e Perulli, 2013.
Perulli, 2013, 2.
10
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
cupazione odierna. E poiché le clausole generali, le norme elastiche, i principi generali e quant’altro di indeterminato sia alla
portata del potere giudicante, si configura quale tecnica ed allo
stesso tempo quale legittimazione di un potere non più soltanto
dichiarativo, ecco che tali strumenti finiscono per acquistare un
rilievo di straordinaria importanza nelle strategie di evoluzione del
sistema.
Accanto a tale funzione “straordinaria”, delle norme a contenuto variabile, non soltanto, quindi, delle clausole generali in senso
stretto, si accompagna anche una loro funzione “ordinaria”. In
questo caso, sono concepite quali mere tecniche di regolazione, con
più limitate implicazioni ideologiche, che registrano differenti
gradi nello stabilire sino a quale dettaglio possa o voglia spingersi
la norma-regola.
2. La dogmatica delle clausole generali nella elaborazione di Luigi
Mengoni.
Il dibattito sulle clausole generali, in Italia, è caratterizzato da
due percorsi, paralleli. Un primo filone dottrinale si è soffermato
soprattutto sull’applicazione di una serie di norme che, in quanto
caratterizzate da un contenuto almeno parzialmente indeterminato, postulano una attività integrativa, o discrezionale, del giudice, suscettibile, in principio, di modificare lo schema tipico di un
ordinamento ispirato agli schemi del positivismo. Questa dottrina,
con minori pretese di rigore analitico, faceva riferimento ad una
nozione particolarmente ampia, che poteva comprendere, a volte
ritenendole varianti semantiche, a volte figure equivalenti, formule come principi generali, norme elastiche, clausole generali,
equità, etc. Il suo interesse era determinato prevalentemente dalla
valenza di tale tecnica legislativa in termini di politica del diritto.
L’orientamento “favorevole” alla diffusione di questa tecnica di
governo, ad esempio, riteneva che una sua diffusione avrebbe
consentito al sistema giuridico un positivo dialogo con una realtà in
continua evoluzione, posto che l’ordinamento giuridico, in quella
fase, non appariva in grado di rispondere alle sempre più mutevoli
e imprevedibili esigenze della società.
11
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
È in questo clima che nasceva la proposta di una legislazione
per principi (17).
Nel frattempo, un’altra parte della dottrina, è impegnata nella
costruzione di una teoria analitica della clausole generali che, a
partire dall’elaboratone della dottrina tedesca, trova una prima,
compiuta, sistemazione nel 1987 con il saggio di Luigi Mengoni. Si
tratta di una trattazione che, tuttora, rappresenta un imprescindibile riferimento per chi voglia condurre l’esame sotto il profilo
analitico. L’analisi di Mengoni si sofferma, essenzialmente, sulla
nozione di clausola generale, esaminata dal punto di vista dogmatico, con la preoccupazione di distinguerla da quelle, più somiglianti, quali la norma generale o il principio generale.
La clausola generale, per Mengoni, è una tecnica giudiziale
“che delega al giudice la formazione della norma (concreta) vincolandolo ad una direttiva espressa attraverso il riferimento ad uno
standard sociale” (18). La clausola generale, pertanto, non contiene “un modello di decisione precostituito da una fattispecie
normativa astratta” tale da potere essere posto a premessa di un
giudizio sussuntivo. Si tratta norme incomplete, “frammenti di
norme”, che non possiedono neppure una propria autonoma fattispecie, “essendo destinate a concretizzarsi nell’ambito di programmi normativi di altre disposizioni” (19). Lo standard sociale,
contrariamente ad alcune perduranti letture, che lo farebbero
coincidere con la stessa clausola generale, è esterno ad essa (20), si
tratta di una norma sociale di condotta cui il giudice è chiamato a
fare riferimento. Vi è una profonda differenza, tuttavia, con la
concezione tradizionale, che intendeva la direttiva contenuta nella
clausola generale — pur consentendo al giudice di ricorrere a
nozioni dell’ordinamento extra-giuridico, alla morale, al costume,
etc. — come rigidamente vincolata alla ricerca di uno standard
(17) Rodotà, 1967.
(18) Mengoni. 1986, 15.
(19) Ivi, p. 11. Nello stesso senso Velluzzi, 2010. In senso contrario Libertini, 2011,
4, secondo il quale “il termine c.g. viene di solito impiegato per designare norme complete,
ancorché usualmente ritenute per qualche aspetto diverse dalle norme ordinarie, e comunque di solito non definite con precisione”.
(20) Così Velluzzi, secondo il quale “lo standard altro non è che il criterio necessario
alla determinazione del significato delle clausole generali”: Velluzzi, 2010, 9. Più problematico Rodotà, 1987, 767, che non coglie un’apprezzabile differenza tra standard e clausola
generale. Utilizza la nozione in termini affatto differenti: Perulli, 2011.
12
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
valutativo socialmente accettato. Per dirla in termini pratici: il
giudice non avrebbe potuto disporre della delega per applicare al
caso concreto valori di riferimento secondo un proprio apprezzamento, ma individuare, necessariamente, quelli, e solo quelli, corrispondenti all’opinione dell’uomo medio. In definitiva, non
avrebbe potuto introdurre visioni più avanzate o pretendere di
svolgere una funzione educativa del costume. Ora, invece, il giudice non è tenuto ad applicare lo standard sociale corrispondente
alla direttiva contenuta nella norma, “il comune senso del pudore”,
ma solo a farvi riferimento. Il giudice si serve degli standard,
intendendoli quali criteri direttivi “per la ricerca di valori che il
giudice deve poi tradurre, con un proprio giudizio valutativo, in
una norma di decisione” (21). Ciò in quanto i valori, non essendo
conoscibili direttamene, richiedono la necessaria mediazione di
esperienze concrete che, offrendone una dimostrazione pratica,
consentono di apprezzarli (22).
Al giudice viene così assegnata “una funzione di estrema
importanza e delicatezza nella verifica della portata della clausola
generale”, per quanto si tratti di una verifica “di carattere essenzialmente empirico e non soggettivo” (23) che consente, o meglio
impone, di sviluppare il processo interpretativo al di fuori della
tecnica della sussunzione (24).
Riprendendo la comparazione con l’altro filone cui si è fatto
cenno, si può osservare che mentre l’aspirazione ad una legislazione
per principi ha carattere “eversivo”, in quanto volutamente indirizzato ad una più radicale modifica del sistema, la teoria di
Mengoni potrebbe essere definita progressista, in quanto innesta le
novità nel solco di un sistema le cui regole non devono essere
stravolte. Non a caso, egli ha cura di precisare che il superamento
del positivismo, promosso dalla nuova concezione che si fa strada,
“non vuol dire superamento del principio di positività del di(21)
(22)
Mengoni, 1986, 15.
Per un approfondimento del rapporto tra norma e valore, si veda Forcellini,
2014.
(23) Pallini, 2009.
(24) Per alcuni, tuttavia, potremmo trovarci in presenza di una sorta di rovesciamento del sillogismo: la premessa maggiore non può essere costituita dalla norma, in quanto
indeterminata, sarebbe, quindi, il giudizio di fatto, espresso sulla base di parametri extralegali “a riempire il contenuto e a concretizzare la clausola generale”: D’amico, 1989, 438.
Così anche Di Majo, 1984, 539. Lo esclude, invece: Luzzati, 2012, 190.
13
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ritto” (25). Pertanto, egli lamenta il fatto che non siano state
utilizzate le clausole generali già presenti nelle fonti normative, che
avrebbero potuto mettere “a profitto le possibilità di contributo al
progresso del diritto”, ma non si duole affatto dell’insuccesso della
proposta di una “legislazione per principi”, ascrivibile soprattutto
a Rodotà (26), considerando “il rischio che una legislazione siffatta
porti lo Stato di diritto a degenerare in uno Stato giustizialista” (27).
Vi è poi da sottolineare che la valutazione del giudice, proprio
per essere vincolata al riferimento a uno standard sociale, impone
al giudice di concretizzarla in una forma generalizzabile, cioè in
funzione di una tipologia sociale (28) che consenta di creare modelli
stabili di decisione. Ciò significa che non può concepirsi un diritto
che possa valere solo per un caso concreto. Ove il giudice, nell’esaminare un caso, ritenga insufficienti le norme esistenti ed elabori
una soluzione, questa, per essere ammissibile, dovrà poter essere
applicabile anche a casi analoghi, “apoyarse en una norma, siquiera esta no esté formulada todavía” (29).
Le clausole generali, nella sistematica di Mengoni, oltreché
dall’equità, vanno distinte anche dalle norme generali e dai principi generali. Distinzione opportuna visto che, ancor oggi, è proprio
con questi due concetti che le clausole generali vengono spesso
confuse.
Le norme generali, sono norme complete. La peculiarità consiste nel fatto che “la fattispecie non descrive un singolo caso o un
gruppo di casi, bensì una generalità di casi genericamente definiti
(25) Mengoni, 1986, 14.
(26) Rodotà, 1967, 83 ss.
(27) Mengoni, 1986, 6. In riferimento al rischio che “la indeterminatezza procurata
dalle clausole generali potrebbe assumere dimensioni anche estreme ed aberranti, mediante
macro-clausole totalizzanti, espressione di regimi totalitari”. In altra occasione: « i valori sono
in se´ guide pericolose, che possono portare alla tirannia di una giustizia politicizzata, se l’uso
corretto delle clausole generali che ad essi rinviano non sia garantito da una disciplina dogmatica cui il giudice possa attingere criteri razionali di soluzione » delle antinomie che insorgono dalla « tensione tra due modelli valutativi costituiti dallo Stato di diritto e dallo Stato
sociale » in Mengoni, Recensione a Franz Wieaker, Storia del diritto privato moderno con particolare riferimento alla Germania, cit., p. 53, citato da Nogler, 2006, 14.
(28) Mengoni, 1986, 13.
(29) Miquel González, 1997, 325, in adesione alla teoria di Jurgen Schmidt.
14
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
mediante una categoria riassuntiva, per la cui concretizzazione il
giudice è rinviato, volta a volta. a modelli di comportamento e a
stregue di valutazione obiettivamente vigenti nell’ambiente sociale in cui opera” (30). È in questa categoria che rientrano, tra gli
altri, concetti a noi familiari, quali giusta causa o giustificato
motivo. La differenza con le clausole generali risiede nella circostanza che, in questo caso, al giudice, cui è consentito uno spazio di
oscillazione nella decisione, viene riconosciuta una discrezionalità
di fatto e non “di una discrezionalità produttiva o integrativa di
norme” (31).
I principi generali, infine, vengono da Mengoni distinti tra
principi assiomatici o dogmatici, “premesse maggiori di deduzione,
nella forma del sillogismo apodittico, di regole di decisione nell’ambito di categorie più o meno ampie di fattispecie”, e principi
retorici, che avrebbero la funzione di fornire “basi di partenza per
argomentazioni del giudice nelle forme dialettiche della logica
preferenziale” (32). Anche in questo caso, la distinzione riposa
soprattutto sul fatto che le clausole generali, a differenza dei
principi generali, pur impartendo al giudice una direttiva volta alla
ricerca della norma di decisione, costituiscono solo una tecnica di
formazione giudiziale della regola da applicare e non contengono
“un modello di decisione precostituito da una fattispecie normativa astratta” (33).
3. Il seguito del dibattito.
Il dibattito successivo ha visto un andamento altalenante. Tra
la fine degli anni ’80 ed i primissimi anni ’90 del secolo scorso si è
registrato un elevato interesse della dottrina con assoluta prevalenza di quella privatistica. Dopo un lungo intervallo, caratterizzato da un interesse più occasionale, il tema delle clausole generali
è tornato di forte attualità nell’ultimo lustro attirando, in maniera
prevalente, l’interesse di altri settori, dalla filosofia al diritto commerciale, amministrativo, penale, costituzionale.
(30) Mengoni, 1986, 11.
(31) Mengoni 1986, 10.
(32) Mengoni, 1986, 10. Nel senso di distinguere la clausole generali dai principi
anche Rodotà, 1987, 721.
(33) Mengoni, loc. ult. cit.
15
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Il filone che ha privilegiato un approccio analitico e dogmatico
alle clausole generali ha continuato a ragionare attorno alla teoria
di Mengoni, precisando o criticando alcuni aspetti, ma non è mai
giunta formulare una teoria alternativa a quella da lui proposta.
Per Rodotà, che ha privilegiato altri percorsi, ed utilizza una
nozione di clausola generale più ampia di quella proposta da
Mengoni, la caratteristica tipica delle clausole generali non consiste
tanto nel potere integrativo riconosciuto al giudice, ammesso anche in presenza di norme generali o comunque indeterminate,
quanto nel fatto che l’indeterminatezza sia intenzionale (34). La
nozione di fattispecie aperta, infatti, ricorre, più in generale nel
caso di “esplicito trasferimento al giudice del potere di procedere
ad un autonomo apprezzamento della situazione di fatto ed alla
concretizzazione della norma” (35). Sembrerebbe, pertanto, che
tra la nozione di fattispecie aperta e la clausola generale intesa in
senso stretto, intercorra una relazione tra genus e species: tra le
possibili fattispecie aperte, possono essere classificate come clausole generali quelle in cui la indeterminatezza derivi da una scelta
intenzionale del legislatore.
Anche Castronovo, dopo aver messo in guardia dal rischio che,
enfatizzando l’elevata generalità quale tratto identitario delle
clausole generali, si potesse confonderle con le norme generali,
aveva indicato nel potere integrativo del giudice l’elemento caratteristico delle clausole (36).
L’elemento della “vaghezza o indeterminatezza” ritorna di
frequente nel dibattito, esso è considerato un “peculiare coefficiente” delle clausole generali “quantitativamente e qualitativamente diverso da quello implicito in ogni enunciato normativo” (37). Senza, con ciò, negare la teoria di Mengoni, posto che
“in fondo” le clausole generali consistono in un rinvio all’inter-
(34) Il carattere dell’intenzionalità è frequentemente ribadito dalla dottrina successiva. In senso contrario, però, Castronuovo, 2013, 12. secondo il quale l’indeterminatezza
potrebbe derivare da una “più o meno intenzionale rinuncia a una tecnica casistica” oppure
dall’impossibilità di determinare a priori il contenuto della norma.
(35) Rodotà, 1987, 721.
(36) Castronovo, 1979, 102-103. Nello stesso senso: D’Amico, 1989, 427 ss.
(37) Castronuovo 2013, 1.
16
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
prete, al quale è delegato il compito di una loro disambiguazione in
funzione di parametri variabili (38).
Più recentemente, Velluzzi si è soffermato sul carattere della
indeterminatezza propria delle clausole generali proponendo che
debba trattarsi di una “indeterminatezza semantica” che ricorrerebbe in presenza di “un termine o sintagma valutativo il/i cui
criterio/i di applicazione non è/sono determinabili se non attraverso il ricorso a parametri di giudizio tra loro potenzialmente
concorrenti” (39). Con ciò sembra escludere che possano rientrare
tra le clausole generali le ipotesi nelle quali il giudice è chiamato a
decidere sulla base di termini non valutativi, come l’impossibilità
sopravvenuta.
Velluzzi perviene ad una definizione delle clausole generali (40)
contenente una ulteriore specificazione, quella per cui i parametri
di giudizio cui dovrà far ricorso il giudice possono essere interni o
esterni al diritto. Cosa debba intendersi per criteri interni o esterni
al diritto è sufficientemente chiaro. Meno chiara l’utilità discretiva,
sulla quale si ritornerà. Uno spunto interessante, semmai, riguarda
la distinzione operata dall’autore tra l’attività interpretativa compiuta per poter individuare il significato della clausola generale e
quella che il giudice compie quando deve affrontare questioni “di
vaghezza di significato o di ambiguità dei termini e degli enunciati,
oppure in presenza di termini generali o generici, ma in assenza di
termini valutativi” (41). Sembra di capire che, nel primo caso, il
giudice debba “scegliere” una soluzione tra quelle possibili, mentre
nel secondo caso, dovrà “capire” il significato delle espressioni che
si trova davanti (ma questo è il tipico problema interpretativo che
(38) Castronuovo, 2013, 3.
(39) Velluzzi, 2010, 8, Idea successivamente accettata da Luzzati, per il quale si può
parlare di clausole generali come sintagmi, ma solo per metonimia, allo stesso modo in cui
si suole affermare che un termine o una frase sono vaghi, intendendo in realtà riferirsi ai
contenuti di tali espressioni”: Luzzati, 2012, 172.
(40) “Le clausole generali sono nell’uso prevalente termini o sintagmi di natura
valutativa caratterizzati da indeterminatezza semantica diversa dalla vaghezza di grado,
dalla vaghezza combinatoria e dall’ambiguità: il significato di tali termini, o sintagmi,
infatti, non è determinabile (o detto altrimenti le condizioni di applicazione del termine o
sintagma non sono individuabili) se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio,
interni e/o esterni al diritto tra loro potenzialmente concorrenti”. Velluzzi, 2010, 9.
(41) Velluzzi, 2010, 12.
17
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
il giudice deve sempre affrontare nell’applicare una norma, anche
quando fosse precisa e incondizionata).
4. Una più ampia nozione di clausola generale all’interno dello
schema elaborato da Mengoni.
Prima di esaminare alcuni problemi interpretativi, recentemente sollevati dalla dottrina, è opportuna qualche riflessione
esplicitamente finalizzata ad un possibile ampliamento della nozione di clausola generale.
La nozione di “clausola generale” proposta da Mengoni presenta margini di incertezza applicativa, nel senso che, a fronte
della chiarezza concettuale, non consente di ascrivere o escludere
con certezza alla categoria delle clausole generali le diverse nozioni
correntemente utilizzate in dottrina e giurisprudenza. La prevalente dottrina, compresa quella che si ispira alla teoria che commentiamo, con l’eccezione di gran parte dei giuslavoristi, include
tra le clausole generali anche ipotesi che non compaiono o sono
esplicitamente rifiutate nella analisi di Mengoni, come la giusta
causa o l’equità.
Ciò non deve stupire: la definizione analitica di un concetto giuridico non comporta che tutte le nozioni che “potrebbero” confluire
nel concetto, debbano necessariamente essere ascritte ad esso. Possono ostare, ad esempio, problemi semantici. La pretesa del diritto
di utilizzare un linguaggio proprio ed inequivoco si è rivelato utopico. Assieme ai sintagmi importati dal linguaggio comune, il sistema
giuridico importa anche i polisensi, le ambiguità e la vaghezza proprie sia dell’ontologia della parola, sia dei significati che essa acquista
o perde nelle sue trasmigrazioni spazio-temporali.
Mengoni, come si è detto, ha insistito nella distinzione tra
equità e clausola generale. Lo ha fatto con particolare insistenza,
sia per marcare la differenza con una diffusa opinione (il riferimento è alla dottrina tedesca) che, a suo avviso, confonde l’equità
con le clausole generali, sia, dal punto di vista pratico, per evitare
che “sotto il nome della buona fede si insinui un giudizio di equità
modificativo del regolamento legale” (42):
(42) Mengoni, 1986, 13. Qualche anno prima, Di Majo aveva espresso ampie riserve
sul fatto di una possibile differenziazione, sul piano pratico, tra equità e clausole generali
18
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Tale intento, tuttavia, è frustrato, almeno parzialmente, proprio per il fatto che il termine “equità” possiede, anche nel sistema
giuridico, per averle mutuate dal linguaggio comune, differenti
accezioni che possono coincidere, o meno, con quella adottata nel
momento di elaborazione della teoria.
Il ragionamento che porta Mengoni ad escludere l’equità dal
novero della clausole generali è ineccepibile: non siamo in presenza
di una clausola generale quando il giudice “integra o adatta il
regolamento negoziale per conformarlo a esigenze di giustizia provenienti da circostanze di fatto peculiari, irriducibili a tipologie
normali (il corsivo è mio)” (43) in quanto “il ricorso all’equità
presuppone lo scardinamento del caso da precedenti o modelli
generali, la non comparabilità con altri casi già sperimentati” (44).
L’accezione di equità che sottende il ragionamento, evidentemente, è quella del giudice che, quando opera secondo equità,
sospende l’operatività della legge. Tuttavia, se penso, alla prescrizione di cui all’art. 2118 c.c., secondo il quale i termini di preavviso
del licenziamento, in ultima analisi, vengono stabiliti secondo
equità, non immagino affatto che il giudice, nel processo che dovrà
portarlo a decidere quale debba essere un equo (congruo) termine
di preavviso lo debba integrare con criteri irriducibili a tipologia
normali e tantomeno che possa decidere sospendendo l’operatività
della legge. Se analizzo la fattispecie contenuta nell’art. 2118 c.c.
alla luce dell’accezione di equità che ho in mente, mi sembra, anzi,
che essa coincida perfettamente con la nozione di clausola generale:
siamo in presenza di un comando, il cui contenuto non è del tutto
determinato, nonché di un giudice, delegato a concretizzare la
norma, vincolato ad una direttiva. Ovviamente, ho anche ben
chiara sia l’idea che il giudice dovrà far riferimento ad uno standard sociale riconoscibile come forma esemplare dell’esperienza
sociale dei valori, sia che la sua decisione dovrà essere espressa in
forma generalizzabile, cioè tale da poter costituire un tipo. Neppure vorrei che la decisione del giudice fosse una decisione del caso
concreto, sganciata che da qualsivoglia forma di controllo. Può
anche darsi che il comando, come invece formulato nell’art. 1374
essendo “assai tenue il filo che lega la decisione sul singolo caso al contenuto (assiologico)
della clausola generale”. Di Majo, 1984, 547.
(43) Mengoni, 1986, 13.
(44) Ivi.
19
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
c.c., che descrive una fattispecie assai più ampia possa non consentire il ricorso ad uno standard ed in tal caso, ma soltanto in tal
caso, potremo dire di trovarci al di fuori della nozione di clausola
generale e di fronte alla giustizia del caso concreto.
Questo ragionamento ci consente di immaginare che, proprio
per la fisiologica mutevolezza dei significati, sia preferibile un
atteggiamento inclusivo, cioè ritenere che, tutte le volte che una
nozione “aperta” consenta l’applicazione rigorosa dello schema,
dovremmo considerarla una clausola generale. Nel caso di formulazioni che contengono il termine equità, ad esempio, non si tratterà di clausole generali se riferite al giudizio di equità, del caso
concreto, da svolgersi al di fuori dell’operatività della legge, ma lo
saranno se, invece, indicano al giudice il criterio di concretizzazione della norma. Secondo una recente opinione dottrinale, da
condividere, “nessuna stringa di parole è in sé e per sé una clausola
generale, ma diventa tale solo in virtù dell’opera interpretativa,
non ho nessun problema ad ammettere che un sintagma possa
essere considerato come una clausola generale nel senso S1 e possa
essere invece non essere considerato tale nel senso S2” (45).
Una nozione più ampia di “clausola generale”, idonea a ricomprendere anche figure che, a prima vista, sembrerebbero esterne ad
essa, può esser elaborata anche grazie ad un percorso “interno”,
cioè costruito attraverso un approfondimento terminologico e, in
particolare, individuando una gerarchia tra gli elementi costitutivi
della nozione proposta da Mengoni così da selezionare, tra i requisiti che costituiscono la nozione, quelli essenziali.
L’elemento distintivo della clausola generale, nel senso mengoniano del termine, non sta tanto nel fatto che il giudice sia
chiamato ad integrare il comando contenuto nella norma piuttosto
che a “riscontrarlo”. In entrambi i casi, a ben vedere, dovrà
attingere a valori sociali extra-positivi. L’integrazione o il riscontro
suppongono un procedimento analogo, quello di attingere a tali
valori e, sulla base di essi, pervenire alla decisione. La decisione in
materia di giusta causa o giustificata motivo è volta, evidentemente, a stabilire la sussistenza del giustificato motivo o della
giusta causa nel caso concreto ma, prima ancora, suppone la
risposta ad una domanda preliminare: in cosa consistano il giusti(45) Luzzati, 2012, 182.
20
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ficato motivo o la giusta causa. Il giudice, cioè, dovrà “completare”
la norma, “concretizzarla”, secondo la direttiva contenuta nel
comando. Anche in questo caso, dovrà trattarsi di una decisione
suscettibile di possibile generalizzazione, cioè della creazione di un
tipo cui l’ordinamento potrà continuare a fare riferimento e che
potrà modificarsi se, e in quanto, si modifichi il patrimonio di valori
che caratterizza la realtà sociale di riferimento. In definitiva,
dovrebbe apparir chiaro che il concetto di giustificato motivo
oggettivo, inteso quale ultima ratio, viene elaborato dal giudice,
anche sulla scorta di valori desunti dall’ambiente sociale, alla luce
della direttiva contenuta nella norma. Ciò che occorre stabilire, per
mantenersi nell’ortodossia, è se la discrezionalità del giudice consista in una semplice “discrezionalità di fatto” oppure una “discrezionalità produttiva o integrativa di norme” (46). Se inquadrassimo la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo, come
fa Mengoni, nell’ambito della norma generale, dovremmo convenire che il giudice “concretizza” la norma mediante l’applicazione
di “modelli di comportamento e a stregua di valutazioni obbiettivamente vigenti (il corsivo è mio) nell’ambiente sociale in cui
opera” (47), mentre mi sembra più plausibile che l’operazione
condotta dal giudice sia più squisitamente integrativa, sempre nel
senso mengoniano del termine.
La possibile labilità della distinzione ha indotto una parte della
dottrina a ritenere che la differenza tra le due figure sia soltanto
quantitativa e non qualitativa o, in altra occasione, a ipotizzare
“una differenza di grado non di specie” (48). Ed invece, la differenza è qualitativa: altro è la discrezionalità funzionale alla individuazione di una comunis opinio, o del quod plerumque accidit,
altro esercitarla sulla base di una direttiva generale con la possibilità di operare “una scelta tra varie possibili ipotesi di soluzione”.
Naturalmente, una volta ammessa la potenzialità della clausola generale, se ne possono sterilizzare gli effetti laddove venga
eccessivamente circoscritta la discrezionalità riconosciuta al giudice.
Lo si può meglio comprendere se si confronta un esempio di
possibile applicazione della clausola generale in materia di atti
(46)
(47)
(48)
Mengoni, 1986,10.
Mengoni, 1986, 9.
Castronovo, 1979, 102.
21
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
osceni, recentemente portato da Luzzati, con un analogo esempio,
attinente alla stessa materia, portato da Mengoni. Per il primo, il
giudice “dovrà tener conto della morale sessuale del momento in
cui il giudizio viene formulato, i dettami della quale saranno
diversi, ma non per questo inconoscibili, da quelli vigenti in
passato” e, quindi, svolgere “la funzione di assicurare il contatto
con le ragionevoli aspettative della vita sociale, cioè di ricostruire,
settore per settore e di volta in volta, secondo la comune esperienza, l’idea giuridicamente rilevante di normalità” (49). Mengoni,
da canto suo, critica proprio chi ritenga che il giudice non possa,
avvalendosi della clausola della buona fede, definire regole di
comportamento più avanzate rispetto alle vedute correnti. La
definisce “una concezione coerente con l’ideologia di stampo ottocentesco, che non accredita al diritto una funzione direttiva del
mutamento sociale” in quanto porta ad indentificare il termine di
riferimento della clausola del buon costume “col costume tout court,
e quindi a ridurre l’aggettivo “buono” a significare la rilevazione
statistica del consenso dell’uomo medio che vien così trasformato
magicamente in una sorta di essenza” (50).
Il vero problema è quello di stabilire, sulla base del sintagma
contenuto nella norma, se la formula volta per volta utilizzata
debba essere intesa nel senso di un rinvio alla stregua dei canoni
della norma generale (rinvio a modelli di comportamento obiettivamente vigenti nell’ambiente sociale) oppure di una delega alla
formazione della norma attraverso il riferimento ad uno standard
sociale. L’idea secondo la quale rientrano tra le clausole generali
quelle che operano secondo lo schema descritto da Mengoni, è
sorretta, infine, dalla valorizzazione dell’elemento essenziale della
nozione. Elemento che, a mio avviso, va visto nel fatto che il
giudice, per pervenire alla decisione, debba far ricorso ad uno
standard sociale, consentendo così l’ingresso nell’ordinamento di
valori metagiuridici.
Del resto, lo stesso Mengoni, in uno scritto successivo al saggio
del 1986, sembra consentire una interpretazione nel senso di quella
qui prospettata. Di fronte alla possibile confusione delle clausole
generali con i principi generali, proprio nel fare riferimento al
(49) Luzzati, 2012, 182.
(50) Mengoni 1986, 14.
22
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
principio della giusta causa dei licenziamenti ed al principio della
buona fede nel contratto, afferma che “gli esempi rappresentano
due specie diverse di clausola generale” (51).
L’impiego di una nozione più ampia di clausola generale, del
resto, è suggerita anche da un’esigenza pratica. La nozione viene,
oggi, comunemente impiegata in accezione ben più estesa rispetto
a quanto inizialmente proposto da Mengoni. Anche chi si rifà alla
sua analisi, include, ad esempio, giusta causa e giustificato motivo
tra le clausole generali, spesso anche l’equità, la ragionevolezza,
l’ordine pubblico. Accanto alla nozione di clausola generale se ne
sono affermate di altre, come quella delle norme aperte, norme a
contenuto variabile, così che oggi, nel riferirsi alle “clausole generali”, dottrina e giurisprudenza, in assoluta prevalenza, fanno
riferimento ad una accezione assai più estesa e, non di rado,
utilizzano in maniera indistinta e/o equivalente i diversi concetti.
Quale esempio di tale confusione può essere richiamata la decisione
della Corte di Cassazione che, all’interno della stessa sentenza,
ascrive la buona fede a tre distinte categorie concettuali definendola prima una “clausola generale”, poi un “principio generale” ed
infine un “obbligo (52). Non meno confuso, come meglio si vedrà il
legislatore.
Peraltro, si può osservare che mentre i privatisti, ad esempio,
includono costantemente giusta causa e giustificato motivo tra le
clausole generali, i più fedeli custodi dell’ortodossia mengoniana
rimangano proprio i giuslavoristi (53).
5. Un interesse che prosegue ed evolve.
Più recentemente, come si è detto, si assiste ad una intensa
ripresa del dibattito che, travalicando l’ambito originario, si è
ormai esteso a quasi tutti i settori della scienza giuridica.
Oggi nessuno, almeno in apparenza, pensa più che le clausole
generali possano essere “un pericolo per il diritto e per lo
Stato” (54), del resto, come ha ricordato Rodotà, i giuristi non
(51)
(52)
(53)
(54)
Mengoni, 1992.
Cass. civ., ss.uu., 18 settembre 2009, n. 21606.
L. Nogler, 2010.
Secondo l’ammonizione di Hedemann, citata da Pedrini, 2012.
23
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
hanno affatto necessità di ricorrere alle clausole generali per piegarsi alle dittature ed ai gruppi di potere (55) e sembrerebbe
consolidata “la consapevolezza che la versione ottocentesca del
positivismo giuridico, più che essere entrata in crisi, è ormai morta
e sepolta” (56).
Fermo restando che non tutte le acquisizioni sono pacifiche, e
che tentazioni neo-positiviste, in realtà, fanno ancora capolino, il
dibattito propone orizzonti nuovi che, pur mantenendo un filo di
continuità con il passato, pongono problemi ulteriori circa l’utilizzo delle clausole generali. I problemi relativi all’interpretazione,
ad esempio, si arricchiscono di nuovi contenuti per l’affermarsi dei
sistemi giuridici sovranazionali, per la riscoperta dei principi costituzionali o per l’affollamento delle fonti. Peraltro, è divenuto di
più stringente attualità il tema relativo alla natura stessa del
“controllo”, da parte delle magistrature superiori, delle decisioni
assunte sulla base di clausole generali e si affaccia un nuovo
interesse da parte del legislatore.
6. Le fonti di integrazione delle clausole generali tra regole interne e
regole esterne al diritto positivo.
Un dibattito dottrinale in atto riguarda il potere integrativo
del giudice di fronte alla clausola generale. L’interrogativo è se il
giudice, nell’esercizio del potere integrativo conferitogli dalla
norma, possa ricorrere a regole esterne al sistema del diritto positivo. Vi è chi lo ammette, chi lo nega e chi ritiene che il rinvio possa
riguardare, a seconda dei casi, sia regole interne che esterne (57).
Una recente dottrina, nel respingere l’idea che il giudice possa
far ricorso a cognizioni extra giuridiche, sostiene che la via normale
sia quella della “costruzione normativa fondata sullo sviluppo
coerente di scelte imputabili a fonti legislative (in particolare a
disposizioni di principio contenute nelle fonti formali) (58). Questa
dottrina, in realtà, non esclude forme di etero-integrazione, solo
che ritiene costituiscano l’eccezione e non la regola.
(55)
(56)
(57)
(58)
Rodotà, 1987, 255.
Luzzati, 2013, 164.
Velluzzi, 2010, 87.
Libertini, 2011, 13.
24
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
La teoria, ascrivibile ad un orientamento di “giuspositivismo
critico, o moderato’”, si fonda sull’idea della tassatività delle fonti di
diritto e paventa il rischio che si affermi “la prevalenza della
consuetudine giudiziale o sociale sulla legge scritta, con tutto ciò
che ne consegue sul piano delle ideologie giuridiche” (59). Ammettere il ricorso a fonti esterne, in definitiva, significherebbe “riconoscere al giudice poteri incontrollabili, sicché la discussione in
materia finisce per abbandonare il terreno della costruzione razionale del significato di una certa norma, per incentrarsi invece sulla
ricerca di strumenti atti a limitare la discrezionalità giudiziale”.
Questa teoria si ispira, esplicitamente, alla corrente di pensiero,
secondo la quale “le clausole generali non sono principi, anzi sono
destinate ad operare nell’ambito di principi” (60). Il fatto che le
clausole generali non siano principi, o che debbano operare all’interno di essi, tuttavia, non fa minimamente venire meno il loro
quid pluris costituito proprio dal possibile rinvio a norme esterne.
Affermare che si impone “il ricorso all’argomentazione per
principi, come criterio di giustificazione delle decisioni giuridiche,
rispetto ad una metodologia che ammetta il ricorso ad argomentazione referenziali” (61), per quanto stemperata dalla considerazione che tale tipo di argomentazione consentirebbe, tuttavia,
un’ampia autonomia e responsabilità all’interprete, significa, in
ogni caso, svuotare di contenuto pratico la stessa teoria delle
clausole generali. Senza contare che potere interpretativo ed apertura a valori esterni non sono alternative tra le quali si imponga la
necessità di una scelta. Il giudice che, sulla base di uno standard
indicato dalla direttiva, ricerchi la regola all’esterno, svolge, allo
stesso tempo, anche le normali operazioni ermeneutiche che sono
proprie del suo ruolo. Solo che alla “normale” discrezionalità
dell’interprete, aggiunge la “specifica” discrezionalità consentita
dalla clausola generale.
La teoria, oltretutto, presenta anche una incoerenza intrinseca, posto che, pretenderebbe di chiarire le previsioni indeterminate indicate dal legislatore, “con il ricorso ad altre (previsioni) non
meno indeterminate delle prime, aprendo lo spazio ad operazioni di
(59) Ivi, 9.
(60) Rodotà, 1987, 721.
(61) Libertini, 2011, 12.
25
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
integrazione da parte del singolo interprete non sempre facilmente
controllabili” (62).
Pur in un differente contesto, questa teoria rivela, essenzialmente, quello stesso timore di una possibile contaminazione del
diritto positivo (assunto in veste sacrale) con elementi di mondanità, lo stesso timore del giuspositivismo del secolo scorso.
Un recente orientamento, in senso contrario, ammette il ricorso a regole esterne al sistema del diritto positivo (63), riconoscendo che il significato concreto delle nozioni contenenti clausole
generali non si ricava “assegnando a queste clausole un contenuto
che si trae dall’interpretazione sistematica dell’ordinamento legale,
ma richiamandosi a standard oggettivi, determinati, conoscibili,
ma che si formano storicamente in una data comunità di interpreti,
che risiedono fuori dal testo della legge” (64). L’autore, preliminarmente, spiega che quando si utilizza il termine “extralegale” si
intende “ciò che si pone all’esterno del sistema della norma (indipendentemente dal rango) posta in essere secondo procedure valide
dell’autorità pubblica” (65), ma poiché nel concetto di “giuridico”
rientrano altre norme, aventi “tutti i caratteri che un precetto
deve possedere per iscriversi nel concetto” (66), il giudice, nel
processo di integrazione del precetto ricorrerà a fonti “esterne al
sistema delle norme poste in essere dall’autorità politica”, quindi
“extralegali”, ma pur sempre a fonti giuridiche, giacché vi è “un
ordine giuridico esterno a quello legale ed il suo fondamento è la
sovranità. Esso è giuridico e, quindi, conoscibile ed accertabile” (67).
Si tratta di un ordine giuridico fondato sui diritti fondamentali, intesi come elenco aperto, e sui doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che non si cristallizzano nell’atto
(62) Perfetti, 2012, 1221.
(63) Libertini, 1991; Id., 2008, 599.
(64) Perfetti, 2012, 1219.
(65) Oppure anche di norme che, seppure non poste dall’autorità pubblica, possano
da queste ultime “esser tratte per via interpretativa a guisa di principio”: Perfetti, 2012,
1220.
(66) Ivi.
(67) Ivi, 1222. La costruzione sembra riecheggiare Mengoni, quando afferma che il
termine ‘legge’ utilizzato dall’art. 101 deve intendersi nell’accezione di diritto vivente
comprensivo del diritto di formazione extralegislativa. Mengoni, 2004, 72.
26
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sovrano di costituzione dell’ordinamento legale, ma rappresentano
“quote di sovranità” trattenute dal popolo.
Poiché quest’ordine giuridico, seppure esterno a quello legale,
è storicamente determinato, l’autore suggerisce che il contenuto
delle clausole generali “trovi un significato determinato e preciso in
quest’ordine (storicamente accertabile in una comunità data) assi
più che in indebite spiegazioni interpretative (che spesso celano
l’opinione privata del singolo interprete) (68).
Si tratta di un ragionamento sicuramente utile per comprendere e giustificare i complessi fenomeni di evoluzione del diritto
alla luce dei principi, e sembra confermare la distinzione tra
principi generali e clausole generali. Si può osservare come il
giudice faccia riferimento ai principi, intesi nella loro intrinseca
capacità evolutiva, tanto più evidente se oltre a quelli “codificati”
debba tener conto anche di quelli che risiedono nella quota di
sovranità mantenuta direttamene dal popolo.
Ciò che non comprendo, tuttavia, è la sopravalutazione della
questione relativa al dilemma circa le fonti che il giudice potrebbe
utilizzare nel processo di integrazione della direttiva stabilita dal
legislatore.
Se partiamo dalla concezione mengoniana, che continua ad
essere l’unico punto fermo di riferimento, il problema della possibilità che il giudice possa ricorrere a fonti extragiuridiche o extralegali è mal posto. Se il giudice, al fine della decisione, fa riferimento a fonti, non potrà che trattarsi di “fonti” in senso legale, ivi
compresi i principi generali. Il giudice, infatti non può modificare
il regolamento legale. La formula secondo la quale al giudice è
delegata “la formazione della norma” non significa riconoscergli un
potere creativo di norme, né attingendo all’ordinamento legale, né
a quello extralegale. “Formare la norma (concreta) di decisione”
significa semplicemente formare la decisione, decidere. Il processo,
infatti, si compone di una norma di direttiva e di una norma
concreta.
Orbene, norma, in senso tecnico, è soltanto quella contenuta
nella direttiva. Solo che essa, come si è avuto modo di ricordare, è
incompleta. Ma è incompleta, non perché il legislatore la voglia
incompleta o indeterminata, ma perché il suo contenuto è incono(68) Ivi, 1222.
27
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
scibile. Quando affermo che il contraente debba comportarsi secondo buona fede, o che il datore di lavoro possa recedere volontariamente solo in presenza di un giustificato motivo, non sono in
grado di apprezzare il comando (non lo conosco) nella sua completezza e tantomeno lo posso utilizzare quale premessa maggiore del
sillogismo.
Per poter conoscere il comando nella sua interezza debbo
necessariamente ricorrere alla mediazione con la realtà (il giudice
seleziona certi fatti o comportamenti con un determinato parametro). Ma non si tratta di una realtà “normativa”, o “legale” che dir
si voglia, bensì di una realtà “storica”. Se si trattasse di una realtà
normativa o legale, tutta la costruzione delle clausole generali si
risolverebbe nel rinvio all’applicazione di un’altra norma: il giudice
dovrebbe semplicemente scegliere quale altra norma applicare per
dare senso alla direttiva contenente la clausola generale ed affrontare, su tale base, il problema interpretativo. Se si trattasse del
rinvio all’ordine giuridico esterno al sistema legale, secondo l’ultima
dottrina richiamata, si tratterebbe di fondare la decisione sulla
base dei principi generali, inclusi i “nuovi diritti”. Per quanto la
seconda ipotesi si differenzi qualitativamente dalla prima, fa anch’essa riferimento ai “vincoli” imposti al legislatore nella ricerca
del contenuto concreto della direttiva, cioè ai principi generali da
interpretare, e non agli strumenti mediante i quali individuare tale
contenuto.
La verità è che la mediazione, indispensabile per il completamento della norma, avviene con la realtà storica, perché i valori
non sono conoscibili se non attraverso la lente della loro sperimentazione pratica. Il valore è indicato dalla direttiva, ma può esser
conosciuto solo attraverso una sua lettura nel mondo del reale.
Così, il giudice non interpreta ma, in un certo senso, sceglie tra le
possibili storicizzazioni del valore suggerito dalla direttiva, quella
che al momento storico ritiene preferibile. Il limite alla sua discrezionalità consiste nel fatto che l’operazione da lui condotta possa
tornare utile al diritto, in quanto suscettibile di diventare un tipo.
La peculiarità delle clausole generali non sta tanto nel fatto
che il giudice possa aprire la finestra sul mondo esterno, ricorrendo
a fonti sicuramente extralegali, ma anche extragiuridiche, ma nel
fatto che i contenuti attinti dall’esterno non vengono solo utilizzati
per la soluzione del caso concreto ma, essendo suscettibili di
generalizzazione e di trasformarsi in tipo, possano influenzare
28
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
l’evoluzione stessa del diritto “non legislativo”. Ciò, evidentemente, ha rilevanti implicazioni teoriche e pratiche, ma negare
questa apertura con l’intento di restringere la platea delle possibili
fonti integrative al solo mondo del diritto, anche se inteso in senso
ampio, significa negare la stessa costruzione dogmatica delle clausole generali. Dal punto di vista teorico, rimane chiaro che siamo
affatto in presenza di una regola esterna che penetra nel diritto. Il
nuovo, anche grazie alle contaminazioni derivanti dal contatto con
la realtà, si crea pur sempre all’interno del sistema giuridico. Il
diritto, cioè, regola la realtà attraverso l’autoregolazione, con la
traduzione in regola del rumore esterno (69).
7. L’ermeneutica delle clausole generali e l’incontenibile potere del
giudice.
Nell’ambito delle clausole generali, come si è visto, al giudice è
attribuito un potere di “integrazione” che comporta una maggiore
discrezionalità nella decisione. Il fatto di dover dar corpo a nozioni
aperte consente, o spinge, il giudice ad una ponderazione degli
interessi in gioco che si conclude “con un giudizio di preferenza in
favore di un progetto di soluzione argomentando da un punto di
vista extrasistematico portatore di nuove esigenze o nuovi bisogni
espressi dall’ambiente sociale”. Si tratta di una decisione che,
secondo Mengoni, viene adottata dal giudice in condizioni oggettive di incertezza, destinata ad essere superata laddove venga
verificata l’integrabilità della decisione. Se essa risulta idonea a
stabilizzarsi nel sistema giuridico, si trasforma in fattispecie normativa. Cioè potrà essere utilizzata per giustificare altre decisioni
che non avranno necessità di esser suffragate da una motivazione,
in quanto già contenuta nella fattispecie emersa attraverso la
decisione originaria.
Viene da chiedersi, a questo punto, se l’apporto dell’interprete
sia diverso a seconda che la norma contenga o no una clausola
generale. “La risposta che ritengo di dover dare — affermava Carlo
Castronovo nel commentare la teoria di Mengoni — è negativa, nel
senso che nell’un caso o nell’altro la norma individuale presuppone
(69) Teubner, 1992, 609: “what legislation does is produce noise in the outside world,
under the disturbing impact of which it changes its own internal order”.
29
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
la norma astratta e prende reali fattezze nella decisione giudiziale.
Se una differenza si dà, essa è quantitativa e non d’essenza” (70),
posto che “in talune ipotesi — come nel caso delle clausole generali
— questa attività′ dell’interprete è più importante e più visibile
che in altre’’ (71). Anche laddove possa riscontrarsi una differenza
tra clausole generali e concetti indeterminati, nel senso che nel
primo caso il giudice “concorre a formulare la norma”, mentre nel
secondo caso si limita “a riscontrare il ricorrere nel fatto concreto
dell’elemento elastico indicato dalla fattispecie... essa mette in luce
una diversità di potere, non una diversità di operazione ermeneutica” (72).
Difficilmente, alla luce delle moderne teorie dell’ermeneutica,
una simile affermazione potrebbe essere smentita nella pratica.
Sono i fatti a determinare l’interpretazione della norma ed a far si
che il giudice possa pervenire a diverse interpretazioni della stessa,
“poiché inducono il giudice ad impiegare diverse argomentazioni
giuridiche, ad esempio facendo riferimento a diversi principi generali o costituzionali, ed anche ad invocare diverse ragioni metagiuridiche, ispirate a differenti valori sociali o morali che orientano la
eterointegrazione della norma” (73). Tuttavia, in presenza delle
clausole generali. la discrezionalità del giudice è esaltata: travalicando la dimensione del fatto, egli può attingere a valori desunti
dalla realtà sociale ed operare una scelta tra le possibili soluzioni.
Anche la moderna ermeneutica, superata l’idea che possa darsi una
sola soluzione (quella giusta) per ogni caso concreto, ammette che
il processo di interpretazione consista nella scelta tra più possibili
soluzioni a disposizione, ciò che cambia, e probabilmente non si
tratta soltanto di quantità, sono l’ampiezza e la qualità degli
strumenti a disposizione del decisore. Le regole dell’interpretazione, intese quale complesso di regole alle quali il giudice deve
attenersi, sono le stesse, ma è la norma, il profilo oggettivo, a
stabilire non solo i margini quantitativi ma, almeno in parte, anche
(70) Castronovo, 1986, 22.
(71) “Ogni interpretazione di norme consiste anche nella individuazione di regole,
standards o criteri mediante i quali si perviene alla riconduzione del fatto entro la norma”:
Taruffo, 2003, XII.
(72) Castronovo, 1986, 24, nota 14.
(73) Taruffo, 2014, 42.
30
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
a legittimare il ricorso a peculiari metodologie d’indagine e valutative.
Altro è stabilire se il contratto a tempo determinato sia stato
posto in essere sulla base di un elenco tassativo e tipico di ipotesi
autorizzative fissate dal legislatore (e successivamente delegato
alla contrattazione collettiva), altro se sia stato stipulato in presenza di una clausola generale, “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo”, poi “riferibili all’ordinaria
attività del datore di lavoro”, ed altro ancora, nel caso non sia
richiesta alcuna causale, chiedersi se possano ugualmente ritenersi
presenti limitazioni al suo utilizzo. Anche nell’ultima ipotesi, evidentemente, tali spazi residuano, ma sono assai più limitati: una
ragione discriminatoria, un contrasto con principi generali dell’ordinamento o con fonti internazionali, etc.
Il processo interpretativo è sicuramente influenzato dal ruolo
(soggettivo) dell’interprete, ma non può trascurarsi l’importanza
del profilo oggettivo, e cioè dalle modalità del “comando” contenuto nella norma. Lo stesso potere che delega al giudice un ruolo
determinante nella produzione del diritto, infatti, fissa anche dei
limiti, stabilendo l’estensione della delega che, a seconda dei casi,
può essere più o meno ampia.
8. Ermeneutica delle clausole generali ed arbitrio giudiziale.
Il secondo, peculiare, aspetto della clausole generali consiste
nella loro irriducibilità al metodo sussuntivo (74). Ciò in quanto,
nelle clausole generali, la fattispecie astratta non è desumibile, o
non compiutamente, dal comando contenuto nella norma, compito
del giudice sarà proprio quello di dare contenuto a quel comando,
costruendo la fattispecie (75) sulla base di elementi ricavati dalla
realtà sociale. In altri termini, posto che le clausole generali risultano così irriducibili alle tradizionali tecniche dell’interpretazione,
la loro diffusione favorisce e rafforza l’affermarsi delle più moderne
teorie dell’ermeneutica e fa si che la dogmatica giuridica esca
“distanziata dalla pretesa di costruire un sistema rigorosamente
(74) Opinione non condivisa da quanti ritengono che si verificherebbe una inversione
dei termini nel sillogismo. Si veda infra.
(75) D’Amico, 1989.
31
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
deduttivo e autosufficiente, secondo il quale il giudizio si ridurrebbe a un atto di pura sussunzione” (76).
Sembra che l’utilizzo della tecnica delle clausole generali favorisca, per un lato, una maggior adattabilità della decisione al caso
concreto (77), in sintonia con gli orientamenti del “particolarismo
giuridico” ed esaltando la funzione creativa del giudice e, per altro
lato, l’adattamento del diritto positivo ai mutamenti che si producono nella realtà sociale (78). In entrambi i casi, tuttavia, gli
effetti sono condizionati dall’opzione interpretativa che si accoglie.
Nel primo caso, l’attenzione va posta in relazione alla funzione
del giudice, tutt’altro che pacifica ma meno problematica se si
abbandona definitivamente l’idea di una sua funzione solo dichiarativa. Una volta ammesso che il giudice “non constata ma costruisce la norma”, in virtù di una “ampia misura di discrezionalità
nella scelta dei significati possibili” (79), proprio la più incisiva
discrezionalità contenuta nella delega farebbe si che in nessun caso
possa parlarsi di arbitrio: “l’interprete della clausola generale naviga senza bussola in un mare aperto a molte rotte” (80), ma questo
non è arbitrio.
Per alcuni, l’ampio spazio di decisione del giudice è il prezzo da
pagare per i vantaggi di una legislazione, per clausole generali, che
consente di meglio governare i fenomeni indotti dalla complessità
della società, abbracciando in formule lessicali semplici, anche
perché indeterminate, una casistica che i codici tradizionali, costruiti su fattispecie dettagliate, non sono più in grado di governare (81). Del resto, “è la giurisprudenza che costituisce il contenuto effettivo del c.d. diritto vivente, il quale rappresenta in molti
(76) Mengoni 1996, 52.
(77) Poiché “la decisione non è mai il frutto dell’applicazione meccanica di norme
generali, e... l’applicazione della norma non può avvenire se non facendo riferimento alla
complessità del caso particolare su cui verte la decisione”. Taruffo, 2014, 40.
(78) Che è problema ermeneutico, e non dogmatico. “Il pensiero dogmatico non è
adatto a questo, perché i concetti da esso formati sono strumenti di conoscenza delle norme
esistenti e le operazioni logico deduttive in cui esso si svolge sono meramente riproduttive
di soluzioni implicite nelle premesse già integrate nel sistema, e perciò inidonee a fornire la
base per l’elaborazione di risposte adeguate a problemi nuovi che insorgono da punti di vista
extra sistematici sopravvenuti” Così: Mengoni, 1990, 432.
(79) Gentili, 2010, XVII.
(80) Ivi.
(81) Gentili, XV.
32
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
casi il solo diritto di cui disponiamo ad esempio quando i giudici
creano diritto colmando lacune o il vero diritto di cui disponiamo,
quando i giudici creano diritto interpretando clausole generali, o
qualunque altro tipo di norma” (82).
Per altri, non si tratta affatto di un prezzo da pagare, posto che
proprio sulla discrezionalità del giudice si fonda la decisone del
caso concreto. Secondo le espressioni più radicali di questo orientamento, evidentemente ascrivibile al particolarismo giuridico,
sono da respingere sia il metodo sussuntivo che quello della concrezione a favore di una terza via: la regola del caso. La norma, in
un certo senso, viene svalutata a favore del potere discrezionale del
giudice, in quanto “la ley no dice lo que aparece en su texto literal sino
lo que los tribunales dicen que diga” (83). A partire da una concezione largamente condivisa, secondo la quale la legge offre una
pluralità di soluzioni tra le quali il giudice dovrà scegliere, Nieto
esalta quindi proprio l’arbitrio del giudice che, seppur non inteso
quale sinonimo di arbitrarietà, tuttavia non può prescindere dai
suoi personali convincimenti. È quasi impossibile, infatti “que en
la sentencia no “queden plasmadas “expresiones que reflejen su
ideológica, su cultura, su conciencia institucional o corporativa, sus
prejuicios, de tal suerte que un lector experimentado — sin necesidad
de ser un psicólogo profesional — puede acceder a rincones ocultos de
la personalidad del juez” (84). Nella decisione influirebbe persino la
conformazione mentale involontaria del giudice, se è vero che le
maggiori distorsioni nella valutazione delle prove non deriverebbero affatto dalle sottigliezze giuridiche, bensì dalla “insensibilidad
del juez, entendida como la incapacidad biológica que todos tenemos
para percibir, comprender e interpretar determinados fenómenos y sus
correspondientes matices” (85). Alcuni negano la stessa premessa,
ritenendo che “considerar que el juez se extralimita en su función de
administrar justicia, porque corrige un precepto legal por medio de
una cláusula general, seria un verdadero sarcasmo. La cláusula
general esta precisamente para eso” (86).
Il rischio, peraltro, sarebbe evitabile in presenza di una “co(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
Taruffo, 2007, 710 Sull’argomento, soprattutto: Mengoni, 1990, 445 ss.
Nieto, 2010, 70.
Nieto, 2010, 72.
Nieto, 2010, 69.
Gonzalez, 1997, 317.
33
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
scienza ermeneutica educata” che richiede che “l’interprete sia
pronto a mettersi in ascolto dell’opinion del testo... cosciente...
delle proprie presupposizioni e dei propri pregiudizi” (87).
Dal punto di vista sistematico, non sarebbe difficile individuare un limite all’arbitrio. Anche in presenza di nozioni a contenuto variabile l’arbitrio troverebbe “davanti a sé un limite invalicabile: l’uso irragionevole” (88). Anzi si potrebbe dire che la
ragionevolezza sia uno dei principali canoni di controllo di cui il
giudice deve tenere conto nella individuazione del contenuto normativo delle clausole generali. Indipendentemente dalla classificazione che della stessa ragionevolezza viene data dalla dottrina,
talvolta come clausola generale (89), talvolta come standard (90),
è senz’altro un tratto caratterizzante dei sistemi giuridici moderni
ed è un segnale della sempre maggiore apertura di tali sistemi, in
risposta alla complessità del reale.
Un ulteriore limite è segnato “dal contenuto stesso delle clausole e dalla necessaria loro coerenza con le plurime razionalità dei
sistemi e dei sottosistemi in cui si articola un complessivo ordine
giuridico” (91). Ma altro è individuare limiti, per così dire teorici,
al potere valutativo del giudice, altro verificare tale assunto sul
piano concreto. L’adattamento del diritto alla realtà cangiante
delle cose, infatti, consentendo uno scambio con la realtà, fa si che
il diritto formale si apra al diritto vivente, ma questo scambio
“introduce « impurezas » en el lenguaje legal, adiciona elementos que
afectan la propia identidad del enunciado y quiebra la lógica autorreferencial que la filosofía analítica ha predicado sobre el Derecho” (92)
amplificando le difficoltà interpretative.
Il tema, inoltre, tocca l’irrisolto nodo del rapporto tra la
correttezza formale della decisione e la ricerca della giustizia, che
potrebbe prevalere su ogni altra esigenza di correttezza formale.
(87) Forcellini, 2014, 139.
(88) “El problema del arbitrio judicial, que tanto preocupa a algunos teóricos y
prácticos del derecho, non puede hacernos olvidar que la concreción de las notions a contenu
variable, como la buena fe, no es enteramente arbitraria, pues se halla sometida a un limite
infranqueable: el uso irrazonable”. Così Gil y Gil, 1990, 92, in adesione alla teoria di
Perelman.
(89) Nivarra, 2002, 373 ss.
(90) Scognamiglio, 1992, 65 ss.
(91) Breccia, 2007, 461.
(92) Lorenzetti, 2013, 156.
34
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Quando si afferma che al giudice si presentano una pluralità di
soluzioni del caso, ovviamente, si vuole intendere che tutte queste
soluzioni sono corrette. Le opzioni scartate, in altri termini, non
appaiono meno corrette di quella adottata. Di conseguenza, non
potrà mai affermarsi che la decisione definitiva sia quella giusta.
Ciò comporta che le sentenze, a seconda della visione di ciascuno,
potranno essere considerate corrette o non corrette (sul piano della
logica argomentativa) oppure giuste o ingiuste (sul piano dei valori
che il diritto aspira a rappresentare), all’interno di una visione
secondo la quale la giustizia “altro non è che il carattere aporetico
che caratterizza il tentativo di ricondurre la legge all’atto di
giustizia” (93).
La decisione “giusta” dovrebbe tener conto “non solo della
correttezza procedurale, ma soprattutto delle effettive condizioni
empiriche sulle quali il suo potere è chiamato a esercitarsi” (94). È
anche possibile che “vinca la tirannia di un valore di parte che il
giudice... tragga soltanto dalla sua ideologia, pur dissimulandola
tra le righe di una motivazione professionale non del tutto sgrammaticata” (95). Non è neppure infrequente che i giudici, e più
ancora le giurie, si trovino di fronte a statuizioni legali che ritengono inadeguate, o inique, per la soluzione del caso concreto. In
mancanza della discrezionalità consentita dalla clausola generale,
“quand le texte qu’il doit appliquer ne lui lasse aucun pouvoir
d’appréciation, le jury n’hésite pas a recourir a une fiction, c’est a dire
a une fausse qualification des faits, pour échapper aux conséquences
de la règle juridique qu’il juge inacceptable” (96). (....).
9. Ermeneutica delle clausole generali: sindacato di Cassazione e
funzione della giurisprudenza.
A questo punto del ragionamento, con particolare riferimento
al sistema italiano, si impone una breve riflessione su alcuni aspetti
cruciali relativi alla funzione delle clausole generali, a partire dai
meccanismi di controllo delle decisioni assunte secondo tale tec(93) Secondo la teoria di J. Derrida, accolta da Giustiniano, 2013, 107.
(94) Ivi.
(95) Breccia, 2007, 462.
(96) Perelman, 1984, 365.
35
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
nica. Dovremmo, poi, chiederci se gli strumenti suggeriti, o concretamente adottati, appaiano idonei a consentire appieno la funzione tipica delle clausole generali, che è quella di consentire una
costante mediazione con la realtà sociale e favorire così l’evoluzione del sistema giuridico.
Già in partenza, si presenta subito un’evidente antinomia:
siamo infatti di fronte a due esigenze, entrambe apprezzabili, che
postulano l’adozione di tecniche tendenzialmente opposte. Da un
lato, sta l’esigenza della certezza del diritto, che richiede affidabilità, sicurezza e suppone, tendenzialmente, costanza nelle decisioni. Per altro verso, le clausole generali contengono, nel proprio
DNA la propensione ad accogliere i “segni dei tempi”, per utilizzare una terminologia conciliare, cioè la vocazione a recepire i
cambiamenti, a fornire soluzioni più appropriate per situazioni
che, in altro tempo o in altro contesto, avrebbero comportato
decisioni differenti. È evidente che il mutamento, soprattutto
laddove ispirato dall’accoglimento di istanze metagiuridiche, è
inversamente proporzionale all’affidabilità della decisione.
Il primo problema che si pone, è quello relativo ai meccanismi
di controllo delle decisioni, cioè all’ammissibilità del ricorso per
Cassazione delle decisioni assunte dal giudice in applicazione di
clausole generali. La risposta dipende, in larga parte dalla qualificazione dell’operazione ermeneutica del giudice: se si trattasse di
una decisione confinabile nell’ambito del giudizio di fatto, il controllo della Cassazione dovrebbe essere ricondotto entro il limite
del primo comma dell’art. 360 c,p.c. n. 5. Ma può anche sostenersi,
ed è anzi questa l’opinione prevalente che si tratti di una questione
di diritto, e cioè che il sindacato della Cassazione vada esercitato ai
sensi del punto n. 3 dello stesso articolo: “facendo uso della clausola
generale si pongono nella premessa maggiore del sillogismo (giudiziale) i parametri e il risultato dell’analisi sui parametri (di giudizio; perciò ) quando il giudice di merito sbaglia in questa fase non
commette un errore di fatto ma di diritto” (97). A conferma di tale
orientamento, si fa riferimento alla disposizione del 2012, secondo
la quale “l’inosservanza delle disposizioni in materia di clausole
generali, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni
(97) Patti, 2013, 93. Nello stesso senso: Fabiani, 2012, 238. Anche per Breccia, 2007,
460, “il controllo dei giudici di legittimità sull’applicazione delle clausole generali è, pur
sempre, controllo sul rispetto o sulla violazione del diritto”.
36
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di
lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme
di diritto” (98). Tale disposizione, contrariamente a quanto spesso
sostenuto (99), non significa che l’impugnazione sulle decisioni che
abbiano ad oggetto clausole generali avvenga per violazione di
norme di diritto, ma solo che il diritto è violato se il giudice entra
nel merito delle valutazioni riservate al datore di lavoro.
Sciogliere il dilemma non è semplice, né rientra tra i miei
compiti. È però opportuno segnalare alcune essenziali implicazioni,
se non complicazioni. A partire dal fatto che la pretesa di un ampio
controllo da parte della Corte di legittimità viene spesso utilizzato
proprio per stemperare il potenziale innovativo delle clausole generali e mantenere il giudice, suppostamene immaginato come
portatore di una forza centrifuga (100), “nel sistema di giuspositivismo voluto dall’art. 101, capoverso, Cost. (allontanandolo) da un
sistema di responsabilità politica estraneo ad un ordinamento
costituzionale...”. A tal fine, anche recentemente, nell’autorevole
sede della Corte di Cassazione, è stato fornito un dettagliato elenco
di tipologie interpretative, evidentemente finalizzate, ad evitare
ogni fuga nel buio dell’extra giuridico, sulla base del presupposto
che “la necessità di ricorrere, quando si tratti di clausole generali
adoperate dal legislatore statale, a criteri esterni alla legge non
significa che si possa giustificare la scelta interpretativa secondo
criteri extragiuridici” e, soprattutto, nella convinzione che “criteri
moralistici o politici, o più largamente ideologici di integrazione del
diritto positivo sono, salvo che si tratti di salvaguardare ‘il minimo
etico di cui l’uomo comune è naturale portatore’, sempre soggettivi
o, peggio, imposti dall’esterno e perciò (il corsivo è mio) pericolosi
o dannosi ai consociati” (101). Si teme, in definitiva, che sfugga di
mano la possibilità di un controllo unitario ed uniforme, ovviamente riservato alla Corte di Cassazione.
(98) Art. 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall’art..
1, comma 43 della legge n. 92/2012.
(99) Rosselli, 2013.
(100) Forti preoccupazioni per il potere dirompente del giudice, proprio in termini di
certezza del diritto, è espresso, per tutti, da Vallebona, 2002, 175.
(101) Le citazioni sono tratte dalla relazione di Federico Roselli, dal titolo: Clausole
generali e nomofilachia, all’incontro di studio svoltosi 10 ottobre 2013 presso la Corte di
Cassazione.
37
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
A parte questo possibile uso “politico”, evidentemente volto
ad introdurre anticorpi in grado di sterilizzare, o almeno stemperare, il potenziale “antipositivista” delle clausole generali, deve poi
segnalarsi un’altra contraddizione. Una volta accertato che al
giudice, pur con le cautele di cui già si è detto, sia consentito
scegliere, tra differenti soluzioni possibili, tutte tendenzialmente
corrette, non si comprende su quale base potrebbe censurarsi la
decisione del giudice in quanto “sbagliata”, salvo che non si tratti
del superamento dei limiti che circoscrivono il potere valutativo
conferitogli dalla clausola o derivanti da altri principi dell’ordinamento. Affermare, fuori dai limiti di cui si è detto, che il giudice di
merito “sbaglia” nell’utilizzo dei parametri ricavati dal sociale,
significa semplicemente che il giudice di legittimità, non condividendo la scelta operata dal giudice di merito, si sostituisce ad esso
nell’esercizio della delega contenuta nella clausola generale. Sostanzialmente l’ideologia della Corte di Cassazione prevarrebbe su
quella del giudice di merito, finendo per rappresentare una sorta di
terzo grado di giudizio di merito senza che ciò possa trovare alcuna
giustificazione razionale.
La questione sembra superata, nella pratica, da un atteggiamento di autocontrollo da parte del Giudice di legittimità che, in
materia di clausole generali, si astiene, di norma, da un controllo
eccessivamente pervasivo. Ed infatti, nei più recenti orientamenti
della Corte di Cassazione, si apprezzano aperture verso un superamento dell’orientamento giurisprudenziale degli anni ’90 che, in
pratica, finisce per misconoscere la peculiarità delle decisioni assunte sulla base di clausole elastiche. Questa sorta di self restraint
da parte della Cassazione è pesantemente criticato da quell’orientamento cui si è fatto cenno, che lo definisce “una tal quale
inclinazione alla fuga dalla responsabilità morale della decisione”
da parte dei giudici di Cassazione (102).
10. Le clausole generali nell’antinomia tra certezza del diritto ed
evoluzione del sistema.
Altro aspetto di frizione con la funzione genuina delle clausole
generali risiede nella elaborazione delle massime giurisprudenziali
(102) Roselli. Loc. ult. cit.
38
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
della Cassazione in materia di clausole generali e, più in generale,
dell’utilizzo della regola del precedente.
La certezza del diritto si alimenta, per un verso, della prevedibilità della decisione, “che può svolgere anche una funzione
economica” (103), e, per altro verso, dalla presenza di una giurisprudenza costante. La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione è volta proprio a garantire “l’esatta osservanza e uniforme
interpretazione della legge” (104) attraverso sentenze, che, secondo l’insegnamento di Calamandrei, siano “capaci non solo di
assicurare l’esatta interpretazione del diritto, ma anche di imporre
questa interpretazione come canone di decisone dei casi successivi” (105).
Una simile funzione, come è evidente, non appare la più
appropriata quando si tratti di clausole generali: le decisioni assunte attraverso la mediazione con la realtà sociale sono mutevoli
almeno quanto lo sono i valori metagiuridici cui esse si ispirano. La
massima tende a cristallizzare l’esperienza storica che interviene
nella decisione del giudice, si trasforma in un ostacolo alla naturale
evoluzione delle fattispecie create dal giudice nel concretizzare la
norma. Si potrà convenire sul fatto che il giudice, secondo l’insegnamento di Mengoni, dovrà operare tale concretizzazione “in
forma generalizzabile” (106), ma non nel senso di completare, una
volta per tutte, l’incompletezza della norma, disvelando il significato che il legislatore ha volutamente lasciato, almeno parzialmente, indeterminato. Perché in tal caso si completerebbe, attraverso l’elaborazione della massima, la formulazione della norma
astratta, restituendo così, ad essa, l’idoneità a fungere da premessa
maggiore del sillogismo e quindi consentendo, o imponendo, all’interprete di agire sulla base del metodo sussuntivo. Operazione
peraltro suggerita, più o meno in questi termini, da una parte della
dottrina (107).
Il tema relativo alla conciliazione tra l’affidabilità della decisione, garantita da una giurisprudenza costante ed uniforme, e la
sua possibile mutevolezza, è tema generale. L’incertezza comporta
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
Taruffo, 2014, 35-36.
R.D. 30.1.1941, art. 65.
Taruffo, 2007, 714.
Mengoni, 1986, 13.
Fabiani, 2012.
39
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
un rischio per gli attori di ogni transazione, a partire da quello del
datore di lavoro che, nello specifico, non di rado, non può o non è
disposto a sopportare il rischio di una decisone giudiziaria in grado
di alterare il proprio programma. Non a caso, anche nell’ambito del
diritto del lavoro, è forte la tendenza alla fuga dalla giurisdizione.
Qualche ordinamento di common law tenta una conciliazione attraverso la tecnica del prospective overruling, mediante la quale la
Corte che formula un principio nuovo continua ad applicare alla
controversia in discussione le vecchie regole di diritto (garantendo
così l’affidabilità) e riservando l’applicazione del nuovo principio
alle decisioni future.
Occorre però sottolineare che la incertezza delle clausole generali si presenta non soltanto in prospettiva diacronia, elemento di
cui l’attività di nomofilachia della Corte di Cassazione sembra
talvolta tener conto, ma anche in prospettiva sincronica, per cui
l’interpretazione della clausola generale risulta aperta non solo alla
successione temporale, ma anche alla possibilità di una differente
interpretazione all’interno del medesimo spazio temporale, in funzione di altre variabili (108). Più precisamente, secondo Teubner,
l’indeterminatezza riguarda le tre dimensioni che caratterizzano la
struttura della norma: quella materiale, quella temporale e quella
sociale, così da rendere particolarmente ampie ed evidenti le diverse possibilità di concretizzazione (109).
Il riferimento al diritto vivente, espresso dalla presenza di una
giurisprudenza consolidata che, ove le sue massime siano rispettate, e pur con le dovute eccezioni (110), può rendere inammissibile
il ricorso per Cassazione, non si addice al diritto espresso dalle
decisioni fondate sulle clausole generali. È diritto vivente, anch’esso, certamente, ma con un peculiare sistema respiratorio.
Le massime giurisprudenziali, in sostanza, non sono sufficienti
(108) Secondo Rodotà, inizialmente si faceva riferimento alla sola funzione diacronica, “che consentiva al diritto di vincere la sua difficile guerra con il tempo”. Successivamente, anche per influenza degli ordinamenti sovranazionali (come l’art. 19 della carta dei
diritti fondamentali) la funzione sincronica si sarebbe affiancata alla prima. Rodotà, 2009,
106.
(109) Miquel Gonzalez, 1997, 312.
(110) Si vedano: Cass., n. 7394/2010 e Cass. n. 25194/2013 che ritengono il ricorso
inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offra elementi per
confermare o mutare l’orientamento della stessa.
40
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
per l’interprete delle clausole generali. Il giudice troverebbe più
utile, semmai, il ricorso alla tecnica del precedente, che è altra cosa
dal ricorso alla giurisprudenza, perché consente di attingere al
fatto concreto rapportandolo direttamene alla norma, e non attraverso la mediazione di una massima alla quale, per forza di cose,
manca proprio la capacità di illuminare il dettaglio.
La tematica relativa all’interpretazione giurisprudenziale, peraltro, riguarda le clausole generali per la peculiarità della tecnica
sottesa alla formazione della decisione, che consente di attingere ad
elementi extragiuridici per completare la norma. Ciò non significa
che solo grazie alle clausole generali si possa pervenire ad interpretazioni innovative o audaci. Come ricorda Treu, guardando in
retrospettiva la giurisprudenza in materia di retribuzione sufficiente, di efficacia normativa del contratto collettivo di diritto
comune e di sciopero si segnalano interpretazioni giurisprudenziali
che “per la loro spregiudicatezza tecnica e, in fondo per il loro
ecclettismo” (111), rimangono impresse per la loro importanza e
durata nel tempo senza necessità di chiamare in causa le clausole
generali. Del resto, non tutti i mutamenti di indirizzo, che poi
confluiscono nelle massime giurisprudenziali, sono “ricavate in via
di interpretazione, ma desunte da principi generali rationes legis o
dai principi costituzionali di solidarietà e di equità (ad esempio il
principio dell’extrema ratio in tema di licenziamenti nell’interesse
dell’impresa” (112).
11. Clausole generali e tensione tra i poteri dello Stato.
Da tempo, si segnala l’idoneità del ricorso alle clausole generali
a fungere da fattore di alterazione dell’equilibrio tra i poteri dello
Stato. Il fatto che alla giurisprudenza venga riconosciuta, seppur
con differenti accentuazioni, una funzione creativa del diritto ne
costituisce un indice rivelatore.
Se si esamina la materia dal punto di vista del legislatore, si
(111) “Laddove, — come precisa l’autore — la spregiudicatezza non va scambiata
per spirito di rottura col passato o di gratuita innovazione, giacché, in effetti, l’originalità
e la tempestività delle decisioni sono tutto tranne che segni di discontinuità storica”. Treu,
1996, 268.
(112) Mengoni, 1996, 48.
41
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
osserva che disciplinare una materia mediante una prescrizione
esaustiva e dettagliata oppure in maniera generale ed incompleta,
lasciando all’interprete il potere di completare la norma, costituisce una scelta in grado di modificare l’equilibrio tra il potere
legislativo e quello giudiziario. Ciò, indipendentemente dal fatto
che la scelta sia volontaria, intesa quale esplicita opzione di politica
del diritto, oppure obbligata dalle circostanze. La ripartizione dei
poteri è definita solo nella sua enunciazione teorica. Nei fatti, una
continua tensione tra i poteri stessi stabilisce, volta per volta, le
funzioni effettive di ciascuno di essi.
Il confine può essere suggerito dal legislatore, quando decida se
disciplinare compiutamente una materia, astenersene, o lasciare
spazio all’interpretazione giudiziale, ma può anche essere modificato dal giudice, laddove interpreti la sua funzione non in termini
meramente dichiarativi ma creativi del diritto. Del potere esecutivo si parla meno. Eppure, contribuisce, anch’esso alla “creazione
del diritto”, sia nella forma della supplenza che nella forma dell’interpretazione, soprattutto mediante lo strumento delle circolari (113). In alcuni casi, come nell’ambito dell’immigrazione, “le
circolari amministrative sono diventate strumento privilegiato di
integrazione e di interpretazione della disciplina giuridica” mediante “la continua creazione di ’nuove’ regole e di ’interpretazioni
autentiche’” (114). Nel passato, hanno disciplinato materie trascurate dal legislatore, come l’avviamento degli invalidi psichici (115)
e, più recentemente, la funzione “creativa” ha riguardato materie
quali la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione all’ammissibilità del lavoro a progetto nei call center o l’applicabilità
delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. A ciò va aggiunta una
funzione “indiretta” ma non meno importante, laddove le modalità e l’efficienza di controlli finiscano per determinare l’ineffettività del diritto sostanziale (116).
Il potere esecutivo, in definitiva, avanza anch’esso una pretesa
(113) Per una visione d’insieme in prospettiva storica si veda: Colao, Lacchè, Stordi,
Valsecchi, 2011.
(114) Gjergji, 2012, 6.
(115) Sull’argomento: Loy, 1993.
(116) “Il ruolo del Ministero del lavoro come fonte di orientamento interpretativo
delle norme e, con esso, il ruolo delle circolari e di strumenti nuovi come gli interpelli” è
cresciuto negli ultimi anni: Del Punta, 2012, 476.
42
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
regolativa che, sebbene dal punto di vista formale non risulti
vincolante per il giudice, né possa aspirare a costituire interpretazione autentica della legge, in quanto regola accettata produce
effetti. A fronte degli “sconfinamenti” di una giurisprudenza ritenuta eccessivamente creativa o di atti amministrativi non condivisi, il legislatore può recuperare la titolarità che rivendica mediante il ricorso ad una disciplina più dettagliata o inequivocabile.
Un recente esempio di esplicita riassunzione del potere, nelle
materie cui abbiamo fatto cenno, è dato dalla previsione della
ammissibilità della collaborazione coordinata e continuativa nel
caso di “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso Call Center ‘outbound’” (117)
Ebbene, può trattarsi di una dialettica di carattere fisiologico,
relativa al governo di quell’area grigia che sfuma i confini tra i
poteri, ma può anche rivelare una più forte tensione tra di essi, tale
da rimettere in discussione l’assetto stesso del sistema.
La tensione sorge soprattutto laddove l’elasticità della norma
lasci spazio ad interpretazioni che, nella prospettiva della certezza
del diritto, creano imprevedibilità, e quindi rischio. Le clausole
generali, con particolare riferimento al diritto del lavoro, diventano così importante terreno di un confronto che travalica i limiti
della normale dialettica.
La tensione, per così dire fisiologica, relativa all’interpretazione di una norma suscettibile di una pluralità di interpretazioni,
tutte corrette, anche grazie all’ausilio di elementi metagiuridici,
cambia di qualità con l’art. 30 della legge n. 183/2010. Oggetto
della tensione, infatti, non è più la interpretazione, ma incomincia
a riguardare, piuttosto, il potere di interpretare. Con l’art. 30 della
legge n. 183/2010, infatti, il legislatore limita il sindacato giudiziale
escludendo che esso possa entrare nel “merito sulle valutazioni
tecniche organizzative e produttive che competono al datore di
lavoro”. Si tratta, per la verità, di un intento già perseguito con gli
art. 27, co. 3 e 69, co. 3 del d.lgs n. 276/2003 in materia di contratto
a progetto e di somministrazione che qui, però, si ripropone in
termini più generali, con riferimento ad istituti particolarmente
sensibili del rapporto di lavoro e facendo esplicito riferimento alle
clausole generali.
(117)
Legge 92/2012, art. 61, come modificato dalla legge 134/2012.
43
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Della norma sono state proposte diverse e contrastanti letture.
Senza entrare nel dettaglio delle diverse interpretazioni, è utile
intenderne l’ispirazione, anche al fine di qualche conclusione finale.
Un primo livello di lettura si sofferma sul fatto che la norma
garantirebbe maggior certezza del diritto ed affidabilità della
norma, con potenziale effetto deflattivo, posto che non tanto le
regole del processo quanto proprio l’incertezza del diritto sostanziale inciterebbero il contenzioso (118). A parte l’evidente inclinazione di tale lettura verso un modello che, con analoga finalità,
ammetta la derogabilità in peius anche da parte del contratto
individuale di lavoro, il limite di questa opzione consiste nella
mancanza del profilo comparativo in relazione agli interessi, o
diritti, che potrebbero esserne coinvolti. Nessuno dubita dei benefici che potrebbero derivare da una deflazione del contenzioso e da
una maggiore affidabilità, ma tali proposizioni non possono comprendersi pienamente se non vengono coniugate con lo strumento
che le rende possibili, se non si dimostri, cioè, che l’interesse per la
“certezza del diritto” possa prevalere sul sacrificio di altri diritti.
Poiché si tratta di operazione che va condotta alla luce dell’equilibrio indicato dall’art. 41 Cost. la pretesa di limitare il ricorso del
giudice a tale principio si porrebbe fuori dall’alveo della Costituzione (119).
Un secondo livello di letture, più tecnico, partendo da una
dettagliata analisi lessicale e sistematica, evidenzia sia il fatto che
il legislatore definisca “clausole generali” nozioni che non sarebbero affatto “clausole generali in senso proprio” (120), sia il fatto
che il controllo giudiziale, anche quando comporti un restringimento della sfera di azione dell’imprenditore, “rientra ancora, sino
ad un certo punto, in un sindacato di legittimità e non di merito” (121), così che la disposizione non farebbe altro che ribadire
un orientamento giurisprudenziale già consolidato (122).
Quanto alla prima osservazione, tecnicamente corretta, os(118) Tiraboschi, 2010, 8; Vallebona, 2010, 211 ss.
(119) Perulli, 2013, 285.
(120) Carinci, 2011, specie pp. 5 ss. In senso analogo Nogler, 2011, 126, Visonà, 2012,
2.
(121) Del Punta, 2012, 475. Anche per Piccinini, “il controllo di legittimità può
investire, entro certi limiti, le finalità della scelta organizzativa”: Piccinini, 2012.
(122) Carinci, 2011. 11; Del Punta, 2012, 475.
44
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
servo che l’interprete è costretto, in continuazione, a precisare che
la norma “non fa riferimento a clausole generali in senso tecnico (il
corsivo è mio)” (123), cioè nell’accezione mengoniana del termine,
e conseguentemente ad escludere che il giustificato motivo, ad
esempio, possa costituire clausola generale “in senso proprio”. Non
è possibile, tuttavia, mantenere l’analisi e prevedere gli effetti della
norma su di un piano evidentemente differente da quello che
sembra intendere il legislatore (124) anche sulla base della relazione al disegno di legge (125), né sminuire l’importanza innovativa della norma con un sofisticato ragionamento capace di attrarre “anche la determinazione in abstracto del contenuto precettivo della norma stessa, alla luce di tutti gli elementi rilevanti del
caso” nell’ambito dell’accertamento del presupposto di legittimità (126). Al proposito, mi viene in mente don Ferrante, che
durante la peste, “con ragionamenti ai quali nessuno potrà dire che
mancasse la concatenazione”, sostenne l’inesistenza del contagio,
che non poteva essere né sostanza né accidenti”, (127) sì da morire
“come un eroe della scienza”.
Pertanto, è ad un diverso piano di lettura, che occorre prestare
attenzione, come fanno, ad es., Perulli e Ferraro, guardando sia
alla portata ideologica della norma, “una restaurazione rispetto
all’assetto ideale disegnato dallo Statuto dei lavoratori” (128), sia
ai suoi possibili effetti, idonei ad alterare “quella trama di diritti
fondamentali previsti dalla nostra Costituzione con particolare
riferimento alla sicurezza, libertà e dignità umana, ormai proiettati
anche a livello sovranazionale con la Carta di Nizza” (129).
All’inciso: “in conformità ai principi generali dell’ordinamento” è stato spesso attribuito un significato, riduttivo, di ov(123) Ivi, 7.
(124) Una volta decifrato il testo, vi è chi prende atto del fatto che il legislatore
allude a tutte le disposizioni connotate da elevata generalità o genericità. Così, ad es., Zoli,
2011, 833 ss.; Ballestrero, 2009, 8.
(125) “Per clausole generali si intendono a quelle disposizioni legislative che, al fine
di definire l’ambito di legittimità del ricorso a particolari tipologie di lavoro o a decisioni
delle parti, non fanno riferimento a specifiche causali tipizzate, bensì stabiliscono requisiti
di carattere generale e quindi flessibile, seppure effettivi e variabili”.
(126) Del Punta, loc. ult, cit.
(127) Manzoni, Promessi sposi, cap. XXXVII.
(128) Ferraro, 2009, 43.
(129) Perulli, 2013, 286; Per un approfondimento: Perulli, 2005, 1 ss.
45
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
vietà, senza rendersi conto che la norma, proprio mentre ribadisce
l’ ovvio primato di tali principi, in realtà tende proprio ad un loro
depotenziamento. Limitare il controllo del merito nell’ambito delle
clausole generali (anche tenendo conto della difficoltà di distinguere — in queste materie — il profilo di legittimità da quello di
merito) significa, infatti, limitare la vitalità di quei principi costituzionali. Essi vivono in quanto il giudice possa concretamente
utilizzarli per la soluzione del caso concreto. Come, altrimenti, il
giudice potrebbe trovare il limite dell’utilità sociale di cui all’art.
41 Cost., se gli viene precluso di sindacare, sulla base di tale
principio, la scelta operata da una delle parti?
Certo, chi tende a sminuire il carattere innovativo della disposizione, potrebbe sostenere, con una certa logica, che proprio il
richiamo ai principi generali dell’ordinamento impedisca i possibili
effetti negativi paventati dall’altra parte della dottrina. Sino a
poter ritenere che tale richiamo possa costituire, addirittura, “un
ulteriore limite esterno alla cui sussistenza è subordinato l’esercizio
del potere di recedere dal rapporto di lavoro” (130). Più realisticamente, ritengo che l’attacco sia rivolto proprio a quei principi
generali che dovrebbero consentire il controllo della discrezionalità.
Anche l’opinione secondo cui la norma si limiterebbe a confermare l’orientamento giurisprudenziale consolidato è discutibile.
Più esattamente, ricorda Zoli, la norma “non fa altro che avallare
l’orientamento prevalente in giurisprudenza, a scapito di quello
minoritario” (131).
12. Conclusioni.
Una delle parziali conclusioni sinora raggiunte riguarda la
necessità di adottare un’accezione di clausola generale in senso
ampio, facendo riferimento soprattutto alla tecnica di concretizzazione del comando contenuto nella norma. Premessa indispensabile per potersi confrontare con una sterminata letteratura che
utilizza indistintamente svariate nozioni nel far riferimento a
situazioni caratterizzate da una indeterminatezza del comando,
(130) Zoli, 2011, 839.
(131) Ivi.
46
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
che lasciano al giudice il potere di completare la norma mediante
ricorso ad elementi metagiuridici.
Ciò è tanto più indispensabile se si pensa alla crescente importanza che le clausole generali hanno assunto nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario, all’interno del quale “facilitano la
‘convivenza’ delle culture giuridiche differenti dei vari Paesi e,
quindi, consentono, più agevolmente, l’adattamento dei principi
comunitari alle diverse tradizioni giuridiche” (132). Le clausole
generali vengono considerate una disposizione autonoma del diritto comunitario, che postula una uniforme interpretazione di esse
nell’intero territorio dell’Unione (133). Il diritto comunitario, per
essere più precisi, conosce due categorie di clausole: le clausole
generali di diritto comunitario, il cui contenuto è direttamene
definito dal legislatore comunitario, e quelle in cui, invece, il
legislatore comunitario non definisce il contenuto ma lascia che
siano i singoli Stati a determinarlo (134). Il potere di interpretare
le clausole generali di diritto comunitario, seppure in via non
esclusiva ed in presenza di un rinvio incidentale, spetta alla Corte
di Giustizia Europea che, in presenza di clausole generali il cui
contenuto non sia definito, svolge comunque il ruolo di controllo
della “congruità dei parametri adottati” dal legislatore e dal giudice nazionale.
La funzione delle clausole generali nel diritto comunitario, che
pure, parallelamente, ricorre a normative di settore assai dettagliate, è quella di favorire il superamento delle differenze esistenti
tra gli Stati membri, così contribuendo all’armonizzazione del
diritto europeo. Le clausole generali non sono alternative ad una
normativa dettagliata che, con tecnica opposta, restringe i margini
dell’interpretazione in funzione della certezza del diritto. Sono,
piuttosto, funzionali a quello stesso disegno di armonizzazione, in
quanto “ammortizzano” il processo di sottrazione del potere statale da parte del diritto comunitario, consentendo di combinare il
rispetto di principi e categorie generali, che si affermano all’interno
(132) Musio, 2010, 38.
(133) Il contenuto di queste clausole è “predeterminato tramite un’operazione di
sintesi che tenga conto del contenuto che le clausole generali, di volta in volta evocate,
assumono nelle varie legislazioni nazionali”. Meruzzi, 2005, 11.
(134) Corte di Giustizia europea, caso SENA (Stichting ter Exploitatie van Naburige
Rechten c. Nederlandse Omroep Stichting) 2003; Musio, 2010, 39.
47
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dell’Unione europea e che esigono uniformità, con la specificità
(sino ad un certo punto) delle tradizioni giuridiche e dei valori che
caratterizzano i differenti ordinamenti giuridici che ne fanno parte.
Si tratta di un processo che evolve e che già mette in conto, per
quanto riguarda le clausole generali, la piena compatibilità tra le
tradizioni di common law e quelle di civil law.
Per poter trarre qualche considerazione conclusiva, è indispensabile prendere le mosse anche dal contesto all’interno del quale si
assiste al rinnovato interesse per le clausole generali.
“Nel capitalismo del novecento, il diritto dismette programmaticamente il suo atteggiamento di puro ausilio, o sussidio, di un
processo economico auto fondato, a favore di una policy interventista, che assume forme diverse e si alimenta di motivazioni parimenti differenti, riconducibili ora alla presa d’atto della possibilità
che il mercato fallisca, ora ad una (presunta o reale) volontà di
affidare alla mano pubblica la promozione di una società più giusta
e più eguale (si vedano gli art. 3, II comma, 2 e 41 della nostra
Costituzione)” (135). Il Diritto del lavoro ha un ruolo non secondario in questo processo, perché ispirato a movimenti sociali e
politici che hanno contribuito al superamento delle politiche del
laissez faire, perché ha precocemente individuato nella specialità lo
strumento per l’abbandono del principio dell’autonomia della volontà, per il suo contributo al disegno di creazione di uno stato
sociale.
La crisi che ha investito (anche) il diritto, a partire dagli ultimi
decenni del secolo scorso, si è manifestata con un graduale processo
di dismissione dell’interventismo statale che ha portato ad “una
riscrittura delle regole giuridiche che disciplinano il rapporto (conflitto) capitale — lavoro, tutta favorevole al primo” (136).
Questo processo, il cui ritmo è sempre più incalzante, comporta
fenomeni ampiamente noti: la legislazione produce un arretramento dello stato sociale, riduce le tutele, crea flessibilità e precariato, ma non si tratta di ritorno al primo capitalismo, quando al
diritto si chiedeva di mantenersi estraneo ai fenomeni economici,
di limitarsi a garantire gli scambi e l’autonomia della volontà (137).
Il neo liberismo, non chiede più al diritto di astenersi, di lasciar
(135) Nivarra, 2010, 25.
(136) Ivi, 30.
(137) Su cui Fernández Sanchez, 2012.
48
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
fare, bensì di cooperare alla fondazione di una nuova società
costruita sulla concorrenza. A prima vista, laddove non è più
garantita la stabilità del rapporto, aumenta il precariato, aumenta
la povertà, si riaffaccia prepotentemente il dominio della parte
forte del rapporto di lavoro, quel dominio che il diritto aveva
cloroformizzato grazie ad una legislazione prima protettiva e poi
garantista: sembra un ritorno al passato. Non è così. Il dominio del
primo capitalismo era l’effetto di spontanee regole di mercato,
l’affermarsi in maniera razionale di rapporti di forza, ma non era
provocato dal diritto dello Stato. Il dominio attuale, al contrario,
è prodotto dal diritto, nel senso che esso ha introiettato la missione
di garante del principio della concorrenza ed opera apertamente
perché essa si affermi. Al diritto, in nome del razionalismo economico e sulla scia della teoria che pretende di essere l’interfaccia tra
i due sistemi, laws and economics, viene richiesto di adattare la sua
legislazione per renderla funzionale alle esigenze di questo nuovo
potere.
Senza entrare nel merito delle tensioni, o dei conflitti ideologici
e sociali che hanno accompagnato la nascita dello Stato interventista, può dirsi che, storicamente, lo Stato sociale è valore condiviso all’interno del capitalismo. Le diverse tensioni, volte ad una
sua accentuazione o ridimensionamento, toccano il tema di quella
“frontiera mobile” di cui parlava Mancini, ma non mettono in
discussione il consenso intorno all’idea di uno Stato che assume su
di sé il compito di promuovere il benessere. Peraltro, nel frattempo, Costituzioni come la nostra hanno positivizzato i valori
ispiratori dello Sato sociale (138), contribuendo al superamento
dell’antinomia tra giusnaturalismo e positivismo, producendo un
sistema di positiva convivenza tra valori e norme. Valori e norme,
operano nei propri ambiti di competenza intessendo, tuttavia, quel
dialogo che consente al diritto di non avvizzire nell’autoreferenzialità e poter evolvere alla luce dei segni dei tempi.
Le clausole generali favoriscono questo dialogo, consentono
che il contenuto del compromesso fondativo che, per la prima
volta, positivizza i valori, possa continuare ad esser aggiornato,
cioè consenta al diritto di vivere.
Questa operazione, tuttavia, non è neutrale. Le decisioni che,
(138)
Mengoni. 1998, 7 ss.
49
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ispirandosi a valori extra giuridici, “aggiornano” il diritto, sono in
grado di modificare il preesistente equilibrio tra Stato e cittadino,
o tra le parti del contratto, così da incidere sugli interessi delle
parti stesse. Quando il legislatore ha aggiornato la regola della
libertà di recesso nel rapporto di lavoro, introducendo l’obbligo di
motivazione, ha alterato l’assetto di interessi a favore della c.d.
parte debole, accogliendo una istanza presente nella società.
Quando i giudici, avvalendosi delle clausole generali, hanno dato
una interpretazione più o meno ampia alle nozioni lasciate aperte
dal legislatore, hanno, a loro volta, attinto a valori esterni percepiti
“anche” secondo la propria sensibilità.
Perché tutto ciò possa funzionare correttamene, è necessario il
consenso, non inteso, ovviamente, come consenso individuale bensì
come consenso collettivo. “El consenso es un presupuesto del
funcionamiento pacífico de la actividad judicial en materia de
cláusulas generales” (139).
Ciò spiega perché il dibattito sulle clausole generali, prevedendone i possibili effetti sugli interessi delle parti, sia stato spesso
caratterizzato dall’antinomia tra fuga dalle clausole generali e fuga
nelle clausole generali.
La fase di consenso del diritto del lavoro ha attraversato
momenti di forte conflittualità, ma il sacrificio di interessi dell’impresa veniva ritenuto giustificato dall’esigenza di tutelare diritti ed
interessi dei lavoratori nell’ottica di un più generale interesse
sociale. Ciò che, in fondo, è rappresentato nell’art. 41 Cost.
Quel consenso è venuto meno: “la crisis de las visiones totalizadoras ha hecho explotar todo texto unificador; los intereses son
individuales o sectoriales, perfectamente diferenciados unos de
otros” (140).
La mancanza di valori comuni, ed anzi l’affermarsi di visioni
contrapposte ed inconciliabili, si riflette nel diritto. Quasi tutti gli
elementi del circuito virtuoso che, nel secolo scorso, pur in mezzo
a mille difficoltà, hanno consentito al diritto di rappresentare e
regolare la complessità del reale sono così entrati in crisi. Il potere
legislativo ed il potere giudiziario si trovano in una nuova fase di
emergenza, non per la necessità di superare una transitoria situa(139) Lorenzetti, 2013, 157.
(140) Ivi.
50
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
zione di difficoltà, bensì in vista, ed in preparazione, all’affermarsi
di una nuova, rivoluzionaria visione ideale della società. Vengono
sempre più sollecitati a porre al centro della propria attività un
interesse altro e diverso rispetto a quello suggerito nell’art. 3,
comma II, della Costituzione (la promozione della persona umana
e la garanzia dei diritti fondamentali della persona) e cioè l’interesse dell’impresa nella sua declinazione di diritto alla concorrenza.
Si può facilmente osservare come non solo la Corte di Giustizia
europea, ma anche alcune Corti costituzionali nazionali, pur con
qualche eccezione, siano disponibili a limitare alcuni diritti fondamentali in nome della crisi economica in atto, cioè in nome dell’interesse dell’impresa e non, come più frequentemente avveniva nel
passato, operando il bilanciamento con l’interesse dell’occupazione.
La differenza, rispetto ad analoghi processi evoluti del passato,
sta nel venir meno di un condiviso patrimonio di valori. Il giudice
che, con la tecnica della clausole generali, dovesse attingere ad
istanze extragiuridiche, riscontrerebbe ancora la presenza di valori
affatto differenti da quelli che oggi premono perché il diritto si
converta definitivamente in uno strumento funzionale al razionalismo economico e dedito alla sua causa. In questo senso, le
clausole generali sono viste con sospetto da chi muove i fili di
questa operazione proprio perché, l’integrazione valutativa potrebbe recepire istanze di segno opposto al disegno generale di cui
si è detto. “Non possiamo ignorare che certe correnti della cultura
moderna, sostenute da principi economici razionalistici e individualisti, hanno alienato il concetto di giustizia dalle sue radici
trascendenti” (141): così dichiara il Papa, ponendo l’accento proprio sulla divaricazione tra i valori (per noi) positivizzati, il valore
la dignità ed i diritti della persona, che “al di là delle dichiarazioni
di intenti”, “sono seriamente minacciati dalla diffusa tendenza a
ricorrere esclusivamente ai criteri dell’utilità, del profitto, e dell’avere” (142).
L’attuale trasformazione, in altri termini, non è spinta da
valori diffusamente condivisi all’interno della società, bensì da un
soggetto esterno, la forza di una visione economica totalizzante
(141) Benedetto XVI, 2012, 4.
(142) Ivi.
51
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
che, nelle sue visioni più estreme, persino dileggia il diritto ed i
giuristi (143), confermando la perdita di autorità del punto di vista
giuridico di cui parlava D’Antona (144). Questa visione si impone
più con la forza che con il consenso, grazie all’enorme potere degli
interessi che rappresenta. Potere che, nella convinzione delle proprie ragioni, viene esercitato prevalentemente dall’esterno e fuori
dalle regole della democrazia. Il diritto, così come è arrivato sino ai
nostri giorni, sia per suoi contenuti (per quanto ancora conserva
dell’idea di stato sociale), sia per le regole del suo esercizio (ivi
compresa la funzione giudiziale) rappresenta un ostacolo all’affermarsi definitivo di questa nuova visione totalizzante. Ne soffre la
stessa democrazia: gli equilibri delle funzioni democratiche rappresentate dalla divisone dei poteri si vanno modificando anche nel
rapporto Stato-cittadino. Il capo dell’esecutivo italiano, nell’assumere decisioni strategiche per l’intera comunità del paese, espone
così la sua, nuova, visione democratica: “Capisco che debbano
tener conto del loro Parlamento, ma ogni governo ha anche il
dovere di educare le camere.... Se io mi fossi attenuto in maniera
del tutto meccanica alle direttive del mio parlamento, non avrei
mai potuto approvare le decisioni dell’ultimo vertice di Bruxelles” (145).
Detto in termini semplici: la discrezionalità concessa al giudice
di concretizzare nome aperte sulla base di idee diffuse e largamente
condivise nell’ambiente sociale, da molti viste come “indispensabili
nella società moderna ed anzi meglio rispondenti alla pluralità di
tradizioni ed orientamenti che in essa convivono” sono viste con
diffidenza, tanto da indurre il legislatore a tentare di soffocarne la
portata ed il senso appropriandosi “di stilemi e categorie nate sul
terreno della dottrina e dell’esperienza giudiziale per piegarle a
finalità diverse e contrarie alle originali ragioni” (146).
(143) Veljanovski scrive che “una fondamentale ragione che spiega la tensione tra il
giurista e l’economista ha a che vedere con il ruolo delle teorie. Il metodo di analisi del
giurista è letterario, il suo ragionamento si fonda sulla metafora, l’analogia, la similitudine.
Il diritto è parassita delle scienze sociali, della filosofia e di altre discipline, proprio perché
la sua limitata base intellettuale le ha impedito di elaborare un armamentario teorico”
Veljanovski, 2011, 31.
(144) D’Antona, 1990, 207 ss.
(145) Monti, 2012, 29.
(146) Rescigno, 2011, 1960.
52
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Né mancano contraddizioni, visto che, proprio all’indomani
del manifesto con il quale il potere legislativo ha proclamato il suo
disegno strategico volto a limitare il potere dei giudici, suggerendo
un diverso equilibrio tra i diritti di cui all’art. 41 Cost., lo stesso
legislatore, nel perseguire l’analoga finalità di sterilizzare la più
significativa tutela dei lavoratori subordinati, la tutela reale in
caso di licenziamento illegittimo, ha finito per ampliare il potere
interpretativo del giudice sino a porre nelle sue mani, almeno in
apparenza, la decisone circa l’applicazione della tutela reale in caso
di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo: “il
giudice ‘può’ disporre”.
Si tratta della conferma di come l’urgenza di conseguire il
risultato, e l’art. 18 vale uno scacco al re, prevalga sulla razionalità.
Di fronte alla strenua resistenza di alcune forze sociali che non
hanno consentito di normalizzare ogni ipotesi di licenziamento
illegittimo, ma non discriminatorio, nell’ambito della tutela obbligatoria, il legislatore si è accontentato di una tracciatura approssimativa dei nuovi confini anche al prezzo di ampliare il potere
giudiziario. La legge n. 92/2012, pur accettando il compromesso, si
pone come negazione del significato di decenni di elaborazioni
giurisprudenziali in materia di licenziamento illegittimo, tant’è
che, all’indomani della sua emanazione, senza neppure attendere la
prima giurisprudenza di merito, si è potuto affermare che, grazie
appunto alla mera formulazione della norma, nel licenziamento
illegittimo per giustificato motivo oggettivo, extrema ratio, all’inverso di quanto prima ipotizzato, sarebbe ora la reintegrazione
del lavoratore illegittimamente licenziato (147). Ma le cose non
stanno proprio così. Il potere e l’indipendenza della magistratura
non sono “graziose” concessioni del potere legislativo. “La sacra
formula riprodotta nella Costituzione, per cui il giudice dipende
solo dalla legge” — scriveva Salvatore Satta 50 anni orsono — non
si riferisce all’indipendenza dal potere esecutivo, “essa esprime
piuttosto... l’indipendenza dal legislatore che diventa estraneo alla
legge che egli ha posto, cedendo il potere al giudice, che diventa il
legislatore del caso concreto. Magistratum vere dicimus legem esse
loquentem (148). Si tratta di un potere che non può essere facil(147)
(148)
Vallebona, 2012.
Satta, 2004, 247.
53
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
mente “revocato” dalla formulazione di una norma, anche perché
il materiale oggi a disposizione dell’interprete è più che mai articolato, multilivello. Il comando contenuto nelle clausole generali,
alle quali, almeno per il momento, non può farsi a meno di
ricorrere, è un riferimento che va letto alla luce dei principi
generali, valutato alla stregua degli ordinamenti sovranazionali,
dev’esser dotato di logicità e di razionalità, non apparire in contrasto con l’ordine pubblico. Tutto ciò si converte in una complessa
attività di bilanciamento, che è nel potere del giudice, cioè di un
giudice che non travalica affatto la propria funzione proclamata
dalla Costituzione. Egli, essendo indipendente proprio dal potere
legislativo, è tutt’altro che un esecutore ed anzi, soprattutto nelle
fasi di crisi, si presenta come legittimo contropotere. Detto in altri
termini: poiché l’ordinamento giuridico, nel suo complesso, continua ad essere retto da principi generali ispirati a valori di giustizia,
di solidarietà, di uguaglianza..., all’arretramento della funzione
legislativa nella tutela dei corrispondenti diritti individuali e collettivi, che tradisce il mandato di cui all’art. 3, II comma della
Cost., può far da contrappeso l’esaltazione di un’altra funzione,
quella giudiziaria.
L’attività del giudice, cioè il processo, opera come “dispositivo
di connessione tra società e mondo del lavoro produttivo”. Il
processo del lavoro, infatti, impedisce al sistema produttivo “di
diventare un mondo a parte rispetto alle idee di giustizia, di
normalità, di valore circolanti nel corpo sociale e assoggettato alla
logica del più forte” (149).
È quanto, in altre parole, riconosce quella giurisprudenza che
considera le clausole generali “indicazioni di “valori” ordinamentali, espressi con formule generiche... che scientemente il legislatore
trasmette all’interprete per consentirgli, nell’ambito di una più
ampia discrezionalità, di “attualizzare” il diritto, anche mediante
l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti
personali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi” (150).
La tensione si fa acuta quando i poteri che concorrono a questa
fase di “attualizzazione”, ed è il caso riprendere in considerazione
(149) Niccolai, 2013, 14.
(150) Cass n. 10741, 11 maggio 2009.
54
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
anche il potere esecutivo, non operano in sincronia ma, in un certo
senso, avanzano per vie contrapposte: mentre gli uni agiscono nella
direzione della esaltazione dei diritti dell’impresa, assumendo come
valore prevalente la concorrenza, il giudice non può fare a meno di
operare sotto l’ombrello dei principi costituzionali e, quando gli è
concesso di attingere alla realtà storica, come nelle clausole generali, è facile che trovi ancora spazio per un’interpretazione orientata verso gli stessi valori sino a qualche tempo fa esaltati dallo
Stato interventista e che ancora permangono nella coscienza sociale.
Non si tratta né di una frizione temporanea, destinata ad
essere superata con il superamento della crisi economica, ma
neppure di una frizione necessariamente destinata a stabilizzarsi.
È la manifestazione di una crisi che, a partire da elementi apparentemente pragmatici — quali la necessità di riaffermare poteri
dell’impresa ritenuti eccessivamente compressi dalla legislazione
dello Stato interventista — si estende ai valori fondativi sino a
rimettere in discussione la formulazione stessa di quelle norme
costituzionali che hanno positivizzato quei valori. Modificare l’art.
41 della Costituzione significherebbe, prima di tutto rimettere in
discussione quel patrimonio di norme (legali ed extralegali) che
sulla base di quel principio, per oltre mezzo secolo, ha arricchito
l’esperienza repubblicana.
Le recenti riforme del mercato del lavoro, e non soltanto in
Italia, “están provocando regresiones en la norma laboral que
empiezan a encontrar puntos de fricción más frecuentes e intensos
con las normas constitucionales y con las obligaciones asumidas en
las normas supranacionales, incluso esos puntos de fricción aparecen con el propio derecho común” (151).
Delle clausole generali, per il momento, non si può prescindere.
Persino nelle materie oggetto di una disciplina legale minuziosa,
come la sicurezza negli ambienti di lavoro, è difficile immaginare
un ordinamento che possa fare a meno di norme, quali l’art. 2087
c.c. che, storicamente, ha consentito, per un verso quella “attualizzazione” di cui tanto si parla e, per altro verso, una migliore
applicazione del principio di giustizia ai casi concreti.
La crisi, in definitiva, non si manifesta nell’uso delle clausole
(151)
Alfonso Mellado C. L., 2013, 4.
55
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
generarli che, in definitiva, non fanno altro che metter in comunicazione la dinamica della norma positiva con il mondo di relazioni
umane in cui trova applicatone, bensì quando “l’interprete di tale
norma non sia più in grado di farsi interprete di una lettura
diffusamente e socialmente condivisa di quella clausola nel suo
tempo, soprattutto se si tratta di un Giudice apicale e inappellabile
di natura sovranazionale quale appunto la Corte di giustizia UE,
tanto da farlo atteggiare quale organo con funzioni para-normative” (152).
Tra gli effetti della crisi, non può farsi a meno di ricordare la
rapida evoluzione, o involuzione, della più tipica modalità di
apertura dell’ordinamento a fonti extralegali, la contrattazione
collettiva. Il legislatore, dopo averla promossa, in funzione progressiva, per il contributo all’affermazione di principi sanciti nella
Costituzione ed appartenenti ad un comune patrimonio di valori,
pretende oggi di utilizzarla per intraprendere un percorso inverso,
strumentale al disegno del razionalismo economico, dotando alcune sue articolazioni decentrate persino di poteri derogatori della
legge, ovviamente in peius, mai prima praticati con tale intensità
ed estensione sino ad entrare in rotta di collisione con l’art. 39 Cost.
Il tempo dello Stato interventista, per il diritto del lavoro, è
stato caratterizzato dalla “fuga” verso la specialità. Si è trattato di
un cammino lungo e difficile, fortemente contaminato da esperienze storiche ed ideologiche, ma caratterizzato da un sostanziale,
ampio, consenso.
Ora, il diritto speciale del lavoro non solo non è più in grado di
garantire la protezione sinora accordata, ma incomincia ad essere
utilizzato, e ad essere teorizzato, in senso prevalentemente funzionale all’interesse dell’impresa. È per questo che il diritto privato,
integrato dalla razionale applicazione dei principi generali contenuti nella Costituzione, incomincia ad offrire livelli di tutela per il
contraente debole che il diritto speciale del lavoro non è più in
grado di garantire. Posto che si tratterà di far riferimento a
principi, piuttosto che a norme speciali, è evidente che le clausole
generali potrebbero risultare di estrema importanza. Clausole generali che, in conclusione, hanno anche a che vedere, oltreché con
il ruolo dei giudici, anche con quello dei giuristi, nel nostro caso dei
(152) Pallini, 2009, 203.
56
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
giuslavoristi, e non a caso, sia vecchi maestri che giovani, hanno
ripreso ad interrogarsi su questo tema con rinnovato impegno e
passione. Valga per tutti, in conclusione, una recente riflessione di
Miguel Rodríguez Pinero: “Hemos de enfrentarnos abiertamente
con la excesiva colonización del Derecho por un pensamiento
económico, insensible a las consecuencias sociales o axiológicas de
sus improbadas teorías y al crecimiento exponencial de las desigualdades y de la pobreza que viene generando su aplicación. Ante
ello, los juristas no podemos permanecer silentes, debemos aportar
nuestro grano de arena a la solución de serios problemas institucionales y constitucionales pendientes, y dar respuesta a la exigencia ciudadana de justicia total” (153).
13. Conclusioni (due).
Molti anni fa, ad epigrafe della mia prima monografia, ho
inserito un versetto dell’Ecclesiaste: c’è un tempo per ogni cosa.
Oggi, ragionando sulle clausole generali e sul mutevole significato che esse traggono con il passare del tempo, mi accorgo di come
l’interpretazione di quelle parole, iscritte da secoli a memoria degli
uomini e delle donne, sia profondamente diversa da quella attuale.
Era, allora, il tempo del principio. È, ora, il tempo della fine.
La fine di una carriera da mediano che mi accorgo di vivere con
emozioni affatto differenti dal tempo in cui, a parte dolorose
contingenze, coltivavo aspettative. Aspettative che non ho più,
come è giusto che sia, proprio perché c’è un tempo per ogni cosa.
Questo è il tempo di terminare la mia carriera di docente, con
qualche anno d’anticipo rispetto al tempo canonico, per una certa
insofferenza all’ambiente e senza lasciarmi convincere da chi ha
tentato di dissuadermi. Con questa relazione ha termine anche la
mia esperienza dentro questa associazione che ho frequentato sin
dall’inizio della carriera e che mi ha visto, per due mandati, nel
tempo suo, all’interno dell’organismo direttivo.
Un commiato, quindi, che mi ispira tre, semplici, riflessioni.
La prima è per rendere conto dei talenti. Li ho investiti tutti
nell’Università. Ora che è tempo di lasciarla, laddove vi era il
vuoto rimane memoria di attività scientifica e rimangono due
(153)
Rodriguez Pinero y Bravo Ferrer, 2013.
57
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
professori (Piera Loi ed Entico Mastinu) ai quali, per quanto ho
potuto, ho dato una mano, e di cui sono orgoglioso, come dovrebbe
essere orgogliosa l’intera accademia. Credo che lo sia, a parte
qualche strabismo che sempre può capitare.
In secondo luogo. La vita accademica, in Italia ed in alcuni
altri paesi a me più congeniali per lingua e cultura, mi ha consentito relazioni personali di stima e di amicizia, talvolta producendo
affetti così importanti da farsi spazio con prepotenza nella mia
vita. Stima ed amicizia che son cresciute al di la degli steccati delle
scuole e degli interessi accademici. Queste relazioni me le porto
appresso nell’intimo. Ma ad una di esse, perché la più simbolica per
il metodo, la passione, l’umanità, l’interpretazione esemplare di ciò
che il nostro lavoro dovrebbe essere, voglio dare un nome: quello di
Mario Napoli.
Da ultimo, lo stupore per l’evento, per me ancora misterioso,
che mi ha aperto la strada dell’accademia. L’incontro, casuale, con
un maestro, Tiziano Treu, che nonostante la mia evidente inadeguatezza (venivo da esperienze affatto diverse e privo di preparazione specifica) mi ha sopportato ed aperto la strada. Solo ed
esclusivamente alla sua pazienza devo il fatto di esser rimasto in
quest’ambiente. Uno di quei maestri capaci di contribuire ad un
governo equilibrato e ragionevole degli eventi della disciplina di
cui in questo tempo (dove è facile che autoproclamarsi prìncipi) si
avverte la mancanza.
Non gli chiederò mai perché lo abbia fatto. Ma spero che non
se ne sia pentito.
Riferimenti bibliografici.
AA.VV. (2011). Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiana. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e
Novecento. Colao F., Lacchè L., Stordi C., Valsecchi C., a cura di, Eum,
Università di Macerata.
ALFONSO MELLADO C. L. (2013). El derecho del trabajo. Referentes constitucionales e
internacionales. Madrid: Fundación 1° de mayo.
BALLESTRERO M.V. (2009). Perturbazioni in arrivo. I licenziamenti nel d.d.l. 116.
LD.
BENEDETTO XVI (2012). Messaggio in occasione della giornata mondiale della pace, 1
gennaio 2012, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/
peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace_it.html.
BRECCIA G.U. (2007). Clausole generali e ruolo del giudice. LD, n. 3.
58
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
CARINCI M.T. (2011). Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice.
A proposito dell’art. 30, l. 183/2010. In: “I working papers. C.S.D.L.E.
“Massimo D’antona”, n. 114.
CASTRONOVO C. (1979). Problema e sistema del danno da prodotti. Milano: Giuffrè.
CASTRONOVO C. (1986). L’avventura delle clausole generali. RCDP.
CASTRONOVO C. (2012). Il significato vivente di Luigi Mengoni nei suoi Scritti. In:
Europa e diritto privato.
CASTRONUOVO D. (2012). Clausole generali e diritto penale. Diritto Penale Contemporaneo, 14 novembre.
COLAO F., LACCHÈ L., STORTI C., VALSECCHI C., a cura di, (2011). Le circolari
ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e
Novecento, Macerata, Eum.
D’AMICO G. (1989). Note in tema di clausole generali. Iure Praesentia.
D’ANTONA M. (1990). L’anomalia post-positivista del diritto del lavoro e la questione
del metodo. RCDP.
DEL PUNTA R. (2012). Il giudice del lavoro tra pressioni legislative e aperture di
sistema. RIDL, I.
DENOZZA F. (2009). Diritto e potere in un mondo senza costi di transazione: un saggio
sulla funzione legittimante della narrativa Coasiana. RDPr, II.
DENOZZA F. (2011). Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale:
un’analisi funzionale. RCDP.
DI MAJO A. (1984). Clausole generali e diritto delle obbligazioni. RCDP.
FABIANI E. (2012). Clausola generale. Enc. Dir., Annali.
FERNÁNDEZ SANCHEZ S. (2012). L’autonomia individuale nelle origini del diritto del
lavoro. Milano: Giappichelli.
FERRARO, G. (2009). Poteri imprenditoriali e clausole generali. DLM, I.
FORCELLINI F. (2014). Le forme della generalizzazione: tra regole e principi. www.Jus
civile.it, n. 3.
GENTILI A. (2010). Prefazione, in VELLUZZI V. Le clausole generali. Semantica e
politica del diritto. Milano: Giuffrè.
GIL Y GIL, J. L. (1994). Autotutela privada y poder disciplinario en la empresa.
Madrid: Ministerio de Justicia.
GIUGNI G. (1986). Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano.
DLRI.
GIUSTINIANO A. (2013). La giustizia a partire da un nuovo modello di razionalità.
Lessico di etica pubblica, 4, n. 2.
GJERGJI I. (2012). Circolari amministrative e immigrazione. Milano: Angeli.
HABERMAS, J. (1986). Law as Medium and Law as Institution, in G. TEUBNER (ed
by), Dilemmas of Law in the Welfare State, Berlin: De Gruyter.
HABERMAS J. (1996). Fatti e norme. Milano: Guerini e Associati.
LIBERTINI M. (2011). Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto
indeterminato. Una proposta di distinzione, Relazione al II convegno nazionale: Orizzonti del diritto commerciale, Roma 11-12 febbraio.
LIBERTINI M. (1991). Il vincolo del diritto positivo per il giurista. In: Studi in onore
di A. Falzea. Milano: Giuffrè.
LIBERTINI M. (2008). Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una
discussione. RDComm., I.
59
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
LOI P. (2000). La sicurezza: diritto e fondamenti dei diritti nel rapporto di lavoro.
Torino: Giappichelli.
LOY G. (1993). Capacità fisica e rapporto di lavoro. Milano: Angeli.
LORENZETTI R. (2013). La discrecionalidad del Juez en el marco de la legislación por
cláusulas generales y los límites constitucionales. Pontificia Universidad Católica del Perú, http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/
6538.
LUZZATI C. (2012). La normalizzazione delle clausole generali. Dalla semantica alla
pragmatica. RCDP.
MENGONI L. (1986). Spunti per una teoria delle clausole generali. RCDP.
MENGONI L. (1990). Diritto vivente. Dig. disc. priv., Sez.. civ., vol. VI. Torino: Utet
giuridica.
MENGONI L. (1992). I principi generali del diritto e la scienza giuridica. DL, I.
MENGONI L. (1996). Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi. Milano: Giuffrè.
MENGONI L. (1998). Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell’uomo
e doveri inderogabili di solidarietà. In: Napoli M., a cura di, Costituzione,
lavoro, pluralismo sociale. Milano: Vita & Pensiero.
MENGONI L. (2004). Intervento. In: Mengoni L., Napoli M., a cura di, Il lavoro nella
dottrina sociale della Chiesa. Milano: Vita & Pensiero.
MERUZZI G. (2005). L’Exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale. Padova:
Cedam.
MIQUEL GONZÁLEZ J. M. (1997). Cláusulas generales y desarrollo judicial del derecho.
In: Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid,
n. 1.
MONTI M. (2014). Dichiarazione resa a Spiegel 5 agosto 2012, riportato da Repubblica 2 aprile 2014, p. 29.
MUSIO, I. (2010). Breve analisi comparata sulla clausola generale della buona fede.
In: www.comparazionedirittocivile.it., maggio.
NICCOLAI S. (2013). Per una lettura costituzionalmente orientata della riforma Fornero ed un diritto del lavoro nuovo. In: Amato F., Sanlorenzo R., a cura di,
Riforma Fornero: un’analisi ragionata (l. n. 92/2012). Altalex.com.
NIETO A. (2010). El arbitrio judicial. Barcelona: Ariel.
NIVARRA L. (2002). Ragionevolezza e diritto privato. AI.
NIVARRA, L. (2010). Diritto privato e capitalismo. Regole giuridiche e paradigmi di
mercato. Napoli: Editoriale Scientifica.
NOGLER L. (2010). La regulacion de los despidos individuales en la epoca del
equilibrio entre los “principios” constitucionales. La Coruna: Netbiblo.
NOGLER L. (2006). L’itinerario metodologico di Lugi Mengoni. I working papers,
Centro Studi di diritto del lavoro “Massimo D’Antona”, n. 47.
NOGLER L. (2011). Opinioni sul collegato lavoro. DLRI.
PALLINI, M. (2009). La tutela dell’ “ordine pubblico sociale” quale limite alla libertà
di circolazione dei servizi nel mercato UE. In: Vimercati A., a cura di, Il
conflitto sbilanciato. Libertà economiche e autonomia collettiva tra ordinamento
comunitario e ordinamenti nazionali. Bari: Cacucci.
PATTI S. (2013). Ragionevolezza e clausole generali. Milano: Giuffrè.
PEDRINI F. (2009). Clausole generali e costituzione. Una (prima) mappa concettuale.
Forum di Quaderni costituzionali.
60
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
PEDRINI F. (2012). Clausole generali e costituzione: osservazioni introduttive. Quaderni costituzionali. n. 2.
PEDRINI F. (2014). Le clausole generali. Profili teorici e aspetti costituzionali.
Bologna: Bononia University Press.
PERELMAN C. (1984). Les notions à contenu variable en droit. Essai de synthèse. In:
Perelman C. e Vander Elst R., a cura di, Les notions à contenu variable en
droit. Bruxelles: Bruyant.
PERFETTI L.R. (2012). Per una teoria delle clausole generali in relazione all’esercizio
dei pubblici poteri. Il problema dell’equità. GI, maggio.
PERSIANI M. (2000). Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico. ADL.
PERULLI A. (2011). I concetti qualitativi nel diritto del lavoro: standard, ragionevolezza equità. DLM, III.
PERULLI A. (2005). Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro. DLRI.
PERULLI A., SPEZIALE V. (2012). L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la
“rivoluzione di Agosto” del Diritto del lavoro, in http://www.cgil.it/Archivio/
Giuridico/L_articolo_8_legge_148-2011-saggio_WP_testo_finale.pdf.
PERULLI A. (2014). Certificazione dei contratti di lavoro e controllo dei poteri
dell’imprenditore: il ruolo e le prerogative del giudice. In: Rapporto individuale
e processo del lavoro, II, diretto da Fiorillo L. e Perulli A. Torino: Giappichelli.
(numerazione delle pagine nella versione pdf pubblicata nel sito dell’autore).
PICCININI A. (2012). A due anni dalla Fornero: la tutela del lavoratore nell’art. 18. In:
Aa. Vv., Rapporti di lavoro e ammortizzatori sociali. Roma: Ediesse.
RESCIGNO P. (2011). Una nuova stagione per le clausole generali. GI.
RODOTÀ S. (1967). Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile. RDComm., I.
RODOTÀ S. (1987). Il tempo delle clausole generali. RCDP.
RODOTÀ S. (2009). Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile. In: Orestatno
A., a cura di, Lezioni sul contratto, Torino: Giappichelli.
RODRIGUEZ PINERO Y BRAVO FERRER M. (2013). Intervento pronunciato il 7 novembre 2013 in occasione del ricevimento del Premio Pelayo, dattiloscritto.
ROSELLI F. (2013). Clausole generali e nomofilachia, relazione all’incontro di studio
svoltosi 10 ottobre presso la Corte di Cassazione.
RUSCIANO M. (2011). Una rilettura di Mengoni. RTDPC, 4.
SATTA S. (2004). Soliloqui e colloqui di un giurista. Padova: Cedam, 1968, nella
riedizione: Nuoro: Ilisso.
SCOGNAMIGLIO C. (1992). Clausole generali e linguaggio del legislatore: lo standard
della ragionevolezza nel d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224. In: Quadrimestre.
STAIANO R. (2013). Contratto a termine e specificazione dei motivi. Diritto.it (25.06).
TARUFFO M. (2003). Prefazione a: Fabiani E. Clausole generali e sindacato della
cassazione. Torino: Utet.
TARUFFO M. (2007). Precedente e giurisprudenza. RTDC, 3.
TARUFFO M. (2014). La giurisprudenza tra casistica e uniformità. RTDPC.
TEUBNER G. (1992). Social order from legislative noise: autopoietic closure as a
problem for legal regulation. In: Teubner G., Febbrajo A. (ed by) State, Law
and Economy as Autopoietic Systems: Regulation and Autonomy in a New
Perspective. Milano: Giuffrè.
TIRABOSCHI, M. (2010). Giustizia del lavoro: la riforma del Collegato. In: Guida al
Lavoro.
61
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
TREU T. (1996). La giurisprudenza e l’ordinamento sindacale. In: Bessone M., a
cura di, Diritto giurisprudenziale. Torino: Giappichelli.
TREU T. (1985). Il futuro del lavoro: contrattualismo, interventismo, liberismo. Ius,
Vita e pensiero, n. 3.
TREU T. (2013). Le istituzioni del lavoro nell’Europa della crisi, Giornate di Studio
AIDLASS, Bologna 16-17 maggio, in: http://www.aidlass.it/news/aidlassgiornate-di-studio-la-crisi-e-i-fondamenti-del-diritto-del-lavoro.
TULLINI P. (1990). Clausole generali e rapporto di lavoro. Rimini: Maggioli.
VALLEBONA A. (2002). Intervento. In: Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, Atti
delle giornate di studio, (Ferrara, 11-13 maggio 2000). Milano: Giuffrè.
VALLEBONA A. (2010). Una buona svolta del diritto del lavoro: il “collegato” 2010.
MGL, n. 4.
VALLEBONA A. (2012). La riforma del lavoro 2012. Torino: Giappichelli.
VARDARO G. (1984). Contrattazione collettiva e sistema giuridico. Napoli: Jovene.
VELJANOVSKI C. (1990). The Economics of Law An Introductory Text. Londres:
Institute of Economic Affairs.
VELLUZZI V. (2010). Le clausole generali. Semantica e politica del diritto. Milano:
Giuffrè.
VISONÀ, S. (2012). La tutela giurisdizionale. Licenziamenti e sindacato giudiziale.
Treccani.it.
WEBER M. (1961). Wirtschaft und Gesellschaft, (tr. it.) Economia e società. Torino:
Edizioni di Comunità.
ZOLI C. (1988). La tutela delle posizioni strumentali del lavoratore. Milano: Giuffrè.
ZOLI C. (2011). La legge n. 183/2010: le novità in materia di licenziamento. ADL,
4/5.
62
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
AUTONOMIA COLLETTIVA E CLAUSOLE GENERALI
di STEFANO BELLOMO
Il procedimento di formazione del diritto non si conclude
nel momento in cui il legislatore si spoglia della legge con l’atto formale
della promulgazione. V’è un momento successivo — quello in cui la legge
entra nella carnalità della vita grazie alla interpretazione/applicazione — che
deve essere recuperato quale momento interno — e il più alto e il più vivo
— del processo formativo della giuridicità.
(P. GROSSI, Storicità del diritto)
SOMMARIO: 1. Oggetto, finalità dell’indagine e premesse generali. — 1.1. Sul metodo. — 1.2.
Sulla nozione di clausola generale (rinvio al successivo n. 2). — 1.3. Sul rapporto tra
clausole generali (anche in veste di “norme elastiche”) e funzioni del contratto
collettivo. — 2. La nozione di riferimento: asserita dicotomia tra “clausole generali” e
“norme elastiche” e spunti per un suo possibile superamento. — 3. Le clausole generali
come norme di rinvio. — 4. Clausole generali e standards valutativi. — 5. Differenziazioni contenutistiche e funzionali tra clausole generali, standards valutativi, principi
giuridici e norme costituzionali. — 5.1. Alterità tra principi e dati di realtà sociale nel
momento applicativo delle clausole generali. — 6. L’intervento dell’autonomia collettiva in funzione di integrazione della fattispecie legale. L’esempio paradigmatico
dell’applicazione per via giudiziale dell’art. 36, primo comma, Cost. — 7. Diligenza e
autonomia collettiva. — 7.1. Diligenza, codici etici, “credo aziendali” e rapporti con gli
standard comportamentali ricavabili dalla contrattazione collettiva. — 8. Ius variandi
e autonomia collettiva. — 8.1. Equivalenza delle mansioni e lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni. — 8.2. Mobilità geografica e ragioni giustificative del
trasferimento. — 9. Inadempimento, potere disciplinare, licenziamento. — 9.1. Licenziamento e “tipizzazioni” di fonte collettiva. — 10. Autonomia collettiva e clausole
generali (in senso atecnico) nella legislazione in materia di lavoro flessibile: contratto
di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro a termine. — 11. Le
ipotesi di rinvio al contratto collettivo quale canale primario o esclusivo di concretizzazione delle clausole generali. — 12. Ragionevolezza, clausole generali e autonomia
collettiva. — 13. L’applicazione giudiziale delle clausole generali di correttezza e
buona fede in funzione di integrazione degli obblighi posti dal contratto collettivo. —
14. Conclusioni. La relazione tra clausole generali e autonomia collettiva come possibile percorso di “costruzione della normalità”.
63
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
1. Oggetto, finalità dell’indagine e premesse generali.
Nell’ampia produzione scientifica in materia di clausole generali nel diritto del lavoro, si deve constatare come il tema delle
interrelazioni fra questa tecnica normativa e l’autonomia collettiva — con particolare riguardo al principale prodotto di quest’ultima, ossia il contratto collettivo — sia sinora rimasto, in generale
e se si eccettuano alcuni non frequenti picchi di interesse, piuttosto
al margine della discussione.
Occorre, dunque, per prima cosa interrogarsi sulla ragione per
la quale i raccordi tra questi fenomeni giuridici non sono stati più
frequentemente e organicamente esaminati. Questo interesse apparentemente ridotto della dottrina potrebbe apparire a maggior
ragione poco spiegabile in considerazione del fatto che nel settore
dell’ordinamento in cui si colloca la disciplina dei rapporti di
lavoro, così incisivamente caratterizzato dalla combinazione di
norme statuali e regole di fonte collettiva, la diffusione o il
“flusso” (1) di norme appartenenti alla macro-categoria delle clausole e norme elastiche/generali/aperte/a contenuto indeterminato
(espressioni sul cui puntuale significato ci si interrogherà più
innanzi) è sempre stata storicamente molto intensa (2) ed ha,
peraltro, vissuto nell’ultimo quindicennio una fase di nuovo e
rilevante impulso (3).
In effetti, tuttavia, più che trascurata, quella tra l’ambito di
applicazione delle clausole generali ed i campi di intervento dell’autonomia collettiva è stata prevalentemente ritratta dalla dottrina come una relazione di alternatività o, meglio, di alterità, se non
di reciproca elisione, piuttosto che di possibile complementarietà
ossia di reciproca integrazione.
In questo senso si orientano, ad esempio, le affermazioni,
abbastanza ricorrenti nelle opere monografiche e negli articoli
dedicati a queste tematiche, secondo le quali, per gli aspetti in cui
l’esercizio del potere imprenditoriale si presenti compiutamente
regolato o disciplinato attraverso forme pattizie, non sarebbero
(1) Montuschi, 1996, 139.
(2) Del Punta, 2013, 51.
(3) Come evidenziato, tra gli altri, da Ferraro, 2009, 36 ss.
64
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ravvisabili spazi per l’applicazione di questi specifici elementi
normativi (4).
Parimenti, è stato sovente rimarcato come il progressivo ampliamento dei limiti esterni ai poteri datoriali, dovuto al progressivo infittirsi della trama di vincoli procedimentali introdotti dalla
contrattazione collettiva e del costante affinamento contenutistico
degli stessi, avrebbe ridotto gli spazi per un controllo dell’esercizio
di tali poteri sulla base delle stesse clausole generali (o, più specificamente, sulla base delle clausole generali di correttezza e buona
fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.) (5).
La propensione a liquidare il tema del rapporto tra clausole
generali e autonomia collettiva negli asciutti termini di un regolamento di confini solo apparentemente molto netto può, però,
prestarsi anche ad essere letta anche come animata dall’intento di
arginare in partenza ogni problematica interferenza tra le une e
l’altra; ossia come riflesso ed elemento rivelatore di una latente
tensione interpretativa e di ben più complesse interrelazioni che in
realtà, come si avrà modo di porre in luce nel prosieguo, si manifestano ogni volta che, nella law in action, queste due manifestazioni regolative finiscono con l’entrare in contatto.
È peraltro noto che, molto spesso e in ogni settore del diritto,
a monte di ogni tesi tendente a ridimensionare l’incidenza delle
clausole generali sui rapporti obbligatori, ossia dietro quelle che
sono stati definite come spinte di “fuga” da queste ultime, si situi
la preoccupazione di una abnorme dilatazione del soggettivismo
giudiziale e di un forte indebolimento della certezza del diritto (6).
Può essere che questa preoccupazione abbia contribuito a far sì
(4) Di Majo, 1983, 350; Tullini, 1990, 182 s.
(5) Montuschi, 1999, 728; Persiani, 1995a, 143 e, nello stesso senso, più recentemente,
Marazza, 2012a, 1308.
(6) Questa preoccupazione potrebbe essere a tutt’oggi espressa con le parole di
Vallebona, 2002a, 176, il quale sottolinea che “quando la norma inderogabile consiste in una
clausola generale, il controllo successivo del giudice è dirompente in termini di certezza del
diritto, di sicurezza dell’individuo e...di competitività dell’ordinamento rispetto ad altri ordinamenti” (e si veda già, per notazioni dello stesso segno, Giugni, 1992, 74, sul cui pensiero si
tornerà in chiusura). Ancora, potrebbe essere richiamato a questo proposito il fulminante
aforisma di Cordero, 1981, 763, il quale osserva come “a fonti fluide corrispondono giudici
potenti”. Sul ruolo attribuito alle clausole generali nelle culture giuridiche dei regimi
autoritari del XX secolo cfr. per tutti, Guarneri, 1999, 140-142 ed ivi ulteriori riferimenti.
Per cenni in argomento, da ultimo, Roselli, 2014, 224.
65
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
che buona parte della dottrina si orientasse, come è avvenuto, nel
senso di una disconnessione tra le ricostruzioni dedicate alle competenze negoziali del sindacato e l’approfondimento delle tematiche concernenti significato ed effetti delle clausole generali (7).
Tuttavia, questa visione, tendenzialmente minimizzante
quando non del tutto ellittica del rapporto tra autonomia collettiva
e clausole generali (a fronte di una forte valorizzazione, in termini
più ampi, del ruolo delle clausole generali come fonti di regole di
giudizio) può essere spiegata, a mio avviso, anche alla luce di
alcune ulteriori premesse di sistema e metodologiche, che propongo
come generali chiavi di lettura di questa relazione.
1.1. Sul metodo.
La prima premessa rinvia alle ragioni metodologiche della
ridotta attenzione sinora dimostrata nei confronti al ruolo dell’autonomia collettiva come forma di concretizzazione del contenuto
delle clausole generali; una forma di concretizzazione diversa e
nella maggior parte dei casi preliminare rispetto all’ordinario
punto di osservazione, che è quello dell’intervento giudiziale.
Una delle spiegazioni di questa sottovalutazione sembra da
ricercare nell’influenza, sui nostri studi settoriali, della tradizione
(7) Una tra le ragioni per le quali la riflessione sulle clausole generali si è sviluppata
lungo coordinate che non si sono frequentemente intersecate, almeno nel periodo più
recente, con le tematiche concernenti l’autonomia collettiva potrebbe essere ricercata negli
effetti riflessi dei forti contrasti, ancora non completamente sopiti, che hanno caratterizzato
soprattutto il periodo tra gli anni ottanta e novanta e tra i cui motivi ricorrenti rientrava
quello dell’ipotizzata assoggettabilità al controllo giudiziale, sulla base degli obblighi di
correttezza e buona fede, dei contratti collettivi, con riferimento alle differenzazioni
retributive e di altra natura tra i lavoratori in relazione al loro differente inquadramento:
tra le voci di questo dibattito, si richiamano sin da ora Pessi, 1992, 3; Persiani, 1995b, 34;
Santoro-Passarelli, G., 1994, ora 2006, 560; Ferraro, 1991a, ora 1992; Del Punta, 1993 e
1996; Scarpelli, 1996, spec. 28 ss. Santucci, 1997, spec. 113 ss. Sulla inammissibilità
dell’utilizzo delle clausole generali, in particolare delle regole di buona fede e correttezza,
come fondamenti giuridici di un controllo di ragionevolezza sugli atti di esercizio dell’autonomia negoziale individuale e collettiva, Cass. 17 maggio 1996, n. 4570, diffusamente
pubblicata (ad es. in GC, 1996, I, 1899, con nota di Del Punta, e in GI, 1997, I, 1, 760, con
nota di Fantini); nello stesso senso, successivamente, Cass. 24 ottobre 1998, n. 10598, GI,
1999, 1147, con nota di Lunardon; Cass. 19 giugno 2001, n. 8296; Cass. 17 maggio 2003, n.
7752, MGL, 2004, 55; Cass. 27 maggio 2004, n. 10195; Cass. 18 agosto 2004, n. 16179; Cass.
16 maggio 2006, n. 11424. Il tema verrà più analiticamente trattato nei successivi paragrafi
n. 12 e 13.
66
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
degli studi civilistici, nei quali il consueto approccio alla tematica
delle clausole generali si incentra, normalmente, su alcuni Leitmotiven costantemente ripresi, che sono i seguenti:
a) analisi del concetto di clausola generale (e delle sue numerose filiazioni);
b) verifica della collocazione di questi enunciati normativi
nel quadro dell’ordinamento giuridico e in quello delle fonti del
diritto;
c) valutazione del potere a volte asseritamente “creativo”
della giurisprudenza, ovvero, più condivisibilmente, della competenza di tipo “ricognitivo” della tipicità sociale che, per il tramite
diretto ed immediato delle clausole generali, l’ordinamento stesso
finirebbe per affidare al giudice (8). Una impostazione, quella ora
riepilogata, che peraltro, come si ribadirà di seguito, appare in via
di parziale superamento nelle stesse elaborazioni civilistiche.
In questa prospettiva, l’unica sede nella quale si realizzerebbe
la concretizzazione del contenuto della clausola generale viene
individuata, per convenzione scientifica quasi universalmente condivisa, nella decisione giudiziale.
L’unico significativo momento applicativo delle clausole generali è ritenuto, pertanto, coincidente con quello della loro giustiziabilità.
Si può, tuttavia, obiettare che questa impostazione non ritrae
in maniera veritiera la dinamica applicativa delle clausole generali
nel diritto del lavoro dove, in realtà, l’intervento di concretizzazione o di integrazione compiuto dal contratto collettivo (ci si
soffermerà più innanzi sulle differenze tra queste distinte forme di
interazione) costituisce un momento in molti casi imprescindibile
per la concretizzazione del significato di tali previsioni legislative
(o, meglio, per alcune di esse).
Rispetto a questo primo momento di “riempimento di significato” della clausola generale in sede negoziale, l’intervento del
giudice costituisce un “a posteriori”. Un passaggio di verifica che
non può non porsi, almeno nelle premesse se non negli esiti, in linea
di continuità con il momento di definizione negoziale degli assetti
regolativi del rapporto di lavoro che si realizza nella sede collettiva
e nel corso del quale le parti sono chiamate anche a confrontarsi
(8)
Come evidenziato, ultimamente, da Libertini, 2011, 345 ss.
67
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
con i possibili significati ed effetti di alcune previsioni legislative —
catalogabili all’interno della categoria delle clausole generali, almeno nell’accezione che verrà adottata ai fini di questo studio —
che rivestono importanza centrale nell’ambito di tali assetti.
Nonostante l’innegabile connessione tra queste due fasi, è
rarissimo che siano specificamente analizzati, sempre nelle trattazioni civilistiche, altri e diversi strumenti rispetto all’applicazione
giudiziale delle clausole generali o che venga preso in esame il
possibile intervento ulteriori competenze istituzionali che permettano, attraverso una mediazione e in una sede diverse da quella
giudiziale, l’assolvimento di quella funzione “omeostatica” che
l’ordinamento assegna alle clausole generali: ossia quella di mantenere la stabilità del sistema garantendo la sintonia del diritto
rispetto ai mutamenti temporali e all’evoluzione socioeconomica (9).
Ora, è stato, condivisibilmente sottolineato come sia indubbio
che per un compiuto svolgimento del “discorso” giuslavoristico
non può ritenersi corretto né accettabile prescindere da quei concetti che ne costituiscono l’innervatura portante e gli forniscono il
vocabolario basico, non reperibili altrove se non nel diritto privato (10); strumenti che rimangono, altresì, indispensabili per la
conduzione del dialogo entro un perimetro culturale sufficientemente ampio, ossia non delimitato dai confini della materia.
Tuttavia, come pure è stato riconosciuto da altra dottrina,
forse il cospicuo debito scientifico assunto nei confronti della
dottrina privatistica non è stato onorato correttamente (11), almeno per ciò che concerne le trattazioni in tema di clausole
generali (e dunque senza voler esprimere considerazioni di respiro
più ampio).
Ciò non tanto e non solo in relazione all’esigenza, rimasta
spesso insoddisfatta, di selezionare strumenti ermeneutici in grado
di arginare una dilatazione incontrollata del potere valutativo del
giudice.
L’impressione che si ricava da una visione di insieme della
letteratura in materia di clausole generali nel diritto del lavoro è,
piuttosto, che su questo versante si sia registrata una ridotta
(9) Così definita da Rodotà, 2009, 103.
(10) Mazzotta, 1991, ora 1994, 25. E si veda già Mengoni, 1990, 10 ss.
(11) Carinci, F., 2007, XCV.
68
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
propensione o forse una certa recalcitranza all’adattamento dei
modelli privatistici alle peculiarità ordinamentali, o meglio pluriordinamentali della nostra disciplina (12); e ciò con particolare
riferimento, si diceva, alla collocazione del contratto collettivo
come primo ed imprescindibile canale di concretizzazione di una
serie notevolmente ampia di precetti generali o elastici, il cui
intervento si manifesta in un momento logicamente anteriore
rispetto al momento della verifica giudiziale.
Del resto, è pacifico come, nonostante alcune definizioni tradizionali le confinino nell’area delle tecniche di decisione delle
controversie giudiziali, non possa dirsi che le clausole generali
operino solamente come una regola di giudizio, ed in questo si
distinguono profondamente, come autorevolmente sottolineato,
dall’equità (13).
Le clausole generali si atteggiano, innanzitutto, come una
tecnica legislativa (14) e, quindi, ancor prima che nella dimensione
giudiziale, operano come regole di costruzione di una fattispecie
che, nel particolare contesto in cui ci si colloca, è destinata ad
inverarsi nel contesto della disciplina negoziale del rapporto di
lavoro.
È certo che, come è stato di recente ribadito, la mediazione
interpretativa giudiziale non può non rappresentare di per sé stessa
una componente di sistema irrinunciabile in un diritto ad alta
densità valoriale come il nostro, dove così spesso gli interventi della
giurisprudenza hanno assecondato, attraverso l’interpretazione
delle norme sostanziali, la penetrazione dei principi costituzionali
in un apparato normativo non progettato per recepirli (15).
Così come, per converso, appare condivisibile ed anzi sarà
ripetutamente rimarcata nel prosieguo, la puntualizzazione secondo la quale il giudice, nell’ambito del controllo degli atti di
esercizio dei poteri datoriali, non può e non deve esimersi dall’includere in questa valutazione anche la verifica dalla conformità di
(12) Connotazione pluriordinamentale sui cui riflessi si tornerà, al termine dell’indagine, nel paragrafo conclusivo.
(13) Mengoni, 1986, 13 e, da ultimo, Roselli, 2014, 224.
(14) Rimane imprescindibile il riferimento a Engisch, 1970, spec. 170 ss., sul punto
192. Sulle clausole generali come tecnica legislativa cfr., altresì, Di Majo, 1983, 347.
(15) Del Punta, 2012, 466.
69
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tali atti agli standards socialtipici a cui le parti dei rapporti di
lavoro normalmente si ispirano (16).
Molti interpreti hanno messo in evidenza le ragioni, sistematiche e di politica del diritto, che inducono a insistere sull’imprescindibilità e l’intangibilità della funzione giurisdizionale e la sua non
sostituibilità con strumenti di fonte legale che perseguano scopi
deflattivi o dissuasivi del contenzioso e che siano impostati su
giustificazioni meramente economicistiche dell’esercizio dei poteri
datoriali.
Altrettanto valide sono le ragioni che rendono necessario, al
contempo, volgere l’attenzione anche all’esigenza (17) di contrastare, nei limiti delle possibilità offerte dall’ordinamento, quei
fenomeni di “opportunismo metodologico” che molte volte ed è un
dato di esperienza difficilmente confutabile, si manifestano proprio
sotto la veste di una lettura e di un’applicazione poco sorvegliate
delle clausole generali.
Tenendo conto di questa esigenza, l’impegno che ci si propone
di assolvere è quello di verificare in che modo la reciproca integrazione di fonti che connota il diritto del lavoro e che si realizza nel
connubio tra precetto legale e regola di fonte collettiva può condizionare, per il tramite dei passaggi ermeneutici metodologicamente connessi alle clausole generali, il “riempimento” di senso e
significato degli enunciati normativi che vengono fatti confluire,
nel discorso scientifico nonché — a volte — anche nel lessico
legislativo, nella macro-categoria delle clausole generali.
1.2. Sulla nozione di clausola generale (rinvio al successivo n.
2).
La seconda premessa prende le mosse dalla constatazione per
cui questa parziale emarginazione dell’autonomia collettiva dallo
scenario ricostruttivo delle clausole generali trova una parte di
spiegazione anche nella scelta di un orizzonte teorico di riferimento
delimitato dai confini di un’accezione alquanto ristretta della
locuzione “clausole generali” come quella che viene adottata nella
(16) Santoro-Passarelli, G., 2013a, 515 ss.; Perulli, 2014, 286; Ferraro, 2011a, 8 ss.;
Magnani, 2013, 780.
(17) D’Antona, 1990, ora 2000, 60, affermazione ripresa da Persiani, 2000, 29.
70
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
maggior parte degli studi in materia, sebbene questa scelta, come
si vedrà, non rappresenti l’unica opzione teorica praticabile.
Del resto, anche entro i più circoscritti confini della legislazione
lavoristica, il ventaglio delle disposizioni normative rientranti in
quest’area viene considerato da molti interpreti, da buona parte
della giurisprudenza nonché, ora, dal legislatore (art. 30 della legge
4 novembre 2010, n. 183) come un territorio più vasto rispetto al
ridotto perimetro degli obblighi di correttezza e buona fede (18).
Di qui la scelta (le cui motivazioni saranno illustrate più
dettagliatamente nel paragrafo successivo) dell’adozione, in questa
sede, di un campo di osservazione più esteso, composto in prevalenza da previsioni legislative che vengono nella maggior parte dei
casi definite non come clausole generali, bensì come norme di tipo
“aperto” o “elastico”. Previsioni legislative che appaiono tra loro
accomunate dal fatto di prestarsi connaturalmente ad essere riempite di contenuto (principalmente) dalla contrattazione collettiva,
efficacemente definita come “il principale se non esclusivo canale di
mediazione tra l’astratto precetto legale e la concretezza dei rapporti di
produzione” (19).
Da questo punto di vista la ricognizione non potrà, comunque,
non risultare in una certa misura limitata, in ragione della potenziale vastità di questo ipotetico aggregato normativo. Il criterio
selettivo e di orientamento che sarà seguito, oltre all’inevitabile
componente soggettiva insita nella valutazione di importanza dei
diversi referenti normativi, trova nell’intitolazione la sua sostanza
e la sua giustificazione: ciò in quanto l’attenzione sarà concentrata
sulle fattispecie normative che, oltre a possedere le caratteristiche
normalmente ascritte alle “clausole generali” in senso ampio, presentano al contempo maggiori elementi di interconnessione con le
manifestazioni dell’autonomia collettiva.
(18) Per esempi dell’attribuzione di un significato maggiormente ampio all’espressione “clausola generale” possono essere esemplificativamente citati, sin da ora, Napoli,
1980, 105 (a proposito della giusta causa di licenziamento; più recentemente, Carinci, M.T.,
2011, 796 ss. contro questa qualificazione, Nogler, 2007, 621; e si veda, comunque, in senso
diverso, ancora, Napoli, 1993, 91); Brollo, Vendramin, 2012, 546 (con riferimento al concetto
di equivalenza delle mansioni; e in precedenza, nello stesso senso, Liebman, 1993, 207);
Vallebona, 2001, 62 (sulla generale condizione di legittimità del contratto a tempo determinato come definita dall’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, nella sua originaria
formulazione).
(19) De Luca Tamajo, 1976, 141.
71
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
1.3. Sul rapporto tra clausole generali (anche in veste di “norme
elastiche”) e funzioni del contratto collettivo.
Come terza premessa, l’angolo visuale qui prescelto induce a
confrontarsi con alcuni profili di ordine più generale in merito alla
funzione regolativa del contratto collettivo (20) e al suo rapporto
con alcune particolari tipologie di norme inderogabili ossia, come
già detto, quelle che si caratterizzano rispetto ad altre sottocategorie di precetti legislativi, per una connotazione che riceve, nei
differenti studi civilistici e di teoria generale, le variabili e per lo
più fungibili denominazioni di elasticità, apertura, indeterminatezza, vaghezza.
Si può dire che l’analisi di questa forma di applicazione o
attuazione delle norme generali attraverso l’intervento integrativo
dell’autonomia collettiva, almeno in una visione di insieme, rappresenti tuttora una prospettiva che non viene frequentemente
visitata (21).
Questo accade anche perché in generale si rimane prevalentemente ancorati, a partire dalla manualistica, ad una concezione
sotto certi aspetti monolitica della funzione normativa del contratto collettivo come atto negoziale preordinato in generale alla
regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro.
Adottando questa prospettiva, tuttavia, si omette di distinguere tra i contenuti del contratto collettivo che sono frutto
esclusivo dell’incontro di volontà delle parti e le diverse statuizioni
a monte delle quali si colloca un fondamento legale, spesso rinvenibile proprio in una clausola generale.
Non manca certamente, tuttavia, seppur raramente esplicitata, la consapevolezza dell’esistenza di diversi piani di rilevanza
giuridica del contratto collettivo, a seconda che esso si sostanzi
esclusivamente in un atto di autonomia privata collettiva ed
investa materie non riconducibili a diritti attribuiti al prestatore di
lavoro da specifiche disposizioni normative, ovvero che concorra
(20) Il termine viene utilizzato in un’accezione prossima a quella proposta da Nogler,
1997, spec. 137 ss.
(21) Spicca per densità, tra i pochi approfondimenti del tema, quello di De Luca
Tamajo, 1976, 108 ss.
72
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
all’attribuzione di diritti soggettivi riconosciuti da norme inderogabili di legge (22).
Le clausole del contratto destinate ad incidere sul rapporto
individuale di lavoro (e prescindendo tanto dalle clausole riconducibili alla parte obbligatoria quanto da quelle attuative di specifici
rinvii legali di carattere integrativo o derogatorio) da questo punto
di vista, potrebbero essere suddivise in tre raggruppamenti, a
seconda:
— che, in mancanza di un fondamento normativo puntuale e,
quindi, di uno specifico obbligo legale, rappresentino il solo ed
esclusivo frutto dell’incontro di volontà delle parti e che, dunque,
rappresentino una mera esplicazione dell’autonomia negoziale collettiva garantita dall’art. 39 Cost. (gli esempi potrebbero essere i
più svariati; si pensi a tutti i trattamenti connessi all’anzianità di
servizio, e in generale, almeno secondo la giurisprudenza prevalente, a tutti i trattamenti retributivi accessori che non rientrano
nel trattamento minimo “coperto” dalla garanzia costituzionale
dell’art. 36, primo comma, Cost. (23); ovvero, in ogni caso, a tutti
i trattamenti che trovano la loro esclusiva fonte regolativa nel
contratto collettivo);
— che, nell’ambito della generale funzione di determinazione dei
trattamenti minimi legalmente riconosciuti, provvedano ad operare
una individuazione puntuale, per lo più di carattere meramente
quantitativo dei contenuti di un diritto garantito da norme inderogabili di legge (come accade, ad esempio, per le ferie ovvero per il
periodo di comporto; non rientrano in questo raggruppamento le
clausole relative al trattamento retributivo, la cui articolata composizione, come è noto, rinvia a referenti normativi molteplici e
distinti);
— ovvero, che intervenendo a valle e in attuazione di un disposto
normativo di carattere “generale” ossia “elastico”, assolvano la funzione di concretizzazione dello stesso, realizzando le direttive ricavabili dalla formulazione legale al fine di adattare il precetto al
contesto sociale in cui lo stesso deve trovare applicazione.
(22) In questa prospettiva, in particolare, Vardaro, 1985, 412 s.
(23) da ultimo, si vedano Cass. 17 aprile 2004, n. 7353; Cass. 13 maggio 2002, n. 6878;
Cass. 12 dicembre 1998, n. 12528; Cass. 6 aprile 1998, n. 3532; in dottrina, recentemente,
Ichino, 2010, 740.
73
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
L’attenzione verrà focalizzata sugli istituti collocabili all’interno di quest’ultimo raggruppamento, concentrandosi, pertanto
la visuale su quelle che sono state definite (24) come qualificazioni
derivate di tipo mediato, nelle quali la legge enuncia una fattispecie
congenitamente bisognosa di integrazioni o comunque aperta,
anche in via alternativa rispetto alla regolamentazione legale, a
questo tipo di interventi finalizzati ad integrare o specificare una
previsione legislativa di carattere generale, anche in assenza di un
rinvio espresso alla contrattazione collettiva.
In ambedue le ipotesi b) e c) sopra elencate, l’efficacia del
contratto collettivo si combina con quella della norma legale, con
la differenza che, nel primo caso, prevale l’aspetto della mera
commisurazione, ossia della determinazione, si è detto, di tipo
quantitativo dei trattamenti che la norma legale definisce come
dovuti, a fronte di un rinvio espresso o tacito, senza che per
ricostruire il significato della norma sia necessario ricorrere a
sistemi valoriali diversi da quelli espressi dall’ordinamento positivo.
Invece nell’ultimo caso, quello sub c), l’operazione di adattamento della fattispecie assume una connotazione del tutto differente perché si sostanzia nell’elaborazione e nel conferimento di un
significato puntuale ad espressioni legislative che necessitano, per
poter acquisire una compiutezza di significato, di essere sempre
“filtrate” attraverso la lente della realtà sociale, nella veste degli
schemi comportamentali (autorevole dottrina — A. Falzea (25) —
parla di “regole etiche”, con un’espressione estensibile anche all’ethos dei rapporti economici), schemi che assumono la denominazione di standards valutativi.
In altri termini, l’autonomia collettiva concorre alla determinazione del significato di norme che, da sole (ma si è consapevoli
che questa lettura non riscuote un consenso unanime), non potrebbero mai prestarsi a costituire la premessa maggiore di un sillogi(24) Si intende qui riprendere la classificazione operata all’interno di uno studio in
cui è stata proposta una raffigurazione assai dettagliata delle diverse sfaccettature del
generale fenomeno dell’efficacia normativa dei contratti collettivi, con particolare riferimento alla funzione di qualificazione della fattispecie: Pedrazzoli, 1990, 562. Sul possibile
modello di interazione permanente e di continuità dinamica tra legge e contratto collettivo
cfr. anche Ferraro, 1981, 294.
(25) Falzea, 1987, 3 ss.
74
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
smo applicativo, perché necessitano sempre di una “traduzione” a
cui si perviene attraverso l’utilizzo di criteri di valutazione esterni
rispetto a quelli legali da ricercare, secondo la terminologia più
frequentemente utilizzata dai civilisti, nella “realtà sociale”.
Si sottoporranno ad analisi, dunque, le varie forme nelle quali
si manifesta questo particolare risvolto del rapporto tra legge e
contrattazione collettiva ovvero, come si vedrà, prende corpo una
particolare ed implicita figura di rinvio legale, spesso implicito, al
contratto collettivo, della quale sono emerse solo parzialmente o
per lo meno raramente sono state contestualmente passate in
rassegna le diverse implicazioni di sistema.
L’utilità di un avvio di riflessione organica su questa particolare forma di intervento dell’autonomia collettiva trova, peraltro,
conforto proprio nelle più recenti riletture del tema delle clausole
generali da parte della dottrina civilistica, dove è avvertita come
un elemento di novità la circostanza che, in molti settori dell’ordinamento, la realizzazione delle finalità affidate alle clausole
generali non è più rimessa in via esclusiva alla mediazione del
giudice, ma viene realizzata ricorrendo a diversi strumenti e a più
varie tecniche legislative (26).
Eppure, queste forme di “concretizzazione” alternativa e, in
particolare, mediante la mediazione dell’autonomia collettiva costituiscono una realtà talmente consolidata nel diritto del lavoro
da aver meritato anche, nel periodo più recente, alcune importanti
puntualizzazioni a livello legislativo.
La molteplicità e il grado di eterogeneità di queste fattispecie
sono tali da meritare un’indagine che, una volta chiarite le giustificazioni teoriche della delimitazione del campo di indagine, si
orienterà verso un’analisi di tipo funzionalistico, ossia improntata
prevalentemente alla ricognizione delle diverse modalità e rationes
con le quali opera il connubio tra la previsione legislativa e la sua
concretizzazione ad opera del contratto collettivo, nel tentativo di
ricavare, da questa visione di insieme, alcune indicazioni in merito
a queste particolari forme di integrazione tra fonti operanti nell’area dell’ordinamento statuale e fonti operanti in quella dell’ordinamento sindacale.
(26)
Rodotà, 2009, 107.
75
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
2. La nozione di riferimento: asserita dicotomia tra “clausole generali” e “norme elastiche” e spunti per un suo possibile superamento.
I temi o motivi principali del dibattito civilistico sui quali si
ritiene utile soffermarsi sono tre e riguardano i sottotemi della
nozione o le nozioni di riferimento; del concetto di standard valutativo; della distinzione tra clausole o norme generali e principi.
Il primo sottotema evoca l’interrogativo, da tempo discusso e
oggi tornato di attualità in ragione dei recenti sviluppi legislativi,
del significato attribuibile all’espressione “clausola generale” e della
delimitazione contenutistica di questa categoria della scienza giuridica.
Si sta parlando — è opportuno rammentarlo perché nella
teoria delle clausole generali il discorso ricostruttivo e quello prescrittivo tendono a sovrapporsi —, non di una categoria del diritto
positivo e come tale definita dallo stesso legislatore, ma di una
categoria che è frutto di una formulazione teorica che l’interprete
potrebbe anche riscrivere ex novo, con il solo onere di chiarire i
termini della convenzione stipulativa che induce a formulare tale
nuova proposta di categorizzazione (27).
Non sembra necessario, tuttavia, cimentarsi in alcun nuovo
tentativo definitorio, apparendo sufficiente spiegare le ragioni per
le quali, nell’ottica del presente lavoro, la categoria “clausola
generale” possa essere intesa come comprensiva anche di alcune
fattispecie come quelle che vengono abitualmente ascritte al sottogruppo delle c.d. norme elastiche e che secondo alcune impostazioni teoriche dovrebbero rimanerne escluse.
È stato riconosciuto come in prima stagione di studi, trascorsa
tra gli anni sessanta e settanta, quello di clausola generale era stato
considerato un concetto di cui non si avvertiva la necessità teorica
di spiegare più minuziosamente il significato, venendo assunto
come una nozione giuridica non bisognosa di più puntuali chiari(27) Conforme, nella letteratura recente, l’opinione di Guarneri, 1999, 133, il quale
osserva come “le opposizioni concetti indeterminati/determinati, concetti normativi/descrittivi,
concetti discrezionali/concetti a valutazione oggettivamente vincolata, regole casistiche/clausole
generali sono soltanto relative, ben potendo una fattispecie essere classificata ora in un modo ora,
invece, in modo opposto, in relazione al tipo di parametro preso a riferimento”.
76
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
menti (28).Viceversa, la ripresa del dibattito sulle clausole generali
negli anni ottanta è coincisa con il proliferare di una serie di
tentativi tassonomici così fitta da indurre una dottrina a constatare come la varietà tassonomica delle clausole generali possa
apparire ormai per alcuni tratti assolutamente labirintica (29).
Ai fini che qui interessano e nell’impossibilità di confrontarsi
con una serie molto ampia di classificazioni, distinzioni e sottodistinzioni via via proposte nel corso degli anni (30), appare sufficiente dare risalto a quella che riveste maggiore importanza ai fini
che qui interessano. Si allude alla linea di demarcazione che separa
le clausole generali, per così dire in senso stretto o tradizionale (tra
le quali si richiamano, ad esempio, quelle di buona fede, correttezza, buon costume) che, seguendo l’insegnamento di Mengoni,
sarebbero definibili come “frammenti di norme” che “non hanno
una propria autonoma fattispecie, essendo destinate a concretizzarsi
nell’ambito dei programmi normativi di altre disposizioni (31)”, e
quelle che, con terminologia varia, sono state denominate come
norme “elastiche” (32), “generali” (33), “aperte” (34), “concetti
giuridici indeterminati” (35), ovvero “norme di condotta a fattispecie indeterminata” (36).
In questa ricostruzione, tuttora ampiamente accettata e seguita (37) nei nostri studi settoriali (38), le norme o precetti
generali (il cui più importante e citato esempio sarebbe offerto
dalle disposizioni in materia di giusta causa e giustificato motivo
soggettivo di licenziamento) per le quali viene prevalentemente
utilizzata la definizione di norme elastiche, rappresenterebbero un
(28) Castronovo, 1986, 21.
(29) Libertini, 2011, 345 ss.
(30) Sul rischio latente che tale impegno classificatorio rischi di risolversi in una mera
questione nominalistica, tra gli altri, Guarneri, 1999, 134.
(31) Mengoni, 1986, 13.
(32) Di Majo, 1984, 539.
(33) Mengoni, 1986, 9.
(34) Taruffo, 1989a, 312.
(35) Rodotà, 1987, 726.
(36) Libertini, 2011, 363.
(37) Si veda, ad es., Gazzoni, 2006, 49. Per una rivisitazione del pensiero di Mengoni
in materia di clausole generali si veda Nivarra, 2007, spec. 165 ss.
(38) In particolare, si vedano Carinci, M.T., 2011, 789 ss.; Nogler, 2011, 928; Perulli,
2014, 281; nello stesso senso, a quanto sembra, Speziale, 2001, 374.
77
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
aliud rispetto alle clausole generali in senso proprio. Le norme
generali o “elastiche” (39), sarebbero, a differenza delle clausole
generali, norme già “complete”, composte di una fattispecie e di un
comando, con la sola particolarità che la prima sarebbe formulata
non in maniera puntuale ma mediante una categoria riassuntiva,
“per la cui concretizzazione il giudice è rinviato volta a volta a modelli
di comportamento e a stregue di valutazione obiettivamente vigenti
nell’ambiente sociale in cui opera (40)”.
In questa prospettiva, solo in sede di applicazione delle clausole generali stricto sensu ricorrerebbe l’esigenza di pervenire ad un
significato “sintetizzato” (ad opera del giudice) mediante il confronto con altri sub sistemi sociali, i cosiddetti standard valutativi.
Viceversa, nel caso delle norme aperte o elastiche, detto significato sarebbe frutto di una “selezione” rispetto ad una serie di
significati già “dati”, ossia immanenti, preesistenti e richiamati
dalla legge con un’espressione di tipo sintetico o riepilogativo. Di
guisa che i concetti indeterminati accolti nelle norme elastiche
sarebbero tali solo linguisticamente, mentre le clausole generali lo
sarebbero sul piano del valore (41).
Molti studi, nel recente passato, hanno accettato il postulato
della radicale eterogeneità tra questi due fenomeni normativi e
dunque l’idea che quelle tradizionalmente definite quali norme
generali o elastiche non possano ascritte alla categoria delle clausole generali. Questa opzione teorica viene motivata anche evidenziando che la sopravvalutazione dell’elemento dell’indeterminatezza quale connotato caratterizzante delle clausole generali recherebbe in sé il rischio di condurre ad “identificare queste ultime con
ogni concetto indeterminato o elastico cosicché la categoria in esame,
dilatata a dismisura, verrebbe a perdere ogni autonoma rilevanza
giuridica per tramutarsi in una mera formula linguistica e descrittiva” (42).
Con l’accentuazione dell’inidoneità dell’elemento della “vaghezza” delle norme a fungere da tratto unificante della categoria
(39) La scelta lessicale è condivisa da Rescigno, 1998, 3 e da Roselli, 1983, 153 s.
(40) Mengoni, 1986, 9.
(41) Castronovo, 1986, 24.
(42) Tullini, 1990, spec. 19 ss. nella stessa prospettiva, successivamente, Saffioti,
1999, spec. 6 ss.; sulla indeterminatezza quale caratteristica di tutte le norme giuridiche,
sebbene presente in grado diverso, classicamente, Hart, 2002, 146 ss.
78
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
si replica indirettamente a quelle critiche che, viceversa, erano
state sollevate già negli anni ottanta nei confronti della distinzione
tra clausole generali e norme elastiche da parte di chi evidenziava
come tale suddivisione rischiasse di apparire come una mera questione nominalistica (43).
Questa critica espressa, tra i primi, da Rodotà veniva ad
inserirsi in quel filone di pensiero (44), secondo i cui esponenti il
tratto comune e quantitativamente (non qualitativamente) più accentuato tanto delle disposizioni tradizionalmente qualificate
come clausole generali in senso stretto, quanto di quelle rientranti
nella categoria delle norme elastiche/aperte/a contenuto indeterminato, sarebbe rappresentato dall’elemento dell’indeterminatezza
che pure, in misura maggiore o minore caratterizza ogni enunciato
normativo. Questo a significare che, per rifarsi ad un esempio
frequentemente utilizzato, quella intercorrente tra le clausole generali di buona fede e correttezza e la “giusta causa” di recesso,
potrebbe essere letta come una mera differenza di grado (maggiore
o minore indeterminatezza) e non di natura del precetto.
Posto che l’interpretazione si concretizza sempre nella scelta
tra più significati normativi, è stato sottolineato come “ciò che
varia da caso a caso non è la necessità della scelta, ma la gamma di
alternative entro la quale essa va compiuta: essa è più limitata per
enunciati tecnicamente formulati in modo dettagliato e preciso ed è
progressivamente più ampia se si tratta di enunciati generali e
ambigui, se essi contengono ‘concetti valvola’ o clausole generali o se si
tratta di affermazioni di principio come nel caso di norme costituzionali” (45).
Secondo questa corrente critica, i tratti dell’indeterminatezza e
dell’apertura non rappresenterebbero, pertanto, i requisiti esclusivi
di quelle che in altri scenari dottrinali assumono la denominazione
di “clausole” generali “in senso tecnico” o stretto (ad es. correttezza e buona fede), ma ricorrerebbero in ogni previsione normativa caratterizzata da una struttura semantica aperta, le quali
tutte presenterebbero una identica sequenza di ragionamento diversa dal classico schema sussuntivo.
(43)
(44)
(45)
Rodotà, 1987, 725.
Cfr. D’Amico, 1989, 426 ss.; Belvedere, 1989, spec. 633 ss.
Taruffo, 1989b, 5.
79
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Tale differenza si basa sul fatto che per la ricostruzione del
significato della norma è sempre necessario rifarsi ad un elemento
esterno rispetto al dato testuale, vale a dire il c.d. standard valutativo. La fattispecie concreta, anziché essere esaminata sulla base
dei significati espressi dalla norma, viene valutata sulla base degli
standards che il giudice individua come più consoni al significato
della norma e diviene oggetto di decisione sulla base di questa
valutazione. Tale procedimento viene adottato, in realtà per l’applicazione sia delle clausole generali tradizionalmente intese sia
delle norme elastiche, riconoscendosi che “concetti indeterminati e
clausole generali, forse distinguibili ex latere legislatoris, perdono la
loro diversità nel momento dell’applicazione” (46).
In altri termini, secondo questa lettura, anche la formulazione
della fattispecie “in termini riassuntivi” ossia secondo il modello
della c.d. norma generale descritto da Mengoni, non esime l’interprete dal compito di operare una concretizzazione della fattispecie
stessa che si risolve nella valutazione della rispondenza del fatto
alla misura di comportamento indicata dal legislatore e desumibile
da quei parametri extralegali (ossia dagli standards) valevoli per la
categoria sociale alla quale la norma stessa si riferisce (47).
Il che equivale, in buona sostanza, a riconoscere che anche le
norme generali o elastiche, in realtà, necessitano di quella specificazione del significato mediante quel ricorso a standard che viene
normalmente denominata, in dottrina, con l’espressione “integrazione valutativa”; ciò che ha indotto una dottrina tra le più
sensibili alle problematiche dell’applicazione giurisprudenziale di
tali precetti normativi, a riconoscere come i concetti di clausola
generale e di norma elastica siano sostanzialmente equipollenti (48), ovvero ha portato altri ad ammettere la difficoltà di
individuare criteri distintivi realmente attendibili con riguardo alle
modalità di concretizzazione di queste due sottospecie di enunciati
normativi (49).
(46) Castronovo, 1986, 24; l’osservazione è condivisa da Zoli, 1988, 228.
(47) Castronovo, 1979, in particolare 102 ss., dove è richiamata adesivamente, tra le
altre, la definizione di Class, 1961, che identifica i “lineamenti” della clausola generale nel
rinvio a determinazioni extragiuridiche e nell’indeterminatezza del suo contenuto.
(48) Roselli, 1983, 7 ss.; per la identificazione tra concetti ampi ed elastici e clausole
generali cfr. anche Roppo, 2010, 13.
(49) Nivarra, 2002, 374 s.
80
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Questi rilievi critici inducono a revocare in dubbio la nitidezza
della distinzione dogmatica tra clausole generali e norme elastiche
sebbene, d’altro canto, sia condivisibile il rilievo per cui la qualificazione di una norma come clausola generale non può farsi
dipendere esclusivamente dal suo grado di vaghezza.
Venendo su un terreno a noi più prossimo, i dubbi che giustificano tali tentativi di superamento della distinzione trovano ulteriori spunti di conferma, proprio con riferimento al rapporto di
lavoro, nell’apparente o a volte esplicitamente dichiarata circolarità di quelle ricostruzioni che, partendo dall’accettazione assiomatica di tale distinzione, finiscono però paradossalmente per offuscarla laddove prefigurano l’assoggettabilità a controllo degli atti
di esercizio dei poteri imprenditoriali il cui esercizio è regolato da
norme elastiche (ad es. in tema di esercizio del potere disciplinare)
indicando come referenti normativi di tale controllo gli stessi
principi di buona fede e correttezza (50).
In effetti, affermando che anche le norme generali o elastiche
divengono suscettibili di valutazione alla luce delle clausole generali si perviene implicitamente, o almeno così pare, a rimettere in
discussione proprio ciò che in partenza si vorrebbe rimarcare,
ovvero la separatezza e l’intrinseca diversità tra i due gruppi di
norme.
In chiave attuale, la questione relativa alla possibile dicotomia
tra clausole generali e norme elastiche è tornata in evidenza con
riferimento all’interpretazione dell’art. 30, primo comma, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di controllo giudiziale
sull’applicazione delle clausole generali nei rapporti di lavoro subordinato e nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: alcuni hanno letto il richiamo alle clausole generali come una
mera imprecisione terminologica (51), altri hanno tratto argomento dall’asserita improprietà linguistica per esprimere l’idea che
la norma sia praticamente inapplicabile proprio perché non include
nel richiamo normativo le norme elastiche (52).
Secondo una recente e più articolata lettura dedicata al significato di questa norma, invece, se da una parte il richiamo legislativo può essere letto come effettivamente riferito alle norme ela(50)
(51)
(52)
Di Majo, 1983, 350.
Carinci, M.T., 2011, 790; Ferraro, 2011a, 6; Pellacani, 2010, 230.
Nogler, 2011, 929.
81
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
stiche, l’applicazione di tale norma influirebbe indirettamente
anche sull’applicazione delle clausole generali, per così dire stricto
sensu.
Questo perché è stato sostenuto che, secondo una logica di
necessaria e imprescindibile circolarità, all’applicazione delle
norme elastiche si abbinerebbe sempre una contestuale valutazione della fattispecie concreta alla luce delle clausole generali di
correttezza e buona fede (53), “in quanto le prime forniscono
precipitato di criteri e parametri derivanti dall’ambiente sociale e dei
suoi valori, anche integrativi rispetto al dettato contrattuale e legale,
alla luce del quale valutare il comportamento delle parti; le seconde,
che pure abbisognano di un intervento anche integrativo del giudice,
recepiscono e modellano quei criteri e parametri nella fattispecie
considerata dalla norma elastica” (54).
Da una parte, una simile ricostruzione alimenta l’idea di una
stretta compenetrazione, se non quasi di commistione, tra le norme
elastiche e le clausole generali degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Per altro verso, occorre prendere atto che si perviene in tal
modo ad avallare l’idea di un’applicazione delle clausole generali
che richiede una serie di passaggi estremamente tortuosa e complessa: prendendo le mosse dalla norma elastica, l’interprete sarebbe chiamato in ogni caso ad operarne una lettura alla luce dello
standard valutativo tratto dal contesto sociale. Gli esiti di questa
lettura, però, in seconda battuta, richiederebbero di essere ulteriormente “filtrati” e “reinterpretati” dal giudice mediante l’applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza.
Ci si deve chiedere se tale ricostruzione risponda effettivamente alla logica funzionale delle clausole generali, riassunta nelle
tradizionali metafore delle “finestre affacciate sulla realtà” ovverosia di “organi respiratori” (55) del diritto oppure se, per sfruttare
ulteriormente la metafora, non sia una visione che finisca per
esaltare oltremisura le pretese virtù purificatrici del “filtro” giudiziale, prestando per altro verso il fianco a possibili alterazioni di
(53) Simile, quindi, a quella già prefigurata da Di Majo, 1983, 349 s.
(54) Perulli, 2014, 283. Non rientrano tra i temi affrontati in questa sede le implicazioni, anche di legittimità costituzionale, che vengono tratte in questa ricostruzione dalla
teorizzata incidenza della norma del “collegato lavoro” sull’applicazione delle clausole
generali.
(55) Polacco, 1908, ora 1928, 61.
82
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
significato degli elementi di realtà sociale che, attraverso il sistema
di osmosi garantito dalle clausole generali, dovrebbero coadiuvare
la concretizzazione del precetto legislativo.
Se la generale finalità cui questi precetti legislativi rispondono
è quella di consentire l’integrazione tra il dato normativo e quelli
offerti dai sub-sistemi di regole sociali esterni al sistema delle fonti
in senso formale, permettere al giudice di rielaborare i secondi in
nome di un’astratta coerenza con i primi rischia, in altre parole, di
vanificare il senso dell’apertura. Ciò che Di Majo e successivamente
Persiani hanno colto con grande acutezza quando hanno sottolineato come non possa pervenirsi a spiegare il contenuto di una
clausola generale con un’altra clausola generale (56).
In buona sostanza, questo è proprio quello che accadrebbe se,
seguendo l’impostazione alla quale si è fatto riferimento, il significato di ogni norma elastica dovesse essere sempre messo a fuoco
attraverso la lente degli obblighi di buona fede e correttezza
ovvero, ed è questo il rischio implicito in tale lettura, attraverso le
non sempre prevedibili declinazioni giurisprudenziali del contenuto di tali obblighi.
Per questa ragione l’impostazione che esalta la pretesa “propensione espansiva” degli obblighi di correttezza e buona fede,
ossia la loro influenza sull’applicazione delle c.d. norme elastiche
non sembra apportare argomenti decisivi né ai fini di né di chiarire
le differenze di contenuto e di struttura tra queste ultime e le
norme elastiche, né al contempo appare come un utile via di
approccio per l’individuazione di elementi comuni alle une e alle
altre.
3. Le clausole generali come norme di rinvio.
Sono state esposte le ragioni che inducono a nutrire riserve
sulla onnivalente utilità teorica della distinzione tra clausole generali e norme elastiche così come è stata data per acquisita per quasi
un trentennio nell’ambito della nostra materia. Procedendo alla
ricerca di un criterio di aggregazione alternativo si parte, come già
detto, dalla constatazione per cui l’idea che il tratto unificante
delle varie sottospecie normative potenzialmente rientranti nella
(56)
Di Majo, 1989, 2758; Persiani, 1995a, 138.
83
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
categoria delle clausole generali in senso ampio possa essere rappresentato solo dall’elemento della loro vaghezza o indeterminatezza, non appare da sola persuasiva.
Da un lato, infatti, occorre tener conto della già riferita osservazione secondo cui tutti gli enunciati normativi presentano un
certo grado, a volte minimo in altri casi più pronunciato, di
vaghezza o possibile incertezza di significato, così che da sola questa
caratteristica non sembra poter consentire di isolare una categoria
normativa autonoma.
D’altra parte si deve riconoscere che, quanto più si riconosce
rilevanza, nel delineare la fisionomia delle norme rientranti nella
definizione di clausola generale, all’elemento della vaghezza o
indeterminatezza della norma, tanto più risulta elevato, nella
ricostruzione del suo significato, il “peso” della concretizzazione di
matrice puramente giudiziale. Così che quanto più la norma venisse intesa come vaga o a fattispecie indeterminata, tanto più la
sua attitudine a regolare comportamenti sociali attraverso criteri
di valutazione sufficientemente prevedibili a priori risulterebbe
messa in discussione.
Vi è, per converso, sufficiente concordia sul fatto che la conoscibilità e prevedibilità dei criteri valutativi sono le condizioni che
più di ogni altra garantiscono l’assolvimento da parte delle clausole
generali di quella funzione di adeguamento dell’ordinamento alla
tipicità sociale che attraverso esse il legislatore intende perseguire (57).
In una prospettiva diversa e maggiormente persuasiva si
orienta un diverso approccio dottrinale, per alcuni versi di lontana
(57) Tra gli altri, Mengoni, 1986, 15; Rodotà, 1987, 726; Di Majo, 1985, 304. In tema
di prevedibilità dei comportamenti dovuti giova il classico riferimento a Neumann, 1983,
398, per l’affermazione secondo la quale la visione del contratto di lavoro come contratto
obbligatorio implica che le prestazioni siano esattamente determinate e calcolabili “per cui
né le autorità giudiziarie né quelle amministrative possono imporre ulteriori obblighi o sopprimere diritti esistenti” (sulla valenza “straordinariamente progressista” di tale impostazione
cfr. Gaeta, 2003, 191 e, più recentemente, Viscomi, 2012, 446). Calcolabilità che dovrebbe
essere garantita dalla “massima precisione” nella delimitazione per via legislativa o negoziale delle rispettive sfere obbligatorie. Osserva Viscomi, 1997, 138 commentando Neumann,
che proprio nelle riflessioni sulle clausole generali si registrerebbe un grave deficit di
precisione e dunque potenziale un punto di instabilità dell’assetto obbligatorio; proprio ciò
che induce a verificare in questa sede la possibilità di qualche margine di progresso in questa
direzione.
84
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ascendenza ma reinterpretato in chiave moderna; approccio che
prende le mosse dalla già ricordata constatazione per cui non
sembra configurabile un nesso necessario tra la caratteristica della
generalità o indeterminatezza della norma ed il concetto di clausola
generale, cosicché il tratto saliente delle clausole generali deve
essere ricercato altrove.
Secondo questa impostazione, il connotato caratterizzante
delle norme o frammenti di norma rientranti nella definizione di
“clausola generale” va individuato nella loro essenza di enunciati
normativi che sia pure in maniera implicita e potenzialmente
pluralistica (ossia lasciando all’interprete l’opzione tra la scelta
dello standard più adeguato), funzionano come vere e proprie
norme di rinvio a parametri o standards definiti come extralegali,
ossia a criteri di valutazione, sistemi valoriali o regole etiche (la
terminologia usata in dottrina è varia) che vengono elaborati al di
fuori dell’ambito del sistema delle fonti formali (58).
In questi termini, appare maggiormente evidente come le
clausole generali non vadano intese come fondamento di un potere
“creativo” originario del giudice (59), quanto piuttosto come fondamenti di un suo dovere “ricettivo” degli elementi di realtà sociale (60). Si sottolinea, per enfatizzare il senso del “rinvio”, che la
c.d. concretizzazione in sede giudiziale della clausole generali non
implica mai il conferimento al giudice del potere di produrre una
norma totalmente nuova.
Queste premesse hanno offerto lo spunto alla dottrina richiamata da ultimo per elaborare uno sviluppo ricostruttivo ulteriore.
Questo perché, in luogo della concezione che le qualifica come la
(58) Per una recente riaffermazione dell’idea secondo cui “la funzione della clausola
generale è quella di arricchire l’ordinamento giuridico attraverso la possibilità concessa al
giudice che applica la clausola di utilizzare parametri provenienti da sistemi di regole e valori
non giuridici” si veda Patti, 2013, 55.
(59) Luzzati, C., 2013, spec. 178 ss. Come ricordato recentemente da Pedrini, 2009,
l’idea delle clausole generali come norme di rinvio a cognizioni di carattere non giuridico è
ben più risalente, essendo già stata affacciata nella dottrina germanica di fine XIX — inizio
XX secolo (Zitelmann, 1879, 19 e successivamente Heck, 1933, 21).
(60) E si veda, in tal senso, Betti, 1949, 55 s., il quale si diffonde su quei concetti
normativi che richiederebbero un “apprezzamento condotto alla stregua di ‘nozioni elastiche’ e
di ‘concetti di valore’, ossia di criteri desumibili dalla coscienza sociale, di per sé extragiuridici,
ma rilevanti per il trattamento giuridico, ai quali rinviano le norme giuridiche da interpretare
e da applicare”.
85
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
fonte di una sorta di “delega in bianco” al giudice, si osserva che le
clausole generali appaiono, piuttosto, leggibili come una sollecitazione allo stesso giudice affinché proceda alla ricerca dei parametri
sociali di comportamento più adeguati, ossia all’individuazione delle
specifiche regole che governano le reciproche attese in uno specifico
sottogruppo sociale o professionale; regole che, come tali, sono
riconosciute, pur rimanendo al di fuori del perimetro delle fonti in
senso formale, come norme c.d. micro sociali che il giudice deve
porre necessariamente a base della sua decisione.
In questo senso, dunque, risulta calzante la definizione delle
clausole generali (intese in senso ampio, ossia come inclusive anche
del sottogruppo delle c.d. norme elastiche) come delle meta-norme,
ossia come norme che vertono su un’altra norma o su un’altra
attività regolativa, che nel caso delle clausole generali è caratterizzata dal fatto di svolgersi in ambiti diversi da quelli entro i quali
opera la legge in senso formale (61).
Da un lato, si ritiene che questa lettura permetta di porre in
luce e di elevare a elemento caratterizzante della categoria giuridica delle clausole generali (intesa a questo punto in senso ampio,
come comprensiva cioè anche delle c.d. norme elastiche) il tratto
comune e caratteristico (62) dell’appartenenza all’area dei precetti
legali aperti verso l’esterno, nel senso che attraverso essi il fatto,
anziché essere sussunto in una norma di per sé dotata di un
significato desumibile in via esclusiva dall’ordinamento giuridico
positivo o meglio dalla legge in senso formale, viene piuttosto
valutato alla stregua di uno o più parametri extralegali.
Dall’altro, l’enucleazione di questo tratto caratterizzante permette di tracciare una linea di demarcazione tra le clausole generali
così intese e le altre norme a contenuto indeterminato.
Questo perché, se si conviene che quello implicitamente leggibile nella clausola generale è un rinvio a sistemi valoriali e connessi
schemi etici esterni alla legge formale, ossia a criteri di valutazione
dei comportamenti umani espressi dai sub-sistemi sociali, ne consegue che non rientrano in questa categoria giuridica quelle previsioni che, invece e in ragione della loro indeterminatezza rinviano
non a criteri valutativi, bensì ad altre tipologie di “dati” conoscitivi
(61) Sul concetto di meta-norma cfr., in particolare, Guastini, 1998, 122 s.
(62) Negli studi di diritto del lavoro, nello stesso senso, Calcaterra, 2000, 317.
86
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
che rimangono indeterminati nella norma perché necessariamente
ricavabile dall’applicazione di altri saperi (potrebbe farsi l’esempio
della nozione di malattia, la cui concretizzazione non può prescindere dall’accertamento medico; ma questo accertamento certamente non si risolve in un giudizio di conformità rispetto a determinati “valori” sociali) ovvero perché richiama elementi di fatto
destinati a manifestarsi in maniera differente caso per caso (63).
L’idea di clausola generale che meglio si presta all’analisi delle
varie forme di interazione con l’autonomia collettiva coincide,
pertanto, con la descrizione che ne ritrae i tratti caratteristici
qualificandola come una disposizione di legge formulata attraverso
espressioni linguistiche generali; espressioni da intendersi come implicitamente rinvianti ai valori e alle relative regole di condotta che
siano condivisi all’interno dei raggruppamenti sociali nei quali la
disposizione deve trovare applicazione oppure ai valori e alle regole di
condotta promananti da altri ordinamenti (64).
Come si desume dall’ultima parte della citazione, l’utilità di
tale prospettiva teorica è correlata, soprattutto, al fatto che l’accoglimento di questa nozione di clausola generale conduce a valorizzare, sulla scia di precedenti ricostruzioni (65) dedicate al tema
dei rapporti tra legge, contratto collettivo e giurisdizione, quella
specifica connotazione funzionale di numerosi precetti appartenenti a tale categoria che si sostanzia nella loro attitudine ad
operare come canali di comunicazione tra l’ordinamento legale e le
regole di fonte collettiva.
L’opzione di fondo che assegna al collegamento con le scelte
attuative compiute dall’autonomia collettiva una netta preminenza rispetto ad altri possibili percorsi di concretizzazione delle
(63) Ed a questo proposito può essere utile il richiamo al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il cui accertamento non implica la valutazione di comportamenti
secondo schemi valutativi offerti dalla realtà sociale, bensì la mera enucleazione di un
determinato risvolto dell’esercizio della libertà di iniziativa economica (cioè la decisione di
addivenire al mutamento organizzativo che determina la soppressione del posto di lavoro),
unita alla valutazione del riflesso di tale mutamento sulla motivazione del licenziamento:
l’estraneità del giustificato motivo oggettivo rispetto agli standard di comportamento
accettati dalla coscienza sociale è sottolineata da Carinci, M.T., 2005, 104; Ead., 2011, 791.
(64) La definizione è adottata da Grossi, 2012, 32 e ripresa, da ultimo, da Roselli,
2014, 222..
(65) Oltre a De Luca Tamajo, 1976, spec. 140 ss. in particolare si vedano Liebman,
1993, spec. 192 ss., Pedrazzoli, 1990, spec. 575 ss. e Nogler, 1997, spec. 109 ss.
87
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
clausole generali richiede, tuttavia, di essere ulteriormente giustificata. Una volta definita la nozione è, infatti, necessario confrontarsi con i temi connessi alla scelta dei referenti extralegali (cioè
esterni alla legge formale) deputati alla concretizzazione delle
clausole generali, per comprendere se siano desumibili dall’ordinamento alcune generali linee di orientamento che agevolino anche la
definizione di un ordine di priorità valutativa tra i diversi sottosistemi regolativi.
4. Clausole generali e standards valutativi.
Indissolubilmente legato a quello di clausola generale, nel
senso ampio e comprensivo delle c.d. norme elastiche che in questa
sede si ritiene di poter condividere, è quello di standard valutativo,
dal cui esame emergono alcuni elementi che consentono di progredire verso gli specifici profili oggetto della relazione. Fattispecie ad
alto tasso di genericità testuale come quelle delle quali ci si occupa
prendono vita nell’ordinamento, si osserva, grazie a parametri e
schemi comportamentali attraverso i quali diviene possibile individuarne i contenuti più puntuali e compiuti (66).
Il ricorso allo standard è visto in prevalenza come indicazione
di metodo che rinvia ad un’idea di “normalità”, prospettata in
termini tali da accrescere l’accettabilità sociale delle decisioni che
su tale idea si fondano (67) in quanto garantisce una loro sufficiente prevedibilità. In questo senso lo standard può prestarsi a
fungere da antidoto al soggettivismo giudiziale, o meglio al pericolo
che, riprendendo una metafora un po’ aulica ma efficace, il giudice
si trovi a volteggiare senza rete nei cieli dell’etica (68).
Si registra sufficiente convergenza sul fatto, è opportuno precisare, che lo standard non costituisce oggetto di un rinvio di tipo
rigidamente recettizio ad una norma sociale di condotta, ma va
inteso, piuttosto, come una direttiva o linea di riflessione per la
ricerca della regola (69) da applicare al caso concreto (70).
(66) Falzea, 1987, 9.
(67) Rodotà, 1987, 726.
(68) Morelli, 1994, 2173.
(69) Sulla necessaria dimensione regolativa dello standard, il quale “equivale a regola
di comportamento e si esprime in norme”, da ultimo, Perulli, 2011, 407.
88
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Dell’utilizzo giulavoristico degli standards si rinviene una traccia esplicita nella giurisprudenza che è stata impegnata sulle più
evocate e discusse norme elastiche/clausole generali (a seconda
delle diverse letture) in materia di lavoro, quelle in tema di
licenziamento.
Se in ambiti diversi da quello giuslavoristico la Corte di Cassazione ha dato corpo, talvolta, alle preoccupazioni di chi ha
paventato la possibile confusione tra clausole generali e standards (71), nella giurisprudenza in tema di licenziamento per giusta
causa si registra una più nitida percezione della concatenazione
logica tra le prime e i secondi (72), attestata dai non infrequenti
richiami al dovere del giudice di seguire una metodologia decisionale che includa la “conformazione” ad adeguati standard valutativi; richiami normalmente abbinati alla precisazione secondo cui il
primo dato di riferimento per la concretizzazione della norma
elatica/clausola generale mediante il ricorso a standards è rappresentato dalla contrattazione collettiva (73).
L’evocazione dei criteri desumibili dalla disciplina negoziale di
fonte collettiva come riferimenti imprescindibili per l’operatività
concreta della norma elastica viene operata con regolarità, del
resto, nelle motivazioni delle sentenze della Cassazione, unitamente e in correlazione con l’avvertenza secondo cui l’utilizzo
doveroso degli standards rinvenibili nella disciplina negoziale del
rapporto costituirebbe uno degli snodi del percorso valutativo
fisiologicamente destinato a scorrere lungo le coordinate fornite
“dalle fonti normative superiori sino a quelle di rango inferiore,
nonché dalle disposizioni negoziali eventualmente esistenti”, coordinate che dovrebbero impedire al giudice di debordare su “vaghi
criteri morali o politici” adottandoli come principali argomenti
della decisione (74).
Di conseguenza, secondo questa giurisprudenza, l’assunzione
di una decisione di merito non fondata su di un’autentica attività
(70) Mengoni, 1986, 12.
(71) Per un esempio tratto dalla materia del diritto societario, Cass. civ., Sez. I, 12
dicembre 2005, n. 27387.
(72) Come attestato da Fabiani, 1999, 3558.
(73) Cfr. Cass., 25 giugno 2013, n. 15926; Cass., 22 dicembre 2006, n. 27452; Cass. 2
novembre 2005, n. 21213.
(74) Cass., 22 aprile 2000, n. 5299.
89
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
interpretativa del parametro di valutazione offerto dal contratto
collettivo dà luogo ad un’erronea integrazione della norma elastica
e come tale implica una violazione della stessa, suscettibile di
ricorso per cassazione (75).
Il riferimento allo standard che assegna al contratto collettivo
il ruolo di primo ed essenziale parametro per l’integrazione valutativa della norma elastica in materia di giusta causa di recesso
costituisce il passaggio argomentativo certo meno controverso di
un orientamento giurisprudenziale che per altri versi ha suscitato
perplessità in chi ha rimarcato quanto sfuggente possa apparire
quella nozione, proposta come riepilogativa e per così dire sincretica (e come tale oscura, per non dire vagamente oracolare), di
“civiltà del lavoro” (76).
Una nozione, quest’ultima, la cui autonomia concettuale e la
cui attitudine a fungere da adeguato criterio orientativo della
decisione giudiziale, alla luce dell’esperienza giurisprudenziale maturata in più di un decennio, sono state messe in discussione in
ragione della più che dubbia idoneità di questa nozione a rappresentare un’adeguata fonte di regole di decisione sufficientemente
prevedibili e socialmente accettabili per i singoli casi concreti (77).
All’interno di una definizione così vaga come quella di “civiltà
(75) Cass., 18 gennaio 1999, n. 434.
(76) Montuschi, 1999, 735. Il richiamo e le critiche di questo autore sono rivolti a quei
passaggi argomentativi delle note pronunce di Cassazione in materia di sindacato di
legittimità delle decisioni di merito che facciano applicazione di norme definite “elastiche”
e segnatamente dell’art. 2119 c.c. (Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514; Cass. 18 gennaio 1999, n.
434, cit.; Cass. 13 aprile 1999, n. 3645; più recentemente, Cass. 18 agosto 2004, n. 16037)
secondo i quali la Corte di Cassazione può essere chiamata a verificare se il giudice di merito
abbia o meno deciso in conformità “ai principi dell’ordinamento (espressi dalla giurisdizione
di legittimità) e quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale — riassumibili nella
nozione di civiltà del lavoro”.
(77) Osserva, ancora, Montuschi, 1999, ult. loc. cit, che “pur consapevole che occorre
conferire un’oggettiva concretezza alle clausole generali per completare il frammento di norma
con l’ausilio di standards socialticipi, la Corte ha omesso di individuarli in concreto e anzi li ha
sostituiti con il rinvio a regole (la ‘civiltà del lavoro’) che si assumono essere state previamente
codificate nell’esercizio della funzione nomofilattica”. ‘Codificazione’ che, è appena il caso di
puntualizzare, non è intervenuta, neanche a livello di enunciazione giurisprudenziale. Nello
stesso senso Calcaterra, 2000, 338, il quale osserva che in mancanza di una sua traduzione
in una serie di regole concrete, l’elaborazione di questa espressione non determina alcun
progresso, ma si traduce in un mero mutamento di denominazione della clausola generale.
In realtà, si potrebbe ritenere che i problemi si siano accresciuti, in quanto l’adozione di una
nozione così generica come quella di “civiltà del lavoro” può autorizzare ad includere
90
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
del lavoro”, infatti, si aprono spazi per operazioni combinatorie,
per non dire “creative”, spesso marcatamente empiriche, assolutamente non riconducibili ad una ratio unitaria e spesso se non
sempre prive di un reale aggancio con schemi valutativi esterni.
Viceversa, il dato di fonte collettiva, quando viene assunto come
criterio di valutazione rilevante ai fini del giudizio sulla legittimità
del recesso (78), rappresenta per certo un elemento dotato un
solido ed incontestabile collegamento oggettivo con il quadro di
realtà sociale preso a riferimento dal giudicante. È in questo
ambito problematico, come si dirà più avanti (al successivo paragrafo n. 9.1), che si presta ad essere calata la previsione introdotta
dall’art. 30, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Quello ricavabile dalla giurisprudenza in materia di licenziamento rappresenta solo uno, seppur di importanza certamente
nodale, dei momenti di emersione di un ben più vasto e ramificato
intreccio di connessioni tra clausole generali, norme elastiche,
standard e autonomia collettiva. Le interrelazioni tra norme
elastiche/clausole generali e regole di fonte collettiva investono,
infatti, uno spettro di istituti assai ampio, anche dal punto di vista
della varietà delle tecniche legislative. Ciò in considerazione del
fatto che nell’ambito di un aggregato di norme tutte rientranti
nella definizione di clausola generale che si intende, per le ragioni
già illustrate, prendere a riferimento, si riscontrano differenti
modalità di concorso del contratto collettivo alla concretizzazione
del significato del precetto legale, con le quali ci si propone di
confrontarsi.
5. Differenziazioni contenutistiche e funzionali tra clausole generali,
standards valutativi, principi giuridici e norme costituzionali.
Prima che il discorso si avvii, tuttavia, verso le diverse ramificazioni normative di questo collegamento, è utile soffermarsi
all’interno di questa espressione i più svariati criteri di giudizio, ancor più di quanto non
appaia ammissibile con riferimento all’astratta nozione di clausola generale.
(78) Tra le sentenze che attribuiscono rilevanza decisiva alla sussumibilità del fatto
nelle fattispecie contemplate dal contratto collettivo tra i comportamenti che giustificano il
licenziamento ai fini della decisione sulla legittimità del recesso, Cass., 15 luglio 2013, n.
17315; Cass., 15 ottobre 2009, n. 21917; Cass., 29 settembre 2009, n. 20846, Cass., 3 gennaio
2005, n. 17.
91
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
brevemente sulla distinzione, spesso rimarcata in dottrina, tra
clausole generali e principi, siano essi identificabili con i principi
generali dell’ordinamento evocati dall’art. 12 disp. prel. c.c. ovvero, soprattutto, con i principi costituzionali o, ancora quelli
rinvenibili nelle fonti del diritto dell’Unione europea. Di qui l’interrogativo se la concretizzazione della clausola generale e, dunque, il controllo giudiziale sulla sua corretta applicazione possa
risolversi, in tutto o in parte, nell’applicazione di un determinato
principio giuridico, accanto o in alternativa agli elementi extralegali offerti dalla realtà sociale.
Il tema dell’incidenza dei principi sull’applicazione delle clausole generali assume importanza in connessione con la questione
generale della natura degli standards valutativi.
È necessario, infatti, chiarire se il “rinvio” implicitamente
rivolto dal legislatore a sistemi regolativi e criteri da ricercare
aliunde, ossia al di fuori del testo legislativo, debba essere inteso
come riferito solo a parametri e dati extralegali ovvero anche (o
prevalentemente) a principi interni al diritto positivo.
Solo in quest’ultimo caso, infatti, potrebbe ipotizzarsi che il
significato delle clausole generali possa essere ricostruito in tutto o
in parte mediante l’applicazione di determinati principi, in prevalenza riconducibili a norme di rango sovraordinato ovvero ricavabili dal complesso del sistema giuridico.
L’interrogativo assume concretezza, anche se non è l’unico
punto di emersione di questo problema teorico, con riferimento a
quelle decisioni giudiziali, anch’esse per lo più riguardanti la materia dei licenziamenti, che includono tra gli standards valutativi
principi definiti come ricavabili dal “diritto vivente”.
Si pensi, ad esempio, al vastissimo filone giurisprudenziale che
allinea le pronunce secondo le quali il giudice sarebbe legittimato a
valutare la legittimità del recesso senza necessità di ricorrere a
standard bensì esclusivamente sulla base di un’astratta “nozione
legale” del contenuto della clausola generale, contrapponibile alla
previsione enunciata dal contratto collettivo (79) e destinata a
prevalere su quest’ultima (sebbene, in realtà, si tratti di una
puntualizzazione espressa a titolo di obiter dictum nell’ambito di
(79) Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906, Cass. 18 febbraio 2011, n. 4060, Cass. 31 gennaio
2012, n. 1405.
92
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
decisioni che si orientano, poi, in senso completamente opposto,
accogliendo in sostanza la qualificazione del comportamento operata dall’autonomia collettiva). Motivazioni che si pongono accanto alla già ricordata ed ellittica giuridificazione dei (vaghi)
principi di “civiltà del lavoro”.
Passando ad un altro profilo di questa problematica si rammenta che nel panorama dottrinale, soprattutto a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale del 9 marzo 1989, n. 103, pure
rimasta del tutto isolata, la questione del possibile collegamento
tra alcuni principi costituzionali e le clausole generali è stata
affrontata in numerosi studi, anche di recentissima apparizione.
L’orientamento maggiormente condiviso, come noto, è quello
secondo il quale deve escludersi che le clausole generali possano
fungere da mero meccanismo di “raccordo” tra i comportamenti
delle parti del rapporto di lavoro e i principi fondamentali dell’ordinamento (80).
La possibile identificazione tra clausole generali e principi
generali di matrice costituzionale è stata, però, ultimamente riproposta da chi ha ritenuto di poter scorgere, in particolare nell’”utilità sociale” richiamata dal secondo comma dell’art. 41 Cost. una
clausola generale, giudizialmente applicabile quale parametro di
legittimità dell’esercizio della libertà di organizzazione di impresa
nei rapporti di lavoro (81).
A tal proposito occorre, innanzitutto, evidenziare come i principi, quali espressioni di valori fondativi di un ordinamento (82),
siano collocati in posizione diversa rispetto alle clausole o norme
generali sì da non potersi al contempo identificare con queste
ultime.
Lungi dal fornire indicazioni stabili ed immutabili, le clausole
generali sono piuttosto, come già evidenziato, espressione di una
tecnica legislativa e (al contempo, ma non esclusivamente) “una
tecnica di formazione giudiziale della regola da applicare al caso
concreto, senza un modello di decisione precostituito da una fattispecie
astratta” (83), ma si collocano pur sempre entro il perimetro delle
regole.
(80) Ferraro, 1991a, ora 1992, 175.
(81) Bavaro, 2012, 73 e in precedenza Scarpelli, 1996, 25 ss. nonchè, più classicamente, Natoli, 1955, 99 ss., spec. 107 s.
(82) Rodotà, 1987, 721; Falzea, 1987, 12 ss.
(83) Mengoni, L., 1986, 10.
93
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
In ragione di questa collocazione, la clausola o norma generale
non può essere né ricondotta né ridotta, quindi, per il tramite della
mera evocazione del referente costituzionale, ad una mera espressione dell’uno o dell’altro principio, dovendo peraltro, nella sua
concretizzazione, certamente conformarsi ad alcuni dei principi
generali espressi dall’ordinamento, ma senza perdere la sua sostanza di ricettore di regole (84).
Con particolare riferimento ai concetti di matrice costituzionale, è utile rifarsi agli studi dedicati, anche in tempi recenti (85),
alla tematica dell’esistenza, all’interno del testo della Costituzione,
di norme o frammenti di norme strutturalmente affini alle clausole
generali e della loro coesistenza con i più “stabili” principi generali,
sempre rinvenibili nella Costituzione (86).
Accanto a questi principi, il cui nucleo concettuale appare
destinato a rimanere fisso e immutabile nel tempo, nel testo
costituzionale sono presenti numerosi richiami a referenti metagiuridici, assimilabili a quelle che nel diritto civile assumono la
denominazione di clausole generali. Richiami che ricorrono con
particolare frequenza, va detto, nel titolo III dedicato ai rapporti
economici (sui allude, come già rammentato, all’“utilità sociale”
menzionata nell’art. 41, secondo comma, così come alla “funzione
sociale” della proprietà nel secondo comma dell’art. 42 o all’”utilità
generale” che legittima le espropriazioni e nazionalizzazioni a
norma dell’art. 43).
In ragione dello specifico contesto normativo in cui questi
enunciati si inseriscono, tuttavia, si riconosce che rispetto alle
clausole generali esistenti a livello di legislazione ordinaria permangono delle profonde differenze in termini di applicabilità (87).
(84) Sulla collocazione “sequenziale” e sulla non sovrapponibilità di valori, principi
e regole, Zagrebelsky, 2002, 877, nonché Mengoni, 1996, 126, e, più recentemente, Garofalo,
M.G., 2008, 34, il quale evidenza come la lettura dei principi costituzionali non debba
tradursi nella descrizione della fattispecie che condiziona l’applicazione della regola, proprio
in quanto muovendosi sul piano costituzionale non si individuano regole, bensì principi.
(85) Da ultimo, in argomento, Pedrini, 2009, al quale si rinvia anche per la ricchezza
di richiami bibliografici.
(86) Tra i quali potrebbero ad es. annoverarsi quelli espressi dagli artt. 3 (uguaglianza) e 2 (diritti inviolabili), 22 (divieto di limitazioni della capacità giuridica per motivi
politici), 97 (imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni) ecc.
(87) Come evidenzia Luciani, 1983, 82, con riferimento al raffronto tra le clausole
generali presenti a livello di legislazione ordinaria e gli analoghi rinvii alla tipicità sociali
94
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Solo in alcuni casi, tutto sommato eccezionali (88), la loro
precettività si traduce in una applicabilità immediata, mentre in
via ordinaria gli “interpreti” dei rinvii ai valori sociali operati nelle
norme costituzionali vanno individuati, per gli ambiti di rispettiva
competenza, nel legislatore e nella Corte costituzionale (89); ciò che
trova ampia conferma proprio nella giurisprudenza costituzionale,
che spesso si richiama ad alcune previsioni costituzionali qualificandole come clausole generali nel momento in cui procede ad
utilizzarle come parametri di costituzionalità delle leggi ordinarie (90).
presenti nel testo costituzionale, “le somiglianze fra le due categorie non possono però far
dimenticare gli elementi di distinzione. In particolare, la qualifica di clausola generale va
riservata (se si vuole restare all’uso tradizionale) a quella previsione che sia (per sua natura e/o
per la fonte che la prevede) atta all’immediata applicazione nei rapporti interprivati. In questo
senso, è inopportuno estendere questa qualifica ai principi costituzionali, la cui immediata
applicabilità non è mai scontata, ed opera comunque, anche quando vi sia, in forme diverse da
quelle proprie delle clausole generali. Meglio dunque definire come principi valvola le norme
costituzionali che presentano le caratteristiche di cui nel testo, quasi a segnarne lo stacco
dall’altra più tradizionale categoria. Il che, ovviamente, non comporta adesione alla vecchia tesi
secondo cui i principi costituzionali sarebbero mere “disposizioni programmatiche” (...). Non
si tratta infatti di negare la precettività dei principi costituzionali, ma soltanto di affermarne la
diversa precettività, dovuta al loro operare ad un livello distinto da quello della norma ordinaria”. In argomento, si veda, anche, Belvedere, 1989, 639 s.
(88) Tra i quali, rientrano, certamente, i precetti, certamente rinvianti ai dati di
realtà sociale, espressi dagli artt. 36, primo comma, e 40 Cost. (senza necessità di argomentare ulteriormente tale affermazione, che si ritiene generalmente condivisa: cfr. Mengoni,
1996, 131 s.).
(89) Per usare le espressioni di Pessi, 2009a, 11, “in carenza di una tavola astratta dei
principi, a ragione dell’inesistenza di una gerarchia assiologica dei valori, la quale, tra l’altro,
contrasterebbe con le esigenze del pluralismo, è necessario operare un controllo sulla razionalità
di ogni contemperamento operato dal legislatore. E, del resto, lo stesso non è effettuato solo tra
valori, ma anche tra diritti, che sono spesso desumibili da regole puntuali presenti nel testo
costituzionale. Un controllo, quindi, che non può che essere svolto dall’organo di chiusura del
sistema”.
(90) Cfr. a titolo di esempio, le sentenze del 23 gennaio 2014, n. 4, 19 luglio 2012, n.
192, 28 marzo 2012, n. 70 (con richiamo all’art. 81, quarto comma, Cost.); 22 maggio 2013,
n. 94, 22 luglio 2010, n. 270 (dove si ribadisce che la realizzazione delle clausole generali
dell’“utilità sociale” e dei “fini sociali” enunciate dai commi secondo e terzo dell’art. 41Cost.
compete al legislatore); 18 dicembre 2009, n. 335 (sulla clausola generale di “compatibilità”
tra le tutele accordate ai figli nati fuori dal matrimonio ed i diritti dei membri della famiglia
legittima) e 28 novembre 2002, n. 494 (sul riconoscimento dei diritti della famiglia riconosciuti dall’art. 29, primo comma, Cost.); 29 luglio 2005, n. 345 (sul principio di ragionevolezza espresso dall’art. 3 Cost. come clausola generale); sull’utilizzazione del limite dell’utilità sociale, intesa quale “vincolo al conseguimento del bene comune”, nell’ambito del giudizio
95
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Di conseguenza, e secondo l’ordine di idee già espresso dalla
dottrina civilistica, simmetricamente a quella costituzionalista,
l’esistenza a livello costituzionale di concetti elastici implica comunque delle differenze rispetto all’operatività degli stessi in ambito privatistico, “non esaurendosi nel profilo interpretativo, ma
comprendendo anche l’eventuale svolgimento di attività legislativa” (91).
Ciò vale a maggior ragione per il limite dell’utilità sociale, la cui
concretizzazione postula il compimento di scelte puntuali e l’accoglimento di specifiche opzioni di politica del diritto entro un
ventaglio di possibilità estremamente ampio, così da non apparire
realizzabile se non per il tramite di uno specifico intervento legislativo (92) anche proprio in ragione della genericità e indeterminatezza del testo costituzionale (93).
5.1. Alterità tra principi e dati di realtà sociale nel momento
applicativo delle clausole generali.
Assodato che, di per sé, le clausole generali non contengono né
esprimono dei principi fondamentali né possono autorizzare l’interprete ad accogliere e ad imporre come immediatamente precettive alcune opzioni attuative delle norme costituzionali il cui
accoglimento rimane di competenza del legislatore, rimane da
valutare, come anticipato, se l’influenza degli stessi sulla concretizzazione del significato delle clausole generali possa riaffacciarsi,
come ipotizzato nelle ricostruzioni dottrinali alle quali si è già fatto
riferimento, mediante la loro inclusione tra gli standards valutativi.
Una delle questioni che rientrano nell’ambito del generale
dibattito in materia di clausole generali, infatti, è se l’idea degli
standards valutativi rinvii esclusivamente a criteri e parametri
esterni al diritto positivo e quindi alluda ad una riconosciuta
necessità di eterointegrazione dell’apparato delle fonti formali,
di legittimità costituzionale si veda già la più risalente Corte cost., 22 gennaio 1957, n. 29,
GCost., 1957, 404.
(91) Rodotà, 1960, 1287.
(92) In termini di esistenza di una specifica riserva di legge in materia di utilità
sociale, Santucci, 1997, 68 e, in precedenza, Santoro-Passarelli, G., 1990, 570; Luciani, 1983,
160 ss.; Galgano, 1982, 42.
(93) In particolare, per questa notazione, Minervini, G., 1958, 623.
96
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ovvero possa estendersi anche a dati tratti da quest’ultimo o,
addirittura, esaurirsi nel richiamo ad essi (94).
Viene rilevato che, nella maggior parte dei casi, la formulazione delle clausole generali non contiene elementi che facciano
risalire alla natura necessariamente esterna al diritto dello standard (95) e con indubbio realismo è stato scritto che “appare
improbabile che, di fronte a una norma a contenuto indeterminato il
giudice non possa tentare di attribuirle un significato facendo appello
ai principi formalmente sanciti nell’ordinamento”; puntualizzandosi, comunque, come le motivazioni autoreferenziali che si richiamino esclusivamente a “interpretazioni consolidate”, piuttosto che
a specifici dati testuali riconosciuti come espressivi di precetti
vincolanti non rappresentino un corretto utilizzo dell’argomentazione per principi (96).
L’idea prevalente rimane, tuttavia, quella secondo cui le clausole generali debbono essere intese come punti di contatto tra
diritto e modelli di comportamento offerti dalla vita sociale, ossia
come strumenti di “ricezione sostanziale (97)” di valori e schemi di
condotta che assumono rilevanza giuridica in quanto espressi e
condivisi dai componenti di determinati gruppi sociali.
È la necessità del richiamo a tali elementi esterni, si evidenzia,
che costituisce il più solido argine al rischio che le clausole generali
siano intese come una delega in bianco al giudice e finiscano per
trasformarsi in un enorme contenitore “stipato di valori e concetti
eterogenei” (98); ciò anche in considerazione del fatto che gli standards assumono una maggiore nitidezza per il fatto di essere
completamente calati nella storicità, laddove, invece, i principi,
per il fatto di essere caricati di una forte idealità, “costituiscono le
norme più generiche dell’ordinamento giuridico (99)”.
Trova conferma, in questa prospettiva, l’idea che per la loro
struttura e funzione le clausole generali non possono né debbono
(94) Sul “rischio di inutilità che si corre se si giunge a ridurre l’attività applicative delle
clausole generali a una semplice iterazione dei precetti costituzionali”, Belvedere, 1989, 639.
(95) Velluzzi, 2010, 65 ss.
(96) Libertini, 2011, 351.
(97) Falzea, 1987, 3.
(98) Luzzati, 2013, 183.
(99) Falzea, 1987, 14. Cfr. anche Ferraro, 1992, 175, che manifesta aperto scetticismo
in merito alla possibilità di individuare linee costituzionali o ordinamentali precise e costanti
suscettibili di conformare i comportamenti privati.
97
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
essere convertite in norme-ponte che in via mediata consentano
l’applicazione di principi giuridici generali e segnatamente di quelli
costituzionali nei rapporti interprivati (100); e ciò non in nome di
un anacronistico ossequio ad una lettura di quei principi in chiave
esasperatamente programmatica, quanto per la più convincente
ragione, maggiormente pertinente rispetto al tema qui trattato,
che la genericità dei principi entra in conflitto con l’obiettivo,
perseguito dal legislatore mediante l’inserzione delle clausole generali nel diritto positivo, di assicurare il contatto con le ragionevoli
aspettative della vita sociale.
In senso diverso, è stato recentemente asserito che l’immissione del limite dell’utilità sociale nella ratio delle clausole generali
potrebbe rappresentare un modo per proteggere la parte debole (101). Ma questa lettura ancora una volta, come spesso accade
nei discorsi in tema di clausole generali nel diritto del lavoro,
trascura di considerare che in un numero considerevole di casi la
concretizzazione delle clausole generali avviene con la mediazione
dell’autonomia collettiva, che è già riconosciuta dall’ordinamento
quale adeguata forma di riequilibrio del divario di posizioni tra le
parti del rapporto di lavoro individuale. Sicché una simile ricostruzione non può non apparire, prima ancora che sbilanciata, come
poco aderente rispetto alle concrete dinamiche regolative dei rapporti di lavoro.
Dal momento che secondo la corrente di pensiero più fedele
alla vocazione “ricettiva” delle clausole generali, queste ultime
sono preordinate a recepire la “vita ordinaria” al fine di assecondare la relativa prevedibilità dei comportamenti negoziali, se ne
dovrebbe far discendere che queste non rappresentino lo strumento opportuno per introdurre nell’ordinamento valori nuovi e
rivoluzionari o per fondare nuovi istituti (102).
Secondo la visione più accreditata e qui condivisa, la finalità
generale a cui tali enunciati normativi obbediscono rimane, piuttosto, quella di tracciare una linea di collegamento tra ordinamento giuridico positivo e dati, tipi di comportamento o standard
sociali, come tali esterni al diritto ma destinati a divenire elementi
di riferimento per il giudice proprio in forza della direttiva ricava(100) Come ricordato da Nogler, 2007, 596.
(101) Franzoni, 2011, 801.
(102) Luzzati, 2013, 182.
98
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
bile dalla clausola generale, quali forme di valutazione degli interessi in gioco che, pur esterne all’ordinamento giuridico, per riprendere un’espressione di Persiani, “assumono tuttavia un valore determinante per l’interpretazione della legge” (103).
Sono molti gli esempi che potrebbero essere richiamati sin da
ora al fine di corroborare l’idea dell’imprescindibilità di tali dati di
riferimento esterni, dal richiamo alla “natura della prestazione
dovuta” (art. 2104 c.c.), alle tematiche connesse allo ius variandi, al
potere disciplinare il cui esercizio deve essere valutato sulla base
del criterio di proporzionalità, tutte previsioni legislative che non
paiono suscettibili di acquisire un significato sufficientemente definito se non attraverso il riferimento a criteri certamente esterni al
sistema giuridico. Ma la veridicità di questo assunto potrà essere
verificata in maniera più circostanziata all’esito di una ricognizione
a più ampio raggio, seppur non esaustiva, come quella che ci si
appresta a svolgere.
6. L’intervento dell’autonomia collettiva in funzione di integrazione
della fattispecie legale. L’esempio paradigmatico dell’applicazione per via giudiziale dell’art. 36, primo comma, Cost.
Definito il quadro teorico generale e passando all’esame più
diretto di elementi normativi appartenenti allo “specifico” giuslavoristico, è possibile avviare la ricognizione delle differenti modalità in cui si esplica questa particolare forma di interazione tra
legge e contratto collettivo, ossia alle diverse forme attraverso le
quali prendono corpo le distinte fattispecie di tacito rinvio agli
standard rinvenibili nella realtà sociale.
Un primo raggruppamento di clausole generali che presentano
tra loro un’affinità strutturale rispetto al loro modo di atteggiarsi
nei confronti dell’autonomia collettiva è rappresentato da quelle
disposizioni con riferimento alle quali quest’ultima opera in funzione di integrazione della fattispecie legale. Qui il contratto collettivo rappresenta implicitamente (o, più di rado, viene definito
esplicitamente come tale) la forma di concretizzazione naturale,
ovvero di completamento di significato, della fattispecie delineata
nei suoi tratti basilari dal legislatore.
(103)
Persiani, 1966, 239.
99
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
In queste ipotesi l’interdipendenza tra la clausola generale e la
sua declinazione pratico-operativa, come risultante dall’elaborazione compiutane dall’autonomia collettiva, si atteggia come una
naturale sequenzialità logica, che può essere interrotta solamente
dall’accertamento della palese inidoneità del contratto collettivo
“a fornire quei criteri di tipicità sociale e ambientale e soprattutto a
testimoniare quella sintesi conflittuale in vista della quale diviene
destinataria del « rinvio » da parte del legislatore” (104).
Le fattispecie nelle quali si realizza questo tipo di integrazione
sono molteplici, anche se va detto che assai di rado la prossimità
strutturale tra queste diverse norme ha sinora rappresentato un
elemento che inducesse gli interpreti riunirle entro un quadro
analitico di insieme. Così come non sono unitarie le giustificazioni
teoriche che sono state formulate per spiegare la rilevanza prioritaria del contratto collettivo quale strumento integrativo essenziale per l’individuazione del concreto significato assegnabile al
precetto legale.
L’esempio storicamente più risalente e per molti versi paradigmatico di questa forma di interazione tra legge e contrattazione
collettiva può essere rinvenuto in quella che, con una espressione
riassuntiva viene definita come attuazione per via giurisprudenziale dell’art. 36, primo comma, Cost. (105)
Si può ritenere che la previsione costituzionale in materia di
giusta retribuzione integri una clausola generale (106) nell’accezione qui accolta per la duplice ragione che, in primo luogo, tale
disposizione esprime sì un principio, ma si tratta di un principio
che si concretizza in un rinvio a parametri esterni rispetto alle
norme di diritto positivo, almeno sin quando non verrà accolta
l’esortazione, ancora recentemente ribadita, all’introduzione nel
nostro ordinamento dell’istituto del salario minimo legale (107). In
secondo luogo, perché si tratta di un un precetto generalmente ed
immediatamente vincolante — per le molteplici e notissime ragioni
(104) De Luca Tamajo, 1976, 144.
(105) Per un richiamo al valore esemplare di questa vicenda giurisprudenziale nel
panorama teorico delle clausole generali, da ultimo, Roselli, 2014, 227.
(106) Non è concorde l’opinione espressa da ultimo da Ghera, Garilli, Garofalo D.,
2013, 165.
(107) Da ultimo, in argomento, Treu, 2010, Magnani, 2010, Marinelli, M., 2010 e
2011, Ricci, G., 2011, 654 ss.
100
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sistematiche che hanno condotto al quasi unanime rigetto della tesi
della c.d. sua programmaticità e al di là delle possibili originarie
intenzioni dei costituenti (108) — e quindi direttamente applicabile da parte del giudice.
Le modalità applicative della previsione in materia di giusta
retribuzione si prestano a considerazioni di respiro più vasto rispetto al suo contenuto specifico non solamente in ragione della
natura di clausola generale di questa norma; spunti ulteriori si
traggono dall’esperienza giurisprudenziale progressivamente dipanatasi lungo un arco temporale più che cinquantennale, durante il
quale si è assistito inizialmente al riconoscimento di una amplissima libertà di apprezzamento del giudice, ritenuto libero di discostarsi, soprattutto in senso riduttivo dai parametri offerti dalla
contrattazione collettiva.
Se parte della dottrina, variamente argomentando, ha espresso
l’idea che l’esercizio di questo potere di “reinterpretazione” giudiziale del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente —
anche in termini sensibilmente difformi rispetto alle determinazioni dell’autonomia collettiva — costituisca una forma di corretta
applicazione della norma costituzionale (109), nell’ultimo ventennio si può dire che siano, viceversa, prevalse le voci fortemente
critiche rispetto a quella che è stata letta come una ingerenza, il
più delle volte del tutto autoreferenziale, rispetto all’esercizio della
competenza istituzionale del sindacato quale “autorità salariale”.
Un orientamento critico che si richiama, da un lato, al riconoscimento del contratto collettivo quale ordinario strumento attuativo del precetto costituzionale, risultante dal combinato disposto
degli articoli 36 e 39 Cost., dall’altra appare trovare sostegno nella
valutazione di insieme della sempre più fitta trama di rinvii legali
che, nel loro complesso, inducono a scorgere nel sistema di contrattazione collettiva di cui sono protagoniste le organizzazioni
(108) In argomento, recentemente, Ichino, 2010, 739, che si richiama a Giugni, 1971.
(109) Cfr., riepilogativamente, Roma, 1993 e Zoppoli, 1994. Una giustificazione
implicita di questa libertà di apprezzamento da parte del giudice si rintraccia all’interno di
quelle ricostruzioni che attribuiscono alla determinazione giudiziale della giusta retribuzione la natura di giudizio sostanzialmente equitativo. Per critiche a questa qualificazione
ci si permette di rinviare a Bellomo, 2002, 85 ss. Sulla distinzione tra applicazione giudiziale
delle clausole generali e giudizio equitativo si veda il precedente § 1.1. e si veda, anche, il
successivo § 12, nota 313.
101
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sindacali dotate di particolari requisiti di rappresentatività l’imprescindibile dato di riferimento per la quantificazione di trattamenti, in particolare di quelli retributivi, coerenti con gli equilibri
economici e con gli assetti occupazionali dei diversi segmenti nei
quali tale sistema si articola (110).
La prossimità fra la tematica dell’applicazione giurisprudenziale dell’art. 36 Cost. e le coordinate teoriche lungo le quali
procede la ricostruzione delle dinamiche di concretizzazione delle
clausole generali diviene evidente nel momento in cui si riscontra
che il precipitato giurisprudenziale di questo dibattito si condensa
nel sempre più marcato riconoscimento del dovere del giudice non
tanto e non solo di assumere come principale parametro di riferimento il contratto collettivo, ma anche di individuare, in caso di
scostamento, un parametro alternativo altrettanto attendibile e
verificabile (ad es. dati economico-statistici provenienti da istituti
di provata autorevolezza).
Questo principio di diritto, ormai universalmente accettato e
condiviso, viene oggi completato — ed è un elemento di significativo progresso rispetto al precedente scenario giurisprudenziale —
con una puntualizzazione tutt’altro che secondaria.
Nelle sentenze emesse a partire dall’inizio degli anni duemila,
(110) In particolare, per una esposizione minuziosamente argomentata di tali critiche, cfr. Liso, 1998, 191 ss. In forza di tali argomenti, ad esempio, è prevalsa l’idea che i
contratti collettivi di riallineamento introdotti nella metà degli anni novanta fossero
legittimati a rimodulare i minimi retributivi in connessione con le finalità di emersione
perseguite da questi provvedimenti legislativi e che gli interventi di riduzione dei minimi
non fossero sindacabili dal giudice per possibile contrasto con la previsione costituzionale.
Una conclusione non giustificata da una ipotetica (e di assai problematica ammissibilità)
efficacia derogatoria di tali contratti rispetto al riconoscimento costituzionale del diritto alla
giusta retribuzione, quanto, piuttosto, dalla considerazione secondo cui tali interventi
rappresentano una delle estrinsecazioni della ordinaria competenza negoziale delle organizzazioni sindacali operanti a livello aziendale o locale, nell’ambito della quale possono
rientrare anche possibili adattamenti della disciplina retributiva dettata dal contratto
collettivo nazionale alle specificità del contesto territoriale o alla situazione di una determinata impresa (in generale, per la legittimità dell’adozione del contratto collettivo aziendale o locale quale parametro per la verifica di conformità de trattamento retributivo all’art.
36 Cost., cfr. Cass. 31 gennaio 2012, n. 1415; Cass., 3 dicembre 1994, n. 10366, GI, 1996, I,1,
546, con nota di Madera, M.; Cass. 23 gennaio 1988, n. 536). In argomento, oltre a Liso, 1998,
Viscomi, 1999; Lambertucci e Maresca, 1997; Bellavista, 1998; Garofalo, D., 1997; Stolfa,
1997; Lambertucci, 1995; Lambertucci, 1992; in giurisprudenza, cfr. Cass. 13 marzo 2008, n.
6755.
102
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
il giudice di legittimità si preoccupa di precisare che il giudice è
tenuto, in ogni caso, a motivare la propria decisione, nell’eventualità di uno scostamento dal parametro, sulla base di “elementi
concreti”.
Il che significa se ben si intende l’ammonimento espresso dal
giudice di legittimità, che non possono essere ritenute conformi a
legge quelle sentenze, spesso tendenzialmente orientate verso una
quantificazione della giusta retribuzione “al ribasso” rispetto al
parametro collettivo (111), che in passato sono pervenute a giustificare questo scostamento attraverso motivazioni di tipo “discorsivo” nelle quali lo scostamento rispetto al parametro collettivo si
riteneva giustificabile con il richiamo generico ad una pluralità di
elementi, quali la quantità e qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere artigianale e le dimensioni dell’azienda,
ma senza necessità per il giudice di dedurre alcun concreto elemento a supporto della effettiva incidenza di tali “fattori” di
riduzione sulla fattispecie concreta, tanto con riguardo all’an
quanto con riferimento al quantum (112).
Sulla base di questa nuova impostazione, il dato di tipicità
sociale offerto dal contratto collettivo rimane il parametro di
riferimento primario, necessario e tendenzialmente sufficiente in
forza della riconosciuta presunzione di rispondenza dei trattamenti
previsti dal contratto collettivo ai criteri enunciati dalla norma
costituzionale (113), con onere a carico di chi ne contesti l’attendibilità di indicare gli elementi dai quali risulti l’inadeguatezza in
eccesso del parametro in considerazione di specifiche situazioni
locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore (114).
Tale onere, nel caso opposto, si trasferisce su chi lamenti
l’inadeguatezza della retribuzione percepita; il lavoratore, però,
non può dedurre la sola astratta insufficienza dei trattamenti
(111) Da ultimo, in argomento, Ricci, G., 2011, 647 ss.
(112) In questo senso, ad esempio, Cass. 17 gennaio 2011, n. 896, FI, 2011, I, 765, la
quale ha cassato la sentenza di merito che aveva reputato adeguata la retribuzione del
lavoratore inferiore ai minimi fissati dal contratto collettivo di categoria facendo generico
riferimento alle retribuzioni correnti nelle piccole imprese operanti nel meridione d’Italia
invece che a quelle della specifica categoria. Cfr. anche Cass. 1 febbraio 2006, n. 2245.
(113) Così, Cass. 15 ottobre 2010, n. 21274; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889, LG, 2009,
302.
(114) Cass. 13 novembre 2009, n. 24092.
103
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
retributivi fissati dal contratto collettivo, ma è tenuto ad indicare
il parametro esterno che conferisce oggettività alla contestazione
di inadeguatezza (115). Rimane escluso in ogni caso, secondo
questo indirizzo, che il giudice possa operare una quantificazione
della giusta retribuzione discostandosi dal parametro offerto dal
contratto collettivo sulla mera base della sua scienza privata (116)
e lo stesso dovrebbe dirsi di quelle pronunce, anch’esse in passato
frequenti, nelle quali il giudice provvede a quantificare in termini
sintetici, ma anche in questo caso senza alcun conforto oggettivo,
la simultanea incidenza di molteplici fattori quali la quantità e
qualità del lavoro prestato, le condizioni personali e familiari del
lavoratore, le tariffe sindacali praticate nella zona, il carattere
artigianale e le dimensioni dell’azienda quali possibili elementi che
autorizzano uno scostamento in senso riduttivo dal medesimo
parametro (117).
In questa fattispecie, così come nelle altre che verranno esaminate, più che muovere alla ricerca di argomenti a sostegno di
una giuridica vincolatività del parametro collettivo (118) — che
incontrerebbe una serie di possibili obiezioni generalmente note e
peraltro non tutte superabili nemmeno nella già di per sé comunque avveniristica prospettiva de iure condendo di un intervento
legislativo in materia di efficacia generale dei contratti collettivi —
l’adozione della chiave di lettura che fa leva sulla attitudine del
contratto collettivo ad integrare, o meglio a concretizzare il contenuto del precetto generale permette di formulare alcune precisazioni.
Nelle clausole generali che posseggono una struttura affine a
quella dell’art. 36 Cost. permane una nozione legale (nell’esempio
ora richiamato, la nozione legale di retribuzione proporzionata e
sufficiente) che mantiene la sua autonomia e la sua imperatività
rispetto alle previsioni del contratto collettivo.
Il giudice chiamato ad applicare la norma deve, al fine di
verificare conformità a legge della condotta delle parti, compiere
(115) Cass. 8 gennaio 2002, n. 132, FI, 2002, I, 1033.
(116) Cass. 26 luglio 2001, n. 10260, RIDL, 2002, II, 299, con nota di Stolfa.
(117) In questo senso, recentemente, Cass. 28 agosto 2004, n. 17250, MGL, 2004, 950.
(118) Diversamente, nel senso della vincolatività per il giudice degli interventi
dell’autonomia collettiva di specificazioni o integrazioni di fattispecie generiche o di clausole
generali, Pedrazzoli, 1990, 565.
104
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
un’operazione di “riempimento” della clausola generale per poterne ricostruire il significato in termini di giustiziabilità e a questo
fine è tenuto a selezionare gli standards, che nel caso della retribuzione proporzionata e sufficiente sono i parametri socialmente
attendibili attraverso i quali il contenuto della norma arriva ad
assumere una sua consistenza concreta.
Nel compiere tale operazione il giudice deve tener conto del
fatto che rispetto ai possibili dati ricavabili dalla realtà sociale e
che permettono la concretizzazione della clausola generale, il contratto collettivo costituisce la sede in cui le generiche indicazioni
del legislatore vengono tradotte in contenuti specifici che presentano una particolare attendibilità. Questo sia perché tali contenuti
provengono dal sistema di relazioni industriali, i cui attori sono
dotati della competenza tecnica derivante dalla conoscenza delle
tipicità sociali che caratterizzano i rapporti di produzione, sia
perché espressivi dei valori che si perfezionano nella sintesi tra le
forze contrapposte che all’interno di questo sistema si confrontano
e degli equilibri che nella realtà del confronto maturano tempo per
tempo.
Il riconoscimento di questa priorità del contratto collettivo
rispetto ad altri possibili dati di tipicità sociale si traduce in quella
che, con particolare riferimento, pur non esclusivo, all’applicazione
dell’art. 36 Cost., viene definita come “presunzione” di adeguatezza della previsione collettiva rispetto alla ratio della clausola
generale (119).
L’esemplificazione alla quale si è fatto ricorso può fungere da
adeguata base di partenza per un discorso di tipo induttivo,
ispirato all’idea che questa preminenza del dato di realtà sociale
offerto dal contratto collettivo non possa essere ricondotta ad una
risultanza di ordine meramente fattuale.
Piuttosto, si può avanzare il sospetto che questo primato trovi
(119) Recentemente, in tal senso, Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889, LG, 2009, 302;
Cass. 16 maggio 2006, n. 11437, RCDL, 2006, 439; Cass. 8 gennaio 2002, n. 132, FI 2002, I,
2033, nel solco, comunque, di un indirizzo assai risalente; cfr., tra le altre, Cass. 14 dicembre
1990, n. 11881; Cass. 29 agosto 1987, n. 7131 sottolinea come tale presunzione possa essere
superata solo in presenza di una rigorosa prova contraria, Cass., 19 marzo 1981, n. 1332; in
materia di recesso, sull’idoneità del contratto collettivo a definire situazioni presuntivamente integranti una giusta causa o un giustificato motivo, Cass. 19 aprile 1982, n. 2366,
MGL, 1982, 387.
105
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
un duplice fondamento, da un lato, nella ratio interna delle clausole
generali in materia di rapporto di lavoro, in base alla quale l’interprete deve farsi carico di selezionare gli standards valutativi più
appropriati, ossia quelli che meglio riflettono i modelli di comportamento generalmente condivisi nel contesto sociale di riferimento.
Dall’altro lato, su questa selezione non è ininfluente il riconoscimento della rilevanza prima di tutto costituzionale del fenomeno dell’autonomia collettiva competenza negoziale attribuita
dall’ordinamento all’autonomia collettiva (con particolare riferimento, quanto ai referenti normativi di tale riconoscimento, agli
artt. 39 Cost. e 1322 c.c.) (120). Una influenza a cui si può
convenire che non ostino né l’inesistenza, più volte rimarcata dalla
Corte costituzionale, di una “riserva” esclusiva di competenza
dell’autonomia collettiva (121), né la mancata attuazione della
seconda parte dell’art. 39 Cost.
Anche a prescindere dal problematico completamento del disegno costituzionale, rimane indiscussa ed è stata ugualmente
posta in risalto dalla stessa Corte costituzionale, proprio con riferimento alla sua funzione di integrazione delle clausole generali, la
tendenziale e generale attitudine del contratto collettivo quale
punto di equilibrio tra gli interessi delle parti (122).
(120) Ogni tentativo di sintesi bibliografica sul punto sarebbe naturalmente velleitario. Per ampi richiami alla dottrina che si è cimentata con il tema dei referenti ordinamentali del riconoscimento dell’autonomia collettiva cfr. riepilogativamente, da ultimo,
Bellocchi, 2013, spec. 332 ss.; Santoro-Passarelli, G., 2007, 18; Rusciano, 2003, spec. 54 ss.
e, in precedenza, Balducci, Carabelli, 1984, 71 ss. In particolare, per l’individuazione
dell’art. 39 Cost. come fondamento dell’autonomia negoziale collettiva cfr., tra gli altri,
Giugni, 1979, 280; Scognamiglio, R., 1971 (ora 1996), 1538; Pedrazzoli, 1990, 364 ss.
(121) In argomento, da ultimo, Persiani, 2006, 1033.
(122) Nella motivazione della sentenza n. 103 del 1989, con riferimento ad una
materia regolata da una clausole generale, quella contenuta nell’art. 2103 c.c., si evidenzia,
ad esempio come “nella determinazione delle mansioni e dei conseguenti livelli retributivi,
l’autonomia del datore di lavoro, cui spetta l’organizzazione dell’azienda, è fortemente limitata
dal potere collettivo, ossia dai contratti collettivi e dai contratti aziendali.
Tali contratti, quali estrinsecazioni del potere delle associazioni sindacali, sono frutto e
risultato di trattative e patteggiamenti e costituiscono una regolamentazione che, in una
determinata situazione di mercato, è il punto di incontro, di contemperamento e di coordinamento dei confliggenti interessi dei lavoratori e degli imprenditori”. Sottolineatura poi ripresa
dal giudice di legittimità nella articolata motivazione della sentenza del 2006 in tema di
legittimità delle clausole di fungibilità professionale (Cass. S.U. 24 novembre 2006, n. 25033,
RIDL, 2007, II, 336, con nota di Occhino). Sul riconoscimento in capo al contratto
collettivo della funzione “di fonte regolatrice dei modi di attuazione della garanzia costituzio-
106
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
La convergenza di queste due indicazioni permette all’interprete di orientarsi verso coordinate valutative che non possono
essere qualificate come finite, autosufficienti e insuscettibili di
alternative rispetto all’adozione del contratto collettivo come parametro di riferimento per la determinazione della “giusta” retribuzione, ma possono, piuttosto essere sì rappresentate come tappe
obbligate del percorso decisorio, superabili solo in presenza di dati
extralegali alternativi concreti, oggettivi, contrastanti e riconoscibili come maggiormente attendibili.
In altri termini, il superamento dei criteri offerti dal contratto
collettivo appare plausibile nel momento in cui il contrasto con
altri dati di tipicità sociale renda palese la loro inadeguatezza.
Eventualità comunque ipotizzabile, seppur, va detto, destinata a
rimanere circoscritta entro un ambito di probabilità fisiologicamente limitato, perché tale inadeguatezza appare fenomenicamente distonica rispetto alle normali dinamiche della realtà sociale.
7. Diligenza e autonomia collettiva.
L’esempio del diritto alla giusta retribuzione, che si è ritenuto
di richiamare per primo, si ricollega ad una fattispecie con riferimento alla quale l’osmosi tra la fonte legale e il dato integrativo di
fonte collettiva appaiono così interdipendenti da apparire coessenziali. Questo schema, va evidenziato, è adattabile a numerosi altri
istituti, con riferimento sia alla normale esecuzione del rapporto di
lavoro sia alle sue patologie, sfocianti nell’inadempimento e nell’eventuale recesso per un inadempimento gravissimo o notevole.
È stata già evocata la tematica riguardante la regola di diligenza sancita dall’art. 2104 c.c., sulla quale può essere opportuno
tornare per evidenziare una serie di punti di convergenza con le
considerazioni sin qui sviluppate.
Prendendo le mosse dalla concezione della diligenza come
criterio (123) o misura (124) di valutazione del comportamento
nale del salario sufficiente”, Corte Cost. 26 marzo 1991, n. 124, FI, 1991, I, 1333, con nota di
Amoroso, G.
(123) Persiani, 1966, 214.
(124) Ghera, 2002, 157.
107
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dovuto dal prestatore di lavoro, e sulla scorta dell’ormai generalizzato dissenso verso l’idea di ascendenza barassiana della misurazione della diligenza sulla base dell’intensità con l’intensità o
bontà dello “sforzo di volontà” compiuto dal debitore (125), la
diligenza è a tutt’oggi al centro di un dibattito in merito alla
connotazione esclusivamente oggettiva o in parte soggettiva (in
termini di duty of care) della diligenza dovuta (126).
Ciò su cui si registra, a prescindere dalle specifiche “componenti” della diligenza, una significativa convergenza, viceversa, è
l’idea della diligenza come standard (127), ossia come norma di
rinvio alle pratiche sociali o, più appropriatamente, professionali
diffusamente condivise.
Si è precisato come l’art. 2104 c.c., nel differenziarsi tanto dalla
nozione di regola puntuale, quanto da quella di principio giuridico
in senso proprio, non ponga un autonomo criterio di decisione,
bensì si configuri come estrinsecazione di una tecnica normativa di
reperimento di criteri di decisione: criteri ricavabili da regole
tecniche che “non sono, in sé, regole giuridiche ma appartengono a
campi diversi del sapere e delle relazioni intersoggettive, campi ai
quali l’ordinamento giuridico fa tuttavia riferimento per dare un
contenuto ad un suo precetto” (128).
In definitiva, si può osservare come la nozione di diligenza
conforme alla natura della prestazione dovuta venga, in effetti,
ricondotta ad una clausola generale nel senso qui proposto.
Di qui l’esigenza di individuare le fonti di tali regole tecniche,
cioè quei parametri di valutazione del comportamento diligente
che appaiano inequivocabilmente come provenienti dall’ambiente
(125) Si vedano, per le più recenti disamine critiche rivolte alle concezioni della
diligenza di stampo prettamente soggettivistico o volontarista, Viscomi, 1997, 133 ss.; Id.,
2010, spec. 615; Menegatti, 2012, 925. Sul rifiuto della concezione soggettiva della diligenza,
in giurisprudenza, si veda, da ultimo, Cass. 9 ottobre 2013, n., 22965.
(126) Oltre agli autori citati in precedenza, si vedano,in particolare, Mancini, 1957,
27 ss.; Magrini, 1973, 410; Grandi, 1987, spec. 341 ss.; Ghezzi, Romagnoli, 1995, 34;
Rusciano, 2000, 656 ss. e, anche per ulteriori e completi richiami bibliografici, Cester,
Mattarolo, 2007, spec. 108 ss.; De Simone, 2007, 281 ss.; Perulli, 1998, 596; Fiorillo, 2010, 515
ss.; Marazza, 2013, 272 ss.
(127) In questi termini, Viscomi, 1997, 137 ss.; Rusciano, 2000, 658; De Simone,
2007, 283.
(128) Ancora Viscomi, 1997, 145 e Cester, Mattarolo, 2007, 126 (dai quali è tratta
l’ultima citazione).
108
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sociale e professionale in cui lo standard di diligenza deve trovare
attuazione e che, al contempo, non lascino spazio a decisioni che,
dissolvendo il dovere di diligenza nel generico rinvio ad un coacervo di regole comportamentali estremamente vaghe, si risolvano in
una decisione molto prossima a una valutazione equitativa.
La soddisfazione di tale esigenza passa imprescindibilmente, si
osserva, per l’assunzione della contrattazione collettiva quale termine di riferimento per l’individuazione delle forme esemplari o
figure paradigmatiche di lavoratore diligente, al fine di azzerare o
ridurre il possibile margine di arbitrarietà delle decisioni giudiziali
attraverso il richiamo alle regole professionali applicate nel particolare settore interessato (129). In questa prospettiva, la contrattazione collettiva assume un peso determinante ai fini della ricostruzione delle ordinarie forme di estrinsecazione dell’agire sociale
e, conseguentemente, del significato della norma (130).
Se è vero che l’esperienza giurisprudenziale offre riscontri nella
maggior parte dei casi poco perspicui (131) e spesso contraddittori (132) a proposito della distinzione tra specifici doveri di
diligenza e generali contenuti dell’attività lavorativa, è possibile
evidenziare, viceversa, come la contrattazione collettiva offra alcuni significativi ed eloquenti esempi di determinazione di specifici
vincoli comportamentali prettamente riconducibili al dovere di
diligenza.
Ciò avviene, ad esempio, quando le parti sociali provvedono a
(129) Viscomi 1997, 148-151.
(130) Viscomi, 1997, 312 e Id., 2010, 640. Sulla qualificazione delle valutazioni
dell’autonomia collettiva come determinanti per la comprensione delle norme in materia di
lavoro, in quanto “espressione di quella coscienza sociale in corrispondenza della quale la legge
deve essere interpretata” si veda già Persiani, 1966, 240; più recentemente, per la riconducibilità della diligenza ad “una serie di prescrizioni concrete che sono solitamente contenute nei
contratti collettivi”, Ferraro, 2004, 128.
(131) In argomento cfr., ad es. Cass. 27 settembre 2000, n. 12769, RIDL, 2001, II,
446, con nota di Nadalet; Cass. 11 maggio, 1985, n. 2951, GC, 1986, I, 483 sull’inclusione nel
dovere di diligenza di comportamenti ulteriori rispetto a quelli connessi all’attività dovuta
come risultante dalle mansioni assegnate; Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1991, n. 11107.
(132) In totale contrasto con quanto asserito nel testo e in termini ictu oculi
difficilmente condivisibili, Trib. Perugia, 8 maggio 2012, tratta dal Repertorio di giurisprudenza de Le leggi d’Italia, secondo la quale le posizioni giuridiche discendenti dall’art. 2104
c.c. troverebbero la loro unica fonte nella legge, “restando pertanto irrilevante, al fine della
sua configurabilità, il grado di specificazione con cui tale concetto è recepito nella contrattazione
collettiva e nel codice disciplinare”.
109
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
definire standard di diligenza nell’espletamento delle mansioni (ad
es. in materia di rapporti con la clientela (133)) ovvero, in alcuni
casi, quando prevengono a definire specifici vincoli comportamentali non direttamente e/o necessariamente correlati con le
stesse (134).
È indubbio che la diligenza rimanga una nozione di fonte legale
e che il giudice sia autorizzato a isolarne ed applicarne caso per
caso il significato concreto, valutando in comportamenti del lavoratore in relazione ai contenuti della prestazione e al grado di
osservanza delle istruzioni del datore di lavoro (135).
Laddove i contenuti della diligenza siano, però, predefiniti o
puntualizzati dal contratto collettivo, tali indicazioni assumono un
valore normalmente considerato come dato di orientamento necessario e sufficiente ai fini della valutazione in sede giudiziale della
condotta del prestatore di lavoro, riconoscendosi le statuizioni
della contrattazione collettiva quali imprescindibili fonte di elementi chiarificatori e di esemplificazioni (136).
Anche dove tale predefinizione manchi, tuttavia, deve ritenersi che alla delimitazione dell’ambito della diligenza debba
ugualmente e necessariamente pervenirsi attraverso il rinvio a
specifici standard tecnici e sociali, ossia a “regole” di comporta(133) Può farsi l’esempio delle linee generali di condotta definite dal CCNL del
settore del credito (art. 25 del CCNL 17 febbraio 1983), la cui violazione “giustifica
l’irrogazione di una sanzione disciplinare, il comportamento di un lavoratore bancario che,
nell’espletamento della propria attività lavorativa, rifiuti di completare una operazione richiesta
da un cliente sul presupposto che l’orario di apertura dello sportello al pubblico era scaduto da
circa tre minuti” (Pret. Roma, 3 maggio 1991, NGL, 1993, 72).
(134) Ciò che si verifica, tra gli altri casi, nell’ipotei di individuazione di specifiche
regole comportamentali durante le assenze per malattia e non solamente in relazione
all’esigenza di un pronto recupero dell’efficienza psicofisica, ma anche con riferimento alla
conformità della condotta del lavoratore rispetto all’esercizio del potere di controllo da
parte dei medici pubblici. Nel senso che l’assenza alla visita domiciliare di controllo
costituisce un inadempimento disciplinarmente sanzionabile solo se previsto come tale dal
contratto collettivo, Cass. 9 agosto 1996, n. 7370, RIDL, 1997, II, 553; Cass. 14 luglio 1994,
n. 6597 e, in precedenza, Cass. 9 marzo 1987, n. 2452, FI, 1987, I, 3082.
(135) Cfr., tra le altre, Cass. 8 giugno 2001, n. 7819, ADL, 2003, 351, con nota di
Fiata; Cass. 27 maggio 1998, n. 5258; Cass. 13 dicembre 1995, n. 12758, RIDL, 1996, II, 530.
(136) Sulla attendibilità delle previsioni del contratto collettivo in merito alle conseguenze sul fronte disciplinare delle violazioni del dovere di diligenza, tra le altre, Cass.10
dicembre 2004, n. 23120; Cass. 11 novembre 2000, n. 14615; Cass. 14 luglio 2004, n. 6597 cit.;
Cass. 13 giugno 1984, n. 3521.
110
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
mento formatesi nell’ambito di sistemi esterni a quello legale, ma
in ogni caso attinte da un’esperienza sociale concretamente pertinente all’ambito professionale interessato e non genericamente
desumibili dalle dimensioni etiche e moralistiche della “buona
volontà” (137), svincolate da ogni specifica concretizzazione delle
stesse in un determinato “sotto-sistema” di regole sociali. Condizione, questa, invece imprescindibile per una realistica calcolabilità in via preventiva dell’impegno esigibile dal lavoratore.
Non si condivide, quindi, l’idea che il sindacato di legittimità
sul rispetto del dovere di diligenza e il conseguente bilanciamento
tra gli interessi economici e finanche morali delle stesse parti e degli
eventuali stakeholders possa risolversi (138) in un mero esercizio di
ponderazione del tutto interno alla sfera decisionale del giudice,
senza necessità di rapportare la fattispecie concreta a paradigmi
comportamentali espliciti ai fini della valutazione di rispondenza o
meno della condotta del lavoratore alle prassi specifiche del settore
o dell’azienda.
7.1. Diligenza, codici etici, “credo aziendali” e rapporti con gli
standard comportamentali ricavabili dalla contrattazione
collettiva.
Una sede nella quale la diligenza può andare incontro a ulteriori
tiva che appare destinata ad espandersi, nei codici etici, di cui le
imprese sono chiamate a dotarsi in relazione allo svolgimento di
determinate attività economiche (139) ovvero nell’ambito degli
adempimenti finalizzati a prevenire particolari forme di responsabilità (140).
A fronte della vivacità del dibattito sui livelli di vincolatività
(137) Evidenzia la distinzione, Viscomi, 2010, 638.
(138) Come ammettono, invece, tra le altre, Cass. 16 agosto 2004, n. 15932; Cass. 14
aprile 1994, n. 3497; Cass. 28 marzo 1992, n. 3485; Cass. 11 maggio 1985, n. 2551.
(139) Cfr. in tal senso l’art. 31, comma 3, lett. d ed e, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
di attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
(140) Ed è questa l’ipotesi dei codici etici adottati nell’ambito dei modelli di organizzazione e controllo previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quali condizioni per
l’esenzione delle imprese dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato. Sul punto, anche per ulteriori, ampi, richiami di dottrina, Bernasconi, 2008,
111
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dei codici etici e in particolare sulla loro idoneità ad operare quali
fonti di obbligazioni nei confronti dei diversi portatori di interessi
con i quali l’impresa intrattiene rapporti (141), è sufficientemente
pacifico e normalmente ribadito dagli stessi come tali codici definiscano una serie di vincoli comportamentali i quali arricchiscono
e puntualizzano i doveri del prestatore di lavoro, contribuendo a
delimitare l’area della responsabilità per inadempimento.
Conseguentemente, i codici etici appaiono investiti di una
funzione integrativa nel senso che, seguendo l’ordine di gerarchia
delle fonti (in senso sostanziale), il codice etico opera come una
puntualizzazione teleologicamente orientata dei doveri del prestatore di lavoro e come tale rappresenta un parametro per l’individuazione degli standard ricollegabili alla diligenza di cui all’art.
2104 c.c.
Dalla matrice normalmente unilaterale dei codici (di cui la
legge richiede l’imputabilità al soggetto imprenditoriale e perciò
solitamente adottati dai datori di lavoro — società di capitali con
delibera del consiglio di amministrazione, anche se non mancano
significative esperienze di coinvolgimento del sindacato (142)) discende, però, sul fronte degli obblighi imposti ai prestatori di
lavoro, la loro subalternità al contratto collettivo quale prima e
inderogabile sede di puntualizzazione dei doveri del lavoratori e di
delimitazione e procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali (143).
132 ss. nonché, in tema di linee guida per la definizione dei contenuti del codice etico,
Confindustria, 2008, 26 ss.; Abi, s.d., 22 ss.
(141) In argomento, da ultimo, Senigaglia, 2013, 73 ss.
(142) Esiste anche, come evidenza Del Punta, 2006, 49, un potenziale e consistente
spazio di intervento della contrattazione collettiva, come dimostrato da importanti esperienze pionieristiche come quella degli accordi Merloni del 2002. Per una ricognizione dei
codici di condotta / accordi quadro in materia di responsabilità sociale delle imprese cfr.
Lama, 2005.
(143) Nello stesso senso, con riferimento alle interrelazioni tra contrattazione collettiva e modelli di Corporate Social Responsibility, Ferrante, 2006, 95. Questo vincolo di
coerenza tra il codice etico e il contratto collettivo viene normalmente rimarcato sia dagli
interpreti sia dai codici stessi con riferimento, ad esempio, all’apparato sanzionatorio
connesso al rispetto dei codici, ossia al sistema disciplinare facente parte del modello di
organizzazione e di gestione di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 ma per chiare ragioni sistematiche
si estende sicuramente anche alla parte prescrittiva, oltre ad interessare quella punitiva. Si
v., con riferimento ai codici etici adottati in attuazione del d.lgs. n. 231 del 2001, Bernasconi,
2008, 152.
112
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Così come, in applicazione della previsione dell’art. 7, primo
comma, della legge n. 300 del 1970 si attribuisce al codice disciplinare aziendale la funzione di specificare le enunciazioni delle clausole del contratto collettivo in materia disciplinare, operanti quale
paradigma generale delle modalità e dei limiti di esercizio del
relativo potere, così i codici etici appaiono definibili, per la parte
dedicata alla condotta dei prestatori di lavoro, come versioni
teleologicamente orientate dei regolamenti aziendali (144).
Ancora più emblematica della necessità di chiari criteri di
selezione tra i diversi potenziali standards si rivela l’esperienza,
caratterizzata da un minor grado di diffusione, dei c.d. “credo”
aziendali che provvedono a definire, è stato detto, in termini
prossimi a quelli dei dettami religiosi, i sistemi valoriali ai quali
l’impresa dichiara di volersi ispirare in ogni suo contatto con la
società (145).
Al di là delle possibili interferenze con la garanzie di rispetto
della vita privata e delle opinioni del lavoratore riconosciute dalle
disposizioni costituzionali e statutarie (interferenze che risultano
connesse alla circostanza della “necessitata” condivisione dei “valori” aziendali da parte del prestatore di lavoro (146)), va evidenziato come non solo per la loro provenienza unilaterale ma anche
perché, al contempo, i “credo” si pongono come frutto di una
visione “atomistica” e fisiologicamente autoreferenziale dell’etica
d’impresa, accolta da una particolare e specifica componente sociale (ossia in quanto espressione della prospettiva di un singolo
soggetto, vale a dire della singola impresa), ai fini che qui interessano questi documenti non appaiono immediatamente assimilabili,
a differenza del contratto collettivo, al concetto di standard valutativo.
Questo soprattutto perché, diversamente da quest’ultimo, i
“credo” aziendali di per sé non rappresentano, in considerazione
(144) In ragione della loro provenienza e collocazione nel sistema delle fonti di
disciplina del rapporto di lavoro, pertanto, la funzione tanto precettiva quanto integrativa
del generale dovere di diligenza assolta da tali codici non può non esplicarsi in via subalterna
rispetto alla fonte collettiva, rispetto alla quale non è configurabile, come è stato anche
recentemente rimarcato in dottrina (Pedrazzoli, 2012), una sostituibilità o una modificabilità da parte del regolamento aziendale.
(145) Viscomi, 2010, 599; Di Toro, s.d.; Azzoni, 2003; D’Oronzo, 2006.
(146) Giustamente Viscomi, 2010, ult. loc. cit. parla di “espropriazione del consenso”.
113
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
del loro consueto processo genetico, il momento di sintesi del
confronto fra gli attori riconosciuti dall’ordinamento come interpreti della realtà sociale a cui le clausole generali, come più volte
ricordato, intendono rinviare.
Si tratta, diversamente, di testi che accolgono o fanno propri
unilateralmente e “dall’alto” determinati “valori” i quali, tuttavia,
non possono assurgere al rango di standard per il solo fatto di essere
accettati dall’impresa, circostanza di per sé — a ben vedere — del
tutto neutra. Questa visione, è stato detto, “aziendalmente identitaria” potrà influire sui contenuti della sfera debitoria sono
qualora esprimano o si richiamino a sociali condivise anche oltre i
confini dell’azienda, o meglio, dei suoi organi di vertice.
È possibile, in linea ipotetica, che dall’adesione individuale
“indotta” al “credo” aziendale discendano, quando siano puntualmente esplicitati, specifici vincoli comportamentali sostanzialmente analoghi a quelli dettati dai codici etici; vincoli che, in
ossequio al principio di inderogabilità del contratto collettivo da
parte degli accordi individuali, non potranno operare se non in
funzione integrativa degli obblighi previsti dal contratto collettivo.
In alternativa i “credo” aziendali, in quando atti unilaterali
pur accettati dal lavoratore saranno leggibili come adesione o
recepimento di determinate Weltanschauungen le quali, tuttavia,
potranno assumere rilevanza ai fini della concretizzazione della
clausola generale di diligenza solo se e nella misura in cui rispecchino modelli di comportamento socialmente — e non solo aziendalmente — considerati come dovuti, ossia legittimati dalla realtà
sociale esterna all’azienda e come tali recepiti e condivisi dall’impresa quali adeguati standard di responsabilità sociale corrispondenti al modello etico prescelto.
A differenza del contratto collettivo, pertanto, tali atti, a meno
che non siano concordati con le organizzazioni sindacali (con
l’obiettivo di una accettazione condivisa della necessaria considerazione di alcuni fattori socialmente rilevanti nell’adozione delle
decisioni aziendali (147)), non operano, di per sé stessi, come fonti
costitutive di determinati valori e relativi sistemi di valutazione,
potendo acquisire rilevanza giuridica, anche ai fini del rispetto
della regola di diligenza, in quanto si conformino a determinati e
(147) Lama, 2005, 100 s.
114
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
pressistenti standard, generalmente o largamente condivisi nel
mondo della produzione o nello specifico settore in cui opera
l’impresa datrice di lavoro (148).
8. Ius variandi e autonomia collettiva.
È certamente sul terreno dello ius variandi e, in particolare,
con riguardo alla clausola generale dell’equivalenza delle mansioni
che l’impostazione qui sperimentata può essere sottoposta ad un
più attento collaudo; a partire, appunto, dalla qualificazione della
stessa equivalenza come clausola generale, che viene da alcuni
interpreti esplicitamente riconosciuta (149) (così come, si vedrà, le
sue implicazioni in termini di rinvio ai dati di realtà sociale),
mentre appare da altri condivisa implicitamente, al di là del
riferimento espresso, quando se ne sottolinea la straordinaria flessibilità concettuale e l’attitudine ad adattarsi al mutare delle
esigenze del contesto di riferimento (150).
Con riferimento alle modalità ed ai canali attraverso i quali
tale attitudine interviene a dispiegarsi, la tensione dialettica tra
ricostruzioni teoriche, evoluzione della contrattazione collettiva e
interpretazioni giurisprudenziali continua tuttora ad essere oltremodo elevata, offrendo spesso l’immagine di una contrapposizione
un po’ manichea tra due apparentemente opposte concezioni attuative della previsione legale.
Vale a dire che sembrano continuare a fronteggiarsi un orientamento maggiormente incline al riconoscimento dell’insostituibile
attitudine del contratto collettivo a fornire regole di giudizio (151),
al quale fa da contraltare la diversa tendenza che antepone alle
(148) Nello stesso senso Viscomi, 2010, 646, il quale evidenzia come le statuizioni dei
“credo” aziendali di per sé non possono essere ritenute come descrittive di comportamenti
propri del buon debitore, dovendosi ricercare aliunde la giustificazione della loro rilevanza
nell’ambito del rapporto obbligatorio.
(149) Recentemente, in tal senso, Brollo, Vendramin, 2012, 540.
(150) Cfr., anche qui per la dottrina più recente, Gargiulo, 2008, 11 e 44; Zoli, 2014;
in precedenza, cfr. Giugni, G., 1975, 555; Liso, 1987, 54. Adattamento ai mutamenti del
quadro economico-sociale, detto per evidenziare il parallelismo, che nel contesto delle
letture del fenomeno delle clausole generali viene individuato come l’essenza teleologica del
ricorso del legislatore alle clausole generali (cfr., recentemente, Guarneri, 1999, 134).
(151) Sul punto, Nogler, l. 1997, 114.
115
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
classificazioni elaborate (o ri-elaborate, nel caso della c.d. “riclassificazione”) dal contratto collettivo il potere giudiziale di controllo
e di individuazione in via empirica di cosa debba intendersi con
l’espressione “mansioni equivalenti”.
Questa contrapposizione non appare risolvibile — e i risultati
di un dibattito più che quarantennale stanno lì a dimostrarlo —,
nell’ambito del raffronto tra posizioni miranti alla dimostrazione o,
all’opposto, alla confutazione della “vincolatività” delle previsioni
dei contratti collettivi in materia di inquadramento e (se esistenti)
delle clausole di fungibilità/equivalenza tra diverse mansioni; questo perché non appare revocabile in dubbio che la ratio di effettività (152) del limite di salvaguardia della professionalità fissato
dalla disposizione legale imponga il superamento delle possibili
contraddittorietà, ambiguità e carenze della concretizzazione attuativa della contrattazione collettiva.
Una trascendenza e una necessaria imperatività del dato legale
che si giustificano non solo in considerazione del dato testuale
offerto dalla previsione normativa in tema di nullità dei patti
contrari, ma anche — seguendo la tipologia della realtà — alla luce
della tutt’altro che puntuale, alle volte, inclinazione della contrattazione collettiva alla rigorosa delimitazione dell’equivalenza attraverso l’individuazione di specifici profili professionali (153).
Eppure è altrettanto pacifico e comunemente riconosciuto
come le qualifiche e le mansioni (similmente alla retribuzione)
configurino un’area nella quale la contrattazione collettiva vanta
una propria competenza istituzionale (154) ed appare per ciò
prioritariamente legittimata ad intervenire in funzione di concretizzazione dell’equivalenza così come definita, in termini ampi,
dalla previsione legale (155).
Del resto è bene rammentare come sia per prima la stessa
giurisprudenza a manifestare, in alcuni casi, una adesione, più che
compatta totalitaria, a questa idea di fondo, per lo meno in
relazione ad alcuni risvolti applicativi correlati all’art. 2103 c.c.
(152) Maresca, A., 1978, 423-4.
(153) Già Persiani, 1971, 14 e 18; Scarpelli, 1994, 50; Magnani, 2004, 169; Brollo,
Vendramin, 2012, 527-8.
(154) Miscione, 1987, 162.
(155) Bianchi D’Urso, 1987, 118.; in senso adesivo v. Liebman, 1993, 208 e Castelvetri, 1992, 86.
116
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Così accade ad esempio quando — accogliendo l’impostazione
c.d. “a doppia chiave” (156) che innesta una valutazione (che ci si
attenderebbe essere solo) di tipo qualitativo su un plafond di ordine
quantitativo — la giurisprudenza fa discendere automaticamente la
violazione dell’art. 2103 c.c. dall’inquadramento delle mansioni di
destinazione in un livello retributivo inferiore rispetto a quello
delle mansioni di provenienza (157); laddove tale conclusione non
sarebbe autorizzata da una valutazione dell’elemento della professionalità del tutto autonoma rispetto ai giudizi di valore retributivo espressi dall’autonomia collettiva, come si continua costantemente a rimarcare da parte della quasi totalità degli interpreti e,
univocamente, della giurisprudenza (158).
Ben più consistenti sono i contrasti e le incertezze affiorate a
fronte dell’evoluzione della negoziazione collettiva nel settore privato, la quale in alcune occasioni (159) ha avviato dinamiche di
“riclassamento” ovvero accorpamento di più livelli contrattuali in
aree di inquadramento più ampie, supportate da previsioni di
appositi meccanismi di fungibilità o rotazione (160).
Questa particolare modalità di esplicazione dell’attitudine
(156) Garilli, 1989, 176.
(157) Da ultimo v. Cass. 25 gennaio 2006, n. 1388, GL, 2006, 36; v. l’ulteriore
giurisprudenza citata da Pisani, 2009, 18-9; cfr. però Liso, 1982, 226 e Grandi, 1987, 267-8.
(158) Per le tesi, rimaste minoritarie, che hanno ritenuto di poter ancorare l’equivalenza alla parità di valore delle mansioni o della professionalità espressa attraverso l’esercizio delle attività in esse ricomprese, Persiani, 1971, 16-7; Pisani, 1988, 300 ss.; Id. 1996,
130-1.
(159) In questo senso già Scarpelli, 1994, 47.
(160) Tra gli esempi più significativi: artt. 43 e 46 del CCNL 26 novembre 1994 per
i dipendenti delle Poste Italiane, recante la clausola di fungibilità di mansioni equivalenti,
accordo del 23 maggio 1995 e art. 5 all. art. 24 del CCNL 1998-2002, nonché nota a verbale
art. 20 CCNL Gruppo Poste del 14 febbraio 2011; art. 4 del CCNL Industrie chimiche 19
marzo 1994, LI, 1994, 6, 47 ss., poi confermato nei rinnovi del 4 giugno 1998, 12 febbraio
2002, 10 maggio 2006, 18 giugno 2009 e 4 marzo 2013 (v. premessa all’articolo); artt. 36 e 37
CCNL per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. 6 febbraio 1998, ma v. poi l’art. 21
del CCNL del 16 aprile 2003 (oggi art. 27 del CCNL per il personale della mobilità del 20
luglio 2012); art. 75 CCNL per le aziende di credito del 11 luglio 1999, poi confermato negli
accordi del 12 febbraio 2005 e 8 dicembre 2007; art. 17 CCNL agenzie di assicurazione in
gestione libera del 4 febbraio 2011; art. 21 CCNL imprese del settore elettrico del 5 marzo
2010, da ridimensionare, però, alla luce delle constatazioni e del rinvio espressi dal rinnovo
del 18 febbraio 2013. A livello aziendale sono noti i contratti Zanussi del 10 dicembre 1993,
LI, 1994, 1, 77 ss.; Dalmine del 1998, LI, 1998, 21, 67 ss.; e più di recente l’accordo Fiat di
Pomigliano del 15 giugno 2010, RIDL, 2010, III, 329 ss.
117
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
della contrattazione collettiva all’integrazione del dettato legale ha
rappresentato l’occasione per il riconoscimento, da parte delle
Sezioni Unite, della legittimità delle clausole collettive che, per
“contingenti esigenze aziendali” e, quindi, entro un’ottica di temporaneità, consentono al datore di lavoro l’esercizio dello ius
variandi, indirizzando il lavoratore verso altre mansioni equivalenti contrattualmente, ma che in mancanza di tale giustificazione
organizzativa non sarebbero state considerate come tali (161).
In alternativa, le Sezioni unite della Cassazione — recependo le
proposte dottrinali (162) tese al riconoscimento della legittimità di
uno scambio tra formazione professionale e adibizione a mansioni
diverse dalle ultime svolte — hanno riconosciuto come legittima
quella che viene definita come una deroga al “livello minimo di
professionalità acquisita” sulla base di meccanismi di scambio,
avvicendamento o rotazione, ma per consentire la valorizzazione
della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in
quella qualifica (163). Una duplice operazione di adattamento (164) “travestita”, come non è insolito nelle letture giurisprudenziali dell’art. 2103 c.c., da deroga eccezionale, si potrebbe
dire in anticipazione della logica ispiratrice dell’art. 8, commi 2,
lett. b), e 2-bis, l. n. 148/2011 (165).
(161) Cass. S.U. 24 novembre 2006, n. 25033; Cass. 11 novembre 2009, n. 23877; Cass.
4 marzo 2014, n. 4989.
(162) Bianchi D’Urso, F., 1987, 132; Liso, F., 1987, 62-4; Treu, T., 1989, 35; Scarpelli,
F., 1994, 51.
(163) Cass S.U. 24 novembre 2006 n. 25033, cit.; Cass., ord. 31 ottobre 2011, n. 17956;
Cass. 10 settembre 2013, n. 20718.
(164) Secondo questa giurisprudenza, il giudice sarebbe autorizzato non soltanto a
valutare se l’inquadramento sia conforme al patrimonio di professionalità acquisito dal
lavoratore, ma anche di valutare se ricorrano esigenze aziendali che ne giustifichino la
sotto-utilizzazione verso mansioni diverse, se esse siano temporanee e contingenti, o ancora
di verificare se i meccanismi di formazione siano adeguati secondo la logica di scambio tra
“deroga” e “formazione”. A commento della svolta giurisprudenziale operata dalla sentenza
delle Sezioni Unite, Santoro-Passarelli, G., 2009a, 207, pone in secondo piano il collegamento con le contingenti esigenze aziendali, evidenziando come l’orientamento accolto dalla
Corte di Cassazione proceda decisamente nel senso del riconoscimento al contratto collettivo
“e non più al giudice” della competenza a definire l’equivalenza delle mansioni.
(165) Sul punto v. Brollo, 2012, 383 ss. e spec. 394 ss. In senso favorevole alle
rielaborazioni o riscritture dell’equivalenza da parte della contrattazione collettiva nella
direzione del suo ampliamento si esprime, altresì, Carinci, M.T., 2013, 228, puntualizzando
come, tuttavia, questo incremento della flessibilità funzionale dovrebbe essere orientato “in
una necessaria prospettiva di temporaneità”. L’idea è condivisa da Sciarra, 2013, 289.
118
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Attraverso questo percorso tutto sommato obliquo la giurisprudenza di legittimità ha finito con il confermare, in sostanza,
come la salvaguardia di “quel complesso di capacità e di attitudini
che viene definito con il termine professionalità” si esplichi, in
condizioni di normalità sociale, nella concretizzazione della disciplina delle mansioni operata dall’autonomia collettiva.
È noto, del resto, come alla base del rapporto tra nozione legale
e collettiva dell’equivalenza si collochino le problematiche interpretative circa la nozione di professionalità da tutelare.
Esclusa la configurabilità di un obbligo di formazione del
lavoratore (166), è indubbio come oggi l’interpretazione si ponga in
termini più delicati anche in ragione della più rapida evoluzione
tecnologico-organizzativa dell’impresa e dei profili ivi operanti (167).
Così, all’orientamento consolidato che riferisce l’art. 2103 c.c.
alla protezione del complesso di capacità e competenze acquisite
dal lavoratore, è seguita l’attribuzione di rilievo alla “storia professionale” del lavoratore o alla “perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate” da questi sino al mutamento delle
mansioni (168), fino a considerare rilevanti, nella c.d. prospettiva
“dinamica”, il potenziale arricchimento del bagaglio di conoscenze
ed esperienze (169) o il mantenimento delle occasioni di crescita
professionale (170) del prestatore di lavoro.
A monte di queste formulazioni, tuttavia, non può non collocarsi la generale consapevolezza del fatto che i contenuti e l’intensità della protezione legale, in quanto destinati a ricevere la loro
concretizzazione all’interno di un determinato contesto professionale caratterizzato da determinati assetti di interessi e tempo per
tempo influenzato da una pluralità di fattori evolutivi, non possono essere dissociati dai significati che alle stesse espressioni
(prime fra tutte “equivalenza” e “professionalità”) vengono asse(166) Cfr. Romagnoli, 1972, 185; ma si vedano, di recente, le ricostruzioni di Guarriello, 2000, sul punto 218 e di Alessi, 2004, spec. 140 ss.
(167) Pisani 2009, 446.
(168) Rispettivamente, Cass. 10 dicembre 2009, n. 25897 e Cass. 4 marzo 2014, n.
4989.
(169) Cass. 2 ottobre 2002, n. 14150; Cass. S.U. 24 novembre 2006, n. 25033; Cass. 23
luglio 2007 n. 16190; Cass. 5 aprile 2007, n. 8596; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25897, cit.
(170) Cass. 29 settembre 2008, n. 2493.
119
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
gnati nelle sedi più idonee a rappresentare il punto di sintesi di tali
interessi (171).
Così delineate le linee applicative di fondo, si comprende come
la locuzione “mansioni equivalenti” si presti, ad essere messa a
fuoco come “una formula aperta, suscettibile di specificazioni tramite
l’autonomia collettiva, secondo la vocazione storica di quest’ultima ad
integrare le clausole generali di estrazione legale ed anzi sarebbe lecito
supporre che tale formulazione generica sia stata adottata di proposito
nella consapevolezza che sarebbe spettata all’organizzazione sindacale
la funzione di tradurre in concretezza quella genericità sulla scorta
delle peculiarità inerenti alle singole realtà produttive” (172).
Di conseguenza, e ricollegandosi a considerazioni già svolte
(cfr. il precedente paragrafo n. 6), va condivisa l’idea che “la
determinazione contrattuale dell’area di fungibilità delle mansioni
dovrebbe avere la stessa forza di resistenza della determinazione contrattuale della retribuzione ex art. 36 Cost.” (173).
Si può, cioè convenire sul fatto che tale determinazione, in
ragione della sua provenienza dal sub-sistema sociale maggiormente attendibile rinvenibile nell’ambito professionale di riferimento, sia assistita da una presunzione di conformità alla legge; nel
senso che, come già puntualizzato da Grandi, una valutazione
giudiziale che si distacchi dalle previsioni del contratto collettivo
presuppone o un vuoto di disciplina da parte del contratto medesimo ovvero dovrà essere necessariamente motivata “sulla base di
altri dati di fatto oggettivi, desunti dall’esperienza tecnica del lavoro o
da altre variabili organizzative e ambientali” (174).
(171) Di qui la conseguenza, sulla quale convengono molti interpreti, che il giudizio
di equivalenza debba essere sempre “fondato su dati di tipicità ambientale registrati e valutati,
con maggiore consapevolezza, dalla contrattazione collettiva la quale, pertanto, è in grado di
formulare appropriati giudizi in ordine al valore di certe prestazioni, di operare la loro
modificazione e addirittura di creare nuove figure professionali alla luce dei dati emergenti dai
concreti assetti produttivi” e si riveli, di fatto, lo strumento più idoneo a individuare i fattori
di affinità qualitativa tra mansioni relative a diverse posizioni: Bianchi D’Urso, 1987,
130-32; nello stesso senso Ghera, 1984, 396-7; Liebman, 1993, 209; Cfr. anche Brollo, 1997,
162, Carabelli, 2004, 59 e Magnani, 2004, 172; Liso, 1982, 178 e v. Id., 1987, 63.
(172) Bianchi D’Urso, ult. loc. cit., e in senso adesivo Liebman, 1993, 209-10. A
sostegno di una nozione convenzionale di equivalenza anche Ichino, 2005, 506 e Pedrazzoli,
1990, 559.
(173) Magnani, 2004, 179.
(174) Grandi, 1986, 267.
120
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
In questa prospettiva, le clausole del contratto collettivo dalle
quali si arriva a desumere o sulla base delle quali è possibile
argomentare, certo con diversi gradi di immediatezza e di evidenza
testuale, la fungibilità tra diverse mansioni collocate nello stesso
livello o area professionale rappresentano il dato sociale presuntivamente idoneo a fungere da regola di giudizio per la soluzione
delle eventuali controversie. Un dato la cui conformità alla clausola generale dell’equivalenza potrà essere, sì, contestata, ma solo
deducendo, con onere a carico di chi sollevi tale contestazione,
elementi di valutazione ulteriori e diversi e comunque anch’essi
ricavati dalla realtà sociale e non esclusivamente ascrivibili all’attività valutativa del giudice.
Elementi di valutazione, quindi, “altri” e diversi rispetto al
contratto collettivo, ma comunque espliciti, oggettivi e controllabili: si pensi, a titolo di esempio, al raffronto con i programmi di
studio per il conseguimento del titolo professionale necessario per
lo svolgimento delle mansioni di provenienza in rapporto ai contenuti delle nuove, ovvero alla valutazione circa il possesso delle
conoscenze tecniche per l’utilizzo di determinati programmi o
macchinari, come individuati dal produttore o dal fornitore; per
non parlare, ma è invero l’ipotesi meno problematica, delle certificazioni di competenze o altre attestazioni conseguite a seguito
della partecipazione ad attività formative realizzate o promosse
dal datore di lavoro.
Tutti elementi, questi, che assecondano la connessione tra il
contenuto della norma e una visione della professionalità non
circoscritta all’angusto e per certi versi claustrofobico perimetro
della “storia professionale individuale” ripercorsa in sede giudiziale, bensì orientata verso una visione dinamicamente rivolta
verso il contesto organizzativo (175).
Il potenziale margine di “scollamento” tra la ratio della norma
e la sua applicazione giudiziale non sembra, quindi annidarsi
nell’eventualità di un controllo giurisdizionale in materia di equivalenza — anche diretto alla verifica del rispetto di questo requisito da parte del contratto collettivo — quanto piuttosto nelle
(175) Una dinamicità, si badi intesa non nel senso, respinto dall’interpretazione
maggioritaria, di un diritto alla progressione professionale, bensì come riflesso dell’evoluzione organizzativa e come riposizionamento dei confini dell’obbligazione lavorativa in
termini coerenti con tale evoluzione: sul punto, in particolare, Carabelli, 2004, spec. 59 ss.
121
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
letture “monistiche” o “personalizzate” dell’equivalenza stessa,
svincolate da ogni altro richiamo agli elementi e ai dati oggettivi
che secondo le pratiche sociali osservate nel contesto professionale
e socio-economico di riferimento ne confermerebbero o ne confuterebbero la sussistenza.
In sintonia con la lettura di questa disposizione in chiave di
rinvio, pur teleologicamente orientato, ai dati di realtà sociale, si
comprende come le letture critiche più consapevoli non si siano
appuntate direttamente sui rischi di autoreferenziale reinterpretazione del requisito dell’equivalenza quanto, piuttosto, sull’intrinseca contraddittorietà di possibili declinazioni giudiziali in senso
involutivo o comunque di cristallizzazione di una nozione logicamente e fisiologicamente dinamica (176); una dinamicità che non
opera, peraltro, solamente sul versante delle innovazioni organizzative interne all’azienda ma dipende da una molteplicità di fattori
anche più generali, come i cambiamenti introdotti nei sistemi di
istruzione e formazione professionale e l’ampliamento dei corredi
di “competenze” il cui possesso si dà per acquisito ai fini dell’accesso a determinate posizioni professionali.
8.1. Equivalenza delle mansioni e lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni.
L’attitudine del contratto collettivo a definire esaustivamente
l’equivalenza professionale trova riscontro nell’art. 52, comma 1,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo risultante dalle numerose
modifiche subite da questa norma, dapprima, dalla c.d. seconda
privatizzazione del lavoro pubblico e, successivamente, ad opera
dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Sono note le questioni interpretative connesse a tale previsione
legislativa, così come è stato fatto oggetto di un ampio dibattito
l’accoglimento ormai generalizzato, da parte della più recente
giurisprudenza di legittimità, della tesi della c.d. equivalenza for(176) Ed in questo senso appare attuali l’analisi critica di Carinci, 1985, 228, laddove
sottolineava il pericolo che l’applicazione dell’art. 2103 c.c. rimanesse eccessivamente
attestata sul fronte del garantismo individuale “costruito a misura di un dato assetto
organizzativo e di un dato quadro economico-sociale”. Nello stesso senso anche le considerazioni di Treu, 1989, 35 e di Proia, 1990, 158 ss.
122
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
male (177); tesi secondo la quale nell’area del lavoro pubblico il
contratto collettivo costituirebbe la fonte esclusiva dell’equivalenza delle mansioni e non autorizzerebbe un intervento giudiziale
che si orienti in senso diverso rispetto alle previsioni del contratto
collettivo in nome ed in applicazione di un concetto legale di
equivalenza svincolato dalle stesse previsioni contrattuali, né,
tanto meno, alla stregua di un giudizio condotto sulla base di una
valutazione soggettiva della professionalità posseduta dal dipendente pubblico.
Pur nella consapevolezza dell’ampiezza complessiva di questa
tematica, il tratto che qui ci si può limitare a porre in evidenza è
individuabile nella generale premessa interpretativa secondo la
quale la formulazione di questa previsione legislativa non è leggibile come una mera variante linguistica dell’art. 2103 c.c.
È stato affermato, coerentemente con tale esigenza ermeneutica come, nella logica dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, che “l’equivalenza tra le mansioni non si presta ad essere rappresentata come la
risultanza di un accertamento in concreto, ex post, condotto sulla base
di parametri — soggettivi e oggettivi — riferibili all’esecuzione della
prestazione lavorativa essendo, invece, affidata al sistema di inquadramento professionale la sua definizione esplicita nel contesto dell’area di inquadramento del lavoratore”; di qui il convincimento che
“il perimetro dell’equivalenza vada in ogni caso delineato dalla contrattazione collettiva...con l’auspicio che i contratti collettivi siano più
puntuali nel definire coerentemente gli ambiti dell’equivalenza professionale...abbandonando il ricorso a formule equivoche e insignificanti, non di rado meramente ripetitive del dettato legislativo” (178).
Ne discende che, in coerenza con lo specifico assetto delle fonti
regolato dall’art. 2 del d.lgs. 165 del 2001, l’art. 52 attribuisce alla
contrattazione collettiva, anche nella versione odierna del disposto
legislativo (179), una piena riserva di competenza in materia di
(177) Sull’affermazione di questa tesi, da ultimo, Mezzacapo, 2014, 2581 ss. Tra le
molte pronunce in tal senso, Cass. S.U. 29 maggio 2012, n. 8520, GC, 2012, I, 2460; Cass. 5
agosto 2010, n. 18283, LPA, 2010, II, 710; Cass. 11 maggio 2010, n. 11405; Cass. 21 maggio
2009, n. 11835, FI, 2010, I, 1, 78; Cass. S.U. 4 aprile 2008, n. 8740, ibidem, 2008, I, 2534. Per
una valutazione complessiva di tale orientamento giurisprudenziale si veda Viscomi, 2013,
83 s.
(178) Esposito, 2010, 171 s.
(179) In tal senso, tra gli altri, Ferrante, 2011, 1338; criticamente, Vendramin, 2009,
1035 ss. e, soprattutto, Viscomi, 2013, 64 il quale osserva che “l’equivalenza è ora affermata
123
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
equivalenza (180), che riflette quella più generale in materia di
regolamentazione del rapporto di lavoro operata nei confronti del
contratto collettivo dal comma 1 dell’art. 40.
Rispetto all’esercizio di tale competenza, l’eventuale intervento giudiziale si configura come avente funzione integrativa
delle possibili carenze o lacune della regolamentazione di fonte
collettiva, nella logica dell’art. 1419, secondo comma, c.c. (oggi
richiamata anche dall’art. 2, comma 3-bis del d.lgs. n. 165 del
2001) (181).
A maggior ragione, quindi, un controllo giudiziale sulle clausole collettive alla luce di un preteso generale e sovrastante concetto legale di equivalenza (182) si risolverebbe in un sostanziale
ribaltamento di questo assetto di fonti; laddove, piuttosto, solo in
presenza di dati ed elementi oggettivi ed esterni che attestino
l’inidoneità professionale del dipendente pubblico allo svolgimento
delle nuove e diverse mansioni (183) potrebbe risultare ammissibile
come caratteristica assoluta, sciolta cioè da ogni valutazione formalmente operata dalla contrattazione collettiva, potendosi così aprire un varco alla valutazione sostanziale, non diversamente
che nel settore privato”; rimane tuttavia da comprendere, accedendo a questa tesi, quali siano
allora le differenziazioni sostanziali correlate alle due diverse enunciazioni legislative, quella
contenuta nella norma codicistica e quella dettata dealla disposizione speciale in materia di
lavoro pubblico.
(180) Come già puntualizzato, in precedenza, tra le altre, da Trib. Milano, 27 marzo
2002, LG, 2003, 90.
(181) Nel senso della possibile censura di nullità del contratto individuale per
indeterminatezza dell’oggetto in presenza di declaratorie contrattuali e di clausole di
fungibilità professionale eccessivamente generiche, Gargiulo, 2008, 86 s.
(182) Per esempi in tal senso cfr., tra le altre, Trib. Milano, 11 dicembre 2007, LG,
2008, 537; Trib. Trieste, 8 febbraio 2002, LG, 2003, 465.
(183) Cfr. in tal senso Trib. Ravenna 9 aprile 2002, Risorse Umane, 2004, 3, 168 (e in
Repertorio di giurisprudenza de Le leggi d’Italia online) secondo la quale “l’art. 52 del d.lgs.
n. 165 del 2001 dispone che il lavoratore dipendente di pubbliche amministrazioni deve essere
adibito alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale
prevista dai contratti collettivi; a differenza dell’art. 2103 c.c., quindi, tale norma non riferisce
il giudizio di equivalenza, secondo i principi generali, alle mansioni da ultimo effettivamente
svolte ma rinvia alle espresse previsioni in materia della contratta-zione collettiva, che acquista
pertanto un ruolo decisivo in materia. Pertanto, la pubblica amministrazione datrice di lavoro
può legittimamente adibire il lavoratore a tutte le mansioni dichiarate equivalenti dal contratto
collettivo in quanto ricomprese nella stessa categoria contrattuale di inquadramento. Il giudice
potrà sindacare l’operato della pubblica amministrazione soltanto con riferimento all’onere di
mettere in grado il lavoratore di procurarsi i titoli professionali o abilitativi eventualmente
necessari allo svolgimento delle nuove mansioni richieste”.
124
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
un intervento integrativo che circoscriva in maniera più puntuale
l’ambito dello ius variandi del datore di lavoro pubblico rispetto a
previsioni eccessivamente generiche dei contratti collettivi.
8.2. Mobilità geografica e ragioni giustificative del trasferimento.
Un’ultima considerazione in materia di ius variandi riguarda il
tema della mobilità geografica; si potrebbe essere indotti, data
l’estrema prossimità delle formulazioni testuali, che il richiamo alle
ragioni tecniche, organizzative e produttive, così come in altri
contesti normativi, precluda all’interprete e al giudice qualunque
spazio di valutazione fondato su schemi etici o sistemi valoriali,
così come è per altre fattispecie nelle quali l’esercizio dei poteri
datoriali è condizionato alla sussistenza di presupposti affini,
prima fra tutte l’ipotesi del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo.
L’assimilazione di queste diverse fattispecie (pur nella diversità di rationes) è senz’altro giustificata, ma non assoluta. Questo
perché tra le ragioni giustificative del trasferimento possono rientrare anche motivazioni di natura etico-comportamentale.
Da questo punto di vista, la tematica del trasferimento connesso a determinate valutazioni etiche assume rilevanza in relazione ai profili del trasferimento come sanzione disciplinare e,
soprattutto, della contigua figura del mutamento della sede di
lavoro conseguente a problematiche relazionali, normalmente qualificato, per affinità con le previsioni normative contrattuali relative a diverse categorie di pubblici dipendenti, come trasferimento
per incompatibilità ambientale (184).
Questi due particolari versanti della mobilità geografica, normalmente ma non necessariamente alternativi tra loro (185), dal
(184) Sulla legittimità del trasferimento disposto in conseguenza di tensioni e
contrasti insorti tra il lavoratore trasferito ed i colleghi, Cass. 5 novembre 2013, n. 24775
(con riferimento al trasferimento di lavoratore disabile in deroga all’art. 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104); Cass. 13 maggio 2013, n. 11414, LG, 2013, 738; Cass. 10
marzo 2006, n. 5320, FI, 2007, I, 1588; Cass. 9 marzo 2001, n. 3525; Trib. Agrigento, 20
marzo 2001, RCDL, 2001, 691; Cass. 16 aprile 1992, n. 4655, RIDL, 1993, II, 571, con nota
di Proia.
(185) Ma si veda, per una possibile commistione generata da situazioni nelle quali la
Cassazione ha riconosciuto da che un fatto disciplinarmente rilevante e sanzionato come tale
125
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
punto di vista delle possibili interrelazioni con l’autonomia collettiva rinviano a forme e tecniche di intervento alquanto dissimili.
Con riferimento alla tematica del trasferimento per motivi
disciplinari può parlarsi di un intervento di integrazione della
clausola generale da parte del contratto collettivo conseguente,
tuttavia, al mutato fondamento giuridico del trasferimento, non
più rinvenibile nell’art. 2103 bensì nell’art. 2106 c.c. (186), sebbene
tale “trasmigrazione” dall’area dello ius variandi a quella delle
sanzioni disciplinari continui a scontare le obiezioni di quella
dottrina che la qualifica come uno sconfinamento rispetto ai limiti
legali della competenza riconosciuta all’autonomia collettiva, che
non si estenderebbe alla facoltà di introdurre nell’apparato sanzionatorio misure punitive idonee a determinare mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro (187).
Con riferimento, viceversa, alle situazioni nelle quali il trasferimento costituisce la risposta organizzativa ad una situazione di
disfunzione organizzativa correlata alla presenza di un lavoratore
in una determinata unità produttiva e al deterioramento di determinati rapporti interpersonali, è innegabile che si tratti di fattispecie difficilmente tipizzabili a priori.
Ciò a maggior ragione se si conviene (188) che in questo caso i
comportamenti idonei ad integrare le ragioni del trasferimento non
siano riconducibili all’inadempimento (anche perché in questo caso
si ricadrebbe nella fattispecie disciplinare), potendo concretizzarsi
in condotte, pur non qualificabili né in ogni caso rilevanti come
inadempimento, che possano divenire fonte di disagio interpersopossa altresì scaturire una ragione tecnica, organizzativa o produttiva che può legittimare
il trasferimento, Cass. 1 settembre 2003, n. 12735, MGL, 2004, 91; Cass. 21 ottobre 1997, n.
10333, NGL, 1997, 761; Cass. 16 giugno 1987, n. 5339.
(186) Per la tesi di matrice giurisprudenziale che condiziona la legittimità del
trasferimento per motivi disciplinari all’inclusione dello stesso nei codici disciplinari incorporati nei contratti collettivi, Cass. 21 novembre 1990, n. 11233, GC, 1991, I, 583; Cass. 28
settembre 1995, n. 10252, GI, 1996, I, 1, 730, con nota di Marazza.
(187) In questo senso, tra gli altri, Brollo, 1997, 552 ss.; Angiello, 2012, 725; contra,
nel senso della legittimità del trasferimento disciplinare, Proia, 1993, 577; Levi, 2000, 138;
Liso, 1982, 282.
(188) In dissenso con alcune posizioni dottrinali. in particolare, cfr. Vallebona, 1987,
78; Carinci, M.T., 2005, 57.
126
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
nale e, conseguentemente, di potenziale disfunzionalità organizzativa (189).
Di conseguenza, in questi casi, tanto — e soprattutto — la
valutazione della fondatezza delle ragioni (al di là della loro scontata non interferenza con i limiti esterni posti dalle norme antidiscriminatorie), quanto la valutazione della giustificatezza della
specifica misura organizzativa del trasferimento adottata nei confronti di quel determinato prestatore di lavoro, dovranno essere
condotte con riferimento a canoni di accettabilità sociale e saranno
suscettibili di un controllo giudiziale diretto alla verifica della
rispondenza tra le motivazioni addotte e la decisione di procedere
al trasferimento (190).
Stante il carattere fortemente empirico delle situazioni di
incompatibilità ambientale, si deve riconoscere che con riferimento
a questa ipotesi non appare immaginabile un intervento dell’autonomia collettiva quale possibile fonte di standard valutativi.
Piuttosto e in alternativa, le forme di intervento dell’autonomia collettiva che appaiono maggiormente appropriate ai fini della
prevenzione e della composizione delle controversie vanno individuate nelle garanzie di tipo procedurale, introdotte in alcuni
contratti collettivi (191) e la cui finalità, diversamente dalle ipotesi
che sono state sin qui esaminate, non è quella di prefigurare un
riempimento di significato della clausola generale, bensì di assecondare il controllo sulla sua applicazione.
Un controllo che si svolge simultaneamente sul duplice piano
del controllo sociale (anche attraverso l’eventuale intervento dei
rappresentanti sindacali), sia del controllo tecnico-giuridico sulla
sussistenza del requisito di legittimità del trasferimento, al cui
compimento sono finalizzati gli obblighi strumentali che impongono
al datore di lavoro di esaminare le eventuali obiezioni e contestazioni del lavoratore e di esplicitare le ragioni della decisione finale
attraverso un provvedimento motivato.
(189) Ammette questa eventualità, da ultimo, Angiello, 2012, 726; in precedenza,
nello stesso senso, Calà, 1999, 221.
(190) Si veda Cass. 23 febbraio 2007, n. 4265, LG, 2007, 1028 la quale puntualizza
come non sia necessario che la scelta del datore di lavoro presenti i caratteri dell’inevitabilità, “essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle tra le scelte ragionevoli che il
datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo”.
(191) Per una panoramica, Brollo, 1997, 600 ss.
127
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
In questo caso l’intervento dell’autonomia collettiva non risponde, quindi, all’esigenza di integrazione della clausola generale
bensì (in possibile raccordo con gli obblighi di correttezza e buona
fede nell’esercizio dei poteri imprenditoriali) ad una esigenza di
carattere gestionale anche finalizzata alla composizione dei possibili conflitti, con l’imposizione alle parti dell’onere di esplicitare le
rispettive posizioni anche in considerazione di un possibile accertamento giudiziale.
9. Inadempimento, potere disciplinare, licenziamento.
Sebbene sia riscontriavile un’evidente analogia strutturale con
le previsioni legislative sinora prese in considerazione — con riferimento alle quali, come è stato osservato nei precedenti paragrafi,
parte della dottrina manifesta minori riserve rispetto alla loro
possibile qualificazione come clausole generali, talvolta anzi sostenendola apertamente — la tematica dell’inadempimento disciplinarmente sanzionabile e, in particolare, dell’inadempimento gravissimo o notevole e per ciò rientrante nelle fattispecie risolutorie
della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, rappresenta l’ambito entro il quale rimane più acceso il confronto
tanto sulla qualificazione come clausole generali delle previsioni di
legge che definiscono le condizioni di legittimità del recesso, quanto
sulla rilevanza delle previsioni dei contratti collettivi nell’ambito
del controllo giudiziale sulla legittimità della sanzione, conservativa o espulsiva.
Un dibattito, questo, all’interno del quale sono stati immessi
alcuni nuovi, significativi elementi a seguito delle innovazioni
legislative del 2010 e del 2012, che proprio in tema di rapporti tra
potere disciplinare e potere di licenziamento, da un lato, e tipizzazione delle ipotesi di esercizio di tali poteri, dall’altro, hanno
operato delle puntualizzazioni di cui appare necessario valutare la
rilevanza sistematica. Aggiustamenti che, potrebbe dirsi, interessano trasversalmente l’intero complesso normativo che include le
previsioni legislative in materia di sanzioni disciplinari, a partire
dall’art. 2106 c.c., per giungere all’apparato sanzionatorio definito
dal nuovo testo dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, con
particolare riguardo al suo quarto comma.
In particolare, quello del licenziamento “ontologicamente”
128
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
disciplinare è un ambito tematico entro il quale le interrelazioni tra
clausole generali e i sottosistemi regolativi rappresentati dalle
previsioni dei contratti collettivi in materia di sanzioni disciplinari
e di licenziamento, oltre ad infittirsi, sono andate assumendo una
rilevanza normativa sempre più marcata.
Il nucleo centrale ed il principale snodo problematico di questo
collegamento trovano, oggi, i loro punti di emersione, innanzitutto,
nel richiamo alle “tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo
presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi” formulato nell’art. 30, comma 3,
della legge 4 novembre 2010, n. 183; richiamo a cui oggi si ricollega
— con qualche discontinuità logica che non esime, tuttavia, l’interprete dal perseguire l’obiettivo di coordinamento sistematico
tra i due enunciati —, l’altro e complementare riferimento rivolto
nell’art. 18, quarto comma, agli illeciti disciplinari non sanzionabili
con il licenziamento perché rientranti “tra le condotte punibili con
una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” formulato nell’ambito della nuova disciplina sanzionatoria del licenziamento
illegittimo.
È stato già ricordato (nel paragrafo n. 4) come la materia dei
licenziamenti per mancanze del lavoratore rappresenti il terreno
sul quale la dicotomia tra clausole generali e norme elastiche viene
più frequentemente evocata. Stante l’impossibilità e del resto
in’inopportunità di un riepilogo, anche sommario, della sterminata
letteratura in tema di licenziamenti, è sufficiente rammentare
come buona parte della dottrina sia orientata (non senza eccezioni)
a ritenere che la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo non
costituiscano delle clausole generali in senso tecnico ma, piuttosto,
delle norme elastiche/vaghe (192), laddove la giurisprudenza di
legittimità oscilla fra il ricorso alla categoria delle clausole generali (193) e quella delle norme elastiche (194).
Al di là di queste oscillazioni, che per quanto riguarda il
versante giudiziale non sempre corrispondono ad una precisa e
coerente opzione classificatoria e spesso tradiscono, in realtà, un uso
(192)
(193)
(194)
Tra gli altri, Mengoni, 1986, 9; Ballestrero, 1991, 104; Nogler, 2007, 651.
Ad esempio, si veda Cass. 29 aprile 2004, n. 8254.
Fra tante, Cass. 12 agosto 2009, n. 18247.
129
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
atecnico e sinonimico delle differenti qualificazioni (195), la stessa
giurisprudenza si esprime con riferimento alla sostanza del dato legislativo evidenziando come la giusta causa e il giustificato motivo
soggettivo siano “disposizioni di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa,
mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza
generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama” (196); e in ogni caso il primo di questi “fattori esterni” considerati quali espressioni della coscienza sociale viene rinvenuto proprio nello standard offerto dalla disciplina collettiva (197) che
esprime delle valutazioni che rispondono a canoni di normalità (198).
Al contempo, viene frequentemente puntualizzato (199) che
“nella valutazione del presupposto della giusta causa di licenziamento, il giudice non è vincolato dalla eventuale previsione del contratto collettivo applicato, dovendo conformarsi, esclusivamente, alla
nozione legale recata dall’art. 2119 c.c.” (200).
Questa linea interpretativa si spinge, a volte, più innanzi, nella
direzione di una forte relativizzazione del “peso” di tali clausole ai
fini del “riempimento di senso” delle espressioni generali utilizzate
dal legislatore.
Siffatta relativizzazione si combina, poi, con una omologazione
di strumenti e tecniche interpretative, in realtà, assai eterogenei. Si
afferma che le tipizzazioni collettive di g.c. e di g.m.s. hanno una
valenza meramente esemplificativa e non tassativa (201), potendo
il giudice discostarsi dalle regole di fonte collettiva sia quando le
ritenga, già in astratto, espressione di una sanzione eccessiva
(195) Come dimostrano emblematicamente quelle pronunce che qualificano la giusta
causa come clausola generale e, al tempo stesso, come norma elastica. Cfr: Cass. 13 dicembre
2010, n. 25144; Cass. 22 aprile 2000, n. 5299; Cass. 15 aprile 2005, n. 7838; Cass. 4 dicembre
2002, n. 17208, secondo le quali “l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito
nell’applicare le clausole generali come quella dell’art. 2119 c.c., che, in tema di licenziamento
per giusta causa, detta una tipica « norma elastica », non sfugge ad una verifica in sede di
giudizio di legittimità”.
(196) Cass. 2 marzo 2011, n. 5095.
(197) Cass. 19 agosto 2004, n. 16260; Cass. 22 dicembre 2006, n. 27452.
(198) Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906.
(199) Cass. 10 agosto 2006, n. 18144, OGL, 2006, I, 880.
(200) Ciò in quanto, si prosegue, “non può essere consentito all’autonomia privata,
individuale o collettiva, di introdurre ipotesi estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse da quelle tassativamente fissate dal legislatore”: Cass. 18 ottobre 2006, n. 22342.
(201) Cass. 18 novembre 2009, n. 24329.
130
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
rispetto alla gravità della mancanza (202). Laddove, al contrario,
solo le previsioni collettive che prevedano sanzioni conservative
sarebbero, in quest’ottica, vincolanti per il giudice, in quanto
espressione di una norma di miglior favore per il lavoratore (ossia
l’art. 12 della legge n. 604 del 1966).
Un’ulteriore manifestazione di questo approccio più spiccatamente relativista nei confronti delle tipizzazioni operate dal contratto collettivo si riscontra nelle pronunce secondo le quali l’applicazione delle norme elastiche può essere censurata in sede di
legittimità ex art. 360 n. 3, c.p.c. “nei casi in cui gli standards
valutativi sulla cui base è stata definita la controversia finiscano per
collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva
o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti standards
valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la
costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di
generalità assunta, come diritto vivente” (203).
È certo indiscutibile che gli standards promananti da un subsistema sociale, sinanche derivanti dall’esercizio di una competenza costituzionalmente riconosciuta dall’ordinamento come
quelli offerti dal contratto collettivo, debbano conformarsi ai principi legali sovraordinati — nei limiti in cui si ritenga che tali
principi possano tradursi in comandi direttamente applicabili nei
rapporti tra privati — nonché agli altri limiti esterni puntualmente
definiti dal legislatore (come quelli, esemplari, promananti dalla
normativa in materia di contrasto alle discriminazioni) ed oggi
richiamati in forma aggregata dal primo comma del “nuovo” art.
18 della legge n. 300 del 1970.
Più ambiguo e sfuggente, in questa giurisprudenza, il richiamo
alle “regole di diritto vivente” che riceverebbero la loro legittimazione
in forza di una “costante e pacifica applicazione giurisprudenziale”.
Appare ancor più difficile ritenere in linea con l’idea di clausola
generale e del correlato standard valutativo l’ipotesi che il giudice
possa provvedere alla sua concretizzazione in termini diversi rispetto alla tipizzazione operata dal contratto collettivo mediante un
empirico ed estemporaneo “bilanciamento” dei contrapporti inte(202)
2010, 237.
(203)
Ballestrero, 2012, 799; Carinci, M. T., 2011, 797; Niccolai, 2008, 98; Pellacani,
Tra le molte pronunce in tal senso, Cass. 17 agosto 2004, n. 16037, cit.
131
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ressi costituzionalmente tutelati, normalmente formulato in forma
“discorsiva” e non supportato da elementi oggettivi e controllabili
ulteriori rispetto alla mera sequenzialità logica della motivazione (204).
Diversa è l’ampiezza del margine di valutazione giudiziale nel
caso in cui il licenziamento sia intimato in conseguenza di una condotta non contemplata dal contratto collettivo (205), sebbene anche
in questo caso dovrebbe considerarsi coerente con la ratio della
norma che la valutazione giudiziale sia compiuta attraverso la ricerca degli standard etico-comportamentali più appropriati (anche
ad esempio attraverso un riscontro sulla percezione di determinati
comportamenti nel contesto imprenditoriale di riferimento) e non di
un’operazione di “libero” ed empirico bilanciamento tra i contrapposti interessi e i relativi referenti di ordine costituzionale.
Per converso e quanto concerne la clausola generale di proporzionalità contenuta nell’art. 2106 c.c. con riguardo alle sanzioni
disciplinari di tipo conservativo, l’impostazione che assegna al
contratto collettivo la funzione di specificazione dei comportamenti disciplinarmente illeciti e delle relative sanzioni ha trovato
una stabile conferma nella concreta applicazione dell’istituto.
Ciò anche in considerazione del fatto che nella lettura adeguata
al quadro normativo odierno, il richiamo contenuto nella previsione del codice civile, alle norme corporative va riferito (come
confermato oggi dal quarto comma dell’art. 18 riformulato dalla
legge n. 92 del 2012) alla contrattazione collettiva di diritto comune (206), autorizzata dall’art. 7, primo comma, della legge n.
300 del 1970 ad individuare i comportamenti disciplinarmente
rilevanti e le relative sanzioni (207).
L’operatività congiunta di queste due componenti del medesimo complesso normativo (art. 2106 c.c. e art. 7 St. Lav.), come è
stato rimarcato anche di recente, “implica la identificazione, ad
(204) Per applicazioni recenti del metodo del bilanciamento degli interessi cfr. Cass.
28 agosto 2013, n. 19834; Cass., 25 giugno 2013, n. 15926, cit.; Cass. 2 novembre 2005, n.
21213, cit.; Cass. 9 settembre 2003, n. 13194.
(205) Sul punto cfr. Carinci, M.T., 2011, ult. loc. cit.; Niccolai, 2008, 99. Cass. 18
febbraio 2011, n. 4060, Cass. 9 luglio 2007, n. 15334, Cass. 16 marzo 2004, n. 5372.
(206) Mainardi, 2002, 116; e si veda già Assanti, 1964, 7 e ss.; Amoroso, 2014, 951.
(207) Con riferimento ad alcuni spunti di superamento della distinzione tra sanzioni
conservative e sanzioni estintive ai fini del loro inserimento nel codice disciplinare, da
ultimo, Del Conte, 2012, 833 s.
132
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
opera dell’autonomia collettiva, in via esemplificativa e ragionevolmente circostanziata, delle condotte e dei fatti rilevanti come
inosservanza/inadempimento/infrazione, non già per la loro considerazione in sé, ma per la loro valutazione, appunto, in termini di
graduazione della gravità e per la commisurazione della sanzione da
applicare, secondo una scelta di valorizzazione delle clausole generali...una attività di specificazione che risulta intimamente e funzionalmente connessa con l’esercizio del potere organizzativo e che incorpora
un significativo grado di soggettività, solo contenuto dalla esistenza a
monte di divieti legali specifici ...il cui apprezzamento è bilateralmente effettuabile in sede contrattuale collettiva” (208).
Nonostante la natura anch’essa sanzionatoria del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo determinato da gravi mancanze del lavoratore, con riferimento al licenziamento disciplinare il quadro delle opinioni e degli orientamenti
appare estremamente più frastagliato. A partire dalla stessa applicabilità al licenziamento disciplinare dell’art. 2106 c.c., data per
pacifica da alcuni interpreti (209) ed energicamente respinta da
altri (salvo, poi, puntualizzare che il licenziamento rimane comunque soggetto ad un giudizio di proporzionalità (210)).
L’incidenza della clausola generale di proporzionalità sulla
valutazione di legittimità del licenziamento poteva già risultare
corroborata, come già accennato, dalla copiosissima giurisprudenza che ha riconosciuto, anteriormente alla riforma del 2012,
l’illegittimità del licenziamento disciplinare nell’ipotesi in cui il
contratto collettivo prevedesse una sanzione meramente conservativa per il medesimo comportamento addebitato al lavoratore (211). Constatazione che aveva indotto un’attenta dottrina a
(208) Sandulli, 2013, 348.
(209) Recentemente, in tal senso, Ballestrero, 2013, 51; Carinci, F., 2013, 43; Tremolada, 2013, 111.
(210) O, per meglio dire, di adeguatezza in ragione dell’interpretazione conforme al
principio dell’extrema ratio dell’art. 3 della legge n. 603 del 1996. Così Nogler, 2007, 628.
(211) Cfr., tra le altre, Cass. 7 novembre 2011, n. 23063, NGC, 2012, 489; Cass. 17
giugno 2011, n. 13353, la quale puntualizza come “deve escludersi che, ove un determinato
comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento,
sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui
corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave
valutazione ad opera del giudice”; Cass. 20 marzo 2007, n. 6621, NGC, 2007, 1225, nel
condividere questo principio di diritto, ha, tuttavia, soggiunto che “per escludere che il
133
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
leggere tale orientamento come indice di una forza vincolante, sia
pur indiretta, del contratto collettivo nei confronti del giudice (212).
La previsione dell’art. 18 St. lav., quarto comma, nel nuovo
testo, recepisce questo principio di diritto conferendogli ora il
valore di regola legale, in quanto stabilisce che ogni qual volta il
fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dal
contratto collettivo o dal codice disciplinare applicabile il giudice è
tenuto a recepire il giudizio di minore gravità espresso dalla
tipizzazione operata da tali fonti e a disporre la reintegrazione con
tutela risarcitoria attenuata (213).
Occorre puntualizzare che le previsioni richiamate dal quarto
comma, secondo una prima opzione interpretativa (214), devono
essere sufficientemente specifiche e tali da consentire alle parti di
poter preventivamente apprezzare l’insufficiente gravità del fatto,
con la sostanziale esclusione — anche alla luce dell’eliminazione,
nel testo definitivo approvato dalla Camere, del riferimento alle
“previsioni di legge” (215) — di ogni valutazione giudiziale della
proporzionalità ex art. 2106 c.c. ai fini dell’individuazione della
sanzione applicabile.
Secondo una diversa lettura (216), proposta da chi pone in
rilievo che il quarto comma richiama il contratto collettivo in
giudice possa discostarsi dalla previsione del CCNL, è necessario che vi sia integrale coincidenza
tra la fattispecie contrattualmente prevista e quella effettivamente realizzata, restando per contro
una diversa e più grave valutazione possibile e doverosa quando la condotta del lavoratore sia
caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei ed aggravanti rispetto alla fattispecie contrattuale”;
Cass. 29 settembre 2005, n. 19053. Sul punto, per la dottrina più recente, si veda Del Conte,
M., 2012, 848.
(212) Napoli, 1993, 91.
(213) Fra i commenti sull’art. 18, St. Lav., come modificato dalla legge n. 92 del 2012
vedi, tra gli altri, Tremolada, 2013, 107 ss.; Carinci, F., 2013; Maresca, 2012, 415 ss.;
Marazza, 2012c, 612 ss.; Vallebona, 2012; Pisani, 2012a, 741; Speziale, 2012.
(214) Vallebona, 2012, 57-8; Tremolada, 2013, 126, secondo il quale le disposizioni
disciplinari devono soddisfare “un requisito di specificità ‘qualificata’, cioè tale da consentire
al datore di lavoro di rappresentarsi agevolmente, senza dover compiere particolari valutazioni,
che il tipo di mancanza commessa dal lavoratore poteva essere punita esclusivamente con una
sanzione conservativa”. Marazza, 2012c, 624, che esclude l’applicabilità del quarto comma
quando le disposizioni disciplinari sono stabilite definendo separati elenchi per le mancanze
e per le sanzioni che possono essere irrogate.
(215) Eliminazione auspicata da Maresca, 2012, 445 ss. e poi valutata positivamente
da Tremolada, 2013, 124 ss.
(216) Speziale, 2012, 35 ss.; Carinci, F., 2013, 44 ss.
134
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
generale e dunque tutte le previsioni disciplinari — incluse quelle
non puntuali — l’eliminazione del riferimento alle previsioni di
legge non consente di escludere che il giudice debba comunque
svolgere una valutazione di proporzionalità sulla base dell’art.
2106 c.c. Anche coloro che accedono a questa interpretazione
riconoscono, tuttavia, che il nuovo quarto comma accentua la
rilevanza della valutazione di gravità del fatto espressa dal contratto collettivo (217).
Per converso, l’onere di predeterminazione tassativa delle infrazioni connesse alle sanzioni di carattere estintivo, ineludibile
con riguardo alle sanzioni conservative, è sempre stato escluso
dalla giurisprudenza; ciò normalmente con riguardo, quanto meno,
alle condotte contrarie alla comune etica o del comune vivere civile
(riconducibilità che, per le motivazioni già accennate, il giudice è
tenuto di volta in volta a motivare, non potendo fari riferimento
esclusivamente a generici e astratti “cataloghi” di “principi”) (218); anche se non mancano pronunce (219) che, più radicalmente, si sono espresse nel senso dell’assoluta inesistenza di tale
onere con generale riferimento a tutte le sanzioni di carattere
espulsivo, “atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate analoghe condotte, punibili con il recesso, nella
pattuizione collettiva, il potere di licenziamento è attribuito direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni che ne integrino la giusta
causa o il giustificato motivo”. Una conclusione che, alla luce della
novità legislativa intervenuta nel 2010, deve essere necessariamente sottoposta a revisione.
9.1.
Licenziamento e “tipizzazioni” di fonte collettiva
Nei numerosissimi commenti all’art. 30, comma 3 del “colle(217) In particolare Speziale, 2012, 35, osserva come “il giudizio di proporzionalità,
dunque, è confermato come elemento essenziale dell’accertamento del giudice, seppure delegato ad
atti esterni, contrattuali o unilateralmente disposti dal datore di lavoro”.
(218) Per tutte, esemplificativamente, Cass. 16 marzo 2004, n. 5372, LG, 2004, 995;
Cass. 1 settembre 2003, n. 12735, MGL, 2004, 91.
(219) In questi termini, Cass. 10 novembre 2004, n. 21378. A tal proposito, ancora
Napoli, 1993, 87, rilevava come, nonostante quanto statuito dalla Corte costituzionale con
la sentenza 30 novembre 1982, n. 204, l’estensione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 al
licenziamento abbia riguardato, in realtà, i soli commi secondo e terzo e non anche il primo.
135
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
gato lavoro”, la maggior parte degli interpreti (220) si sono espressi
nel senso della sua nulla o scarsissima incidenza rispetto ad un asseritamente consolidato panorama giurisprudenziale in tema di rapporti tra le fattispecie legali di giusta causa e giustificato motivo
soggettivo e le ipotesi predefinite dai contratti collettivi; si è osservato, per lo più, come l’espressione “tiene conto” appaia troppo prudente (221) e blanda (222) per consentire un superamento della regola dell’inderogabilità in pejus della disciplina legale dei licenziamenti. In questa prospettiva si è ritenuto che l’art. 30 comma 3
possa, a tutto concedere, imporre un rigoroso onere di motivazione
al giudice che voglia discostarsi dalla tipizzazione collettiva (223).
Nonostante l’indubbio realismo che accomuna queste ricostruzioni, è innegabile che una lettura della previsione legislativa che
perviene al risultato di assegnarle un significato meramente confermativo di costruzioni giuridiche preesistenti e generalmente
accettate non può non suscitare un senso di insoddisfazione.
Né, del resto, l’espressione “tiene conto” va letta necessariamente nell’accezione così debole (224) che è stata pressoché generalmente avallata.
Le considerazioni espresse da chi ha osservato come la disposizione del “collegato lavoro” non possegga un carattere innovativo prendono a riferimento le sentenze che, come è stato ricordato,
identificano nel contratto collettivo il principale standard valutativo (225), puntualizzando, al contempo, che quand’anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come
giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice
dovrebbe comunque valutare l’effettiva gravità del comportamento, tenendo conto del caso concreto e della portata soggettiva
della condotta (226).
(220) Fra i commenti che hanno preceduto e seguito la legge n. 183 del 2010 si vedano
Ferraro, 2009; Ballestrero, M.V., 2009; Vallebona, 2010; De Angelis, 2010; Tiraboschi, 2010;
Pellacani, 2010; Zoli, 2011; Carinci, M.T., 2011; Nogler, 2011; Pisani, 2012b; Perulli, 2014.
(221) Pellacani, 2010, 243.
(222) Carinci, M.T., 2011, 797.
(223) Vedi, tra gli altri, Zoli, 2011, 839-840; Pellacani, 2010, 243-244.
(224) Utilizza questo aggettivo Del Punta, 475.
(225) Cfr. le già citate Cass., 25 giugno 2013, n. 15926; Cass., 22 dicembre 2006, n.
27452; Cass. 22 aprile 2000, n. 5299.
(226) Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095; Cass.24 ottobre 2000, n. 13983; Cass. 16 febbraio
1998, n. 1604.
136
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Qualora non siano riscontrabili, tuttavia, specifiche circostanze
“attenuanti” e la fattispecie concreta sia completamente sussumibile nella previsione del contratto collettivo, alcuni interventi del
giudice di legittimità si orientano con maggiore decisione nel senso
che “la specifica previsione contrattuale di un illecito disciplinare, con
la corrispondente sanzione, impedisce al giudice di sostituire le proprie
valutazioni a quelle dell’autonomia privata, individuale o collettiva,
salvo il controllo sulla nullità ex art. 1418 c.c. ...più precisamente,
quando la clausola generale di licenziamento venga definitiva, ossia
specificata, attraverso la volontà negoziale, il giudice è tenuto ad uniformarsi alla definizione contrattuale, salva l’ipotesi che questa permetta il licenziamento arbitrario o discriminatorio” (227).
Non vi è però, come si è visto, un’assoluta convergenza di
opinioni e di orientamenti giurisprudenziali in questo senso. Si
incontrano pronunce che relegano la previsione comminatoria del
licenziamento disciplinare contenuta nel contratto collettivo al
rango di mera esemplificazione e si esprimono nel senso della
pratica inammissibilità di una vera e propria tipizzazione, quando
statuiscono che “la contrattazione collettiva è nulla e, perciò, inapplicabile, per contrasto con norme imperative dello stato tutte le volte in
cui essa preveda una ipotesi automatica di sanzione disciplinare
conservativa o espulsiva che prescinda dalla valutazione della sua
proporzionalità rispetto all’infrazione commessa dal lavoratore sia
sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo” (228).
Queste pronunce rivelano uno scenario, quindi, in cui la valutazione empirica di “proporzionalità” compiuta a posteriori sul
caso concreto finisce per assumere un peso largamente preponderante rispetto alla qualificazione di determinati comportamenti
quali giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento
da parte del contratto collettivo.
In un panorama così nebuloso interviene il legislatore dettando, con l’art. 30, comma 3, una norma che, per la prima volta,
riconosce espressamente al contratto collettivo la competenza a
“tipizzare” ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, compe(227) Cass. 1 aprile 2003, n. 4932 e nello stesso senso Cass. 8 aprile 1991, n. 3681; Cass.
15 dicembre 1989, n. 5645.
(228) Cass. 27 settembre 2002, n. 14041, ma si veda anche Cass. 2 novembre 2005, n.
21213.
137
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tenza già riconosciuta dalla legge n. 300 del 1970 con riferimento
alle sanzioni aventi carattere conservativo.
È possibile osservare che questo riconoscimento può essere letto
in connessione con l’idea di fondo, ampiamente condivisa — e si
potrebbe dire implicita nel riconoscimento della centralità dell’art.
2106 c.c. nella ricostruzione del potere disciplinare (229) — della
riconducibilità all’inadempimento e dunque, al contratto, dell’esercizio del potere disciplinare (230). In ragione di tale riconducibilità
e sino ad ora con riferimento alla tematica delle sanzioni di tipo
conservativo, si riconosce che il binomio infrazione disciplinare/
sanzione disciplinare, governato dal criterio della proporzionalità
sancito dall’art. 2106 c.c., presuppone sempre un inadempimento in
senso tecnico agli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (231).
Ciò induce a prendere atto che l’accertamento del rilievo
disciplinare di un determinato fatto o comportamento, affidato
dagli artt. 2106 c.c. e 7 comma 1, della legge n. 300 del 1970 ai
contratti collettivi (232), oltre alla funzione di specificare le conseguenze dell’inadempimento e prioritariamente rispetto all’assolvimento di tale funzione, ha la funzione di delimitare l’area del
debito di prestazione del lavoratore (233), cristallizzando l’insieme
di regole generali di condotta, e tra queste quelle attinenti la
“esecuzione e la disciplina del lavoro” (234), che il lavoratore deve
osservare per adempiere correttamente alla propria obbligazione (235). Ciò che contribuisce a spiegare perché, tradizionalmente, il tema della valutazione giudiziale di proporzionalità non
abbia interessato le previsioni dei contratti collettivi in materia di
illeciti punibili con sanzioni di tipo conservativo.
(229) Sottolineata, da ultimo, da Carinci, F., 2012, 43.
(230) Tra gli altri, Montuschi, 1973, 17 ss., nonostante le conclusioni critiche cui
perviene: 154 ss; Spagnuolo Vigorita, 2011, 818.
(231) Mainardi, S., 2002, 115 e ss. Molto significativa, ai fini che qui interessano, ossia
con riferimento al licenziamento, appare la puntualizzazione di Napoli, M., 1980, 159, il
quale sottolinea come “per la legittima utilizzazione di uno strumento contrattuale, quale è il
recesso, è possibile addurre, in quanto notevoli, inadempimenti che, ove non notevoli, darebbero
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari”. In argomento cfr. anche, recentemente,
Cester, Mattarolo, 2007, 246 ss.
(232) Del Punta, 1991, 90 ss.
(233) Chieco, 1996, 219.
(234) Montuschi, 1973, 163; Spagnuolo Vigorita, Ferraro, 1975, 167.
(235) Montuschi, 1991, 13.
138
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Ne discende che le clausole del contratto collettivo che contengono l’elencazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti (le
infrazioni) e delle relative sanzioni, incluse espressamente, oggi, le
“tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo” richiamate dall’art.
30, comma 3, si muovono tutte, senza distinzione fra sanzioni conservative ed espulsive, sul piano degli artt. 2106 c.c. e 7 St. Lav., nel
senso che tali elencazioni hanno la funzione di delimitare l’area del
debito di prestazione e, al tempo stesso, di esprimere dei giudizi
sintetici di gravità degli inadempimenti del lavoratore ai quali consegue l’individuazione delle sanzioni che andranno applicate; sanzioni che, secondo la graduazione insita nel principio di proporzionalità, andranno da quelle più lievi, per gli inadempimenti di scarsa
importanza, a quelle più gravi, per gli inadempimenti di maggior
importanza, fino ad arrivare, in caso di notevole o gravissimo inadempimento, al licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
In questa prospettiva si potrebbe ritenere che la previsione dell’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010 riconosca la competenza del contratto collettivo in materia di tipizzazione dei comportamenti sanzionabili con il licenziamento in quanto tale tipizzazione esprime, in applicazone degli artt. 2106 c.c. e 7 St. Lav., un
giudizio di gravità dell’inadempimento che delimita ex ante le aree
del debito di prestazione e del gravissimo (e del notevole) inadempimento.
Un riconoscimento che opera, è necessario puntualizzare,
senza incidere sull’assetto e sulla gerarchia delle fonti ma che ha il
più circoscritto significato, per tornare su un terreno più prossimo
al tema qui affrontato, di rimarcare, questo sì inderogabilmente, la
priorità della valutazione compiuta dal contratto collettivo (236)
nella determinazione della gravità dell’inadempimento (237).
(236) Tremolada, 2011, 176-178. In senso assai prossimo alla lettura qui tratteggiata
Carinci, M.T., 2011, 797, secondo la quale “si tratta di una norma che non limita i poteri del
giudice e non modifica le nozioni di giusta causa e giustificato motivo soggettivo invalse nel
diritto vivente, ma conferma ancora una volta l’orientamento giurisprudenziale dominante - si
potrebbe aggiungere, dominante ma non incontrastato — che legge le nozioni legali come
clausole generali ed utilizza i contratti collettivi come standard sociali di riferimento”.
(237) Occorre specificare che la norma, riferendosi in generale alle tipizzazioni di
“giustificato motivo”, non preclude all’autonomia collettiva di intervenire anche con
riferimento alle ipotesi di giustificato motivo oggettivo. Un esempio in tal senso è offerto dal
contratto collettivo per le agenzie di somministrazione di lavoro, che ha previsto all’art. 23
bis una procedura di confronto sindacale e un periodo di riqualificazione per i lavoratori
139
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Questo riconoscimento, è necessario soggiungere, non preclude
il controllo della previsione sanzionatoria tanto — ed è pacifico —
dal punto di vista del possibile contrasto con i limiti esterni,
quanto anche dal punto di vista della proporzionalità ma piuttosto, potrebbe dirsi, da un lato àncora questo controllo alla necessità
di elementi oggettivi, dall’altro, potrebbe aggiungersi, lo contestualizza, ossia lo riconduce all’interno del complessivo “sistema
disciplinare” (ossia dell’insieme delle sanzioni conservative e di
quelle estintive) definito dal contratto collettivo, come può essere
denominato prendendo a prestito la terminologia adottata nella
normativa in materia di responsabilità amministrativa delle imprese (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
Con ciò si vuol dire che, anche in coerenza con il canone
interpretativo dell’art. 1363 c.c., il giudice potrà valutare, nel
giudizio sulla legittimità del licenziamento, se il comportamento
per il quale è prevista dal contratto collettivo la sanzione espulsiva
appaia caratterizzato dalla gravità estrema o notevole che caratterizza le fattispecie contemplate dagli artt. 2119 c.c. e 3 della legge
n. 604 del 1966; e ciò anche in rapporto alla gravità degli illeciti per
i quali lo stesso contratto collettivo prevede la comminazione di
sanzioni di carattere conservativo (238).
Così come rimane in ogni caso rimessa al giudice, con riferimento alla fattispecie concreta, la valutazione circa la sua concreta
sussumibilità nella fattispecie astratta tipizzata dal contratto colassunti a tempo indeterminato per i quali si riscontri la mancanza di occasioni di lavoro. Nel
caso in cui al termine di tale periodo il lavoratore non sia comunque occupabile, la
previsione contrattuale autorizza l’intimazione del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo. La giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 29 luglio 2011, inedita per quanto
consta; ma si v. il breve commento su Il Sole 24 Ore del 17 agosto 2011) si è espressa, pur
senza richiamare l’art. 30 della legge n. 183 del 2010, nel senso che l’avvenuto adempimento
degli obblighi contrattuali e la permanenza dello stato di mancata occupazione valgono a
dimostrare la sussistenza delle obiettive carenze di mercato e, dunque, del giustificato
motivo di licenziamento. Conviene sulla “tipizzabilità” di ipotesi di giustificato motivo
oggettivo Zoli, 2011, 838.
(238) Del resto, anche il nuovo art. 18 comma 4, da tale punto di vista, sembra porsi
in linea con l’art. 30 comma 3 e entrambe le disposizioni, nonostante le tante diversità,
evidenziate da Carinci, F., 2013, 42 ss., sembrano segnalare una tendenza legislativa nella
quale la valutazione di proporzionalità sintetizzata nel giudizio di gravità espresso dalla
previsione collettiva assume un peso sempre più crescente rispetto alla valutazione empirica
di “proporzionalità” compiuta a posteriori sul “caso concreto” ai sensi dell’art. 2106 c.c. (e
si veda ancora, sul punto, Id., 2013, 44).
140
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
lettivo (239), cioè quando in sede di accertamento di fatto emerga
che non vi è una precisa coincidenza, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo sia sotto il profilo di quello oggettivo, fra la
previsione contrattuale che dispone la sanzione espulsiva e l’infrazione oggetto di addebito (240).
In alternativa potrebbe accadere che, a fronte di un’astratta
rispondenza del fatto contestato alla fattispecie sanzionata dal
contratto collettivo, venga accertata l’esistenza di standard o
schemi comportamentali differenti, normalmente risultanti dalla
prassi (241), i quali, sempre in coerenza con la dinamica di concretizzazione delle clausole generali che impone al giudice di attingere
dalla realtà sociale gli elementi che permettono di riempire di
contenuto il precetto legale (in questo caso quelli relativi al gravissimo o notevole inadempimento) e di escludere, in una simile
ipotesi, la configurabilità dell’inadempimento o di ridurne la gravità.
Residua, in questo quadro, il coordinamento del richiamo alle
tipizzazioni presenti nei contratti collettivi con il riferimento a
quelle ipoteticamente previste nei contratti individuali stipulati
con l’assistenza e la consulenza delle Commissioni di certificazione
dei contratti di lavoro. L’art. 30, comma 3, infatti, sembrerebbe a
prima vista riconoscere all’autonomia privata individuale certificata la stessa competenza riconosciuta a quella collettiva manife(239) Il che, in fondo, è quanto sembra sostenere la stessa giurisprudenza di legittimità quando, da una parte, rimarca il carattere non vincolante delle esemplificazioni
collettive di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e poi,
dall’altra, soggiunge che il giudice può però discostarsi dalla valutazione del contratto
collettivo solo “in considerazione delle circostanze concrete” che hanno caratterizzato il
comportamento del lavoratore. Tra le molte decisioni in tal senso Cass. 18 febbraio 2011, n.
4060 ed ancor più esemplarmente, Cass. 2 novembre 2005, n. 21213, cit. sulla non equiparabilità all’“assenza ingiustificata” (punita dal contratto collettivo, in caso di reiterazione,
con il licenziamento) del mero ritardo nella fornitura delle giustificazioni.
(240) Tremolada, 2011, 178, secondo il quale l’uso dell’espressione “tiene conto” si
spiega non già in ragione della non vincolatività della tipizzazione collettiva, bensì in
ragione della necessità che il giudice provveda alla valutazione di tutti gli aspetti della
fattispecie concreta (intensità della colpa, esistenza di attenuanti o cause esimenti) che
potrebbero condurre a ritenere ingiustificato un licenziamento astrattamente riconducibile
all’ipotesi tipizzata dal contratto collettivo.
(241) In tal senso, ad es., Trib. Firenze, 26 settembre 2008, FIR, 2009, voce Lavoro
[rapporto], n. 1113.
141
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
stata dai sindacati comparativamente più rappresentativi (242).
Tuttavia, se si considera, da una parte, che gli artt. 2106 c.c. e 7 St.
Lav. riconoscono al contratto collettivo la competenza in materia
disciplinare, e, dall’altra, che l’art. 30, comma 3, deve essere letto
in combinato disposto con le disposizioni ultime richiamate, va
escluso che i contratti certificati possano legittimamente modificare in senso peggiorativo le tipizzazioni definite dal contratto
collettivo, potendosi limitare a recepirle ovvero a prevedere un
trattamento di miglior favore per il lavoratore (243).
Il diverso ruolo assegnato al contratto collettivo e ai contratti
individuali certificati sembra aver trovato, peraltro, una ulteriore
conferma nella previsione dell’art. 18 St. lav., quarto comma,
nuovo testo (244), nella quale si fa richiamo, ai fini dell’applicazione della tutela reale attenuata, unicamente alle previsioni “dei
contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.
10. Autonomia collettiva e clausole generali (in senso atecnico) nella
legislazione in materia di lavoro flessibile: contratto di lavoro a
tempo determinato e somministrazione di lavoro a termine.
Nelle fattispecie normative sinora prese in considerazione, la
ricostruzione del rapporto tra le previsioni legislative contenenti
clausole generali ed il contratto collettivo si delinea nei termini di
una relazione tra un precetto necessariamente, fisiologicamente,
bisognoso di integrazione valutativa e il contratto collettivo quale
sottosistema regolativo più di ogni altro idoneo, per competenza
istituzionale e attinenza specifica, a completarne il significato.
In alternativa, la legislazione in materia di forme flessibili di
lavoro subordinato offre notoriamente un campionario di differenti
soluzioni tecniche e di differenti rapporti funzionali tra legge e
contratto collettivo, a volte sperimentati dal legislatore in successione diacronica con riferimento ai medesimi istituti.
(242) Così per Tremolada, 2011, 179-180.
(243) Carinci, M.T., 2011, 796; Pellacani, 2010, 245; Zoli, C., 2011, 840. Contra,
Tremolada, 2011, 180, che sembra attribuire alle tipizzazioni del contratto individuale
certificato lo stesso valore di quelle contenute nel contratto collettivo stipulato dai sindacati
comparativamente più rappresentativi.
(244) V. sul punto, criticamente, Cester, 2012, 571.
142
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Occorre rilevare che non sempre, anzi raramente, le disposizioni legislative contenenti un rinvio al contratto collettivo in
materia di forme di impiego flessibile presentano quella connotazione di fisiologica incompletezza e di apertura ai sistemi valoriali
sub legislativi che è stata sin qui assunta come tratto saliente delle
clausole generali.
Imprescindibile, a tal proposito, il richiamo all’istituto del
contratto di lavoro a tempo determinato ed in particolare alla
condizione di legittimità dell’apposizione del termine, nella sequenza di passaggi che, prima dell’ultima tappa rappresentata dal
d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014 n.
78, ha visto avvicendarsi dapprima il sistema improntato alla
tipizzazione legislativa per causali specifiche e tassative, quali
quelle della legge 18 aprile 1962, n. 230, successivamente affiancato
ed assorbito dal conferimento della c.d. delega in bianco alla
contrattazione collettiva (245) e sostituito, a partire dal 2001, dalla
generale condizione giustificativa delle “ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo” richieste dall’art. 1, comma
1, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Analoga generale condizione giustificativa riferita alle “ragioni
di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo” come è
noto era richiesta, prima delle modifiche apportate recentemente
dal d.l. 20 marzo 2014 n. 34 all’art. 20, comma 4, d.lgs. 20
settembre 2003 n. 276 e all’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2001,
anche per il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
Si è progressivamente consumato, in questo modo, nelle due
principali forme di impiego temporaneo, il superamento della
flessibilità negoziata che aveva caratterizzato la stagione legislativa
dei due decenni precedenti attribuendo all’autonomia collettiva
un’indispensabile funzione di controllo qualitativo della flessibilità (246).
Della condizione di giustificazione del termine introdotta nel
2001 sono state proposte numerose differenti definizioni: da quella,
(245) In merito alla quale cfr. Cass. S.U. 2 marzo 2006, n. 4588, ADL, 2006, 1649;
Cass. civ. [ord.], 16 novembre 2010, n. 23119.
(246) Da ultimo, sugli spazi di intervento dell’autonomia collettiva in materia di
regolazione dei rapporti di lavoro tempo determinato v. Alvino, 2013, 35.
143
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
inizialmente più ricorrente, di clausola generale (247) o clausola
generica (248), alle diverse qualificazioni quale norma generale (249), fattispecie generale (250), norma aperta (251), fattispecie
aperta a un numero indeterminato di ipotesi (252). Definizioni,
queste ultime, maggiormente appropriate in quanto, indipendentemente dal venir meno di un rinvio esplicito al contratto collettivo in funzione integrativa e/o specificativa del disposto legale, le
previsioni legislative del 2001 sul contratto a termine e del 2003
sulla somministrazione a termine venivano certamente a configurarsi quali fattispecie pur generali, ma caratterizzate da completezza ed autosufficienza, come tale non bisognose di integrazione
valutativa bensì enunciata dal legislatore mediante il ricorso ad
una categoria riassuntiva (253).
Questo perché e prescindendo, naturalmente, dall’estesissimo
ed assai articolato dibattito sulla questione della “temporaneità
oggettiva” o meno delle ragioni giustificative, non è revocabile in
dubbio come tali ragioni dovessero sussistere ed essere provate su
di un piano oggettivo e fattuale e si ponessero, pertanto, su un
piano del tutto diverso rispetto alle scelte valoriali o eticocomportamentali associate all’idea di standard valutativo.
Dato atto del ridimensionamento del ruolo del sindacato nella
regolamentazione dell’istituto (254) rispetto all’assetto legislativo
consolidatosi dopo il 1987, il dibattito sviluppatosi dal 2001 in
avanti ha toccato, tra gli altri, anche il tema degli eventuali
interventi della contrattazione collettiva finalizzati alla specificazione delle causali giustificative di matrice legale.
Appare più corretto definire tale forma di intervento come di
(247) Pera, 2002, 18; Menghini, 2002, 28; Tiraboschi, 2002, 93; Vallebona, 2002b, 62;
Altavilla, 2001, 242 s.
(248) Montuschi, 2002, 55.
(249) Vallebona, Pisani, C 2001, 25 (ma si veda anche Pisani, 2003, 69, per l’affermazione secondo cui la distinzione tra clausole generali e norme generali cambierebbe ben
poco i termini della questione perché in ogni caso si rende necessaria un’opera molto
accentuata di concretizzazione della norma stessa da parte del giudice); Maresca, 2008, 292;
Speziale, 2001, 374; Proia, 2002, 428; Ciucciovino, 2002, 45; Id., 2008, 93 ss.
(250) Santoro-Passarelli, G., 2002, 179.
(251) Perulli, 2002 372.
(252) Napoli, 2003, 88, Magnani, 2008, 635.
(253) Carabelli, 2001.
(254) Su cui, in particolare, si veda Giubboni, 2002.
144
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
specificazione anziché integrazione (255), trattandosi, in sostanza,
non del completamento del significato del precetto legale, bensì
dell’enucleazione da parte dell’autonomia collettiva di alcuni significati “particolari” dello stesso, comunque sussumibili nella
generale causale definita dal legislatore. Una forma di intervento la
cui legittimità era stata inizialmente messa in discussione (256),
obiezione superata (257), tuttavia, non solo in ragione dell’assenza
di un esplicito divieto legale (258) quanto, soprattutto, in considerazione della possibile incostituzionalità di una generale preclusione dei possibili interventi regolativi dell’autonomia collettiva (259) nonché della possibile qualificazione quali condizioni di
miglior favore rispetto alla legge dell’eventuale individuazione per
via convenzionale di ipotesi tassative di ricorso al contratto di
lavoro a tempo determinato (260).
Ciò che si pone in linea di continuità con le considerazioni
espresse nei paragrafi precedenti, a dispetto della diversa natura
dell’intervento dell’autonomia collettiva, è l’opzione di fondo —
che conferma l’impostazione proposta nei precedenti paragrafi —
nel senso della presuntiva rispondenza a legge delle ragioni giustificative espressamente previste in via eventuale, anche nel vigore
della nuova disciplina, dai contratti collettivi (261).
Si sono orientati nel senso dell’accoglimento di questa opzione
gli interventi della Cassazione secondo i quali, anche in questo
(255) Come ritiene, invece, Ghera, 2002, 628.
(256) Cfr. Speziale, 2001, 369 (nota 26); Altavilla, 2001, 247.
(257) Oltre a Ghera, 2002, ult. loc. cit., si vedano, in particolare, Napoli, 2003, 92;
Montuschi, 2006, 188.
(258) Sulla quale, in particolare, Marinelli, 2003, 69. Per converso, nel Preambolo
(punto 12) e nella clausola 8.4 della direttiva 1999/70/CE viene puntualizzato come
“l’accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi
compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo
in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate”.
(259) Sul punto, per tutti, Montuschi, 2006, 118.
(260) In merito alla qualificazione come condizioni di miglior favore di tali clausole,
cfr. Marinelli, 2003, 70; Quaranta, 2006, 502; Aimo, 2006, 473; per considerazioni dubitative,
invece, Ciucciovino, 2007, 496, Passalacqua, 2005, 178.
(261) Cfr. Magnani, 2008, 636, secondo cui il vaglio giudiziale, pur formalmente non
impedito, è caratterizzato da una sorta di self restraint riguardo alle tipizzazioni collettive.
Precedentemente Montuschi, 2006, 117, per la puntualizzazione secondo cui il controllo del
giudice sarà verosimilmente “più intenso e penetrante quando la causale è farina del sacco del
datore”; Lunardon, 2007, 54.
145
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
caso, così come per altri istituti del rapporto di lavoro, la valutazione giudiziale assume l’ipotesi regolata dal contratto collettivo
quale primo elemento paradigmatico ai fini della decisione sulla
legittimità del contratto (262).Un elemento rispetto al quale si
conferma come la specificazione operata dal contratto collettivo sia
assistita da una presunzione di legittimità (263), fermo restando il
potere/dovere del giudice di valutare la rispondenza della causale
individuata dalle parti del contratto di lavoro rispetto alla generale
condizione di legittimità posta dalla legge, anche in presenza di
una preventiva tipizzazione di questa causale da parte della fonte
collettiva (264).
Un controllo che sarebbe stato definibile in questo caso come
bidirezionale, perché volto a verificare la sussumibilità sia della
previsione collettiva nella previsione legale aperta (265), sia quella
(262) Di conseguenza, come specificato dalla Cassazione, il giudice non può limitare
“il proprio esame alle ragioni indicate nella singola clausola riportata in seno al contratto di
assunzione, ritenendole vaghe e meramente apparenti, ma deve valutare l’incidenza che sulla
posizione del dipendente possono dispiegare gli accordi collettivi indicati nello stesso contratto”
(Cass. 10 novembre 2010, n. 22866; Cass. 25 maggio 2010, n. 8286).
(263) Come riconosciuto da Trib. Firenze 23 aprile 2004, RIDL, 2005, II, 195 “la
previsione in sede collettiva della possibilità di assunzione a termine in determinate circostanze
costituisce un elemento di garanzia e di riscontro oggettivo in ordine alla reale sussistenza delle
ragioni giustificatrici richieste dalla legge... garantisce contro ogni arbitrarietà datoriale e
assicura l’effettiva sussistenza della ragione oggettiva nello specifico settore”; nello stesso senso
App. Milano, 25 ottobre 2005, LG, 2006, 7, 710.
(264) Napoli, 2003, 92; Bellavista, 2009, 27; Magnani, Bollani, 2008, 353, nota 33;
Franza, 2010, 214.
(265) Con conseguente inammissibilità, nel quadro generale del d.lgs. n. 368 del 2001,
del procedimento inverso, ossia della sussumibilità della causale collettiva in quella legale ad
es. con riferimento ad ipotetiche causali soggettive, stante il criterio esclusivamente oggettivo indicato dalla medesima norma: sulla questione v. Cass. sez. un. 2 marzo 2006, n. 4588,
cit. Fatta eccezione, evidentemente, per gli accordi collettivi stipulati ex art. 8, d.l. 13 agosto
n. 138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, in forza del quale è stata
attribuita ai contratti di prossimità la competenza non soltanto a regolamentare l’applicazione degli istituti utilizzati per la realizzazione delle finalità individuate dal comma 1 dello
stesso art. 8, ma anche derogare con efficacia erga omnes, le regolamentazioni contenute
nella legge (in argomento, da ultimo, Bollani, 2013, 95 ss. e Saracini, 2013, 144 s. nonché in
precedenza, Menghini, 2012a, 444 ss.). In questi casi si può senz’altro ritenere che alle parti
sociali sia stato attribuito il potere di individuare causali di legittima apposizione del
termine, come accadeva nel vigore dell’art. 23, comma 1, legge n. 56 del 1987, con la
differenza che tale potere è stato riconosciuto, ex art. 8, a livello di negoziazione aziendale
o territoriale, ma non nazionale.
146
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
della clausola del contratto individuale nell’ipotesi “tipizzata” dal
contratto collettivo.
Ciononostante, proprio perché in un contesto normativo governato da una norma generale non è né può essere messa in
discussione la preminenza della “nozione legale” della cui concretizzazione (salvi gli eventuali interventi specificativi dell’autonomia collettiva) rimane investito il giudice, anche il riconoscimento
della tendenziale e presuntiva rispondenza della previsione di fonte
collettiva a tale nozione non poteva non risultare un argine troppo
sottile (266) rispetto alla prospettiva di una frammentazione interpretativa come quella che, come l’esperienza ha insegnato, è
stata alimentata dalla tecnica legislativa adottata per il contratto
a termine e per la somministrazione di lavoro a termine, almeno a
livello di giurisprudenza di merito, per più di un decennio (267).
La necessità di rimediare all’intrinseca debolezza di sistema
prodotta dalla combinazione tra l’ambiguità del dato legislativo, il
cui scioglimento veniva rimesso sostanzialmente alla sensibilità del
giudice, da un lato, e il depotenziamento dell’autonomia collettiva,
dall’altro, costituisce, pertanto, la più appropriata chiave di lettura dei cambiamenti introdotti nella disciplina del contratto a
termine e della somministrazione a termine a partire dal 2012 e dei
relativi avvicendamenti di modelli regolativi.
Per quanto riguarda il contratto di lavoro a tempo determinato, in un primo momento la soluzione prescelta dal legislatore è
risultata quella del sostanziale ritorno alla flessibilità contrattata,
dapprima compiuto in forma in verità esitante e “vischiosa” dall’art. 1, comma 9, della l. 28 giugno 2012, n. 92 (268) e poi con
(266) Di diverso avviso, da ultimo, Menghini, 2012b, 278, secondo il quale la
contrattazione collettiva, provvedendo a specificare la clausola generale, avrebbe attribuito
al sistema “un po’ di certezza” e ridotto il contenzioso sul punto.
(267) Ed a tal proposito cfr. Viscomi, 2003, 220, il quale sottolinea come il passaggio
a tale tecnica abbia segnato la transizione “da una flessibilità concertata ad un governo togato
della flessibilità”. Sul punto, con riferimento sia al contratto a termine sia alla somministrazione di lavoro, Romei, 2012, 969.
(268) Che conferiva alla contrattazione collettiva la competenza ad autorizzare
assunzioni “acausali” nell’ambito di un “processo organizzativo” determinato da una serie
di ragioni genericamente descritte nei termini: di avvio di una nuova attività; lancio di un
prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento
tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o
dalla proroga di una commessa consistente.
147
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
maggiore decisione dall’art. 7 del d.l. 28 giugno 2013, n. 76,
convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 99. Più precisamente, quest’ultimo intervento aveva dato vita ad un sistema misto, risultante
dalla combinazione tra la generale causale legale, la speciale figura
di contratto acausale “di primo impiego” (art. 1, comma 1-bis, lett.
a) e le ulteriori “ipotesi” introdotte dai contratti collettivi stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi (art. 1,
comma 1-bis, lett. b, d.lgs. 368 del 2001 introdotto dal d.l. 76 del
2013 (269)), sia in termini di espansione della “acausalità” (270),
sia dell’introduzione di nuove ipotesi di natura soggettiva legittimanti il ricorso al contratto a termine per lavoratori facenti parte
di categorie deboli (271).
Anche sul fronte della somministrazione di lavoro si è registrato un processo parallelo di articolazione dei presupposti di
legittimo ricorso all’istituto, che sostanzialmente ha depotenziato
il regime di giustificazione causale della somministrazione a termine, introducendo quella acausale per il primo utilizzo del lavoratore somministrato (cfr. la riformulazione dell’art. 20, comma 4,
d.lgs. n. 276 del 2003 e del comma 1-bis dell’art. 1 d.lgs. 368 del
2001 ad opera dell’art. 1, comma 10, lett. b, l. 92 del 2012), nonché
quella di natura soggettiva in funzione promozionale dell’impiego
dei lavoratori svantaggiati (cfr., prima l’art. 20, comma 5-bis, d.lgs.
276 del 2003, introdotto dall’art. 2, comma 143, l. 191 del 2009 e,
poi, l’art. 5-ter dell’art. 20, aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c,
d.lgs. 24 del 2012). Ma soprattutto ha restituito all’autonomia
collettiva un ruolo significativo nella individuazione di “ulteriori
(269) Con riferimento a quest’ultima previsione, per rilievi critici e dubbi di legittimità costituzionale connessi all’ampiezza del rinvio, si veda, da ultimo, Saracini, 2013, 112.
(270) Cfr. art. 38 del CCNL Alimentari-Panificazione — accordo di rinnovo del 19
novembre 2013 — che prevede l’ampliamento della durata massima del rapporto a termine
senza causale fino a 24 mesi con la precisazione che “tale tipologia di contratto a termine potrà
essere adottata anche con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con la
medesima impresa”.
(271) Cfr art. 28 CCNL Trasporto Aereo del 28 agosto 2013 secondo cui possono
essere assunti in regime di c.d. acausalità i percettori di ammortizzatori in deroga, i
disoccupati da almeno un mese, donne con figli, giovani fino a trentacinque anni d’età,
lavoratori svantaggiati, studenti delle scuole superiori durante gli intervalli di frequenza per
realizzare collegamento scuola-lavoro; v. anche art. 23 CCNL Occhialeria del 9 novembre
2013; art. 79 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del
settore turismo — accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014.
148
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ipotesi” di somministrazione sia a termine (art. 20, comma 5 quater,
d.lgs. 276 del 2003 introdotto dal d.lgs. 24 del 2012) che a tempo
indeterminato (art. 20, comma 3, lett. i, d.lgs. n. 276 del 2003
introdotto dalla l. n. 191 del 2009).
Il baricentro dei limiti legali posti dall’ordinamento come
condizione per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo
determinato e per il ricorso alla somministrazione di lavoro è
andato, quindi, riposizionandosi, in un primo momento, dal fronte
del controllo causale in sede giurisdizionale a quello del controllo
sindacale mediante la riattribuzione alla contrattazione collettiva
del compito di definire modalità, forme e condizioni (sia pure in
alternativa a quelle definite dalla legge) del ricorso all’impiego
temporaneo. La “delega in bianco” è stata, quindi, inizialmente
restituita alle parti sociali ed è stata, anzi, formalmente ampliata
rispetto alla previsione del 1987, con l’estensione diretta alla contrattazione aziendale della competenza ad individuare specifiche
ipotesi oggettive o soggettive di assunzione a tempo determinato (272) e di somministrazione (273).
Questa fase ha però avuto una durata oltremodo breve, in
quanto il sistema a tre vie inaugurato dal d.l. n. 76 del 2013 (274)
è stato drasticamente superato dalla generalizzazione del contratto
di lavoro a termine e di somministrazione a termine acausale
operata dall’art. 1 del d.l. n. 34 del 2014 e dalla soppressione di ogni
richiamo alle ragioni giustificative, tanto di fonte legale quanto di
fonte collettiva.
Con questo mutamento di tecnica legislativa il legislatore ha
dato mostra della intervenuta consapevolezza, alla luce della perdurante crisi occupazionale richiamata nel preambolo alle nuove
previsioni legislative (come riformulato in sede di conversione del
decreto legge), dell’opportunità di un superamento dei limiti e dei
controlli, anche affidato alle parti sociali, di tipo qualitativo sull’accesso al lavoro a tempo determinato, con l’intento di sottrarre
(272) Rispetto alla possibile estensione indiretta alla contrattazione aziendale, dietro
delega da parte dei contratti collettivi nazionali o locali, della competenza ad individuare le
causali di assunzione a tempo determinato nel vigore della legge n. 56 del 1987, si veda, da
ultimo, Cass. 22 ottobre 2012, n. 18118.
(273) Cfr. da ultimo Alvino, 2013, 54, che parla al riguardo di clausole collettive
“autorizzatorie”.
(274) Ciucciovino, 2013, 99.
149
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
definitivamente al sindacato giudiziale la valutazione dei presupposti oggettivi di ricorso all’impiego temporaneo. Un superamento
forse in parte comprensibile anche in considerazione della forte
trasversalità degli effetti della crisi occupazionale e, quindi, della
ridotta utilità di un’impostazione di tipo “selettivo”, quand’anche
affidata alla conduzione delle parti sociali.
Lo schema della giustificazione causale e, dunque della rispondenza delle ragioni determinative del contratto rispetto ad una
fattispecie generale di legge o a specifiche ipotesi oggettive o
soggettive delineate dal contratto collettivo è, quindi, stato definitivamente abbandonato, allo stato, in favore di un controllo di
tipo meramente quantitativo (275), ancora una volta compartito
tra la legge e la contrattazione collettiva (che conserva le competenze connesse al c.d. contingentamento sia nella disciplina del
contratto a termine sia in quella della somministrazione a tempo
determinato ai sensi degli artt. art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368
del 2001 e 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003).
Una metamorfosi sistemica che, indipendentemente da ogni
valutazione in termini di politica del diritto e in attesa dell’annunciato provvedimento di riordino delle forme contrattuali flessibili
previsto dal disegno di legge delega n. 1428 presentato dal Governo
al Senato lo scorso aprile, presenta almeno due innegabili pregi sul
piano tecnico. Il primo appare quello della semplificazione e del più
elevato margine di certezza che sottrae i due istituti alla nebulosità
interpretativa che per più di dieci anni ne ha condizionato l’applicazione. Il secondo è ravvisabile nel mantenimento di un significativo margine di controllo sindacale, che si esplicita nelle limitazioni consentite attraverso lo strumento delle clausole di contingentamento.
Un controllo, è utile puntualizzare, che potrà essere esercitato
anche in forma “modulare”, ossia attraverso limitazioni non uniformi come quelle consentite dall’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368
del 2001 e che potrà anche essere amministrato dalle parti sociali in
modo da canalizzare il flusso delle assunzioni verso determinate
figure di lavoratori o privilegiando determinate categorie di esigenze organizzative, con individuazione di specifiche ipotesi di
(275) Per una proposta di evoluzione in questo senso della disciplina legale si veda già
Maresca, 2010,87.
150
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
contratto assoggettate a limiti percentuali differenziati; non appare, quindi, del tutto preclusa per le parti sociali, attraverso un
adattamento del limite quantitativo, la strada per pervenire alla
definizione di un assetto non troppo dissimile da quello prefigurato
dal legislatore con le modifiche introdotte nel 2013 (276).
11. Le ipotesi di rinvio al contratto collettivo quale canale primario o
esclusivo di concretizzazione delle clausole generali.
Dall’evoluzione legislativa che ha interessato l’istituto del contratto di lavoro a tempo determinato si ricava anche una suggestione di respiro più ampio, con riferimento, è stato già anticipato,
alla pluralità dei moduli legislativi entro i quali possono trovare
accoglienza le clausole generali.
Non sempre, infatti, l’utilizzo da parte del legislatore di questo
strumento implica e sottintende il rinvio ad una potenziale pluralità di standard, tra i quali il giudice viene chiamato ad operare una
selezione e a motivare le proprie scelte interpretative.
Rientra tra le possibili opzioni entro le quali si muove la
discrezionalità legislativa anche la scelta della combinazione tra la
tecnica della clausola generale e l’investitura delle contrattazione
collettiva quale possibile canale diretto di concretizzazione del
contenuto della stessa clausola, in via esclusiva o in via alternativa
rispetto ad altre possibili metodologie attuative.
In questo caso, l’esplicito rinvio legale esclude, laddove le parti
stipulanti il contratto collettivo ritengano di accogliere la sollecitazione del legislatore, il ricorso ad altri possibili, differenti standard.
Questo perché il contratto collettivo viene a priori individuato
come lo schema attuativo più adeguato, sia sul fronte della competenza “settoriale”, riferita allo specifico ambito professionale
entro il quale la clausola generale deve trovare attuazione, sia sul
versante dell’adeguatezza sociale ai fini della concretizzazione del
precetto legale; concretizzazione che, dunque, non passa in questo
caso per il controllo giudiziale, salvo che per quanto concerne il
(276) Carinci, F., 2014 ritiene invece fortemente ridimensionato, nel nuovo assetto
regolativo dell’istituto, il margine di intervento della contrattazione collettiva.
151
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
rispetto dei limiti esterni, generali e specifici, a cui le parti sociali
debbono in ogni caso sottostare (277).
Le clausole generali operano dunque, in queste fattispecie
normative, come strumenti di valorizzazione della mediazione
collettiva in netta alternativa e non in abbinamento a quella
giudiziale, nella prospettiva già indicata diversi anni fa da
Liso (278).
La differenza ulteriore rispetto ad altre forme di rinvio al
contratto collettivo e connessa all’utilizzo della clausola generale, è
che in questo caso la funzione del rinvio non è meramente autorizzatoria. Diversamente, il ricorso alla clausola generale implica il
riconoscimento al contratto collettivo della competenza ad operare
determinate scelte valoriali al fine di pervenire alla “perimetrazione” (per mutuare una felice espressione accolta dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al contratto di lavoro a tempo
determinato (279)) della possibilità di accesso a determinati segmenti normativi.
Ciò che caratterizza queste fattispecie, dunque, è che si tratta
di casi nei quali la funzione del contratto collettivo non è solamente
quella di permettere che l’esercizio dell’autonomia negoziale individuale si orienti verso forme contrattuali o specifici contenuti a
cui altrimenti le rimarrebbe interdetto l’accesso (come è invece
avvenuto, ad esempio, nel caso dell’individuazione da parte del
contratto collettivo delle “ipotesi” che legittimano la stipulazione
del contratto di lavoro a tempo determinato e come avviene con
riferimento alle “condizioni” che legittimano l’inserimento delle
clausole elastiche e flessibili nel contratto di lavoro a tempo parziale).
Diversamente, in queste l’ipotesi, l’accesso alla flessibilità
viene ancorato all’individuazione di specifiche precondizioni organizzative che trascendono le singole posizioni individuali, per inve(277) Per una recente rilettura e per una conferma della validità della tecnica dei
limiti esterni quali strumenti di controllo dei poteri imprenditoriali si veda Pessi, 2009b,
spec. 678 ss.
(278) Liso, 2002, 213.
(279) A partire, come è noto, da Cass. 26 gennaio 2010, n. 1576 e 1577, quest’ultima
in FI, 2010, I, 1169; tra le molte pronunce negli stessi termini, successivamente, Cass. 7
settembre 2010, n. 15005; riassuntivamente, per una ricognizione aggiornata della giurisprudenza in materia, Preteroti, 2014, 362 ss.
152
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
stire un determinato assetto dell’intera compagine aziendale; e
sono queste precondizioni, se e quando riconosciute come meritevoli dalle parti sociali, che giustificano la scelta del legislatore di
autorizzare il ricorso a questi specifici strumenti normativi.
Negli esempi di utilizzo di questa tecnica legislativa può essere
fatta rientrare la previsione dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 276
del 2003, riguardante l’istituto del lavoro intermittente (280) che
rimette alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze
per le quali è ammesso il ricorso alle prestazioni di carattere discontinuo o intermittente; esigenze che di per sé legittimano la stipulazione del contratto, almeno sulla base della ricostruzione che respinge l’idea di un immanente (od ontologico) carattere discontinuo
o intermittente delle prestazioni per riconoscere che tale carattere
costituisce “un riflesso normativo delle scelte compiute dalla fonte competente, che non un carattere intrinseco dell’attività come tale” (281).
Un rinvio che, da un lato, legittima la contrattazione collettiva
a “calibrare” il grado di ampiezza e specificità di tali esigenze (282),
(280) Il quale, pur oggetto delle note vicende legislative di soppressione e riattivazione (art. 1, comma 45, legge 24 dicembre 2007, n. 247 e art. 39, comma 10, lett. m, del d.l.
25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha registrato, almeno
sino al 2012, una fase di significativa crescita: in argomento: cfr. il Quaderno sul primo anno
di applicazione della legge n. 92 del 2012, diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nell’ambito del sistema permanente di monitoraggio delle politiche del lavoro,
www.lavoro.gov.it.
(281) Bellocchi, 2007, 529, la quale rammenta anche (nota 6) come la circolare del
Ministero del Welfare del 2 febbraio 2005, n. 4 abbia escluso l’ammissibilità di “un giudizio
caso per caso circa la natura intermittente o discontinua della prestazione essendo questo compito
rinviato ex ante alla contrattazione collettiva o, in assenza, al Decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali cui spetta il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica
o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di
lavoro intermittente”; si veda, in senso conforme, anche Nuzzo, V., 2005, 9. Per una possibile
diversa lettura a “doppio filtro”, secondo la quale la legge consentirebbe solo la stipulazione
del contratto di lavoro intermittente per prestazioni di carattere strutturalmente o ontologicamente intermittente, che, al contempo però, sarebbero utilizzabili solo al ricorrere delle
specifiche esigenze determinate in sede collettiva, cfr., Ales, 2005, 863.
(282) Sicché, è stato affermato che la contrattazione collettiva “ben potrebbe o
adottare la tecnica normativa consueta, quella cioè di individuare le specifiche ipotesi in cui è
consentito ricorrere al lavoro intermittente; ovvero, limitarsi ad individuare tali esigenze
mediante una clausola generale, similmente a quanto avviene per il contratto a termine e per la
somministrazione a tempo determinato” (Romei, 2004, 422 e, nello stesso senso, Mattarolo,
2004, 26; Passalacqua, 2005, 164). Sulla concreta attuazione del rinvio da parte della contrattazione collettiva, da ultimo, Voza., 2013, 360. Per la necessità di una casistica analitica,
153
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dall’altro implica la definizione, in via esplicita o implicita, della
correlazione tra il contenuto del contratto e la soddisfazione delle
esigenze medesime, soddisfazione a cui le prestazioni lavorative
debbono essere preordinate per poter essere fatte rientrare nei
“casi” di legittimo ricorso al lavoro intermittente (art. 40, comma
1, d.lgs. n. 276 del 2003) (283).
Se il controllo giudiziale potrà investire senz’altro questo secondo versante, ossia quello della coerenza tra l’ipotesi indicata nel
contratto di lavoro intermittente stipulato ai sensi sell’art. 35,
comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 276 del 2003 e le esigenze individuate
dal contratto collettivo, dovrà viceversa essere escluso, stante la
natura “aperta” del rinvio legale, un controllo di merito sulle scelte
dell’autonomia collettiva (284); e ciò in considerazione della evidente impossibilità di isolare, sul piano oggettivo, esigenze che siano
oggettivamente od ontologicamente satisfattibili con prestazioni di
lavoro intermittente anziché con il ricorso ad altri modelli contrattuali.
Si pone in linea con questa lettura la nuova previsione legislativa, introdotta dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, la quale ha inserito nella disposizione di
legge che definisce i casi di ricorso al lavoro intermittente rimettendoli, in primo luogo, alle determinazioni dell’autonomia collettiva un contrappeso limitativo di ordine quantitativo (quello dell’impiego del lavoratore per un massimo di quattrocento giornate
di lavoro effettivo nell’arco di tre anni previsto dall’attuale comma
2-bis dell’art. 34) che, in verità, avrebbe ben poca ragion d’essere se
la natura “ontologicamente” intermittente delle esigenze e delle
prestazioni ad esse correlate fosse in ogni caso suscettibile di
verifica giudiziale, indipendentemente dalla sua durata.
Evidente, è appena il caso di notare, la parziale affinità ante
invece, Perulli, 2004, 145. Per osservazioni di segno critico, invece, sull’abbinamento tra il
rinvio alla contrattazione collettiva e la contemporanea previsione autorizzatoria di tipo
“soggettivo” che consente la stipulazione del contratto di lavoro intermittente con lavoratori
collocati in fasce anagrafiche a rischio di esclusione sociale, si veda Sciarra, 2006, 61.
(283) Può dirsi che in questo caso la clausola generale (destinata a trovare la sua
concretizzazione attraverso il contratto collettivo) viene integrata all’interno del più diffuso
e versatile schema legislativo della flessibilità, dove il contratto collettivo “è un mezzo per
adattare al caso specifico una regolamentazione di legge che ha carattere generale” (così, da
ultimo, Romei, 2011a, 197).
(284) Bellocchi, 2007, ult. loc. cit.
154
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
litteram con le trasformazioni che di lì a poco avrebbero interessato
anche il contratto di lavoro a tempo determinato, anche lì con
l’introduzione di un limite oggettivo di tipo quantitativo e con la
conseguente, radicale sottrazione al controllo giudiziale delle motivazioni del ricorso alla forma contrattuale flessibile, non più
sussumibile in una o più ragioni giustificative di fonte legale.
Ricorso che il legislatore delegato, tuttavia, dati i possibili
margini di “antagonismo” tra la figura del lavoro intermittente e
quella dell’ordinario rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto di
condizionare anche ad un controllo ex ante, rappresentato dall’intervento autorizzativo delle parti sociali chiamate a concretizzare,
almeno in via prioritaria rispetto alla decretazione ministeriale
suppletiva, le “esigenze” giustificative dell’utilizzo di questo particolare strumento flessibile.
Una tecnica similare, seppur in chiave di adattamento o “temperamento” (285) di vincoli già regolati in forma autosufficiente
dalla legge, è quella adoperata dal legislatore delegato nella regolamentazione dell’orario massimo di lavoro, come risultante dal
combinato disposto dell’art. 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2003,
n. 66.
Va detto che, in questo caso, struttura e contenuto del precetto
non sono frutto di un’elaborazione compiuta dal legislatore nazionale, in quanto la formulazione legislativa riprende letteralmente
la previsione contenuta nella direttiva europea (cfr., ora, l’art. 19,
secondo capoverso, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 novembre 2008, concernente taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).
Ci si riferisce alla possibilità che i contratti collettivi “a fronte
di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro”
elevino sino a dodici mesi il periodo di riferimento per il calcolo
della durata massima media dell’orario di lavoro, fissata in quarantotto ore settimanali. Condizione per l’esercizio di tale facoltà è
che — con scelta discrezionale questa, sì, imputabile al legislatore
nazionale — tali esigenze siano “specificate” dai contratti collettivi
destinatari del rinvio (286).
(285) Così definito da Carabelli, Leccese, 2006, 199.
(286) Tra le competenze riconosciute al contratto collettivo dal d.lgs. n. 66 del 2003
rientrano anche quelle di carattere derogatorio previste dall’art. 17, comma 1, che il comma
4 dello stesso articolo condiziona alla concessione di periodi di riposo compensativo ovvero al
155
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Una scelta che come comunemente si riconosce — anche in
considerazione, peraltro, della riconducibilità della stessa alla normativa europea — non appare suscettibile di controllo dal punto di
vista di una astratta rispondenza alla ratio della norma delle
“ragioni” concretamente individuate dalle parti (287).
All’autonomia collettiva è, pertanto, riconosciuta la competenza a selezionare, tra i diversi “eventi”, anche di carattere
esterno, o tra i molteplici interventi organizzativi che possono dar
luogo a riflessi sul fronte dell’orario di lavoro, quelli che possono
implicare un più intenso ricorso a forme di flessibilizzazione dei
tempi di lavoro, tali da incidere potenzialmente sul computo
dell’orario massimo medio come quantificato dal comma 2 dello
stesso art. 4. Una selezione che appare evidentemente come il
frutto di una libera scelta delle parti sociali piuttosto che di una
ricognizione di situazioni oggettive.
Per questo motivo e nonostante le analogie lessicali, le “ragioni” in relazione alle quali il contratto collettivo può autorizzare
il più elastico criterio di computo dell’orario massimo medio non
sono assimilabili a quelle menzionate dagli artt. 2103 c.c. e 3 della
legge n. 604 del 1966.
fato che ai lavoratori interessati dalle deroghe sia accordata una “protezione appropriata”.
Nonostante il tenore generale di questa espressione, in questo caso l’ambito delle scelte rimesse
all’autonomia collettiva è limitato dalla necessità di salvaguardia dell’integrità psicofisica del
lavoratore, ossia di un elemento fattuale che impedisce di considerare questa previsione legislativa come un rinvio finalizzato alla semplice concretizzazione di comportamenti caratterizzati da una mera adeguatezza sociale; un profilo che, in relazione alla ratio della deroga,
appare sicuramente secondario rispetto all’esigenza di garanzia della tollerabilità individuale
delle differenti modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa previste dall’accordo derogatorio. Il controllo del giudice, in questo caso, è di natura e contenuto diversi
rispetto a quello che, teoricamente potrebbe investire gli accordi derogatori ai sensi dell’art.
4, comma 4, in quanto viene condotto al fine di verificare che dalle scelte dell’autonomia
collettiva non scaturiscano conseguenze pregiudizievoli e tecnicamente verificabili (sulla base
delle conoscenze offerte dalla scienza medica e dagli altri saperi specialistici) sulla salute del
lavoratore: sul punto si rinvia a Ferrante, 2004, 1404 e a Ricci, G., 2004, 466 ss.
(287) Fatta eccezione per i casi, che potrebbero definirsi di sostanziale inattuazione
del rinvio, in cui manchi del tutto la specificazione delle ragioni giustificatrici ovvero il
contratto collettivo abbia autorizzato la deroga sulla base di ragioni palesemente incongrue,
vale a dire sulla base di ragioni non sussumibili nelle “ragioni obiettive, tecniche o inerenti
l’organizzazione del lavoro” indicate dalla norma: in tal senso Del Punta, 2003, XIII; per
l’affermazione secondo la quale la verifica giudiziale sulle ragioni individuate dal contratto
collettivo si risolverebbe in un sindacato sulla contrattazione collettiva che quelle ragioni
aziendali ha riconosciuto ed attestato, Mariani, 2013, 1930.
156
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Questo perché le “ragioni” del trasferimento e del licenziamento
non si identificano con la scelta imprenditoriale effettuata a monte,
ma ne costituiscono le oggettive e ineluttabili conseguenze, le quali
rimangono esterne e si collocano a valle degli eventi, volontari o
meno, che si riflettono, si ripete, in termini oggettivi sulla situazione
individuale del prestatore di lavoro trasferito o licenziato.
Al contrario, negli esempi che sono stati sin qui esaminati con
riferimento al lavoro intermittente e all’orario massimo medio,
l’individuazione delle “ragioni” e delle “esigenze” da parte del
contratto collettivo assolve una finalità duplice. Da un lato, infatti, in contratto collettivo provvede a giustificare la scelta della
misura di flessibilità o della specifica forma contrattuale per la
quale la legge richiede il previo intervento autorizzativo.
Dall’altro, proprio “selezionando” queste specifiche ragioni ed
esigenze, il contratto collettivo concorre a circoscrivere ossia delimitare cioè a “perimetrare” gli effetti della previsione legale: ed è
proprio il connubio di queste due funzioni (selezione delle “ragioni”
od “esigenze” e delimitazione degli effetti della norma legale) che
autorizza a leggere tale attività negoziale quale concretizzazione di
clausole generali.
Ancora diversa e comunque distante dal territorio delle clausole generali appare, per concludere sul punto, la tecnica utilizzata
dal legislatore per delimitare le competenze negoziali attribuite ai
contratti collettivi di prossimità dall’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il comma 1 dell’art. 8, ai fini della delimitazione dell’ambito di
applicazione della norma, stabilisce che le “intese” legittimate ad
intervenire nelle materie di cui al comma 2, anche operando in
deroga alle relative norme di legge ai sensi del comma 2-bis dello
stesso articolo, debbono essere “finalizzate” al perseguimento di
una serie di obiettivi generali, obiettivi che vengono predefiniti
dallo stesso legislatore nello stesso ultimo inciso del comma 1 (288).
Nelle numerosissime analisi della norma che si sono succedute
nel periodo trascorso dalla sua emanazione non è stato dedicato
molto spazio, pur con qualche eccezione, a questo “vincolo di
(288) Tali intese debbono essere preordinate, stabilisce la norma, “alla maggiore
occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei
lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività”.
157
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
scopo” (289). Sul quale è invece opportuno soffermarsi brevemente
per evidenziare come in questa fattispecie legislativa il rinvio al
contratto collettivo non implichi la rimessione all’autonomia collettiva di una scelta assiologia e valoriale, già operata a priori dal
legislatore.
Le finalità (ovvero, per usare la terminologia adoperata dal legislatore in altre previsioni legislative, le “esigenze” o le “ragioni”)
che giustificano il conferimento di un’efficacia così penetrante, tanto
dal punto di vista soggettivo quanto sul piano dei contenuti, degli
accordi di prossimità sono e rimangono quelle dettate dalla legge, la
quale rimette alle parti sociali la scelta delle soluzioni, ossia delle
concrete misure che possano favorirne la realizzazione.
È stato osservato come, nella pratica attuazione della disposizione legislativa, a questo vincolo potrebbe essere attribuito un
livello più o meno elevato di intensità, a seconda che lo si intenda
come un onere delle parti di specificare in termini oggettivi e
specificamente verificabili i risultati che le stesse si prefiggono di
conseguire ovvero che lo si interpreti in senso “debole”; vale a dire
come mera necessità di una espressa dichiarazione che attesti la
comune aspettativa nutrita dalle parti circa l’effettiva strumentalità dell’accordo rispetto alle finalità elencate dalla legge (290).
Se si conviene sulla maggiore aderenza della prima interpretazione alla lettera e alla ratio della norma, occorre, in via ulteriore,
interrogarsi sui contenuti e sui limiti del possibile controllo giudiziale degli accordi di prossimità dal punto di vista della loro
rispondenza a questo specifico requisito di legge; un controllo di cui
alcuni si sono limitati a sottolineare la problematicità, laddove
altri hanno ritenuto di poterlo assimilare ad un controllo di ragionevolezza e proporzionalità delle condizioni pattuite rispetto ai
benefici che le parti si sono riproposte di conseguire (291).
(289) Come viene definito da Perulli, e Speziale, 2012a, 205. Per alcuni cenni sul
punto si veda anche Romei, 2011b.
(290) In questo senso ed escludendo l’ipotesi di un controllo giudiziale, o per lo meno
di un controllo penetrante, Treu, 2011, 635; Vallebona, 2011, 684. Nello stesso senso
Ferraro, 2011b, 21, secondo il quale “in una situazione di crisi economica planetaria non sarà
mai difficile indicare una motivazione giustificatrice”.
(291) Perulli, Speziale, 2012a, 206 e, pur dubitativamente, De Luca Tamajo, 2012,
293; Brollo, 2012, 387; Ales, 2011, 20; negli stessi termini, ma con accenti critici, Bellavista,
2012, 312.
158
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Il tema generale del controllo giudiziale sugli atti di esercizio
dell’autonomia collettiva è troppo imponente ed eccedente i limiti
di questo lavoro per poter sviluppare ulteriori approfondimenti di
questa problematica (se ne affronteranno alcuni profili nel paragrafo che segue). È solo possibile evidenziare come la stipulazione
di un accordo del tipo di quelli delineati dall’art. 8 implichi due
distinte valutazioni, non rimesse dall’ordinamento ai medesimi
soggetti.
Da una parte, il raggiungimento di un’intesa ai sensi del
comma 1 dell’art. 8 implica una necessaria correlazione causale tra
le condizioni pattuite nell’accordo e le finalità a cui l’accordo stesso
è preordinato (se, cioè, vi sia effettivamente, nell’accordo, una
compresenza e una connessione logica — per meglio intendersi, una
non contraddittorietà — tra le misure previste, le eventuali deroghe pattuite e le concrete modalità definite dall’accordo per il
conseguimento delle finalità con esso perseguite). Da questo punto
di vista, l’eventualità che il giudice valuti la rispondenza alla legge
dell’accordo, verificando l’effettiva sussistenza di tale correlazione (292), non appare eccentrica rispetto al consueto schema del
sillogismo giudiziale e può non trascendere (il condizionale è l’obbligo, trattandosi di una valutazione che richiede grandissimo
senso di equilibrio e una notevole dose di self restraint) in un
sindacato di merito sulle scelte dell’autonomia collettiva.
Altra e diversa valutazione è quella relativa all’adeguatezza
degli interventi pattuiti ossia alla già ricordata proporzionalità
degli stessi rispetto ai risultati che con l’accordo le parti si propongono di conseguire. Si tratta di una valutazione che rimane nella
sfera esclusiva dell’autonomia collettiva, e rispetto alla quale non
(292) Cfr., sul punto, Carinci, F., 2012, 35, che nel senso che tali finalità debbano
essere esplicitate a premessa delle intese e possano essere sindacate dalla giurisprudenza
nella loro capacità di giustificare le misure ivi adottate (e già in tal senso Santoro-Passarelli,
G., 2011, 1243). Cfr. anche Marazza, 2012b, 44; sul controllo dei “presupposti oggettivi ai
quali va ancorato il perseguimento della finalità modificativa” Zoppoli, L., 2011. Sembrano
ammettere un controllo di questo tipo anche Leccese, 2013, 51, nota 61 e Magnani, 2012, 8,
la quale, da un lato, osserva che la ragionevolezza dell’art. 8 (dal punto di vista della
discrezionalità legislativa) sembra sostenibile in considerazione del fatto che l’intervento dei
contratti di prossimità è previsto solo in presenza di determinate esigenze del contesto
produttivo e, per altro verso, esclude l’eventualità di un controllo giurisdizionale/
amministrativo sul perseguimento delle finalità medesime da parte degli accordi di prossimità.
159
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
appare ammissibile, neanche in questa materia, configurare un’ingerenza del giudice nell’esercizio di prerogative negoziali di cui
l’ordinamento garantisce la libertà e l’affrancamento da vincoli
funzionali incompatibili con la natura tuttora privatistica dell’autonomia collettiva (293).
12. Ragionevolezza, clausole generali e autonomia collettiva.
Per molti versi il tema del rapporto tra clausole generali e
sindacato di legittimità del giudice sugli atti di esercizio dell’autonomia collettiva risulta, ad oggi, definito in termini piuttosto
stabili da una giurisprudenza ormai consolidata; ci si può esimere
almeno in parte, quindi, dal riepilogare in dettaglio le varie fasi del
dibattito in tema di parità di trattamento e azionabilità giudiziale
delle relative violazioni, nonché dei collegamenti tra questo dibattito e la tematica delle clausole generali.
Vi è, tuttavia, la necessità di dedicare uno spazio ad una delle
ramificazioni di tale dibattito che presenta perduranti profili di
vivacità e con riferimento alla quale la tensione tra le modalità di
esercizio delle competenze regolative attribuite al contratto collettivo e le valutazioni giudiziali è andata elevandosi al punto di
sfociare in contrapposizioni radicalmente antitetiche: cosa che si
può dire accada tuttora in materia di licenziamenti collettivi, con
particolare riferimento all’individuazione dei criteri di scelta ex
art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991.
Un terreno di confronto, si potrebbe dire, coltivato fuori dalle
righe dei testi legislativi, posto che in questo caso il parametro
ordinamentale che legittimerebbe il controllo giudiziale non è
rappresentato né da una clausola generale in senso proprio né,
comunque, da un elemento di fonte legale, bensì da un “principio”,
sinteticamente definito come principio di razionalità, enucleato da
alcune statuizioni espresse, nella loro forma più evidente, in due
notissime sentenze interpretative della Corte costituzionale, la n.
103 del 1989, in materia di parità di trattamento retributivo a
(293) Sull’inammissibilità di un controllo giudiziale di proporzionalità, con riferimento alle differenze di trattamento economico tra i lavoratori determinate dal loro
differente inquadramento come regolato dal contratto collettivo, in particolare, Cass. 7
gennaio 1999, n. 62, oltre alla notissima Cass. S.U. 29 maggio 2003, n. 6030.
160
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
parità di mansioni, e la n. 268 del 1994, per l’appunto dedicata
all’efficacia degli accordi sui criteri di scelta previsti dall’art. 5,
comma 1, della legge n. 223 del 1991 (294).
Le costruzioni elaborate a partire da quegli interventi, che
traggono origine e alimento, comunque, da un retroterra più
radicato e risalente (295) di cui tra poco si dirà, hanno inciso
profondamente entro alcuni ambiti di intervento dell’autonomia
collettiva e ancora oggi trovano un riscontro “settoriale” nella
giurisprudenza in materia di sindacabilità giudiziale degli accordi
sui criteri di scelta dei lavoratori nell’ambito dei licenziamenti per
riduzione di personale.
Una giurisprudenza, quest’ultima, che in materia di controllo
di razionalità degli accordi in materia di riduzione di personale si è
in parte allineata alle indicazioni della Corte costituzionale (o, per
lo meno, ad alcune letture della sentenza n. 268 del 1994), dimostrandosi da questo punto di vista più ricettiva rispetto a quanto
avvenuto in materia di differenziazioni retributive tra lavoratori a
parità di mansioni, dove la prospettiva di un controllo di razionalità appare ormai definitivamente tramontata dopo gli interventi
delle Sezioni Unite del 1993 e del 1996 (296).
Viceversa, nelle motivazioni delle pronunce del giudice di
legittimità relative ai criteri di scelta individuati dai contratti
collettivi ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 è
a tutt’oggi ricorrente il richiamo ad una generica “ragionevolezza”
come necessaria qualità intrinseca dei criteri di scelta nego-
(294) Sull’impatto della riforma della disciplina dei licenziamenti operata dalla legge
n. 92 del 2012 su questo specifico versante cfr., in particolare, Sitzia, 2013.
(295) Cfr., tra gli altri, Buoncristiano, 1986, spec. 259 ss.; Balletti, 1990, spec. 237 ss.;
criticamente, Tullini, 1990, 277 ss.
(296) Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570, RIDL, 1996, II, 765, preceduta da Cass.
S.U. 29 maggio 1993, n. 6030-6034, FI, 1993, I, 1794, con nota di Mazzotta. Nell’intervallo
tra i due interventi si collocano quelle sentenze che, discostandosi dall’orientamento accolto
dalle pronunce del 1993, si erano espresse a favore di un onere, gravante sia sul datore di
lavoro sia sulle parti stipulanti il contratto collettivo, di addurre “apprezzabili e giustificate
motivazioni” delle differenze di trattamento retributivo a parità di mansioni: cfr. Cass. 8
luglio 1994, n. 6448, RIDL, 1994, II, 304 e 535, con note di Bolego, Bianchi D’Urso (e sulla
quale si veda anche, criticamente, Castelvetri 1995); Cass. 17 febbraio 1994, n. 1530, GI,
1995, I, 1, 464, con nota di Bellomo; Cass. 11 novembre 1995, n. 11515.
161
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ziali (297) ovvero alla rispondenza dei criteri di fonte negoziale ad
un asserito “principio” legale di ragionevolezza (298).
La prospettiva nella quale ci si è sinora collocati nell’esaminare
la dinamica applicativa delle clausole generali sembra qui sostanzialmente ribaltata: questo perché non è più il contratto collettivo
ad operare come possibile forma di concretizzazione del precetto
legale. Il c.d. principio di ragionevolezza, non configurabile, in
verità, come “fonte” di specifiche direttive comportamentali sintetizzabili a priori e suscettibili di “implementazione” da parte del
contratto collettivo (299), si configura all’atto pratico come un
criterio di giudizio applicabile dal giudice in via successiva, ossia in
sede di valutazione dei contenuti dell’accordo (300).
Così come detto a proposito dell’asserito principio di parità di
trattamento, i termini e le posizioni del vastissimo dibattito scientifico attorno all’assoggettabilità degli atti del datore di lavoro al
controllo giudiziale di “razionalità” o “ragionevolezza” sono
troppo noti per essere esaustivamente passati in rassegna in questo
contesto, così come le articolazioni di tali dibattito riguardanti
l’ammissibilità di un controllo di questa natura sulle manifestazioni dell’autonomia collettiva.
Né, peraltro, questo confronto scientifico si è risolto nella
spaccatura tra le posizioni di chi, da un lato, si è espresso a favore
(297) Ad es. 3 dicembre 2013, n. 27059, per il riconoscimento della razionalità del
criterio di scelta che consentiva il licenziamento dei lavoratori che avessero rifiutato la
trasformazione part time del contratto di lavoro.
(298) Cfr. Cass. 3 ottobre 2013, n. 22612 e Cass. 9 maggio 2013, n. 10985, sulla
conformità a tale principio del criterio della prossimità al pensionamento.
(299) Si vuol dire che, data la sua incommensurabile vastità, per la varietà di
significati e per la sua portata generale (cfr., su questa ampiezza di significato, Perulli, 2005,
2) questo principio (non a caso principio e non clausola generale) non appare comparabile
con concetti oggettivamente più circoscritti quali, ad es. quelli di diligenza conforme alla
natura della prestazione o di equivalenza professionale e conseguentemente non si presta ad
essere calato in una serie più o meno circoscritta di comportamenti socialmente tipi definibili
ex ante.
(300) E si potrebbe evocare, a questo proposito, l’immagine, proposta in dottrina a
proposito del rapporto tra scelte dell’autonomia collettiva e successiva loro sottoposizione al
controllo giudiziale, dei possibili margini di conflitto tra due componenti della cultura
giuslavoristica, identificabili nella “cultura dell’autotutela” e nella “cultura dei diritti” (Del
Punta, 1993, 2370), due culture che nell’ottica del controllo giudiziale operato “a valle” delle
scelte dell’autonomia collettiva finiscono per trovarsi fatalmente a grave rischio di contrapposizione.
162
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di tale controllo, prospettando una possibile valutazione delle
scelte (anche) dell’autonomia collettiva sotto la lente dei criteri di
proporzionalità e necessità visti come un “portato” dei valori
accolti nelle norme costituzionali in materia di lavoro, ovvero
giustificandolo come controllo di “coerenza” di tali scelte con la
ratio dell’istituto della mobilità (301). Mentre sull’altro versante
sono andati collocandosi coloro i quali respingono l’idea che anche
su questo specifico versante i poteri del datore di lavoro e l’autonomia collettiva siano assoggettati a limiti interni e sottoponibili a
un controllo di merito, rilevando, in particolare la contraddittorietà tra il riconoscimento costituzionale dell’autonomia collettiva
e la previsione di un controllo di razionalità da parte del giudice, la
quale “altro non significherebbe che abilitare il giudice a sostituirsi
alle parti” (302).
Non sono mancate, in passato, posizioni diversificate sul
punto, come quella assunta da chi, su un piano generale, ha
ritenuto conciliabile la salvaguardia dell’autonomia collettiva e
l’affermazione di un generale principio di imparzialità delle scelte
operate dal datore di lavoro o dalle parti collettive, accogliendo
un’impostazione di tipo procedimentale e traducendo in sostanza
l’idea di ragionevolezza nella generalizzazione dell’obbligo di giustificazione (303).
Procedimentalizzazione che da altri è stata letta, invece, nella
più rigorosa accezione di puntuale adempimento degli obblighi
legali ed è la posizione espressa da chi, con riferimento agli accordi
sindacali a cui la legge demanda l’individuazione dei criteri di
scelta nell’ambito della procedura di mobilità, difende una concezione essenzialmente procedurale della razionalità, intesa come
corretto adempimento degli obblighi che la legge e in particolare
l’art. 4 della legge n. 223 del 1991, pongono a carico dell’impresa,
escludendo che l’esito finale di tale percorso procedurale — frutto
(301) In questi termini, in particolare, Perulli, 2005, spec. 17 ss. e in una prospettiva
più ampia Id., 2011; Scarpelli, 1996, 30 ss.; Natullo, 2004, 147 ss.
(302) Così Persiani, 1995b, spec. 7 e 11; Id., 1999, spec. 13 ss.; nello stesso senso, tra
gli altri, Pera, 1989, 398; Scognamiglio, R., 1989a; Id., 1989b; Id., 1990; Id., 1993 SantoroPassarelli, G., 1990 e 1994, ora 2006; Mazzotta, 1990, ora 1994 e 1993, ora 1994; Ferraro,
1991b, ora 1992; Liso, 1998.
(303) Del Punta, 1993, 2368. Per alcune critiche a questa ricostruzione, SantoroPassarelli, G., 1994, ora 2006, 560.
163
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di una dinamica negoziale complessa attraverso la quale le parti
pervengono a superare possibili lacerazioni trovando un delicato
punto di equilibrio — possa essere vagliato alla luce di una riformulazione astratta del canone di razionalità (304).
Per evidenziare i collegamenti tra questo dibattito e il tema
qui affrontato, è utile partire, sperimentando un tragitto di tipo
induttivo, dalla presa d’atto della persistenza di contrasti e di
elementi di ambiguità nella giurisprudenza in materia di criteri di
scelta, che la metodologia del “controllo di ragionevolezza” non ha
contribuito a risolvere.
Per esemplificare, oltre alla questione dell’adozione quale criterio di scelta della prossimità al pensionamento, sulla quale la
giurisprudenza ha espresso orientamenti fortemente divergenti (305), rimane controversa, almeno secondo alcune opinioni
dottrinali, la legittimità della scelta delle parti sociali di dare
rilievo, ai fini della individuazione dei lavoratori da licenziare, alle
sole esigenze tecnico-produttive senza considerare i criteri del
carico di famiglia e dell’anzianità di servizio, così limitando la
scelta dei lavoratori ad una categoria di dipendenti o prevedendo
che la scelta debba essere effettuata reparto per reparto o limitatamente ad un solo settore e non con riferimento a tutti i dipendenti in servizio nell’azienda (306).
Al di là di tali risvolti specifici, l’osservazione di un panorama
(304) In particolare, per questa posizione, Liebman, S., 1999, spec. 140 ss.; Castelvetri, L., 1999 e Ead., 2000, spec. 84 s. Nello stesso senso, seppur in una prospettiva più
ampia, Marazza, M., 2001, 271.
(305) Sulla legittimità di tale criterio, oltre alle sentenze già citate, Cass. 11 novembre 1998 n. 11387, MGL, 1999, 153, Cass. 2 marzo 1999, n. 1760; Cass. 11 maggio 1999, n.
4666, MGL, 1999, 935, con nota di Castelvetri. Altra giurisprudenza ha, viceversa, reputato
il criterio della prossimità al pensionamento: in alcuni casi, non conforme alle finalità
dell’istituto della mobilità poiché impedirebbe una effettiva comparazione fra le posizioni
dei lavoratori, consentendo invece una immediata identificazione dei lavoratori da licenziare (c.d. “criterio fotografia”): così Cass. 24 aprile 1999, n. 4097, anch’essa in MGL, 1999,
935 e RIDL, 1999, II, 866. Altre sentenze hanno ritenuto il criterio illegittimo perché tale
da realizzare una discriminazione fra i lavoratori per età: App. Firenze 27 marzo 2006,
RCDL, 2006, 910, con nota di Calafà; Trib. Milano, 27 ottobre 2005, OGL, 2005, I, 938. Sul
tema si vedano anche le osservazioni di Del Punta 1999.
(306) Cfr. in tal senso Cass. 6 novembre 2013, n. 24990; Cass., 19 maggio 2006, n.
11886; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1405, NGL, 2006, 209. Analogamente: Cass., 17 febbraio
1999, n. 1335, MGL, 1999, 421, con nota di Liebman; Cass., 24 marzo 1998, n. 3133, NGL,
1998, 475; contra le opinioni di Scarpelli 1996, 35 e Perulli, 2005, 19.
164
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
giurisprudenziale non solo composito e frammentario, ma nel quale
il passaggio cruciale di ciascuna decisione si condensa e si esaurisce
il più delle volte nel perentorio riconoscimento (o disconoscimento)
della “razionalità” e della “coerenza con il fine dell’istituto della
mobilità” (307) dei criteri adottati dalle parti sociali può indurre ad
ammettere che si sia in qualche misura avverato il pericolo, paventato all’indomani dell’intervento della Corte costituzionale, che
l’applicazione di tale limite interno potesse tramutarsi in una
troppo agevole sponda per qualsiasi decisione il giudice ritenga di
adottare (308).
Cercando di trarre da questa vicenda particolare elementi che
si prestino a considerazioni di taglio più generale, rimane difficilmente contestabile che basi normative e puntuali referenti di
significato di questo ipotetico principio, come già detto, rimangono
oltremodo difficili da isolare. L’evocazione della figura della clausola generale, che pure emerge in alcune delle trattazioni in cui la
tesi del controllo di razionalità è stata sviluppata (309), appare
problematico nella misura in cui questa stessa tesi sembra escludere che l’idea di razionalità possa essere ricostruita attraverso il
ricorso a standard valutativi tratti dalla realtà sociale. Anche
perché, nel caso dei criteri di scelta pattizi, sono proprio questi dati
e più precisamente il più significativo tra questi, vale a dire il
contratto collettivo, ad essere assoggettati al controllo giudiziale.
Ad essere sottoposto a controllo, come già accennato, non è l’atto
che l’ordinamento vorrebbe come conforme al parametro comportamentale socialmente più adeguato, ma, piuttosto, il parametro
stesso.
Per altro verso e pur essendo stata definita come un “principio” (si direbbe, di portata generale), la “ragionevolezza” come
(307) Ad es. Cass. 28 ottobre 2013, n. 24263; Cass. 21 settembre 2011, n. 19233; Cass.
10 giugno 1999, n. 5718, FI, 1999, I, 2520.
(308) Persiani, 1995b, 4. Cfr. anche Castelvetri, 1999, 944, per la constatazione che,
alla luce della produzione giurisprudenziale, resta “del tutto imprecisato cosa debba intendersi
per giustificazione ragionevole”, ed altresì per il richiamo a Irti, 1980, ora 1984, 304, sul
pericolo di fuoriuscita dal sistema giuridico a cui l’interprete si espone nel salto dalla
“ragione della legge” alla “legge della Ragione”. Per la presa d’atto che le decisioni giudiziali
sulla valutazione di legittimità dei criteri di scelta “esprimono posizioni differenti quando non
antitetiche, dichiarando, tutte, di ispirarsi ai principi enucleabili dal dictum della Consulta”,
Natullo, 2004, 149.
(309) Cfr., in particolare, Perulli, 2007, 446 ss.
165
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
criterio di controllo degli atti dell’autonomia collettiva non appare
puntualmente ricollegabile a specifiche previsioni costituzionali;
anche considerando i possibili referenti che sono stati evocati nei
discorsi relativi a questa tematica, proprio per la loro essenza di
principi e anche strutturalmente, per la loro estrema latitudine
(oltre all’art. 3 Cost. si pensi all’art. 4, primo comma o al generale
principio di tutela del lavoro espresso dall’art. 35, primo comma),
si tratta di norme che non possono strutturalmente trovare applicazione nei rapporti interprivati (310), in quanto possono essere
lette sì come vincoli alla discrezionalità legislativa ma sono intraducibili in precetti applicabili alle relazioni contrattuali.
Di qui le perplessità che sono state avanzate di fronte alla
prospettiva dell’estensione agli atti tra privati di una forma di
controllo alla quale si fa normalmente ricorso nel diverso ambito
dell’esame di legittimità costituzionale delle leggi (311).
Ancora e stavolta con riferimento specifico alle ramificazioni
della verifica giudiziale di razionalità degli accordi in tema di
riduzione di personale, la stessa configurabilità astratta delle ipotetiche “linee di coerenza con l’istituto della mobilità” che siano
idonee a fungere da adeguati criteri di valutazione delle soluzioni
raggiunte dalle parti sociali appare ostacolata, si direbbe irrimediabilmente, dal fatto che il rinvio operato dalla legge alle scelte
operate dall’autonomia collettiva non si presta ad essere letto né
interpretato come una funzionalizzazione della stessa alla soddisfazione di interessi predeterminati come quelli, peraltro inespressi, della garanzia del “minore impatto sociale e della tutela
degli interessi dei lavoratori” (312), da considerare ipoteticamente
(310) La necessità di individuare un tramite legislativo è stata colta da Cass. 11
maggio 1999, n. 4666, cit. che qualifica la ragionevolezza come “un’estensione del principio
di non discriminazione tipizzato dalle fattispecie previste dall’art. 15 St. lav. al (più ampio)
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., il quale altrimenti non opererebbe nei rapporti
privatistici”.
(311) Così Ferraro, 1991b, ora 1992, 209 e nello stesso senso Persiani, 1995b, 5, nota
15. In giurisprudenza, per una notazione nello stesso senso, Cass. 25 settembre 1999, n.
10581, NGL, 2000, 49.
(312) È peraltro opportuno rammentare, a conferma della scarsa o nulla univocità
del teorizzato “principio” di ragionevolezza e della possibile, forse inevitabile, potenziale
antiteticità delle decisioni che possono essere assunte sulla sua base, che, in passato è stato
sottolineato come lo stesso principio potesse essere anche declinato in termini esattamente
opposti a quelli più recentemente ipotizzati, paventandosi che la valutazione di ragionevo-
166
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
prevalenti rispetto al valore della produzione e alle esigenze di
recupero dell’efficienza produttiva.
Ciò non solo in relazione alla persistente natura privatistica
degli atti di esercizio dell’autonomia collettiva a cui la legge rinvia,
rimettendo alle parti sociali la definizione degli equilibri e l’assunzione delle scelte che riflettono gli equilibri congiunturalmente
raggiungibili. Ma anche perché, per pervenire a soluzioni diverse,
sarebbe necessario individuare i supporti di diritto positivo che
possano operare quale fondamenti di questo diverso assetto dei
rapporti tra iniziativa economica privata e contropotere sindacale,
autorizzando il giudice a valutare la rispondenza a tali indicazioni
legislative delle soluzioni negoziali concretamente raggiunte (313).
Diversamente, anche in questa materia, la legge non definisce
specifici limiti interni dell’azione sindacale, bensì attribuisce alle
parti sociali competenze negoziali che sono sì oggetto di interesse
pubblico, ma destinati ed essere esercitati con gli ordinari metodi
di composizione degli interessi privati (314). Conseguentemente, si
è detto che il giudice “può e deve interpretare la disciplina legale e
quella sindacale in un’ottica conforme ai valori umani ad esse sottese,
lezza potesse implicare “il rischio di privilegiare, ancora una volta, le ragioni dell’efficienza
economica e le esigenze organizzative dell’impresa” (così Tullini, 1990, 281).
(313) Sulla separazione tra il momento dell’individuazione dei criteri, rimesso all’autonomia collettiva e quello della verifica della loro applicazione, di competenza del giudice,
cfr. anche D’Antona, 1994, 931. È stato osservato come vi siano esempi nei quali la
giurisprudenza è intervenuta operando una valutazione di tipo proporzionalistico trascendente le determinazioni dell’autonomia collettiva, come nel caso della celebre giurisprudenza in materia di licenziamento per eccessiva morbilità, a partire dalla fondamentale
Cass. S.U. 29 marzo 1980, n. 2072, 2073, 2074 (Perulli, 2005, 16). In tal caso, tuttavia,
l’intervento giudiziale trovava la propria giustificazione nell’espresso riconoscimento del
potere equitativo del giudice in materia di quantificazione del periodo di comporto, operato
dal secondo comma dell’art. 2110 c.c.: non può parlarsi, quindi, di scrutinio di “razionalità”
bensì di determinazione equitativa. Ed è possibile soggiungere, se si vuole, che anche l’art.
2106 c.c., sul quale ci si è già soffermati, riconosce direttamente al giudice la competenza ad
operare un controllo di proporzionalità tra infrazione e sanzione. Ma in questo caso non può
parlarsi — pacificamente — di un giudizio di proporzionalità/razionalità in cui il giudice è
chiamato a farsi l’unico ed esclusivo interprete (o autore?) di tale principio. Viceversa, il
controllo avviene nei diversi termini della concretizzazione della clausola generale, con il
conseguente dovere del giudice di ricavare gli elementi posti a base della decisione dagli
standard valutativi esterni ritenuti più attinenti al caso di specie (primo fra tutti il contratto
collettivo, stando anche all’art. 7, primo comma, dello statuto).
(314) Santoro-Passarelli, G., 1989, ora 2006, 75.
167
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ma non può svincolarsi dalla dimensione testuale di quelle discipline
per sovrapporsi ad esse” (315).
In altri termini, e richiamandosi a quanto già accennato (al
precedente par. n. 5), è difficile sottrarsi all’impressione che, al
fondo, l’idea di un controllo di razionalità (316), di cui la materia
dei criteri di scelta nei licenziamenti per riduzione di personale ha
rappresentato per così dire uno dei fronti avanzati, si riallacci ed
evochi l’immagine di quell’applicazione diretta e per via giudiziale,
estesa anche agli atti di esercizio dell’autonomia collettiva (e
comunque in quei termini potenzialmente espandibile “a tutto
campo”, al di là specifici rinvii legali all’autonomia collettiva (317)
del limite dell’utilità sociale (318), il quale però allude e postula
l’assunzione di specifiche scelte legislative per poter assumere
concretezza precettiva ed acquisire una connotazione di azionabilità.
La tecnica della limitazione funzionale dell’autonomia collettiva non è, del resto, ignota al legislatore, che vi è ricorso (319) a
proposito di una componente di grande peso rispetto agli equilibri
negoziali di alcune categorie di imprese o comparti, ossia gli accordi
sulle prestazioni indispensabili ai cui si applica il combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e 13, comma 1, lett. a della legge 12
(315) Persiani, 1995b, 31. Oltre al controllo sui limiti esterni come quelli di non
discriminazione, è stato affermato che l’accordo sui criteri di scelta è suscettibile di
valutazione giudiziale nel caso in cui i criteri di scelta appaiano “incomprensibili, illogici o
tra loro contraddittori” (Castelvetri, 2000, 95): affermazione che riterrei spiegabile, più che
come una riapertura per una via laterale al controllo di razionalità, alla luce della previsione
legislativa in materia di determinatezza e determinabilità del contratto (1346 c.c.).
(316) Con riferimento al quale si veda anche, nella letteratura recente, Fontana,
2010, spec. 294 ss., nella cui ricostruzione lo scrutinio di ragionevolezza si espliciterebbe, a
seconda dei casi, nel controllo di “proporzionalità” o nel “bilanciamento” tra posizioni
contrapposte ed entrambe tutelate dall’ordinamento; per la dimostrazione di questo assunto, tuttavia, questo autore ricorre ad esempi, come la materia delle sanzioni disciplinari
o l’esercizio del diritto di sciopero, nelle quali la valutazione di proporzionalità ovvero il
necessario contemperamento delle contrapposte posizioni, attraverso l’applicazione dei
limiti esterni, conseguono a specifiche e palesi opzioni legislative, non estensibili o trasponibili automaticamente su altri e diversi terreni.
(317) Come evidenzia, ancora, Santoro-Passarelli, G., 1993, ora 2006, 558 s.
(318) Conforme l’opinione di Carinci, F., 2007, XCIII; in precedenza, sul punto,
Santoro-Passarelli, G., 1981, ora 2006, 487.
(319) per questa notazione Persiani, 1995b, 10; Id., 1999, 15 ss.; D’Antona, 1991, 422.
Più recentemente, Santoro-Passarelli, G., 2009b, 971.
168
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
giugno 1990, n. 146 ed ai fini della concretizzazione di una condizione di legittimità formulata in termini generali come è quella
delle “prestazioni indispensabili” (320).
Anche l’applicazione di questa norma si sviluppa, almeno nei
suoi tratti iniziale e finale, in termini non dissimili dalle altre
fattispecie qui esaminate, con l’intervento di concretizzazione realizzato in prima battuta dall’autonomia collettiva e l’intervento di
verifica del giudice che assume il contratto collettivo come principale standard (321).
Nel mezzo si colloca la valutazione di idoneità della Commissione di garanzia, alla quale è attribuita dalla legge la competenza
allo svolgimento di un giudizio di adeguatezza e in particolare, di
“adeguatezza proporzionale” delle limitazioni definite nell’accordo, quale garanzia del contemperamento tra gli interessi collettivi dei lavoratori, di quelli degli utenti e dell’interesse pubblico ad
un equilibrato contemperamento che (322). Ma in questo caso
l’assoggettabilità del contratto collettivo ad una valutazione di
proporzionalità è il frutto di una chiara scelta legislativa ed è,
inoltre, rimessa ad un soggetto istituzionalmente preposto alla
valutazione del corretto bilanciamento tra differenti posizioni le-
(320) Per una messa a fuoco della nozione di “prestazioni indispensabili” nella
prospettiva teorica delle clausole generali, Curzio, 1992, 109 ss. E sul punto si vedano anche
le osservazioni di Pascucci, 1999, 118, il quale, pur senza prendere posizione sul punto,
evidenzia come gli accordi sulle prestazioni indispensabili esplichino “una funzione definita
(con termini diversi ma sostanzialmente di identico significato) come dichiarativa, specificativa, ricognitiva, esplicativa, ermeneutica, di un precetto che la legge ha già dettato”.
(321) Come evidenzia Curzio, “il giudice interviene in generale, a posteriori, quando
la lesione del bene giudirico tutelato è già avvenuta; la specificazione svolta dalla contrattazione collettiva si colloca, invece, prima di tale momento... La presenza di una regolamentazione peculiare, ma pur sempre generale, perché predisposta a monte e a prescindere
dal singolo episodio conflittuale, comporta evidenti effetti positivi sulla certezza dei rapporti” (Curzio, 1992, 134 s.).
(322) Così la “relazione Ghera” del 23 gennaio 1991 alla Commissione di garanzia sui
criteri di valutazione delle prestazioni individuate negli accordi, in RGL, 1991, I, 544 s.; in
argomento cfr., anche Pino, 2005, spec. 256 ss. Sulla Commissione di garanzia, da ultimo,
Ferrari, 2011, spec. 436 ss. Sulla valutazione della Commissione cfr. anche, in particolare,
Pascucci, 1999, spec. 131 e 133, il quale, tuttavia, considera l’accordo sulle prestazioni
indispensabili come eterogeneo rispetto alla generale categoria degli atti di esercizio dell’autonomia collettiva con cui le parti provvedono, tra l’altro, a disporre degli strumenti
organizzativi propri della gestione dei rapporti di lavoro.
169
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
galmente garantite, piuttosto che non all’organo investito della
(diversa) funzione giurisdizionale (323).
13. L’applicazione giudiziale delle clausole generali di correttezza e
buona fede in funzione di integrazione degli obblighi posti dal
contratto collettivo.
Le ricostruzioni che ipotizzano un controllo giudiziale di razionalità e di proporzionalità dell’agire datoriale si pongono in linea di
continuità, è stato già accennato, con un filone di pensiero ampiamente coltivato negli ultimi decenni, le cui linee portanti sono
andate indirizzandosi verso l’incidenza delle clausole generali di
correttezza e buona fede sul comportamento delle parti del rapporto di lavoro.
Vi sarebbe una contiguità strettissima, in questa prospettiva,
e a tratti un’identificazione, tra controllo degli atti di esercizio dei
poteri datoriali (nonché, come è stato chiaramente puntualizzato,
degli atti di esercizio dell’autonomia collettiva) secondo “razionalità” e “proporzionalità” e l’applicazione delle clausole generali
rinvenibili negli artt. 1175 e 1375 c.c.
Sono due, come è già stato accennato i nodi problematici
evocati da queste ricostruzioni e che possono contribuire a spiegare
le diverse soluzioni che nel periodo più recente hanno riscosso
maggior consenso.
Il primo di questi nodi, a cui già si è fatto riferimento nel
(323) Un contemperamento tra esigenze imprenditoriali e diritti inviolabili della
persona (ovvero che, eventualmente, di bilanciamento tra esigenze di tutela dei lavoratori
di diversa natura, visto il richiamo, tra le altre esigenze, alla sicurezza) è anche quello
rimesso agli accordi previsti dagli artt. 4 e 6 St. lav. Anche qui rinvio al contratto collettivo
non può essere inteso come autorizzazione alla libera definizione in sede collettiva di regole
socialmente adeguate, essendo finalizzato al bilanciamento tra le esigenze di impresa e
posizioni giuridiche individuali il cui contenuto e i cui limiti di compressione conservano la
loro natura di limiti legali; il contemperamento tra queste diverse posizioni potrà essere
verificato ex ante in sede amministrativa (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo e
di conseguente provvedimento di autorizzazione adottato dalla direzione territoriale del
lavoro), ovvero potrà essere fatto oggetto di esame giudiziale in caso di contestazione in sede
giudiziale dei contenuti dell’accordo da parte dei singoli prestatori di lavoro che lamentino
la lesione dei loro diritti alla riservatezza e all’inviolabilità della persona: in argomento, da
ultimo, Trojsi, 2013, 305 ss., anche con riferimento al problematico raccordo con le
previsioni derogatorie dell’art. 8, comma 2, lett. a e comma 2-bis del d.l. n. 138 del 2011.
170
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
precedente paragrafo è rappresentato dalla difficoltà di ricavare
stabili e costanti direttive di giudizio, per l’esclusivo tramite della
mediazione giudiziale, da principi come quelli costituzionali; principi la cui ampiezza e generalità che non sembrano facilmente
conciliabili con l’esigenza di individuare parametri prevedibili,
controllabili e avallati dalla realtà sociale.
Il secondo è rappresentato dalla possibile pervasività di tale
controllo, con particolare riferimento agli atti di esercizio dell’autonomia collettiva, rispetto ai quali rimane l’interrogativo sulla
loro assoggettabilità a limiti interni che, secondo questa prospettazione troverebbero nelle clausole generali il loro fondamento
legislativo.
La risposta a cui l’elaborazione giurisprudenziale è addivenuta, con specifico riferimento al peso assegnabile ai risultati
dell’azione sindacale è, come noto, di segno contrario.
Questo approdo può essere condensato negli assunti per cui le
clausole generali di buona fede e correttezza “consentono al giudice
di accertare che l’adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di
riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva”, inferendosene che “esse attengono alle modalità
comportamentali ed esecutive del contratto quale esso è e non quale si
vorrebbe che fosse. Tali regole non possono quindi essere forzate al
punto di introdurre nel rapporto diritti e obblighi patrimoniali che il
contratto non contempla e anzi esclude” (324). Statuizioni giurisprudenziali che sono state riconosciute come una conferma “della
storica funzione integratrice degli effetti contrattuali, come tali specificatrice di obblighi e doveri già testualmente previsti dalla legge o
dall’accordo collettivo” (325).
Non occorre diffondersi sui punti di contatto e soprattutto, di
complementarietà ordinamentale tra le conclusioni raggiunte dalla
giurisprudenza e gli indirizzi lungo i quali è proceduta la contrattazione collettiva, a partire dal momento in cui quest’ultima ha
(324) Così Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570; in linea con questo principio, tra le
altre, Cass. 25 marzo 2009, n. 7202; Cass. 29 maggio 2006, n. 12721. Per rilievi critici in
merito a quest passaggio della motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite, in particolare, Barbera, 2000, 256.
(325) Montuschi, 1996, 147. Più recentemente si veda Marazza, 2001, 265 ss., spec.
271.
171
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
iniziato ad includere tra i suoi obiettivi privilegiati quello della
procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali (326). Una realtà
il cui consolidamento ha indotto a constatare come l’esigenza di un
controllo di buona fede dei poteri datoriali si sia andata attenuando a fronte dell’ampliamento delle forme di controllo dell’esercizio dei poteri datoriali definite dalla contrattazione collettiva (327).
Se è vero, quindi, che in presenza di una regolamentazione
contrattuale sufficientemente puntuale il ricorso alla regola di
correttezza può apparire nella maggior parte dei casi come un
elemento sovrastrutturale (328), nondimeno permangono spazi,
nel concreto esercizio dei poteri imprenditoriali, entro i quali
l’applicazione di tali clausole rimane un passaggio imprescindibile
per la valutazione di legittimità degli atti del datore di lavoro.
Rispetto a tale esigenza di fondo, sino alle svolte giurisprudenziali di metà degli anni novanta si è assistito al confronto tra
impostazioni di segno diverso orientate, per un verso, verso la
definizione di un quadro di doveri integrativi ulteriori, accessori o
strumentali direttamente riconducibili ai principi di correttezza e
buona fede (con particolare riguardo all’esternazione delle motivazioni poste alla base degli atti datoriali (329)), ovvero improntate,
sul fronte opposto, al mantenimento della coerenza “fra il disegno
contenuto negli impegni contrattuali e la scelta puntualmente operata”
posto che “le clausole generali non operano quali strumenti integralmente sostitutivi della volontà delle parti ...ma solo quali integratori di
quella volontà in funzione di riequilibrio e di misura dei poter
concretamente esercitabili” (330) e, dunque, “come parametri di
adeguamento dell’obbligato all’esattezza dell’adempimento” (331).
La scelta interpretativa che ha finito con il prevalere, come
premesso, è stata nel secondo senso, dovendosi, comunque, puntualizzare che l’accoglimento di questa opzione non ha precluso
(326) Sul rapporto tra tecniche di procedimentalizzazione e regole di correttezza e
buona fede, in particolare, Tullini, 1990, 176 ss.; Zoli, 163 ss., 214 s.
(327) Persiani, M., 1995a, 147.
(328) Tullini, 1990, 200, con richiamo a Rodotà, 1969, 179.
(329) Tullini, 1990, spec. 199 ss., Zoli, 1988, 231 ss. e, sulla stessa linea, Barbera,
1991, 265 ss.
(330) Mazzotta, 1989, ora 1994, 148.
(331) Mazzotta 1987, ora 1994, 180. E si veda, ora, Marazza, 2012a, 1309.
172
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
l’elaborazione di figure sintomatiche di comportamenti conformi a
buona fede e correttezza entro il perimetro obbligatorio segnato
dalla contrattazione collettiva, come è avvenuto, oltre che in
materia di concorsi privati (332), con riferimento alle tematiche
delle note di qualifica (333), di giustificatezza del licenziamento del
dirigente (334), di modalità di esercizio del potere disciplinare (335).
Questa dinamica di delimitazione dell’ambito di applicazione
delle clausole generali, naturalmente, si presta a molteplici e non
univoche chiavi di lettura.
Una tra le più realistiche è connessa alla constatazione per cui
l’ambito della solidarietà contrattuale, la quale potrebbe in
astratto essere addotta quale giustificazione degli obblighi strumentali a garanzia della buona fede in executivis, nel diritto del
lavoro incontra un limite fisiologico nella “forte” contrapposizione
di interessi tra le parti, una contrapposizione che trova un punto di
mediazione e insieme un confine nel contratto e segnatamente nel
contratto collettivo (336).
Ipotizzare che, al di là di questo confine, il giudice possa
muovere alla ricerca di punti di riferimento che riflettano, anche
per il tramite del richiamo alle clausole generali di buona fede e
correttezza, valori e parametri esterni al comune sentire delle parti
allora rischia di apparire, come confermato anche da una nota
ricostruzione civilistica, non come un’operazione di ausilio alla
cooperazione tra le parti medesime ai fini del completamento del
regolamento contrattuale, bensì come rottura di una composizione
di interessi antagonistici che anziché favorire la cooperazione tra le
(332) Cfr., da ultimo, Cass. 7 febbraio 2014, n. 2836; Cass. 24 marzo 2009, n. 7053;
Cass. 14 settembre 2005, n. 18198.
(333) Ad es. Cass. 27 settembre 2011, n. 19710; Cass. 11 febbraio 2008, n. 3227; Cass.
8 agosto 2003, n. 12013.
(334) A partire da Cass. S.U. 9 dicembre 1986, n. 7295; più recentemente, Cass.12
febbraio 2000, n. 1591; Cass. 8 novembre 2002, n. 15749, LG, 2003, 274; Cass. 28 ottobre
2005, n. 21010, ADL, 2006, 1356, con nota di Topo; sulla riconducibilità della nozione di
giustificatezza al vincolo fiduciario e, quindi, all’oggetto del contratto di lavoro dirigenziale,
Tosi, 2012a, 459; Id., 2012b, spec. 545 s.; Id., 1996, 393, per l’esplicita qualificazione della
giustificatezza come clausola generale.
(335) In materia di immediatezza della contestazione, ad es., Cass. 9 settembre 2003,
n. 13190; Cass. 8 gennaio 2001, n. 150.
(336) Mazzotta, 1989, ora 1994, 147; e si veda anche Persiani, 1995a, 139.
173
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
parti del contratto, rischia di alterarne irrimediabilmente gli equilibri (337).
Di qui l’interrogativo se effettivamente sussistano condizioni e
necessità per una revisione di quest’opzione.
Se è vero, come pare, che la raffigurazione in chiave moderna
del rapporto di lavoro come una relazione caratterizzata essenzialmente dalla supremazia datoriale e dallo stato di soggezione del
prestatore di lavoro fornisce una visione tutto sommato parziale di
un fenomeno giuridico che, nella sua concretezza attuale, appare
come la risultante dell’equilibrio di tre sfere regolative, ossia quella
legale, quella collettiva e quella dei poteri imprenditoriali — le quali,
per così dire, si fronteggiano e si autolimitano vicendevolmente —,
si potrebbe ritenere, allora, che le ragioni di conservazione delle
pre-condizioni di questo equilibrio prevalgano tuttora sulle spinte
favorevoli ad una maggiore influenzabilità di tale equilibrio da
parte di attori esterni.
Questo perché, se da una parte la fissazione di limiti esterni
equivale ad una definizione preventiva delle “regole del gioco”,
dall’altra l’eventuale espansione dei margini di controllo giudiziale
attraverso la regola della buona fede implicherebbe l’eventualità
che questi assetti regolativi siano rimessi in discussione nel loro
complesso, ossia nella loro globalità, nel momento in cui l’area dei
rispettivi obblighi viene ad essere estesa oltre il perimetro originariamente percepibile dalle parti (338).
È un’eventualità che può essere considerata o meno come
coessenziale all’esigenza di un’adeguata salvaguardia dei diritti
fondamentali del prestatore di lavoro (ad anche qui il dibattito è
troppo esteso per essere ripreso in questa sede, anche perché in
massima parte declinato in prospettiva individualistica e perciò
estraneo all’angolo visuale dell’autonomia collettiva), ma sulla
quale non sarebbe realistico sorvolare.
Ulteriori elementi di riflessione in tal senso vengono offerti,
(337) Monateri, 2003, 413.
(338) Evidenzia coerentemente questa implicazione Barbera, 2000, 265, quando
rileva che l’accoglimento dell’impostazione accolta dalla sentenza n. 103 del 1989 della Corte
Costituzionale, nella parte in cui prefigura il controllo giudiziale degli atti di esercizio dei
poteri datoriali sulla base della loro coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento
(con richiamo specifico all’utilità sociale) implica “la destrutturazione di alcune delle categorie
su cui si è costituito il diritto del lavoro, a cominciare dalla categoria dell’interesse collettivo”.
174
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
anche su questo versante, dal diritto civile, dove la dottrina ha
accolto in maniera fortemente critica, con valutazione pressoché
unanime, alcuni recenti interventi giurisprudenziali orientati a
favore di una lettura della buona fede che ne esaspera la portata
correttiva o, meglio, destrutturante: al punto di spingersi a valutare quale abuso del diritto, qualificato dai giudici di legittimità
come “criterio rivelatore dell’obbligo di buona fede oggettiva”, l’esercizio di una facoltà (nella specie, di recesso) contrattualmente
prevista: ciò in considerazione della disparità di forze tra i contraenti e riconoscendosi la conseguente assoggettabilità a controllo
dell’esercizio di tale facoltà sotto il profilo (rimesso all’apprezzamento del giudice) della “proporzionalità” dei mezzi usati per
pervenire all’esito voluto (339). Con il risultato, è stato scritto, di
mettere a nudo “le insidie implicite in un ‘paternalismo benevolente’
che, rivisitando ex post le opzioni contrattuali le ridisegni in funzione
di apprezzamenti esterni e (suppostamente) oggettivi, deresponsabilizzando le parti in sede programmatica, salvo astringerle ad un
contratto mai voluto” (340).
Sono considerazioni che in certa misura potrebbero essere
adattate anche al quadro dei diritti ed obblighi delle parti del
rapporto di lavoro come definiti anche attraverso la mediazione
dell’autonomia collettiva e che, dunque, in una certa misura,
mettono in guardia rispetto alle prospettive di ampliamento dell’ambito del controllo giudiziale sulla base del parametro della
buona fede in senso oggettivo; o, comunque, pongono in luce
possibili implicazioni problematiche con le quali, nell’ambito dei
discorsi orientati verso queste prospettive, risulterebbe indispensabile confrontarsi.
(339) Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, tra le altre in FI, 2010, 85, con nota di
Palmieri e Pardolesi e in GI, 2010, I, 556, con nota di Scaglione, (e si vedano, ancora, i
commenti di Orlandi e Scognamiglio, C., NGCC, 2010, 129 ss. e di Cenini, e Gambaro 2011,
109 ss.); in precedenza, valutazioni altrettanto critiche erano state espresse con riferimento
a Cass. S.U. 15 novembre 2007, n. 23726, FI, 2008, I, 1514 e RDC, 2009, II, 347, con nota
di Donati, secondo la quale “il frazionamento giudiziale di un credito unitario è contrario alla
regola generale di correttezza e buona fede, in relazione agli inderogabili doveri di solidarietà di
cui all’art. 2 Cost.: tale comportamento si risolve in un abuso del diritto, in particolare del diritto
di azione, che preclude l’esame della domanda. In presenza di un unico rapporto obbligatorio il
credito non può essere parcellizzato al fine di adire, per ogni singola parcella, un giudice
inferiore a quello competente alla cognizione del rapporto unitariamente considerato”. Per
considerazioni in argomento si veda anche Scaglione, 2010, 103.
(340) Così Palmieri, Pardolesi, 2010, 97.
175
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
14. Conclusioni. La relazione tra clausole generali e autonomia collettiva come possibile percorso di “costruzione della normalità”.
Nell’accingersi a formulare alcune brevi considerazioni di sintesi finale, si può partire dalla constatazione — certamente scontata, occorre ammettere — che l’ampiezza del tema e lo spessore
degli interrogativi che esso evoca consentono certamente di orientare l’approfondimento del tema delle clausole generali verso una
pluralità di direzioni e di sposare diverse opzioni di senso.
Un’impostazione che sembra aver trovato alcune conferme nel
tragitto sin qui compiuto è quella secondo la quale la riflessione
sulle clausole generali può contribuire (come auspica C. Castronovo) a rendere meno labile il confine tra legislazione e giurisdizione (341) nel momento in cui venga impostata come un percorso
di “costruzione della normalità” (342); percorso che può divenire
praticabile se si accoglie l’idea che le clausole generali rappresentano degli strumenti per trasportare nella dimensione del diritto
statuale i canoni di normalità, i valori della vita ordinaria accolti
come tali in uno specifico gruppo sociale o professionale, operando
come un indispensabile canale di adattamento del diritto agli
“equilibri di coordinazione” raggiunti da parte dei privati. E da
questo punto di vista, non sembra revocabile in dubbio come il
raccordo con l’autonomia collettiva rappresenti uno snodo fondamentale di questa dinamica di collegamento.
Sennonché si è avuto occasione di osservare che nei “discorsi”
(dottrinali e giurisprudenziali) in materia di clausole generali nel
diritto del lavoro, con particolare riguardo ai collegamenti con
l’autonomia collettiva, è dato di cogliere, con una certa frequenza,
alcuni passaggi caratterizzati da un incedere circolare dei ragionamenti che lascia aperto più di un dubbio sul lineare funzionamento
di queste connessioni.
Questo accade ad esempio quando, con riferimento a quelle che
vengono correntemente definite come clausole elastiche, da un lato
si accolgono le indicazioni del contratto collettivo, riconoscendolo
espressamente come indicatore o fonte di appropriati standard
valutativi, dall’altro e simultaneamente si ritiene che lo standard
sia suscettibile di rilettura da parte del giudice alla luce di una non
(341) Cfr. Castronovo, 1986, 29.
(342) Luzzati, 2013, 185 ss.
176
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
altrimenti specificata “nozione legale” ovvero dei frequentemente
richiamati ma mai specificati “principi di civiltà del lavoro” (343).
Ovvero quando si teorizza un controllo di ragionevolezza o razionalità, estensibile anche alla contrattazione collettiva, attribuendo
al giudice il ruolo di interprete e, si direbbe, si artefice di questa
razionalità ma, al contempo, si evidenzia come tale controllo
potrebbe consentire al giudice di individuare comportamenti socialtipici anche (facoltativamente, verrebbe da soggiungere)
traendo ispirazione dai risultati raggiunti dalla stessa autonomia
collettiva (344).
Questa circolarità, così come il gioco di specchi tra gli interventi dell’autonomia collettiva e l’intermittente e sovente distorta
“imitazione” giudiziale degli stessi che su di essa si innesta, come
dimostrano tanto l’esperienza giurisprudenziale, quanto il confronto con alcuni orientamenti dottrinali, sono un punto di analogia che si riaffaccia sia nell’applicazione pratica delle clausole
generali tradizionalmente intese, ossia quelle di buona fede e
correttezza, sia in quella delle c.d. norme elastiche (prime fra tutte
quelle, stando almeno alla qualificazione che ne dà buona parte
della dottrina, sulla giusta causa e sul giustificato motivo soggettivo).
È, questo, uno tra i molti elementi di prossimità tra le due
categorie di “oggetti” normativi partendo dai quali si è cercato di
argomentare la confluenza di entrambi i modelli all’interno di una
(343) Cfr., recentemente, sul punto, Cass. 15 luglio 2013, n. 17315. Gli esempi più
eloquenti dei paradossi o, per lo meno, delle macroscopiche divergenze valutative conseguenti a questa impostazione sono quasi sempre mutuati dalla materia dei licenziamenti:
come, ad es., Cass. 13 agosto 2008, n. 21575, NGL, 2009, 67, che ha cassato la decisione del
giudice di merito per cui l’allontanamento non autorizzato dei cassiere dal posto di lavoro,
senza previa chiusura della cassa e il rifiuto opposto nei confronti dei clienti di svolgere
operazioni specificamente regolate da procedure aziendali avrebbero potuto essere letti alla
luce di una prassi “dettata dal buon senso” e come tali non meritevoli di essere sanzionati con
il licenziamento. Per converso, secondo Cass. 26 giugno 2013, n. 16095, l’abbandono del
posto di lavoro da parte dell’addetto alla vigilanza privata con mezz’ora di anticipo dalla
fine del turno, comportamento espressamente previsto dal contratto collettivo come motivo
di licenziamento, può essere qualificato come un inadempimento non meritevole della
sanzione estintiva. Per ulteriori esempi si rinvia, da ultimo, a Nogler, 2014, 132 ss.
(344) Zoli, 1988, 227; Perulli, 2006, 448, secondo i quali, tuttavia, il giudice sarebbe
libero di estendere, in applicazione del principio di buona fede, soluzioni elaborate dall’autonomia collettiva anche a settori diversi da quelli in qui tali soluzioni sono state introdotte;
contra Persiani, 1995a, 148.
177
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
definizione unitaria, inclusiva e ampia di clausola generale, peraltro in linea con alcuni orientamenti della moderna civilistica che fa
leva sulla loro comune sostanza di norme di rinvio a parametri che
riflettono le ragionevoli aspettative della vita sociale (345).
Si è constatato, altresì, che l’ampliamento di prospettiva conseguente a questa ridefinizione della categoria delle clausole generali può essere di ausilio per una più nitida messa a fuoco dell’ambito o degli ambiti valoriali verso i quali le medesime si rivolgono;
vale a dire, per sfruttare la celebre metafora, per meglio comprendere verso quale tipo di “realtà” giuridicamente rilevante sono
orientate le “finestre” che il legislatore colloca nell’edificio ordinamentale attraverso le disposizioni di legge che contengono al loro
interno delle clausole generali.
Un interrogativo che induce ad interrogarsi in via ulteriore, si
è detto, sulla scelta dei criteri di riferimento per l’integrazione delle
clausole generali; i quali possono essere alternativamente ricercati,
a seconda delle opzioni ricostruttive verso le quali ci si orienta, o
negli standard che esprimono, al di fuori del sistema delle fonti in
senso formale, la c.d. coscienza sociale o, diversamente nei “principi” giuridici espressi od accolti dall’ordinamento statuale o dagli
ordinamenti sovranazionali ovvero da essi teoricamente “sintetizzabili” (346).
La scelta verso la quale è apparso preferibile indirizzarsi,
supportata del resto da più di un’opinione scientifica, procede nel
primo senso, in base alla convinzione che il riferimento ai frutti dei
c.d. sottosistemi regolativi extralegali sia il criterio che meglio
esprime quella funzione di contatto con le valutazioni sociali
generalmente o diffusamente condivise che può dirsi in generale
assegnata alle clausole generali.
L’ulteriore conseguenza di una delimitazione di tipo “ampio”
del campo di indagine, è che essa ha reso possibile una perlustrazione trasversale e una ricognizione della pluralità e della diversificazione morfologica dei vari modelli di clausola generale che sono
(345) Luzzati, 2013, 182, il quale, come già rammentato, manifesta contrarietà
rispetto al possibile utilizzo delle clausole generali come strumento di introduzione nelle
relazioni interprivate di “valori nuovi, rivoluzionari o principi etici esigenti” ovvero come
mezzo “per fondare istituti e conferire al sistema una maggiore coerenza sistematica, data la
costitutiva — e irrinunciabile — variabilità storico-contestuale degli standard cui è fatto rinvio”.
(346) Libertini, 2011, 349.
178
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
andati ramificandosi nella crescita notoriamente alluvionale della
legislazione lavoristica. E l’osservazione del fenomeno delle clausole generali, sviluppata in una prospettiva né atomistica (ossia
con riferimento a singole e particolari fattispecie) né, all’opposto,
generalissima e astratta, bensì percepita nelle dimensioni e nella
consistenza che assume nello specifico giuslavoristico, permette di
giungere a constatazioni che trascendono il piano descrittivo per
investire quello del significato e delle modalità peculiari di concretizzazione giudiziale delle clausole generali.
Questo perché all’elemento che si è identificato come strutturale e fisiologico del rinvio (347), viene ad abbinarsi quello, se si
vuole ancor più consueto e dato per scontato ma raramente associato a questa prospettiva, della rilevanza presuntiva del contratto
collettivo come dato di tipicità sociale idoneo alla concretizzazione,
integrazione, specificazione della clausola generale.
In questo abbinamento, si ribadisce, è sembrato di poter
scorgere il punto di contatto più sostanzioso tra il fenomeno delle
clausole generali e l’autonomia collettiva. Potrebbe forse dirsi che
questa presunzione, nelle varie forme in cui si esplica all’interno di
ciascuno dei diversi contesti legislativi esaminati, ponga in luce un
particolare risvolto (o un possibile tratto di assottigliamento) della
bivalenza normativa del contratto collettivo (348). Ciò nel senso,
anche se è chiaro che si tratta di una considerazione che meriterebbe certo ulteriori approfondimenti, che questa interrelazione
potrebbe essere letta (cosa che spiegherebbe, del resto, il fatto che
il giudice possa essere chiamato a rapportarsi ai fini della concretizzazione della clausola generale non con un contratto collettivo
monisticamente inteso, ma come prodotto di un sistema contrattuale, come tra poco si dirà) in termini di possibile declinazione, in
chiave squisitamente privatistica, della prospettiva pluriordinamentale di matrice giugniana, raccogliendo, peraltro, un’esorta(347) Si è constatato che il concorso del contratto collettivo al completamento del
significato della previsione legale si manifesta, nella maggior parte dei casi, nella forma del
rinvio implicito; ma l’evoluzione legislativa induce a non considerare questa specifica
modalità come una costante, dal momento che il legislatore individua, come si è visto,
ipotesi nelle quali al contratto collettivo è attribuita una competenza esclusiva ad “individuare” o “specificare” i contenuti della clausola generale (cfr. il paragrafo n. 11).
(348) Sulla cui persistente utilità ai fini della comprensione delle diverse forme di
efficacia del contratto collettivo, Santoro-Passarelli, G., 2013b, 110; Ghera, 2012, 206 s.
179
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
zione in tal senso a suo tempo espressa dal suo stesso scopritore (349).
Si è proceduto, in altri termini, nella direzione dello sviluppo e
dell’adattamento, nella particolare direzione tematica delle clausole generali, di quell’enunciazione teorica, di portata più ampia,
secondo la quale il contratto collettivo può ben assumere “una
molteplicità di valenze giuridiche, sia dal punto di vista dell’ordinamento da cui proviene (cioè il sistema contrattuale) sia in relazione ai
diversi apprezzamenti di cui è fatto oggetto nell’ordinamento giuridico-statuale” (350); nel senso che una utile chiave d’approccio alle
complessità dei fenomeni normativi può essere quella di considerare “che ciascun sistema o contesto normativo determini un distinto
campo di rilevanza del contratto collettivo, avendo le norme dei vari
sistemi un contenuto precettivo diversamente orientato” (351).
Volendo esplicitare i termini di tale rilevanza nel contesto
preso in esame, dall’indagine compiuta è emerso che il raccordo tra
le clausole generali e la fisiologica e irrinunciabile attitudine del
contratto collettivo ad integrare il dato legale (352) implica, da una
parte, la priorità valutativa accordata dall’ordinamento alla concretizzazione delle clausole generali da parte dell’autonomia collettiva e la necessità per il giudice di motivare eventuali scelte
interpretativa differenti sulla base di parametri “esterni” e controllabili, spiegando le ragioni della loro maggiore aderenza alla
ratio della norma legale. Dall’altra, tale correlazione comporta che
l’incidenza delle clausole generali di buona fede e correttezza e la
connessa elaborazione in via di integrazione di figure sintomatiche
(349) Giugni, 1992, 75. Nella medesima prospettiva, recentemente, Ghera, 2009,
spec. 361. In precedenza, sul “coordinamento tra sotto-sistema giuridico intersindacale e
sotto-sistema giuridico statale” come possibile risultato della rilettura “funzionalisticosistemica” dell’ordinamento intersindacale, Vardaro, 1984, 123.
(350) Mariucci, 1985, 452.
(351) D’Antona, 1990, ora 2000, 62. E a tal proposito, nella prospettiva di questo
studio, è possibile fare direttamente richiamo al pensiero di Giugni laddove, nella sua
relazione al Convegno di Pescara-Teramo, del 1966 venivano simultaneamente evidenziate,
da una parte la sostanza di dato di tipicità sociale del contratto collettivo, messo a fuoco
anche nella sua dimensione storica, dall’altro la rilevanza specifica dallo stesso assunta quale
canale di realizzazione dei principi costituzionali di tutela del lavoro (Giugni, 1967, ora 1989,
182 e 160). In argomento da ultimo, Speziale, 2012b, spec. 369 s.
(352) Potendosi convenire senz’altro sulla sostanziale “impossibilità di fare a meno...della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, indispensabile per la stessa applicazione della legislazione lavoristica” (così Rusciano, 2003, 39).
180
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
da parte del giudice rimangono delimitate al perimetro degli obblighi contrattualmente definiti dal contratto collettivo (353).
Disposizione legale e standard di fonte collettiva finiscono per
trovarsi allineati, quindi, sull’asse di una sequenzialità (non in ogni
caso sufficiente, ma) necessaria. Necessaria nel senso che il “tenere
conto” delle previsioni del contratto collettivo — per mutuare la
terminologia dell’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010 —
rappresenta per il giudice un passaggio ineludibile per la costruzione della “regola” di decisione del caso concreto.
Il procedimento di concretizzazione giudiziale della clausola
generale a volte si esaurisce nell’ambito di questo passaggio per
espressa volontà del legislatore (ed è ciò che accade quando la legge
conferisce in via esclusiva al contratto collettivo la competenza
alla concretizzazione delle clausole generali mediante un rinvio
espresso). Nella maggior parte degli altri casi allo stesso risultato si
perviene (affermazione che trova conferma nella quotidianità giurisprudenziale) in quanto il giudice accetta il dato proveniente dal
contratto collettivo come espressione dello standard più confacente
all’ambito professionale entro il quale la clausola generale deve
trovare applicazione.
Ferma restando, in caso di rinvio “implicito” la possibilità del
giudice di richiamarsi, motivatamente — e potrebbe dirsi in seconda istanza —, a sistemi valoriali alternativi, la concretizzazione
della clausola generale rimane comunque un percorso che si sostanzia nel collegamento tra la norma e le linee di condotta ricavabili
da elementi “esterni” socialmente condivisi e controllabili, tra
quali primeggia necessariamente il contratto collettivo.
A tal proposito è stato recentemente evidenziato come, in sede
di valutazione degli atti di esercizio dei poteri datoriali, non possa
darsi per scontato “che il giudice possa o debba sempre sostituirsi al
titolare per domandarsi cosa avrebbe fatto al suo posto”, dal momento
che il potere “deve essere sentito dalle parti e valutato come espressione della convivenza e delle regole che questa proietta” (354). Un’affermazione che appare del tutto condivisibile, a condizione di
ammettere che tali “regole” vadano ricercate, in primo luogo, nella
(353)
(354)
Sul punto, nella letteratura recente, Carinci, F., 2007, XCV.
Gragnoli, 2011, 537.
181
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sede strutturalmente preordinata all’enunciazione di queste regole,
che rimane fisiologicamente quella della contrattazione collettiva.
Viene a porsi al di fuori di questa prospettiva, al contrario, una
valutazione svincolata da questi riscontri ed espressa sulla base di
“nozioni legali” ovvero di “principi” direttamente o indirettamente espressi dall’ordinamento ma non trasfusi né ricollegabili a
norme direttamente vincolanti per i privati. Con ciò intendendo
che una concretizzazione delle clausole generali realizzata attraverso la sovrapposizione di una “nozione legale” autonomamente
espressa dal giudice (con il forte ed inevitabile rischio di solipsismo)
alla lettura della clausola generale operata dalla contrattazione
collettiva, è un’operazione che il giudice finirebbe (di fatto finisce,
a volte) per compiere avventurandosi nella strettoia tra la valutazione equitativa, che pure rimane inammissibile in assenza di una
esplicita autorizzazione legale, e la identificazione tra la clausola
generale e il principio, che contraddice o quanto meno impoverisce
senso e autonomia concettuale della seconda (355).
Occorre segnalare, altresì, che il recepimento del dato di tipicità sociale offerto dal contratto collettivo implica anche una
valutazione sulla sua provenienza, nel senso che l’attitudine del
contratto collettivo a rappresentare un valido schema di concretizzazione della clausola generale si misura anche sulla base del
livello di condivisione che il contratto collettivo riscuote nell’ambito del gruppo o settore professionale in cui il rapporto di lavoro
si ambienta.
Almeno nel caso di rinvio c.d. implicito non può certamente
farsi riferimento a criteri selettivi di fonte legale (356), sicché
sarebbe fuorviante il riferimento diretto alla rappresentatività dei
soggetti stipulanti (357), quale criterio di selezione dello standard
contrattual-collettivo maggiormente attendibile; nondimeno, si
tratta di un elemento che, su un piano indiretto, il giudice è
chiamato a prendere in considerazione.
(355) È utile ancora una volta il richiamo a Belvedere, 1989, 639 ss.
(356) Mentre non è così nel caso dei rinvii espressi richiamati al precedente paragrafo
n. 11, nei quali il legislatore provvede a definire i criteri di selezione dei soggetti negoziali
abilitati ad intervenire in funzione di concretizzazione della clausola generale.
(357) Alla quale pure si è fatto richiamo in passato, ma sulla base di un modello
ricostruttivo e con riferimento ad un quadro ordinamentale ormai profondamente mutato:
cfr. Ferraro, 1981, 275 ss.
182
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Questo perché non è revocabile in dubbio che il “canone di
normalità” offerto dal contratto collettivo appare meritevole di
essere preso in considerazione se e in quanto risulti elaborato
all’interno di un sistema negoziale in grado di rispecchiare fedelmente le aspettative del gruppo professionale di riferimento (358).
È evidente come su questo versante non siano enucleabili
rigide direttive di giudizio, ma è altrettanto plausibile riconoscere
che le indicazioni desumibili dall’ordinamento sindacale in materia
di assetti negoziali e di rappresentatività dei soggetti o delle
coalizioni negoziali ai fini della legittimazione negoziale si profilano
come altrettante linee di orientamento imprescindibili per il giudice.
L’osservazione ha anche un risvolto di carattere, per così dire
riflessivo che pertiene la stessa valutazione di rappresentatività
che, a seconda dei contesti, il giudice viene chiamato a recepire
dalle fonti legali o contrattuali che ne definiscono i criteri e le
condizioni di attribuzione.
Una valutazione che, alla luce dell’evoluzione legislativa e
contrattuale, non segue lo schema dell’applicazione di clausole
generali, in quanto rinvia a specifici criteri quantitativi o precisi
riscontri oggettivi. Prima fra tutte, naturalmente, la fattispecie
contemplata dall’art. 19 della legge n. 300 del 1970, nella quale il
legislatore (con l’apporto “correttivo” della Corte costituzionale
attraverso la sentenza n. 231 del 2013) ha individuato un criterio
selettivo che non si concretizza né in una clausola generale né in
una norma elastica, ma rinvia a circostanze oggettive e concrete
come quelle della sottoscrizione del contratto collettivo o della
partecipazione alle trattative. Si tratta, pertanto, di un dato
normativo non suscettibile di valutazione e che, dunque, il giudice
non ha il potere di riscrivere, sostituendo il dato normativo puntuale con una concezione di rappresentatività accolta o forgiata
dallo stesso giudice per individuare le associazioni sindacali abilitate a costituire le r.s.a. vanificando la scelta del legislatore (359).
(358) Per considerazioni sul collegamento tra rilevanza parametrica del contratto
collettivo ai fini della determinazione della giusta retribuzione ex art. 36, primo comma,
Cost. e rappresentatività degli attori negoziali, si veda Ichino, 2010, 742, e ci si permette,
altresì, di rinviare a Bellomo, 2002, 66 s., 208 ss.
(359) La problematica della rappresentatività sindacale e della sua regolazione
nell’ordinamento statuale e in quello sindacale, così come la sterminata letteratura in
183
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Una scelta diversa, in definitiva, darebbe luogo ad un’autentica inversione di percorso, mediante la quale il giudice finirebbe
con il trasformare una previsione puntuale in una norma elastica,
autoattribuendosi al contempo il potere di operarne la concretizzazione sulla base della sua personale lettura della realtà delle
relazioni industriali.
Per chiudere e sfruttando ancora una volta le suggestioni
offerte dal diritto civile, potrebbe ben dirsi che quello che si è
ritenuto di poter scorgere nel collegamento tra le due categorie
della scienza giuridica il cui connubio dà il titolo a questa relazione
può prestarsi ad essere definito come un abbinamento caratterizzato, veniva anticipato nel precedente paragrafo, dalla “rudezza”,
che riflette una concezione del contratto fisiologicamente antagonista nella quale l’accordo costituisce il punto di incontro fra parti
naturalmente antagoniste e nel quale qualunque “riempimento”
eteronomo “richiede una giustificazione ben più forte dell’usuale”,
perché qualunque interferenza mette in discussione gli equilibri
(non solo economici, ma nel caso dell’autonoma collettiva anche
sociali) sottesi all’accordo stesso (360).
Si ammette certo, anche in questa logica, che in nome della
buona fede sia ammissibile un intervento di riequilibrio di posizioni
contrattuali in origine diseguali, caratterizzate cioè da una disparità di potere negoziale (361). Ma è un distinguo che, proprio
perché fa leva sul divario che può manifestarsi tra le parti del
rapporto individuale, perde la sua giustificazione nel momento in
cui tale divario viene colmato dall’intervento riequilibratore del
contratto collettivo (che, per inciso, costituisce il modello di riferimento della concezione “rude” del contratto propugnata da
Monateri).
Che la riflessione sull’impiego delle clausole generali debba
tener conto di queste connotazioni di sistema e delle controindicamateria, richiederebbero svolgimenti ben più diffusi (sulla pluralità di dimensioni giuridiche
della rappresentatività, oltre al classico riferimento a Ferraro, 1981, passim, cfr., in
particolare, Caruso, 1992, spec. 91 ss.; Campanella, 2000, sul punto 301 ss.), che, tuttavia,
condurrebbero la trattazione oltre i limiti non solo dimensionali ma, soprattutto, tematici
entro i quali deve essere mantenuta. Pertanto, si è ritenuto di limitare l’esposizione dei punti
di contatto tra le due tematiche alle sole osservazioni formulate nel testo.
(360) Monateri, P. 2003, ult. loc. cit.
(361) Ancora, Monateri, 2005, 70. In argomento si veda, altresì, Barcellona, 2002,
spec. 313 ss.
184
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
zioni da esse derivanti era già stato icasticamente sottolineato,
come si rammentava, da Giugni, quando metteva in guardia la
comunità scientifica dalla tentazione di ricavare da questi strumenti normativi “un concetto generale di discrezionalità da applicare
al rapporto di lavoro”, con il connesso rischio di emarginare “definitivamente il diritto del lavoro dai suoi rapporti con l’economia di
mercato” (362).
La statura culturale e la sensibilità giuridica e sociale dell’autore di questo avvertimento possono essere di ausilio per andare
oltre l’impressione tutto sommato semplicistica di un cedimento a
pure logiche mercantilistiche e per risalire alla sua più profonda
giustificazione ordinamentale, che permette di riconoscerne la perdurante validità. Nel senso che, come evidenziato successivamente
da Persiani, qualunque verifica delle scelte valutative operata
all’interno del sistema normativo del lavoro non può prescindere
né dalla coessenzialità e dalla fisiologica compenetrazione tra i
diversi valori che in esso si confrontano né del riconoscimento del
contratto collettivo come sede in cui le parti definiscono il punto di
equilibrio dei contrapposti interessi mediante l’individuazione dei
diritti dei lavoratori e dei limiti ai poteri dei datori di lavoro (363).
Tutte affermazioni, si potrebbe dire, che a ben vedere rispecchiamo la medesima impostazione di fondo laddove confermano,
da angolature differenti, la convinzione che tra i presupposti degli
equilibri di sistema del diritto del lavoro figura tuttora quello per
cui il diritto privato è e deve necessariamente rimanere, innanzitutto, un terreno aperto alla libera espansione dell’autonomia
collettiva e non uno strumento di compressione, di “preterintenzionali” attribuzioni di senso o di addomesticamento della stessa
autonomia collettiva verso direzioni e obiettivi che le rimangono
(362) Giugni, 1992, 74.
(363) Così che lo stesso sindacato, in realtà, concorre alla “funzione di regolazione del
lavoro in ragione dell’economia, cioè del mercato”: così Persiani, 2000, 25, nel testo e in nota
105. In precedenza, nello stesso senso, Scognamiglio, R., 1994, ora 1996, 949, il quale osserva
come il codice civile, anche grazie all’opera di reinterpretazione realizzata dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, raggruppa “le regole disciplinatrici del lavoro subordinato
...senza voler interferire nel ruolo della contrattazione collettiva, di grande mediatrice dei conflitti
di interessi collettivi che travagliano il mondo del lavoro, con una autoregolamentazione,
destinata ad operare principalmente nell’ambito delle categorie, che appare insostituibile per i
pregi della sua aderenza alla realtà concreta e alla sua specificità”.
185
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
estranei; una convinzione che, condensando in ultimo il risultato di
queste riflessioni, merita ancora di essere coltivata.
Riferimenti bibliografici.
ABI — ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Linee guida dell’Associazione Bancaria
Italiana per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche, s.d., in www.abi.it.
AIMO M., Il contratto a termine alla prova, LD, 2006, 459.
ALES E., Dal “caso FIAT” al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le
sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali, WP CSDLE “Massimo D’Antona”
n. 134/2011, http://csdle.lex.unict.it/.
ALES E., I paradossi della tipizzazione: i “contratti” di lavoro intermittente, nel
volume Diritto del lavoro — I nuovi problemi, Omaggio dell’Accademia a
Mattia Persiani, Padova, 2005, II, 857.
ALESSI C., Professionalità e contratto di lavoro, Milano, 2004.
ALTAVILLA R., I contratti a termine nel mercato differenziato, Milano, 2001.
ALVINO I., Autonomia collettiva e legge nella regolazione dei rapporti di lavoro a
termine, in (a cura di) DEL PUNTA R., ROMEI R., I rapporti di lavoro a termine,
Milano, 2013, 35.
AMOROSO G., Sanzioni disciplinari, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza
sociale, a cura di Santoro-Passarelli G., Milano, 2014, 949.
ANGIELLO L., Il luogo di lavoro, Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da Persiani M.
e Carinci F., vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, tomo I, a cura di
Martone, M., Padova, 2012, 710.
ASSANTI C., Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro, Milano, 1964.
AZZONI G., Religioni aziendali, intervento al Convegno di Sociologia del Diritto su
Diritto/Diritti, Morale/Morali, Religione/Religioni, Cagliari, 19-20 settembre
2003, www.cfs.unipv.it.
BALDUCCI C., CARABELLI U., Il sindacato, t. 1, L’organizzazione sindacale, Torino,
1984.
BALLESTRERO M.V., Dell’estinzione del rapporto di lavoro, Commentario del Codice
Civile diretto da Gabrielli E., artt. 2118-2187, a cura di Cagnasso O. e
Vallebona A., Milano, 2013, 3.
BALLESTRERO M.V., Licenziamento individuale, ED, Annali V, 2012, 791.
BALLESTRERO M.V., Perturbazione in arrivo. I licenziamenti nel d.d.l. 1167, LD,
2009, 3.
BALLESTRERO M.V., Giusta causa e giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ne
La disciplina dei licenziamenti dopo le leggi 108/1990 e 223/1991, a cura di
Carinci F., 1991, 95.
BALLETTI E., La cooperazione del datore all’adempimento della prestazione di lavoro,
Padova, 1990.
BARBERA M., La sfida dell’eguaglianza, RGL, 2000, I, 245.
BARBERA M., Discriminazioni ed uguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano, 1991.
BARCELLONA M., La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in Mazzamuto,
S. (a cura di), Il contratto e le tutele, Torino, 2002, 305.
186
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
BAVARO V., Azienda, contratto e sindacato, Bari, 2012.
BELLAVISTA A., L’art. 8 del d.l. n. 138/2011: interpretazione e costituzionalità, in
Carinci F. (a cura di), Contrattazione in deroga — accordo interconfederale del
28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, Milano, 2012, 311.
BELLAVISTA A., Lavoro a termine e contrattazione collettiva, in Bellavista A., Garilli
A., Marinelli M. (a cura di), Il lavoro a termine dopo la legge 6 agosto 2008, n.
133. Privato e pubblico a confronto, Torino, 2009, 25.
BELLAVISTA A., I contratti di riallineamento retributivo e l’emersione del lavoro
sommerso, RGL, 1998, I, 93.
BELLOCCHI P., Commento all’art. 39, in Diritto del lavoro — la Costituzione, il Codice
Civile e le leggi speciali, Amoroso G., Di Cerbo E., Maresca A. (a cura di),
Milano 2013, 310, 310.
BELLOCCHI P., Lavoro intermittente, in DE LUCA TAMAJO R., e SANTORO-PASSARELLI
G., Il nuovo mercato del lavoro, Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n.
276, Padova, 2007, 518.
BELLOMO S., Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, Torino, 2002.
BELVEDERE A., Le clausole generali tra produzione e interpretazione di norme, PD,
1989, 631.
BERNASCONI A., Commento all’art. 6, in BERNASCONI A., FIORIO C., PRESUTTI A., La
responsabilità degli anti. Commento articolo per articolo al d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, Padova, 2008, 109.
BETTI E., L’interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e
dogmatica, Milano, 1949.
BIANCHI D’URSO F., La mobilità “orizzontale” e l’equivalenza delle mansioni, in
AA.VV., L’inquadramento dei lavoratori, QDLRI, 1987, 1, 117.
BOLLANI A., Lavoro a termine, somministrazione e contrattazione collettiva in deroga,
Padova, 2013.
BROLLO M.-VENDRAMIN M., Le mansioni del lavoratore: inquadramento e ius variandi. Mansioni, qualifiche e jus variandi, Trattato di Diritto del Lavoro,
diretto da Persiani M. e Carinci F., vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, tomo I, a cura di Martone M., Padova, 2012, 512.
BROLLO M., Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale,
in Carinci F. (a cura di), Contrattazione in deroga — accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, Milano, 2012, 371.
BROLLO M., La mobilità interna del lavoratore, in Schlesinger P. (diretto da), Il
codice civile. Commentario, Milano, 1997.
BUONCRISTIANO M., Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova, 1986.
CALÀ F., Il trasferimento del lavoratore, Padova, 1999.
CALCATERRA L., Sindacato di legittimità e norme elastiche in materia di lavoro, GC,
2000, II, 315.
CAMPANELLA P., Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, Milano, 2000.
CARABELLI U., Leccese, V., Il sofferto rapporto tra legge e autonomia collettiva: alcune
riflessioni ispirate dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, in Garofalo D.,
Ricci M. (a cura di), Percorsi di diritto del lavoro, Bari, 2006, 193.
CARABELLI U., Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo, DLRI, 2004, 1.
CARABELLI U., intervento al Seminario su La nuova legge in materia di contratto di
lavoro a termine, 2001, dattiloscritto.
187
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
CARINCI F., Il diritto del lavoro che verrà, rielaborazione dell’intervento al Convegno
di Torino “Diritto del lavoro e mercato globale” dell’11-12 aprile 2014 in corso
di pubblicazione in ADL, 2014, dattiloscritto.
CARINCI F., Ripensando il “nuovo” art. 18 dello Statuto dei lavoratori, WP CSDLE
“Massimo D’Antona” n. 172/2013, http://csdle.lex.unict.it/.
CARINCI F., Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore,
in Carinci F. (a cura di), Contrattazione in deroga - accordo interconfederale del
28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, Milano, 2012, 1.
CARINCI F., Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte, in Trattato di
diritto privato, diretto da Bessone, M., vol. XXIV, Il lavoro subordinato, a
cura di Carinci F., t. I, Il diritto sindacale, coordinato da Proia G., Torino,
2007, XIV.
CARINCI F., Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale,
DLRI, 1985, 203.
CARINCI M.T., Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, ne Il diritto del lavoro al
tempo della crisi, Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro,
Milano, 2013, 155.
CARINCI M.T., Clausole generali, certificazione e limiti al sindacato del giudice. A
proposito dell’art. 30 l. n. 183/2010, in Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale
— Studi in onore di Tiziano Treu, II, Napoli, 2011, 787.
CARINCI M.T., Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato,
Padova, 2005.
CARUSO B., Rappresentanza sindacale e consenso, Milano, 1992.
CASTELVETRI L., 2000, La negoziazione dei criteri di scelta nelle riduzioni di personale, RIDL, 2000, I, 75.
CASTELVETRI L., Riduzioni di personale e “principio di razionalità”, MGL, 1999,
940.
CASTELVETRI L., L’obbligo di correttezza come limite esterno alle prerogative imprenditoriali e alla gestione collettiva degli interessi dei lavoratori, RIDL, 1995, I,
453.
CASTELVETRI L., Fonti collettive e differenziazioni normative tra lavoratori, DRI,
1992, 81.
CASTRONOVO C., L’avventura delle clausole generali, RCDP, 1986, 21.
CASTRONOVO C., Problema e sistema nel danno da prodotti, Milano, 1979.
CENINI M., GAMBARO A., Abuso di diritto, risarcimento del danno e contratto: quando
la chiarezza va in vacanza, Corriere giuridico, 1/2011, 109.
CESTER C., Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni,
ADL, 2012, 547.
CESTER C., MATTAROLO M.G., Diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro, Milano,
2007.
CHIECO P., Poteri dell’imprenditore e decentramento produttivo, Milano, 1996.
CHIECO P., Principi costituzionali, non discriminazione e parità di trattamento,
RGL, 1989, I, 447.
CIUCCIOVINO S., I requisiti sostanziali (soggettivi ed oggettivi) dei contratti a termine,
in Del Punta R., Romei R. (a cura di), I rapporti di lavoro a termine, Milano,
2013, 99.
CIUCCIOVINO S., Il sistema normativo del lavoro temporaneo, Torino 2008.
188
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
CIUCCIOVINO S., Il contratto a tempo determinato: la prima stagione applicativa del
d.lgs. n. 368 del 2001, DLRI, 2007, 455.
CIUCCIOVINO S., Commento all’art. 1, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), d.lgs. 6
settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 99/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, CEEP e CES,
NLCC, 2002, 30.
CLASS W., Generalklauseln im Strafrecht, in Festschrift für Eberhard Schmidt,
Göttingen, 1961, 122.
CONFINDUSTRIA Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione,gestione
e controllo ex d.lgs. 231/2001, 31 marzo 2008, in www.confindustria.it.
CORDERO F., Riti e sapienza del diritto, Bari, 1981.
CURZIO P., Autonomia collettiva e sciopero nei servizi essenziali, Bari, 1992.
D’AMICO G., Note in tema di clausole generali, in In Iure Praesentia, 1989, 426.
D’ANTONA M., Commento all’art. 5, in Persiani M. (a cura di), legge 23 luglio 1991,
n. 223, Commentario, NLCC, 1994, 922.
D’ANTONA M., Crisi e prospettive della regolamentazione extralegislativa del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, RGL, 1991, I, 417.
D’ANTONA M., L’anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del
metodo, 1990, ora in in Opere, a cura di Caruso B. e Sciarra S., I, Milano, 2000,
53.
DE ANGELIS L., Collegato lavoro e diritto processuale: considerazioni di primo
momento, WP CSDLE “Massimo D’Antona” n. 111/2010, http://
csdle.lex.unict.it/.
DE LUCA TAMAJO R., L’art. 8 del d.l. n. 138/2011: interpretazione e costituzionalità,
in Carinci F. (a cura di), Contrattazione in deroga — accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, Milano, 2012, 291.
DE LUCA TAMAJO R., La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976.
DE SIMONE G., Poteri del datore di lavoro e obblighi del lavoratore, in Trattato di diritto
privato, diretto da Bessone M., vol. XXIV, Il lavoro subordinato, a cura di
CARINCI F., t. II, Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e svolgimento,
coordinato da Perulli A., Torino, 2007, 249.
DEL CONTE M., Il potere disciplinare, Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da
Persiani M. e Carinci F., vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, tomo I,
a cura di Martone M., Padova, 2012, 801.
DEL PUNTA R., Epistemologia breve del diritto del lavoro, LD, 2013, 37.
DEL PUNTA R., Il giudice del lavoro tra pressioni legislative e aperture di sistema,
RIDL, 2012, I, 461.
DEL PUNTA R., Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, LD, 2006, 41.
DEL PUNTA R., La riforma dell’orario di lavoro, DPL, 2003, inserto al n. 22.
DEL PUNTA R., I vecchi e i giovani: spunti sui criteri di scelta dei lavoratori in
esubero, LD, 1999, 415.
DEL PUNTA R., Parità di trattamento e clausole generali nel rapporto di lavoro: un
nuovo intervento delle Sezioni unite, GC, 1996, 1908.
DEL PUNTA R., Parità di trattamento e rapporto di lavoro, GC, 1993, I, 2362.
DEL PUNTA R., Le sanzioni conservative, QDLRI, 1991, 9, 87.
DI MAJO A., La fideiussione “omnibus” e il limite della buona fede, FI, 1989, I, 2753.
DI MAJO A., Delle obbligazioni in generale, in Commentario Scialoja e Branca,
Bologna-Roma, 1985.
189
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
DI MAJO A., Clausole generali e diritto delle obbligazioni, RCDP, 1984, 539.
DI MAJO A. Limiti ai poteri privati nell’esercizio dell’impresa, RGL, 1983, I, 341.
DI TORO P., Codice etico d’impresa. Processo di “emersione” del credo aziendale,
www.unitus.it, s.d.
D’ORONZO A.V., Responsabilità sociale delle imprese e codici etici, tesi di dottorato,
XVII ciclo, Università di Bologna, http://amsdottorato.unibo.it/.
ENGISCH K., Introduzione al pensiero giuridico, Milano, 1970.
ESPOSITO M., Ordinamento professionale e disciplina delle mansioni nel lavoro
pubblico, ne Il lavoro pubblico in Italia, a cura di Carabelli U., e Carinci M.T.,
Bari, 2010, 167.
FABIANI A., Norme elastiche, concetti giuridici indeterminati, clausole generali,
“standards” valutativi e principi generali dell’ordinamento, FI, 1999, 3558.
FALZEA A., Gli standards valutativi e la loro applicazione, RDC, 1987,1.
FERRANTE V., Nuove norme in tema di inquadramento e di progressione di carriera
dei dipendenti pubblici, NLCC, 2011, 1329 ss.
FERRANTE V., Responsabilità sociale dell’impresa e lavoro subordinato, LD, 2006, 83.
FERRANTE V., Commento all’art. 17, in Napoli M. (a cura di), L’orario di lavoro tra
ordinamento interno e disciplina comunitaria, NLCC, 2004, 1402.
FERRARI P., La Commissione di garanzia, Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da
Persiani M. e Carinci F., vol. III, Conflitto, concertazione e partecipazione, a
cura di Lunardon, F., Padova, 2011, 419.
FERRARO G., Il controllo giudiziale sui poteri imprenditoriali, in Cinelli M., Ferraro
G. (a cura di), Il contenzioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010, n. 183,
Torino, 2011a, 3.
FERRARO G., Il contratto collettivo oggi dopo l’art. 8 del decreto n. 138/2011, WP
CSDLE “Massimo D’Antona” n. 129/2011b, http://csdle.lex.unict.it/.
FERRARO G., Poteri imprenditoriali e clausole generali, DLM, 2009, 36.
FERRARO G., Il rapporto di lavoro, Torino, 2004.
FERRARO G., Poteri imprenditoriali e clausole generali, DRL, 1991a, 159 ora in
Autonomia e poteri nel diritto del lavoro, Padova, 1992, 167.
FERRARO G., Continuità e innovazione nella giurisprudenza lavoristica della Corte
Costituzionale, RIDL, 1991b, I, 639 ora in Autonomia e poteri nel diritto del
lavoro, Padova, 1992, 191.
FERRARO G., Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela,
Napoli, 1981.
FIATA E., Obblighi “positivi”di diligenza e fedeltà. Sanzioni e codici disciplinari,
ADL, 2003, 285.
FIORILLO L., Obblighi del lavoratore, DDP, Sez. comm., agg. 2010, 501.
FONTANA G., Dall’inderogabilità alla ragionevolezza, Torino, 2010.
FRANZA G., Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento, Milano, 2010.
FRANZONI M., Diritto civile e diritto del lavoro a confronto, ADL, 2011, 795.
GAETA L., Lodovico Barassi, Philipp Lotmar e la cultura giuridica tedesca, ne La
nascita del diritto del lavoro. “Il contratto di lavoro” di Lodovico Barassi
cent’anni dopo, 2003, 159.
GALGANO F., Commento all’art. 41, Commentario alla Costituzione, a cura di Branca
G., Bologna-Roma, 1982, 11.
GARGIULO U., L’equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro, Soveria Mannelli,
2008.
190
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
GARILLI A., La mobilità orizzontale fra “soggezione” e “collaborazione”, in ID.,
BELLAVISTA A., Innovazioni tecnologiche e Statuto dei lavoratori: i limiti ai
poteri dell’imprenditore fra tutela individuale e collettiva (artt. 4-9-13),
QDLRI, 1989, 6, 139 ss.
GAROFALO D., Le novità in tema di contratti di riallineamento, DPL, 1997, 2129.
GAROFALO M.G., Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, DLRI, 2008,
21.
GAZZONI F., Manuale di diritto privato, XII ed., Napoli, 2006.
GHERA E., GARILLI A., GAROFALO D., Diritto del lavoro, Torino, 2013.
GHERA E., Il contratto collettivo tra natura negoziale e di fonte normativa, RIDL,
2012, I, 195.
GHERA E., L’autonomia collettiva e le trasformazioni del diritto sindacale da Francesco Santoro-Passarelli al pluralismo, LD, 2009, 351.
GHERA E., Diritto del lavoro, Bari, 2002.
GHERA E., Mobilità introaziendale e limiti all’art. 13 dello Statuto dei lavoratori,
MGL, 1984, 392.
GHEZZI G., ROMAGNOLI U., Il rapporto di lavoro, Bologna, 1995.
GIUBBONI S., Contratto a termine e contrattazione collettiva. Note critiche sul decreto
legislativo n. 368 del 2001, RGL, 2002, I, 505.
GIUGNI G., Intervento, in Santoro-Passarelli G. (a cura di), Diritto del lavoro e
categorie civilistiche, Torino, 1992, 73.
GIUGNI G., Commento all’art. 39, in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca
G., Bologna-Roma, 1979, 257.
GIUGNI G., Mansioni e qualifica, ED, XXV, Milano, 1975, 545.
GIUGNI G., Prefazione a De Cristofaro M.L., La giusta retribuzione, Bologna, 1971.
GIUGNI G., La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, relazione al III
convegno nazionale di Diritto del Lavoro di Pescara-Teramo, 1967, ora in
Lavoro, legge contratti, Bologna, 1989, 151.
GRAGNOLI E., Considerazioni preliminari sui poteri del datore di lavoro e sul loro
fondamento, RGL, 2011, I, 511.
GRANDI M., voce Rapporto di lavoro, ED, XXXVIII, 1987, 313.
GRANDI M., La mobilità interna, in Aa.Vv., Strumenti e limiti della flessibilità,
Milano, 1986, 251.
GROSSI P., Luigi Mengoni nella civilistica italiana del Novecento, Europa e dir. priv.,
2012, 32.
GUARNERI A., Le clausole generali, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, R.,
LE fonti del diritto italiano, 2, Le fonti non scritte e l’intepretazione, Torino,
1999, 131.
GUARRIELLO F., Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro, Napoli, 2000.
HART H.L.A., The Concept of Law, 1961, trad. it., Il concetto di diritto, nuova ed.,
Torino, 2002.
GUASTINI R., Teoria e dogmatica delle fonti, TrattCM, I, t. 1, Milano, 1998.
HECK P., Das Problem der Rechtsgewinnung, II ed., Tübingen, 1933.
HERNANDEZ S., I principi costituzionali in materia di retribuzione, relazione al
Convegno di Roma del 3 febbraio 1997 su Nuove forme di retribuzione e
attualità dei principi costituzionali, Quad. ADL, n. 2, Padova, 1998, 9 e in
DL, 1997, I, 153.
ICHINO P., La nozione di giusta retribuzione nell’art. 36 Cost., RIDL, 2010, I, 719.
191
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ICHINO P., La qualità del lavoro dovuto e il suo mutamento, in AA.VV., Scritti in onore
di Giuseppe Suppiej, Padova, 2005, 489.
IRTI N., Le ragioni delle leggi e le leggi della ragione, RassDC, 1980, 71, ora in Norme
e fatti. Saggi di teoria generale del diritto, Milano, 1984, 300.
LAGALA C., I contratti di riallineamento retributivo alla seconda prova, LG, 1997,
365.
LAMA L., Codici etici, responsabilità e dialogo sociale, in Felici L. (a cura di),
Dall’etica ai codici etici, Milano 2005, 90.
LAMBERTUCCI P., MARESCA A., Contratti di area, flessibilità salariale e occupazione,
DPL, 1997, 413.
LAMBERTUCCI P., Determinazione giudiziale della retribuzione, minimi sindacali e
condizioni territoriali, ADL, 1995, n. 1, 201.
LAMBERTUCCI P., Contratti collettivi di riallineamento e retribuzione sufficiente ex art.
36 della Costituzione, RIDL, 1992, II, 544.
LECCESE V., Il diritto sindacale al tempo della crisi, ne Il diritto del lavoro al tempo
della crisi, Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro, Milano,
2013, 29.
LEVI A., Il trasferimento disciplinare del prestatore di lavoro, Torino 2000.
LIBERTINI M., Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, RCDP, 2011, 345 ss.
LIEBMAN S., La mobilità del lavoro nella legge n. 223/1991: tendenze della prassi
applicativa, RIDL, 1999, I, 125.
LIEBMAN S., Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, Milano, 1993.
LISO F., Intervento, ne Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, Atti del Congresso
Aidlass di Ferrara, Milano, 2002, 213.
LISO F., Autonomia collettiva e occupazione, DLRI, 1998, 191.
LISO F., L’incidenza delle trasformazioni produttive, in AA.VV., L’inquadramento dei
lavoratori, QDLRI, 1987, 1, 53.
LISO F., La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982.
LUCIANI M., La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova,
1983.
LUNARDON F., L’eccezionalità del contratto a termine: dalle causali specifiche alla
“specificazione delle ragioni giustificatrici”, ADL, 2007, 41.
LUNARDON F., Ancora sul principio di parità di trattamento nel diritto del lavoro, GI,
1999, 1147.
LUZZATI C., La “normalizzazione” delle clausole generali. Dalla semantica alla
pragmatica, RCDP, 2013, 163.
MAGNANI M., Il giudice e la legge, RIDL, 2013, 777.
MAGNANI M., L’art. 8 della legge n. 148/2011: la complessità di una norma sovrabbondante, DRL, 2012, 1.
Magnani M., Il salario minimo legale, RIDL, 2010, I, 769.
MAGNANI M., Bollani, A., I contratti di lavoro a termine nelle recenti riforme, in
Previdenza, mercato del lavoro,competitività, a cura di Magnani M., Pandolfo
A., Varesi P.A., Torino, 2008, 343.
MAGNANI M., Ancora sul contratto di lavoro a termine: tanto rumore per nulla?, in
Scritti in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, 2008, I, 632.
MAGNANI M., Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del
lavoro, DLRI, 2004, 165.
192
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
MAINARDI S., Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico, Milano, 2002.
MAGRINI S., Lavoro (contratto individuale), ED, XXIII, 1973, 369.
MANCINI F., La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957.
MARAZZA M., Diligenza del prestatore di lavoro, Commentario del Codice Civile
diretto da Gabrielli E., artt. 2099-2117, a cura di Cagnasso O. e Vallebona A.,
Milano, 2013, 261.
MARAZZA M., Limiti e tecniche di controllo sui poteri di organizzazione del datore di
lavoro, Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da Persiani M. e Carinci F., vol.
IV, Contratto di lavoro e organizzazione, tomo II, a cura di Marazza M.,
Padova, 2012a, 1271.
MARAZZA M., La contrattazione di prossimità nell’art. 8 della manovra 2011: i primi
passi della dottrina giuslavoristica, DLR, 2012b, 41.
MARAZZA M., L’art. 18 nuovo testo dello statuto dei lavoratori, ADL, 2012c, 612.
MARAZZA M., Saggio sull’organizzazione del lavoro, Padova, 2001.
MARESCA A., Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche
dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, RIDL, 2012, 415.
MARESCA A.,Una proposta per la modifica della legge sul contratto di lavoro a tempo
determinato, in Dell’Aringa C., Treu T. (a cura di), Le riforme che mancano,
trentaquattro proposte per il welfare del futuro, Bologna, 2010, 81.
MARESCA A., Apposizione del termine, successione di contatti a tempo determinato e
nuovi limiti legali: primi problemi applicativi dell’art. 5, commi 4-bis e ter,
d.lgs. n. 368/2001, RIDL, 2008, I, 287.
MARESCA A., La Cassazione “scopre” la parità di trattamento tra i lavoratori: ma
esiste davvero, LI, 1990, n. 6, 4.
MARESCA M., La promozione automatica del prestatore di lavoro secondo l’art. 13 dello
statuto dei lavoratori, RGL, 1978, I, 413.
MARIANI M., Commento all’art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in De Luca Tamajo
R., Mazzotta O., Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2013, 1929.
MARINELLI M., La retribuzione proporzionata e sufficiente nel pensiero di Tiziano
Treu, in Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale — Studi in onore di Tiziano
Treu, II, Napoli, 2011, 913.
Marinelli M., Il diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente: problemi e
prospettive, ADL, 2010, 86.
MARINELLI M., Contratto a termine cause di giustificazione, in Il lavoro a termine in
Italia e in Europa, a cura di Garilli A., Napoli, M., Torino, 2003, 45 ss.
MARIUCCI L., La contrattazione collettiva, Bologna, 1985.
MATTAROLO M.G., Lavoro intermittente, in Brollo M., Mattarolo, M.G. Menghini, L.
(a cura di) Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi, Commentario al
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, coordinato da Carinci F. tomo III, Ipsoa,
2004, 7.
MAZZOTTA O, Diritto del lavoro e categorie civilistiche, RIDL, 1991, I, 35, ora in
Diritto del lavoro e diritto civile. I temi di un dialogo, Torino, 1994, 16.
MAZZOTTA O., La resistibile ascesa della parità di trattamento nel rapporto di lavoro,
FI, 1993, I, 1795, ora in Diritto del lavoro e diritto civile. I temi di un dialogo,
Torino, 1994, 193.
MAZZOTTA O., Parità di trattamento ed autonomia collettiva: dal mercato economico al
mercato giudiziario, FI, 1990, I, 2887, ora in Diritto del lavoro e diritto civile.
I temi di un dialogo, Torino, 1994, 185.
193
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
MAZZOTTA O., Variazioni su poteri privati, clausole generali e parità di trattamento,
DLRI, 1989, 583, ora in Diritto del lavoro e diritto civile. I temi di un dialogo,
Torino, 1994, 139.
MAZZOTTA O., Enti economici e concorsi privati: alla ricerca di una regola di diritto,
RIDL, 1987, I, 188, ora in Diritto del lavoro e diritto civile. I temi di un dialogo,
Torino, 1994, 153.
MENEGATTI E., L’obbligo di diligenza, Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da
Persiani M. e Carinci F., vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, tomo I,
a cura di Martone M., Padova, 2012, 907.
MENGHINI L., Contratti a termine, in Carinci F. (a cura di), Contrattazione in deroga
— accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011,
Milano, 2012, 433.
MENGHINI L., L’apposizione del termine, Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da
Persiani M. e Carinci F., vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, tomo I,
a cura di Martone M., Padova, 2012b, 211.
MENGHINI L., La nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, in La
nuova disciplina del lavoro a termine, a cura di L. Menghini, Milano, 2002, 3.
MENGONI L, L’argomentazione nel diritto costituzionale, in Ermeneutica e dogmatica
giuridica, Milano, 1996, 115.
MENGONI L., L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, processuale civile e
diritto amministrativo. Diritto Civile, DLRI, 1990, 5.
MENGONI L. Spunti per una teoria delle clausole generali, RCDP, 1986, 5.
MEZZACAPO D., Le mansioni, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale,
a cura di Santoro-Passarelli G., Milano, 2014, 2579.
MINERVINI G., Contro la « funzionalizzazione » dell’impresa privata, RDC, 1958, I,
621.
MISCIONE M., La classificazione nella contrattazione aziendale, in Aa.Vv., L’inquadramento dei lavoratori, QDLRI, 1987, 1, 149.
MONATERI P.G., Contratto rugiadoso e contratto rude nel diritto europeo e comunitario, in D’Angelo A., Monateri P.G., Somma A., Buona fede e giustizia
contrattuale, Torino, 2005, 57.
MONATERI P.G., Ripensare il contratto, RDC, 2003, I, 409.
MONTUSCHI L., il contratto a termine e la liberalizzazione negata, DRI, 2006, 109.
MONTUSCHI L., Ancora nuove regole per il lavoro a termine, ADL, 2002, 41.
MONTUSCHI L., Ancora sulla rilevanza della buona fede nel rapporto di lavoro, ADL,
1999, 723.
MONTUSCHI L., L’applicazione giurisprudenziale del principio di correttezza e buona
fede nel rapporto di lavoro, LD, 1996, 139.
MONTUSCHI L., Potere disciplinare e rapporto di lavoro privato, QDLRI, 1991, 9, 9.
MONTUSCHI L, Potere disciplinare e rapporto di lavoro, Milano, 1973.
MORELLI M.R., La buona fede come limite all’autonomia negoziale e fonte d’integrazione del contratto nel quadro dei congegni di conformazione delle situazioni
soggettive alle esigenze di tutela degli interessi sottostanti, CG, 1994, I, 2168.
NAPOLI M., Il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina del lavoro a termine,
in Il lavoro a termine in Italia e in Europa, a cura di Garilli A., Napoli, M.,
Torino, 2003, 85.
NAPOLI M., voce Licenziamenti, DDP, sez. comm., IX, 1993, 58.
NAPOLI M., La stabilità reale nel rapporto di lavoro, Milano, 1980.
194
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
NATOLI U., Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro,
Milano, 1955.
NATULLO G., Il licenziamento collettivo: interessi, procedure, tutele, Milano, 2004.
NEUMANN F., Il diritto del lavoro nella società moderna, ne Il diritto del lavoro tra
democrazia e dittatura, trad. it. di Capobianco A., Gaeta L., Vardaro G.,
Bologna, 1983.
NICCOLAI A., Previsioni collettive e ruolo del giudice, in Mazzotta O. (a cura di),
Ragioni del licenziamento e formazione culturale del giudice, Torino, 2008, 95.
NIVARRA L., Clausole generali e principi generali del diritto nel pensiero di Luigi
Mengoni, in Nogler L. e Nicolussi A., Luigi Mengoni o la coscienza del metodo,
Padova, 2007, 159.
NIVARRA L., Ragionevolezza e diritto privato, Ars interpretandi — Annuario di
ermeneutica giuridica, 7, 2002, 373.
NOGLER L., L’interpretazione giudiziale nel diritto del lavoro, RIDL, 2014, 115.
NOGLER L., Prime considerazioni sulla disciplina legislativa delle “clausole generali”
in materia di diritto del lavoro, in Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale —
Studi in onore di Tiziano Treu, II, Napoli, 2011, 927.
NOGLER L., La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento
tra i « principi » costituzionali, DLRI, 2007, 593.
NOGLER Saggio sull’efficacia regolativa del contratto collettivo, Padova, 1997.
NUZZO V., Il lavoro intermittente: un’opportunità nelle Information communication
technology?, WP CSDLE “Massimo D’Antona” n. 31/2005, http://
csdle.lex.unict.it/.
PALMIERI A., PARDOLESI R., Della serie “a volte ritornano”: l’abuso del diritto alla
riscossa, FI, 2010, I, 95.
PASCUCCI P., Tecniche regolative dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Torino,
1999.
PASSALACQUA P., Autonomia collettiva e mercato del lavoro, Torino, 2005.
PATTI S., Ragionevolezza e clausole generali, Milano, 2013.
PEDRAZZOLI M., Il regolamento unilaterale dei rapporti di lavoro: solo un reperto
archeologico?, WP CSDLE “Massimo D’Antona” n. 149/2012, http://
csdle.lex.unict.it/.
PEDRAZZOLI M., Qualificazioni dell’autonomia collettiva e procedimento applicativo
del giudice, LD 1990, 355 e 549.
PEDRINI F., Clausole generali e Costituzione. Una (prima) mappa concettuale, in
Forum di Quaderni costituzionali, 2009.
PELLACANI G., Il cosiddetto “Collegato lavoro” e la disciplina dei licenziamenti: un
quadro in chiaroscuro, RIDL, 2010, I, 215.
PERA G., Sulla nuova disciplina del contratto a termine e sul regime sanzionatorio del
licenziamento ingiustificato, RIDL, 2002, 15.
PERA G., Sulla parità di trattamento tra i lavoratori, RIDL, 1989, II, 396.
PERSIANI M., Conflitto industriale e conflitto generazionale, ADL, 2006, 1031.
PERSIANI M., Diritto del lavoro e autorità dal punto di vista giuridico, ADL, 2000, 1.
PERSIANI M. Contratti collettivi normativi e contratti collettivi gestionali, ADL, 1999,
1.
PERSIANI M., Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore di lavoro,
DL, 1995a, I, 135.
PERSIANI M., Diritto del lavoro e razionalità, ADL, 1995b, 1.
195
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
PERSIANI M., Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori, DL, 1971, I, 11.
PERSIANI M., Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966.
PERULLI A., Certificazione dei contratti di lavoro e controllo dei poteri dell’imprenditore: il ruolo e le prerogative del giudice, ne Il nuovo diritto del lavoro.
Rapporto individuale e processo del lavoro, Torino, 2014, 265.
PERULLI A., SPEZIALE, V., L’art. 8 del d.l. n. 138/2011: interpretazione e costituzionalità, in Carinci F. (a cura di), Contrattazione in deroga — accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, Milano, 2012, 165.
PERULLI A., I concetti qualitativi nel diritto del lavoro: standard, ragionevolezza,
equità, DLM, 2011, 403.
PERULLI A., Diritto del lavoro e diritto dei contratti, RIDL, 2007, I, 427.
PERULLI A., Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro, DLRI, 2005, 1.
PERULLI A., Il lavoro intermittente, in Perulli A. (a cura di), Impiego flessibile e
mercato del lavoro, Torino, 2004, 133.
PERULLI A., Interessi e tecniche di tutela nella disciplina del lavoro flessibile, DLRI,
2002, 335.
PERULLI A., Obbligazione di lavoro, diligenza e rendimento, Diritto del lavoro —
Commentario diretto da Carinci F., II, Il rapporto di lavoro subordinato:
costituzione e svolgimento, a cura di Cester C., Torino, 1998, 637.
PESSI R., Diritto del lavoro e « regole » costituzionali, in Id. Valori e “regole”
costituzionali, Roma, 2009a, 6.
PESSI R., Persona, lavoro e poteri privati, ADL, 2009b, 675 ss. .
PESSI R., Dal divieto di discriminazione alla parità di trattamento: considerazioni
dubitative, NGL, 1992, 56, 3.
PINO G., Conflitto e autonomia collettiva, Torino, 2005.
PISANI C., L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento: convincimento del giudice
e onere della prova, MGL, 2012a, 741.
PISANI C., Le norme “anti incertezza” della legge n. 183/2010, in Giustizia del lavoro
ed effettività dei diritti, a cura di Basenghi F., Russo A., Torino, 2012b, 45.
PISANI C., L’oggetto e il luogo della prestazione, in Vallebona A. (a cura di), I
contratti di lavoro, t. I, Torino, 2009, 4172.
PISANI C., La certezza del diritto nelle tecniche della flessibilità, RIDL, 2003, I, 67.
PISANI C., La modificazione delle mansioni, Milano, 1996.
PISANI C., Rapporti di lavoro e nuove tecnologie: le mansioni, DLRI, 1988, 293.
POLACCO V., Le cabale del mondo legale, discorso letto all’Istituto veneto di scienze,
lettere ed arti nel 1908, ora in Opere minori, I, Problemi di legislazione,
Modena, 1928, 41.
PRETEROTI A., Il contratto di lavoro a tempo determinato, in Santoro-Passarelli G. (a
cura di) Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Milano, 2014,
357.
PROIA G., Flessibilità e tutela “nel” contratto di lavoro subordinato, DLRI, 2002,
411.
PROIA G., Qual è il trasferimento “disciplinare”?, RIDL, 1993, II, 574.
PROIA G., Ancora in tema di ius variandi: mansioni fungibili e professionalità
“congelata”, RIDL, 1990, II, 158.
QUARANTA M., Il contratto a tempo determinato: autonomia individuale e contrattazione collettiva, in Istituzioni e regole del lavoro flessibile, Napoli, 2006, 487.
196
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
RESCIGNO P., Appunti sulle “clausole generali”, RDC, 1998, 1.
RICCI G., La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al
salario minimo, LD, 2011, 635.
RICCI G., Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, diritto alla
pausa, lavoro notturno e durata media della prestazione di lavoro, in Leccese V.
(a cura di), L’orario di lavoro. la normativa italiana di attuazione delle direttive
comunitarie, Milano, 2004, 466.
RODOTÀ S., Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile, in Orestano, A. (a
cura di) Lezioni sul contratto, Torino, 2009, 97.
RODOTÀ S., Il tempo delle clausole generali, RCDP, 1987, 709.
RODOTÀ S., Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969.
RODOTÀ S., Note critiche in materia di proprietà, RTDPC, 1960, 1253.
ROMA G., La retribuzione, Torino, 1993.
ROMAGNOLI U., sub art. 13, in Scialoja A., Branca G. (diretto da), Statuto dei
lavoratori, Commentario al Codice Civile, I ed., Bologna-Roma, 1972, 174.
ROMEI R., La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme, DRI, 2012, 4, 969.
ROMEI R., L’autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano
Vardaro, DLRI, 2011a, 181.
ROMEI R., Qualche spunto di riflessione sull’art. 8 della manovra d’agosto, www.nelmerito.com, 16 settembre 2011b.
ROMEI R.,Commento agli artt. 33-40, ne Il nuovo mercato del lavoro, Commentario
coordinato da Pedrazzoli, M., Bologna, 2004, 401.
ROPPO V., Diritto privato, Torino, 2010.
ROSELLI F., Clausole generali e nomofilachia, MGL, 2014, 222.
ROSELLI F., Il controllo della Cassazione Civile sull’uso delle clausole generali,
Napoli, 1983.
RUSCIANO M., Contratto collettivo e autonomia sindacale, Torino, 2003.
RUSCIANO M., La diligenza del prestatore di lavoro, Studium iuris, 2000, 656.
SAFFIOTI M.T., Le clausole generali di buona fede e correttezza e la posizione del
lavoratore subordinato, Torino, 1999.
SANDULLI P., Sanzioni disciplinari, Commentario del Codice Civile diretto da
Gabrielli E., artt. 2099-2117, a cura di Cagnasso O. e Vallebona A., Milano,
2013, 345.
SANTORO-PASSARELLI G., Note per un discorso sulla giustizia del lavoro, RIDL,
2013a, I, 515.
SANTORO-PASSARELLI G., Diritto dei lavori, IV ed., Torino, 2013b.
SANTORO-PASSARELLI G., Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d.l. 138/
2011 conv. con modifiche l. n. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze,
ADL, 2011, 1224.
SANTORO-PASSARELLI G., Competitività e flessibilità del rapporto di lavoro, RIDL,
2009a, I, 201.
SANTORO-PASSARELLI G., I corsi, i ricorsi e i discorsi sul contratto collettivo di diritto
comune, ADL, 2009b, 970.
SANTORO-PASSARELLI G., Diritto sindacale, Bari, 2007.
SANTORO-PASSARELLI G., Note preliminari sulla nuova disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato, ADL, 2002, 1, 177.
SANTORO-PASSARELLI G., La parità di trattamento retributivo nell’ordinamento ita-
197
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
liano e nella prospettiva dell’ordinamento comunitario, GI, 1994, I, 1, 913, ora
in Realtà e forma nel diritto del lavoro, Torino, II, 2006, 557.
SANTORO-PASSARELLI G., Il problema della parità di trattamento retributivo, DLRI,
1990, 567, ora in Realtà e forma nel diritto del lavoro, Torino, I, 2006, 47.
SANTORO-PASSARELLI G., Istituzionalizzazione della rappresentanza sindacale?,
DLRI, 1989, 329.
SANTORO-PASSARELLI G., Impresa, contratto collettivo e concorsi privati, GI, 1981, ora
in Realtà e forma nel diritto del lavoro, Torino, I, 2006, 485.
SANTUCCI R., Parità di trattamento, contratto di lavoro e razionalità organizzative,
Torino, 1997.
SARACINI P., Contratto a termine e stabilità del lavoro, Napoli, 2013.
SCAGLIONE F., Il mercato e le regole della correttezza, Padova, 2010.
SCARPELLI F., Iniziativa economica, autonomia collettiva, sindacato giudiziario:
dall’art. 41 della Costituzione alla recente legislazione sulla trasformazioni
dell’impresa, LD, 1996, 15.
SCARPELLI F., Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, DRI, 1994, 2, 43.
SCIARRA S., Intervento, ne Il diritto del lavoro al tempo della crisi, Atti del XVII
Congresso nazionale di diritto del lavoro, Milano, 2013, 288.
SCIARRA S., Norme imperative nazionali ed europee: le finalità del diritto del lavoro,
DLRI, 2006, 39.
SCOGNAMIGLIO R., Codice Civile e diritto del lavoro, RDC, 1994, ora in Scritti
giuridici, t. II., Padova, 1996, 935.
SCOGNAMIGLIO R., Il cosiddetto principio di parità di trattamento tra i lavoratori al
vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, MGL, 1993, ora in Scritti
giuridici, t. II., Padova, 1996, 1071.
SCOGNAMIGLIO R., Parità e libertà di trattamento economico e inquadramento dei
lavoratori (a proposito di due recenti sentenze del Supremo Collegio, MGL, 1990,
ora in ora in Scritti giuridici, t. II., Padova, 1996, 1065.
SCOGNAMIGLIO R., Considerazioni in tema di parità delle condizioni di trattamento
economico-normativo dei lavoratori subordinati, in Questioni attuali di diritto
del lavoro — supplemento di NGL, 1989b, ora in Scritti giuridici, t. II.,
Padova, 1996, 1055.
SCOGNAMIGLIO R., Considerazioni sulla sentenza n. 103/1989 della Corte costituzionale
in tema di parità di trattamento retributivo tra i lavoratori subordinati, MGL,
1989a, ora in Scritti giuridici, t. II., Padova, 1996, 1048.
SCOGNAMIGLIO R., Autonomia sindacale ed efficacia del contratto collettivo di lavoro,
RDC, 1971, 140, ora in Scritti giuridici, t. II., Padova, 1996, 1517.
STOLFA F., I contratti di riallineamento retributivo: luci e ombre, DPL, 1997, 3181.
SENIGAGLIA R., La vincolatività dei codici etici: ossimoro o sineddoche?, in La
responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi, a cura di Perulli A., Bologna,
2013, 73.
SITZIA A., Licenziamenti collettivi, in Cester C. (a cura di), I licenziamenti dopo la
legge n. 92/2012, Padova, 2013, 315.
SPAGNUOLO VIGORITA L., Riflessioni in tema di potere disciplinare, ADL, I, 2011,
818.
SPAGNUOLO VIGORITA L., Ferraro, G., Commento all’art. 7, Commentario dello Statuto
dei Lavoratori, diretto da Prosperetti U., t. 1, Milano, 1975, 146.
198
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
SPEZIALE V., Giusta causa e giustificato motivo dopo la riforma dell’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, WP CSDLE “Massimo D’Antona” n. 165/2012a,
http://csdle.lex.unict.it/.
SPEZIALE V., Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro,
DLRI, 2012b, 361.
SPEZIALE V., La nuova legge sul lavoro a termine, DLRI, 2001, 361.
TARUFFO M., La giustificazione delle decisioni fondate su standards, in Comanducci
P. e Guastini R. (a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico. Materiali ad
uso degli studenti, II, Torino, 1989a, 311.
TARUFFO M.,Giudizio (teoria generale), in Enc. giur. Treccani, XV, 1989b.
TIRABOSCHI M., Giustizia del lavoro: la riforma del Collegato, Guida al Lavoro, 2010,
8.
TIRABOSCHI M., La recente evoluzione della disciplina in materia di lavoro a termine:
osservazioni sul caso italiano in una prospettiva europea e comparata, in Biagi
M., (a cura di), Il nuovo lavoro a termine, Milano, 2002, 41.
TOSI P., Il dirigente d’azienda, Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da Persiani M.
e Carinci F., vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, tomo I, a cura di
Martone M., Padova, 2012a, 427.
TOSI P., Intuitus personae e fiducia, ADL, 2012b, 539.
TOSI P., Il licenziamento del dirigente: profili legali, RIDL, 1996, I, 387.
TREMOLADA M., Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa,
ne I Licenziamenti, a cura di Cester C., Padova, 2013, 107.
TREMOLADA M., Norme della l. n. 183/2010 in materia di certificazione e di limiti al
potere di accertamento del giudice, in Miscione M., e Garofalo D. (a cura di), Il
Collegato lavoro 2010, Milano, 2011, 173.
TREU T., L’accordo 28 giugno 2011 ed oltre, DLR, 2011, 613.
TREU T., Le forme retributive incentivanti, RIDL, 2010, I, 637.
TREU T., Lo Statuto dei lavoratori: vent’anni dopo, QDLRI, n. 6, 1989, 7.
TROJSI A., Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, Torino, 2013.
TULLINI P., Clausole generali e rapporto di lavoro, Rimini, 1990.
VALLEBONA A., La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012.
VALLEBONA A., L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola
l’idolo dell’uniformità oppressiva, MGL, 2011, 682.
VALLEBONA A., Una buona svolta del diritto del lavoro: il “collegato” 2010, MGL,
2010, 210.
VALLEBONA A., Intervento, ne Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, Atti del
Congresso Aidlass di Ferrara 11-13 maggio 2000, Milano, 2002a, 175.
VALLEBONA A., I requisiti sostanziali di ammissibilità del termine: le nuove clausole
generali giustificative e il problema dell’onere della prova, ne La nuova disciplina del lavoro a termine, a cura di Menghini, L., Milano, 2002b, 62.
VALLEBONA A., PISANI C., Il nuovo lavoro a termine, Padova, 2001.
VALLEBONA A., Il trasferimento del lavoratore, RIDL, 1987, I, 67.
VARDARO G., Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro, Milano, 1985.
VARDARO G., Contrattazione collettiva e sistema giuridico, Napoli, 1984.
VELLUZZI V., Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano, 2010.
VENDRAMIN M., L’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico “privatizzato”
all’indomani della riforma “Brunetta” tra modelli negoziali e interpretazioni
giudiziali, LPA, 2009, 997.
199
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
VISCOMI A., Il pubblico impiego: evoluzione normativa e orientamenti giurisprudenziali, DLRI, 2013, 53.
VISCOMI A., Autonomia privata tra funzione e utilità sociale: prospettive giuslavoristiche, DLM, 2012, 441.
VISCOMI A., L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e principi
civilistici, DLRI, 2010, 595.
VISCOMI A., Intervento, in Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile, Atti
delle giornate di studio di diritto del lavoro flessibile, Pesaro-Urbino, 24-25
maggio 2002, Milano, 2003, 217.
VISCOMI A., Il contratto di riallineamento, in Rusciano M. e Zoppoli L. (a cura di),
Diritto del mercato del lavoro, Napoli 1999, 225.
VISCOMI A., Diligenza e prestazione di lavoro, Torino, 1997.
VOZA R., Il lavoro intermittente, Sub art. 2094, in Commentario al Codice civile,
diretto da Gabrielli E., Dell’impresa e del lavoro, artt. 2060, 2098, Torino,
2013, 356.
ZAGREBELSKY G., Diritto per: valori, principi o regole?, Quaderni fiorentini, 2002,
865.
ZITELMANN E., Irrtum und Rechtsgeschäft, Leipzig, 1879.
ZOLI C., Gli atti di esercizio del potere direttivo e il controllo giudiziario. Il trasferimento del lavoratore e il mutamento delle mansioni, relazione presentata al
Convegno del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, su I poteri dell’imprenditore ed il controllo giudiziale, Venezia, 4-5
aprile 2014, dattiloscritto.
ZOLI C., La legge 183 del 2010: le novità in materia di licenziamento, ADL, 2011, I,
833.
ZOLI C., La tutela delle posizioni “strumentali” del lavoratore, Milano, 1988.
ZOPPOLI L., Art. 8, analisi di una norma mal scritta, www.eguaglianzaeliberta.it,
2011.
ZOPPOLI L., L’art. 36 della Costituzione e l’obbligazione retributiva, in Caruso B., Zoli
C., Zoppoli L. (a cura di), La retribuzione. Struttura e regine giuridico, Napoli,
1994, 93.
ZOPPOLI L., Potere disciplinare e unificazione normativa del lavoro, QDLRI, 1991,
9, 37.
200
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Giovedì 29 maggio 2014 - pomeriggio
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
CLAUSOLE GENERALI E OBBLIGHI
DEL PRESTATORE DI LAVORO
di PIERA CAMPANELLA (*)
SOMMARIO: 1. Premessa. — I. Tra norma positiva e valori etico-sociali: la buona fede e la
correttezza come clausole generali. — 2. Le clausole generali: nozione, struttura e
funzioni. — 2.1. Le clausole generali: origini della nozione. — 2.2. Le clausole generali
nella cultura giuridica italiana. — 2.3. Struttura e funzione delle clausole generali. —
2.4. Il controllo sul processo di “concretizzazione” delle clausole generali: il controllo
a “monte” e il rapporto delle clausole con gli standards e i principi generali dell’ordinamento. — 2.5. Segue: il controllo a “valle” e il sindacato di legittimità. — 3. Buona
fede e correttezza: significati, ambiti e modalità di applicazione. — 3.1. Origini e
contenuto della buona fede e della correttezza. Coincidenza o distinzione di nozioni? —
3.1.1. La prospettiva storica. — 3.1.2. Il codice civile vigente e la sostanziale identità
dei concetti di correttezza e buona fede. — 3.1.3. Il contenuto delle clausole di
correttezza e buona fede. — 3.2. Modalità operative della buona fede e della correttezza: in funzione integrativa del regolamento contrattuale. Gli obblighi di protezione
ex artt. 1175 e 1375 c.c. — II. Rapporto di lavoro e obblighi del prestatore: il ruolo delle
clausole generali di buona fede e correttezza. — 4. La buona fede e la correttezza come
clausole generali: dal diritto civile al diritto del lavoro. — 4.1. Norme generali e
clausole generali nel diritto del lavoro. — 4.2. Buona fede e correttezza nel diritto del
lavoro. — 5. Correttezza e buona fede in executivis nel lavoro subordinato: gli obblighi
di protezione e il contratto di lavoro. — 6. La “concretizzazione” delle clausole generali
di correttezza e buona fede nei confronti del prestatore di lavoro: l’approccio giurisprudenziale. — 7. Correttezza e buona fede: il rapporto con la diligenza. Una prima
conclusione. — 8. Segue: il dovere di obbedienza e il potere direttivo. — 9. Segue:
ipotesi applicative. — 9.1. Comportamenti diretti all’adempimento della prestazione.
— 9.2. Comportamenti diretti all’adempimento di compiti complementari e strumentali. — 9.3. Comportamenti diretti alla conservazione di beni del datore di lavoro in
funzione della prestazione (dovere di custodia). — 9.4. Comportamenti diretti alla
conservazione della propria persona in funzione della prestazione (dovere di cura della
(*) Sono grata ai tanti amici e colleghi, che, con generosa disponibilità, hanno
discusso con me il presente lavoro di ricerca, offrendomi preziosi spunti e riflessioni. Un
sentito ringraziamento va, in particolare, a F. Carinci e, altresì, a E. Gragnoli, D. Garofalo,
M.G. Greco, nonché a F. Pantano, L. Angelini, C. Lazzari. Ringrazio altresì V. Lamonaca,
A. Biagiotti, M. Biasi, D. Casale, A. Lima per l’importante supporto nella ricerca del
materiale bibliografico.
203
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
propria salute). — 9.5. Comportamenti diretti a conformare l’aspetto esteriore della
propria persona in funzione della prestazione (dovere di cura del proprio aspetto
personale). — 10. Correttezza e buona fede: il rapporto con la fedeltà. Una seconda
conclusione — 11. Segue: ipotesi applicative. — 11.1. Comportamenti diretti alla
salvaguardia dell’organizzazione in senso “statico” (dovere di protezione dell’organizzazione in senso “statico”). — 11.2. Comportamenti diretti alla salvaguardia dell’organizzazione in senso “gestionale” (doveri di avviso, informazione, comunicazione e
altri doveri di protezione dell’organizzazione tecnico-produttiva). — 11.3. Comportamenti diretti alla salvaguardia dell’organizzazione in senso “dinamico” (dovere di
protezione dell’organizzazione dal punto di vista economico e di mercato). — 11.3.1.
Dovere di protezione dell’organizzazione dal punto di vista economico. — 11.3.2.
Doveri di protezione e atti preparatori della concorrenza. — 11.3.3. Doveri di protezione e denuncia, critica o divulgazione di notizie pregiudizievoli per l’impresa. —
11.3.4. Doveri di protezione, vita privata e qualità personali del prestatore.
1. Premessa.
È un tema ampio e complesso quello del rapporto tra clausole
generali e diritto del lavoro, che si colora di profili di particolare
delicatezza, se guardato dal punto di vista degli obblighi del
prestatore nel rapporto di lavoro.
L’ampiezza e la complessità del tema derivano dal fatto che la
materia delle “clausole generali”, di portata trasversale rispetto
alle diverse branche del diritto, tuttora « attende una sistemazione
teorica definitiva » (1): a riguardo, il quadro non è mutato in modo
sostanziale, benché il dibattito sul punto abbia conosciuto da
ultimo un rinnovato interesse, anche alla luce degli sviluppi del
diritto privato europeo (2).
Approcciarsi al tema significa fare i conti anzitutto con l’ambiguità e l’elevata vaghezza del sintagma “clausola generale”. Le
incertezze derivano dalla difficoltà di individuarne i tratti caratterizzanti e di delimitarne i confini rispetto ad altre nozioni giuridiche ruotanti anch’esse attorno all’indeterminatezza del testo
della norma (3). Ciò ha finito per, dar vita, « nella cultura giuridica
italiana », a « una situazione articolata, ma soprattutto confusa » (4); sicché oggi non è semplice capire a cosa ci si debba
(1)
(2)
(3)
(4)
Mengoni, 1986, p. 8.
Patti, 2013, p. 93 ss.
In tema Fabiani, 2012, p. 191.
Velluzzi, 2010, p. 1.
204
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
riferire, sul piano concettuale, quando si parla di “clausole generali”.
A disorientare è in particolare un duplice fenomeno. V’è, da un
lato, la tendenza di giudici e giuristi a una “moltiplicazione delle
etichette” (5), con possibilità di assistere a un uso, a stregua di
sinonimi — in tutto o solo in certa misura — di locuzioni quali
“clausole generali”, “standard valutativi”, “standard”, “concetti
indeterminati”, “norme elastiche”, “concetti-valvola”, “valvole di
sicurezza”, “nozioni a contenuto variabile”, “formule aperte”,
concetti valutativi caratterizzati da “vaghezza socialmente tipica”, “norme in bianco”, per citarne solo alcune (6). V’è, dall’altro
lato, la concomitante propensione della letteratura giuridica a una
“moltiplicazione delle nozioni” riferibili alla medesima “etichetta”,
con il risultato di veder attribuiti significato ed estensione di volta
in volta differenti all’espressione “clausola generale”, sì da consentirle di abbracciare — a seconda delle diverse opzioni interpretative e, quindi, delle nozioni adottate — i più disparati concetti:
certamente la « correttezza », la « buona fede », l’« ordine pubblico »,
il « buon costume », l’« utilità sociale », ma anche, per certuni, la
« giusta causa » e il « giustificato motivo », di immediato impatto sul
versante giuslavoristico. Anche poi a volersi immediatamente
orientare in direzione di una delle tante summenzionate opzioni e
nozioni, i problemi non sarebbero comunque finiti, perché resterebbe pur sempre da fare i conti con un lungo ed eterogeneo
catalogo di clausole, nel cui ambito selezionare quelle meritevoli di
specifico esame.
Tutto questo rischierebbe di complicare non poco l’operazione
di delimitazione del campo di indagine, se non fosse per gli stessi
(5) Pedrini, 2014, p. 32; v., del resto, già risalente dottrina tedesca, che, nel soffermarsi sulla « metodologia della legislazione nel caso di allentamento del vincolo dei tribunali
e degli organi amministrativi alla legge », rinveniva « diverse forme di espressione legislativa,
per le quali colui che applica la legge acquista autonomia nei confronti di essa », in
quest’ambito distinguendo « i concetti giuridici indeterminati, i concetti normativi, i concetti di discrezionalità e le clausole generali » e lamentandosi del fatto che « purtroppo la
terminologia non è unitaria »: così Engisch, 1970, p. 170.
(6) « Tanti nomi per dire la stessa cosa o tante cose diverse? », si chiede Denozza,
2011, p. 2, rilevando che « se il dibattito anglosassone », sulla scorta del classico distinguo tra
rules e standards, sembra soffrire di una certa semplicità e ripetitività degli argomenti,
altrettanto non si può dire per quello continentale, che soffre del vizio opposto. Qui i poli del
discorso non sono due o tre, ma una quantità pressoché indeterminata ».
205
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
termini dell’odierna riflessione — Clausole generali e diritto del
lavoro — nel cui connubio è evidentemente implicito il richiamo a
correttezza e buona fede. Ed invero non può dubitarsi di come la
storia delle clausole generali nella nostra disciplina di settore abbia
coinciso proprio con la penetrazione (altalenante nel corso del tempo)
di tali clausole all’interno di quel peculiare rapporto obbligatorio,
che è il rapporto di lavoro subordinato (7). Ne deriva una “sdrammatizzazione”, per così dire, dei problemi connessi alla delimitazione del campo di indagine: la collocazione, in forza del criterio
storico, della buona fede e della correttezza al centro del percorso
di ricerca non solo scioglie ogni possibile perplessità sulla scelta
dell’una o dell’altra clausola generale meritevole di analisi nell’ipotesi de qua, ma sottrae altresì valenza propedeutica alla questione
definitoria prima accennata, non potendo certo dubitarsi della
qualificazione della buona fede alla stregua di « clausola generale
per eccellenza » (8), indipendentemente dalla nozione che di quest’ultima s’intenda adottare.
Piuttosto, la menzionata questione definitoria rileverà in funzione del discorso sulla correttezza e la buona fede. È pacifico,
infatti, come le caratteristiche, le funzioni e le modalità applicative
di tali regole discendano, anzitutto, dalla loro ascrivibilità, sul
precipuo piano delle tecniche di normazione, alla categoria delle
“clausole generali”, le cui modalità di funzionamento — sub specie
di problemi interpretativi che sollevano e di ruolo che al giudice
impongono — dipendono a propria volta dal loro inquadramento
concettuale (9).
(7) Come era già stato nell’ordinamento tedesco con riguardo alla clausola di Treu
und Glauben del § 242 BGB, anche nel diritto del lavoro italiano delle origini è stata la bona
fides dell’art. 1124 del vecchio codice civile del 1865 a fungere da fondamento normativo per
« colmare le lacune del sistema in materia lavoristica e (...) stabilire in concreto le singole
conseguenze dell’accordo fra l’imprenditore e i suoi sottoposti (...) »: Corradini, 1970, p. 407;
sottolinea come « nell’ordinamento tedesco la problematica delle clausole generali ruoti
« attorno al principio di buona fede, che ha determinato una vera e propria fase normativa
ad opera della giurisprudenza » Patti, 2013, p. 85 s.
(8) Castronovo, 1986, p. 29; Klinder, 1998, p. 59; Mazzamuto, 2011, p. 1699 parla di
clausola generale « per antonomasia » e Di Majo, 1984, p. 541 di « tipica clausola generale ».
(9) Per il rapporto tra normazione per clausole generali e tematica interpretativa v.
Pedrini, 2014, p. 36 ss.; con riguardo altresì al ruolo del giudice cfr. Fabiani, 2012, p. 193,
secondo il quale « la straordinaria ricchezza e complessità della tematica (delle clausole
generali) (...) si coglie appieno (...) ove » si guardi alla sua « dimensione processuale » e non
solo dal punto di vista del « ”giudizio” posto in essere dal giudice nella peculiare ipotesi in
206
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Come noto, è il diritto delle obbligazioni, specie quelle di
origine contrattuale, a rappresentare lo scenario di fondo entro il
quale si colloca il discorso sulla normativa di correttezza e buona
fede. Detta normativa viene chiamata ad accompagnare tutto
« l’iter, che dalle trattative giunge, tramite l’interpretazione del
contratto, all’attuazione del conseguente rapporto » (10). Benché
siano dunque, molteplici le norme codicistiche rilevanti in un tal
contesto (artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.) l’attenzione si
indirizzerà qui agli articoli 1175 e 1375. Non si tratta di una scelta
di campo aprioristica, bensì della necessità di tener fede al tema
stesso della relazione, che eleva a obiettivo della ricerca l’esame
della relazione tra clausole generali e posizione debitoria del prestatore nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I
Tra norma positiva e valori etico-sociali:
la buona fede e la correttezza come clausole generali
2. Le clausole generali: nozione, struttura e funzioni.
2.1. Le clausole generali: origini della nozione.
È stato a ragione osservato come sia inevitabile « che ogni
discorso giuridico intorno al significato e al contenuto » della
« buona fede coincida, in parte, con la teoria della clausole generali » (11). È, allora, importante risalire alle origini di questa teoria,
origini quanto mai significative dell’ampio novero di questioni
racchiusevi e, prim’ancora, dello stretto legame con le vicende
della buona fede oggettiva nel diritto delle obbligazioni.
Il concetto di “clausola generale” deriva « dall’osservazione di
cui si trovi a dover interpretare ed applicare, con riferimento al singolo caso di specie, il testo
di una norma contenente una clausola generale (...), ma anche sotto il profilo della
controllabilità » di tale “giudizio” « in sede di impugnazione, se del caso di mera legittimità
(quale il giudizio di cassazione) »: su quest’ultimo tema Roselli, 1983; Id., 1988; AA.VV.,
2013, p. 5 ss.
(10) Bigliazzi Geri, 1988, p. 177.
(11) Tullini, 1990, p. 13.
207
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
certe norme (o di certe disposizioni) munite di determinate caratteristiche (che si presumevano) comuni » (12). Nasce come categoria del linguaggio dottrinale, per poi transitare parzialmente anche
nel lessico giurisprudenziale. A lungo, il termine è stato sconosciuto
(anche) al nostro legislatore nazionale, finché, proprio nella materia del lavoro, l’art. 30 l. n. 183 del 2010 non vi ha fatto esplicito
richiamo (13).
La sua genesi è strettamente legata alle vicende del diritto
privato tedesco, in particolare al § 242 del Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB), redatto tra il 1873 e il 1896 ed entrato in vigore il 1°
gennaio del 1900. La norma, rimasta a tutt’oggi immodificata,
sancisce che il debitore è obbligato a effettuare la prestazione
secondo quanto esige la “buona fede” (Treu und Glauben, alla
lettera “fiducia e credere”), con riferimento agli usi del traffico (14).
A suscitare interesse fu, al tempo, il peculiare impiego giurisprudenziale del § 242 BGB, dapprima occasionale, poi sempre più
generalizzato, fino ad assumere i contorni di un vero e proprio
disegno di politica del diritto (15), non certo destinato a passare
inosservato presso la dottrina dell’epoca, in un primo momento
ancora dominata da una forte ideologia positivista.
È all’interno di un tale contesto che la locuzione “clausola
generale” (Generalklauseln) viene alla luce, assurgendo a vera e
propria categoria del diritto. Si trattava, per i giuristi del tempo, di
attribuire connotati teorici a un fenomeno nuovo (16), consistente
nell’uso preponderante di sintagmi normativi, quali la « buona
fede », ma anche in certa misura il « buon costume » (Gute Sitten) di
cui al § 138 BGB, capaci, per le loro caratteristiche, di rinviare sul
(12) Pedrini, 2014, p. 13.
(13) Per notazioni particolarmente critiche Rescigno, 2011, p. 1689 s.; Id., 2013, p.
321.
(14) “Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern”: § 242 BGB.
(15) Di Majo, 1984, p. 555.
(16) Come osserva Klinder, 1998, p. 56, le clausole generali del BGB « rimasero per
molti anni lettera morta » e ciò riesce ben comprensibile, se si considera che « i seguaci della
pandettistica provavano (...) un palese disagio dinanzi alle clausole in bianco (...) »: Corradini, 1970, p. 487 e ivi per un ampia ricostruzione dottrinale del clima culturale dell’epoca.
208
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
piano contenutistico a criteri extragiuridici (17), sì da garantire
quel collegamento con il sistema sociale, necessario a conferire
« una certa flessibilità, una capacità di adattamento » all’ordinamento giuridico (18).
Sebbene già nel periodo antecedente al primo conflitto mondiale la magistratura attribuisse ormai alla buona fede un ruolo
cardine nel sistema del BGB, siccome deputata « a chiarire, ad
ampliare o a limitare posizioni giuridiche previste dalla legge » (19),
è solo nel periodo successivo a quel conflitto che il fenomeno viene
a completa maturazione, in corrispondenza con il progressivo
affermarsi di nuove tendenze dottrinali, la c.d. giurisprudenza
degli interessi (Interessenjurisprudenz) e il movimento del diritto
libero (Freirechtsbewegung) (20).
Si tratta di correnti di pensiero, le quali segnavano un distacco
dalle tradizionali teorie dommatiche, insistendo sul bisogno di
connettere la ricerca del giureconsulto al mondo della prassi e della
cultura, affinché il corpus iuris, ormai percepito come un organismo aperto, tutt’altro che completo, immutabile e privo di lacune,
possa accogliere, con l’ausilio della magistratura, le istanze enucleate dalla società nel corso del tempo. In questo contesto la
buona fede e altri precetti simili, con la loro straordinaria elasticità
e ampiezza, rappresentano tutt’altro che « un ostacolo per l’indagine o un pericolo da cui è meglio allontanarsi subito per non
cadere nell’arbitrio », come era stato in passato per l’esegesi e la
pandettistica. « Analizzandoli, gli studiosi » vi scoprivano (21) non
più solo la caratteristica di concetti « la cui funzione principale
consiste nell’approntare una categorizzazione dell’imprevi(17) Come rileva Pedrini, 2014, p. 57 s. e nt. 7 « fra i precursori della categoria delle
clausole generali s’annovera tradizionalmente Ernest Zitelmann, il quale distingueva i
“reine Rechtsbegriffe” (termini giuridici chiari), che avrebbero assunto senso soltanto all’interno del diritto o della scienza giuridica, e concetti che invece avrebbero rinviato per la
determinazione del loro contenuto a scienze esatte o comunque non giuridiche: queste
ultime di ritroverebbero innanzi un Blankett, una sorta di assegno in bianco »: il richiamo è,
in particolare, a Zitelmann, 1879, p. 19 ss.
(18) Cfr. Wurzel, 1924, p. 86 richiamato da Pedrini, 2014, p. 58, che fa riferimento
anche all’opera di Wendt, 1906, p. 106 ss.
(19) Patti, 2013, p. 62.
(20) Klinder, 1998, p. 56; Corradini, p. 429 ss.
(21) Corradini, 1970, p. 491.
209
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sto » (22), bensì i connotati di vere e proprie « clausole in bianco »,
necessarie a riempire le lacune legislative, al di là della tecnica
interpretativa analogica (23), se non addirittura, i tratti di precipue « valvole di sicurezza », deputate ad allargare « le maglie del
tessuto normativo », per saldarlo alla storia e alle consuetudini del
popolo tramite l’opera creativa della magistratura (24), con funzione non solo correttiva dell’autonomia privata, ma anche di
« rottura dell’ordinamento scritto » a fronte di esigenze di « equità
generale » (25).
« Un primo riscontro applicativo » (26) di tali innovativi indirizzi venne durante la Repubblica di Weimar, all’epoca della
grande inflazione, quando i giudici, nell’intento di tutelare la
piccola borghesia risparmiatrice, inaugurarono vere e proprie tecniche rivalutative dei crediti proprio sulla scorta del § 242
BGB (27). Così facendo, essi diedero un impulso decisivo a quel
processo di rivisitazione del diritto delle obbligazioni a mezzo della
“buona fede”, destinato ben presto ad assumere i tratti di una vera
e propria « fuga nelle clausole generali » (Die Flucht in der Generalklauseln), secondo un’espressione passata alla storia, sì da elevare la locuzione “clausola generale” a termine di uso comune (28).
È certo che in quel periodo i giudici « ebbero a confrontarsi con
una vasta gamma di posizioni soggettive, difficilmente immaginabili » (29), nell’assenza peraltro di strumenti sufficienti a fronteggiare la situazione, data l’inadeguatezza e altresì la rigidità di un
sistema codificato di stretta marca pandettistica (30). Il richiamo
alla buona fede riusciva effettivamente a garantire un rapporto di
continuità almeno formale con quel sistema. Nei fatti, però, apriva
(22) In tal senso Wurzel, 1924, p. 19 ss. parlò di « concetti valvola (Ventilbegriffe),
perché (...) paragonabili a delle valvole di sicurezza », secondo quanto riporta Pedrini, 2014,
p. 58.
(23) Corradini, 1970, p. 490.
(24) Ibidem, p. 491.
(25) Così Mengoni, 1986, p. 8, con riferimento alle tesi anche di giuristi di epoca
successiva, come lo stesso Wieacker, 1956, p. 36 ss., che hanno perseverato nella direzione
di una confusione tra clausole generali ed equità.
(26) Guarnieri, 1988, p. 406.
(27) Di Majo, 1984, p. 550 s.
(28) Hedemann, 1933.
(29) Di Majo, 1984, p. 551.
(30) Tullini, 1990, p. 16.
210
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
le porte a una sostanziale “rifondazione” del diritto delle obbligazioni su fondamenta ideologiche e tecniche diverse da quelle classiche (31), non priva di pericoli ed eccessi.
Il « grido d’allarme » (32) fu lanciato, da prospettive diverse,
ad opera di più di un giurista dell’epoca. Si osservò che il § 242
BGB, « assunto (...) a pilastro della giurisprudenza », aveva finito
ben presto per essere utilizzato allo scopo di sopprimere « istituti
giuridici » e abrogare « espresse disposizioni di legge » (33). La
direzione di marcia a favore di un uso politico delle clausole
generali, destinato a maturare negli anni del nazionalsocialismo,
era, insomma, segnata. Furono quasi profetiche, a riguardo, le
parole di chi denunciò con forza il fenomeno di « fuga nelle
clausole generali » (34), affermando che « dove un potere sovraordinato pone clausole generali e giudici indipendenti le adoperano,
tali clausole restano, malgrado la loro flessibilità, dei parametri.
Ma se lo Stato come supremo potere pone da sé le clausole generali
per il proprio comportamento, il fattore della flessibilità si fonde
con quello del potere e la clausola generale (...) diviene un’arma
da adoperare in modo incontrollabile. E improvvisamente ci sta di
nuovo dinanzi agli occhi l’Impero Romano », quando « cominciò a
trasformarsi nello Stato bizantino. Infatti, proprio Costantino fu
colui che di fronte al vecchio, autentico “ius” ha aperto una porta
particolarmente ampia all’“aequitas”, riservando alla sua volontà
imperiale la determinazione di ciò che è “equo” » (35). « La volontà
imperiale » — si è commentato di recente — « quale fonte del
diritto, insomma, come di lì a poco la “volontà del Führer” » (36).
E non è un caso se il « flusso delle clausole generali » (Der Fluch der
Generalklauseln) (37), ampiamente presenti nella dottrina dell’epoca, si intensificherà in particolar modo nei lavori preparatori
del Volksgesetzbuch, pur mai divenuto legge dello Stato (38).
(31) Di Majo, 1984, p. 552.
(32) Corradini, p. 546.
(33) Neumann, 1929, trad. it., 1983, p. 94.
(34) Hedemann, 1933, p. 58, che indicava le clausole generali « direttamente come un
pezzo di legislazione lasciata aperta » („ geradezu als ein Stück offengelassener Gesetzgebung“).
(35) Ibidem, 1933, p. 51 s.
(36) Wegerich, 2004, p. 46.
(37) Bueckling, 1983, 190 ss.
(38) Guarnieri, 1988, p. 406 con riferimento a clausole generali come « senso giuridico
del popolo », « sano sentimento del popolo », « coscienza del popolo », « senso morale della
211
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
La fine del secondo conflitto mondiale e il ritorno alla democrazia non arresterà comunque quel « flusso » in ambito giurisprudenziale. L’attitudine dei giudici a far uso delle clausole generali
perdurerà (39). Questo si spiega probabilmente alla luce dei connotati stessi del sistema giuridico tedesco, ad alto tasso concettuale
e dogmatico, ove il rilievo di nuove esigenze provenienti dalla
realtà sociale viene filtrato per il tramite « di nuove tecniche di
formazione di regulae juris, tra cui, appunto, quella delle “clausole
generali” » (40).
Muteranno, invece, i valori veicolati per il tramite delle clausole generali. Dette clausole cominceranno a rappresentare « le
porte (Einbruchstellen) che l’ordinamento privatistico tiene aperte
per i valori della Costituzione » (41); sicché lo stesso obbligo di
correttezza e buona fede si candiderà nel tempo a fungere da
tramite per la penetrazione delle norme costituzionali nel diritto
privato (c.d. Drittwirkung mediata).
Questo sintetico spaccato sull’origine della locuzione “clausola
generale”, benché volto a ripercorrere alcune risalenti e ormai
acquisite vicende, peraltro affatto peculiari all’esperienza tedesca,
si rivela comunque utile, perché in grado di dar conto dell’articolato e complesso campionario di temi che si agitano attorno alle
clausole generali: il nesso con il diritto delle obbligazioni e, in
particolare, con la buona fede oggettiva, di lontana matrice romanistica poi generalizzata dallo ius commune; il legame con l’evoluzione della cultura giuridica continentale, specie alla luce della
storica dicotomia tra “formalismo” e “antiformalismo”; le commistioni con l’equità; il collegamento con il tema della divisione dei
poteri; il ruolo del giudice nell’alternativa tra funzione suppletiva,
comunità »; l’A. dà conto, peraltro, di come un uso massiccio di tali clausole fosse talvolta
degenerato in forme di vera e propria perversione, allorché, ad esempio, si giudicò l’appartenenza del conduttore alla razza ebraica quale giusta causa di risoluzione del contratto di
locazione.
(39) Sulla concretizzazione delle clausole generali nella recente esperienza tedesca v.
Patti, 2013, p. 37 ss.
(40) Di Majo, 1984, p. 570; sulla scorta delle clausole generali si dà vita, ad esempio,
al principio della culpa in contrahendo o allo Störung der Geschäftsgrundlage (declino dei
presupposti del contratto), che troveranno poi tipizzazione nella riforma dello Schuldrecht
del 2002 (§§ 311 e 313 BGB).
(41) Klinder, 1998, p. 664 con riferimento all’orientamento della giurisprudenza
costituzionale tedesca.
212
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
correttiva o integrativa della buona fede. Si tratta, in tutti i casi,
di snodi fondamentali della materia, su cui avremo occasione di
tornare più volte nel prosieguo.
2.2. Le clausole generali nella cultura giuridica italiana.
Si è detto di come la cultura giuridica del primo trentennio del
novecento sia stata percorsa in Germania e, si può aggiungere,
nella stessa Francia, da profondi mutamenti, nel tentativo dei
giuristi più aperti ai nuovi indirizzi di « infrangere i modelli rigidi
delle costruzioni meramente logiche » e di aprire il sistema codificato a valori esterni all’ordinamento, espressione delle istanze
provenienti dalla realtà sociale, tramite una valorizzazione del
comando della buona fede (42).
Bisogna ora osservare come l’esperienza italiana sia rimasta,
per la verità, tendenzialmente impermeabile a ciò (43). Non che
mancassero, già sul finire dell’Ottocento, testimonianze d’interesse
per la tecnica legislativa delle “clausole generali”. Solo che esse
dovettero scontrarsi con un duplice ostacolo: da un lato, il contesto
culturale, assai poco aperto all’impiego di strumenti irriducibili
« allo schema della normazione analitica »; dall’altro, il diffondersi,
presso la scienza giuridica successiva al primo dopoguerra, del
metodo sistematico, in una « sorta di reazione » alla c.d. scuola
dell’esegesi (44).
Da qui la tendenza a una sostanziale svalutazione della buona
fede (45), per quanto temperata, già ai primi del novecento, da
alcuni segnali diversi, collegati all’emergere di istanze di solidarietà
in corrispondenza con l’ascesa dell’industrialismo e della c.d. questione sociale. Non è un caso che proprio in materia lavoristica si
affievolisca il timore nei confronti dei giudizi di valore e affiori una
prima tendenza all’impiego dell’art. 1124 c.c., nel desiderio di
giudici e giuristi di far fronte a pressanti problemi concreti, dovuti
(42) Corradini, 1970, p. 501.
(43) Guarnieri, 1988, p. 406.
(44) Rodotà, 1969, pp. 184 e 186.
(45) Natoli, 1974, p. 31 parla di « sostanziale sordità dei nostri giudici al richiamo
delle regole della correttezza e della buona fede; v. anche Nicolò, 1960, p. 247, laddove
auspica che i giudici sappiano servirsi di tali regole, recepite nella nuova codificazione, « in
modo più penetrante di quanto di solito facciano ».
213
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
alla presenza di significative lacune nel sistema codificato (46),
lacune che la successiva codificazione si farà carico di riempire, con
conseguente ridimensionamento degli spazi attribuiti alla bona
fides quale tecnica di formazione di nuove regulae iuris.
A differenza che in Germania, non fu comunque neanche il
periodo corporativo a comportare un rinnovato interesse per le
“clausole generali” in campo privatistico. La dittatura, nell’intento di sottolineare il legame con la tradizione romanistica e di
esaltare il concetto idealistico di Stato, favorì piuttosto « la facciata “formalistica” del diritto » (47). Rimase minoritario il tentativo d’impiego di tali clausole quale tecnica di trasposizione nel
sistema civilistico dei principi politici elaborati dal regime (48). Al
di là dei classici omaggi alla politica fascista, i giudici, salvo
eccezioni (49), non dedicarono soverchia attenzione alla buona fede
dell’allora art. 1124 c.c. ed espressero estrema diffidenza verso ogni
auspicio di « superamento dell’angusta lettera della legge » (50).
Quel tentativo riuscì invece a far breccia nella redazione finale
del successivo codice civile, dove il largo ricorso a clausole generali
vecchie e nuove avrebbe dovuto garantire l’aderenza del diritto
civile alle direttive del potere politico. Il che non valse, però, a
modificare di fatto la situazione, poiché, anzi, il metodo sistematico riuscì obiettivamente rafforzato dalla novella codificazione, in
quanto espressione fedele, quest’ultima, proprio di tale metodo.
Neppure il tramonto dell’esperienza corporativa arrivò, del
resto, a segnare il declino del formalismo giuridico, a cui fu piuttosto attribuito, negli anni del post-corporativismo, il merito di
aver ostacolato la penetrazione nel sistema privatistico dei principi
del regime. In un tal contesto, le clausole generali vennero considerate, salva la persistenza di isolate eccezioni (51), « strumenti
imprecisi e pericolosi », capaci di « minare alla base l’ordinamento »,
di compromettere « la certezza del diritto » e consentire « un controllo discrezionale », dunque, « arbitrario del giudice sulla attività
privata ». Correttezza e buona fede furono, in particolare, ritenute
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
Corradini, 1970, p. 396.
Luzzati, 2013, p. 166.
Il riferimento è, in particolare, al pensiero di Betti, 1940, p. 222.
Su cui v. Guarnieri, 1988, p. 407 e ivi per i relativi riferimenti giurisprudenziali.
Corradini, 1970, p. 540.
Ancora Betti, 1943, pp. 124 s., 245 ss.
214
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
prive di qualsivoglia rilevanza giuridica, giacché espressione di un
ordinamento corporativo ormai non più vigente (52).
Un rovesciamento di prospettiva si avrà presso la dottrina
civilistica solo in tempi più recenti, sul finire degli anni sessanta
dello scorso secolo, in corrispondenza con il progressivo abbandono
del metodo sistematico ad opera di significativi settori della dottrina in direzione di nuove concezioni antiformalistiche. Come si è
osservato, l’attenzione per le clausole generali costituì « l’avventura culturale forse più attraente e fascinosa per le generazioni
giovani che in quegli anni si affacciavano all’arengo del dibattito
scientifico » (53). Si arrivò, da parte di taluni, a caldeggiare una
legislazione per principi (54) e, non senza un certo carico d’ideologia, si invocò, in corrispondenza con l’affermarsi di una nuova
teoria delle fonti, un rinnovato modello di razionalità giuridica, nel
cui ambito assegnare alle clausole generali, in particolare alla
correttezza e buona fede, interpretate alla luce dell’art. 2 Cost., un
ruolo integrativo del regolamento contrattuale in vista della penetrazione dei principi costituzionali nel diritto delle obbligazioni (55).
A distanza di un ventennio, il discorso sarà ripreso e, sia pur
all’interno di un contesto ormai « laicizzato », quindi, meno ideologico del passato, si ribadirà la bontà di una regolamentazione
attraverso clausole generali, anche in ragione della necessità di
arrestare il ben noto fenomeno di fuga verso la legislazione speciale
e di garantire, al tempo stesso, l’apertura del sistema a quel
pluralismo di valori, atteggiamenti e culture tipico delle attuali
organizzazioni sociali (56).
Per quanto « l’idea di governare società complesse ricorrendo
(...) a clausole generali » si sia poi rivelata « illusoria » nel corso del
tempo (57), poiché, anzi, in dimensioni organizzative non omogenee e pluraliste dette clausole rischiano, secondo taluni, addirittura
(52) Guarnieri, 1988, p. 407.
(53) Castronovo, 1986, p. 21.
(54) Rodotà, 1967, p. 83 ss.; in tema v. però già le riflessioni di Nicolò, 1960, p. 241,
per il quale « se il codice rinunzia alla pretesa di definire e regolare tutto, (...) se esso tende
ad essere una articolazione di principi e di regole di ampio respiro (...), la stabilità di un
codice è in definitiva assicurata (...) ».
(55) Rodotà, 1969, p. 111 ss.
(56) Rodotà, 1987, p. 718.
(57) Denozza, 2011, p. 17.
215
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di mostrarsi inadeguate (58), bisogna dar atto a questo indirizzo di
pensiero di aver introdotto un salutare elemento di rottura rispetto
alle tradizionali concezioni in materia di clausole generali, sottolineando quanto oggi sembra un dato acquisito presso la stessa
giurisprudenza e cioè l’esser correttezza e buona fede espressione di
un dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost. (59).
È così che il dibattito ha potuto ripartire, e non più, come era
stato in passato, da una denuncia di possibile « fuga nelle clausole
generali », « che una società informata ai principi della democrazia
e del pluralismo si rivela idonea a rimuovere », bensì, al contrario,
« da un articolato discorso per impedire o fermare (piuttosto)
quella « fuga dalle clausole generali », la quale « viene dichiarata o si
nasconde in una impostazione che aspira alla “purezza” tecnica del
linguaggio e ad un rigore indifferente ad ogni fonte esterna che
cerca di integrarlo e di arricchirlo » (60).
A tutt’oggi, la questione delle clausole generali continua a
suscitare discussioni. Continua a farlo, però, in un clima più
disteso, giacché dibattere del tema « ha cessato di comportare una
presa di posizione pro o contro il formalismo interpretativo ». È,
insomma, venuta meno « l’urgenza di risposte ideologiche » (61).
Del resto, ai più, le clausole generali appaiono ormai « ineliminabili
(58) Parla di « potenziale anacronismo » delle clausole generali Pedrini, 2014, p. 172;
v. anche le osservazioni di Taruffo, 1989, p. 334 secondo il quale « un sistema di valori stabili
e coerenti può essere individuato (...) nelle società statiche e omogenee, o omogeneizzate da un
gruppo dominante. Questa non è però la situazione delle società moderne, dinamiche e
conflittuali, in cui valori diversi caratterizzano i diversi gruppi sociali e politici, le classi, i
movimenti d’opinione, gli strati sociali ed economici, ed anche i singoli individui. In queste
condizioni, il rinvio alla morale sociale è pressoché privo di senso »; per alcune riflessioni sui
rapporti tra pluralismo e clausole generali v. anche Carusi D., 2011, 1692.
(59) Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22819, in NGCC, 2011, 4, 1, p. 355, con
nota di Russo; Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1618, in CED Cass., 2009; Cass. civ., Sez.
III, 18 settembre 2009, n. 20106, in RDC, 2010, p. 653 ss., con nota di Panetti; Cass. civ.,
Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056, in CED Cass., 2008; Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2008,
n. 21250, in G. Comm., 2010, II, p. 229 con nota di Grosso; Cass. civ. sez. I, 5 novembre 1999,
n. 12310, in FP, 2000, I, p. 348 ss.; Trib. Genova, 11 aprile 2013, in RIDL, 2014, II, p. 185
ss., con nota di Donini.
(60) Rescigno, 2011, p. 1689.
(61) Luzzati, 2013, p. 170; in tema v. anche Astone, 2011, p. 1715, che ravvisa « il
superamento della contrapposizione tra clausole generali e norme “comuni”, spesso vissuta
come drammatica », giustificandolo « essenzialmente con il tramonto del positivismo »; più di
recente, v. anche Del Punta, 2014, 373 ss., che, in posizione anti-cognitivista, sottolinea
particolarmente il ruolo del giudice « quale soggetto che produce diritto » (p. 375).
216
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dalla “tecnica” legislativa » (62). In buona sostanza, esse « non sono
né la peste, né una panacea » (63). Alla luce di ciò, la stessa
immagine della “fuga” (nelle o dalle clausole generali), che « si
associa all’idea di una minaccia » dai « volti opposti e alquanto
manierati dell’implacabilità della dura lex ovvero dell’arbitrio illimitato del giudice (fiat iustitia pereat mundus) », tende a scolorire (64). Si rafforza, invece, per converso, l’istanza di approfondimento analitico della materia e con essa la necessità di interrogarsi,
secondo equilibrio e senza chiusure aprioristiche, su struttura e
funzione di dette clausole.
2.3. Struttura e funzione delle clausole generali.
È stato segnalato come « solo per comodità espositiva » si
possano « distinguere con nettezza struttura e funzione delle clausole generali, in quanto (...) il modo » in cui le medesime sono
« ricostruite sul piano strutturale » finisce in buona parte per incidere anche sul profilo funzionale (65). Se questo è vero, bisogna,
allora, convenire sul fatto che qualsiasi indagine sulla funzione
delle clausole generali debba prendere le mosse da uno studio della
loro struttura (66). A riguardo, continua, tuttavia, a regnare molta
(62) Rescigno, 2011, 1689; nello stesso senso D’Amico, 2011, p. 1704, il quale sostiene
che sarebbe ingenuo porsi « tra le domande rilevanti l’alternativa “Clausole generali: sì o
no?” (oppure, se si vuole riformulare in altro modo la domanda: “È preferibile una
“legislazione per principi” o una legislazione basata sulla tecnica della “fattispecie”?) perché
nessun ordinamento può fare a meno di ricorrere a “clausole generali”, ma al contempo
nessun ordinamento potrebbe basarsi esclusivamente su clausole generali ».
(63) Luzzati, 2013, p. 170; v., del resto, già lo stesso Rodotà, 1967, p. 720, il quale
ammette come « le clausole generali non » possano, « per sé sole, costituire la soluzione per
tutti questi problemi »: il riferimento è alla dissoluzione dell’impianto concettuale tradizionale, quale effetto dei mutamenti e dell’accresciuta complessità della società.
(64) Breccia, 2007, p. 444; del resto, per l’idea secondo la quale le « clausole elastiche
sono strumenti neutri il cui contenuto può essere determinato volta per volta mediante
qualsiasi tipo di valutazione politica, v. già Alpa, 1971, p. 281; Roselli, 1983, p. 141, ad
avviso del quale « norme elastiche, concetti indeterminati, clausole generali non sono (...)
tipici di alcun ordinamento politico ».
(65) Fabiani, 2012, p. 192, nt. 62.
(66) Per questo si può dubitare di quanto sostiene Denozza, 2011, p. 4, secondo cui
« la domanda fondamentale » è « cosa si può fare » di fronte a una norma contenente una
clausola generale e non, invece, « cosa è » una clausola generale, secondo un’impostazione
« spesso tanta cara ai filosofi », giacché deve ritenersi che la risposta al primo interrogativo
presupponga necessariamente la soluzione della seconda.
217
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
incertezza, con ovvi riflessi problematici sull’inquadramento teorico, nonché sulle modalità applicative della stessa correttezza e
buona fede.
Si è rilevato che già la locuzione “clausola generale” porta con
sé un equivoco di fondo. L’attributo “generale”, siccome evocativo
« di una forma di fattispecie che — in alternativa alla tecnica
legislativa “per casi e fattispecie” — descrive con grande generalità
un àmbito di casi e li consegna alla valutazione giuridica » (67),
rischia di ingenerare una deleteria confusione con i concetti indeterminati (o c.d. norme generali) (68). Da questi, invece, le clausole
generali si distinguono ampiamente. Ciò perché la loro indeterminatezza, o alta capacità di astrazione (69), che dir si voglia, non è
dovuta alla necessità, in certi contesti giuridici, di andare oltre una
elencazione casistica delle singole ipotesi particolari. Essa si spiega,
piuttosto, per l’esigenza di aprire il mondo del diritto a principi o
criteri di valutazione metalegislativi, che il giudice non trova,
dunque, nella legge, bensì in sistemi valutativi diversi ed esterni a
essa (70).
Se si intende “specializzare” il concetto di clausola generale,
per coglierne tutto il suo proprium diventa insufficiente enfatizzare
semplicemente quel tratto di « “indeterminatezza intenzionale” »,
che lo caratterizza, ma che lo accomuna, al tempo stesso, ai
concetti indeterminati (71). Occorre, invece, chiarire come, a differenza di questi ultimi concetti, le menzionate clausole funzionino
da congegni normativi finalizzati a garantire il rinvio a valori tratti
(67) Engisch, 1970, p. 193.
(68) Luzzati, 2013, p. 163, il quale osserva che « il termine tedeschizzante “clausole
generali” (Generalklauseln) non è dei più felici. Troppo spesso a tale espressione si associa
indebitamente l’idea di una formula ampia e comprensiva contrapposta all’elencazione
casistica delle singole ipotesi particolari »; v. anche Castronovo, 1986, p. 26.
(69) Di Majo, 1984, p. 546.
(70) Mengoni, 1986, passim; D’Amico, 2011, p. 1705; Di Majo, 1984, p. 542 e passim;
Belvedere, p. 642 e passim; Taruffo, 1989, p. 313; Rescigno, 1998, p. 2, che parla di « delega
a ricercare “valori” fuori dei rigidi confini dell’ordinamento positivo »; riconduce, invece, le
clausole generali « nell’ambito assai vasto delle norme elastiche » Roselli, 2013, p. 3; in
giurisprudenza, da ultimo, cfr. Cass., sez. lav., 14 marzo 2013, n. 6501, in RIDL, 2013, II,
pp. 888 ss., con nota di Ratti, ove si parla di « norme elastiche o clausole generali (entrambe
le locuzioni possono adoperarsi fungibilmente, come altre di analoga valenza) ».
(71) Rodotà, 1987, p. 728, il quale, non a caso, considera « fragile la distinzione tra
concetti giuridici indeterminati e clausole generali » (p. 723 s.).
218
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dall’esperienza sociale (72) e non si configurino quale semplici
categorie riassuntive di una generalità di casi. Da tal punto di
vista, sarebbe altresì riduttivo intenderle « come mera tecnica legislativa ossia una tra le tante tecniche che possono adoperarsi dal
legislatore per meglio garantire il rapporto tra diritto e realtà
sociale. L’uso delle clausole generali serve anche a consentire
l’ingresso, nel mondo del diritto a principi o criteri extralegislativi.
Sotto questo profilo l’uso delle clausole generali è una scelta di
valore di un qualsiasi ordinamento, più o meno “aperto” a valori
provenienti da altre realtà » (73).
Se così stanno le cose, appare evidente che le Generalklauseln
assumono i tratti di termini valutativi (74), contenuti in enunciati
normativi (75) e caratterizzati da una forte « contaminazione valoriale » (76), nonché, per conseguenza, da una « naturale estroversione » (77), indirizzando il giudice nella ricerca “all’esterno” dell’ordine di valori da cui far discendere la decisione del caso concreto.
È, del resto, proprio questa caratteristica e cioè il connotarsi in
senso estroflesso della clausola generale a spiegarne la elasticità. Ed
invero, nella sua funzione di strumento d’interazione tra ambiente
(72) Betti, 1955, passim parlò di concetti connotati da una « eccedenza di contenuto
assiologico »; v. anche Rescigno, 1998, p. 1.
(73) Di Majo, 1984, p. 542; diversamente Engisch, 1970, p. 197, per il quale « il vero
significato delle clausole generali risiede nel settore della tecnica legislativa » e in posizione
sostanzialmente adesiva Rodotà, 1987, p. 723.
(74) Cfr. Velluzzi, 2006, p. 8, che così definisce una serie di termini, tra cui la buona
fede e il buon costume, in contrapposizione ai « termini non valutativi (ad esempio:
impossibilità sopravvenuta) ».
(75) Velluzzi, 2010, p. 26 ss.; Belvedere, 1988, p. 632.
(76) Forcellini, Iuliani, 2013, p. 23, nt. 68 con richiamo a Piraino, 2010, p. 1186.
(77) Mazzamuto, 2011, p. 1698; v. anche D’Amico, 2011, passim; Mengoni, 1986,
passim; ciò impedisce di ritenere che i criteri di determinazione del significato delle clausole
generali possano anche essere di natura interna al sistema giuridico, cui l’enunciato
normativo contenente la clausola generale appartiene: per questa opinione v., invece,
Velluzzi, 2010, p. 65 ss., dalla cui definizione di clausola generale prende le mosse anche
Ballestrero, 2014, 392 ss., per poi, tuttavia, discostarsene in parte, quando afferma che
« laddove la fattispecie sia completa (per quanto aperta) e il sintagma valutativo in essa
contenuto rinvii l’interprete alla considerazione di standards che rientrano nella “cornice”
disegnata da altre norme (o insiemi di norme) (...) saremmo al di fuori dell’ambito delle
c.g. »; v. anche Fabiani, 2012, p. 217; per ulteriore tesi cfr., poi, Libertini, p. 352 e 354,
secondo cui dovrebbe essere il ricorso a disposizioni di principio di diritto positivo a
costituire il criterio integrativo fondamentale delle clausole generali.
219
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
giuridico e dimensione sociale, la clausola permette al sistema di
“evolvere”, facendo propri — « per così dire “in automatico” » — i
cambiamenti che si producono di in volta in volta all’interno dei
vari sottosistemi socio-culturali, « senza bisogno (e prima ancora)
che il legislatore “recepisca” attraverso le sue norme tali cambiamenti » (78). Si pensi, se non proprio all’elasticità della buona fede
oggettiva dell’art. 1375 c.c., a quella del buon costume dell’art.
2035 c.c., che implica « l’enunciazione di regole via via mutevoli nel
tempo » (79), al punto da legittimare, oggi, una concezione di
“immoralità” riferita ad un giudizio di più generale disvalore
sociale, con una lettura ampia dell’art. 2035 c.c. alla stregua di
norma posta a tutela dei più generali e fondamentali interessi
dell’ordinamento (80).
Si comprende bene, dunque, quale straordinaria duttilità il
legislatore attribuisca ad un enunciato normativo quando vi inserisca all’interno una clausola generale. Quest’ultima suona alla
stregua di un’« autorizzazione » (81) al giudice a ricercare da sé la
norma sociale di condotta da applicare al caso concreto, in assenza
di una fattispecie astratta delineata dal legislatore medesimo (c.d.
integrazione valutativa (82)).
Siamo di fronte a un congegno normativo molto diverso — è
bene ribadirlo ulteriormente — da quello sotteso alle “norme
generali” o “elastiche”. Queste ultime conservano ancora una
struttura tradizionale, data « da una fattispecie e da un comando »,
con la sola peculiarità che la fattispecie descrive una generalità di
casi, sicché il giudice, nell’esercizio della sua attività interpretativa, sarà indotto a concretizzarli rinviando « volta a volta a
modelli di comportamento e a stregue di valutazione obiettivamente vigenti nell’ambiente sociale in cui opera », con un ampiezza
di giudizio significativa, sì, ma pur sempre espressiva di una
« discrezionalità di fatto » (83). Si pensi all’ipotesi della « giusta
(78) D’Amico, 2011, p. 1708.
(79) Gazzoni, 2013, p. 49.
(80) Caringella, De Marzo, 2008, p. 205.
(81) Il termine è impiegato da Esser, 1983, p. 55, in riferimento a « fattispecie con
riferimenti a parametri extrapositivi ».
(82) Secondo un’espressione impiegata per la prima volta da Engisch, 1970, p. 199,
sia pur con riguardo ai « concetti normativi in senso stretto ».
(83) Mengoni, 1986, p. 9 s.
220
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
causa » e del « giustificato motivo » di licenziamento (artt. 2119 c.c.
e 3 l. n. 604 del 1966), ove il giudice dispone comunque di una
fattispecie astratta, ossia di una pre-valutazione del legislatore;
sicché basterà sussumere il fatto concreto entro quella fattispecie
per darle specifica concretizzazione.
Il discorso cambia, invece, al cospetto di enunciati normativi
contenenti clausole generali. Anche qui siamo in presenza di una
delega al giudice, ma l’intervento giudiziale si svolge nell’assenza
di un patrimonio di dati offerti dal testo normativo (84) e la
discrezionalità valutativa richiesta all’organo giudiziario assume,
dunque, connotati qualitativi peculiari: è una discrezionalità produttiva o integrativa di norme (85).
Grazie all’impiego della clausola generale, il legislatore si
astiene dal compiere una sua pre-valutazione, preferendo piuttosto
formulare una direttiva al giudice per la ricerca “all’esterno” della
regola di decisione, sì da consentire ai valori ivi consolidati di
penetrare nel sistema giuridico proprio per il tramite dell’organo
giudiziario, il quale funge, in tal modo, da “canale di collegamento” fra il mondo del diritto e la dimensione sociale.
Alla luce di ciò, sembra, allora, condivisibile l’idea che « delle
clausole generali può apprezzarsi » soprattutto « l’aspetto di rottura con il tradizionale sillogismo giudiziale, secondo il quale le
regole dell’agire debbono essere sempre ricavate da giudizi e valutazioni pre-esistenti » (86). In maniera efficace, anche se tecnicamente imprecisa, per così dire, si è parlato di una “sussunzione”
operante alla rovescia: quando è in gioco una clausola generale,
(84) « Nel comune sentire, la norma giuridica è una regola generale, capace di
adattarsi alle diverse situazioni della vita; le clausole generali presuppongono invece un
sistema senza regole formulate ex ante, fondato sulla concreta giustificazione della soluzione
accolta che l’interprete riesce ad offrire »: Astone, 2011, p. 1716.
(85) Per la concezione “qualitativa” di clausola generale Di Majo, 1984, p. 539 ss.;
Belvedere, 1988, p. 631 ss,; Mengoni, 1986, p. 5 ss.; Luzzati, 2013, p. 173 ss.; Forcellini,
Iuliani, 2013, p. 425; D’Amico, 2011, p. 1704 ss.; contra Castronovo, 1986, p. 21 ss., che opta
per una concezione “quantitativa” di clausola generale; cfr. pure Rodotà, 1987, p. 723, per
il quale « rimane nella sostanza valida la sottolineatura di Engisch, quando mette in
evidenza che “il vero significato delle clausole generali risiede nel settore della tecnica
legislativa, senza che ciò comporti una diversa qualità delle norme che le prevedono ».
(86) Di Majo, 1984, p. 569; nello stesso senso Mengoni, 1986, p. 16 s.; Taruffo, 1989,
p. 319; D’Amico, 2011, 1709 ss.; Patti, 2013, p. 88; nonché già Esser, 1983, p. 55; contra
Luzzati, 2013, p. 190; Velluzzi, 2010, p. 81 ss.; Carusi D., 2011, p. 1693.
221
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
« non è il fatto concreto che va “sussunto” nella “norma” (già
data), bensì è il giudizio del fatto (...) a riempire di contenuto e a
“concretizzare” la clausola generale » (87).
Si pensi, ad esempio, all’art. 1175 c.c.: qui il legislatore « non
compie una propria valutazione, ma si affida a quella altrui » (88).
Com’è stato efficacemente rilevato, si ha una « sospensione del
giudizio da parte del legislatore, la sua remissione a una competenza diversa » (89); sicché il giudice, quando applica l’art. 1175
c.c., trae dalla clausola generale ivi contemplata una regola, che la
norma stessa, però, non contiene, avendo scelto il legislatore di
devolvere all’organo giudiziario stesso il potere di ricercarla/
definirla a partire dal caso concreto e all’interno dell’ordine dei
valori segnato dalla clausola medesima, nella specie la direttiva di
correttezza.
Ciò vuol dire, più in generale, che le clausole generali si configurano quali congegni volti a sollecitare la produzione di regole
ulteriori, destinate a combinarsi, nell’ambito normativo in cui
operano, con quelle già esistenti, talora integrandole, talaltra limitandone l’operatività (90). Siamo, insomma, certamente di fronte a
un « fenomeno di produzione normativa » (91): in particolare, a una
« tecnica di formazione giudiziale della regola da applicare al caso
concreto, senza un modello di decisione precostituito da una fattispecie normativa astratta » (92).
Da tal punto di vista, le clausole generali operano secondo
modalità diverse anche dall’equità (93). Entrambe, clausole gene(87) D’Amico, 2011, p. 1710; v. anche Taruffo, 1989, p. 319.
(88) Belvedere, 1988, p. 647, nt. 29.
(89) Rodotà, p. 723.
(90) Così Forcellini, Iuliani, 2013, p. 7, con specifico riferimento alla buona fede;
secondo Mengoni, 1986, p. 11, « nell’ambito normativo in cui si inserisce la clausola generale
introduce un criterio ulteriore di rilevanza giuridica (...) ».
(91) Belvedere, 1988, p. 634.
(92) Mengoni, 1986, p. 10.
(93) Ibidem, p. 13, ove si insiste su tale distinzione, ritenendo « la confusione con
l’equità una delle cause degli eccessi in cui cade la giurisprudenza tedesca nell’applicazione
del § 242 BGB » (p. 8); e infatti v., nella dottrina tedesca, Esser, 1983, p. 55 secondo cui,
nell’ipotesi di clausole generali, « il giudice viene rinviato all’apprezzamento di tutte le
circostanze da considerare nel singolo caso, per l’equità della decisione, in modo tale che egli
(...) esercita una giurisprudenza del caso singolo nel senso più schietto del termine, secondo
una diretta normativa ad hoc »; v. anche Wieacker, 1956, p. 36 ss., richiamato in Mengoni,
1986, p. 8 e in Alpa, 2003, p. 1; Klinder, 1998, p. 54 ss., ove emerge chiaramente la funzione
222
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
rali ed equità, sollevano la questione del particolare ruolo attribuito all’organo giudiziario in funzione integrativa dell’autonomia
privata (art. 1374 c.c.) (v. anche infra, in questa sezione, § 3.2.).
Tuttavia, mentre l’equità autorizza il giudice a rintracciare la
regola specifica in funzione della peculiarità del caso concreto, le
clausole generali lo delegano, al contrario, a trarre dal dato sociale
regole generali (di condotta) a partire dal caso concreto (94). Ciò
implica che la valutazione integrativa dell’organo giudiziario potrà
rivestire carattere suppletivo o correttivo dell’autonomia privata
solo nel primo caso (quello della valutazione secondo equità), ove
prevale l’esigenza di un giudizio tutto calibrato su circostanze di
fatto che resterebbero altrimenti irrilevanti, non invece nel secondo (quello connesso al processo di “concretizzazione” della
clausola generale), ove emerge piuttosto il bisogno di un’integrazione (in luogo di una modificazione) giudiziale del regolamento
contrattuale tramite la formazione, sulla scorta dei dati reali del
caso da decidere, di regole ulteriori, suscettibili di generalizzazione,
espressione di valori inerenti all’esperienza sociale (95).
2.4. Il controllo sul processo di “concretizzazione” delle clausole
generali: il controllo “monte” e il rapporto delle clausole con
gli standards e i principi generali dell’ordinamento.
Un nodo fondamentale del discorso sulle clausole generali
riguarda il controllo sull’operato del giudice, giacché l’inclinazione
altresì correttiva del regolamento negoziale attribuita nell’ordinamento tedesco alla buona
fede, quale conseguenza del suo intrecciarsi al giudizio di equità.
(94) L’equità non è, dunque, una clausola generale, come non lo è la “ragionevolezza”, che rappresenta, anch’essa un mero criterio di giudizio o canone di valutazione, non
potendovisi ravvisare una delega a ricercare valori fuori dai confini dell’ordinamento
positivo (Patti, 2013, p. 19 s.; v. anche Troiano, 2013, p. 784, che critica, peraltro, la
tendenza europea — eclatante il caso olandese — all’abbandono della clausola di buona fede
in favore della ragionevolezza); per alcuni potrebbe essere piuttosto utilizzata al fine di
verificare la coerenza di standards e norme sociali di condotta ai principi generali dell’ordinamento, sul presupposto che quanto è ragionevole risulta altresì coerente con detti
principi: D’Amico, 2007, pp. 429 ss. e 465 s., non vidi, ma cit. in Fabiani, 2012, p. 226;
tuttavia, in senso critico nei confronti di tesi che tendono ad attribuire alla ragionevolezza
la funzione di standard ai fini della corretta applicazione del dovere di buona fede, v. Patti,
2013, p. 25.
(95) Sulla distinzione tra giudizio di equità e giudizio secondo buona fede, per la
« funzione più integrativa che correttiva » svolta dalle clausole generali, v. Zoli, 1988, p. 223.
223
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
valoriale di dette clausole e l’assenza di una fattispecie normativa
astratta di riferimento rimarca il ruolo creativo del magistrato e
accentua il tasso di “pre-comprensione” (Vorverständniss) (96)
della decisione, sollecitando, a “monte”, la ricerca di parametri
oggettivi cui ancorare il giudizio — o, come è stato detto, « criteri
generali » volti a « guidare l’interprete nell’applicazione delle clausole generali » (97) e, a “valle”, la possibilità di un sindacato, in
sede di impugnazione, sulle scelte compiute dal giudice (98).
Quanto alla questione a “monte” (99), bisogna osservare che, a
dispetto di quanto potrebbe in prima battuta supporsi, l’organo
giudiziario non gode di discrezionalità assoluta nel procedimento di
concretizzazione della clausola generale (100). Ciò è palese se si
considera, intanto, che ciascuna clausola, per quanto indeterminata, offre già all’interprete « certi criteri di valutazione e non
altri ». A tal stregua, differenti saranno, ad esempio, le valutazioni
di un dato comportamento, a seconda che le si effettui alla luce
della “correttezza” o del “buon costume”, pur non potendosi
ovviamente escludere un esito di egual « segno (positivo o negativo) » con rispetto al medesimo comportamento. Ogni singola
clausola generale, insomma, nel suo atteggiarsi a direttiva indicativa dell’ordine dei valori dal quale far discendere la decisione,
disegna una “cornice”, entro cui il giudice è chiamato a muoversi.
Pertanto, questi sarà autorizzato a ricercare regole sociali di condotta del più vario contenuto ma pur sempre nel rispetto della ratio
ascrivibile a quella “cornice” (101).
(96) Esser, 1983; Di Majo, 1984, p. 547 s.; nella dottrina giuslavoristica, si sofferma
sul punto Calcaterra, 2000, p. 318.
(97) D’Amico, 1989, p. 451.
(98) Cfr. Fabiani, 2012, p. 224 ss. e ivi per una esauriente analisi del problema sotto
ambedue i profili; v. anche Roselli, 2013, p. 6.
(99) Tale questione va affrontata sia pur nella consapevolezza di una sua connessione
al tema della “giustificazione razionale” nel campo delle decisioni giudiziarie e, più in
generale, del ragionamento giuridico, tema che qui non si può avere neppure la lontana
pretesa di esplorare, data la sua complessità.
(100) « Il fatto che la legge attribuisca al giudice ampi poteri creativi non significa,
infatti, che essi possano essere esercitati in modo arbitrario, e che il giudice sia svincolato dal
dovere di giudicare secondo criteri razionali e controllabili »: Taruffo, 1989, p. 314; v. anche
D’Amico, 1989, p. 452, per il quale « lo “spazio di libero giudizio” che le clausole generali
dischiudono non è uno spazio illimitato »; per questo le clausole generali non possono dirsi
“norme in bianco”, come ritiene, invece, Esser, 1983, p. 55.
(101) Belvedere, 1988, p. 635.
224
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Come si comprende, « l’attività di produzione normativa del
giudice è condizionata e indirizzata », dunque, « da una attività
interpretativa, esercitata sul termine (valutativo) che indica la
clausola generale e volta ad individuare » la ragione ispiratrice
« della disciplina che deve essere posta » (102).
Nello svolgimento di questa attività, il giudice deve, anzitutto,
porsi alla ricerca di modelli o parametri oggettivi di comportamento, riconoscibili come « forme esemplari dell’esperienza sociale » (103), i c.d. standards, che possano fungere da guida per la
individuazione della regola di decisione (del caso in discussione). Al
tal stregua, si tratterà di interrogarsi circa l’esistenza, all’interno
della vita sociale, di condotte, opinioni, aspettative dotate di una
tale regolarità da potersi ritenere socialmente accettate, nonché
capaci di inverare l’ordine dei valori sotteso alla singola clausola
generale, sì da offrirne precisa traduzione.
Gli standards svolgono una funzione centrale in sede di “concretizzazione” della indeterminatezza propria delle clausole in
parola, giacché da essi è possibile enucleare un catalogo di tipi
normali (figure tipiche o sintomatiche) di comportamento (c.d.
Fallengruppen) a disposizione dell’organo giudiziario per la ricerca
della norma sociale di condotta da applicare al caso concreto. Gli
standards restano, tuttavia, mere direttive, ossia strumenti orientativi non vincolanti per il giudice, poiché essi mantengono il loro
connotato identificativo di criteri di « regolarità sociale » (104) e non
sono, pertanto, idonei a esprimere un « dover essere ». Si è rilevato,
a ragione, che il rapporto tra clausole generali e standards « non ha
la natura di rinvio (recettizio) a una norma sociale di condotta »,
bensì di rinvio a modelli « riconoscibili come forme esemplari
dell’esperienza sociale », costituenti « linee di riflessione per la
ricerca della regola di decisione » (105).
Si pensi così, ancora una volta, alla clausola di correttezza
dell’art. 1175 c.c. Il giudice per offrirne una concretizzazione ai fini
della soluzione del caso, dovrà individuare gli standards di riferimento e conseguentemente le figure tipiche di comportamento,
cioè capire quali sono, tra le tante condotte tenute dai consociati,
(102) Ibidem.
(103) Mengoni, 1986, p. 15.
(104) Per questa espressione Carusi D., 2011, p. 1691.
(105) Mengoni, 1986, p. 13.
225
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
quelle che possono dirsi corrette nella sensibilità sociale consolidata del momento. Tuttavia, lo standard funzionerà, nei confronti
del giudice stesso, alla stregua di mera linea direttiva, perché la
clausola generale dell’art. 1175 c.c. non gliene imporrà il rispetto,
come fosse una norma vincolante. È stato osservato che gli standards rappresentano solo il punto di partenza di « un’argomentazione dialettica strettamente aderente (..) al caso da decidere, il cui
oggetto è la ricerca metodica del grado di verosimiglianza delle
ipotesi di soluzione corrispondenti ai punti di vista valorativi messi
a confronto ». Ne deriva che la concretizzazione di ogni singola
clausola generale potrà realizzarsi anche attraverso « una decisione
non corrispondente puntualmente a modelli di condotta già sperimentati » (106), purché formulata all’esito di un iter argomentativo
guidato dai precipui standards sottesi a quella clausola.
Ciò, del resto, è perfettamente coerente a una visione del
diritto come branca del sapere capace di fungere da interprete e da
guida del mutamento sociale. In un tal contesto, spicca il ruolo del
“diritto vivente”, secondo una formula — da intendersi nell’accezione tecnica più diffusa, alla stregua di « risultato interpretativo
consolidato » (107) — evocativa del « complesso problema della
partecipazione del giudice alla formazione del diritto » (108), con
inevitabili collegamenti al tema qui in discussione. Risalta, però,
anche il ruolo della dottrina, che non potrebbe mai restare ai
margini di una discussione sui rapporti tra dimensione giuridica e
realtà sociale, limitandosi a registrare con approccio casistico le
acquisizioni giurisprudenziali (109).
(106) Ibidem, p. 15.
(107) V. Fabiani, 2012, p. 219.
(108) Mengoni, 1990b, p. 448.
(109) Come osserva Rodotà, 1987, p. 728, « in questo senso la casistica giurisprudenziale costituisce sicuramente un punto di riferimento importante, ma non esclusivo, dal
momento che la riflessione va in primo luogo rivolta ai dati sociali ed ai valori, nonché ai
principi fondamentali, ai quali le clausole generali debbono necessariamente riferirsi, al fine
di mettere a punto adeguati modelli operativi »; v. anche Falzea, 1987, p. 17, per il quale
« sarebbe un grave errore di prospettiva avere riguardo soltanto alla » prassi giudiziale « e
non anche alla » prassi sostanziale « nella identificazione della natura e del contenuto degli
standards valutativi (...). Questo errore sarebbe tanto più inspiegabile ove si rifletta sul
punto, che gli standards valutativi, trovando la loro radice nel tipo di esistenza e nello stile
di vita della società, si uniformano, almeno tendenzialmente, agli standards etici, che, ancor
prima del diritto, aggregano i gruppi sociali e li costituiscono in comunità politiche. Gli
standards valutativi, dunque, debbono essere studiati nell’ambito del processo di determi-
226
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Come visto, l’applicazione o, meglio, la “concretizzazione”
delle clausole generali pone anzitutto un problema di identificazione nell’esperienza sociale di figure sintomatiche dei valori cui le
clausole generali rinviano. Queste ultime richiedono un’attività
conoscitiva e interpretativa della realtà, volta a individuare dati,
per verificare, anzitutto se certe regolarità meritino di assurgere a
standards riconosciuti e se sì, con quali contenuti, ossia nelle vesti
di quale norma di condotta. In un tal contesto, il ruolo della
dottrina potrebbe, allora, essere prezioso, almeno se e nella misura
in cui la stessa riuscisse a trarre dal discorso sulle clausole generali
nuova linfa per una discussione concettuale sui valori, capace di
captare e valutare nuove istanze, opinioni, aspettative di una
società in rapido cambiamento, persino prima che queste trovino
espressione nelle aule dei tribunali, sì da porre il confronto teorico
al centro dell’interazione tra sistema giuridico e dimensione sociale (110).
Nella riflessione sui limiti posti alla discrezionalità del giudice
nel processo di “concretizzazione” delle clausole generali, un interrogativo di rilievo attiene al rapporto tra standards e principi
generali dell’ordinamento. Ci si chiede, in particolare, se i primi
debbano comunque essere sottoposti ad un test di compatibilità con
i secondi, in particolare con le norme costituzionali. La risposta è
positiva, giacché tali norme si collocano in posizione di evidente
supremazia anche rispetto agli standards. Pertanto, non potrà darsi
accoglienza a valori, desunti da “fonti” extralegali, che siano in
contrasto con direttive costituzionali (111).
nazione progressiva della realtà giuridica e sono di competenza, oltre della funzione pratica
del giudice, del compito teorico del giurista, formando oggetto, rispettivamente, dell’ermeneutica empirica dell’attività giurisdizionale e dell’ermeneutica teorica dell’attività scientifica ».
(110) Per alcune osservazioni sul punto, nell’ambito di una più generale riflessione
sull’impiego delle clausole generali a fini limitativi dei poteri imprenditoriali, v. Gragnoli,
2010, p. 18 ss.
(111) Fabiani, 2012, p. 219; D’Amico, 1989, p. 453; in giurisprudenza per la tesi (sia
pur formulata in riferimento alla giusta causa) secondo cui l’operatività in concreto di
clausole generali debba « rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale a
cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare in cui la concreta
fattispecie si colloca », v. Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2005, n. 21213, in ADL, 2006, p.
903 ss., con nota di Garattoni; Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 2000, n. 5299, in FI, 2003, I, c.
1847 ss., con nota di Fabiani; Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 2002, n. 17208, in LG, 2003,
p. 344 ss., con nota di Mannacio.
227
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Da tempo la dottrina ritiene che il giudice, nell’applicare le
menzionate clausole, debba ispirarsi ai principi della Costituzione (112). Questo è vero, ma solo nella misura in cui « ogni
attività di produzione normativa (...) non può che costituire attuazione delle norme costituzionali » (113). Come già detto, gli
enunciati contenenti clausole generali hanno natura estroflessa e se
ne tradirebbe la ratio ove se ne concepisse l’applicazione nei
termini di una mera ripetizione di precetti costituzionali (114). Le
clausole generali, in quanto termini valutativi idonei ad orientare
il giudice fuori dal campo del diritto, alla ricerca di regole di
(112) Rodotà, 1969, pp. 134 ss., 163 ss. e 184 ss.
(113) Belvedere, 1988, p. 639.
(114) « Un problema di rapporti tra clausole generali e norme o principi vigenti
indubbiamente sussiste, ma va risolto senza negare la natura creativa dell’attività del
giudice, evitando cioè di ridurla a mera iterazione di precetti »: Belvedere, 1988, p. 638. Alla
luce di ciò, il richiamo ai principi costituzionali non può essere concepito come strumento di
determinazione del contenuto (ossia del significato) della clausola generale, ma va considerato quale mezzo di controllo della conformità a Costituzione dei relativi standards cui la
clausola generale rinvia. Ai principi costituzionali può, al più, essere attribuito il significato
di « peculiare chiave di lettura, confermativa — o meno — dei valori espressi dalla coscienza
sociale »: Zoli, 1988, p. 226. Una dottrina (Roselli, 1983, p. 211) ha ritenuto i principi
costituzionali « strumenti (“interpretativi”) che (...) possono essere usati dalla Cassazione
civile per ridurre l’area di indeterminatezza delle disposizioni di legge elastiche », con ciò,
però, « implicitamente riconoscendo » — come rileva opportunamente Di Majo, 1984, p. 570
e nt. 85 — « la estrema difficoltà di distinguere ciò “che appartiene” alla norma costituzionale e/o alla clausola generale. Quando es. si interpreta la buona fede alla stregua della
“solidarietà sociale” espressa dall’art. 2 Cost. non è il richiamo alla prima un obiter dictum
per dare ingresso alla seconda? ». Così il riferimento alle clausole generali sfuma e queste
finiscono per essere offuscate dalla concorrenza dei principi costituzionali, cui si è ormai
disposti tendenzialmente a riconoscere la diretta applicabilità ai rapporti tra privati (c.d.
Drittwirkung): su tale diretta applicazione v. ad es. l’indirizzo inaugurato da Cass. civ., Sez.
Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in RIDL, 2009, II, p. 645 ss., con note di Scognamiglio R.
e di Del Punta, che ha abilitato il giudice a risarcire il danno ex art. 2059 c.c. in presenza di
lesioni di diritti o interessi inviolabili di natura non patrimoniale riconosciuti dalla Costituzione. Si capisce che in un tale scenario, il richiamo alle clausole generali, se concepito
essenzialmente come veicolo di penetrazione della Costituzione nei rapporti privati, diviene
superfluo. E, infatti, v. Belvedere, 1988, p. 639, per il quale « non va (...) sottovalutato il
rischio di inutilità che si corre se si giunge a ridurre l’attività applicativa delle clausole
generali ad una semplice iterazione dei precetti costituzionali, almeno se a questi ultimi si
è disposti a riconoscere la possibilità di una diretta applicazione nella disciplina dei rapporti
tra privati, senza il bisogno quindi di un tramite privilegiato rappresentato dalle clausole
generali civilistiche »; hanno, tuttavia, sostenuto l’assenza di valore precettivo nei rapporti
tra privati dell’art. 2 Cost., Mengoni, 1997, p. 3 s.; Saffioti, 1999, pp. 53 e 56; Lambo 2007,
p. 75.
228
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
condotta (morali, etiche, di costume, ecc.) proprie di sottosistemi
sociali, hanno struttura e funzione diversa dai “principi generali”,
incluso quelli costituzionali, che racchiudono i valori fondamentali
della civile convivenza secondo l’ordinamento giuridico (115). Perciò, potrà darsi l’ipotesi in cui norma costituzionale e clausola
generale esprimano « valori distinti, anche se necessariamente compatibili ed eventualmente anche convergenti verso la medesima
qualificazione positiva o negativa di determinati comportamenti »,
come pure potrà accadere che esse arrivino, invece, a manifestare
una « coincidenza o almeno un rapporto di genere a specie » tra
loro (116).
Sempre nella logica di una “concretizzazione” delle clausole
generali aderente alla razionalità complessiva del sistema si
muove, infine, quella dottrina favorevole alla traduzione delle
clausole medesime in corrispondenti categorie concettuali o « strutture dogmatiche assiologicamente orientate ». L’opinione è persuasiva, se si considera che i valori e le correlative regole sociali non
sono suscettibili di una « visione immediata » e, pertanto, richiedono necessariamente di essere incorporati in categorie concettuali, per potersi integrare nel sistema giuridico. Così, ad esempio,
la correttezza di cui all’art. 1175 c.c. si traduce nella categoria degli
“obblighi di protezione” tanto da potersi inserire, con funzione
(115) Come ben pone in luce Rodotà, 1987, p. 721, « le clausole generali non sono
principi, anzi sono destinate ad operare nell’ambito segnato dai principi ». Da ciò bisognerebbe però dedurre, come già detto, che detti principi non possano essere utilizzati per
riempire di contenuti le clausole generali (così invece Rodotà, 1969, p. 171 con riferimento
alla clausola di correttezza). Tra queste ultime e i principi generali dell’ordinamento esiste
un rapporto di forte correlazione, ma il significato e la funzione delle prime non può essere
appiattito sui secondi. Se, infatti, i principi generali dell’ordinamento racchiudono i valori
etici fondamentali su cui si fonda la convivenza civile, le clausole generali, presupponendo
detti principi, spingono il giudice alla ricerca di regole di condotta, connesse a valori posti
nell’ambito dei vari sottosistemi e gruppi sociali, dunque, espressione degli aspetti culturali,
economici e mercantilistici della società: cfr. Forcellini, Iuliani, 2013, p. 14. Per questo, v’è
da chiedersi fino a che punto sia corretto “concretizzare” una clausola generale mediante la
tecnica di bilanciamento tra valori costituzionali (su cui v., di recente, nell’ambito di una
ricostruzione dei lineamenti fondamentali del neocostituzionalismo, Bongiovanni, 2013, p.
84 ss. spec. p. 95 ss.): in giurisprudenza per l’opinione favorevole a tale bilanciamento in
ipotesi di « giusta causa » di licenziamento, sul presupposto, peraltro, di una coincidenza tra
la categoria della “norma elastica” e quella della “clausola generale” v., ad es. Cass. civ., sez.
lav., 2 novembre 2005, n. 21213, cit.
(116) Belvedere, 1988, p. 639.
229
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
integrativa, nell’ambito normativo di disciplina dei rapporti obbligatori.
Concepite in tal modo, le categorie concettuali non esauriscono, pertanto, il contenuto delle clausole generali, sempre
« aperte alla possibilità di nuove applicazioni, ma consolidano (...)
una serie di ipotesi applicative » già verificatesi nella pratica,
agevolando lo stesso « compito del giudice in ordine ai casi futuri »
sussumibili entro le medesime categorie (117), in vista di un
impiego accorto e consapevole delle clausole, nonché di un controllo razionale su di esso (118).
2.5.
Segue: il controllo a “valle” e il sindacato di legittimità.
Se da “monte” si scende a “valle”, il problema fondamentale
diventa quello della sindacabilità della decisione di merito, emanata all’esito del processo di “concretizzazione” della clausola
generale, ad opera della Corte di Cassazione, cui è attribuito il
controllo finale di legittimità sulle pronunzie di merito (art. 360
c.p.c.) e altresì la c.d. funzione nomofilattica (art. 65 ord.
giud.) (119).
I problemi derivano dalle peculiarità del giudizio sotteso alle
clausole in parola, in particolare, dalla circostanza che il giudice è
qui chiamato a una integrazione della norma, per il tramite di
(117) Mengoni, 1986, p. 19.
(118) D’Amico, 1989, p. 461. L’Autore, peraltro, individua un ulteriore limite generalissimo, posto all’interprete nella “concretizzazione” delle clausole generali, quale rappresentato dalla c.d. natura del fatto (Natur de Sache), con ciò intendendosi « esprimere
l’immanenza a ciascun “rapporto di vita” (Lebensverhältnis) di un principio ordinatore, o
comunque di un quid di rilevante o tipico, che ne definisce la struttura essenziale, e che,
come tale, condiziona lo stesso legislatore, il quale, nel valutare e qualificare i fatti di vita
non può appunto prescindere dalla loro “natura” ». La Natur de Sache, se destinata a
condizionare il legislatore, tanto più dovrebbe costituire un limite per la stessa attività
creativa del giudice, il quale, per individuare la “natura del fatto”, dovrebbe affidarsi « non
soltanto a dati, per dir così, “naturalistici” e “pregiuridici”, ma anche » a « principi e (...)
regole giuridiche operanti nel particolare settore che viene in esame » (p. 457). Il che
comporta che il contenuto di una medesima clausola possa essere diverso a seconda del
contesto in cui opera, ossia « a seconda della “natura” dell’istituto o del settore dell’ordinamento rispetto al quale quella clausola deve essere applicata (...) »: cfr. D’Amico, 2008,
pp. 429 ss. e 465 s., non vidi, ma cit. in Fabiani, 2012, p. 226.
(119) Sul punto, è fondamentale il contributo di Roselli, 1983¸ Id., 1988, p. 667 ss.;
Id., 2011, p. 1701; Id., 2013, p. 1 ss.
230
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
un’attività valutativa, la quale intreccia quasi inestricabilmente
“fatto” e “diritto”, per di più ai fini della formulazione di una
regola di condotta, che, rinviando a regole sociali, è destinata a
rimanere fuori dall’ambito giuridico in senso puro.
Siamo, allora, all’interno di quella « dimensione processuale »
delle clausole generali (120), che non può certo essere trascurata in
questa sede, per quanto la sua specificità ed elevata complessità,
oggetto di rinnovato interesse nello stesso diritto del lavoro, ne
imponga una trattazione sintetica.
Al di là della più ampia problematica relativa alla delimitazione del sindacato della Cassazione, il discorso deve partire dal
nuovo indirizzo inaugurato sul finire degli anni ’90, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (121), la quale, (soprattutto) in tema di
giusta causa di licenziamento, ma anche (più limitatamente) di
buona fede e correttezza, ha affermato che « il giudizio di merito
applicativo di norme elastiche è soggetto al controllo di legittimità
al pari di ogni altro giudizio fondato su qualsiasi norma di
legge » (122), secondo un orientamento espressamente fatto proprio
oggi dallo stesso legislatore (art. 30 l. n. 183 del 2010). Successivamente, e da ultimo, la Cassazione è tornata più volte sul punto,
sempre a proposito di giusta causa ex art. 2119 c.c., talora riproducendo espressamente il menzionato principio o comunque confermandolo nella sostanza, talaltra discostandosene in parte, senza
assumere, tuttavia, una posizione univoca e consolidata.
In talune ipotesi, i giudici, pur aderendo all’indirizzo sopra
illustrato, hanno precisato come « il controllo di legittimità (...)
della Cassazione » non si esaurisca « in una verifica del contenuto
della norma, ma sia « esteso alla sussunzione del fatto, accertato
dal giudice di merito nell’ipotesi normativa » (123). In altre, sono
ricorsi alla “contrapposizione” fra « “specificazioni del parametro
normativo”, che « hanno natura giuridica » e « “accertamento della
(120) Fabiani, 2012, p. 193.
(121) Panuccio, 2000, p. 85 ss.; Calcaterra, 2000, p. 315 ss.
(122) Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1998, n. 10514 e Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio
1999, n. 434, in FI, 1999, I, c. 1891 ss., con note di Fabiani e De Cristofaro; Cass. civ., sez.
lav., 13 aprile 1999, n. 3645, ivi, 1999, I, c. 3558, con nota di Fabiani; per un esame critico,
nel merito, di tali sentenze, v. Nogler, 2014a, p. 131 ss.
(123) Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2006, n. 27464, in RIDL, 2007, II, p. 641, con
nota di Zoppoli.
231
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
concreta ricorrenza”, nel fatto, « “degli elementi che integrano il
parametro normativo e le sue specificazioni”, e della loro concreta
attitudine a costituire giusta causa di licenziamento », accertamento che si colloca, invece, « sul diverso piano del giudizio di
fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione
se privo di errori logici e giuridici » (124). Infine, in ulteriori
occasioni, la Corte, approfondendo ulteriormente, ha affermato che
« solo l’“integrazione giurisprudenziale a livello generale ed
astratto” della nozione di giusta causa (...) si colloca sul piano
normativo e consente una censura per la violazione di legge;
mentre l’“applicazione in concreto” del più specifico canone interpretativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità
se non per vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria » (125). Merita, allora, quanto meno un cenno — per gli effetti
ulteriormente restrittivi del controllo di legittimità su norme e
clausole generali (126) — l’intervenuta riforma dell’art. 360, 1°
comma, n. 5, c.p.c., che ha cancellato il ricorso in cassazione per
vizi della motivazione della sentenza impugnata, sostituendovi il
motivo fondato sull’« omesso esame circa un fatto decisivo che è
stato oggetto di discussione tra le parti ». La novella ha evidentemente inteso limitare il più possibile l’ambito del sindacato di
legittimità sulla motivazione della sentenza, ma resta comunque
aperta la via di un « controllo sull’esistenza (...) e sulla coerenza »
della stessa; il che implica pur sempre la possibilità, per la Suprema
Corte, di sindacare le gravi, evidenti illogicità e contraddizioni
riscontrabili nell’anzidetta motivazione, tali, dunque, da integrare
il vizio di violazione di legge, secondo il più recente insegnamento
delle Sezioni Unite (127).
Al di là dei più generali interrogativi suscitati da tale novella,
il problema che le pronunce finora citate sollevano è rappresentato,
(124) Cass. civ., sez. lav., 29 aprile 2004, n. 8254, in CED Cass., 2004.
(125) Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2005, n. 7838, in MGL, 2005, p. 839, con nota di
Pizzuti; è da rilevare come l’impugnazione dinanzi alla Cassazione per vizio di motivazione
insufficiente e contraddittoria è venuta meno ai sensi del nuovo testo dell’art. 360, 1°
comma, n. 5, c.p.c.
(126) Nella dottrina giuslavoristica, v. AA.VV., 2013, p. 7 ss.
(127) Cass. civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, in Il Fisco, 2014, p. 1682, con nota
di Russo; sulla riforma dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., Poli, 2013, p. 203 ss.; con accenti
fortemente critici Taruffo, 2014, p. 381 ss.
232
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
in realtà, dalla loro premessa, accogliendosi una concezione di
clausola generale allargata e fungibile rispetto a quella di “norma
generale” o “elastica” (128). Una tale concezione pare, ora, avallata dallo stesso legislatore, nell’intento di porre limiti a quegli
spazi di creatività del giudice (del lavoro) derivanti da enunciati
normativi a carattere flessibile e indeterminato (129) e con la
precisazione, peraltro, che l’inosservanza di tali limiti « costituisce
motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto » (130)
(art. 30, 1° comma, secondo periodo, l. n. 183 del 2010).
Si tratta, per i motivi sinora illustrati, di una concezione non
persuasiva, che giunge a sacrificare, almeno in parte, la stessa
(128) In tal senso si esprime la giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., sez. lav., 14
marzo 2013, n. 6501, cit.; Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2011, n. 5095, in CED Cassazione,
2011; Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2005, n. 21213, cit., la quale, da un lato, precisa che
le norme rientranti nella nozione di “clausola generale” sono « connesse ma non confondibili » con le “norme elastiche”, dall’altro, però, qualifica l’art. 1 l. n. 604 l. n. 604 del 1966,
con l’indicazione della giusta causa e del principio di proporzionalità, come disposizione
riconducibile all’« ambito delle “norme elastiche” e (corsivo nostro) di quelle (...) rientranti
nella nozione di “clausola generale” », per quanto, poi, giunga a valutare la gravità del
comportamento del debitore di opere non in base al sentire sociale, bensì alla stregua delle
attese del datore di lavoro creditore. Ciò dovrebbe suonare a conferma implicita che la
« giusta causa » è concetto indeterminato o elastico, che dir si voglia, non, invece, clausola
generale, come ben sottolineato da una parte della dottrina giuslavoristica: cfr. Tullini,
2013, p. 156; Nogler, 2011, p. 927 ss.; Gragnoli, 2010, p. 27 ss.; Carinci M.T., 2005, p. 101 ss.;
contra Napoli, 1980, p. 108; non è chiaro, tuttavia, fino a che punto la giurisprudenza
qualifichi la « giusta causa » quale clausola generale e la tratti poi effettivamente come tale,
considerato che la pronuncia appena citata non rinuncia comunque a riaffermare il potere
del giudice di discostarsi dagli standards collettivi, cosa, questa, che riesce a giustificarsi solo
negando, appunto, la natura di clausola generale della « giusta causa ».
(129) Il riferimento è all’art. 30, 1° comma, primo periodo, l. n. 183 del 2010, su cui
cfr. Gragnoli, 2010, p. 29, secondo cui « la disposizione vuole solo censurare pretesi eccessi di
discrezionalità del giudice: quindi, l’espressione “clausole generali” è da vedere in senso
estensivo e atecnico, chiamata ad abbracciare tutti i casi di creatività delle pronunce e di
interferenza con prescrizioni suscettibili di una più intensa rielaborazione interpretativa »;
invece, per la mera presa d’atto del fatto che « l’espressione “clausole generali” entra, così,
nel linguaggio legislativo », allo scopo di « indicare, al di là del più ristretto significato
tradizionale, qualsiasi norma contenente un precetto generico », v. Vallebona, 2010, p. 211;
analogamente Ghera, Valente, 2010, p. 866, per i quali « la norma intende restringere la
discrezionalità interpretativa indubbiamente ampia in presenza di enunciati legislativi
generici o c.d. “aperti” »; rilievi fortemente critici, tuttavia, in Rescigno, 2011, p. 1690.
(130) Come visto, tale previsione trova ormai riscontro nella giurisprudenza di
legittimità e, pertanto, ad essa può attribuirsi mera portata « ricognitiva di una posizione già
acquisita » in ambito giurisprudenziale: Del Punta, 2013, p. 23.
233
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
« dimensione processuale » specifica delle clausole generali (131),
con un’alterazione, peraltro, dello stesso ragionamento decisorio
sotteso all’applicazione della “norma generale” o “elastica” (132).
Alla luce delle ricostruzioni finora compiute su struttura e
funzione di dette clausole, non sembra che ad esse si attaglino
affermazioni, come quelle appena menzionate, secondo cui il controllo di legittimità della Cassazione è esteso (anche) alla sussunzione del fatto nella norma o comunque all’integrazione giurisprudenziale della nozione legale (di giusta causa), ma non all’applicazione “in concreto” della stessa. Le clausole generali « non descrivono una fattispecie » e sono prive di una nozione “a monte”,
essendo caratterizzate proprio dall’assenza di una pre-valutazione
normativa. Perciò, esse, come già sottolineato in precedenza, vivono in un rapporto di reciproca esclusione con il modello sillogistico tradizionalmente impiegato per descrivere il c.d. ragionamento decisorio (133).
Al cospetto di clausole generali, quali la correttezza e la buona
fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), il giudice non applica una norma
giuridica astratta mediante riconduzione ad essa dei fatti relativi al
caso concreto, con una decisione assiologicamente orientata, come
accade, invece, di fronte alla giusta causa (art. 2119 c.c.), che è
(131) Ma diversamente Fabiani, 2004, p. 8 s., per il quale « non sembra corretto (...)
introdurre possibili distinzioni sotto lo specifico profilo del sindacato della Cassazione a
seconda (...) che vengano in rilievo ipotesi di indeterminatezza del testo della norma di tipo
“quantitativo” o “qualitativo” ».
(132) Con riferimento a pronunce di legittimità in tema di « giusta causa », le quali
hanno valutato il comportamento del prestatore secondo la tecnica del bilanciamento tra
principi costituzionali (artt. 4 e 41 Cost.), invece che alla stregua delle specifiche norme
legislative di disciplina dei fenomeni oggetto di giudizio, si è parlato di « semplificazione
della giustificazione » della decisione, con conseguente indebolimento della funzione nomofilattica attribuita alla Cassazione: Nogler, 2014a, p. 135. Probabilmente, ciò che qui si pone
giustamente in luce con tono critico potrebbe essere il riflesso di un errore di prospettiva dei
giudici stessi, quale dato proprio dall’assimilazione delle norme generali alle clausole
generali. È, infatti, esattamente tale assimilazione a fuorviare i giudici, ponendoli alla
ricerca di standards sociali — con i principi costituzionali elevati a criteri orientativi della
ricerca stessa — invece di indirizzarli verso una considerazione più attenta dei singoli
elementi interni al sistema normativo. Nasce da qui, evidentemente, quell’impressione, di
« semplificazione della giustificazione con la rimozione, in sede di motivazione della decisione, di una serie di vincoli argomentativi pure positivamente previsti », denunciata dalla
dottrina appena citata (p. 134 s.).
(133) Taruffo, p. 319; D’Amico, 1989, p. 446; Mengoni, 1986, p. 16 s.; Di Majo, 1984,
p. 569; contra Luzzati, 2013, p. 190; Velluzzi, 2010, p. 81 ss.
234
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
“norma generale” o “elastica”. Egli concretizza la clausola generale
a partire dai fatti riguardanti il caso concreto, per arrivare ad
individuare la norma sociale di condotta, con una decisione corrispondente a un giudizio di valore. Detta norma è, peraltro, suscettibile di generalizzazione, ma (in quanto “sociale”) trova “fonte” in
specifici sottosistemi, esterni a quello giuridico, e risulta, quindi,
sprovvista « del carattere di universalità (...) proprio del termine di
un giudizio sussuntivo in senso logico-formale »; sicché appare
inidonea a fungere da premessa maggiore di un sillogismo (134).
Nella “concretizzazione” di una clausola generale, come può
essere la correttezza e buona fede, non v’è, quindi, da chiedersi se
la sussunzione del fatto costituisca o meno “giudizio di diritto”,
giacché il meccanismo di funzionamento della clausola generale è
tutto diverso ed è su di esso, nonché sul tipo di attività richiesta al
giudice, che bisogna ragionare.
Quando il magistrato ritiene di trovarsi in presenza di una tal
clausola, sa, come detto, di avere a che fare con dati fattuali
inerenti al caso concreto, i quali sono non da sussumere entro la
norma astratta, ma da porre a base di partenza per la ricerca,
tramite rinvio a standards sociali, di una norma sociale di condotta.
È sufficiente questa circostanza — e cioè che la regola generale di
comportamento sia formulata in stretta aderenza a circostanze di
fatto — per sottrarre il giudizio di valore al sindacato di legittimità
della Corte di Cassazione?
Intanto, bisogna dire che tale giudizio, benché fondato su uno
stretto intreccio tra fatti e decisione finale, non è paragonabile a
quello di equità (135) — su cui, invece, insistono espressi limiti di
sindacabilità/appellabilità — essendo formulato, come già sottolineato in precedenza, (non in funzione del, bensì) a partire dal caso
concreto. Siamo di fronte, cioè, ad una attività finalizzata alla
formazione giudiziale di vere e proprie regole giuridiche mediante
il metodo casistico. Al di là della pura ricostruzione processuale dei
fatti, ossia di cosa è veramente successo, tale attività, in cui si
concreta il giudizio di valore, non può essere esonerata da un
controllo, anche di legittimità, tanto più se si considera che essa si
intreccia con una forte attività interpretativa, che non avviene
(134)
(135)
Mengoni, 1986, p. 12.
Roselli, 2013, p. 5.
235
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
« nel vuoto, bensì all’interno del campo delimitato dal legislatore » (136).
Già la qualificazione di un dato sintagma alla stregua di
clausola generale implica un’interpretazione da parte del giudice
che può essere di non poco conto, se a venire in considerazione
siano termini la cui appartenenza alla categoria in parola sia
dubbia. C’è, poi, l’individuazione dello standard e la verifica di una
sua conformità ai principi generali dell’ordinamento. Anche questa
fase presuppone un’attività valutativo-interpretativa da parte del
magistrato suscettibile di un successivo controllo a valle, anche di
legittimità (137).
Quanto, invece, all’individuazione del contenuto dello standard
e alla sua traduzione in specifica norma di condotta, qualche
perplessità in merito alla sindacabilità ex art. 360, 1° comma, n. 3,
c.p.c. potrebbe venire dal fatto che detta norma resta fuori dallo
stretto campo del diritto. Tuttavia, anche chi ha sostenuto l’insindacabilità del responso tratto dalla standard, non avendo « il giudice di legittimità miglior titolo dell’altro quale interprete, piuttosto che del diritto positivo, di dati ad esso estrinseci », ha dovuto
poi ammettere la problematicità di una simile affermazione, « perché (...) la normalità statistica, i sentimenti diffusi, la “coscienza
comune” sono costantemente strutturati dal diritto » (138).
Altri ha rilevato che « la possibilità di sindacare le decisioni che
applicano clausole generali anche nel merito, e dunque sotto il
profilo di un loro possibile contrasto con il diritto, se da un lato
riduce il rischio di decisioni (del tutto) “arbitrarie” da parte dei
giudici di prime cure, dall’altro comporta altresì, (...) il pericolo di
“irrigidire” (in qualche modo) il contenuto della clausola generale,
finendo per generalizzare direttive dotate, invece, di un elevata
soggettività (139). Ma a questo discorso si può obiettare che le
clausole generali, proprio perché pongono un notevole problema
pratico di « fondazione della decisione » (140), a fronte del forte
rischio di « soggettivismo giudiziario » postulano già “a monte” una
loro tipizzazione entro categorie dogmatiche precostituite; sicché
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
Del Punta, 2013, p. 23.
Fabiani, 2012, p. 238 ss.
Carusi D., 2011, p. 1693.
D’Amico, 2011, p. 1713.
Mengoni, 1986, p. 18.
236
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
non sarà certo il successivo controllo ad irrigidire le clausole
medesime. Anzi, la loro traduzione in specifiche strutture concettuali viepiù giustifica un’attività conoscitiva e valutativa della
Suprema Corte, anche alla luce della funzione nomofilattica ad essa
attribuita. Detta attività « “rientra a pieno titolo in quella attività
di interpretazione e applicazione delle norme che fornisce le premesse per la decisione in diritto”, nel controllo della cui correttezza
“si manifesta la funzione di nomofilachia che definisce il ruolo
istituzionale della Corte” » (141).
3. Buona fede e correttezza: significati, ambiti e modalità di applicazione.
3.1. Origini e contenuto della buona fede e della correttezza.
Coincidenza o distinzione di nozioni?
Sono state accese e risalenti nel tempo le dispute consumatesi
attorno al concetto di buona fede, ma non è certo questa la sede per
darne partitamente conto. Un chiarimento è, tuttavia, utile in
partenza e riguarda la questione della natura etica o psicologica del
concetto medesimo, giacché quando si parla di clausola generale di
buona fede è alla sola accezione oggettiva di quest’ultima che
s’intende alludere, come si è potuto ben comprendere: rileva, in
altri termini, la buona fede intesa quale regola di condotta, cioè
alla stregua di comportamento secondo buona fede, e non di stato
della coscienza di colui che è in buona fede, alla stregua di
un’accezione propriamente soggettiva del termine (v., a titolo
meramente esemplificativo, artt. 1337, 1358, 1375 c.c. e, rispettivamente, gli artt. 534, 2° comma, 535, 2° comma, 1147, 1° comma,
c.c.) (142).
(141) Fabiani, 2012, p. 244, con richiamo a Taruffo, 2003, p. XX.
(142) La distinzione generale e fondamentale tra buona fede oggettiva e soggettiva,
che riposa sul distinto impiego normativo del termine, è ormai corrente: Bessone, D’Angelo,
1988, p. 1; anche se non sono mancati orientamenti volti a negare ogni possibile distinguo
- con la buona fede ridotta a mero stato psicologico soggettivo, in linea con una più generale
tendenza a svalutare le clausole generali (Montel, 1958, p. 599) — ovvero ricostruzioni
unitarie, ruotanti attorno ad una supposta comune matrice etica del concetto (v. Romano
Salv., 1959, p. 677 ss.); tali ricostruzioni sono, tuttavia, smentite alla luce della prospettiva
237
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Ciò chiarito, si può ora volgere lo sguardo alla menzionata
clausola, per ricercarne partitamente il significato.
Su questa strada, va, intanto, anticipato che ragioni legate al
più generale oggetto dell’indagine — quello del rapporto tra clausole generali ed obblighi del prestatore nell’esecuzione del contratto di lavoro — impongono di concentrare l’attenzione sullo
specifico precetto della c.d. buona fede in executivis (art. 1375 c.c.).
Si tratta di una anticipazione rilevante, che va colta fin d’ora,
perché è vero che « l’apparentamento sistematico » tra le varie
norme codicistiche in materia di buona fede contrattuale autorizza
« una ricostruzione unitaria » del concetto (di buona fede oggettiva) (143), ma è altrettanto vero che siamo al cospetto di una
clausola generale, destinata come tale a trovare una peculiare e
distinta “concretizzazione” nei diversi ambiti normativi entro cui
si inserisce, con ogni conseguenza sulla specifica configurazione
della stessa all’interno di ciascun contesto.
È stato, anzi, osservato che la buona fede oggettiva, in quanto
clausola generale, rifuggirebbe a priori da una vera e propria
definizione giuridica, al punto da scoraggiare qualsivoglia tentativo a riguardo. L’opinione contiene alcuni aspetti di verità: la
buona fede « non impone un comportamento a contenuto prestabilito » (144), ma si traduce giocoforza in condotte di tipo diverso,
difficilmente confinabili ex ante entro rigidi schemi definitori (145)
poiché individuate (volta a volta) dal giudice a partire dal caso
concreto, sulla scorta di una delega legislativa per la ricerca di
norme sociali di condotta. Resta, tuttavia, che quella del legislatore all’organo giudiziario non può considerarsi una “delega in
bianco”: come ogni clausola generale, anche la buona fede, nel suo
atteggiarsi a direttiva indicativa dell’ordine valoriale dai cui far
discendere la decisione, disegna una “cornice” di riferimento per il
giudice, sia pur « a maglie assai larghe » (146); sicché sarebbe un
storica, in particolare, della diversa configurazione (prima oggettiva, poi soggettiva) assunta
dalla buona fede nel diritto romano: Bigliazzi Geri, 1988, p. 156 s.
(143) Bessone, D’Angelo, 1988, p. 1.
(144) Bianca, 1983, pp. 206 e 209.
(145) Rodotà, 1969, p. 189 sottolinea l’impossibilità di ridurre le clausole generali
entro « contesti definiti una volta per tutti »; pure per Bessone, D’Angelo, 1988, p. 5, « la
natura stessa delle clausole generali impedisce la individuazione di elementi di giudizio
rigorosi e circoscritti, che, oltretutto, frustrerebbe la stessa funzione della buona fede (...) ».
(146) Bessone, 1969, p. 340 ss.
238
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
errore rinunciare aprioristicamente a individuarne i tratti caratterizzanti.
In quest’ordine di idee, un primo problema attiene al rapporto
della buona fede in executivis (art. 1375 c.c.) con la correttezza (art.
1175 c.c.). Ci si chiede se si tratti di sinonimi, secondo quanto
desumibile dal comune linguaggio tecnico-giuridico, aduso ad un
impiego delle due espressioni a mò di endiadi, ovvero di concetti
dal significato differente, come potrebbero, al contrario, suggerire
la differente terminologia adottata, la diversa collocazione topografica e l’ambito applicativo non del tutto coincidente.
3.1.1. La prospettiva storica.
Ove si guardi alla questione da una prospettiva storica, risalta,
anzitutto, la storia non comune dei due concetti (147): se la
correttezza compare per la prima volta nel vigente codice civile, la
buona fede affonda le sue radici nella tradizione romanistica, con la
parola “fides” a designare « una qualità oggettiva » da attribuirsi a
tutto ciò su cui può farsi sicuro affidamento (148). Il concetto
giuridico di “fides” emerge, tuttavia, solo con l’intensificarsi degli
scambi commerciali di Roma nel bacino del Mediterraneo: nella
specie, con lo sviluppo di un nuovo sistema giuridico, il c.d. ius
gentium, chiamato a regolamentare le relazioni tra cittadini romani
e mercanti stranieri (peregrini), in alternativa al rigido e formalistico ius civile, da cui sarà poi assorbito, in corrispondenza con
l’affiorare del c.d. ius honorarium (149).
Dello ius gentium, la fides, accompagnata dalla qualifica etica
di bona, costituì principio normativo fondante (150): da qui la
nascita del concetto obiettivo della fides bona, e cioè di una
correttezza commerciale destinata a disciplinare specificamente i
rapporti commerciali inter pares, cioè tra soggetti dotati di uno
stesso peso giuridico ed economico (151).
La dimensione processuale della fides bona è testimoniata
dall’affermarsi dei c.d. bonae fidei iudicia, con il praetor peregrinus
(147) In tema, v. amplius Saffioti, 1999, p. 1 ss.
(148) Betti, 1953, p. 76.
(149) Grosso, 1959, p. 1 ss.; Scognamiglio M., 2010; Senn, 1988, p. 131 ss.; Musio,
2010, p. 3 ss.
(150) Grosso, 1959, p. 1 s.
(151) Bigliazzi Geri, p. 156.
239
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
chiamato a ius dicere inter cives Romanos et peregrinos (152). Si è
osservato come tali giudizi modificassero « profondamente il diritto
romano dei contratti, introducendo una superiore tutela basata su
esigenze socialmente riconosciute, a prescindere dagli elementi
sostanziali e formali tipici dello ius civile. Di fatto, i bonae fidei
iudicia permettevano il richiamo a valori etici e sociali, attraverso
« l’introduzione di regole di correttezza che godevano, per la prima
volta, di difesa processuale (...) » (153).
Nel corso del tempo, e fino al VI sec. D.C., « l’ambito della bona
fidei actio si ampliò sempre di più, soprattutto grazie alla introduzione di una chiara distinzione tra obblighi di adempimento e
obblighi di comportamento delle parti. La bona fides, da regola di
mero rispetto della parola data, diventava una vera e propria
regola del rapporto obbligatorio, assumendo la veste di fonte
autonoma dell’obbligazione, distinta dal vecchio ius civile » (154).
La bona fides acquistò poi un « respiro amplissimo » nel periodo
medievale (il periodo del c.d. diritto intermedio), quando essa, in
un contesto di forte simbiosi tra il morale e il giuridico (155), da un
lato, si colorò di venature strettamente fiduciarie, anche alla luce
dei rapporti di subordinazione e di fedeltà tra feudatario e vassalli (156); dall’altro, venne a designare, sul versante propriamente
contrattuale, tre tipi di condotta: l’obbligo delle parti di tener fede
alla parola data; il divieto delle parti di trarre vantaggio da proprie
condotte sleali; il dovere dei contraenti di adempiere alle obbligazioni ritenute giuste da persona onesta e leale, benché non espressamente previste. La bona fides svolse, del resto, un ruolo centrale
nell’ambito della stessa lex mercatoria medievale, divenendo criterio valutativo a tutti gli effetti della condotta delle parti (157).
A propria volta, essa ebbe un ruolo importante anche nel
diritto canonico, il quale contribuì, pertanto, all’affermarsi del
concetto, lì inteso nel senso di coscienza, di morale, tant’è che i
giuristi del c.d. periodo intermedio finirono sovente per identificare
la bona fides con l’aequitas, dando, così, avvio a quel noto processo
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
Grosso, 1959, p. 2; Senn, 1988, p. 131 ss.
Musio, 2010, p. 3.
Ibidem, p. 3.
Massetto, 2006, p. 137.
Serpetti, 2007, p. 2.
Musio, 2010, p. 4.
240
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di commistione tra le due nozioni, capace di aprir le porte ad un
impiego della buona fede quale strumento diretto a orientare
l’interpretazione oltre i limiti dello ius strictum (158).
Nel periodo delle codificazioni ottocentesche, fu, invece, il
richiamo alla filosofia giusnaturalistica a consentire la sopravvivenza del concetto in parola (159), « nella sua peculiare attitudine
a filtrare i valori metagiuridici entro la regola di diritto » (160). A
testimoniare il ricorso dei codici del tempo al ius naturae furono,
infatti, proprio i riferimenti a buona fede ed equità, concepiti in
funzione di temperamento delle istanze individualiste e liberali
proprie dell’epoca. Il code Napoléon li distribuiva in due norme
distinte, collocate nel Chapitre III, intitolato « De l’effet des obligations »: l’art. 1134, 3° comma, per il quale gli accordi « devono
essere eseguiti secondo buona fede » (161); l’art. 1135, alla cui
stregua « gli accordi obbligano non solo a quanto vi è espresso, ma
anche a tutte le conseguenze che derivano dall’equità, dagli usi e
dalla legge » (162).
È, allora, proprio su questa falsariga che l’art. 1124 del codice
civile italiano vede la luce nel 1865: collocato nel § III, intitolato
« Degli effetti dei contratti » — e non « des obligations », come nel
code, per la sentita necessità di distinguere il negozio dai rapporti
obbligatori (163) — vi si legge che « i contratti devono essere
eseguiti di buona fede ed obbligano non solo a quanto nei medesimi
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l’equità,
l’uso o la legge ne derivano ».
La riconduzione ad un unico articolo dell’equità e della buona
fede, da intendersi, secondo l’opinione dell’epoca, alla stregua di
correttezza e di solidarietà, balza evidente agli occhi dell’interprete. Ciò non deve, però, destar sorpresa, considerata la tendenza
degli stessi giuristi francesi a leggere comunque gli artt. 1134, 3°
comma e 1135, del code Napoléon in maniera congiunta, con la
(158) Ibidem.
(159) Corradini, 1970, p. 3.
(160) Tullini, 1990, p. 14.
(161) Art. 1134, troisième alinéa, Code civil 1804: « Elles (les conventions) doivent être
exécutées de bonne foi ».
(162) Art. 1135 troisième alinéa, Code civil 1804: « Les conventions obligent non
seulement à qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi
donnent à l’obligation d’après sa nature ».
(163) Corradini, 1970, p. 85.
241
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
buona fede chiamata a svolgere una funzione integrativa del
contratto alla stessa stregua dell’equità (164). La vicinanza logica
dei due concetti sarà, dunque, oltremodo confermata dalla codificazione italiana, peraltro, con un’interessante estensione, da parte
dottrinale, dei concetti medesimi oltre lo stretto ambito dei contratti: « la equità e la buona fede sono lo spirito vivificatore di tutto
il sistema giuridico e non de’ soli contratti » — si afferma da parte
di taluni — sicché « pecca » chi « limita la buona fede all’esecuzione
delle obbligazioni contrattuali » (165).
3.1.2. Il codice civile vigente e la sostanziale identità dei concetti
di correttezza e buona fede.
Si è già detto di come la cultura giuridica italiana del primo
trentennio del novecento sia rimasta sostanzialmente impermeabile agli orientamenti antiformalistici che andavano affermandosi
nell’Europa continentale, tant’è che lo stesso tentativo d’impiego
della buona fede in funzione traspositiva dei principi del regime
corporativo all’interno del sistema civilistico non trovò particolare
spazio presso i giudici (v. retro § 3.1.2.).
Si è anche osservato, però, come tale tentativo riuscì, invece, a
far breccia nella redazione finale del nuovo codice civile del 1942.
È probabile che il processo di moltiplicazione delle clausole generali in questo ambito ebbe a referente normativo proprio il Volksgesetzbuch tedesco (che molte ne prevedeva), redatto dall’Akademie
für deutsches Recht (senza peraltro mai entrare in vigore) e ben
conosciuto da alcuni giuristi italiani in rapporti con quella Akademie (166).
È in una tale cornice che vanno, allora, inquadrate le vicende
relative alle clausole generali nel libro IV del codice italiano.
Il legislatore si preoccupa, in primo luogo, di valorizzare al
massimo la buona fede negoziale. Lo fa, anzitutto, sul versante
della disciplina degli effetti del contratto, con una scissione del
precedente art. 1124 in due norme — gli artt. 1374 e 1375 — che
suona alla stregua di un ritorno al vecchio code Napoléon, vissuto,
però, in funzione di un rafforzamento (dell’autonomia) della men(164) Ibidem, p. 88.
(165) Fadda, Bensa, 1902, p. 693.
(166) Patti, 2013, p. 63.
242
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
zionata clausola generale rispetto all’equità. Lo fa, poi, anche fuori
da quel versante, con la buona fede chiamata ormai a presidiare il
comportamento delle parti durante tutto l’iter contrattuale: dal
momento delle trattative e della formazione dell’accordo, a quello
dell’esecuzione, della pendenza della condizione e dell’interpretazione del negozio (167).
Il legislatore provvede, in secondo luogo, a introdurre, nell’ambito delle disposizioni preliminari del titolo primo sulle obbligazioni in generale, il riferimento tutto nuovo alla correttezza, stabilendo, all’art. 1175, che « il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, in relazione ai principi
della solidarietà corporativa ».
Non sembra che al fondo dell’intervento legislativo vi fosse il
bisogno di immettere nell’ordinamento una nuova clausola generale, diversa da quella contenuta nel vecchio art. 1124 e poi
trasposta nell’art. 1375. Come visto, già in vigenza del codice civile
del 1865, l’idea prevalente era quella di una regola di buona fede,
espressione di solidarietà e correttezza, sulla falsariga della tradizione romanistica, occasionalmente enunciata in sede di regolamentazione del contratto, ma valida per ogni rapporto obbligatorio (168). Sicché, ove anche l’art. 1175 fosse mancato nel nostro
codice, quella regola si sarebbe probabilmente potuta dedurre da
una lettura estensiva dell’art. 1375.
Piuttosto, premeva l’esigenza formale di ancorare il contenuto
della clausola a precisi termini di riferimento. Qualcosa di simile
era, del resto, accaduto pure per il § 242 BGB, che, similmente, non
mancava — e non manca tuttora — di raccordare la buona fede a
precisi parametri sul piano contenutistico. Tuttavia, se il § 242 fa
richiamo « agli usi del traffico » [« con riferimento agli (...) »], coerentemente all’ideologia liberale dell’epoca in cui fu redatto, l’art.
1175 rinviava « ai principi della solidarietà corporativa » [« in relazione ai (...)], con un inciso che, siccome concepito in evidente
omaggio all’ideologia fascista, sarà definitivamente soppresso mediante l’art. 3, 2° comma, del d.l.lgt. n. 287 del 1944 (169).
(167) In tema v. amplius Castelvetri, 2001, p. 239 s.
(168) Natoli, 1974, p. 6.
(169) È stata invece definitivamente smentita la tesi dell’implicita abrogazione
dell’intero art. 1175 c.c. con la caduta del regime corporativo, tesi affacciata da Ferri, 1963,
p. 412; Pugliese, 1950, p. 71; e infatti cfr. le argomentazioni decisive di Rodotà, 1969, p. 124
243
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Alla luce di un parallelismo tra l’art. 1175 c.c. e il § 242 BGB,
va inquadrata pure la questione relativa all’ambito applicativo
soggettivo della clausola in parola: circoscritto (almeno letteralmente) al solo debitore nel § 242 BGB [« Der Schuldner (...) »] (170);
esteso anche al creditore nell’art. 1175 c.c. [« Il debitore e il
creditore (...) »]. E ciò in ragione di una scelta di reciprocità (171)
— ben esplicitata in apertura della Relazione al Re (172) — che fa
della correttezza una misura di comportamento imposta ad ambedue le parti del rapporto obbligatorio (173), con un netto distinguo
rispetto alla diligenza (174), siccome misura gravante sul solo
debitore nell’adempimento dell’obbligazione, ai sensi del successivo art. 1176 c.c. [« Nell’adempiere l’obbligazione il debitore
(...) »].
In forza di un parallelismo con l’art. 1375 c.c. va, invece,
affrontata la questione dell’ambito applicativo oggettivo dell’art.
1175. Non v’è dubbio, intanto, che una regola di correttezza nei
rapporti obbligatori avrebbe potuto dedursi anche da quella di
buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., al punto
da far persino apparire superfluo, da tal punto di vista, l’art. 1175.
Se quest’ultima norma fosse mancata, non vi sarebbe stato, infatti,
solo l’art. 1324 c.c. a consentire alla buona fede di trascendere
ss. a favore della sopravvivenza del disposto; in giurisprudenza Cass. civ., sez. lav., 3 giugno
1985, n. 3301, in MGL, 1986, p. 44.
(170) V. Patti, 2013, p. 60, laddove sottolinea come il riferimento a « un solo soggetto
del rapporto obbligatorio » abbia « determinato un primo problema di interpretazione ».
(171) V. Betti, 1953, p. 93, laddove afferma che « la buona fede è essenzialmente un
criterio di reciprocità, che deve essere osservato vicendevolmente nei rapporti fra soggetti di
pari grado, aventi una pari dignità morale »; poi diffusamente sulla reciprocità della clausola
Rodotà, 1969, pp. 150, 153 e passim.
(172) Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice civile del 4 aprile
1942, n. 558: « Il codice civile, pur considerando preminente la posizione del creditore, ha
ritenuto, nell’art. 1175 del c.c., di imporgli un dovere di correttezza, e di parificarne la
situazione, da tal riflesso, a quella fatta al debitore: il debitore, per il medesimo art. 1175 del
c.c., è infatti tenuto a identico contegno. (...) Trasferito (...) (il) concetto di solidarietà
nell’ambito del rapporto obbligatorio, si affievolisce ogni dato egoistico, e si richiama nella
sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il
giusto riguardo all’interesse del creditore ».
(173) Per Rodotà, 1969, p. 137, « la formulazione dell’art. 1175 e dell’art. 1375
discende anche dalla volontà di evitare gli equivoci che potevano nascere dal riferimento di
ciascuno di essi al solo debitore o al solo creditore »; in giurisprudenza Cass. civ., sez. I, 5
novembre 1999, n. 12310, cit.
(174) Rodotà, 1969, p. 152 ss., spec. p. 153.
244
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
l’ambito dei rapporti contrattuali, giacché, impiegando una tal
norma, sarebbero comunque rimaste escluse, dall’ambito applicativo della clausola, le obbligazioni ex lege. Si sarebbe potuto altresì
contare sulla valenza della buona fede quale regola portante del
nostro ordinamento (175), suscettibile, per ciò stesso, di interpretazione estensiva.
Certo, però, che una volta dato ingresso nel sistema ad una
norma come l’art. 1175, la quale espressamente estende la regola di
correttezza (pur “germinata” dalla buona fede ed espressione della
stessa) a tutti i rapporti obbligatori, essa si presenta a stregua di un
più ampio “contenitore” rispetto all’art. 1375 (176), al punto da
temperare la stretta necessarietà di tal ultimo disposto (177). Il
che, però, vale a dimostrare proprio la intercambiabilità della
correttezza e della buona fede ex artt. 1175 e 1375. Alla luce di ciò,
si può, pertanto, concludere che la concorde natura di clausole
generali, l’identità di fondamento, la sostanziale coincidenza di
contenuto (178) e la comunanza di ambito operativo (179) delle
due formule attribuisca carattere sostanzialmente unitario al loro
richiamo, autorizzandone un impiego congiunto (180).
(175) Bianca, 1983, p. 206; Persiani, 1966, p. 228.
(176) Per Castronovo, 1990, p. 4, « nel nuovo sistema instaurato dal codice civile del
1942 l’introduzione del principio di correttezza nella previsione normativa dell’art. 1175 c.c.,
in testa alla disciplina generale del rapporto obbligatorio, fa sì che l’interpretazione del
contratto secondo buona fede e l’esecuzione del contratto secondo buona fede vadano
considerate pure specificazioni attraverso le quali viene operata una prima Konkretisierung
di quel principio ».
(177) Per Messineo, 1961, p. 956, « è da riconoscere che l’art. 1375 trova applicazione
nel solo campo dell’obbligazione contrattuale; ma questo porta a osservare che, attesa la
presenza della norma generale, di cui all’art. 1175, quella particolare, di cui all’art. 1375,
potrebbe, forse, considerarsi superflua ».
(178) V. Natoli, 1974, p. 6, nt. 10, per il quale « il significato della distinzione resta
oscuro »; Messineo, 1961, p. 956, a cui avviso « sarebbe arduo stabilire una sensibile
differenza di contenuto fra le due norme ».
(179) Come afferma Gazzoni, 2006, p. 560, « da un punto di vista sistematico, ha (...)
poco senso affermare che la buona fede opererebbe nell’ambito della materia contrattuale
mentre l’art. 1175, nel suo rinvio alla correttezza, avrebbe il compito di estendere il richiamo
all’intera materia delle obbligazioni, posto che anche la materia contrattuale rientra in
questo ambito ».
(180) Per Mengoni, 1997, p. 9, nt. 16 « i due termini, essendo equivalenti, possono
congiungersi in una endiadi »; v. anche Id., 1984, p. 507, ove si parla della correttezza come
« una variante » della buona fede; per la sostanziale coincidenza di contenuto della buona
fede in senso oggettivo con la correttezza, v., tra gli altri, Patti, 2013, p. 17; Lambo, 2007,
245
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
3.1.3. Il contenuto delle clausole di correttezza e buona fede.
Deve ritenersi che buona fede e correttezza, una volta riscontratane la sostanziale unità concettuale, impongano ai soggetti del
rapporto contrattuale (ed obbligatorio in genere) una serie di
comportamenti, espressione di norme sociali, finalizzate a garantire il rispetto e la conservazione dell’altrui interesse in vista
dell’integrale realizzazione, dunque, del buon esito e della stabilità,
del complessivo programma negoziale (181). È in ciò, nella salvaguardia dell’utilità della controparte, che si racchiude l’ordine dei
valori sotteso alla direttiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. È in
quest’ambito che il giudice sarà chiamato a muoversi nella ricerca,
volta a volta, della regola di condotta applicabile al caso di specie,
regola comunque suscettibile di generalizzazione in virtù dell’opera di “concretizzazione” della clausola.
Si può credere che l’indirizzo dato alle parti di preservare
ciascuna l’interesse dell’altra richieda condotte non rigidamente
predeterminabili a priori, ma tutte finalizzate a stabilire una
relazione di rispetto e di collaborazione reciproca tra debitore e
creditore in ogni fase del rapporto (182). Si tratterà di comportamenti a contenuto sia positivo, sia negativo (183), ispirati a lealtà,
cioè al “mantenimento della parola data”, a coerenza, ma più in
generale a spirito di solidarietà (184), perché non salvaguarda certo
l’interesse altrui colui che, pur astenendosi da atteggiamenti sleali,
p. 76 ss.; Bigliazzi Geri, 1988, p. 170; Bianca, 1983, p. 205; Natoli, 1974, p. 6; Rodotà, 1969,
p. 119 ss.; Breccia, 1968, p. 17 s.; contra Betti, 1953, p. 68, sulla scorta di una distinzione tra
la correttezza, che comporterebbe meri obblighi negativi e la buona fede che imporrebbe più
penetranti obblighi positivi; negli stessi termini, Persiani, 1966, p. 223 s.; cfr. pure Saffioti,
1999, p. 31 ss.; Ciccarello, 1988, p. 157 ss.
(181) Rodotà, 1969, p. 152 parla della correttezza « come criterio idoneo a consentire
la formazione di una norma contrattuale tale da rendere possibile la realizzazione completa
dell’operazione economica perseguita dalle parti ».
(182) Analogamente Mengoni, 1997, p. 7.
(183) Diversamente Betti, 1953, p. 68, per il quale, come già detto (cfr. retro, nt. 180),
« la correttezza impone normalmente solo doveri di carattere negativo; la buona fede impone
degli obblighi di carattere positivo ».
(184) Bianca, 1983, p. 209; Rodotà, 1969, p. 143; Mancini, 1957, p. 83; Persiani, 1966,
p. 223; da ultimo v. Lambo, 2007, p. 83; in giurisprudenza, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 27
settembre 2001, n. 12093, in CG, 2002, 3, p. 928 ss., con nota di Di Majo; Cass. civ., sez. I,
22 maggio 1997, n. 4598, in DF, 1997, II, p. 827 ss., con nota di Lembo; diversamente,
invece, Barcellona M., 2006, p. 173, per il quale « la buona fede (...) non introduce affatto (...)
istanze etiche o solidaristiche (...), ma ha, invece, carattere “civile”, cioè è intesa a
246
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
speculativi o comunque di turbativa dell’altro, eviti poi di farsi
carico, in concreto, delle esigenze del medesimo tramite condotte
ispirate a forme di solidarismo attivo.
È stato osservato che questo impegno di solidarietà, il quale si
proietta al di là del contenuto dell’obbligazione e dei doveri di
rispetto altrui, trova « il suo limite nell’interesse proprio del soggetto » (185). Da tal punto di vista, può parlarsi dell’« obbligo di
ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò
non importi un apprezzabile sacrificio a suo carico » (186).
È, invece, da escludere che la richiesta di un contegno ispirato
a senso di solidarietà possa finire per connotare in senso fiduciario
il rapporto tra le parti. La componente etico-solidaristica insita
nella buona fede non può consentire uno scivolamento della stessa
« in un atteggiamento di fedeltà (187) al vincolo », che implicherebbe « fattiva cooperazione », dedizione, « impegno, (...) capacità
di sacrificio, (...) prontezza nel soccorso della controparte » (188),
con una « costante subordinazione dell’interesse del debitore a
quello del creditore » (189). Una nozione di buona fede così lata e
« pregnante » (190), volta a imporre « un obbligo di fedeltà e di
promozione dell’interesse altrui » (191) nei rapporti patrimoniali,
pare mutuata da tradizioni estranee al nostro ordinamento giuripreservare le ragioni del sistema giuridico e dell’autonomia privata (...), traendo dall’uno e
dall’altra i criteri di composizione dei conflitti normativi che è chiamata a dirimere ».
(185) V. Bianca, 1983, p. 209; v. anche la Relazione del Ministro Guardasigilli Dino
Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942, n. 558, ove si legge che « (...) la correttezza (...) è
un dovere giuridico qualificato dall’osservanza dei principi di solidarietà (...). Questo dovere
di solidarietà (...) non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l’interesse altrui
fuori dei limiti della legittima tutela dell’interesse proprio (...) ».
(186) Bianca, 1983, p. 210; in giurisprudenza, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 18
ottobre 2004, n. 20399, in GD, 2004, 44, p. 30 ss.; Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n.
12093, cit.; Cass., sez. I, 5 novembre 1999, n. 12310, cit.; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1997,
n. 4598, cit.; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775, in FI, 1995, I, c. 1296 ss.; Cass. civ.,
sez. III, 9 marzo 1991, n. 2503, ivi, 1991, I, c. 2077 ss.; Cass. civ., sez. I, 18 luglio 1989, n.
3362, in BBTC, 1989, II, p. 537 ss.; Trib. Genova, 11 aprile 2013, cit.
(187) Corsivo nostro.
(188) Betti, 1953, pp. 76 e 93.
(189) Cottino, 1955, p. 146.
(190) Betti, 1953, p. 92; per l’A. dalla buona fede « in senso pregnante » si distinguerebbe la correttezza, da intendersi come mero dovere negativo di astensione « da indebite
ingerenze nell’altrui sfera di interessi » (p. 76).
(191) Tullini, 1990, p. 25, così esprimendo la stessa critica di cui al testo.
247
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dico (192), nonché ispirata ad un concetto di bona fides più vicino
alla tradizione germanistico-medievale che a quella romanistica,
cui si deve invece, come visto, il vigente l’art. 1375 c.c.
Si è molto discusso a proposito della valenza “contrattuale” (193) o propriamente “sociale” (194) della solidarietà evocata da correttezza e buona fede. Il tema chiama in causa la
questione degli standards di riferimento delle clausole generali: se
esse cioè rinviino a dati esterni all’ordinamento ovvero a parametri
interni al medesimo, in quanto « indici della valutazione legislativa
delle esigenze sociali » (195).
L’argomento è stato già affrontato in precedenza e gli esiti cui
si è pervenuti inducono a propendere per la prima opinione. Le
clausole generali — è stato osservato — hanno natura estroflessa,
ossia spingono l’interprete a rinvenire standards di riferimento
fuori dal campo del diritto, nell’ambito dei canoni valoriali interni
ai diversi sottosistemi sociali e se ne tradirebbe la ratio ove se ne
concepisse la “concretizzazione” nei termini di una mera « iterazione di precetti » (196) costituzionali, i quali sono, invece, deputati
a fungere da “cornice” generale entro cui (anche) le diverse e
peculiari norme sociali di condotta devono trovare collocazione.
Sarebbe scorretto un ricorso alle norme della Costituzione per
determinare il contenuto di buona fede e correttezza (197). Il
richiamo a tali norme può avere al più carattere retorico-persuasivo (198), ma non certo assolvere a una « funzione argomentativa
(192) Rodotà, 1969, p. 177; Mancini, 1957, p. 85.
(193) Bianca, 1983, p. 209.
(194) Rodotà, 1969, p. 163 ss.
(195) Ibidem, p. 151.
(196) Belvedere, 1988, p. 638; in tema, con precipuo riferimento alla buona fede, v.
anche Cattaneo, 1971, p. 625 ss.
(197) Così invece Rodotà, 1969, p. 171; a riguardo, v. anche Alpa, 1971, p. 283 ss.; più
di recente Navarretta, 2012, p. 953 ss., la quale, concependo la buona fede come funzionale
alla realizzazione di obiettivi di giustizia, ritiene, con particolare riguardo al suo impiego nel
diritto europeo dei contratti, che, se il riferimento è ora all’Europa, la buona fede debba
essere letta alla luce delle norme sulla solidarietà, l’uguaglianza e tutela dei diritti della
persona, di cui agli artt. 2 e 6 del T.U.E. e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (p. 4).
(198) V. anche Barcellona M., 2006, p. 173 ss., per il quale « buona fede e Costituzione
non c’entrano (...) » (p. 176, nt. 209) e lo dimostrerebbe lo stesso riferimento solo verbale dei
giudici al principio costituzionale di solidarietà in pronunce come quella di Cass. civ., sez. I,
248
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
fondante » nel processo di “concretizzazione” delle clausole (199).
E ciò perché queste ultime trovano all’interno di singoli sottosistemi sociali, non nell’ordinamento giuridico nel suo complesso
(rispetto a cui, certo, quei sottosistemi dovranno poi esprimere
coerenza), i propri referenti valoriali.
« L’art. 2 Cost. » — è stato a ragione osservato — « ha svolto
piuttosto una funzione di rinnovamento della precomprensione
della dottrina di diritto privato (...) aprendola a una progressiva
rivalutazione dell’art. 1175 (...) », ma non ha oscurato il fatto che
« la norma dell’art. 1175 esprime già per se stessa, come proprio
“fondamento etico”, un dovere di solidarietà tra le parti del
rapporto — nel senso specifico di “dovere di ciascuna parte di
assicurare l’utilità dell’altra nella misura in cui ciò non comporti un
apprezzabile sacrificio a proprio carico” — senza bisogno di integrarla con il dovere sociale di solidarietà umana previsto dalla
Costituzione (artt. 2 e 41, comma 2) (...) » (200). Per questo è giusto
ritenere « che il contenuto assiologico della clausola della correttezza e della buona fede è sempre in grado, per chi sappia (e voglia)
leggerla, di tradursi in giudizi di dover essere appropriati al caso
concreto, senza bisogno di stampelle costituzionali » (201).
20 aprile 1994, n. 3775, cit, con nota di Picardi o di Cass. civ., sez. I, 24 settembre 1999, n.
10511, in GC, 1999, I, p. 2929 ss.
(199) Mengoni, 1997, p. 9; lo stesso sarebbe, allora, avvenuto, anche qualora si fosse
soprasseduto all’abrogazione dell’inciso finale dell’art. 1175 c.c., limitandosi solo a sostituire
all’aggettivo « corporativa » l’aggettivo « sociale », secondo un’opzione che, ad avviso di
Mengoni, 1954, p. 393, nt. 35 avrebbe dovuto essere privilegiata dal legislatore; ritiene, al
contrario, positiva l’abrogazione, per la sua idoneità ad eliminare ogni equivoco in merito al
contenuto dell’art. 1175 c.c., Natoli, 1974, p. 28; sottolinea opportunamente l’inammissibilità di un « trapianto nell’art. 1175 (...) del dovere di solidarietà sociale (...), perché esso non
può essere pacificamente contrapposto alla solidarietà corporativa » Castelvetri, 2001, p.
240; cfr. pure ampiamente Saffioti, 1999, p. 47 ss..
(200) Mengoni, 1997, p. 9; sembrerebbe, del resto, confermare ciò anche la definizione
di buona fede che emerge nei testi di diritto contrattuale europeo: v. ad esempio il Draft
Common Frame of Reference (DCFR) (art. I.1: 103, 1° comma) e la Proposta di Regolamento
sul diritto comune europeo della vendita (art. 2, 1° comma, lett. b), alla cui stregua la buona
fede è « uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli
interessi dell’altra parte della transazione o del rapporto in questione ».
(201) Mengoni, 1997, p. 9; per Nicolussi, 2000, p. 707, « presunti agganci costituzionali di tale clausola generale (sarebbero) inutili proprio in quanto si tratta di patrimonio
della tradizione del diritto europeo che non ha alcun bisogno di essere fondata su basi
contingenti e mutevoli come una particolare costituzione nazionale (...). Fondata su una
tradizione giuridica secolare, la buona fede (...) è una clausola generale che restituisce al
249
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Ciò non vuol dire che un problema di raccordo con i precetti
costituzionali sia del tutto estraneo al tema delle clausole generali,
considerato che la “concretizzazione” di queste ultime dovrà comunque avvenire nel quadro segnato dai principi generali dell’ordinamento: certamente, per quanto riguarda la correttezza, nella
cornice dell’art. 2 Cost., di cui andrebbe valorizzato — specie alla
luce delle nuove frontiere del diritto alla riservatezza e del danno
esistenziale — l’aspetto della solidarietà umana, intesa quale garanzia di rispetto della personalità dei soggetti, della loro dignità e
integrità, in una parola, di salvaguardia dei valori della persona,
secondo una visione capace di tenere insieme la dimensione individualistica e mercantilistica del codice con quella sociale del testo
costituzionale (202).
Non sembra, invece, che a correttezza e buona fede possano
collegarsi obiettivi di giustizia distributiva in senso proprio, per il
senso del tutto diverso in cui tali clausole sono state concepite e ci
sono state tramandate dalla tradizione, cioè quella di strumenti
destinati a operare nell’ottica dell’eguaglianza formale tra le parti.
E anche la giustizia commutativa — secondo questa tradizione —
« viene perseguita solo in misura limitata: se infatti è genericamente vero » che ogni valutazione secondo buona fede « mira ad un
giusto equilibrio fra gli interessi delle parti », si è sempre escluso
che essa potesse esigere « la fissazione di un “giusto prezzo” nei
contratti di scambio » (203).
3.2. Modalità operative della buona fede e della correttezza: in
funzione integrativa del regolamento contrattuale. Gli obblighi di protezione ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Chiarito il significato di correttezza e buona fede, ossia l’ordine
dei valori che il giudice è autorizzato a ricercare nell’offrire “concretizzazione” a dette clausole, occorre verificare in quale modo le
diritto un collegamento con i valori etici che nel tempo si sono consolidati in seno alla
coscienza sociale e in questo senso costituisce, nell’ambito del rapporto obbligatorio, una
legittimazione, circoscritta e pur sempre di matrice legale, a una forma particolare di diritto
vivente ».
(202) Saffioti, 1999, p. 71.
(203) Cattaneo, 1971, p. 630.
250
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
stesse, e le relative norme di condotta, operino nei confronti delle
parti del rapporto obbligatorio.
È certo, a riguardo, come la buona fede (art. 1375 c.c.), anche
se formalmente riferita alla fase attuativa del contratto, costituisca
regola oggettiva, la quale concorre a determinare il comportamento dovuto, con funzione integrativa del regolamento contrattuale (204). Ciò con un’incidenza diretta sulla struttura del rapporto obbligatorio, sì da arricchirne il contenuto attraverso un
complesso di regole, ispirate a parametri di moralità sociale, ulteriori rispetto a quelle discendenti dalla volontà delle parti (art.
1374 c.c.) (205).
Non può essere condivisa la tesi contraria, che fa leva sulla
sistematica del codice civile, segnalando il netto distinguo tra
integrazione dell’art. 1374 (affidata a legge, usi ed equità) ed
esecuzione dell’art. 1375 (ispirata a buona fede) (206). Un tale
distinguo, derivante dalla scissione dell’antico precetto unitario
(204) Bianca, 1983, p. 206.
(205) Cfr. Rodotà, 1969, p. 118, che spiega il meccanismo dell’integrazione della
buona fede ex art. 1374 c.c. sulla scorta del richiamo alla « legge » di cui a tale norma,
richiamo il quale « consente già di far capo a tutti quei concetti legislativi che l’interprete
ritiene funzionalmente preordinati alla integrazione del contratto », tra cui appunto quelli
degli artt. 1175 e 1375 c.c.; per la funzione integrativa della buona fede v., oltre a Bianca,
1983, p. 205 s.; Betti, 1953, p. 99; Mancini, 1957, p. 73, che, tuttavia, limita la funzione
integrativa alla sola regola di correttezza dell’art. 1175 c.c.; Persiani, 1966, p. 231 (anche se,
per una successiva più tiepida valutazione del ruolo delle clausole di correttezza e buona
fede, Id., 1995, p. 34 ss.); Mengoni, 1984, p. 510; Zoli, 1988, p. 219 ss.; Castronovo, 1990, p.
4; Mazzamuto, 2003, p. 646 ss.; Lambo, 2007, p. 116 ss.; pertanto, solleva perplessità, in
giurisprudenza, l’orientamento espresso da Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 1995, n. 7190, in
MGL, 1995, p. 370 ss., secondo cui « correttezza e (...) buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c. non creano obbligazioni (...), bensì rilevano o come modalità di generico comportamento
delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti ed obblighi,
oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione ».
(206) Cfr. Natoli, 1974, pp. 3 e 42; aderiscono, tra gli altri, alla presente tesi, della
buona fede esecutiva o correttiva, che dir si voglia, Ghezzi, 1965, p. 90 ss.; Smuraglia, 1965,
p. 245 ss.; Id., 1967, p. 97 ss; Breccia, 1968, p. 130; Bigliazzi Geri, 1988, p. 170 ss.;
Buoncristiano, 1986, p. 163; Saffioti, 1999, p. 62 ss.; Faleri, 2007, p. 47 ss.; v., inoltre,
Restivo, 2007, p. 147 ss., il quale, dopo aver ritenuto « che la distinzione tra buona fede
integrativa ed esecutiva non riflette due modi di essere alternativi di questa clausola, ma è
semplicemente funzione della prospettiva assunta », (p. 153) pare valorizzare particolarmente la teoria della buona fede correttiva, per l’affinità di tale concezione con la figura
dell’abuso del diritto, oggetto del suo studio monografico; in giurisprudenza ammette che la
buona fede « può anche imporre alle parti di operare in modo difforme e contrastante da
quanto stabilito nel contratto » Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1991, n. 2503, cit.
251
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
(art. 1124 c.c. 1865) in due nuove norme separate (artt. 1374 e
1375), riflette storicamente un’esigenza, tutta propria del codice
del 1942, di massima valorizzazione delle clausole generali — con la
buona fede in posizione autonoma rispetto all’equità — più che
esprimere una precipua volontà di escludere la funzione integrativa tipica della buona fede.
Coloro i quali criticano la tesi della funzione integrativa della
buona fede ex art. 1374 c.c., lo fanno con lo sguardo rivolto alla
dinamica del rapporto (207), nella ferma convinzione che la clausola in parola abbia lo scopo di autorizzare una valutazione giudiziale aderente al caso concreto, per garantire che le parti, a fronte
di eventuali “sopravvenienze” in fase esecutiva, realizzino comunque, nella sostanza, l’assetto di interessi di cui al regolamento
contrattuale (208).
Ora, nessuno dubita che il richiamo all’art. 1375 c.c., imponendo una correttezza improntata a parametri di moralità sociale,
possa servire, in molti casi, a gestire eventuali “sopravvenienze”,
legate allo svolgersi dinamico del rapporto, nel rispetto reciproco
dei contraenti e in funzione di quel risultato integralmente utile
sotteso al programma negoziale (209). Solo che ciò non può aprire
(207) V. Natoli, 1974, p. 5, che parla di « inesatta ricomprensione » dell’art. 1175 c.c.
« nella regolamentazione più della statica, che della dinamica del rapporto obbligatorio
(...) ».
(208) Ibidem, p. 4, laddove criticamente osserva che « mentre sulla base anche
dell’art. 1175 si giunge alla costruzione di tutta una serie di obblighi ed oneri complementari
(c.d. di protezione o di sicurezza; di comportamento positivo o negativo, etc.) imputabili in
astratto alle due parti del rapporto, quando poi si passa alla fase di attuazione di questo, di
tali effetti (...) non sembra essere percepibile più alcuna traccia. Eppure il senso della norma
sembra essere nettamente diverso: essa non tende, infatti, ad ampliare il novero degli effetti,
che, ex lege, compongono la struttura dell’obbligazione, ma a fornire al giudice un criterio di
valutazione dell’attività esplicata dalle parti (...) ».
(209) Si pensi, ad es., al caso della rottura di un tubo dell’acqua, di domenica a tarda
ora, in un’azienda le cui chiavi di accesso siano in possesso di un’impiegata, la quale, pur
abitando nelle vicinanze, si rifiuti di recarsi presso lo stabilimento per aprire la porta
d’accesso ai vigili del fuoco, costringendoli con dispendio di molto tempo e fatica a spaccare
una finestra: potrebbe discutersi, in effetti, della corrispondenza a buona fede di un simile
comportamento, a fronte di una “sopravvenienza” di tal fatta. E in effetti, v. quanto
osserva Mazzamuto, 2003, p. 650, secondo il quale la stessa buona fede integrativa, sulla
base di standard valutativi, « consente di modificare, sospendere, o ridurre l’applicazione di
regulae juris per ragioni di etica materiale, vale a dire di raccordo tra le regole formali ed i
valori sociali ed etici (...) »; v. anche Di Majo, 1991, p. 794, secondo cui ambedue le
concezioni della buona fede sembrano in fondo « concordare su un’esigenza di fondo, e cioè
252
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
le porte a una concezione della buona fede come clausola a disposizione del giudice, diretta a fondare una valutazione ex post
dell’attività delle parti, in pratica « un giudizio di secondo grado,
articolato secondo la struttura dell’exceptio doli generalis, e condotto a posteriori al fine di garantire l’effettiva realizzazione dell’assetto di interessi delineato dal regolamento contrattuale, eventualmente correggendo gli esiti di una (...) applicazione formalistica » dello stesso (210). Non può farlo, perché si finirebbe per
assegnare alla buona fede una funzione correttiva, che, in quanto
clausola generale, non le appartiene, con un innegabile avvicinamento all’equità (211). Ciò rappresenterebbe proprio l’esatto contrario di quanto il legislatore del codice ha inteso perseguire.
Bisogna, invece, ribadire che correttezza e buona fede incidono
direttamente sul contenuto del rapporto obbligatorio, imponendo
alle parti modelli di condotta ispirati a canoni di moralità sociale,
tecnicamente sintetizzabili nella forma dell’obbligo. Ciò appare
coerente rispetto ai tratti tipici delle clausole generali, quali conche l’impiego della buona fede non interessa tanto l’astratta costruzione della regola
contrattuale, quanto il suo svolgimento ex fide bona, onde la buona fede deve rivelarsi quale
criterio destinato a regolare principalmente la fase dello svolgimento del contratto, specie a
fronte di circostanze emergenti in detta fase e non previste al momento della conclusione ».
Certo è, invece, che la buona fede, se concepita in funzione integrativa ex art. 1374, come qui
si ritiene, diviene inconciliabile con quelle costruzioni che configurano l’abuso come esercizio
del diritto contrario a correttezza: cfr. Salvi, 1988, p. 3, che ben rileva come la tematica
dell’abuso si riferisce, infatti, « non all’imposizione di regole di condotta ulteriori rispetto a
quelle poste dalle parti o dalle legge; ma al controllo sulle modalità di svolgimento della
condotta, oltre l’osservanza della regola, comunque essa sia posta »; sul punto cfr. pure
Restivo, 2007 p. 153 s.
(210) Le parole sono di Restivo, 2007, p. 149 s., ma sulla scorta del pensiero di Natoli,
1974, pp. 4 e 39.
(211) Lo ammette lo stesso Natoli, 1974, p. 5, nt. 8, laddove osserva che « in questo
senso può essere facile la confusione del criterio in esame con l’equità ». È, peraltro, da
escludere che una funzione correttiva della buona fede possa passare attraverso l’art. 1366
c.c. (come invece ritiene Bigliazzi Geri, 1991, p. 216 ss.): sul versante giuslavoristico, la
questione è emersa come delicata a proposito dell’interpretazione del contratto collettivo,
ove si è osservata la tendenza surrettizia della giurisprudenza a « ritagliarsi una maggiore
area di manovra (...), fino a giungere talora ad una sorta di integrazione del regolamento
negoziale »: Carinci F., 2000, XIII; criticamente, infatti, circa tale tendenza Gragnoli, 2004,
p. 185 ss., spec. p. 189 ss., per il quale « se è inevitabile un ruolo creativo della giurisprudenza, con implicazioni innovative, è diverso invitare ad una correzione delle indicazioni
convenzionali sulla base dei valori fondanti dell’ordinamento, travasati nel contenuto
negoziale per mezzo dell’art. 1366 c.c. ».
253
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
gegni volti a sollecitare la produzione di regole ulteriori, destinate
a combinarsi, nell’ambito normativo in cui operano, con quelle già
esistenti.
L’integrazione del regolamento contrattuale mediante norme
sociali di condotta espressive di buona fede dà vita a una serie di
obblighi, che appaiono precipuamente finalizzati a imporre « l’osservanza di un complesso di cautele normalmente necessarie » alla
salvaguardia dell’altrui sfera giuridica in vista del « pieno e integrale raggiungimento dello scopo dell’obbligazione » (212). Esigenze prettamente dogmatiche hanno indotto per lo più a ricomprenderli entro la categoria concettuale degli “obblighi di correttezza”, detti anche “obblighi di protezione” (Schutzpflichten) o
“obbligazioni di sicurezza” (obligations de sécurité), distinguendovi
all’interno diversi comportamenti, tra cui quelli di comunicazione,
di avviso, di cooperazione, di segreto, di conservazione, tutti
funzionali alla salvaguardia della sfera giuridica altrui, esposta a
potenziale pericolo per effetto del contatto sociale instauratosi tra
le parti in forza del rapporto obbligatorio (213).
Il richiamo a tale categoria è stata discussa, probabilmente non
del tutto a ragione (214), ma, a prescindere dal suo impiego, è
(212) Mengoni, 1954, p. 204.
(213) Benatti, 1960, p. 1344 ss.; Castronovo, 1990, passim.
(214) Larga parte della dottrina italiana si è schierata a favore di tale categoria: tra
gli altri, cfr. Betti, 1953, pp. 68 ss. e 99; Mengoni, 1954, p. 638 ss.; Mancini, 1957, pp. 3 ss.
e 81 ss.; Cattaneo, 1958, 91 ss.; Benatti, 1960, p. 1342 ss.; Id., 1991, p. 221 ss.; Giugni, 1963,
p. 153; Scognamiglio R., 1968, p. 670 ss.; Carusi F., 1962, p. 711 ss.; Castronovo, 1990, p. 1
ss.; Id., 2006, p. 443 ss., ove si ricorda, peraltro, come la categoria « avesse cominciato a
circolare in dottrina già alla fine dell’ottocento in materia di infortuni sul lavoro » (p. 448,
nt. 12); Visintini, 2006, p. 239 ss.; Pisani, 2004, p. 85 ss.; Ferrante, 2004, p. 43; Nogler, 2007,
p. 622 ss.; Gragnoli, 2010, p. 33 ss., almeno nella misura in cui vi riconduce l’art. 2087 c.c.;
Lambo, 2007; Mormile, 2013, p. 34 ss.; le critiche sembrano soprattutto incentrarsi sull’origine tedesca della teoria degli obblighi di protezione e sul fatto che in Germania tale teoria
è stata chiamata a colmare lacune del BGB in tema di inadempimento inesistenti nel nostro
codice civile. In realtà, però, i detrattori della teoria paiono soprattutto animati dal rifiuto
di accedere ad una ricostruzione dell’obbligazione nei termini di rapporto complesso,
finendo così, da un lato, per configurare tali obblighi quali mere specificazioni della
prestazione principale e, dall’altro, per ritenere la categoria dei doveri di protezione una
inutile superfetazione: v. Natoli, 1974, p. 14 ss.; cfr. anche Bianca, 1983, p. 211; Saffioti,
1999, passim; Castelvetri, 2001, p. 241; si veda ancora Ciccarello, 1988, il quale esclude
comunque che il fondamento di tali doveri risieda negli artt. 1175 e 1375 c.c. e Majello, 1958,
p. 58 s., che rinviene tale fondamento nell’art. 1176 c.c.; in realtà, una volta data per accolta
la concezione dell’obbligazione come rapporto complesso, sembra che quella dei doveri di
254
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
indubbio che quelli originati dagli artt. 1175 e 1375 siano obblighi
secondari, collaterali o accessori rispetto alla prestazione principale
di lavoro: obblighi a carattere reciproco, come vuole l’art. 1175 c.c.,
proprio perché diretti complessivamente a « “pilotare” il rapporto
obbligatorio verso quel risultato integralmente utile che esso è di
per sé volto a realizzare » (215).
Essi sono coerenti con una concezione dell’obbligazione alla
stregua di rapporto a struttura complessa, ove al nucleo costituito
dall’obbligo di prestazione accede un’altra serie di obblighi e
doveri, posti a carico dell’obbligato, ma anche dell’avente diritto,
fra di loro connessi e in vario modo correlati al primo (216). Non è
un caso che si oppongano al riconoscimento della categoria delle
Schutzpflichten proprio coloro i quali optano per una ricostruzione
dell’obbligazione in termini di rapporto a struttura lineare. Essi
finiscono così per ricondurre direttamente all’adempimento dell’obbligazione anche quei contegni diretti a preservare i beni
personali e patrimoniali del creditore, valutandone, a tal punto,
l’adempimento a stregua di diligenza (217). Non si accorgono, però,
che, così facendo, giungono a gravare il solo debitore di un dovere
di salvaguardia dell’altrui sfera giuridica e non entrambi i soggetti
del rapporto.
Occorre, invece, riconoscere come la salvaguardia dei beni
personali e patrimoniali chiami in causa obblighi reciproci ex artt.
1175 e 1375, costituenti parte integrante del regolamento contrattuale ex art. 1374, da valutarsi, a propria volta, secondo il metro
della buona fede, obblighi diversi e autonomi nel contenuto dalprotezione sia categoria meglio di ogni altra capace di offrire uno statuto definitivo e una
collocazione dogmatica soddisfacente a certi obblighi nell’ambito della responsabilità contrattuale; per un suo riconoscimento, v., peraltro, Corte Cost., 28 febbraio 1992, n. 74, di cui
fu redattore proprio Mengoni.
(215) Castronovo, 1990, p. 1.
(216) Mengoni, 1984, p. 512; Castronovo, 1990, p. 1.
(217) V. ad es. Bianca, 1983, p. 502; ma soprattutto Natoli, 1974, p. 14 ss.; criticamente, invece, Mengoni, 1984, p. 509, quando afferma che « non mancano voci che negano
autonomia agli obblighi di protezione e li riconoscono, nell’ambito del rapporto obbligatorio,
solo nella misura in cui sono analizzabili come parti non-indipendenti del contenuto dello
stesso obbligo principale di prestazione. Ma gli attacchi dei critici nostrani sono abbastanza
facilmente rintuzzabili già sulla base degli indici normativi da essi utilizzati: per esempio
l’art. 1681 (...). E analogamente si dica, per fare un altro esempio, a proposito dell’obbligo
del datore di lavoro previsto dall’art. 2087 ».
255
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
l’obbligo di prestazione, siccome finalizzati alla garanzia del precipuo interesse di protezione di ciascuna parte, e persino — è stato
osservato — « di terzi legati a una di esse da particolari rapporti
che li associano al medesimo rischio specifico » (218). L’autonomia
di tali obblighi è testimoniata dal fatto che essi comprendono
condotte « la cui inosservanza lede o mette a repentaglio l’interesse
di protezione del creditore, ma non pregiudica altresì l’interesse
positivo alla prestazione, vale a dire non esclude che la prestazione
principale sia stata o possa essere ancora esattamente adempiuta » (219). Proprio in ragione di tale autonomia, gli obblighi in
parola possono investire il contegno della parti « anche nella fase
successiva alla cessazione del vincolo di prestazione, mantenendo
in vita il rapporto obbligatorio sotto specie di uno o più obblighi
rispondenti a un eventuale interesse residuo di protezione » (220).
Come s’intende, la buona fede agisce, allora, secondo un duplice senso: costituisce gli obblighi di protezione e ne individua al
tempo stesso i contenuti, seppur in maniera non predeterminabile
una volta per tutte, per le caratteristiche stesse della clausola
generale, di rinvio a parametri di moralità sociale mutevoli nel
tempo, da ricercarsi volta per volta in aderenza alle circostanze del
caso concreto.
La costituzione degli obblighi a stregua di buona fede si spiega,
come visto, grazie alla funzione integrativa del regolamento negoziale assegnata alla citata clausola in sede di esecuzione del contratto. Sotto tal profilo la buona fede si atteggia a “fonte” degli
obblighi medesimi (artt. 1374-1375 c.c.). L’individuazione del contenuto di questi ultimi si spiega, invece, in ragione del ruolo
(218) Mengoni, 1984, p. 510.
(219) Mengoni, 1954, p. 369.
(220) Ibidem, p. 394; la sopravvivenza di tali obblighi non potrebbe, peraltro giustificarsi, né quindi ammettersi qualora, invece, li si volesse ricondurre tutti entro la prestazione principale, negandone il contenuto autonomo; peraltro, secondo Castronovo, 2006, p.
443 ss. l’autonomia di detti obblighi (anche sul piano delle fonti, che l’A. ritiene essere legale
e non negoziale) consentirebbe addirittura di ammettere l’esistenza di « obbligazioni senza
prestazione », cioè di obblighi di protezione ab origine avulsi da un obbligo di prestazione
primario. Una tale prospettiva parrebbe evocare la figura di origine tedesca del contratto
con effetti protettivi a favore del terzo, che sembra aver trovato un certo spazio anche in
giurisprudenza: v. Cass. civ., sez. III, 22 novembre 1993, n. 11503, in GI, 1994, I, 1, p. 550
ss., con nota di Carusi D.; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, ivi, 2000, p. 740 ss.,
con nota di Pizzetti.
256
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
attribuibile alla clausola, di direttiva per la ricerca all’esterno di
standards di condotta, poiché non v’è dubbio che rispetterà l’interesse di protezione della controparte solo chi si conformerà a tali
standards di corretto comportamento, desunti dalla realtà sociale.
Sotto tal profilo, la buona fede si atteggia a strumento di “concretizzazione” del contenuto (221), sia pur non predeterminabile ex
ante, degli obblighi di protezione.
A propria volta, la lesione dell’interesse di protezione prodotta
da contegni della controparte causalmente connessi all’esecuzione
del contratto (222) cambia, a questo punto, natura: da illecito
civile si trasforma in una fattispecie di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. Ciò vuol dire che il comportamento contrario
a un obbligo di protezione ben potrà assumere « rilevanza giuridica
indipendentemente dalla produzione di un danno attuale, in funzione dei rimedi della risoluzione del contratto e dell’eccezione di
inadempimento » (223).
Da quanto detto finora appare chiaro che la buona fede, quale
fonte di obblighi secondari e accessori, nonché strumento di individuazione del loro contenuto, resta estraneo all’obbligo principale
(221) Come afferma Breccia, 1968, p. 131 pur non condividendo la teoria degli
obblighi di protezione, « la funzione svolta dalla regola della buona fede è certamente una
funzione costruttiva, nel senso di dare pienezza di estrinsecazione al contenuto dell’obbligo.
Tale funzione (...) ribadisce l’impossibilità di definire a priori l’obbligo nella sua interezza
(...) ».
(222) L’accessorietà, cioè il fatto che si tratti comunque di obblighi nascenti dal
contratto (così Mengoni, 1954, p. 369 s., nt. 17; per il fondamento legale v., invece,
Castronovo, 1990, p. 4, che da qui giunge, poi, a ipotizzare l’esistenza di « obbligazioni senza
prestazione »), che concorrono con l’obbligo principale di prestazione alla realizzazione dello
scopo complessivo del rapporto obbligatorio, fa sì che in sede di responsabilità contrattuale
si richieda non un rapporto di mera di occasionalità necessaria, bensì una relazione di
causalità con l’adempimento della prestazione in caso di responsabilità contrattuale: Mengoni, 1954, p. 369, nt. 15; cfr. pure Castronovo, 1990, p. 8, secondo cui « la gamma delle
lesioni da ascrivere all’ambito contrattuale (...) sono soltanto quelle che rientrano nell’area
dei costi di attuazione del rapporto obbligatorio »; diversamente Di Majo, 1988, pp. 122, 125,
316 e 323; Mastrandrea, 1994, p. 60; Pisani, 2004, p. 116.
(223) Mengoni, 1984, p. 510; ma, in ipotesi di recesso dell’imprenditore dal contratto
di lavoro, v. Trib. Genova, 11 aprile 2013, cit., il quale anche dal carattere non tipizzato
degli obblighi di correttezza e buona fede (in particolare, dal fatto che il lavoratore aveva
trasgredito propriamente non gli obblighi codificati nell’art. 2105 c.c., bensì solo a quelli di
cui alle succitate clausole generali) ha curiosamente dedotto la non particolare gravità della
loro violazione e dunque l’insussistenza di una giusta causa di licenziamento, seppur di
rilievo tale da meritare una mera sanzione indennitaria ex art. 18, 5° comma, St. lav.
257
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di prestazione del debitore (224). Per tal motivo è da escludere che
l’art. 1375 serva a funzionalizzare la prestazione del debitore in
funzione del risultato (225). La clausola ivi contenuta non può
importare una riconfigurazione dell’obbligo primario gravante sul
debitore, con un contestuale allargamento del contenuto della
prestazione stessa, in vista della garanzia dell’interesse creditorio
al risultato finale e ciò perché gli artt. 1175 e 1375 c.c. non sono
affatto chiamati a incidere direttamente sul dovere di prestazione.
Alla valutazione di quest’ultimo è stato, invero, sempre preposto l’art. 1176 c.c. (226). Con il che diviene altresì netto il
distinguo tra diligenza e correttezza-buona fede, entrambe dirette
ad operare in fase esecutiva del contratto, ma con diversa funzione:
la prima deputata a intervenire su un obbligo del debitore già
individuato a livello contenutistico (227) e a fungere da strumento
di controllo delle modalità dell’esatto adempimento; la seconda
chiamata a costituire obblighi a carico di creditore e debitore in
sede di integrazione degli effetti del negozio e a stabilirne il
contenuto, avuto riguardo a parametri di condotta desunti dalla
realtà sociale non predeterminabili una volta per tutte, ma desumibili volta a volta in base alle circostanze del caso concreto.
(224) Castronovo, 1990, p. 4; v. pure Breccia, 1968, p. 131, laddove sottolinea che « la
buona fede è regola di determinazione o di esecuzione di un’attività accessoria, ma diversa
dalla prestazione in senso stretto »; anche sotto tal profilo non pare condivisibile Cass. civ.,
sez. lav., 24 giugno 1995, n. 7190, cit., secondo cui « correttezza e (...) buona fede di cui agli
artt. 1175 e 1375 c.c. non creano obbligazioni (...), bensì rilevano o come modalità di generico
comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di
diritti ed obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di
prestazione (corsivo nostro) ».
(225) Diversamente, invece, Persiani, 1966, p. 228 ss., che conviene sull’autonomia
dei soli obblighi di correttezza e non di quelli di buona fede (p. 232, nt. 365), la cui violazione
« si traduce sempre nell’inadempimento dell’obbligazione principale » (p. 233). Negando
detta autonomia, l’Autore perviene ad affermare, con precipuo riferimento al contratto di
lavoro, che « l’integrazione dello schema del contratto determinata dalla direttiva di buona
fede, influisce, quindi, direttamente sulla struttura e sull’oggetto delle obbligazioni (...) » (p.
231), sicché da tale integrazione deriva « essenzialmente una qualificazione del comportamento dovuto in funzione del risultato atteso » (p. 233).
(226) Castronovo, 1990, p. 4.
(227) Di Majo, 1988, p. 455 osserva che la diligenza « presuppone già l’individuazione
dell’obbligo in base al quale il debitore è tenuto ad assumere comportamenti volti a
salvaguardare l’interesse del creditore ».
258
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
II.
Rapporto di lavoro e obblighi del prestatore:
il ruolo delle clausole generali di buona fede e correttezza.
4. La buona fede e la correttezza come clausole generali: dal diritto
civile al diritto del lavoro.
4.1. Norme generali e clausole generali nel diritto del lavoro.
È stato opportunamente osservato che, sebbene il diritto del
lavoro abbia storicamente rappresentato un terreno fecondo per
l’impiego di clausole generali ad opera dei giudici (v. infra, § 4.2.),
l’attenzione degli studiosi e dei magistrati stessi è apparsa per lo
più concentrata su quelle qui qualificate come “norme generali” o
“elastiche”, ovvero, per meglio dire, su enunciati normativi contenenti concetti “elastici” o “generali” (228), quali, ad esempio,
« giusta causa », « giustificato motivo » (artt. 2119 c.c., 1 e 3 l. n. 604
del 1966, 18 St. lav., 30, comma 3, l. 183 del 2010), ma anche
« ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo » (art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001; art. 20, 4° comma, d.lgs. n. 276
del 2003), « comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive », « mansioni equivalenti » (art. 2103 c.c.), « esigenze tecnico
produttive e organizzative » (art. 5, 1° comma, lett. c), l. n. 223 del
1991).
Ciò non deve stupire, se si considera che il diritto del lavoro, in
quanto volto a disciplinare un rapporto tra soggetti posti su un
piano di disparità sostanziale, ha costruito la sua specialità attraverso una « fuga dal diritto civile » (229), ispirato piuttosto a
un’ottica di parità formale tra le parti. Lo ha fatto, nella specie,
tramite la legificazione di regole ad hoc, poste a tutela del presta(228) Nogler, 2009.
(229) Carinci F., 2007a, p. 2, che osserva, peraltro, come il diritto privato sia « padre
di innumerevoli figli, tutti ospitati nel codice civile del 1942 (...); fra questi il più ribelle è
stato fin dall’inizio, il diritto del lavoro, non per nulla esiliato fuori da quel libro IV
contenente il diritto “comune” delle obbligazioni e delle loro fonti » (p. 1); sul rapporto tra
diritto civile e diritto del lavoro o, più in generale, diritti speciali, Santoro-Passarelli G. (a
cura di), 1992; Mazzotta, 1994; Mengoni, 1990a, p. 5 ss.; Scognamiglio R., 1994, p. 245 ss.;
Napoli, 2008, p. 253 ss.; Ichino, 2011, p. 1 ss.
259
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tore, diverse da quelle del diritto delle obbligazioni e dei contratti (230). Si tratta di una scelta comprensibile per un diritto
segnato da importanti esigenze di inderogabilità, specialità ed
effettività della disciplina (231). Invero, se si fosse battuta la
diversa via del mero impiego di clausole generali in funzione
integrativa del regolamento contrattuale, nessuna delle tre menzionate esigenze avrebbe ricevuto idonea soddisfazione e la tutela
del prestatore sarebbe stata realizzata in maniera certo meno
pregnante: non la prima e la seconda esigenza, perché ci si sarebbe
limitati a immettere mere dosi di solidarismo contrattuale nel
rapporto tra le parti, invece che riequilibrarne le reali disparità, in
nome di obiettivi di giustizia sociale; non la terza, perché comunque detta immissione sarebbe stata delegata al giudice, invece che
realizzata direttamente dal legislatore, con inevitabili ricadute
negative in termini di certezza del diritto.
La tendenza a risolvere il problema della disparità di potere tra
le parti del contratto di lavoro attraverso regole normative ad hoc
affiora, del resto, già nel codice civile del 1942, nell’ottica della
protezione del lavoratore quale “contraente debole”: si pensi all’art. 2087 c.c., che ricorrendo, peraltro, proprio a un concetto
“generale” ed “elastico” (232) — quale quello di « misure (...),
secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, (...)
necessarie a tutelare l’integrità (...) del prestatore » — ha tipizzato
un dovere di sicurezza prima desumibile dal (solo) dovere di
correttezza per via d’integrazione giudiziale del regolamento contrattuale (v. infra, § 4.2.).
Lo stesso accadrà anche successivamente, nella stagione della
c.d. legislazione garantista, quando la normativa speciale del la(230) Per una ricostruzione dell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano v.
Giugni, 1979; Romagnoli, 1995, p. 11 ss.; Mengoni, 2000, p. 181 ss.
(231) Sui connotati del diritto del lavoro come sistema normativo autonomo e
speciale v. già, Viesti, 1946, p. 8 ss.; Scognamiglio, 1960, p. 83 ss.; Santoro-Passarelli F.,
1967, p. 3 ss.
(232) Albi, 2008, pp. 79 e 81, che sottolinea come il giudice, nel riempire di contenuto
il principio della massima sicurezza tecnologica, non debba rifarsi a una funzione meramente ricognitiva di standards sociali di condotta (p. 80); invece, per la tesi secondo cui
« l’art. 2087 si pone (...) come clausola generale e valvola di chiusura del sistema prevenzionistico » Mazzotta, 2008, p. 538; per un accenno in tal senso v. pure Montuschi, 1986, p. 78
e, in giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 1988, n. 5048, in GC, 1988, I, p. 2871,
con nota di Marino.
260
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
voro si arricchirà di discipline fondamentali, nell’ottica della tutela
del prestatore come “persona” (233). In quest’ambito una parte di
rilievo la giocheranno proprio le norme contenenti concetti “generali” o “elastici”, viste e vissute in funzione dell’apposizione di
limiti ai poteri dell’imprenditore (v. i già menzionati artt. 1, 3 l. n.
604 del 1966 e art. 2103 c.c., novellato dall’art. 13 St. lav.). Si è
ricordato, non a caso, come la legificazione dei concetti di « giusta
causa » e di « giustificato motivo » abbia, ad esempio, reso del tutto
superflue ricostruzioni, pur avanzate in dottrina prima dell’emanazione della l. n. 604 del 1966, dirette a dedurre la illiceità del
licenziamento individuale dalla violazione dell’art. 4 Cost., per il
tramite del richiamo alla clausola generale dell’ “ordine pubblico”
(art. 1345 c.c.) (234).
Si noti, peraltro, che la tipizzazione di concetti come quelli
giusta causa e giustificato motivo tende ad avere un effetto anche
indiretto di ridimensionamento dell’impiego di clausole generali,
considerato che l’assenza di giustificazione del licenziamento importa la vera e propria invalidità dell’atto, mentre la violazione
degli obblighi di correttezza e buona fede fa scattare il mero
rimedio risarcitorio. Così, con riferimento alla disciplina precedente alla l. n. 92 del 2012, ove si fosse affermato l’obbligo del
datore di far precedere al licenziamento economico un confronto a
fini solutori con il prestatore di lavoro, ebbene sarebbe stato
preferibile, quanto alla tutela del prestatore stesso, ancorare tale
obbligo direttamente al giustificato motivo oggettivo, invece che al
dovere di correttezza, per le conseguenze sanzionatorie più forti
connesse alla inottemperanza dell’art. 3 l. n. 604 del 1966 rispetto
a quelle collegate all’inosservanza degli artt. 1175 e 1375 c.c. (235).
La tecnica normativa per “norme generali” o “elastiche” troverà comunque largo impiego anche nella successiva stagione della
c.d. legislazione flessibile, specie nel passaggio dalla fase della c.d.
deregolazione “controllata” a quella della c.d. deregolazione
(233) Sulla legislazione statutaria v. Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli (a cura
di), 1972; Prosperetti U. (diretto da), 1975; Giugni (diretto da), 1979.
(234) Nogler, 2009, con richiamo alla ricostruzione di Natoli, 1951, p. 118 e Id., 1954,
p. 285 ss.
(235) Ibidem.
261
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
“secca” (236). Le vicende normative in materia di lavoro flessibile
ne rappresentano testimonianza emblematica. Si pensi, nell’ambito del contratto a termine, alla transizione da una tecnica legislativa per tassativi “casi di specialità”, sia pur ampliabili dalla
contrattazione collettiva (l. n. 230 del 1962 e l. n. 56 del 1987), a
una disciplina imperniata sulla sussistenza di più generali « ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo »
(d.lgs. n. 368 del 2001), secondo un trend destinato, peraltro, a
riprodursi sul contiguo versante della fornitura di lavoro temporaneo, oggi somministrazione a tempo determinato (dalla l. n. 196
del 1997 al d.lgs. n. 276 del 2003). Ebbene, se si pone mente a ciò,
sarà facile comprendere il ruolo ancora una volta primario recitato
dalle norme contenenti concetti “elastici” o “generali”, norme ora
concepite, però, quali strumenti di “liberalizzazione” del lavoro
flessibile, benché in un contesto ancora dominato dalla regola
secondo cui « il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro » (art. 1,
comma 01, d.lgs. n. 368 del 2001) (237).
V’è da chiedersi, venendo ai nostri giorni, cosa ne è stato della
tecnica legislativa per “norme generali” o “elastiche” nell’odierna
stagione della globalizzazione dei mercati e della crisi. Sembra di
poter ritenere che, a fronte delle accresciute difficoltà economiche
e delle sollecitazioni provenienti dallo stesso versante europeo per
una flessibilizzazione ulteriore del mercato del lavoro nazionale (238), l’attenzione normativa resti solo in parte focalizzata su
tali “norme generali” o “elastiche” (invece che sulle clausole generali) (239), peraltro allo scopo di stemperarne il più possibile gli
(236) Il termine è impiegato in senso lato, nella consapevolezza del fatto che
l’ordinamento italiano non ha mai chiuso del tutto le porte a forme di coinvolgimento del
sindacato, sia pur progressivamente sempre minori; sul tema Lunardon, 2009, p. 153 ss.
(237) Sul lavoro a termine e la sua progressiva liberalizzazione v. Montuschi, 2006, p.
109 ss. e, poi, più di recente Gragnoli, 2014, p. 429 ss. Miscione, 2014a, p. 5 ss.; Saracini,
2013; Bollani, 2013; Del Punta, Romei (a cura di), 2013; Franza, 2010.
(238) Perulli, Speziale, 2011, p. 1 ss.; Carinci F., 2012, p. 531 ss.; Carinci M.T., 2012,
p. 528 ss.; Speziale, 2012, p. 523 ss.
(239) E ciò per la tendenza a ravvisare nelle “norme generali” un ostacolo a quella
« calcolabilità del diritto », vista e vissuta, oggi, come indispensabile al perseguimento
dell’efficienza economica: ma per riflessioni giustamente problematiche sul punto, v. Del
Punta, 2014, spec. p. 380 ss.; sulle tecniche normative nella legislazione della flessibilità, da
ultimo, Calcaterra, 2014, p. 1286 ss.
262
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
effetti di rigidità nei confronti dell’impresa. L’intervento del legislatore si snoda, a riguardo, lungo un triplice versante: l’indebolimento ulteriore (rispetto al passato) della inderogabilità tipica
della “norma generale” o “elastica”; l’alleggerimento dell’apparato
sanzionatorio connesso alla violazione della “norma generale” o
“elastica”, se non, addirittura, l’eliminazione della norma stessa; la
limitazione dei poteri giudiziali connessi all’applicazione della
“norma generale” o “elastica”.
Con riguardo al primo versante, il riferimento è, anzitutto, alla
legislazione sul lavoro a termine e somministrato, ove l’incidenza
limitativa delle « ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo » (vecchio art. 1, 1° comma, d.lgs. n. 368 del
2001; art. 21, 4° comma, d.lgs. n. 276 del 2003) è stata prima
ridimensionata ex lege, poi del tutto cancellata dalla liberalizzazione completa delle tipologie contrattuali in parola (l. n. 92 del
2012 e poi d.l. n. 34 del 2014, conv. in l. n. 78 del 2014) (240). È,
inoltre, più in generale, l’art. 8 d.l. n. 138 del 2011 conv. in l. n. 148
del 2011 a meritare specifica menzione, laddove autorizza il « contratto collettivo di prossimità » a derogare, a certe condizioni, ma
senza confini di sorta, alle “norme generali” o “elastiche” limitative dei poteri imprenditoriali nelle materie di cui al suo 2° comma,
tra cui quelle delle mansioni, del contratto a termine, della somministrazione, delle conseguenze del recesso, salvo il solo rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli normativi comunitari e internazionali (241).
Quanto al secondo versante, riguardante l’alleggerimento dell’apparato sanzionatorio connesso alla violazione di “norme generali” o “elastiche”, è emblematico l’art. 18 St. lav., come riformato
dalla l. n. 92 del 2012, che ha modificato il sistema rimediale contro
il licenziamento privo di giusta causa e di giustificato motivo,
disarticolando la condizione di illegittimità del recesso a fini riduttivi dell’ambito applicativo della sanzione restitutoria (v. del resto,
ora, in direzione ancor più radicale, la l. n. 183 del 2014 e il d.lgs.
n. 23 del 2015, recante disposizioni in materia di contratto a tempo
(240) Gragnoli, 2014, p. 429 ss.; Carinci F., 2014, p. 1 ss.; Miscione, 2014b, p. 1243 ss.;
Magnani, 2014, p. 1 ss., Zoppoli L., 2014, p. 1 ss.; Brollo, 2014, p. 566 ss.
(241) Leccese, 2012, p. 479 ss.; Carinci F. (a cura di), 2012; Liso, 2012, p. 20 ss.;
Lunardon, 2014, p. 35 ss.
263
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
indeterminato a tutele crescenti (242)), con un’indiretta incidenza,
secondo certe opinioni, sugli stessi presupposti sostanziali del potere datoriale estintivo del rapporto e sugli spazi del relativo
controllo giudiziale (243).
Il tema ci conduce così al terzo versante, quello dei limiti
all’attività valutativa del giudice nell’applicazione di “norme generali” o “elastiche”. Qui la mente corre subito all’art. 30 l. n. 183
del 2010 (244). Vi si riscontra una palese volontà del legislatore, da
un lato, di arginare il sindacato del giudice sulle ragioni tecnicoorganizzative di cui alle “presunte” (245) « clausole generali » (per
noi “norme generali” o “elastiche”) « in tema di instaurazione di un
rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di
azienda e recesso », con l’ulteriore previsione della possibilità di
impugnativa « per violazione di norme di diritto » (1° comma);
dall’altro, di ancorare il più possibile la valutazione dell’organo
giudiziario in materia di giusta causa e di giustificato motivo alle
« tipizzazioni (...) presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi (...) » (3° comma). È
questa una linea di tendenza destinata a trovare viepiù conferma
nell’art. 18 St. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, secondo
cui il giudice annulla il licenziamento e applica la tutela reintegratoria “minor”, qualora l’assenza di giusta causa o di giustificato
(242) In tema Rusciano, Zoppoli L. (a cura di), 2014, p. 1 ss.; Carinci F., 2015, p. 1
ss.; Speziale, 2014, p. 1 ss.
(243) Cfr. Tullini, 2013, p. 147 ss., ove si sostiene che l’intervento di riforma dell’art.
18 St. lav. abbia mutato non solo il sistema dei rimedi, ma anche le caratteristiche tecniche
e morfologiche del recesso; su posizioni più sfumate Carinci F., 2013, p. 461 ss., secondo il
quale il nuovo art. 18 St. lav. avrebbe inciso sulle condizioni del recesso datoriale ma solo
“per reazione”, poiché senza toccare direttamente le nozioni di « giusta causa » e di
« giustificato motivo », avrebbe attribuito capacità estintiva (anche) ad un licenziamento
disciplinare collegato a un inadempimento meno che notevole, eppure di gravità superiore
a quelli suscettibili di mera sanzione conservativa. Detto licenziamento, tuttavia, rimanendo illegittimo, giacché privo di « giustificato motivo soggettivo », darebbe diritto comunque a un’indennità economica in favore del lavoratore, oltre che al preavviso. Insomma,
sarebbe come dire che, per effetto della riforma del sistema rimediale, anche un inadempimento meno che notevole, ma superiore a quelli inclusi tra le sanzioni conservative,
consentirebbe al datore di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale, mediante
esercizio del proprio potere di recesso, sia pur con un costo economico in più.
(244) In tema, Tremolada, 2011, p. 160 ss.; Benassi, 2012, p. 91 ss.; Del Punta, 2012,
p. 474 ss.
(245) Nogler, 2009.
264
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
motivo derivi (non solo dall’assenza), ma anche dalla riconducibilità del fatto contestato al novero delle condotte punibili con una
sanzione conservativa « sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili » (4° comma).
Come si dirà a breve, questo tentativo di ancoraggio della
valutazione giudiziale alle disposizioni dei contratti collettivi è
sintomatica di una concezione (qui non condivisa) della giusta
causa e del giustificato motivo alla stregua di « clausole generali »,
secondo quanto dimostra, del resto, lo stesso 1° comma dell’art. 30,
il quale le definisce espressamente così. È sintomatica di tale
concezione, perché solo quando una norma contiene clausole generali e, dunque, risulta priva di una propria autonoma fattispecie
giuridica “a monte”, il giudice è chiamato a darne “concretizzazione” mediante conformazione a standards esterni, siccome espressivi di norme sociali di condotta, che egli stesso è stato autorizzato
dal legislatore a ricercare. Nelle altre ipotesi, invece, l’organo
giudiziario ha pur sempre di fronte una norma giuridica completa,
cioè dotata di una propria autonoma fattispecie, per quanto “generale” o “elastica”, sicché, dovendo semplicemente applicarla,
alias sussumervi una serie aperta e indefinita di casi concreti, potrà
tener conto (246) degli standards sociali, se coerenti con il patrimonio dei dati offerti dal legislatore per la ricerca della decisione,
ma non necessariamente dovrà conformarvisi (v. retro, sez. I, §
2.3.).
Certo è che il quadro evolutivo della legislazione lavoristica sin
qui tratteggiato è assai diverso da quello legato ai più recenti
sviluppi della normativa civilistica, specie del diritto europeo dei
contratti. Negli ultimi decenni, a fronte dell’emergere di inedite
situazioni di squilibrio sostanziale tra le parti negoziali, « aumenta
il peso del diritto imperativo e l’autonomia contrattuale conosce
nuovi limiti » (247). A propria volta, la tecnica legislativa per
clausole generali è parsa più di ogni altra idonea a immettere nel
sistema una certa dose di solidarismo, senza sacrificare una « flessibilità » essenziale in un ordinamento giuridico europeo orientato
a perseguire l’armonizzazione del diritto privato a mezzo della soft
(246) E non, invece, « tiene conto », come afferma in maniera assertiva il testo
dell’art. 30, 3° comma.
(247) Patti, 2013, p. 105.
265
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
law (248). La normativa comunitaria abbonda, dunque, di riferimenti alla buona fede (249), come pure alla ragionevolezza, concepiti in un’ottica di razionalizzazione del mercato, con una risposta alle asimmetrie informative « affidata al principio di solidarietà
e alla considerazione della posizione » nella quale « si trova l’altro » (250).
Non v’è dubbio che una tale tendenza inneschi poi, al tempo
stesso, problemi di non poco momento, tra cui quello della delimitazione concettuale e funzionale tra le diverse figure, visto che alle
clausole generali i testi di matrice europea affiancano sovente legal
standards, principi, “norme generali” o “elastiche” (251). V’è, del
resto, chi solleva dubbi sulla scelta metodologica del giurista
europeo, di avvalersi di una tecnica, la quale amplia notevolmente
il margine di discrezionalità giudiziale rispetto al potere legislativo (252). Ciò chiama evidentemente in causa la stessa delicata
questione dei rapporti tra Corte di Giustizia e giudici nazionali
nella “concretizzazione” delle clausole generali presenti, ad esempio, nell’ambito delle direttive europee. È stato osservato che tali
rapporti dovrebbero ispirarsi a una certa dialettica, affinché possa
(248) Ibidem, p. 69, che imputa il ricorso alle clausole generali anche al fatto che
« nella società moderna (...) il legislatore si trova a rincorrere il progresso della tecnica e
l’evoluzione della società, mentre nel contempo si è ancora accresciuta la sensibilità per una
decisione che tenga conto delle peculiarità del caso concreto ».
(249) Anche se non manca chi ritiene che la proiezione sul versante europeo e
sovranazionale della buona fede ne abbia determinato l’assunzione di caratteri « più sfumati »: Cruciani, 2011, p. 475; v. anche Barcellona M., 2006, p. 290 s., che ravvisa nella
moltiplicazione dei rinvii alla buona fede e alla ragionevolezza all’interno del diritto europeo
un segnale del primato del mercato a scapito della politica.
(250) Navarretta, 2012, p. 4.
(251) Patti, 2013, p. 69.
(252) Navarretta, 2012, p. 8; anche Patti, 2013, p. 69 osserva come « nelle direttive
e — ancor più — nei progetti di codice civile europeo » si riscontri « sovente un numero
eccessivo di clausole generali che suscita perplessità, sia alla luce dell’antico monito secondo
cui un “abuso di clausole generali” comporta un ingiustificato trasferimento di responsabilità da parte del legislatore al giudice, sia perché in molti casi si determina soltanto
un’illusione di armonizzazione »; cfr., inoltre, Barcellona M., 2006, p. 289 ss., che nella
moltiplicazione, all’interno dei principi di diritto europeo dei contratti, dei rinvii alla buona
fede e alla ragionevolezza — « ben rinserrate », queste ultime, « dentro una logica funzionale
che le lega (...) alle prassi e agli equilibri di mercato » — rinviene il segno di una tendenza
al superamento del primato della legislazione, dunque, della politica, in coerenza coi processi
di globalizzazione che hanno precipitato in una grave crisi le sovranità nazionali a tutto
favore delle regole del mercato.
266
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
« effettivamente realizzarsi l’obiettivo di assicurare, attraverso le
clausole generali, un processo di armonizzazione non rigido né
calato dall’alto, ma flessibile dialogante con le realtà nazionali » (253).
4.2. Buona fede e correttezza nel diritto del lavoro.
Benché il diritto del lavoro sia stato connotato, come visto, da
un largo impiego della tecnica legislativa per “norme generali” o
“elastiche”, manterremo qui il nostro impegno ad occuparci, per i
motivi enunciati in premessa, del rapporto tra clausole di correttezza e buona fede e posizione del prestatore di lavoro. D’altronde,
è noto come il diritto del lavoro medesimo abbia rappresentato uno
dei settori più interessati dall’intervento delle clausole sopra menzionate (254).
Il « flusso delle clausole generali » nel sistema giuslavoristico
italiano ci riporta addirittura alle origini della materia, quando la
bona fides contribuì in maniera consistente a forgiare i singoli
istituti di un contratto di lavoro ancora « collocato nel genus
locativo » (255). Potrà apparire curioso (256) che sia stato proprio
un così nobile e antico istituto civilistico, la bona fides appunto, a
rappresentare l’elemento costitutivo e fondante di un diritto moderno, collegato all’affiorare di nuovi rapporti di produzione e
lavoro, e destinato via via ad acquisire una completa autonomia
scientifica (257). Eppure ciò non deve meravigliare: nell’assenza di
una disciplina organica del settore, la buona fede, per la particolare
elasticità e il forte contenuto etico, si presentava più di ogni altra
idonea a consentire la recezione, tramite integrazione del programma contrattuale, di quelle istanze solidaristiche tipiche di una
fase d’industrialismo in ascesa. Grazie a un esteso impiego dell’art.
1124 vecchio c.c., « le norme in materia lavoristica » emergeranno,
così, « da una prassi giurisprudenziale » connessa all’equità, rap(253) Navarretta, 2012, p. 8.
(254) Osserva Mazzamuto, 2003, p. 656, nt. 55 che « non a caso un buon quaranta per
cento delle pronunce la cui ratio decidendi si fonda sulla clausola generale di buona fede
riguarda il rapporto di lavoro subordinato ».
(255) Perulli, 2002, p. 4; v. anche Garofalo D., 2004, p. 8; nonché Castelvetri, 2001,
p. 238.
(256) Perulli, 2002, p. 4.
(257) Cfr. Carinci F., 2007a, p. 1 s.
267
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
presentando « un tangibile esempio di creazione spontanea o extralegislativa del fenomeno giuridico » (258).
Sarà un processo che godrà, peraltro, del pieno avallo di
almeno una parte della dottrina dell’epoca. Non è un caso se
Enrico Redenti, nell’esaminare le decisioni probivirali del tempo,
rileverà come il consenso non sia l’unica fonte del rapporto obbligatorio, poiché la legge ne individua un’altra, sussidiaria e in
qualche modo esterna, quale data dalla « pratica e dalle convinzioni dei galantuomini in proposito » (259). E sarà poi lo stesso
Lodovico Barassi a sostenere che « secondo l’interpretazione migliore l’art. 1124 viene ad avere una notevole latitudine di portata », al punto da consentire di affermare che « nel contenuto
dell’obbligazione complessa del conduttore d’opere, deve rientrare
l’obbligo di fornire un ambiente sano di lavoro, e buoni istromenti
di lavoro » (260). Da questo « seguirà la responsabilità soggettiva
del conductor operarum (...) » (261). Il che corrisponde esattamente
alla matrice fondativa del dovere di sicurezza, oggi consacrato
dall’art. 2087 c.c. sotto la rubrica Tutela delle condizioni di lavoro.
D’altra parte, è proprio una tale scelta codicistica, volta alla
tipizzazione legislativa di precetti altrimenti deducibili solo dalla
« comune coscienza giuridica » (262) per il tramite della buona fede,
a spiegare in fondo la persistente estraneità dell’ordinamento giuridico italiano da quel fenomeno, tipico dell’esperienza d’Oltralpe,
di utilizzo della menzionata clausola quale « tecnica di formazione
(258) Corradini, 1970, p. 413.
(259) Cfr. Redenti, 1906, p. 25, anche laddove afferma che « (...) il contratto di lavoro
è (...) un contratto (art. 1098 C. civ.), soggetto quindi a tutte le regole generali sui contratti
(art. 1103 C. civ.). Ora i contratti, nella loro applicazione ed esecuzione, sono regolati dalla
lex a paciscentibus dicta (art. 1123 C. civ.), in quanto giuridicamente lecita e, in difetto, dalle
norme di quel tipo sotto cui ciascuno di essi per la sua figura e il suo scopo va classificato (art.
1103 C. civ.). (...) Ma ho già notato (...), che il contratto di lavoro è riconosciuto e definito,
come tipo, ma non è punto o quasi punto regolato dalle legislazioni vigenti (...). Combinando
queste osservazioni col principio, (...) che nel nostro codice sta scritto nell’art. 1124 (ed è,
come ho detto, principio di tutti i diritti positivi), se ne deriva che la legge stessa, in
sostanza, ha prescritto, che il contratto di lavoro, in quanto non sia regolato dalla lex a
paciscentibus dicta, debba conformarsi al tipo praticamente in uso fra galantuomini: ut inter
bonos agere oportet et sine fraudatione ».
(260) Barassi, 1901, p. 556.
(261) Ibidem, p. 562.
(262) Ibidem.
268
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di regulae iuris » (263). Si capisce, però, come da ciò sia derivato un
inevitabile ridimensionamento della portata applicativa degli artt.
1175 e 1375 c.c., persino nel corso degli anni 50’ del secolo scorso,
quando l’influenza della dottrina tedesca presso quella italiana fu
comunque ragguardevole.
Non si creda, tuttavia, che ciò abbia implicato una totale
assenza di dibattito, all’epoca, circa la rilevanza della buona fede
nel rapporto di lavoro. All’interno di un contesto ancora improntato alle concezioni dominanti del ventennio corporativo e all’idea,
sulla scorta delle teorie organicistiche, che ai prestatori dovesse
richiedersi “una buona fede particolarmente accentuata”, nel
senso più pregnante della fedeltà (264), è stata proprio la teoria
civilistica degli obblighi di protezione ex artt. 1175 e 1375 c.c. (265)
a guidare la reazione nei confronti di una simile idea. Da qui
l’emergere di una lettura giuslavoristica della menzionata clausola
generale tutta diversa, incentrata sull’effetto integrativo nei confronti dell’obbligazione del lavoratore, in termini di obblighi di
sicurezza e di obblighi preparatori dell’adempimento (266).
Certo, così si finiva per sottolineare i vincoli posti a carico del
prestatore, invece di tracciarne un quadro riduttivo, con qualche
rischio di assecondare operazioni di politica del diritto a carattere
conservatore, ben testimoniate da quell’orientamento in materia di
buona fede e forme anomale di lotta sindacale, che caratterizzerà la
giurisprudenza dell’epoca (267). Eppure in una dimensione ancora
dominata dalle ricostruzioni acontrattualistiche del rapporto di
lavoro quella si presentava come l’unica via per far passare l’opzione contrattualistica: bisognava dimostrare, « nei modi di una
rigorosa elaborazione dogmatica, l’idoneità del contratto a costituire la fonte di tutti gli obblighi del lavoratore, di tutte le
prerogative dell’imprenditore ragionevolmente necessarie per il
funzionamento dell’impresa e la sicurezza del patrimonio azien(263) Di Majo, 1984, p. 570.
(264) Di Majo, 1992, p. 19, con riferimento, evidentemente, soprattutto alla concezione “bettiana” della buona fede in senso « pregnante ».
(265) Mengoni, 1954, p. 368 ss.
(266) Mancini, 1957.
(267) Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 1952, n. 584, in RGL, 1952, II, p. 84 ss.; Cass. civ.,
sez. lav., 28 luglio 1956, n. 2961, in MGL, 1956, p. 304 ss.; Cass., 19 giugno 1959, n. 1936, in
FI, 1959, I, p. 254 ss.
269
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dale, senza bisogno di ricorrere alla fedeltà, alla comunità d’impresa o ad altro che ponesse l’imprenditore su di un piano diverso
da quello della pura e semplice parte di un contratto » (268).
Ma il punto più alto della riflessione giuslavoristica sulle clausole generali sarà segnato, già sul finire degli anni ’70, da quelle
teorie orientate a ipotizzare un recupero della buona fede e della
correttezza in funzione di contenimento e razionalizzazione dei
poteri datoriali (269). Si muove, qui, da specifiche esigenze protettive del prestatore, sulla scorta, ancora una volta, di un dialogo
serrato con la dottrina civilistica, indirizzata già da qualche tempo
a prospettare un uso delle menzionate clausole a fini di controllo
dei c.d. poteri privati (270). E ciò sul presupposto che la buona
fede, nella qualità di “veicolo” d’accesso delle norme costituzionali
all’interno del diritto delle obbligazioni e dei contratti, serva
« anche a realizzare le finalità sociali proprie dell’ordinamento » (271).
Il diritto del lavoro, quale dimensione dominata dall’autorità e
dalla subordinazione, deve essere apparso, in quel momento, il
terreno più congeniale per un impiego degli artt. 1175 e 1375 c.c. a
fini limitativi dei summenzionati poteri. In un tal contesto, la
clausola di buona fede diviene tecnica di governo della discrezionalità datoriale ad opera del giudice, destinata ad aggiungersi e a
cumularsi con la tecnica per norme generali, orientata, invece, per
parte sua, ad affidare direttamente al legislatore il controllo di
quella discrezionalità. È come, insomma, se nelle aree lasciate
vuote dalle norme generali, oltre che dai contratti collettivi, si
rinvenisse comunque la persistenza di spazi di discrezionalità del
datore di lavoro, che, in quanto suscettibili di degenerare in
arbitrio, richiederebbero un ulteriore, aggiuntivo controllo, questa
(268) Mancini, 1993, p. 152; da ultimo cfr. Nogler, 2013, p. 966 ss., spec. p. 970, per
alcune significative riflessioni circa l’importanza di tali tesi — a partire dall’opera di Luigi
Mengoni — ai fini della « rideclinazione contrattuale di tutte le posizioni giuridiche soggettive delle parti del rapporto di lavoro subordinato ».
(269) In tema, Zoli, 1988; Tullini, 1990; Fergola, 1990, p. 470 ss.; Perulli, 1992, p. 161
ss.; Id., 2002, p. 11 ss; Buoncristiano, 1986, p. 187 ss.; in giurisprudenza, v. già Cass. civ.,
Sez. Un., 2 novembre 1979, n. 5688, in GI, 1980, I, 1, c. 440 ss., con nota di Di Majo; per
rilievi critici, in dottrina, Persiani, 1995b, p. 1 ss.
(270) Di Majo, 1992, p. 18 ss.; Id., 1983, p. 344 ss.
(271) Rodotà, 1969, p. 183.
270
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
volta giudiziario, da esperirsi in virtù della funzione integrativa
della buona fede.
Si capisce, allora, perché mai, già sul finire degli anni ’70, le
Sezioni Unite della Cassazione abbiano riconosciuto, in un caso di
promozione a “scelta”, il diritto del prestatore al corretto e trasparente esercizio del potere: « è il primo passo verso un uso sempre più
esteso (...) delle clausole generali (buona fede e correttezza), in una
proiezione (a questo punto) del tutto inedita rispetto al diritto
civile ». E una ulteriore estensione del sindacato giudiziario si
concreterà, poi, con l’avvio della legislazione dell’emergenza e della
crisi, che moltiplicherà « le occasioni di esercizio forte dei poteri e la
necessità di garantire l’uso imparziale degli stessi » (272).
Il « flusso » della buona fede toccherà, allora, il suo apice
quando, sulla scorta di una significativa pronuncia del Giudice
delle leggi (273), la giurisprudenza di legittimità giungerà ad affermare l’esistenza di un principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro. È un orientamento, questo, che segnerà il punto
più alto di un diritto del lavoro “classico”, cioè “maturo” e “sofisticato”, destinato, però, di lì a poco ad avviarsi verso un lento, ma
inesorabile declino (274).
Al di là dei dissensi dottrinali verso la giurisprudenza or ora
menzionata (275) e della netta divaricazione creatasi in proposito
all’interno della stessa Cassazione, sì da richiedere un successivo
intervento compositivo delle Sezioni Unite (276), al di là di ciò, c’è
che, a cavallo del nuovo secolo, si consumerà un vero e proprio
cambio di passo nelle politiche legislative. L’orizzonte politiconormativo in ambito giuslavoristico muterà, con la tecnica della
legislazione per “norme generali” o “elastiche” funzionalizzata al
soddisfacimento di esigenze di flessibilità del mercato del lavoro,
(272) Montuschi, 1996, p. 141 con riferimento a Cass. civ., Sez. Un., 2 novembre
1979, n. 5688, cit.
(273) Corte Cost., 9 marzo 1989, n. 103, in MGL, 1989, p. 127 ss., con nota di
Scognamiglio R.
(274) Carinci F., 2007b, p. LV.
(275) Cfr. Persiani, 1995a, p. 135 ss.; Id., 1995b, p. 1 ss.; e, tra gli altri, più di recente,
Marazza, 2002, p. 265 ss.
(276) Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 1993, n. 6030, in GC, 1993, I, p. 2341, con nota
di Del Punta; Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 1993, n. 6031, in FI, 1993, I, c. 1794, con nota
di Mazzotta.
271
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
invece che al bisogno di tutela dei prestatori nello svolgimento del
rapporto.
Quanto ai limiti legali ai poteri imprenditoriali, il legislatore
non li rimuoverà di certo, ma sarà palese la revisione del senso di
marcia (anche) a riguardo. Se la giurisprudenza applicativa della
buona fede al versante datoriale si muoveva in direzione dell’attribuzione al giudice di poteri valutativi degli atti imprenditoriali
diversi e ulteriori rispetto a quelli già derivanti dalla legge e dal
contratto collettivo, ormai da qualche tempo la normativa si
orienta in senso opposto.
A fronte di disposizioni (che permangono) finalizzate a vincolare il potere organizzativo del datore mediante “concetti generali”
o “elastici”, il legislatore tenta di porre sotto controllo, per quanto
possibile, i relativi poteri discrezionali del giudice, che da quelle
norme derivano. Sembra questo il senso da dare a una disposizione
come il 1° comma, dell’art. 30 l. n. 183 del 2010, laddove stabilisce
che « in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di
cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001,
contengano clausole generali (...), il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può
essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche,
organizzative e produttive che competono al datore di lavoro ».
Alla medesima ratio pare rispondere il successivo 3° comma,
dello stesso art. 30, nel suo tentativo di ancorare il più possibile la
valutazione dell’organo giudiziario in materia di giusta causa e di
giustificato motivo alle « tipizzazioni (...) presenti nei contratti
collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi (...) ». Come già anticipato, questo tentativo di ancoraggio
della valutazione giudiziale alle disposizioni dei contratti collettivi
è sintomatica di una concezione della « giusta causa » e del « giustificato motivo » alla stregua di « clausole generali », come del resto
lo stesso 1° comma dell’articolo si fa carico, in qualche modo, di
esplicitare. Si trascura, però, che « giusta causa » e « giustificato
motivo » rappresentano, al contrario, “norme generali”, cioè disposizioni finalizzate a descrivere anch’esse (come tutte le altre norme)
una fattispecie giuridica, seppure in maniera “generale” ed “elastica”, sì da poter sussumere nel proprio ambito « una pluralità
272
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
indeterminata e aperta » di casi concreti (277). Detta in altri
termini, la presenza di una norma del tutto completa di fattispecie
(come quella “generale” ed “elastica”) segnala che il legislatore ha
già compiuto una propria pre-valutazione e non si affida, invece, a
quella “esterna”, risultante da parametri sociali di comportamento. Sicché mal si sposa con questa evidenza il tentativo di
legare il più possibile il controllo giudiziale sui motivi del licenziamento alle previsioni dei contratti collettivi (278), che, seppur
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, restano meri standards sociali.
Una norma come l’art. 30, spia (altresì) di una (più generale)
situazione di scollamento, se non addirittura di conflitto, tra potere
legislativo e giudiziario tipica del quadro istituzionale italiano,
rischia, a questo punto, di apparire contraddittoria. Il legislatore
non si accorge che, nel tentativo di contenere il ruolo giudiziale (279), a tutto favore della normativa collettiva, finisce per
sconfessare se stesso (280), in particolare la sua attività di prevalutazione, appiattendola su quella operata da contratti collettivi, stipulati per di più da soggetti collettivi, la cui maggiore
rappresentatività comparata appare assai labile quanto a modalità
di accertamento.
L’excursus finora compiuto a proposito della penetrazione e del
ruolo della buona fede nel diritto del lavoro dimostra, ad ogni
modo, come ormai da oltre un quarantennio, il discorso sulle
(277) Lo ribadisce opportunamente Tullini, 2013, p. 156, richiamando altresì Cass.
civ., sez. lav., 17 gennaio 2008, n. 837, in LG, 2008, p. 520, secondo cui « giusta causa e
giustificato motivo costituiscono mere qualificazioni giuridiche, devolute al giudice, dei fatti
che il datore di lavoro ha posto a base del recesso ».
(278) Sul punto v. Tremolada, 2011, p. 177.
(279) Per Rescigno, 2013, p. 322 « risulta trasparente il disegno di limitare gli spazi
di creativa attività rimessa al giudice attraverso regole flessibili, e di orientare la tipicità non
già a tutela del soggetto debole (...), ma a garanzia dell’impresa e del mercato »; per
Ballestrero, 2014, p. 400, « l’obiettivo del comando rivolto al giudice è l’inibizione della
“integrazione valutativa” che (...) costituisce (...) la caratteristica precipua della c.g. ».
(280) E, del resto, per i possibili effetti controproducenti di una legislazione come
l’attuale, tendente a contenere il ruolo interpretativo del giudice, v. Del Punta, 2014, p. 382;
cfr. pure Ballestrero, 2014, p. 400, che rileva il carattere contraddittorio dell’art. 30, 1°
comma, laddove, nell’inibire l’operazione di “integrazione valutativa” e dunque la ricerca di
standards esterni per riempire di contenuto nozioni come quelle di « giusta causa » o
« giustificato motivo » di licenziamento, costringe il giudice a ricorrere, a riguardo, alle sue
mere valutazioni personali, come tali arbitrarie.
273
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
clausole generali intercetti solo e unicamente quello del governo dei
poteri imprenditoriali. È invece rimasta puntualmente in ombra la
materia dei rapporti tra correttezza e buona fede e posizione del
prestatore di lavoro. E ciò ha finito per giocare a favore di « quelle
opinioni le quali considerano che, per la particolare struttura del
rapporto e per la natura degli interessi » implicativi, il rapporto di
lavoro sia refrattario « sia pure ex uno latere (cioè sul versante del
prestatore), all’impiego di tali clausole generali » (281).
Si tratta, come si comprende, di opinioni da sottoporre necessariamente a verifica in questa sede. Ciò tanto più se si considera
l’orientamento della giurisprudenza, nient’affatto avversa, invece,
all’applicazione degli artt. 1175 e 1375 ex latere praestatoris, per
quanto, sovente, con un richiamo così generico e ripetitivo da
ingenerare il sospetto di un utilizzo alla stregua di « meri escamotages verbali » (282).
La questione è comunque delicata, come si anticipava in
apertura. L’idea secondo cui il lavoratore sarebbe esentabile dal
rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede sconta, da un
lato, i timori connessi ai suoi possibili esiti, cioè quelli di una
rimodulazione degli obblighi negoziali in direzione di una maggiore
onerosità della posizione debitoria del prestatore; risente, dall’altro, delle difficoltà collegate alla non agevole distinzione tra l’area
dominata dalle clausole generali (artt. 1175 e 1375 c.c.) e quella
governata dalle regole di diligenza, obbedienza e di fedeltà (artt.
2104 e 2105 c.c.). Tali difficoltà non hanno, peraltro, mancato di
emergere nel corso delle precedenti Giornate di studio dell’Associazione: si pensi, anzitutto, alla relazione sulla « Disciplina dei
licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali » di Luca Nogler, e poi, ancor più, a quella su
« L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e
principi civilistici » di Antonio Viscomi, che in quel contesto si era
interrogato partitamente circa il rapporto tra diligenza e buona
fede. Lo aveva fatto, peraltro, in linea di continuità con altro suo
precedente studio, dedicato a « Diligenza e prestazione di lavoro »,
dove, nel trattare dei rapporti « di inclusione, esclusione o di
indifferenza reciproca tra l’area governata » dalla regola di dili(281) Saffioti, 1999, p. XII, sia pur criticamente rispetto a tali opinioni.
(282) Ibidem.
274
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
genza e « l’area affidata al controllo delle clausole generali », sottolineava espressamente la « centralità della questione, ma anche » la
« impossibilità di esaminarla (...) ab imis; a tal fine » — si diceva —
« sarebbe necessaria una ricerca specifica (...) ».
È da ritenere, a questo punto, che il presente percorso di
ricerca debba partire proprio dalla segnalazione di una simile
“necessità”, esplicitata, certo, con precipuo riferimento alla diligenza e ben oltre un decennio fa, ma destinata ad assumere valenza
più generale, nonché a mantenere inalterata la sua attualità.
5. Correttezza e buona fede in executivis nel lavoro subordinato: gli
obblighi di protezione e il contratto di lavoro.
Si è detto di come l’integrazione del regolamento contrattuale
a mezzo di norme sociali di condotta espressive di correttezza e
buona fede dia vita a una serie di obblighi secondari, di tipo
accessorio, riconducibili entro la categoria concettuale degli “obblighi di correttezza” o di “protezione” (v. retro, sez. I, § 3.2.).
Va ora osservato che tale categoria ha, però, trovato tiepida
accoglienza nel diritto del lavoro, a ciò concorrendo non solo la
giurisprudenza, restìa ad applicarla (283), ma anche la stessa
dottrina. Beninteso, se si parte da autorevoli ricostruzioni civilistiche, non si scorgerebbe in teoria nessuna « seria preclusione a
servirsi del concetto di buona fede (...) sia a favore del datore di
lavoro (...) sia a favore del lavoratore subordinato » (284); solo che
poi tale concetto viene chiamato a svolgere essenzialmente « una
funzione di salvaguardia del prestatore » (285). Si tratta di ricostruzioni che mirano a funzionalizzare sostanzialmente correttezza
e buona fede al governo della discrezionalità datoriale in executivis
sulla scorta di una lettura coordinata con gli artt. 2 e 3, 2° comma,
Cost. Esse finiscono, così, per deporre a favore di « quelle opinioni
le quali considerano che, per la particolare struttura del rapporto
e per la natura degli interessi » implicativi, il rapporto di lavoro sia
(283)
(284)
(285)
Pisani, 2004, p. 119.
Rescigno, 1987, p. 35.
Così, ma criticamente, Saffioti, 1999, p. 118.
275
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
refrattario « sia pure ex uno latere, all’impiego di tali clausole
generali » (286).
Tali opinioni sono, in fondo, coerenti con l’impostazione giuslavoristica “classica”, la quale, a partire dalla legislazione statutaria, è giunta a « svalutare il richiamo, per il contratto di lavoro,
alle regole della correttezza e della buona fede in funzione integrativa del rapporto obbligatorio » (287). Una tale svalutazione si è
giocata, però, su basi diverse da quelle della dottrina civilistica, la
quale ha parimenti osteggiato la teoria dei doveri di protezione, ma
per strade tutte sue: ora confutando l’unitarietà di ambito applicativo degli artt. 1175-1375 c.c. e la effettiva reciprocità dei relativi
obblighi (288), ora contestando la teoria del rapporto a struttura
complessa, con doveri autonomi destinati ad affiancare l’obbligo di
prestazione (289).
Nell’impostazione giuslavoristica “classica” non si è, invece,
mai inteso discutere della struttura complessa della relazione
lavoratore-datore, d’altronde chiaramente consacrata dal legislatore (artt. 2087 e 2105 c.c.) (290) e neppure, quindi, negare l’esistenza di obblighi ulteriori, autonomi rispetto alla prestazione
(286) Ibidem, p. XII; invece per alcune più generali e non trascurabili perplessità
circa l’impiego delle clausole generali nell’ambiente lavoristico, giacché « in un rapporto
attraversato da “forti tensioni sociali” non è immaginabile un comune sentire sui valori
generali da trasfondere, con la mediazione di figure sintomatiche, nell’esecuzione in buona
fede del contratto di lavoro », anche se tali considerazioni « nulla tolgono alla rilevanza, in
linea di principio, delle clausole generali » in tale ambiente, v. Montuschi, 1999, p. 728, con
richiamo a Mazzotta, 1989, p. 592.
(287) Napoli, 1980, p. 219.
(288) V. Rescigno, 1965, p. 259 s., il quale ha sostenuto che « la correttezza, come
principio legislativo (art. 1175), abbia senso proprio se riferita al creditore, poiché la
condotta del debitore si valuta già alla stregua della diligenza del buon padre di famiglia »,
ma contra giustamente, in ragione della diversità funzionale e di ambito operativo degli artt.
1175 e 1176 c.c., Rodotà, 1969, p. 135 s.; Natoli, 1974, p. 8 ss.
(289) V. Natoli, 1974, p. 14 ss., spec. p. 20, ove si afferma che la c.d. obbligazione di
protezione o di sicurezza « appare, in realtà, come un momento essenziale del contenuto
dell’obbligazione ».
(290) Cfr. sempre Napoli, 1980, p. 219, per il quale la configurazione del contratto di
lavoro come rapporto complesso è, anzi, il punto di partenza del discorso. Per l’Autore
sarebbe, infatti, proprio questa configurazione, direttamente imposta dal legislatore nel
delineare la pluralità degli obblighi del lavoratore, a ridurre « la pretesa ampia portata della
funzione integratrice delle clausole di correttezza e buona fede ».
276
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
principale, derivanti dall’assunzione del vincolo negoziale (291).
Piuttosto, il ripudio della categoria dei doveri di correttezza ha
coinciso con la necessità di sgombrare il campo da tutte quelle
teorie, per lo più a sfondo acontrattualistico, volte a concepire gli
artt. 1175-1375 c.c. in funzione dilatatoria del debito del prestatore. Il ridimensionamento del ruolo attribuito alle clausole generali ha rappresentato la via maestra per ricondurre alla fonte
contrattuale gli obblighi del lavoratore e presidiare, al tempo
stesso, il contenuto dell’obbligazione di lavorare, impedendone
l’allargamento — sia dall’interno (292), sia dall’esterno (293) —
oltre il limite segnato dal contratto, secondo una scelta di politica
del diritto conforme al modello statutario.
Anche studiosi sensibili alla teoria dei c.d. obblighi di protezione hanno, dunque, finito per escludere la configurabilità, tramite integrazione (degli effetti) del contratto di lavoro (artt. 1175
e 1375 c.c.), di doveri di correttezza ulteriori rispetto a quelli già
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si è, anzi,
affermato che « il principio di buona fede può svolgere soltanto una
funzione delimitativa, non di allargamento della sfera coperta
dall’obbligazione, (...) appunto perché l’esecuzione della prestazione lavorativa si svolge in un ambito contraddistinto da una
pluralità di obblighi collegati alla subordinazione, sufficienti, nella
valutazione legale tipica, a soddisfare la funzione », che l’ordinamento assegna al negozio (294).
(291) Ibidem; l’Autore, proprio nell’intento di evitare eventuali dilatazioni del contenuto dell’obbligazione di lavorare, tiene in fondo a riconoscere autonomia agli obblighi
diversi da quello di prestazione (alias di protezione), pur riconducendoli, poi, strumentalmente alla prestazione principale stessa, al punto da negarne l’accessorietà (così, in particolare, per l’obbligo di sicurezza facente capo al lavoratore); diversamente, invece, chi, nella
dottrina civilistica, confuta, in generale, la teoria del rapporto complesso, finendo per
escludere l’autonomia di tali obblighi: Natoli, 1974, p. 20.
(292) Cioè mediante un allargamento del concetto di prestazione: v. infatti, Napoli,
1980, p. 204, nt. 129, che critica l’orientamento di Natoli, 1974, p. 18 s., laddove « unifica in
un ampio concetto di prestazione obblighi tenuti distinti dal legislatore, pur se inerenti ad
un unico rapporto obbligatorio fondamentale ». Per Napoli « nel rapporto di lavoro, una cosa
è (...) l’adempimento della prestazione lavorativa, un’altra l’osservanza degli altri contegni
a cui il lavoratore è tenuto, nonostante che il criterio di valutazione sia sempre quello della
diligenza ».
(293) E cioè mediante la costruzione di obblighi accessori, riconducibili, appunto,
alla categoria degli obblighi di protezione.
(294) Napoli, 1980, p. 220.
277
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Su questa strada, si è escluso persino un possibile raccordo tra
la teoria dei c.d. doveri di protezione e quegli obblighi di sicurezza
del lavoratore di cui ai contratti collettivi (295), che, siccome al
tempo (ancora) privi di tipizzazione nella forma di un dovere
generale di autotutela e di collaborazione (296) (v. invece ora l’art.
20 d.lgs. n. 81 del 2008), ben avrebbero potuto essere spiegati in
forza di un’integrazione del negozio ex artt. 1175, 1374, 1375 c.c. È
prevalsa, piuttosto, una ricostruzione dei medesimi alla stregua di
obblighi principali: autonomi rispetto alla prestazione lavorativa,
ma “strumentali” alla stessa, siccome orientati a garantirne il
sostrato, tanto da dover essere adempiuti nel rispetto delle regole
di diligenza e di obbedienza (art. 2104 c.c.). In senso speculare si è,
allora, concluso pure a proposito della natura del dovere di sicurezza del datore di lavoro, questo già disciplinato all’art. 2087 c.c.:
autonomo rispetto al dovere di retribuzione, ma strumentale ad
esso, siccome diretto a conservare al lavoratore la possibilità di
adempiere senza danno alla sua sfera (297).
Ora, premesso che ambedue gli obblighi di sicurezza, del datore
e del lavoratore, appaiono attualmente “positivizzati”, sicché ogni
chiamata in causa degli artt. 1175 e 1375 c.c. sarebbe ormai
superflua, premesso ciò, non sembra potersi fondatamente negare
l’inclusione di detti obblighi nell’area dei doveri di protezione.
Detta inclusione ne migliora l’inquadramento teorico (298), perché
ne valorizza la componente personalistica, sottolineando che il
fulcro di tali precetti sta ben al di là del facere del prestatore e di
quanto necessita a garantirne il relativo sostrato: esso riposa, cioè,
(295) Ibidem, p. 198, dove l’Autore osserva che « la contrattazione collettiva sancisce
alcuni obblighi il cui contenuto non è possibile immediatamente collegare con l’obbligazione
di lavorare. Si considerino questi esempi: fumare là dove vietato; danneggiamento volontario degli impianti o della produzione; rissa nei reparti di lavorazione; osservanza delle
disposizioni per la sicurezza e l’igiene del lavoro ».
(296) V. già con riguardo al d.lgs. n. 626 del 1994 Del Punta, 1997, pp. 158 e 180, che
sottolinea la novità di tale dovere generale, nonostante la derivazione dagli specifici obblighi
di cui alla vecchia normativa prevenzionistica degli anni ’50.
(297) Napoli, 1980, p. 198 ss.; critiche in Castronovo, 1990, p. 7; riconduce altresì il
dovere di sicurezza all’area della cooperazione creditoria Montuschi, 1986, p. 66 ss.; più di
recente, esclude la riconducibilità degli obblighi di sicurezza del prestatore all’area dei
doveri protezione, Corrias, 2008a, passim; Id., 2008b, p. 347 ss.
(298) Gragnoli, 2007, p. 450 s.; v. anche Id., 2010, p. 33 ss.; Benatti, 1960, 1359 ss.;
Castronovo, 1990, p. 7; Mengoni, 1984, p. 509; Mazzamuto, 2003, p. 646 ss.
278
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
nella tutela della persona, come parte di una formazione sociale
intermedia rilevante ex art. 2 Cost., nonché nella salvaguardia
dell’organizzazione produttiva, come parte di un ambiente non
solo di lavoro, ma anche esterno (299).
Ciò a maggior ragione risalta dopo l’emanazione del decreto
legislativo n. 81 del 2008, che, in ottemperanza al dettato comunitario (300), ha adottato una concezione globale di sicurezza,
arricchendo oltremodo l’esecuzione dei relativi obblighi, con una
« complessità tecnica » e una specificità culturale particolarmente
significative, sì da rendere ormai inevitabile una distinzione del
tema da quello del facere (301).
Quanto al dovere di sicurezza posto in capo al datore di lavoro
(artt. 2087 c.c., 17 e 18 d.lgs. n. 81 del 2008), esso mira evidentemente a realizzare l’interesse del prestatore alla salvaguardia della
sua persona nel senso più ampio del termine, alias del suo « stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale » (art. 2, 1° comma,
lett. o), d.lgs. n. 81 del 2008), per il solo fatto di esser parte
dell’organizzazione produttiva altrui, senza di necessità un nesso
stringente con l’obbligo di prestazione. E d’altronde, è proprio tale
inserimento a circoscrivere l’area di estensione del debito imprenditoriale (302), non invece, la sussistenza di un rapporto di subordinazione, dunque, di sottoposizione al potere direttivo (303), dopo
che il legislatore ha esteso la qualificazione di « lavoratore » a
« qualsiasi persona che (...) svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di lavoro » (art. 2, 1° comma, lett. a), d.lgs.
n. 81 del 2008) (304). Ciò pare suonare a conferma del fatto che a
fondare l’interesse alla protezione del prestatore è il contatto
(299) Del Punta, 1999, p. 155; lo dimostra emblematicamente il recente “caso Ilva”,
su cui v. Pascucci, 2013, p. 1 ss.
(300) In proposito, da ultimo, Angelini, 2013, p. 1 ss.
(301) Gragnoli, 2007, p. 452.
(302) Stolfa, 2014, p. 24 ss., ma già Id., 2010, p. 54 ss.
(303) Peraltro, sulla delicata questione relativa alla sottoposizione a tale potere
anche di lavoratori non subordinati, che parrebbe evincersi dal d.lgs. n. 81 del 2008, v.
Lazzari, 2012b, p. 2 ss.
(304) Pascucci, 2011, p. 39; sia consentito altresì il richiamo, sul punto, a Campanella, 2010, p. 79 ss.
279
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sociale, a prescindere dall’obbligazione di lavorare (tantomeno in
maniera subordinata) (305).
Con riguardo, invece, agli obblighi di protezione del lavoratore,
essi tendono al soddisfacimento dell’interesse del datore alla sicurezza della propria organizzazione, imponendo una vera e propria
cooperazione del lavoratore stesso al disegno prevenzionistico, con
un carico obbligatorio, che non è concepito semplicemente in
funzione dell’adempimento della prestazione, ma va oltre, in direzione della salvaguardia dell’intero complesso produttivo altrui,
ossia di una organizzazione, fatta di mezzi e di persone, di cui il
responsabile rimane pur sempre il datore.
A nulla vale il fatto che tra gli obblighi di sicurezza gravanti
sul lavoratore ve ne siano taluni immediatamente collegati all’attività lavorativa (art. 20, 2° comma, lett. b), c), d), d.lgs. n. 81 del
2008), dunque, destinati a intersecarsi con l’art. 2104, 2° comma,
c.c. Ciò dipende dalla circostanza che la prestazione consiste in un
facere destinato a inserirsi nell’organizzazione; sicché il soddisfacimento dell’interesse datoriale alla protezione non può non connotare anche il comportamento del lavoratore nell’esercizio della
prestazione, imponendogli il rispetto di direttive e regolamenti
aziendali posti dal datore a tutela del proprio patrimonio aziendale. Però questo dato non può esaurire il senso e la portata di uno
specifico obbligo di sicurezza ben più ampio e complessivo rispetto
a quello di prestare il lavoro, quindi affatto distinto dallo stesso.
Del resto, il dovere di obbedienza ben può interferire con gli
obblighi di protezione, siccome diretto a imporre la disciplina del
lavoro nell’azienda e, dunque, a garantire la salvaguardia dell’organizzazione produttiva dal punto di vista gestionale, incluso per
gli aspetti relativi alla sicurezza.
Così se, ad esempio, il lavoratore segnala al datore episodi
persecutori perpetrati da alcuni suoi colleghi a danno di un altro,
egli avrà assolto al dovere di cura di chi è presente sul luogo di
lavoro (art. 20, 1° comma, d.lgs. n. 81 del 2008) e soddisfarà con ciò
l’interesse del datore alla protezione, non certo quello alla presta(305) A fronte di ciò, dimostra, pertanto, scarsa tenuta la tesi di Natoli, 1974, p. 23,
che ritiene l’art. 2087 c.c. un esempio di dovere di protezione o di sicurezza, che la legge
esplicitamente prevede a temperamento del potere direttivo dell’imprenditore e, dunque, in
ragione dell’implicazione personalistica della prestazione, nonché della particolare natura
subordinata del rapporto di lavoro.
280
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
zione (306). Pertanto, il suo comportamento non dovrà ritenersi
presidiato dalle disposizioni dell’art. 2104 c.c. E l’esempio sottolinea altresì, indirettamente, che quanto più la sicurezza non è solo
assenza di rischio fisico, ma globale benessere di ciascuna persona
in una comunità di vita e di attività, tanto più diventa arduo
sostenere che il lavoratore adempiente al proprio obbligo di sicurezza nulla di più stia facendo se non preservare la propria possibilità di adempiere, in termini di conservazione del substrato
materiale della relativa attività lavorativa.
Per altro verso, l’inquadramento degli obblighi di sicurezza
delle parti del contratto di lavoro nell’area dei c.d. doveri di
protezione non dovrebbe comportare effetti negativi per il lavoratore sul piano rimediale. In forza della reciprocità e della simmetria
di tali obblighi, la trasgressione dell’art. 2087 c.c. giustificherà
senza problemi il ricorso all’eccezione di inadempimento (art. 1460
c.c.) (307) e alle dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), così
(306) Né può dirsi, quindi, che con un tale comportamento il lavoratore abbia assolto
all’obbligo di rendere una prestazione atta ad inserirsi utilmente in un’organizzazione del
lavoro data, secondo quella ricostruzione — fatta propria da Del Punta, 1997, p. 184 sulla
scorta di Persiani, 1966 — degli obblighi di sicurezza del lavoratore come « obblighi accessori
alla prestazione di lavoro, il cui ambito teorico » andrebbe ricercato « in una certa ricostruzione complessiva (...) del contratto di lavoro in quanto contratto di organizzazione »; per
l’A., infatti, la tipizzazione di un generale obbligo di sicurezza a carico del prestatore si
porrebbe « come una sorta di suggello della teorica che concepisce il contratto di lavoro come
un contratto di integrazione organizzativa »; da qui « l’impressione che una normativa come
questa non possa non determinare (...) un’intensificazione dei nessi fra contratto e organizzazione, e dunque un punto a favore di Persiani (Persiani, 1966) e magari di Liso (Liso, 1982)
e contro Mancini (Mancini, 1957) » (p. 172 s.); sulla questione, con riferimento al d.lgs. n. 81
del 2008, v. Lazzari, 2012a, p. 19 ss.
(307) Lai, 2010, p. 25 ss. e ivi anche per i relativi riferimenti giurisprudenziali; in
tema Ferrante, 2004, p. 259, anche qui con ampio corredo di richiami alla giurisprudenza,
ove, nell’ambito delle ipotesi di esercizio di autotutela da parte del lavoratore che rifiuti di
eseguire un ordine datoriale illegittimo, cita « innanzi tutto, i casi in cui vi sia stata
violazione dell’art. 2087 c.c. da parte del datore di lavoro, che abbia omesso di predisporre
gli strumenti necessari alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore », inquadrando, poi, conseguentemente il meccanismo del rifiuto nella prospettiva dell’inadempimento, non, invece, della illiceità dell’atto datoriale; l’Autore precisa comunque, che la
fattispecie dell’art. 1460 c.c. reclama, ad ogni modo, « non tanto (...) un vero e proprio
preavviso », salvo casi particolari in cui l’assenza di questo sarebbe contraria a buona fede,
« quanto piuttosto di una manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell’eccezione ».
In tal senso è anche la giurisprudenza, che, per fare applicazione dell’art. 1460, richiede
l’offerta della prestazione dovuta, da ritenersi tuttavia implicita nel palesamento dei motivi
281
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
come la violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008 potrà comportare il licenziamento, sempre per giusta causa, del prestatore (artt.
2119 c.c. e 3 l. n. 604 del 1966) (308).
Non v’è, dunque, motivo per rifiutare, sul piano concettuale, la
categoria dei c.d. doveri di protezione. Un tal rifiuto, motivato
essenzialmente dal timore di un arricchimento della posizione
debitoria del prestatore, non pare aver sortito, sul piano pratico,
l’effetto atteso, cioè quello di un contenimento di quella stessa
posizione obbligatoria. Se, da un lato, i giudici sono apparsi restii
all’accoglimento della summenzionata categoria, in uno con l’impostazione giuslavoristica “classica”, dall’altro, non hanno comunque rinunciato ad ampliare il contenuto dell’obbligo di prestazione
per altre vie. Così, omesso qualsiasi riferimento ai doveri di protezione, hanno piuttosto perseguito lo scopo dilatatorio puntando
sulla diligenza (art. 2104 c.c.) e sulla fedeltà (art. 2105 c.c.), non
senza, peraltro, qualche omaggio formale alla stessa correttezza e
buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Sarebbe allora più costruttivo, giunti a tal punto, dismettere
l’abito mentale “classico” e orientarsi verso una riflessione capace
di fornire la giusta collocazione ai doveri di protezione nell’ambito
della posizione debitoria delle parti del contratto di lavoro. In
quest’ottica, bisognerà ammettere che gli spazi concessi a detti
doveri, in quanto derivanti dal diritto delle obbligazioni e dei
contratti, non sono amplissimi all’interno di un contesto come
quello del diritto del lavoro. Si tratta, infatti, di un contesto ad alto
tasso di regolamentazione, in virtù della legge e della contrattazione collettiva: per un verso, segnato dal dominio del precetto
inderogabile, impositivo di obblighi a carico del datore e altresì di
limiti al suo potere, proprio in funzione della salvaguardia della
dell’astensione, e destinata a fungere in sostanza « quale dichiarazione di volersi avvalere
dell’exceptio » (p. 290); diversamente, invece, Giugni, 1963, p. 340, nt. 31, che qualifica il
rifiuto di svolgere il lavoro per violazione del dovere di sicurezza dell’imprenditore non tanto
quale eccezione di inadempimento, quanto « come riflesso dell’impossibilità, determinata da
colpa dell’imprenditore (art. 1218 c.c.), di svolgere il compito senza pericolo di nocumento
della propria persona (...); il che condurrebbe però a rivedere, almeno in parte, la collocazione della norma nei doveri autonomi di protezione ».
(308) Ovvero altre sanzioni a carattere conservativo, ferma restando l’obbligatorietà,
almeno secondo certe ricostruzioni, del ricorso al potere disciplinare in presenza di violazioni
di obblighi di sicurezza del datore, data la valenza pubblica del bene “salute”: in tema
Lazzari, 2012a, p. 36 ss.
282
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
persona del prestatore, che appare, pertanto, già sufficientemente
presidiata ab externo; per l’altro verso, contraddistinto da penetranti e speciali doveri del prestatore, a garanzia del soddisfacimento dell’interesse alla prestazione e alla protezione della controparte. Tutto ciò non vuol dire, comunque, che ogni spazio per i
doveri di protezione sia assente. Si tratta piuttosto di individuarne
alcuni, cimentandosi in un’opera di non agevole distinzione tra
area presieduta dalle clausole generali (artt. 1175, 1375 c.c.) e area
dominata dalle regole di diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104,
2105 c.c.), secondo una prospettiva ispirata da evidenti esigenze di
certezza del diritto, che le stesse istanze di tutela del prestatore di
opere sollevano a gran voce.
6. La “concretizzazione” delle clausole generali di correttezza e buona
fede nei confronti del prestatore di lavoro: l’approccio giurisprudenziale.
Nell’ottica di una “concretizzazione” degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sul lavoratore, emerge come ineludibile
il confronto con la giurisprudenza. Essa è chiamata ad offrire
concreta “traduzione” a clausole generali civilistiche nell’ambito di
un negozio, il contratto di lavoro, caratterizzato dal perseguimento
di un interesse durevole delle parti, con l’inserimento del debitore
di opere e della sua personale collaborazione nell’organizzazione
produttiva del datore creditore in condizioni di subordinazione, ai
sensi dell’art. 2094 c.c. Da questo inserimento discende, come noto,
la sottoposizione del debitore medesimo a specifici doveri, introdotti e regolamentati dalla legge agli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché
disciplinati dalla contrattazione collettiva.
V’è da comprendere quali siano la connotazione, il ruolo e i reali
spazi di agibilità degli artt. 1175 e 1375 c.c. all’interno di un simile
contesto. Per farlo, sarà necessario individuare i tipi normali di comportamento, le relative regole di condotta e le categorie concettuali
di riferimento, enucleabili, secondo i giudici, alla luce di tali norme.
Occorrerà, insomma, identificare alcune consolidate ipotesi applicative della correttezza e della buona fede alla posizione debitoria del
prestatore di lavoro, con approccio critico e aperto, attesa la funzione
di stimolo alla riflessione teorica di cui è investita la dottrina ed
altresì la natura esemplificativa di dette ipotesi applicative, le quali
283
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
mai potranno esaurire il contenuto delle menzionate clausole, bensì
solo agevolare il compito del giudice in ordine a casi futuri sussumibili entro le stesse regole e categorie.
Su questa strada, è bene anzitutto rammentare come la funzione integrativa e la natura estroflessa di correttezza e buona fede
quali clausole generali attribuiscano alle “norme” di condotta da
esse desumibili la valenza di precetti ulteriori e diversi (309) da
quelli già inseriti dalle parti nel programma contrattuale o comunque imposti alle parti medesime per via di legge e di contrattazione
collettiva (310). Ciò vuol dire che alla “concretizzazione” dei comportamenti del lavoratore conformi alle menzionate clausole si
dovrà giocoforza pervenire attraverso un’operazione di distinguo
tra l’area governata dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e l’area dominata
dagli artt. 2104 e 2105 c.c.
Sul punto, tuttavia, non aiutano gli approdi della giurisprudenza, che preferisce per lo più racchiudere entro una “formula”
unitaria la correttezza, la buona fede, la diligenza e la fedeltà,
chiamandole nel complesso a individuare gli estremi della posizione
debitoria del prestatore, senza alcuna (almeno) apparente distinzione interna (311).
(309) Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 1991, n. 1747, in AC, 1991, p. 683 ss. parla di
« obblighi non codificati conseguenti al generale dovere di esecuzione del contratto secondo
buona fede »; in tal senso, v., del resto, già Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1985, n. 2559, in
MGI, 1985; cfr. pure Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1998, n. 10514, cit., ove si attribuisce agli
obblighi di correttezza e buona fede la funzione di imporre « una serie di comportamenti a
contenuto atipico »; cfr. pure Trib. Genova, 11 aprile 2013, cit., che anche dal carattere non
codificato di tali obblighi parrebbe desumere la non particolare gravità della loro violazione
(come se un conto fosse, per i giudici, trasgredire il divieto di non concorrenza dell’art. 2105
c.c. e del CCNL, altro, invece, tenere una condotta meramente scorretta), con conseguente
illegittimità (per assenza di giusta causa) del licenziamento irrogato dal datore, seppure non
assistito dalla tutela reintegratoria, versandosi piuttosto in un’ipotesi applicativa del 5°
comma, dell’art. 18 St. lav. (mera tutela indennitaria).
(310) V. Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, cit., ove afferma che gli artt.
1175, 1366 e 1375 c.c., rilevando sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali,
« impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto
o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte », per
quanto poi la pronuncia riconosca altresì alle clausole generali contenute in quelle norme
una funzione di equo contemperamento degli interessi dei contraenti; per affermazioni di
analogo tenore Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2004, n. 20399, cit.; Cass. civ. sez. I, 5 novembre
1999, n. 12310, cit.; Trib. Genova, 11 aprile 2013, cit.
(311) In tal senso è molta della giurisprudenza sul dovere del prestatore di curare la
propria salute e non ostacolare o ritardare la guarigione — App. Roma, 27 aprile 2013, n.
284
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
L’impressione immediata che ne deriva è di un riferimento agli
artt. 1175 e 1375 c.c. in funzione meramente rafforzativa dell’argomentazione giuridica, se non, addirittura, di un richiamo affatto
superfluo a dette disposizioni, giacché privo di un effettivo contenuto decisorio (312). In realtà, a una riflessione più attenta, ci si
accorge che i giudici, proprio a partire da un’accezione di correttezza e buona fede antitetica alla c.d. teoria dei doveri di protezione, finiscono per attribuire alle menzionate clausole una funzione strategica.
Gli artt. 1175 e 1375 c.c., per un verso, invadono gli spazi
assegnati alla diligenza dell’art. 2104, 1° comma, c.c., ora sottraendole l’area degli obblighi preparatori all’adempimento, ora orientando direttamente l’adempimento della prestazione verso la realizzazione di un « risultato » (313) altrimenti destinato a rimanere
fuori da un’obbligazione di lavoro ancora qualificata “di
mezzi” (314). Per altro verso, i suddetti articoli si saldano con la
fedeltà dell’art. 2105 c.c., quasi alla stregua di un corpo unico, per
2824, in Red. Giuffrè, 2013; Cass. civ., sez. lav., 14 settembre 2012, n. 15476, in ADL, 2012,
p. 1278 ss., con nota di Riccio; Cass. civ., sez. lav., 24 aprile 2008, n. 10706, in DPL, 2008,
p. 1394 ss.; Trib. Bergamo, 21 luglio 2006, in OGL, 2006, p. 620 ss., con nota di Malandrini;
Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9056, in LG, 2006, p. 1019 ss.; Cass. civ., sez. lav., 1°
luglio 2005, n. 14046, in GD, 2005, 36, p. 75 ss.; Cass. civ., sez. lav., 6 ottobre 2005, n. 19414,
in OGL, 2005, p. 835, con nota di Picciariello; Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 2002, n. 17128,
in MGL, 2003, p. 171 ss. — mentre gli orientamenti sul dovere di fedeltà del prestatore
prediligono il richiamo agli artt. 1175 e 1375 c.c. in combinato disposto con il solo art. 2105
c.c. — per le relative pronunce v., infra, nota 319 — salvo casi eccezionali, come Trib. Lecce,
16 gennaio 2013, in NGL, 2013, p. 337 ss.; sempre per un richiamo unitario agli artt. 1175,
1375, 2104, 2105 c.c. in materia di svolgimento di altra attività lavorativa in periodo feriale
v. Trib. Bergamo, 17 aprile 2008, in RCDL, 2009, p. 241 ss.
(312) Cester, 2007, p. 85 ss.; Mattarolo, 2000, p. 48 ss; Saffioti, 1999, p. 207 ss.;
Viscomi, 1997, p. 160; Menegatti, 2012b, p. 922 s.; Boscati, 2012, p. 966 ss.
(313) V. Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1998, n. 10514, cit., che ravvisa negli obblighi
di correttezza e buona fede « la funzione di salvaguardare l’interesse della controparte alla
prestazione dovuta e all’utilità che la stessa le assicura »; Cass. civ., sez. lav., 26 settembre
2013, n. 22076, in GD, 2013, 41, p. 73 ss., per l’idoneità della buona fede ad assicurare l’uso
proficuo del lavoro.
(314) Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2002, n. 1365, in OGL, 2002, p. 88 ss.; Cass. civ.,
sez. lav., 6 marzo 2006, n. 4761, in LG, 2006, p. 813; Cass. civ., sez. lav., 24 aprile 2008, n.
10728, in CED Cass., 2008; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2005, n. 15255, ivi, 2005; Cass. civ.,
sez. lav., 27 luglio 2000, n. 9877, MGI, 2000; Trib. Milano, 20 dicembre 2000, in RCDL, 2001,
p. 442; per la ricostruzione dell’obbligazione di lavoro quale obbligazione di mezzi cfr. in
dottrina Carabelli, 2004, p. 19.
285
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
consacrare l’idea di una buona fede, la quale, ove trasposta in
ambiente lavoristico, assume senso « pregnante », come se dal prestatore di opere si dovesse inevitabilmente pretendere una buona
fede più accentuata di quella comune, in virtù di un supposto
vincolo fiduciario che legherebbe tra loro le parti del rapporto (315).
Ne emerge, così, una sorta di figura di “lavoratore modello”:
leale collaboratore dell’imprenditore, tutto proteso a garantire la
proficuità del lavoro e ad evitare qualsiasi contegno pregiudizievole dell’interesse all’effettiva attuazione della prestazione. È ciò
quanto può arguirsi dall’orientamento secondo cui « l’obbligo di
collaborazione è insito nel dovere di diligenza e trova fondamento
anche nel dovere di esecuzione secondo buona fede, poiché il
lavoratore non adempie i doveri nascenti dal contratto di lavoro
mettendo formalmente a disposizione dell’imprenditore le sue
energie lavorative, ma è necessario e indispensabile che il suo
comportamento sia tale da rendere possibile al datore di lavoro
l’uso effettivo e proficuo di queste » (316). Lo stesso può dirsi a
proposito dell’opinione che fa carico al prestatore di comportarsi in
maniera prudente e oculata, evitando ex artt. 1175 e 1375 c.c.
qualsiasi condotta lesiva dell’interesse del datore all’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa (317). Alle medesime conclusioni induce pure la tesi per cui « l’obbligo di fedeltà (...) va
collegato ai principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175
e 1375 c.c.) (e) impone al lavoratore di tenere un comportamento
leale verso il datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo
a nuocergli, anche potenzialmente » (318), ossia « da qualsiasi condotta », la quale, « per la sua natura e le sue possibili conseguenze,
(315) V. la giurisprudenza citata a nota 319, evidentemente sulla falsariga di quella
nozione di buona fede fatta propria da Betti, 1953, pp. 76 e 93, poi accolta, in ambito
giuslavoristico, da Persiani, 1966, p. 228 ss.; non è un caso che il richiamo a correttezza e
buona fede, in connessione con il carattere fiduciario del rapporto, sia centrale nella
valutazione di legittimità del licenziamento del dirigente: v. Cass. civ., sez. lav., 13 maggio
2005, n. 10058, in GD, 2005, p. 42 ss; ma, in dottrina, sul punto, con riflessioni problematiche, Tosi, 1974, p. 141 ss.
(316) Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2013, n. 22076, cit.
(317) Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2011, n. 1699, in LG, 2011, p. 909, con nota di
Golisano.
(318) Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 1990, n. 11657, in RIDL, 1991, II, p. 828 ss., con
nota di Proia.
286
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nell’impresa e sia, comunque, idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro » (319).
Certo è che richiami così generici e indistinti agli obblighi del
prestatore consentono ai giudici di imboccare « la strada in fondo
più comoda » (320), sottraendosi, però, a quell’opera di “concretizzazione” della correttezza e della buona fede affatto essenziale a
fronte di clausole generali per loro natura indeterminate. Combinati, se non addirittura indistintamente sovrapposti agli artt. 2104
e 2105, gli artt. 1175 e 1375 c.c. dismettono, in tal modo, la loro
indiscussa valenza costitutiva di obblighi integrativi a reciproco
carico dei contraenti, per essere indirizzati ad assistere e sostenere
obblighi già esistenti e in sé vincolanti (321), nell’ambito di generiche formule di stile oltremodo dilatatorie della sfera debitoria del
(solo) prestatore. È da qui che nasce l’impressione di una « funzione
meramente accessoria e decorativa » della buona fede (322).
Non è un caso, del resto, se la giurisprudenza di legittimità,
allorché ha inteso confutare l’operatività degli artt. 1175 e 1375 sul
piano del governo della discrezionalità imprenditoriale, lo abbia
fatto proprio a partire dal presupposto che correttezza e buona
fede non valgano a configurare obblighi aggiuntivi e dunque obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, rilevando semplicemente « come modalità di generico comportamento delle parti ai
fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti
e obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a
specifici obblighi di prestazione (...) » (323).
(319) Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 1998, n. 4952, in RIDL, 1999, II, p. 346 ss., con
nota di Tullini; ma già Cass. civ., sez. lav., 1° giugno 1988, n. 3719, in RIDL, 1990, II, p. 978
ss., con nota di Tullini; successivamente Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12489, in
NGL, 2004, p. 180 ss.; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6957, ivi, 2005, II, p. 916 ss., con
nota di Pisani; Cass. civ., sez. lav., 1° febbraio 2008, n. 2474, in LG, 2008, p. 625 ss.; per
un’accentuazione anche in senso positivo di tale obbligo, da intendersi pertanto, come
dovere del prestatore di tutelare in ogni modo gli interessi dell’impresa, ma con richiamo al
solo art. 2105 c.c., v. Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1986, n. 645, in NGL, 1986, p. 478.
(320) Mattarolo, 2000, p. 244 in riferimento specifico alla giurisprudenza sull’art.
2105 c.c., ma con osservazioni senz’altro estendibili anche agli artt. 1175 e 1375, siccome
impiegati dai giudici in stretto connubio con quella disposizione.
(321) Perulli, 2002, p. 13.
(322) Montuschi, 1999, p. 735.
(323) Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 1995, n. 7190, cit.; v. anche Cass. civ., sez. lav.,
24 marzo 2009, n. 7053, in LG, 2009, p. 833 ss.; ma efficacemente, in senso critico rispetto
287
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Del resto, quando pure i giudici hanno ammesso quella funzione integrativa che a correttezza e buona fede va riconosciuta
quali clausole generali, non ne hanno poi saputo trarre le dovute
conseguenze. Così è stato, ad esempio, laddove la Suprema Corte
ha affermato che gli obblighi di correttezza e buona fede — proprio
a ragione della « predetta funzione integrativa del contenuto tipico
del rapporto (di lavoro, nel caso di specie) » — « non possono
debordare dal complesso di regole » entro « cui si sostanzia la civiltà
del lavoro », quale « assieme dei principi giuridici espressi dalla
giurisdizione di legittimità e (degli) standards », diretti a compendiare « il diritto vivente del lavoro » (324).
In effetti, più che suggestivamente evocare il rispetto di non
meglio definite regole di « civiltà del lavoro », la Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, dovrebbe provvedere a
guidare meglio il giudice di merito nella complessa opera di “concretizzazione” delle clausole generali contenute negli artt. 1175 e
1375 c.c. Al di là della ricostruzione del fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, v’è tutta un’attività interpretativa a
carico del magistrato di prime cure, funzionale alla “concretizzazione” stessa e ben suscettibile di un vaglio ad opera della Suprema
Corte. Si tratta, infatti, di un’attività, che, se condotta rigorosamente, dovrà anzitutto procedere alla verifica degli spazi riservati,
in casu, alla direttiva di buona fede, intesa nel suo corretto
significato. Il confronto con l’area già governata dalla diligenza e
dalla fedeltà diverrà, allora, ineludibile per il giudice del merito e
le risultanze del suo giudizio appariranno ampiamente meritevoli
di un rigoroso controllo di legittimità. Troppo spesso gli artt. 1175
e 1375 sono stati richiamati a sproposito, dando luogo a una
sovrapposizione di concetti e relative norme, che non giova alla
certezza del diritto (325).
a simili orientamenti, v. Tullini, 1990, p. 183, per la quale « risulta inaccettabile » l’applicazione della correttezza e della buona fede « in funzione meramente ausiliaria, cioè al
limitato scopo di assicurare il rispetto di doveri già specificamente e puntualmente previsti
o di “misurare” il grado di adempimento concreto ».
(324) Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1998, n. 10514, cit.
(325) La stessa Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1998, n. 10514, cit., che pure ha
richiamato le regole di « civiltà del lavoro » ai fini della decisione, non ha mostrato piena
consapevolezza di ciò, considerato che nel caso di specie la Suprema Corte ha glissato sulla
correttezza dell’inquadramento — operato dal giudice di merito — della condotta del
prestatore nell’area governata dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Di ciò, invece, si sarebbe potuto
288
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Una volta riscontrata l’esistenza di quegli spazi, occorrerà che
l’organo giudiziario proceda all’individuazione degli standards di
riferimento e, dunque, delle figure tipiche di comportamento,
destinate a tradursi in norme sociali di condotta, suscettibili, poi,
di “incorporazione” in precise categorie concettuali (v. retro, sez. I,
§ 2.4.). Anche su questo versante dovrebbe essere ipotizzabile un
controllo della Suprema Corte, trattandosi, a tutti gli effetti, di
un’attività giudiziale valutativo-interpretativa. Ai fini del controllo, il « diritto vivente del lavoro » costituirà senz’altro un punto
di riferimento imprescindibile, ma nella consapevolezza che esso si
atteggerà alla stregua di mera linea direttiva, poiché la concretizzazione di ogni singola clausola generale potrà sempre realizzarsi
attraverso « una decisione non corrispondente puntualmente a
modelli di condotta già sperimentati » (326).
Sono, invece, piuttosto i principi generali dell’ordinamento, in
primis quelli della Costituzione, a fungere da limite alla discrezionalità del giudice impegnato nel processo di “concretizzazione”
delle clausole. È vero, infatti, che questa “concretizzazione” giammai potrà essere concepita come una mera ripetizione di precetti
costituzionali. Tuttavia, è altrettanto vero che le norme sociali di
condotta sono chiamate a esprimere valori, di cui va pur sempre
vagliata la compatibilità con quelli posti a fondamento della civile
convivenza secondo l’ordinamento.
È lodevole il tentativo della Cassazione di indirizzare il processo di “concretizzazione” delle clausole generali tramite rinvio al
« diritto vivente del lavoro ». Non è, però, ipotizzando un obbligo di
conformazione a tale « diritto » da parte del magistrato di merito
che si argina il rischio di “soggettivismo giudiziario”. Piuttosto,
varrebbe la pena di identificarne più precisamente il contenuto, nei
termini di standards e di principi che lo compendiano, data comunque per premessa e accolta l’esigenza di individuazione rigorosa, “a
dubitare, considerato che quella condotta era sostanzialmente consistita in un’assenza
ingiustificata e, quindi, nel mancato adempimento della prestazione di lavoro; sicché non si
vede perché mai la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito delle regole di
correttezza e buona fede (in particolare, il lavoratore, a seguito dell’assenza di un giorno —
la cui mattinata sarebbe stata impiegata per la raccolta di funghi — aveva taciuto al datore
di lavoro che il certificato medico prodotto gli era stato rilasciato nel pomeriggio e pertanto
non copriva l’assenza ingiustificata del mattino).
(326) Mengoni, 1986, p. 15.
289
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
monte”, del confine volto a separare la correttezza e la buona fede
dalla diligenza e dalla fedeltà. Se un comportamento viola, infatti,
un precetto giuridico già fissato dalla legge e dall’autonomia privata, individuale e collettiva, e lo viola in forza di altre norme, il
richiamo agli artt. 1175 e 1375 appare fuori luogo.
Sarà che il modo di procedere della Suprema Corte « testimonia
la difficoltà di collocazione e precisazione (...) delle clausole generali » (327), ma esso risulta inappagante e non persuasivo. Come è
stato osservato, « rimane un po’ oscuro il significato da attribuire al
concetto di “civiltà del lavoro”, né si comprende di quali principi
e regole esso si componga. (...) Il risultato è che al giudice del rinvio
non sono stati segnalati i criteri cui attenersi in via alternativa per
dare un significato concreto alla buona fede (...) » (328).
È innegabile, allora, se si condivide la riflessione sinora compiuta, che tale significato vada ricercato sulla scorta, anzitutto, di
una precisa delimitazione dell’area governata dagli artt. 1175 e
1375 c.c. rispetto all’area presidiata dagli artt. 2104 e 2105
c.c. (329) A riguardo, occorrerà partire da quelli che, secondo la
ricostruzione qui proposta, rappresentano i tratti fondamentali
degli obblighi derivanti dalle clausole di correttezza e buona fede:
la reciprocità; la « atipicità » (330), per così dire, discendente dalla
funzione integrativa degli artt. 1175 e 1375; la richiesta di comportamenti improntati a spirito di solidarietà, cioè diretti a preservare l’utilità della controparte nei limiti in cui ciò non importi
un apprezzabile sacrificio a proprio carico; la concretizzazione di
tali comportamenti in obblighi di salvaguardia dell’altrui sfera
giuridica, esposta a potenziale pericolo per il contatto sociale
instauratosi tra le parti in virtù del rapporto obbligatorio; l’accessorietà o secondarietà di tali obblighi, siccome preordinati alla
realizzazione di un interesse di protezione, diverso da quello di
prestazione, al cui soddisfacimento è preposto l’obbligo principale
o primario.
Guardati alla luce della posizione debitoria del lavoratore,
(327) Cester, 2007, p. 85 s.
(328) Montuschi, 1999, p. 735.
(329) V. Pisani, 2004, p. 120, dove si afferma che gli obblighi di protezione ex art.
1175 c.c. « “coprono” tutto quello spazio dove non arriva alcun altro obbligo contrattuale
del lavoratore ».
(330) Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1998, n. 10514, cit.
290
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
detti obblighi si atteggiano alla stregua di vincoli, i quali, siccome
derivanti dall’immissione del prestatore nella sfera giuridica dell’imprenditore e dal pericolo di pregiudizio che a quest’ultima ne
deriva, non sono riferibili all’adempimento del dovere di prestazione del lavoro in sé considerato. Ciò ci induce a indirizzare
l’attenzione su quell’area piuttosto variegata e frammentata, occupata da condotte richiedibili al prestatore fuori dallo stretto
adempimento dell’attività lavorativa — comportamenti strumentali o preparatori all’adempimento, rispetto della disciplina aziendale, salvaguardia del patrimonio dell’impresa, contegni extralavorativi consoni all’immagine dell’azienda — per verificarne
l’eventuale riconducibilità agli artt. 1175 o 1375 c.c.
7. Correttezza e buona fede: il rapporto con la diligenza. Una prima
conclusione.
Si è detto di come la correttezza e la buona fede, data la
reciprocità del loro ambito applicativo soggettivo, vincolino anche
il debitore, non potendosi certo sostenere il contrario a motivo
della sottoposizione del medesimo già alla regola di diligenza
nell’adempimento. Piuttosto, vi è da interrogarsi sul rapporto tra
dette clausole e la regola appena menzionata, attesa la idoneità
delle stesse a incidere direttamente sulla struttura del rapporto
obbligatorio, sì da integrarne il contenuto, in sede di esecuzione del
programma contrattuale, attraverso precisi obblighi, destinati a
interferire o comunque ad articolarsi con quelli derivanti ab origine
dalla stipulazione del contratto (331).
La correttezza e la buona fede non sono incompatibili con la
diligenza, né, però, vi appaiono fungibili (332). Per capirlo, è bene
partire proprio dalle prime, dal loro modo di operare alla stregua di
clausole generali, perché è esattamente su tal versante che è
percepibile il netto distinguo con la seconda.
Bisogna, in particolare, riflettere sul connotato etico e deontologico di correttezza e buona fede, quali congegni normativi finalizzati a garantire il rinvio a valori tratti dall’esperienza sociale. Gli
artt. 1175 e 1375 c.c. offrono a al giudice veri e propri criteri
(331)
(332)
Rodotà, 1964, p. 2, che parla di reciproche interferenze.
Natoli, 1974, p. 9.
291
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
direttivi per la ricerca, a partire dal caso concreto, di tali valori.
Questi sono poi destinati a tradursi in modelli di comportamento
suscettibili di generalizzazione, quindi, in obblighi di condotta
integrativi del programma contrattuale, riconducibili come tali —
nella ricostruzione fin qui proposta — alla categoria degli obblighi
“accessori” o “secondari” di protezione.
Più discutibile è, invece, la caratterizzazione in senso etico e
deontologico della diligenza, la quale s’atteggia, da tal punto di
vista, più a norma “generale” o “elastica” che a clausola generale.
Anche quando il 1° comma, dell’art. 1176 c.c. la aggancia alla
nozione di « buon padre di famiglia », evocativa di un rinvio a
valutazioni sociali, il riferimento è comunque pur sempre a un
parametro di normalità statistica, non, invece, a modelli rappresentativi dei valori propri della comune coscienza generale (333).
Ciò accade perché la diligenza, a differenza della correttezza e della
buona fede, non possiede quella funzione costitutiva di obblighi
per via d’integrazione del regolamento negoziale (334), che è tratto
tipico della clausola generale, bensì serve solo a valutare l’esatto
adempimento di doveri già definiti nel loro contenuto (335).
Tutto questo è ancor più lampante se si pone mente al 2°
comma, dell’art. 1176 c.c. e all’art. 2104 c.c., che ne rappresenta
l’« adattamento » (336) o, per certuni, l’« applicazione » e « specificazione » al rapporto di lavoro (337). Qui il riferimento è a una
diligenza ispirata a valutazioni di carattere propriamente profes(333) Pone l’attenzione sul problema Cester, 2007, p. 104.
(334) Persiani, 1966, p. 213.
(335) « La diligenza si presenta come un criterio di valutazione, senza per ciò
costituire (a dispetto delle espressioni talvolta adoperate) il contenuto di una obbligazione
autonoma »: Rodotà, 1964, p. 4, che sottolinea la coerenza di ciò rispetto a quanto sancito
nella stessa Relazione al Re (n. 559), per il quale « il criterio richiamato in via generale
dall’art. 1176 come misura del comportamento del debitore nell’eseguire la prestazione
dovuta riassume in sé quel complesso di cure e cautele che ogni debitore deve normalmente
impiegare nel soddisfare la propria obbligazione »; v. anche Rodotà, 1969, p. 153, laddove
osserva come la diligenza « altro non sia se non uno strumento di controllo dell’attività del
debitore: essa riguarderebbe soltanto il come della prestazione »; in tal senso v. pure Persiani,
1966, p. 213; diversamente, però, Mengoni, 1954, p. 198; nella letteratura giuslavoristica per
una diligenza riguardante le sole modalità esecutive della prestazione v. Persiani, 1966, p.
208 ss.; Cester, 2007, p. 92; Perulli, 2007, p. 596; Rusciano, 2000, p. 656; Menegatti, 2012b,
p. 923 ss.; in senso contrario Viscomi, 1997, p. 110.
(336) Ghera, 2011, p. 94.
(337) Cester, 2007, p. 125.
292
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sionale, cioè rapportata, in ambiente lavoristico, alla « natura della
prestazione dovuta » e « all’interesse dell’impresa » (338). Nulla,
dunque, che possa evocare il rinvio a valori tratti dall’esperienza
sociale, giacché a rilevare è piuttosto il richiamo alle peculiarità
tecniche dell’attività lavorativa svolta, espressione, a propria volta,
della specificità del contesto aziendale, nonché delle relative scelte
produttive e di organizzazione del lavoro compiute nel caso concreto dall’imprenditore (339).
È allora qui, entro il perimetro segnato dalla diligenza professionale del lavoratore nell’adempimento dell’obbligazione di prestare lavoro, che trova riconoscimento giuridico l’interesse organizzativo dell’impresa, nelle forme del « risultato » atteso dal datore di
lavoro creditore. Il tentativo di far penetrare l’« organizzazione »
nello schema causale del contratto di lavoro, sì da identificare il
menzionato « risultato » (non tanto nel comportamento diligente,
quanto, invece) in una condotta subordinata e fedele (340), idonea
a soddisfare l’interesse al coordinamento del datore di lavoro, ex artt.
1375 e 2105 c.c., appare poco persuasivo (341).
L’integrazione dello schema negoziale secondo buona fede, al
pari di quello secondo correttezza, impone, infatti, di preservare
l’utilità della controparte — nei limiti in cui ciò non importi un
apprezzabile sacrificio a proprio carico — attraverso condotte
ispirate a criteri relazionali di rispetto e solidarietà reciproca tra i
contraenti. Pertanto, essa consente sì di offrire riconoscimento
giuridico all’interesse organizzativo del datore di lavoro, ma solo
nei termini di un interesse negativo a non subire nel corso dell’esecuzione del contratto comportamenti pregiudizievoli della propria
(338) Il riferimento all’interesse superiore della produzione nazionale contenuto
nell’art. 2104 c.c. deve, invece, ritenersi abrogato con la caduta del regime corporativo.
(339) Sottolineano la necessità di guardare al contesto organizzativo Grandi, 1987, p.
342; Viscomi, 1997, p. 277.
(340) Persiani, 1966, p. 213 s.
(341) Liso, 1982, p. 157; Grandi, 1987, p. 330 s.; Gragnoli, 2006, p. 15 ss.; per una
riedizione o aggiornamento della teoria del contratto di organizzazione Marazza, 2002,
passim; sulla “funzione organizzatoria” del contratto di lavoro al fine di spiegare l’origine e
la natura negoziale del potere disciplinare v. Mainardi, 2002, p. 36; da ultimo, cfr. Nogler,
2014b, p. 884 ss., che, in aderenza alle teorie mengoniane, si esprime sì nel senso di un
ampliamento della causa del contratto di lavoro, ma senza richiamo alla norma sul dovere
di fedeltà, poiché l’obbligo del prestatore di collaborare con gli altri sarebbe ricavabile
direttamente dall’art. 2094 c.c.
293
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
organizzazione ad opera del prestatore. È escluso, invece, che la
clausola di buona fede agisca direttamente sull’obbligazione di
lavorare, richiedendo al lavoratore una tensione cooperatoria al
risultato atteso dal datore, oltre quanto specificato nell’esercizio
del potere, al punto che la violazione di tale clausola importi
l’inadempimento dell’obbligazione principale. È escluso perché,
come visto, essa prescrive, piuttosto, condotte obbligatorie finalizzate al soddisfacimento di un interesse diverso da quello alla
prestazione e, come tali, “accessorie” o “secondarie” rispetto all’obbligazione di svolgere il lavoro.
Anche l’idea che il dovere di esecuzione secondo buona fede
implichi un comportamento tale da rendere possibile al datore di
lavoro l’uso effettivo e proficuo delle energie lavorative — secondo
un orientamento espresso a proposito di scioperi articolati delle
maestranze e di contestuale rifiuto imprenditoriale ad accettare e/o
retribuire l’attività resa tra un intervallo e l’altro dell’astensione
collettiva — sembra risentire in fondo dell’attrazione del fenomeno
organizzativo nella struttura del contratto di lavoro, con un trasferimento sul lavoratore del “rischio” del risultato relativo alla
prestazione. È vero, però, che « le mansioni di ciascun prestatore di
opere non sono inserite » entro « un disegno organizzativo oggetto
dell’accordo individuale, né si può trarre dalla sua stipulazione »
l’ipotesi « di una prestazione di facere organizzabile » (342). Non si
può, almeno se e nella misura in cui da ciò si intenda far discendere
obblighi autonomi, ancorché strumentali rispetto all’obbligazione,
invece che una direttiva volta più semplicemente a tarare la
condotta diligente al concreto assetto aziendale e al risultato
produttivo di volta in volta dinamicamente pianificato e perseguito dal datore, con l’imposizione ex art. 2104 c.c., di contegni
funzionali all’inserzione e al coordinamento di ciascuna singola
(342) Gragnoli, 2006, p. 19, con richiamo peraltro a una concezione di organizzazione
come « progetto », ossia come « programma soggettivo » dell’imprenditore, oltretutto in
costante evoluzione, tant’è che al giudice, impegnato nel controllo sul giustificato motivo
oggettivo di licenziamento, essa si presenta alla stregua di « categoria della conoscenza »,
cioè, quale « forma tipica di riflessione sui fatti dal cui esame » deve ricavarsi quel « quid
novi » (organizzativo), a cui il licenziamento medesimo si ricollega; per la tesi dell’organizzabilità Vardaro, 1986, p. 12 ss. Sul rapporto tra prestazione di lavoro e organizzazione v.
Carabelli, 2004, p. 45.; v. inoltre, Liso, 1982, p. 169, il quale sottolinea come l’art. 2103 c.c.
determini un criterio per l’esercizio del potere e non un previsione indirizzata all’identificazione dell’oggetto del contratto.
294
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
attività nella specifica organizzazione di lavoro [« la diligenza richiesta (...) dall’interesse dell’impresa »], oltre che conformi a perizia e rispetto delle regole tecniche (« la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta »).
L’inidoneità della buona fede a reagire direttamente sull’obbligo primario del lavoratore debitore induce altresì ad escluderne
eventuali interferenze con il tema dello scarso rendimento. L’art.
1375 c.c. non può essere invocato allo scopo di « introdurre un
generico elemento di elasticità, al fine di adattare l’impegno richiesto alla dinamicità della vita economica contemporanea » (343), sul
presupposto che « la condotta del lavoratore debba essere teleologicamente indirizzata al risultato », inteso quale « “tassello” dell’organizzazione » (344) e misurato attraverso il rendimento, concepito, a tal stregua, come capacità del prestatore di rispondere nel
tempo al risultato atteso dal datore.
Questa teoria si fonda su una ricostruzione stimolante, attraversata dalla condivisibile idea che lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle organizzazioni produttive moderne, ove « i contenuti
cambiano continuamente e richiedono duttilità nelle capacità »,
« svela un inevitabile conflitto tra diligenza e risultato della prestazione » (345). Tuttavia, essa, nel meritorio sforzo di risolvere quel
conflitto attraverso una revisione delle teorie sulla struttura dell’obbligazione di lavoro, giunge a una lettura audace, anche se suggestiva, con una svalutazione della diligenza tradizionalmente intesa, che appare concepita in senso puramente conservativo, e sostituita con il rendimento, quale misura, esso stesso, dell’adempimento (346).
L’operazione, sollecitata da un più generale confronto con le
categorie e i risultati delle scienze sociali, trova fondamento in una
concezione dell’obbligo primario del prestatore alla stregua di
un’obbligazione di risultato (347), concezione adottata sulla falsariga di una tendenziale revisione della categoria dell’obbligazione
di comportamento ad opera della giurisprudenza civilistica. Ma va
(343) Pantano, 2012, p. 74.
(344) Ibidem, p. 63.
(345) Ibidem, p. 69.
(346) Ibidem, pp. 71 ss. e 94.
(347) Nella dottrina civilistica, Mengoni, 1954, passim; più di recente, Occhino, 2011,
p. 184.
295
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
considerato che questa revisione è emersa sul precipuo versante
delle professioni intellettuali, allo scopo di far fronte ai peculiari
problemi della responsabilità medica (348), con esiti quantomeno
problematici e forse non del tutto generalizzabili.
Con ciò non si vuol dire che un “risultato” sia escluso nell’obbligazione di comportamento, ma solo che esso andrà qui “mediato” dalla diligenza professionale. Del resto, il paziente del
medico nutre un’aspettativa giuridicamente tutelata a godere di
una buona cura, considerate tutte le circostanze del caso, affinché
possa vedersi garantita la possibilità di una guarigione (o del
massimo prolungamento della vita, nel caso di malattie inguaribili), ma non la guarigione certa, così come il cliente dell’avvocato
non potrà mai vedersi assicurata la vittoria della causa.
Proprio per questo, nel ristorare, ad esempio, il danno da
perdita di chance occorso al cliente del « legale negligente, dimentico di depositare l’appello prima del decorso del termine », potrà
essere risarcita solo la perdita della possibilità di ottenere il risultato utile, ma non il risultato utile in sé (349).
Probabilmente, in campo medico, la giurisprudenza è stata
mossa verso simili arresti dall’esigenza di instaurare un onere probatorio più favorevole al paziente, con un sostanziale irrigidimento
dei criteri di responsabilità, data la considerazione del bene “salute”
qui in discussione. Tant’è che, poi, con riguardo alla professione forense, sono prevalsi atteggiamenti assai meno lontani dalla tradizione (350).
Possiamo, allora, concludere con l’osservazione secondo cui
l’art. 2104, 1° comma, e gli artt. 1175-1375 c.c. hanno funzioni,
meccanismi operativi, nonché ambiti applicativi diversi e, pertanto, non sono destinati a sovrapporsi.
(348) Cfr. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, in GI, 2008, p. 2197 ss., con nota
di Cursi; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781, in DPL, 2006, p. 404 ss.; Cass., Sez. Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533, in GC, 2002, I, p. 1934 ss.; in tema di responsabilità medica ex art.
1218 c.c. v., da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 17 aprile 2014, n. 8940, in CED Cass., 2014; Cass.
civ., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4030, in GI, 2013, p. 2514 ss., con nota di Valore; ma per
una incrinatura di tale consolidato orientamento, v., da ultimo, Trib. Milano, 17 luglio 2014,
in DR, 2015, 1, p. 47 ss., con nota di Mattina.
(349) Gragnoli, 1997, p. 625 s.
(350) Cass. civ., 11 agosto 2005, n. 16848, in CED Cass., 2005; Cass. civ., 14 novembre
2002, n. 16023, MGI, 2002; Cass. civ., 5 luglio 2004, n. 12273, in GI, 2005, I, p. 1409 ss., con
nota di Perugini.
296
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
La diligenza dell’art. 2104, 1° comma, c.c. è deputata a intervenire sull’obbligo primario di prestazione del lavoratore debitore,
già individuato e definito nel suo contenuto al momento dello
scambio dei consensi, fungendo, così, da criterio oggettivo di
misurazione dell’esatto adempimento (351), dunque, da metro
valutativo di qualsivoglia contegno anche solo strumentale al
soddisfacimento dell’interesse del datore di lavoro creditore alla
prestazione di lavoro, con un’evidente rilevanza ai fini del giudizio
di responsabilità ex artt. 1218 e 2106 c.c.
La correttezza e la buona fede degli artt. 1175 e 1375 c.c. sono,
invece, chiamate a costituire obblighi secondari di protezione a
carico del lavoratore debitore (ma anche del datore di lavoro
creditore) per via d’integrazione degli effetti dello stesso contratto,
e a stabilirne il contenuto sulla scorta del rinvio a parametri di
moralità sociale, mentre è, ancora una volta, la diligenza, quella
però dell’art. 1176, 1° comma, c.c. — quale generale criterio di
misurazione dell’esatto adempimento dell’obbligazione del debitore — a fungere da metro valutativo dei relativi contegni strumentali al soddisfacimento dell’interesse di protezione del datore
(ma anche del lavoratore, qualora si tratti di obblighi di protezione
gravanti sul primo), ogni qualvolta tali contegni assumano contenuto positivo (352) e se ne debbano individuare le corrette modalità di svolgimento, con altrettanta rilevanza ai fini del giudizio di
responsabilità ex artt. 1218 e 2106 c.c. (353).
8. Segue: l’obbedienza e il potere direttivo.
Se il 1° comma dell’art. 2104 e gli artt. 1175-1375 c.c. si
“spartiscono”, per così dire, il campo nell’ambito delle posizioni
(351) Carabelli, p. 47; Cester, 2007, p. 92 s.
(352) Come precisa, infatti, Mengoni, 1954, p. 368, nt. 12, « gli obblighi di protezione
hanno uno scopo puramente negativo, (...) ma non per questo il loro contenuto è necessariamente negativo ».
(353) Rodotà, 1964, p. 3, che correttamente osserva come la buona fede costituisca
« il criterio in base al quale si determina il contenuto della prestazione: la diligenza verrà in
questione unicamente come criterio di valutazione del comportamento del debitore, tenuto
a quella prestazione già individuata »; nella dottrina lavoristica Cester, 2007, p. 97; Viscomi,
1997, p. 275; contra, nella dottrina civilistica, Breccia, 1968, p. 87, ma sulla scorta di una più
generale critica alla funzione integrativa del contratto attribuita alla buona fede.
297
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
passive del prestatore, procedendo in parallelo lungo i binari
segnati dall’obbligo primario di prestazione e, rispettivamente,
dall’obbligo secondario di protezione, non così è quando si passa ad
esaminare il 2° comma, dell’art. 2104 c.c. Il dovere di obbedienza
ivi contemplato, in quanto « proiezione passiva dell’esercizio del
potere direttivo », presenta una struttura soggettiva autonoma
rispetto all’obbligo di prestare lavoro, perché, dipendendo dall’esercizio del correlativo potere », attiene allo svolgimento della
prestazione e, quindi, all’attuazione del rapporto (354).
Peraltro, esso copre un’area più ampia di quella collegata al
mero esercizio dell’attività lavorativa, come ben dimostra il riferimento dell’art. 2104, 2° comma, c.c. al dovere di osservare non
solo « le disposizioni per l’esecuzione », bensì anche « per la disciplina del lavoro ». Pure ciò è un riflesso della connotazione del
dovere di obbedienza alla stregua di “rovescio” del potere direttivo
datoriale, che inerisce all’attuazione dell’obbligo principale di prestare l’attività lavorativa, ma altresì alla più generale gestione
dell’impresa e della vita collettiva del personale al suo interno.
Benché riconducibile a un unico fondamento contrattuale e
ricostruibile in senso unitario, come potere giuridico al cui rispetto
il lavoratore è tenuto in relazione alla (sola) circostanza dell’esecuzione dell’attività lavorativa (355) — sicché la violazione delle
disposizioni impartite per suo tramite darà comunque luogo a
inadempimento (356), riguardino esse l’esecuzione ovvero la disciplina del lavoro — si è giustamente insistito, da ultimo, sul
distinguo tra un potere direttivo stricto sensu inteso, che potremmo
ritenere inerente all’attuazione del lavoro, e un potere più latamente organizzativo, destinato a preservare la dimensione organizzativa dell’impresa e a disciplinare l’ordinato svolgimento della
vita aziendale (357).
(354) Grandi, 2004, p. 725 ss., spec. p. 746 s.
(355) Persiani, 1966, p. 198, criticamente rispetto alla tesi di Suppiej, 1963, II, p. 73
circa la « esistenza di poteri del datore di lavoro che prescindono dall’esecuzione dell’attività
lavorativa e che ad esso sarebbero attribuiti come titolare dei diritti di godimento sui beni
organizzati ».
(356) Persiani, 1966, p. 197.
(357) V. Pantano, 2012, p. 62 ss., spec. p. 64 s., che parla di « potere direttivo in senso
proprio », riconoscendogli la funzione di individuare l’oggetto dell’obbligazione, nell’ambito
di una ricostruzione di quest’ultima come obbligazione di risultato, e potere « di conforma-
298
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Quando il potere direttivo si presenta nella prima forma, esso
è diretto a specificare, conformare, organizzare i modi di adempimento dell’obbligo principale di prestare lavoro, facendo penetrare
al suo interno l’interesse dell’impresa ai fini del soddisfacimento
dell’aspettativa alla prestazione del datore. A tal stregua, la direzione e le disposizioni dell’imprenditore potranno volgersi a specificare i compiti volta a volta richiesti tra quelli rientranti nelle
mansioni oggetto del contratto (funzione specificativa); potranno
orientarsi a individuare le modalità tecniche o spazio-temporali a
cui il prestatore dovrà adeguarsi (funzione conformativa) ovvero
indicare i soggetti cui il prestatore sarà tenuto effettivamente a
rispondere (funzione di organizzazione gerarchica) (358).
L’inosservanza di tali disposizioni e, dunque, del dovere di
obbedienza, potrà comportare, in certi casi, la violazione della
stessa regola di diligenza, con la quale il dovere di obbedienza è
chiamato ad articolarsi, siccome destinato a inverare quell’interesse dell’impresa al quale la diligenza medesima va commisurata.
Ciò può accadere, ad esempio, quando il lavoratore svolga comunque l’attività lavorativa, ma senza il rispetto delle direttive, oppure senza coordinarsi con i suoi colleghi ed i superiori, sicché non
v’è dubbio che egli potrà ritenersi inottemperante (non all’obbligo
di prestare, ma) al dovere di tenere una condotta diligente (359).
Diversamente, potrà dirsi, invece, quando il prestatore rifiuti del
tutto l’esecuzione del lavoro imposta dal datore per il tramite di
specifiche direttive oppure si opponga, ad esempio, ad un trasferimento geografico, disattendendo così allo svolgimento delle opere
negozialmente convenute. A tal stregua, egli si sottrarrà ai suoi
doveri contrattuali, facendo mancare del tutto la prestazione,
sicché si configurerà un’ipotesi di vero e proprio inadempimento
dell’obbligazione di prestare lavoro.
zione », destinato ad agire sulle condotte del lavoratore per « provvedere alla regolarità e
correttezza della vita aziendale ». Cfr. anche Carabelli, 2004, p. 25 ss.
(358) Mattarolo, 2007, p. 287.
(359) V’è allora da chiedersi se possa ritenersi davvero diligente il lavoratore che
presti in maniera tecnicamente ineccepibile la prestazione, ma senza il rispetto delle
direttive imprenditoriali: probabilmente, la risposta dovrebbe essere negativa, perché il
lavoratore in parola avrà posto in essere una condotta diligente dal punto di vista
professionale, cioè della natura della prestazione, ma non da quello dell’interesse imprenditoriale, destinato ad esprimersi proprio per il tramite del potere direttivo. Diversamente
però Mengoni, 1965, p. 475.
299
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Le cose cambiano qualora il potere si presenti in forma più
latamente organizzativa, siccome destinato a preservare la dimensione produttiva dell’impresa e l’ordinato svolgimento della vita
aziendale. Qui le disposizioni imprenditoriali appaiono dirette a
regolamentare aspetti riconducibili all’adempimento dell’obbligo
secondario di protezione (360), giacché connessi a esigenze di
salvaguardia dell’organizzazione, dal punto di vista statico (della
custodia di beni, strumenti, ecc.), dinamico (della conservazione
delle posizioni di mercato) e gestionale (del rispetto del buon
funzionamento dell’organizzazione, nella sua dimensione gestionale del lavoro e della convivenza tra persone) (361).
Come dunque può comprendersi, il mancato rispetto del dovere di obbedienza non ha rilievo autonomo rispetto all’inosservanza degli obblighi di prestazione e protezione, già ricollegabili
agli artt. 2094 e 2104, 1° comma, e rispettivamente, agli artt. 2105
c.c., 1175 e 1375 c.c., nonché alla relativa contrattazione collettiva.
Questa, almeno sul versante degli obblighi di protezione, è solita
già da sé ampliare la posizione di vincolo gravante sul lavoratore
con l’introduzione di clausole contenenti doveri e situazioni passive
ulteriori rispetto a quelle dell’art. 2105 c.c. Benché la prevalente
dottrina non revochi in dubbio la validità di simili clausole, ci si è
interrogati su tale fenomeno, che importa un allargamento del
potere organizzativo imprenditoriale, sul presupposto evidentemente che il contenuto dell’art. 2105 medesimo non sia esaustivo,
né vincolante, con conseguente possibilità di introdurre doveri
accessori ulteriori a carico del lavoratore, assai « più prossimi al
concetto tecnico di fedeltà esistente nel diritto delle persone » (362)
e, quindi, lontani dallo stesso significato di correttezza e buona
fede qui accolto.
Di certo, invece, rappresenta un limite al potere direttivo
l’esistenza di obblighi di protezione a carico (anche) del datore di
lavoro, la cui inosservanza può determinare il ricorso del lavora(360) Tant’è che anche chi non parte dalla teoria dei doveri di protezione, parla
comunque di « esigenze di convivenza imposte dall’organizzazione oppure a tutela del
patrimonio aziendale »: Liso, 1982, p. 56, nt. 62.
(361) Per l’impostazione tradizionale, invece, ribadita di recente in Pantano, 2012, p.
62, il potere conformativo sarebbe finalizzato a garantire il sostrato della prestazione: v.
anche Napoli, 1980, passim; Montuschi, 1973, p. 42.
(362) Tullini, 1988, p. 991.
300
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tore all’eccezione di inadempimento nei limiti di cui all’art. 1460,
2° comma, c.c. La tesi, già affermata con riferimento all’inottemperanza del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. (v. retro, § 5),
dovrebbe essere sostenuta, in linea generale, anche per l’ipotesi di
inadempimento del dovere di garanzia della professionalità del
lavoratore, parimenti riconducibile all’area della salvaguardia del
prestatore nella sua dignità personale, dunque, al novero degli
obblighi di protezione facenti capo al datore (363). Andrebbe forse
rimeditata la tesi secondo cui il demansionamento, non costituendo « inadempimento delle obbligazioni fondamentali del datore di lavoro », è inidoneo a legittimare il rifiuto di eseguire
mansioni dequalificanti, ogni qualvolta il datore assolva tutti gli
altri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione, comunque, del posto di lavoro,
ecc.). Per questa tesi, una parte potrà rendersi inadempiente ex art.
1460 c.c. « soltanto se è totalmente inadempiente l’altra parte e non
quando vi sia potenziale controversia solo su di un’obbligazione,
(...) oltretutto non incide(nte) (come, invece, avviene per la retribuzione) sulle immediate esigenze vitali del lavoratore » (364).
Il ragionamento muove dalla condivisibile esigenza di limitare
ai casi più seri il ricorso al 1° comma, dell’art. 1460 c.c., ma finisce
per accreditare l’idea secondo cui l’inadempimento di obbligazioni
secondarie riveste tendenzialmente una gravità minore e non
possa, di regola, legittimare la sospensione della prestazione principale. A tale idea si è, però, giustamente replicato che il 2° comma,
dell’art. 1460 c.c., nell’escludere l’impiego dell’exceptio ove « il
rifiuto sia contrario alla buona fede », richiede non un giudizio di
proporzionalità fra gli inadempimenti, bensì una valutazione complessiva dello scostamento dal programma negoziale originario,
realizzatosi per effetto del mancato adempimento di una delle
(363) V. Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10157, in LG, 2004, p. 1265 ss., con
nota di Girardi; Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2006, n. 4975, in MGI, 2006; Cass. civ., sez. lav.,
18 maggio 2012, n. 7963, in CED Cass., 2012; Cass. civ., sez. lav., 2 gennaio 2002, n. 10, in
RIDL, 2003, II, p. 58, con nota di Quaranta. In dottrina Luciani, 2007, p. 49.
(364) Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 2007, n. 10547, in Ragiusan, 2007, 281-282, p. 290
ss.; Cass. civ., sez. lav., 23 dicembre 2003, n. 19689, in LG, 2004, p. 1169 ss., con nota di
Dallacasa; Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 1998, n. 1307, in MGI, 1998; Cass. civ., sez. lav.,
16 gennaio 1996, n. 307, in RIDL, 1996, II, p. 536 ss., con nota di Saisi; contra Cass. civ., sez.
lav., 28 luglio 2000, n. 9957, in CED Cass., 2000; Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 1999, n. 6663,
ivi, 1999; Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 1996, n. 8939, ivi, 1996.
301
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
parti (365), pertanto a nulla rilevando il carattere primario o solo
accessorio dell’obbligazione rimasta inadempiuta.
Limiti al potere direttivo, espressione dell’obbligo di protezione facente capo al datore, derivano anche in materia di determinazione del periodo di riposo annuale del prestatore. La legge
stabilisce il diritto di quest’ultimo a usufruire del menzionato
riposo nel tempo stabilito dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’imprenditore
ha, così, da un lato, l’obbligo di concedere le ferie al lavoratore,
impegnandosi a non beneficiare della sua prestazione per un certo
periodo, che il decreto legislativo n. 66 del 2003 fissa in almeno
quattro settimane all’anno; dall’altro, gode di un potere di fissarne
la collocazione temporale (366), essendo in linea di principio vietata la c.d. autoassegnazione delle ferie ad opera del prestatore
medesimo (367).
La legge stabilisce un termine finale per l’adempimento dell’obbligo di concedere le ferie al lavoratore, considerato che queste
vanno godute « per almeno due settimane, (...) nel corso dell’anno
di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine » di quell’anno, salvo diversa disposizione
dell’autonomia collettiva (368). Non impone, invece, al datore di
esercitare il proprio potere determinativo di collocazione del riposo
entro tempi ragionevoli, in rapporto al vantaggio che la controparte ne deve trarre, pur stabilendo un dovere di comunicazione
preventiva al prestatore di lavoro del periodo di godimento delle
ferie.
(365) Ferrante, 2004, pp. 153 ss. e 281 ss.
(366) Per Trib. Milano, 18 febbraio 2004, in RCDL, 2004, p. 657 ss., con nota di
Bacciola, è, tuttavia, « illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento
delle ferie da parte del datore di lavoro, allorché il Ccnl preveda che il calendario delle ferie
debba essere definito con le Rsu », per una recente rassegna giurisprudenziale cfr. Ponte,
2014, p. 1205 ss., spec. p. 1215 ss.
(367) Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 1994, n. 175, in RIDL, 1994, II, p. 710 ss., con
nota di Pizzoferrato; Cass. civ., sez. lav., 7 maggio 1992, n. 5393, in MGL, 1992, p. 492 ss.;
più di recente, Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 2008, n. 9816, in MGI, 2008; Trib. Udine, 2
maggio 2013, in ADL, 2014, pp. 790 ss., con nota di Galletti.
(368) Sia pur con riferimento alla disciplina previgente, v. Cass. civ., sez. lav., 24
ottobre 2000, n. 13980, in RIDL, 2001, II, p. 504 ss., con nota di Calafà, secondo cui le ferie
annuali vanno godute nel termine previsto dalla legge, sicché il datore di lavoro non può
pretendere che il lavoratore ne goda successivamente, essendo piuttosto tenuto al risarcimento del danno per mancata fruizione delle stesse.
302
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Potrebbero, allora, soccorrere a riguardo la correttezza e la
buona fede. Queste, intese come clausole impositive di un vincolo,
a carico di ciascuna parte, « di salvaguardare l’utilità dell’altra nei
limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio a suo
carico » (369), ben sarebbero idonee a fondare un obbligo dell’imprenditore di comunicare la collocazione delle ferie « con quel
preavviso che consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente » il proprio tempo-libero (370). Lo stesso potrebbe dirsi a
proposito dello spostamento del periodo di riposo annuale, già
determinato ex ante. La giurisprudenza afferma la legittimità di
tale spostamento (371), ma bisognerebbe quantomeno pretendere
dal datore un comportamento ispirato a correttezza e buona fede,
sicché ogni modifica del “piano ferie” preventivamente fissato
dovrebbe intervenire in tempi utili a permettere al lavoratore di
programmare la gestione delle sue ferie nella maniera più vantaggiosa, così come qualsiasi obiezione del prestatore stesso alla modifica introdotta dall’azienda dovrebbe pervenire tempestivamente a quest’ultima, essendo lo stesso prestatore investito di un
dovere di corretto comportamento.
Sotto altro profilo, se la legge richiede che la determinazione
del periodo feriale avvenga ad opera dell’imprenditore, ma sulla
scorta della valutazione comparativa delle diverse esigenze aziendali e del lavoratore (372), le clausole generali ora menzionate
(369) Bianca, 1983, p. 210.
(370) Trib. Milano, 12 dicembre 2005, in OGL, 2006, p. 142 ss.; v. anche Trib. Milano,
17 gennaio 2002, in RCDL, 2002, p. 413 ss., con nota di Bulgarini D’Elci, che ha ritenuto
contrario a correttezza e buona fede il « lungo, (...) irragionevole e immotivato silenzio del
datore di lavoro alla richiesta di ferie avanzata con congruo anticipo dal prestatore ».
(371) Addirittura sarebbe legittima anche la modifica unilaterale, che sopravvenga
alla determinazione concordata delle ferie imposta dalla contrattazione collettiva, secondo
Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2000, n. 1557, in MGL, 2000, p. 637, con nota di Stanchi.
(372) Per Pret. Milano, 20 gennaio 1999, in RCDL, 1999, p. 359 ss., « è illegittima la
determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore allorché
non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate
esigenze organizzative aziendali »; tuttavia, secondo Mattarolo, 2012, p. 670, nt. 837 è
censurabile la tesi di Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2000, n. 1557, cit., secondo cui l’obbligo
dell’imprenditore di tener conto degli interessi del lavoratore comporterebbe per quest’ultimo il dovere di « palesarli all’atto della fissazione (...) del periodo feriale in modo che il
primo possa valutarli al fine della decisione da parte del lavoratore »; se così è, potrebbe,
allora, ritenersi altrettanto criticabile la teoria espressa da Trib. Milano, 17 gennaio 2002,
cit., secondo la quale anche il datore dovrebbe palesare i motivi del mancato accoglimento
303
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
imporrebbero, a propria volta, di dare una prevalenza all’interesse
del lavoratore medesimo, almeno nella misura in cui ciò non
comporti un apprezzabile sacrificio a carico dell’impresa (373). Da
tal punto di vista, è solo parzialmente appagante quella giurisprudenza, la quale si limita a sostenere che « l’esatta determinazione
del periodo feriale », in forza di una comparazione tra i vari
interessi coinvolti, « spetta unicamente all’imprenditore quale
estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa », « mentre al lavoratore compete la mera facoltà di
indicare il periodo entro il quale intenda fruire del riposo annuale » (374).
9. Segue: ipotesi applicative.
È alla luce della ricostruzione sin qui proposta, specie del
rapporto tra clausole generali e diligenza, che vanno ora individuati e sinteticamente vagliati i modelli di comportamento, nonché le relative norme sociali di condotta individuati dalla giurisprudenza in sede di “concretizzazione” delle clausole generali sul
versante del prestatore di lavoro.
9.1. Comportamenti diretti all’adempimento della prestazione.
Lungo questa strada, spicca, intanto, un primo gruppo di
pronunce, ove i giudici procedono a valutare condotte, le quali
appaiono, per la verità, difficilmente comprendibili nell’area governata dagli artt. 1175 e 1375 c.c., come pure in quella presidiata
dall’art. 2104, 1° comma, c.c. Così è, ad esempio, per le ipotesi di
della richiesta di ferie formulata dal prestatore; sul tema, in dottrina, Ichino, 2003, p. 430
ss., spec. p. 432.
(373) Invece, per l’insufficienza della tecnica normativa per clausole generali a
garantire l’effettività del diritto alle ferie v. Bavaro, 2008, p. 264 ss.; valorizza, al contrario,
l’idea secondo cui il potere di determinare le ferie « dovrà comunque essere esercitato
secondo criteri di correttezza e buona fede » Occhino, 2010, p. 104; ancora più recentemente,
Testa, 2012, p. 78 ss.; nella manualistica cfr. Carinci F., De Luca Tamajo, Tosi, Treu, 2013,
p. 247.
(374) Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 1988, n. 4198, in MGL, 1988, p. 474 ss.; Cass. civ.,
sez. lav., 12 giugno 2001, n. 7951, in LG, 2002, p. 56 ss., con nota di Ferraù; Cass. civ., sez.
lav., 26 luglio 2013, n. 18166, in ADL, 2014, p. 295 ss., con nota di Caponetti.
304
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
fraudolenta timbratura del cartellino (375), di simulazione della
malattia con presentazione di falso certificato medico (376), di
mancata reperibilità alla visita medica di controllo disposta dal
datore (377), tutte idonee a dar luogo a un’assenza ingiustificata
del lavoratore, suscettibile di essere qualificata alla stregua di vero
e proprio inadempimento dell’obbligazione principale di prestare
lavoro. Lo stesso può concludersi per il comportamento doloso
consistito nell’omessa consegna della posta da parte di un portalettere, nella cui borsa erano state rinvenute alcune raccomandate
aperte, che dagli atti dell’ufficio risultavano regolarmente consegnate ai destinatari (378). V’è proprio bisogno di scomodare « la
lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del
prestatore di lavoro », in uno con « i più basilari principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro » per
ricondurre un simile contegno nel novero della giusta causa di
licenziamento o non è, invece, sufficiente sottolinearne, a rigore, la
natura di inadempimento dell’obbligo contrattuale di prestare
lavoro assunto ex art. 2094 c.c.?
9.2. Comportamenti diretti all’adempimento di compiti complementari e strumentali.
Un secondo gruppo di pronunce riguarda la valutazione di
condotte collegate allo svolgimento di compiti complementari e
strumentali, detti anche “accessori”, rispetto alle mansioni di
assegnazione. La giurisprudenza li ha generalmente ritenuti “esigibili” dal datore, ma sulla scorta di argomentazioni non sempre
limpide e univoche.
Anche qui pare che il problema meriti soluzione al di fuori dei
confini tracciati dagli artt. 1175, 1375 e 2104, 1° comma, c.c.,
precisamente, sul piano della individuazione dell’oggetto del contratto. Non è, forse, necessario affidarsi alla categoria degli « ob(375) Pret. Milano, 23 aprile 1986, in OGL, 1986, p. 752.
(376) Cass. civ., sez. lav., 22 ottobre 1998, n. 10514, cit.
(377) Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2002, n. 15773, in GC, 2002, I, p. 3054; Cass.
civ., sez. lav., 11 agosto 1993, n. 8612, in MGC, 1993, p. 1276; TAR Reggio Calabria, 25
novembre 2002, n. 1781, in GM, 2003, p. 562.
(378) Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre 2013, n. 22791, in LG, 2014, p. 367 ss., con nota
di Garofalo C.
305
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
blighi integrativi strumentali », frutto, secondo alcune teorie, di
un’integrazione del contratto alla stregua della clausola di buona
fede (379), per sostenere la natura obbligatoria di simili contegni (380). Ciò balza all’evidenza se si considera che la « “professionalità rappresentata in una qualifica, contiene”, oltre ai compiti ed
alle operazioni esplicitate contrattualmente, altri compiti “interni”, immediatamente preparativi o inscindibilmente connessi
con quelli esplicitamente caratterizzanti”. (...) L’identificazione
della prestazione dovuta per via del riferimento alle mansioni di
assegnazione non esclude », dunque, « l’adempimento di compiti
“immediatamente preparatori”, “inscindibilmente strumentali” o
“interni”, quand’anche non espressamente previsti in sede di individuazione dell’oggetto contrattuale » (381).
Così stando le cose, il problema diventa, allora, « quello di
individuare esattamente l’area complessiva o globale di atti dovuti » (382), in quanto ricompresi nel vincolo obbligatorio primario, quindi, nelle mansioni negozialmente convenute e, come tali,
esigibili.
Dovendosi procedere a una ricostruzione del contenuto oggettivo dell’obbligazione di prestare lavoro, sarà la concreta organizzazione aziendale, in una con le normali modalità di adempimento
entro un tal contesto a costituire il punto di riferimento imprescindibile a riguardo (383). Il criterio della diligenza, nella sua funzione
di strumento valutativo dell’esattezza dell’adempimento dell’obbligo principale, interverrà solo dopo, per misurare l’idoneità della
condotta del debitore prestatore, incluso quella relativa allo svolgimento di compiti complementari e strumentali, al soddisfacimento dell’interesse dell’imprenditore creditore (384).
(379) Sulla scorta della dottrina tedesca, cfr. Betti, 1953, p. 96 ss.; Mancini, 1957, p.
81 ss. ed altresì Mengoni, 1954, pp. 203 e 370, che, tuttavia, collega gli obblighi integrativi
strumentali ex art. 1375 alla diligenza, intesa come conservazione della possibilità di
adempiere; per una concezione della buona fede come clausola posta a presidio della
possibilità dell’esatto adempimento, v. da ultimo Ferrante, 2012, p. 151; Id., 2004, p. 43 s.
(380) Così, invece, più di recente, anche Mazzotta, 2008, p. 489.
(381) Viscomi, 1997, p. 276 s.
(382) Grandi, 1987, p. 341.
(383) Viscomi, 1997, p. 277.
(384) Ibidem, p. 277 s., « essendo (quelli complementari e strumentali) compiti
deducibili per via di una pertinente individuazione della prestazione dovuta in relazione alle
modalità normali di adempimento di un dato contesto organizzato, non è dunque nella
306
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Di questo la giurisprudenza non sembra, tuttavia, mostrare
piena consapevolezza, perché, se un lato, si concentra correttamente su un particolareggiato esame delle caratteristiche concrete
assunte dall’organizzazione del lavoro entro cui il prestatore è
inserito, sì da delimitarne esattamente la posizione debitoria (385),
dall’altro, inquadra detto esame nel contesto della diligenza (386).
Giunge così a imputare la doverosità dei compiti “accessori” all’art. 2104, 1° comma, invece che all’art. 2094 c.c., come, invece,
suggerirebbe un rigoroso inquadramento della tematica in parola
nell’ambito della ricostruzione del contenuto oggettivo dell’obbligazione di lavoro (387).
Interrogativi di un certo rilievo potrebbero, a questo punto,
concernere i rimedi correlati al mancato o inesatto svolgimento (a
stregua di diligenza) dei compiti summenzionati. Se si ritiene, come
si è fin qui sostenuto, che detti compiti siano parte integrante delle
mansioni oggetto del contratto, occorre concludere che il loro
difetto o la loro non esatta attuazione integri a ogni effetto gli
estremi dell’inadempimento della prestazione principale, senza
possibilità di distinguo alcuno rispetto all’adempimento dei restanti compiti (388).
regola formale di diligenza che si fonda l’obbligo del prestatore di eseguire compiti integrativi ».
(385) Pret. Cagliari, 25 settembre 1995, in DL, 1996, II, p. 45 ss., che ha ravvisato gli
estremi della insubordinazione nel rifiuto di un caporeparto di una tipografia ove si
stampava un quotidiano di svolgere l’operazione preliminare di avvio dei compressori,
necessaria ad assicurare il funzionamento dell’impianto e la pubblicazione del quotidiano
stesso, rinvenendo, alla luce delle modalità concrete di organizzazione del lavoro, l’esistenza
di un obbligo del prestatore « di attivarsi » a riguardo; Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 1992, n.
3845, in NGL, 1992, p. 496 ss., per l’esclusione di un obbligo di vigilanza a carico del
prestatore, siccome rientrante nelle mansioni di altri colleghi.
(386) Pret. Cagliari, 25 settembre 1995, cit.; Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 1992, n. 3845,
cit.; potrebbe, invece, effettivamente accedere all’area governata dalla diligenza la questione
decisa da Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 2000, n. 12769, in RIDL, 2001, II, p. 446 ss., con
nota di Nadalet, che ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al dipendente di banca per
aver dato corso a rilevanti operazioni di bonifico già autorizzate dal direttore di filiale senza
passare per la “prassi aziendale”, introdotta direttamente dai lavoratori, consistente nel riscontro telefonico di ogni operazione richiesta dai clienti a mezzo fax.
(387) Cfr. Grandi, 1987, p. 341, che opportunamente sottolinea come « la problematica degli obblighi integrativi non autonomi » si dissolva, così, nella ricostruzione del
contenuto oggettivo dell’obbligazione di lavoro »; v. anche Natoli, 1974, p. 18.
(388) È stato, pertanto, ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo
soggettivo del propagandista di prodotti medicinali, causato dal ritardo, nonostante le
307
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Qualche notazione va dedicata, però, alle modalità di esatta
individuazione delle condotte dovute in forza del vincolo contrattuale alla prestazione. V’è da interrogarsi soprattutto a proposito
di quell’orientamento giurisprudenziale, che esclude la doverosità
di certi comportamenti accessori nei confronti di un lavoratore,
qualora formino oggetto delle specifiche mansioni di altri colleghi (389). La tesi sembra corretta, potendosi in simili casi escludere, proprio alla luce di una precipua analisi dell’organizzazione di
lavoro, che detti compiti accedano a quelli propri della mansione
del primo prestatore. Ciò, tuttavia, non esime dal pretenderli in
taluni casi, (questa volta sì) a stregua di correttezza e buona fede
anche da coloro i quali non vi siano obbligati espressamente. Se si
ragionasse in modo diverso si rischierebbe di giungere a esiti
paradossali. Così è accaduto quando i giudici hanno ritenuto
illegittimo il licenziamento della terapista di un minore inabile, la
quale, sul presupposto che incombesse ai portantini prendere in
consegna il paziente per ricondurlo dalla palestra al luogo di
degenza, lo aveva lasciato privo di sorveglianza una volta terminata la cura, così consentendogli di impossessarsi di una serie di
« chiodini ad incastro » e ingerirne, in quel mentre, una gran
quantità (390).
Potrebbe anche consentirsi sul fatto che alla terapista non
spettasse vigilare il minore inabile fino all’arrivo dei portantini e
che la vicenda nascondesse un problema non irrilevante di organizzazione del lavoro inefficiente e insicura. Tuttavia, non v’è
dubbio come in forza dell’obbligo di protezione incombente (anche) sui prestatori (v. ora, del resto, l’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008),
la terapista avrebbe dovuto segnalare immediatamente il problema ed evitare di abbandonare il paziente, in spregio a qualsiasi
regola attingibile da parametri di moralità sociale. Del resto,
correttezza e buona fede sollecitano proprio comportamenti ispirati a solidarietà nei confronti della controparte; il che può anche
tradursi nello svolgimento di mansioni diverse, qualora sia necesripetute diffide, nell’invio alla sede della società di rapporti informativi circa la qualità e
qualità dei prodotti dei prodotti medicinali venduti, impedendo così la conveniente e
continua ricostituzione delle scorte di magazzino: Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 1995, n.
Cass. 12 luglio 2002, n. 10187, in RIDL, 2003,II, 53, con nota di Casciano
(389) Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 1992, n. 3845, cit.
(390) Ibidem.
308
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sario per venire incontro a improrogabili e contingenti esigenze
aziendali (391).
9.3. Comportamenti diretti alla conservazione di beni del datore
di lavoro in funzione della prestazione (dovere di custodia).
Qualche brevissima considerazione merita un terzo gruppo di
pronunce, relativo alla valutazione di comportamenti diretti alla
conservazione delle materie prime, della merce, degli strumenti di
lavoro forniti dal datore di lavoro per la prestazione. La giurisprudenza ne ha ravvisato la doverosità, intravvedendovi gli estremi di
un vero e proprio obbligo di custodia accessorio rispetto all’obbligazione principale di prestare l’attività lavorativa (392).
Siamo, dunque, nell’area governata dalla diligenza dell’art.
2104, 1° comma, c.c. (393), non in quella presidiata dalle clausole di
correttezza e buona fede, fonte di obblighi diretti al soddisfacimento dell’interesse alla protezione del creditore datore di lavoro
(e non alla prestazione).
Si è molto discusso circa la ripartizione dell’onere probatorio
conseguente alla violazione dell’obbligo in parola. È prevalsa l’idea
secondo cui il danneggiamento del bene sotto custodia costituisce
già in sé inadempimento; sicché al datore spetterebbe provare,
(391) Cfr. Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 2002, n. 10187, cit., la quale ha ritenuto
legittima anche l’adibizione del prestatore a mansioni non strettamente equivalenti, se ciò
« sia imposto da improrogabili esigenze aziendali »; v. anche Cass. civ., sez. lav., 4 luglio
2002, n. 9709, in GD, 2004, 1, p. 47 ss., per cui « la disposizione di cui all’art. 2103 c.c., che
tende a tutelare la professionalità del lavoratore, non impedisce che allo stesso possa essere
richiesto lo svolgimento di attività corrispondenti a mansioni inferiori, quando ciò avvenga
eccezionalmente e marginalmente, e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali »; sul
punto Ichino, 2003, p. 258; in generale sul tema delle mansioni, incluso quello, non del tutto
coincidente, però, con il presente, della legittimità di assegnazione a mansioni promiscue, v.
Brollo, 1997, p. 129 ss.
(392) Cass. civ., sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12758, in RIDL, 1996, II, p. 530 ss.,
con nota di Calafà; v. Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1986, n. 430, in MGI, ma per l’obbligo
di custodia gravante sul lavoratore autonomo.
(393) Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2008, n. 13530, in MGI, 2008; Cass. civ., sez. lav.,
13 dicembre 1995, n. 12758, cit.; Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2000, n. 6664, in MGI, 2000;
Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1991, n. 11107, ivi, 1991; Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1987,
n. 7861, ivi, 1987; Pret. Trieste, 18 maggio 1989, in NGL, 1990, p. 49 ss.; Cass. civ., sez. lav.,
3 giugno 1982, n. 3416, ivi, 1982, p. 349 ss.; Pret. Napoli, 30 novembre 1981, ivi, 1982, p. 17
ss.
309
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
oltre a ciò, solo l’esistenza di un rapporto di causalità « con la
materiale condotta (anche omissiva) del lavoratore », competendo
piuttosto a quest’ultimo la prova della propria diligenza, con
conseguente non imputabilità del fatto ex art. 1218 c.c. (394). Più
condivisibile sembra, tuttavia, l’orientamento opposto, atteso che
l’obbligo di custodia rientra a tutti gli effetti nell’obbligazione
principale di svolgere il lavoro (che è obbligazione di comportamento), quindi nella prestazione dovuta, di cui dovrà dimostrarsi
l’inesatto adempimento, proprio sulla scorta della prova relativa
alla sua negligente esecuzione (395).
9.4. Comportamenti diretti alla conservazione della propria persona in funzione della prestazione (dovere di cura della
propria salute).
Un quarto e più cospicuo gruppo di pronunce riguarda comportamenti tenuti dal prestatore in costanza di malattia e di per sé
suscettibili di incidere negativamente sulla sua guarigione in vista
della ripresa del lavoro.
Emerge così all’attenzione il tema, assai discusso, degli obblighi preparatori all’adempimento, intesi come condotte vincolanti,
aventi ad oggetto tutto quanto necessario a rendere possibile la
prestazione lavorativa, anche nella forma di un dovere del lavoratore di cura della propria persona.
Parte della dottrina ne ha affermato l’esistenza alla stregua di
obblighi autonomi; altra parte li ha sostanzialmente ricondotti
entro la regola della diligenza, da intendersi in senso conservativo.
In entrambe le ipotesi, se ne è rinvenuto il fondamento nella
correttezza o, rispettivamente, nella buona fede. Tuttavia, simili
ricostruzioni collidono con le tesi fin qui accolte e, pertanto, non
appaiono persuasive.
Si può, intanto, escludere che i menzionati obblighi abbiano
una qualche attinenza con l’area governata dalle clausole generali,
ove si collocano, invece, i soli doveri finalizzati alla realizzazione
(394) Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2008, n. 13530, cit.; v. anche Cass. civ., sez. lav.,
26 maggio 2000, n. 6664, cit.; Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1991, n. 11107, cit.
(395) Cass. civ., sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12758, cit.
310
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dell’interesse alla protezione del datore medesimo (396). Tra questi
può, certo, annoverarsi l’obbligo del prestatore di salvaguardare la
propria integrità psico-fisica ai sensi all’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008,
cui corrisponde, come reciproco, un dovere di sicurezza dell’imprenditore, volto, di regola, ad imporre un vincolo di sorveglianza
sanitaria del lavoratore a mezzo del medico competente. Non può,
invece, dirsi lo stesso per quel dovere di cura della propria persona
ricondotto entro gli obblighi preparatori all’adempimento. Esso è
da intendersi, infatti, nel senso della conservazione, da parte del
prestatore, della capacità psico-fisica di svolgere l’attività dedotta
in contratto, conservazione, che, in quanto funzionale al soddisfacimento dell’interesse alla prestazione del datore, trova il suo
corrispondente nel potere di controllo, esercitato dall’imprenditore
attraverso i medici della struttura pubblica (397).
Neppure può ipotizzarsi che i comportamenti generalmente
riportati nel novero dei c.d. doveri preparatori trovino la propria
“fonte” in una diligenza da intendersi secondo un’accezione propriamente conservativa. Ciò perché l’impegno del lavoratore volto
a garantire la possibilità di adempiere sembra, piuttosto, imporre
una serie di condotte direttamente riconducibili al dovere primario
di prestazione, più che alla regola di cui all’art. 2104, 1° comma,
c.c.
Se s’intende, infatti, « la prestazione dovuta come attività che
il debitore deve svolgere affinché sia procurata al creditore l’utilità
attesa, è indubbio che il contegno da assumere in fase di preadempimento non può essere considerato ad essa estraneo ed anzi la
integra nella misura in cui incide sul concreto procedimento di
produzione del risultato cui il rapporto tende »; mentre, a propria
(396) Diversamente potrebbe dirsi ovviamente qualora si facesse propria la tesi di
Persiani, 1966, p. 238, riaffermata nel caso degli obblighi preparatori da Proia, 1991, p. 836
ss. sull’esistenza, per il tramite della buona fede, di una nozione di fedeltà atta a ricomprendere nelle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro « tutti i comportamenti
necessari alla soddisfazione dell’interesse tipico del creditore valutato meritevole di tutela ».
(397) È noto, infatti, che se il datore sottopone il lavoratore a visita di idoneità per
tutelarne l’integrità psico-fisica, deve rivolgersi al medico competente (art. 41, 2° comma,
d.lgs. n. 81 del 2008); se invece ne vuole valutare l’effettivo stato di malattia, quindi,
l’impossibilità a prestare e il suo impegno a non ostacolare in alcun modo la subitanea
guarigione in vista della ripresa dell’attività lavorativa, farà riferimento ai medici della
struttura pubblica (art. 5 St. lav.).
311
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
volta, la diligenza funzionerà, come di consueto, da parametro
(esterno) di misurazione del corretto adempimento (398).
Non esistono, pertanto, obblighi preparatori autonomi da
quello primario, destinati per questa strada ad attrarre nella « sfera
del vincolo la totalità della vita umana » (399), ma comportamenti
doverosi, misurati a stregua di diligenza e volti ad assicurare la
possibilità di adempiere in rapporto al vincolo assunto con il
contratto di lavoro, siccome introiettati nel profilo genetico del
rapporto obbligatorio e qui espressi, nonché limitati dalla collaborazione (art. 2094 c.c.) (400).
Anche qui, il problema diventa, allora, quello di individuare
esattamente l’area degli atti dovuti in funzione dell’interesse del
datore alla prestazione. È stato osservato, a tal stregua, che il
vincolo obbligatorio primario non è riducibile « alla sola prestazione di lavoro in sé considerata » in relazione al solo interesse del
datore di lavoro, poiché vanno considerati pure gli interessi del
lavoratore, « ove questi ricevano una tutela preminente o non siano
sacrificabili rispetto all’interesse stesso a ricevere la prestazione. Il
problema, (però), è difficilmente risolubile in termini generali » e va
affrontato con riguardo alle singole fattispecie concrete, nonché
all’assetto reale degli interessi in gioco (401).
Intanto, è giusto sottolineare come nell’attuale ordinamento
non vi siano spazi « per la dilatazione dell’impegno contrattuale
fino a comprimere la dignità della persona e della sua dignità
(398) Viscomi, 1997, p. 259; V. anche Natoli, 1984, p. 83, che riconduce i doveri
preparatori a una nozione “lata” di prestazione, invocandone a sostegno, tra i diversi indici
normativi, anche quelli riguardanti la disciplina dell’infortunio in itinere. Detta disciplina,
come ben osserva Viscomi, 1997, p. 258, nt. 74, può essere invocata « per argomentare che
la regola di diligenza è misura e non fonte dei doveri preparatori ». Ciò è chiaramente
espresso dalla giurisprudenza quando nega l’indennizzabilità nel caso in cui il “dovere
preparatorio” di recarsi sul posto di lavoro sia stato realizzato esso stesso in modo negligente
(cfr. Corte conti, sez. IV, 2 aprile 1993, n. 8096, in RCC, 1993, p. 179)”, cioè attraverso l’uso
di mezzi privati e non, in presenza di condizioni ottimali, di mezzi pubblici; cfr. pure
Smuraglia, 1967, p. 121, che fa richiamo alla diligenza allo scopo di valutare il comportamento del prestatore in fase preparatoria.
(399) Napoli, 1980, p. 177.
(400) Viscomi, 1997, p. 258; v. anche Natoli, 1984, p. 90, secondo il quale, per
valutare il comportamento nella fase preparatoria, appare evidente che il limite è costituito
dal « margine d’incidenza dell’attività sul concreto procedimento di produzione del risultato »; insiste molto sulla questione anche Smuraglia, 1967, p. 235 ss.
(401) Grandi, 1987, p. 341.
312
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
personale » (402). È stato osservato che « l’interesse del creditore
cede infatti di fronte al diritto della persona al libero e pieno
dispiegarsi delle sue potenzialità vitali, nel corso del tempo di
non-lavoro (403).
A partire da tale premessa, se si prescinde dall’ipotesi in cui il
lavoratore con dolo si procuri l’infermità per porsi nell’impossibilità di lavorare, ipotesi evidentemente qualificabile come inadempimento (404), occorrerà distinguere tra i vari casi.
Così in dottrina si è ritenuto legittimo il comportamento del
lavoratore che nel tempo libero si dedichi all’esercizio di qualsiasi
attività ludica o sportiva anche particolarmente pericolosa (volo in
deltaplano, pesca subacquea a grandi profondità, difficili arrampicate in montagna, ecc.), ma non invece quello del prestatore
impedito nel lavorare da uno sciopero del personale ferroviario
debitamente preannunciato, di cui non aveva tenuto conto nel
programmare i propri spostamenti del fine-settimana (405).
La questione del rapporto « tra l’interesse dell’imprenditore al
corretto adempimento della prestazione di cui è creditore e la
libertà di godimento da parte del lavoratore dei diritti irrinunciabili » (406) inerenti alla propria esistenza si è posto analogamente
anche con riferimento alle pause di lavoro, in particolare, alle
ferie (407).
Alcuni arresti giurisprudenziali sono apparsi particolarmente
problematici: così è stato quando i giudici, proprio invocando gli
artt. 1175 e 1375 c.c., hanno sancito la legittimità del licenziamento di un dirigente bancario della Caripe S.p.A., che si era
recato a trascorrere il periodo di ferie in Madagascar, anche per
esigenze di cura della madre ammalata, così assumendo, a detta dei
magistrati, un rischio elettivo particolarmente elevato rispetto
all’insorgenza della malaria, poi effettivamente contratta, con
ripetute e lunghe assenze dal posto di lavoro per malattia (408).
(402) Napoli, 1980, p. 177; Smuraglia, 1967, p. 337.
(403) Ichino, 2003, p. 282.
(404) Napoli, 1980, p. 178; Pandolfo, 1991, p. 111 nt. 92
(405) Ichino, 2003, p. 282.
(406) Proia, 1991, p. 832.
(407) Sul punto Mancini, 1957, p. 155 ss. sottolinea come l’obbligo di conservarsi in
buona salute non possa giungere a pregiudicare il diritto alle ferie e ai riposi.
(408) Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2011, n. 1699, cit.
313
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Altre volte, la giurisprudenza è sembrata più equilibrata: così
è stato allorché ha stabilito la legittimità del recesso intimato ad un
pilota d’aereo che, in periodo di assenza dal servizio, aveva svolto
attività di volo per altra società. Ciò sul presupposto che « la
prestazione lavorativa in favore di terzi, durante i periodi di ferie
o riposi, è sanzionabile ove pregiudichi l’attitudine fisio-psichica
del pilota medesimo a rendere la propria prestazione lavorativa
senza pericoli per la sicurezza del volo » (409). Come si vede, qui i
magistrati, tralasciando ogni improprio richiamo alle clausole di
correttezza e buona fede, hanno non solo dato spazio ad una
verifica della conformità del comportamento preadempiente rispetto alla utilità attesa dal datore di lavoro creditore, ma anche
valutato il comportamento medesimo alla luce della diligenza
richiesta dalla natura della prestazione.
Così dovrebbe essere, allora, anche ove si venisse, ad esempio,
a giudicare la condotta del medico, il quale si ubriacasse il giorno
prima di un’importante intervento chirurgico. Non è un caso che
proprio con riguardo all’abuso di alcool o di stupefacenti, la giurisprudenza si sia orientata nel senso di non considerarlo elemento
sufficiente a giustificare il licenziamento, neppure in presenza di
abitualità o dipendenza dalle sostanze (410), salvo però che « la
natura della prestazione (vi) sia radicalmente incompatibile (...)
(come nel caso del pilota d’aereo, conducente di treno, guidatore di
automezzo, o altri casi analoghi) » (411).
Si diceva, ad ogni modo, di come la gran parte delle pronunce
giurisprudenziali abbia trattato il tema qui in discussione soprattutto sotto il profilo dei comportamenti tenuti dal lavoratore nel
corso della malattia. Qui il discorso assume tratti diversi, perché
qui l’interesse del datore all’adempimento della prestazione rileva
nel senso di un interesse alla verifica sia dell’effettivo stato di
impossibilità sopravvenuta del prestatore allo svolgimento dell’at(409) Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 1990, n. 11657, cit.
(410) Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2001, n. 7192, in RIDL, 2002, II, p. 205 ss., con
note di Ichino e Pallini.
(411) Ichino, 2003, p. 282, il quale, peraltro, sostiene l’esistenza di un obbligo
contrattualmente dovuto di disintossicazione; ma la questione può essere controversa,
considerato che neppure può ravvisarsi con certezza un obbligo di adoperarsi per la
guarigione; v. comunque per i controlli in materia di sicurezza su alcool e tossicodipendenza
Pascucci, 2014, p. 1 ss.
314
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tività, sia della tenuta, ad opera del prestatore stesso, di comportamenti tali da non prolungare oltremodo detta impossibilità.
Nella materia si registra un amplissimo richiamo agli artt. 1175
e 1375, in combinato disposto con gli artt. 2104 e 2105, al fine di
accreditare l’idea, sintetizzata in un’ormai tralatizia formula, secondo cui « lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del
dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del
datore in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza
e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé
sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui
la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla
natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o
ritardare la guarigione o il rientro in servizio » (412).
A simili arresti la giurisprudenza è approdata da tempo, una
volta abbandonata la più restrittiva tesi, volta a configurare lo
svolgimento di altra occupazione in costanza di malattia quale
contegno di per sé illegittimo alla luce di una buona fede intesa in
senso pregnante, come fedeltà nei confronti dell’imprenditore. Per
effetto di tale “nuovo corso”, il dedicarsi del lavoratore ammalato
ad altri lavori non è più elemento idoneo a pregiudicare il vincolo
fiduciario, ma diviene circostanza al pari di altre (esercizio di
attività sportiva, ricreativa, ecc.), suscettibile di verifica quanto
alla sua compatibilità con lo stato patologico in essere.
Non si creda, tuttavia, che le reminiscenze del passato siano
scomparse. Lo dimostra lo stesso perdurante richiamo agli artt.
1175 e 1375, tuttora abbinati all’art. 2105 c.c. nella cornice di un
ragionamento che lega un po’ approssimativamente il tema della
simulazione della malattia al problema dello svolgimento di altra
attività lavorativa idonea a ritardare la guarigione. Sicché non è
chiaro se le decisioni dirette a confermare la legittimità del licenziamento per avere il prestatore atteso ad altre occupazioni siano
davvero fondate sulla « ritenuta idoneità del comportamento contestato a ritardare la guarigione, o non piuttosto sulla convinzione
(412) Cass. civ., sez. lav., 14 settembre 2012, n. 15476, cit.; Cass. civ., sez. lav., 8
marzo 2013, n. 5809, in CED Cass., 2013; Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2013, n. 4559, ivi,
2013; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2012, n. 21253, in GD, 2013, p. 73; Cass. civ., sez. lav.,
21 aprile 2009, n. 9474, in RCDL, 2009, p. 448, con nota di Scarcelli.
315
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
inespressa del giudice circa l’idoneità del comportamento stesso a
dimostrare che l’impedimento al lavoro non sussisteva, o non era
comunque tale da giustificare l’astensione dal lavoro » (413).
Occorrerebbe, in verità, distinguere. Quando lo svolgimento di
altro lavoro è indice di simulazione della malattia, non dovrebbero
sussistere particolari perplessità in merito all’illiceità del comportamento. Per statuirlo non c’è bisogno di richiamarsi alla fedeltà,
perché se la malattia è falsa, l’impossibilità di lavorare non esiste e
il debitore di opere, sottraendosi immotivatamente all’obbligo di
prestare lavoro, risulta inadempiente a tutti gli effetti.
Diversamente qualora, invece, l’attività lavorativa prestata nel
periodo di sospensione del rapporto non sia indice di una malattia
simulata, ma si presenti comunque astrattamente idonea a ritardare
la guarigione (414). Qui il comportamento denunciato dal datore si
pone in violazione di una regola cautelare, ricollegabile alla stessa
diligenza e si presenta certamente incoerente con quell’interesse alla
prestazione, al cui soddisfacimento il lavoratore si è impegnato in
forza del vincolo contrattuale. Il dato potrà senza meno rilevare sul
versante disciplinare, a prescindere dal fatto che tale condotta determini, poi, l’effettivo prolungamento della malattia e, quindi, il
difetto della prestazione dovuta, rilevante, invece, ai fini della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. (415).
Solleva, infine, perplessità la tesi secondo cui il prestatore
ammalato, ma in possesso ancora di residue capacità lavorative,
debba offrire le proprie opere all’imprenditore da cui dipende,
prima di fornirle, nel corso del periodo di malattia, ad altro datore.
(413) Caro, 1992, p. 676.
(414) Criticamente, invece, Boscati, 2012, p. 978 s. che propone una soluzione più
drastica, volta a negare « lo svolgimento di qualsiasi attività in quanto di per sé idonea a
precludere detto recupero, ferma la possibilità per il lavoratore di dimostrare che lo
svolgimento occasionale di certe attività (...) sia funzionale in positivo ad un più rapido ed
integrale recupero della forma psico-fisica ». Sarebbe forse preferibile distinguere tra l’esercizio di altra attività lavorativa, la cui retribuzione finisce peraltro per sommarsi con
l’indennità di malattia, e lo svolgimento di altre attività non lavorative che al contrario
potrebbero essere ammesse, ove compatibili. In ogni caso sarebbe auspicabile la produzione
di certificati medici più precisi in merito alla necessità o meno di assoluto riposo in costanza
di malattia; diversamente si rischia che l’indagine giudiziale circa la compatibilità delle
attività compiute in stato di malattia conduca di caso in caso a soluzioni eccessivamente
divergenti tra loro, come segnala lo stesso Boscati, 2012, p. 975 e nt. 41.
(415) In senso contrario Mattarolo, 2000, p. 250 s.; Del Punta, 1992, p. 564 s.
316
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
È stato, infatti, osservato come un simile orientamento « presuppone che rientrino nell’oggetto del contratto » (416), anche mansioni diverse da quelle convenute, ovvero riconducibili alla qualifica di assunzione e ciò non pare persuasivo.
9.5. Comportamenti diretti a conformare l’aspetto esteriore della
propria persona in funzione della prestazione (dovere di
cura del proprio aspetto personale).
Un quinto, meno cospicuo gruppo di pronunce attiene a comportamenti del prestatore relativi alla cura della propria persona
dal punto di vista propriamente esteriore. Qui il richiamo agli artt.
1175 e 1375 è del tutto assente, sebbene la materia non possa dirsi
certo estranea al campo di azione delle clausole generali.
Lo confermano, intanto, tutte quelle direttive impartite dall’imprenditore al proprio personale nell’esercizio del potere direttivo, riguardanti l’obbligo di indossare divise, calzature, copricapo,
indumenti protettivi, necessari allo scopo di salvaguardare la salute,
l’igiene, la sicurezza dei prestatori di lavoro ex art. 2087 c.c. Si tratta
di direttive vincolanti, la cui inosservanza espone i prestatori medesimi alla violazione del dovere di salvaguardare l’organizzazione
altrui, dovere oggi tipizzato all’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008 (417).
È, invece, riconducibile alla diligenza generica dell’art. 1176, 1°
comma, c.c. l’adozione obbligatoria di comportamenti — ad opera
indistintamente di tutti i lavoratori senza riguardo per le mansioni
svolte — diretti a conservare una ragionevole decenza nella propria
esteriorità, evitando altresì stravaganze eccessive (418).
(416) Mattarolo, 2000, p. 249.
(417) Ibidem, p. 375, ma in senso diverso dal testo, ravvisandosi nell’inottemperanza
a simili direttive un’ipotesi di inadempimento al dovere di diligenza (tecnica) nella esecuzione della prestazione. Se, invece, si opta, come nella ricostruzione qui proposta, per la
violazione dell’obbligo di sicurezza dell’art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008, le modalità di esatto
adempimento dell’obbligo saranno quelle della diligenza di cui all’art. 1176 c.c., poiché è
quest’ultimo a fungere da metro valutativo del comportamento di protezione, nel cui
ambito va ricondotto anche il citato dovere di sicurezza dei lavoratori.
(418) Su alcune di queste stravaganze, v. Cass. civ. sez. lav., 21 dicembre 1991, n.
13829, in GC, 1992, I, p. 3083 ss., con nota di Pizzoferrato, per il caso di un bancario
legittimamente punito sul piano disciplinare per essersi presentato al lavoro in canottiera;
Trib. Latina, 19 settembre 1989, in RIDL, 1990, II, p. 248 ss., con nota di Poso e Pret.
Latina, 10 novembre 1988, ivi, 1989, II, p. 551 ss., per il caso di un lavoratore invalido che
317
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Si collocano, poi, nel campo delle disposizioni per l’esecuzione
del lavoro tutti gli ordini volti a imporre ai debitori di opere una
particolare cura dell’aspetto esteriore, allorché ciò si leghi immediatamente alla esecuzione dell’attività lavorativa in vista del
soddisfacimento dell’interesse alla prestazione proprio del datore
creditore. In questo caso, la cura della persona è parte del dovere
di svolgimento della prestazione secondo la diligenza professionale.
Siamo, dunque, nell’area governata dall’art. 2104, 1° comma, c.c.
Così, corrisponde senz’altro a un comportamento tecnicamente
diligente, in rapporto alla « natura della prestazione », quello dovuto da chi, essendo preposto ad attività a contatto col pubblico,
sia chiamato a dedicare una particolare attenzione al proprio
aspetto fisico, alla pulizia personale, all’acconciatura dei capelli,
alla rasatura della barba (419), all’abbigliamento in genere.
Sempre nell’area della diligenza professionale si collocano,
inoltre, quelle condotte orientate a recepire particolari modelli
estetici o esteriori, siccome richiesti dall’azienda in ragione delle
particolari caratteristiche cui si ispira il progetto organizzativo
imprenditoriale. Si è fatto l’esempio del ristorante esotico nel quale
si imponga ai camerieri di indossare abiti tipici del paese di cui si
vuol riprodurre l’ambiente (420), ma si può pensare anche ad una
discoteca, ove si prescriva al personale l’impiego di un look da sera,
aggressivo e provocante. In questi casi, più che un contegno idoneo
a salvaguardare l’immagine aziendale (421), si pretende un comportamento aderente all’indirizzo produttivo impresso dal datore
alla propria azienda, insomma, una condotta che, in quanto finalizzata al soddisfacimento del risultato della prestazione, risulti
improntata ex art. 2104, 1° comma, c.c. alla « diligenza richiesta
(...) dall’interesse dell’impresa ».
aveva ripetutamente indossato sul luogo di lavoro un cappello alla messicana e una stella da
sceriffo; come osserva Montuschi, 2001a, p. 1051, « la giurisprudenza in tema di “giusta
causa” di licenziamento offre sempre qualche spunto di riflessione fra il serio e il faceto. I
giudici di merito e di legittimità sono costretti ad occuparsi un po’ di tutto », incluso delle
« abitudini bizzarre di un lavoratore “modaiolo” (che amava vestirsi da “sceriffo”) (...) ».
(419) Per App. Milano, 9 aprile 2002, in RIDL, 2002, II, p. 658 ss., con note di Ichino,
Pera, non è, tuttavia, punibile disciplinarmente « il lavoratore addetto al reparto di
gastronomia di un supermercato, per l’omissione della rasatura quotidiana della barba,
richiesta da precise istruzioni aziendali ».
(420) Ichino, 2003, p. 279.
(421) Così, invece, Valente, 1999, p. 621 ss.; Ichino, 2003, p. 279.
318
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
È probabile, invece, che si ritorni entro l’area governata dai
doveri di protezione ogni qualvolta l’aspetto esteriore richiesto dal
datore al proprio dipendente non sia parte caratterizzante del
progetto organizzativo imprenditoriale, ma corrisponda ad una più
generale esigenza di immagine di « compostezza e serietà della
struttura produttiva » (422), secondo i modelli corrispondenti alla
“morale comune”: si pensi al caso dell’imprenditore che imponga al
personale maschile di indossare pantaloni lunghi (423) o vieti l’uso
di minigonne eccessive alle impiegate (424), ovvero impedisca di
ornare la propria persona con piercing, ciondoli, treccine nei capelli
e altri particolari accessori (425).
In assenza di previsioni negoziali specifiche sull’argomento, ci
si chiede se il datore di lavoro possa comunque pretendere comportamenti improntati al rispetto di simili regole, in forza delle
clausole di cui agli artt. 1175 e 1375, che, integrando il regolamento
contrattuale in sede esecutiva, impongono al prestatore debitore il
rispetto di determinate norme sociali di condotta a salvaguardia
dell’interesse di controparte. La risposta deve essere positiva,
almeno se e nella misura in cui dette regole siano espressione dei
parametri dell’esperienza sociale. Può condividersi l’idea secondo
cui, anche in difetto di una disciplina negoziale ad hoc della
materia, non si può impedire al datore di far valere « l’inaccettabilità di indumenti prescelti dai dipendenti e non consoni a quanto
si può pretendere da un lavoratore subordinato, sulla base di criteri
di comune convivenza e di abituale professionalità » (426).
(422) Gragnoli, 1993, 427.
(423) Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 1993, n. 4307, in MGL, 1993, p. 426 ss., con nota
di Gragnoli.
(424) Pret. Milano, 12 gennaio 1995, in GC, 1995, I, p. 2267 ss., con nota di Pera ha
tuttavia ritenuto « colpevole di molestie sessuali il dirigente d’azienda » che aveva invitato
« una lavoratrice a non presentarsi al lavoro in minigonna per evitare apprezzamenti, con
fischi e battute, da parte degli altri lavoratori », invece di punire i prestatori stessi per i loro
comportamenti lesivi della dignità della lavoratrice.
(425) Il tema è molto discusso nelle società anglosassoni, specie negli USA, patria
della diversità culturale, etnica, razziale, ma anche Paese percorso da una lunga tradizione
di lotte contro le discriminazioni, tradizione ripresa, nell’ambito del pensiero scientifico, dai
c.d. critical legal studies: v., infatti, Klare, 1994, p. 567ss.; nella letteratura giuslavoristica
italiana, Aimo, 2003, p. 283 ss.
(426) Gragnoli, 1993, p. 429; a riguardo v. comunque l’orientamento di Pret. Roma,
3 dicembre 1998, in RGL, 1999, II, p, 619 ss., con nota di Valente, che ha condizionato le
direttive sull’abbigliamento e sull’aspetto estetico alla sussistenza di ragioni produttive o di
319
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Il limite a tutto ciò è, tuttavia, rinvenibile nel significato stesso
attribuito a correttezza e buona fede, quali clausole generali finalizzate ad imporre a ciascun contraente forme di rispetto e protezione dell’altrui utilità, ma sempre ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio. Così, dovrebbe ritenersi
legittimo, sulla scorta di un rinvio alla realtà sociale, il divieto di
presentarsi a lavoro in pantaloni corti (427), non, invece, quello
imposto ad una donna africana di portare capelli pettinati a
treccine secondo costumi e, soprattutto, esigenze della propria
etnia. In generale, la solidarietà verso l’altro contraente non tollererebbe mai un’intrusione nella sfera di libertà dell’individuo, tale
da pretendere la rinuncia a modelli esteriori, che rappresentano
simboli radicati di un’identità culturale, etnica o religiosa, nei quali
si esprime la personalità dell’individuo, né mai potrebbero attentare al bene della dignità personale in generale (428), come lo stesso
dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro e codificato
all’art. 2087 c.c. si fa carico di dimostrare (429).
10. Correttezza e buona fede: il rapporto con la fedeltà. Una seconda
conclusione.
Si è visto come la giurisprudenza si sottragga di fatto ad
un’opera di puntuale “concretizzazione” delle clausole generali,
ora trascurandone del tutto la possibile invocabilità (v. retro, §§ 9.2.
e 9.5.), ora richiamandole a sproposito (v. retro, § 9.1) ovvero, più
frequentemente, abbinandole alla fedeltà in funzione ausiliaria
della diligenza, sì da poter reagire direttamente sul dovere di
immagine dell’azienda, in relazione alla natura dell’attività imprenditoriale esercitata e alla
clientela cui la stessa si rivolge; ha così ritenuto illegittima la sanzione disciplinare irrogata
ad un cameriere di ristorante, che, a fronte di un ordine di servizio volto a prevedere che « il
personale maschile » dovesse « avere sempre il viso ben rasato, i capelli in ordine e ben
tagliati, possibilmente con acconciature classiche », si era presentato a lavoro con un taglio
di capelli corto, ma caratterizzato da una vistosa orlatura, in particolare da « una frangia
anch’essa corta, (ma) divisa con gel in ciocchette ».
(427) Potrà discutersi della gravità dell’infrazione e della sproporzione di un licenziamento irrogato al lavoratore in corrispondenza con il conflitto accesso nei confronti del
datore dall’avere il primo indossato i pantaloni corti senza volerne rinunciare, ma non si può
partire dal ragionamento opposto, come ha fatto Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 1993, n. 4307, cit.
(428) Bellavista, 1994, p. 226.
(429) Ranieri, 2010, p. 27 ss.
320
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
prestazione, secondo un significato molto ampio e generico, sostanzialmente coincidente con i concetti di lealtà e fiducia (v. retro, §
9.4.).
A fronte di simili orientamenti, è fondamentale, invece, ricondurre la correttezza e la buona fede entro il terreno elettivo loro
proprio, segnato dall’interesse dell’imprenditore creditore alla salvaguardia della propria sfera giuridica, nei limiti in cui ciò non
comporti un apprezzabile sacrificio a carico della controparte.
Su questa via, un primo problema attiene ai rapporti tra gli
artt. 1175, 1375 e l’art. 2105 c.c., che, sotto la rubrica « obbligo di
fedeltà », introduce, come noto, due doveri di contenuto negativo
« finalizzati alla tutela di un interesse del datore distinto da quello
primario alla prestazione di lavoro: l’interesse alla capacità di
concorrenza dell’impresa e alla sua posizione di mercato » (430). È
condivisibile, a riguardo, l’inquadramento della fedeltà — ricorrente nella stessa manualistica — alla stregua di obbligazione di
protezione accessoria rispetto alla prestazione principale, con « la
funzione di proteggere gli interessi che le parti potrebbero vedere
pregiudicati dall’instaurazione di un rapporto obbligatorio », destinato a esporre « le proprie sfere giuridiche » a pericoli derivanti
dall’attività della controparte (431). Pertanto, « che si tratti di una
proiezione o di un’applicazione particolare dei più generali doveri
di correttezza (art. 1175 c.c.) o di buona fede (art. 1375 c.c.), contro
l’insorgenza di rischi derivanti dal cosiddetto “contatto sociale”,
cui può dar luogo l’attuazione della prestazione principale, è affermazione tanto consueta quanto ormai non più assoggettabile a
dubbi » (432).
Un tale “contatto sociale” si rivela, peraltro, viepiù stretto e
intenso, quando il contratto di lavoro implichi l’inserimento del
debitore nell’organizzazione del creditore (433). Ciò può spiegare
perché mai in taluni rapporti, ove un simile inserimento si verifica
in maniera, appunto, così penetrante, il legislatore abbia sentito
l’esigenza di tipizzare il dovere di protezione succitato e parallela(430) Carinci F., De Luca Tamajo, Tosi, Treu, 2013, p. 215.
(431) Ibidem, p. 216; v. anche Ghera, 2006, p. 86 s.; Vallebona, 2011, p. 147.
(432) Grandi, 1987, p. 343; Mancini 1957, p. 131 ss.; da ultimo, ma più tiepidamente,
Mattarolo, 2000, p. 43; diversamente, sia pur con diverse impostazioni, Persiani, 1966, p.
248; Napoli, 1980, p. 207 ss.; di recente Boscati, 2012, p. 970; Menegatti, 2012a, p. 15 ss.
(433) Da ultimo Pisani, 2004, p. 121.
321
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
mente quello di sicurezza: così è nel lavoro subordinato, ove,
peraltro, i menzionati doveri permangono persino nell’ipotesi di
prestazione di fatto (434), ma pure nel lavoro parasubordinato, ove
questo si espleti nelle forme del lavoro a progetto (artt. 64, 66, 4°
comma, d.lgs. n. 276 del 2003; v. però anche l’art. 3, 7° comma,
d.lgs. n. 81 del 2008, che estende la tutela in materia di sicurezza
anche ai collaboratori coordinati e continuativi).
Numerosi problemi emergono, tuttavia, allorché, acclarata la
natura accessoria dei doveri di cui all’art. 2105, ci si interroghi
partitamente sui loro rapporti con le clausole di cui agli artt. 1175
e 1375. A riguardo, pesano soprattutto le incertezze che circondano
la nozione di fedeltà.
È stato a ragione sottolineato come « in proposito » si registri
« da tempo un singolare fenomeno di incomunicabilità tra dottrina
e giurisprudenza » (435). Ciò al punto da indurre nella prima (la
dottrina) « l’impressione di una scoraggiante inutilità (quanto
meno a fini applicativi) di una ricerca che si proponga di individuare i limiti dei comportamenti descritti dall’art. 2105 c.c., se poi
tali limiti sono facilmente e acriticamente superati con affermazioni tanto ampie e onnicomprensive quanto inafferabili » (436).
Bisogna partire dalla consapevolezza che la giurisprudenza
continua ad accreditare una « nozione “allargata” di fedeltà » (437),
(434) Ciò conferma la rilevanza dell’inserzione del prestatore nell’organizzazione ai
fini della previsione di simili doveri; in tema sia consentito rinviare a Campanella, 2013, p.
125 ss.
(435) Pisani, 2004, p. 1.
(436) Mattarolo, 2000, p. 15; per tale richiamo v. anche Bellomo, 2013, p. 292 s.;
diversamente, però, Tosi, 2012, p. 539 ss., per il quale « la rilevanza della fiducia non può
essere obliterata perché (...) scaturisce inevitabilmente dall’implicazione della persona non
solo nel rapporto ma nell’organizzazione aziendale (p. 541); pertanto, non stupisce che nelle
« operazioni giurisprudenziali (...) l’obbligo di fedeltà finisca sempre per emergere (...) come
sintesi dei doveri desumibili dall’implicazione della persona del lavoratore nell’organizzazione produttiva (p. 544); ciò deve indurre, per l’A., a prendere atto che « della rilevanza
della fiducia e del suo corrispettivo fedeltà non è possibile affrancarsi ragionando in termini
di categorie generali ed astratte se non al prezzo (...) dello scollegamento dal diritto vivente »
(p. 546).
(437) Tullini, 1988, p. 981 ss.; sul tema, v. anche tutta la dottrina più recente
occupatasi del tema, a partire da Gragnoli, 1996, p. 49; Mattarolo, 2000, p. 15 ss. e passim;
Pisani, 2004, p. 119 e passim; Zoppoli L., 2005, p. 837 ss.; Boscati, 2012, p. 936 ss.;
Menegatti, 2012a, p. 38 ss.; Bellomo, 2013, p. 292.
322
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
quasi che l’art. 2105 contenga mere esemplificazioni (438), o comunque un semplice « richiamo sintetico » ad un più ampio dovere
di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro. La
citata norma codicistica prevede, al contrario, « obblighi astensivi
tipici », identificando talune obbligazioni di non facere, « rivolte ad
impedire forme particolari di negazione dell’utilità della collaborazione e di nocumento allo sforzo concorrenziale ». Essa realizza
una tipizzazione di comportamenti riconducibili all’area dei doveri
di protezione ex artt. 1175 e 1375, ma proprio per questo non
funziona da clausola generale, « incidente sull’intero spettro di
situazioni verificatesi nell’esecuzione del rapporto », attraverso la
previsione di obblighi ulteriori a carico del lavoratore debitore (439). Non siamo, in altri termini, al cospetto di « un istitutovalvola al quale poter ricondurre situazioni e/o comportamenti che
si assumono ingiustamente lesivi degli interessi dell’impresa » (440). Pertanto, l’impegno ad assecondare le aspettative
datoriali con astensioni è dovuto », ai sensi dell’art. 2105 c.c., « nei
limiti della loro espressa contemplazione » (441).
Piuttosto, sono clausole generali la correttezza e la buona fede
ed è per il tramite della loro funzione di integrazione negoziale che
possono essere richieste al debitore di opere condotte obbligatorie
ulteriori. Queste non dovranno, però, ritenersi improntate a una
fedeltà « particolarmente pregnante » (442), da ritenersi estranea al
contenuto degli artt. 1175 e 1375 c.c., bensì al rispetto di specifici
doveri di sicurezza, a salvaguardia dell’interesse alla protezione del
datore di lavoro creditore, nei limiti in cui ciò non comporti un
apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio del prestatore. Non
offuscano, del resto, tali conclusioni alcune previsioni di contratti
collettivi e, soprattutto, di codici aziendali, che, pur tentando di
accreditare una nozione di fedeltà in senso ampio, lo fanno con
(438) Emblematica Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6957, cit., la quale ritiene,
sulla scorta della « prevalente dottrina » (!!!), che le ipotesi dell’art. 2105 c.c. « non abbiano
carattere tassativo e non esauriscano, quindi, l’obbligo di fedeltà del lavoratore, obbligo che
è violato da ogni comportamento tale da scuotere la fiducia del datore di lavoro, anche in
presenza di un danno solo potenziale ».
(439) Gragnoli, 1996, p. 50.
(440) Tullini, 1988, p. 987.
(441) Gragnoli, 1996, p. 49 s.
(442) Trib. Nocera Inferiore, 26 maggio 2000, in LG, 2000, p. 1159 ss., con nota di
Bonaiuto.
323
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
enunciazioni troppo vaghe, generiche e prive di un significato
giuridico concreto per poter aggiungere alcunché rispetto a quanto
già desumibile, sul piano obbligatorio, dall’art. 2105, nonché dagli
artt. 1175 e 1375 c.c., intesi nell’accezione loro propria (443).
Lette nel senso qui prospettato, le clausole generali non possono svolgere, dunque, una mera funzione ausiliaria dell’art. 2105
c.c., ma andranno, volta per volta “concretizzate”, a partire dai
casi reali, in specifici modelli di comportamento espressivi di norme
sociali di condotta. È frequente, invece, che a fondamento della
nozione allargata di fedeltà i giudici pongano proprio il richiamo a
correttezza e buona fede (444). Il tutto per accreditare l’esistenza
di un supposto vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro, destinato
a venire irrimediabilmente leso da condotte “infedeli” del dipendente non meglio identificate e tipizzate nel loro contenuto (445).
Si dilata, così, anche la nozione di giusta causa (bisognerebbe dire,
“soggettiva”: v. infra), « oltre il piano dell’inadempimento contrattuale: giungendo, per tale via, a far rientrare nella nozione di cui
all’art. 2119 c.c. qualsiasi comportamento ascrivibile al lavoratore
di per sé idoneo a ledere la fiducia che il datore ha riposto nei
confronti del proprio dipendente » (446).
Vero è che « la prestazione di lavoro non è in sé oggettivamente
infungibile, in relazione alla natura del risultato dovuto, ma lo è
solo soggettivamente, in relazione alla fiducia risposta nella persona del prestatore », sicché l’elemento personalistico dell’adempimento si atteggia a caratteristica fondamentale del contratto di cui
(443) Lo stesso art. 3, 2° comma, del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici nulla aggiunge quando afferma che « il dipendente rispetta altresì i principi di
integrità, correttezza, buona fede (...) »; sui regolamenti aziendali v., invece, Montuschi,
2001b, p. 413 e, nell’ambito di un più vasto discorso sulla responsabilità sociale d’impresa,
Ferraresi, 2012; Perulli (a cura di), 2013.
(444) Tra le tante, v. Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 1995, n. 7529, in MGL, 1995, p. 568
ss., con nota di Lucifredi, per la quale « gli obblighi di correttezza e buona fede (...)
individuano il bene-interesse peculiare dell’art. 2105 c.c., affermativo dell’obbligo di fedeltà
del lavoratore (...) ».
(445) Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6957, cit.; Cass. civ., sez. lav., 14 giugno
2004, n. 11220, in MGL, 2004, p. 813 ss., con nota di Nuzzo; Cass. civ., sez. lav., 4 maggio
2002, n. 6420, in RIDL, 2002, II, p. 860 ss., con nota di Martinucci; Cass. civ., sez. lav., 7
luglio 2004, n. 12528, MGL, 2004, p. 722 ss., con nota di Montanari; Trib. Milano, 25 agosto
2001, in LG. 487 ss.; Trib. Lecce, 16 gennaio 2013, cit.; Trib. Genova, 11 aprile 2013, cit.
(446) Zoppoli L., 2005, p. 846; in giurisprudenza Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2004,
n. 1878, in DRI, 2005, p. 799 ss.; Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12489, cit.
324
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
all’art. 2094 c.c. (447). Tuttavia, ciò non implica una connotazione
fiduciaria del rapporto (448); tant’è che il licenziamento disciplinare deve trovare causa in un inadempimento ai sensi della legge,
non nell’irreparabile lesione di un ipotetico legame fiduciario. Il
richiamo giurisprudenziale alla fiducia finisce per apparire, in
realtà, un semplice « pleonasmo » o, comunque, un’abituale strategia comunicativa dei giudici, per sottolineare che, « ai fini della
decisione sulla gravità, non rileva solo la deviazione in sé da
parametri di dovere essere, ma l’impatto sull’interesse del datore di
lavoro » (449).
« La conclusione » sarà pure « ineccepibile », anche se « estranea
al tema della fiducia, intesa come effettivo pensiero o sentimento
del datore di lavoro » (450). Certo è che, però, essa non aiuta
nell’opera di “concretizzazione” delle clausole generali, le quali
pure una certa parte dovrebbero avere nella individuazione di
specifici obblighi posti a carico del prestatore, suscettibili (questi
sì), se violati, di legittimare la reazione disciplinare dell’imprenditore.
Nel censurare l’operato dei giudici, ritenuto eccessivamente
semplificatorio in sede di motivazione della decisione, una dottrina (451) ha recentemente esaminato, a scopo esemplificativo,
una serie di casi, tra cui quello di un lavoratore, licenziato, ai sensi
della disciplina collettiva, per aver a lungo (otto giorni) ritardato di
giustificare l’assenza dovuta alla necessità, risultante da certificazione medica, di assistere la figlia di cinque anni affetta da broncopolmonite e bisognevole di cure continue da parte di ambedue i
genitori. La Suprema Corte ha, in questa ipotesi, cassato la sentenza del giudice di merito favorevole alla legittimità del recesso,
per non avere essa proceduto, nell’applicazione dell’art. 2119 c.c.,
a compiere quel bilanciamento tra gli artt. 4 e 41 Cost., necessario
per poter giungere in casu alla corretta conclusione dell’inesistenza
(447) Grandi, 1972, p. 51; in generale, sulla rilevanza dell’elemento personalistico
dell’adempimento cfr. Cataudella A., 1972, p. 3 ss.; Galasso, 1974; Alessi, Mazzarese,
Mazzamuto (a cura di), 2013.
(448) Smuraglia, 1967, p. 78 ss.; Persiani, 1971, p. 681; Grandi, 1972, p. 41 ss.; Tosi,
1974, p. 141 ss.; Pisani, 2004, p. 63 ss.; Zoppoli L., 2005, p. 846; Gragnoli, 2014, p. 19 ss.
(449) Gragnoli, 2014, p. 20.
(450) Ibidem.
(451) Nogler, 2014a, p. 115 ss.
325
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di un inadempimento (la ritardata giustificazione dell’assenza) di
gravità « tale da far venir meno l’elemento fiduciario costituente il
presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del
rapporto di lavoro » (452).
A commento di questa come di altre decisioni, la dottrina
summenzionata ha rimproverato alla Cassazione di aver compiuto
un’eccessiva semplificazione del ragionamento giuridico, tralasciando « vincoli argomentativi pure positivamente previsti ». In
particolare, nel caso di specie, la Corte non avrebbe accennato —
come invece ci si sarebbe attesi — « all’autonoma causa di esonero
della responsabilità contrattuale, che trova il proprio fondamento
nella clausola generale della correttezza (art. 1175 c.c.) e dà rilievo
(...) all’assolvimento di doveri fondamentali che gravano sulla
persona del debitore », « rendendo la prestazione inidonea a formare oggetto di un dovere giuridico » « (prestazione inesigibile) ».
Occorre, tuttavia, in replica a tale dottrina, considerare che
quando, in genere, si fa riferimento a prestazioni c.d. inesigibili, gli
esempi richiamati sono quelli della « cantante che all’ultimo momento disdice il recital cui è impegnata per accorrere al capezzale
del figlio gravemente infermo, o del prestatore che si assenta senza
permesso perché colpito da un grave lutto familiare » (453), situazioni, pertanto, diverse da quelle oggetto della citata pronuncia,
ove il dipendente era mancato dal lavoro per oltre una settimana
senza dare nessun avviso, tanto da essere licenziato proprio (e solo)
per il prolungato ritardo nella comunicazione, non (sicuramente),
invece, per una supposta assenza ingiustificata (454).
Certo è che la Corte avrebbe forse fatto bene a impostare la
decisione sulla scorta di una “concretizzazione” delle clausole
(452) Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2005, n. 21213, cit.
(453) Mengoni, 1988, p. 1084.
(454) Per il caso, invece, di un licenziamento illegittimo, irrogato ad una dipendente,
che si era assentata senza giustificazione, dopo che le era stato negato un permesso ex art.
4, 1° comma, l. n. 53 del 2000, per assistere il fratello che aveva perso la gamba a seguito di
un gravissimo incidente e versava in pericolo di vita, v. Trib. Milano, 30 giugno 2003, in
RCDL, 2003, p. 997 ss., con nota di Zezza; v. anche Trib. Vercelli, 26 maggio 1981, in OGL,
1981, p. 713 ss., secondo cui, a sostegno dell’illegittimità del licenziamento irrogato a una
dipendente per assenza di tre giorni consecutivi dal lavoro dovuta alla necessità di assistere
la madre ammalata, non può essere invocata « la violazione del principio di buona fede ex
art. 1375 c.c., per non » aver l’imprenditore avvertito la dipendente stessa « dell’inidoneità
della malattia della madre a giustificare la sua assenza ».
326
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
generali di correttezza e buona fede: da un lato, si sarebbe potuto
ricostruire un obbligo, gravante sul datore, di proteggere la persona del prestatore, a fronte di interessi del medesimo preminenti
sul piano valoriale rispetto a quelli economici suoi propri; dall’altro, si sarebbe potuto configurare un parallelo obbligo, in capo al
prestatore, di salvaguardare l’organizzazione imprenditoriale, attraverso una immediata comunicazione, anche solo telefonica, dei
motivi dell’assenza, a meno di un apprezzabile (e quindi intollerabile) sacrificio a suo carico. Sicché proprio su questo si sarebbe
dovuto richiedere di indagare più a fondo. È possibile che, così
impostando le cose, le conclusioni non sarebbero mutate, ma certo
l’argomentazione della decisione ne sarebbe uscita rafforzata.
Come si comprende, uno sforzo orientato alla reale “concretizzazione” delle clausole generali sarebbe quanto meno auspicabile:
gioverebbe alla solidità d’impostazione delle pronunce e limiterebbe altresì il ricorso a tralatizie affermazioni di stile in tema di
obblighi dei prestatori. Bisognerebbe farlo, però, a partire da quel
che è il corretto significato attribuibile alle clausole di correttezza
e buona fede sul versante del prestatore.
Se si tiene ferma l’ipotesi ricostruttiva qui prospettata, sarà
facile concludere che la correttezza e la buona fede — nella loro
accezione di clausole impositive di obblighi reciproci a carico dei
contraenti, diretti a preservare l’utilità altrui nei limiti in cui ciò
non importi un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio —
richiedono, nel rapporto di lavoro, condotte del prestatore ispirate
a rispetto e solidarietà del confronti del datore. Ciò non implica una
tensione cooperatoria al risultato atteso dal datore dall’attività
lavorativa. Impone, piuttosto, la tenuta di comportamenti obbligatori autonomi e diversi da quello consistente nel prestare lavoro,
diretti a salvaguardare l’altrui organizzazione da eventuali pregiudizi che potrebbero occorrere ad essa per effetto del “contatto
sociale” connesso all’inserzione (del prestatore medesimo) nel complesso produttivo.
L’interesse organizzativo dell’imprenditore, che già (come interesse positivo) condiziona il dovere prestazione per il tramite
della « diligenza richiesta (...) dall’interesse dell’impresa » (art.
1176, 1° comma, c.c.), trova così riconoscimento giuridico (come
interesse negativo) anche fuori dal perimetro segnato dall’adempimento di quel dovere, nelle forme di un obbligo di protezione del
327
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
complesso produttivo imprenditoriale, per il tramite della correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375 c.c.) (455).
Si può ritenere che al debitore di opere siano richiesti contegni
protettivi — in termini di “non facere”, ma anche di “facere” —
finalizzati al soddisfacimento dell’interesse negativo del datore a
non subire nel corso dell’esecuzione del contratto comportamenti
pregiudizievoli della propria organizzazione sotto un triplice profilo (456): statico (dei beni, macchinari, attrezzature, merci, ecc.);
gestionale (delle regole relative all’esecuzione e alla disciplina del
lavoro); dinamico (di mercato, di immagine, ecc.). Sulla scorta di
ciò, andrebbero, allora, individuati i vari modelli di comportamento secondo correttezza e buona fede e le relative norme sociali
di condotta gravanti a tal stregua sul prestatore, tenuto conto, in
ogni caso, che il richiamo agli artt. 1175 e 1375 c.c. può trovare
spazio, solo nelle aree lasciate scoperte dalla legge, dalla contrattazione collettiva e, potremmo aggiungere, dagli stessi codici etici
e di comportamento (457), se immediatamente vincolanti nei confronti del prestatore (458).
(455) Diversamente, invece, Bellomo, 2013, p. 298 ss., che riconduce all’art. 1176, 1°
comma, c.c., per il tramite della « diligenza richiesta (...) dall’interesse dell’impresa », tutti
quei comportamenti che la giurisprudenza ritiene ascrivibili a una nozione “allargata” di
fedeltà.
(456) Per una distinzione non dissimile da questa v. Pisani, 2004, p. 123 ss.
(457) Correttamente, in tal senso, Trib. Genova, 11 aprile 2013, cit., seppure con
richiamo (improprio) all’art. 2105 c.c., invece, che agli artt. 1175 e 1375 c.c.
(458) Le previsioni della legge e della contrattazione collettiva entrano, infatti,
direttamente a far parte del programma contrattuale, ex artt. 1339, 1419, 2° comma, c.c. e,
rispettivamente, art. 1374 c.c., senza bisogno di esservi integrate per il tramite delle clausole
di correttezza e buona fede; quanto ai codici di comportamento, quello relativo ai dipendenti pubblici, adottato con d.P.R. n. 62 del 2013, ha assunto ormai carattere precettivo e
pertanto, nella sua minuziosa previsione di doveri di comportamento, spesso specificativi
della correttezza e della buona fede, sottrae ampio spazio agli artt. 1175 e 1375 c.c.: cfr., ad
esempio, già Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5113, in CED Cass., 2010, che ha
richiamato direttamente l’inottemperanza degli artt. 5 e 6 del codice in parola per giudicare
legittimo il recesso della P.A. dal contratto di lavoro con un dirigente, che si era « limitato
ad effettuare comunicazioni orali e non scritte, (...), del potenziale conflitto di interesse in
cui si era venuto a trovare (nel caso di specie partecipazione ad una gara indetta dal
Comune, presso cui lavorava il dirigente) e non si sia poi astenuto dal prendere decisioni o
dal compiere attività strettamente connesse con la situazione determinante il conflitto
suddetto (nella fattispecie concreta il dirigente firmava gli inviti di partecipazione ed il
provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara) »; quanto ai codici etici aziendali,
invece, ne è controversa l’immediata precettività (sul punto v. Perulli, 2013; Angelici, 2011,
328
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
11. Segue: ipotesi applicative.
11.1. Comportamenti diretti alla salvaguardia dell’organizzazione in senso “statico” (dovere di protezione dell’organizzazione in senso “statico”).
Sono dovuti a stregua di correttezza e buona fede, con richiamo agli artt. 1175 e 1375 c.c. in assenza di disciplina collettiva
o aziendale ad hoc, tutti quei comportamenti diretti a soddisfare
l’interesse del datore alla protezione dei mezzi di produzione, ossia
del suo « patrimonio inteso in senso lato » (459) o « statico » (460):
merci, locali, arredamenti, suppellettili, attrezzature, autovetture,
cancelleria, strumenti di comunicazione, software, accesso a internet, banche dati, e così via.
Costituisce, pertanto, inadempimento non dell’art. 2105 c.c.,
ma di obblighi accessori di protezione non “tipizzati” ex lege, il
furto o l’appropriazione indebita di tali beni, così come il loro
danneggiamento o l’utilizzazione indebita, sempre che ciò non leda
direttamente l’interesse dell’imprenditore alla prestazione, come
accade, ad esempio, qualora il lavoratore distrugga o si appropri
indebitamente delle attrezzature, dei mezzi, della merce che gli era
stata fornita in dotazione o data in custodia per adempiere all’obbligazione principale di prestare lavoro, venendo il quel caso meno
il “sostrato” della prestazione medesima (e dunque la stessa possibilità di adempiere) (v. retro, § 9.3.).
Si può, così, pensare al furto di materiali di proprietà del
p. 169; per il carattere impegnativo di tali codici, invece, Senigaglia, 2013, p. 86), ma
probabilmente questa può essere affermata perlomeno laddove vi sia un’esplicita accettazione richiesta al dipendente ovvero una incorporazione del codice medesimo all’interno del
modello organizzativo per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 (v. ad es.,
tra i tanti, il codice etico e di comportamento aziendale di IECE S.r.l., ove si esplicita che
il codice « si integra nel modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsto dal (...)
D.lgs. n. 231/2001 » o il codice etico di AMG S.r.l., artt. 5 e 6); sicché anche in queste ipotese
gli spazi per gli artt. 1175 e 1375 c.c. verrebbero a ridursi. Ciò sarà ancor più vero, poi, ove
si ritenga che tali codici siano coerenti col (e rappresentino una riproposizione, in versione
aggiornata, del) vecchio modello dei regolamenti disciplinari aziendali e perciò ne sia
indubbia la vincolatività.
(459) Montuschi, 1973, p. 179.
(460) Pisani, 2004, p. 124.
329
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
datore di lavoro (461), al danneggiamento di cose dell’azienda (462), al prelievo di merce per fini personali senza il rispetto
della procedura prevista dal regolamento aziendale per gli acquisti
dei dipendenti (463), all’utilizzazione indebita dei locali (464) o dei
beni dell’impresa (465), tutte ipotesi venute all’attenzione presso i
giudici di merito e di legittimità, ma ricondotte genericamente alla
lesione del legame fiduciario tra le parti del rapporto, oppure più
frequentemente alla violazione dell’obbligo di fedeltà in senso
ampio, sovente associato alla contestuale inosservanza dei doveri
di correttezza e buona fede.
(461) V. Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2011, n. 23422, in LG, 2012, p. 89 ss., con
note di Giovanardi, Guarnieri, Ludovico, Treglia, riguardante il licenziamento di un
dipendente di un’azienda operante nel settore dei pellami pregiati, che si era incontrato con
il conducente di un autocarro, il quale aveva sottratto, da un magazzino dell’azienda
medesima, otto pezze di pellame per poi rivenderle a terzi. Il licenziamento è stato ritenuto
legittimo in ragione della lesione del vincolo fiduciario inerente al rapporto; diversamente,
in dottrina, per alcune valutazioni critiche circa la « pretesa di far reagire sul contratto
azioni integranti ipotesi di reato » v. Montuschi, 1973, p. 185.
(462) Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1982, n. 5618, in MGL, 1983, p. 38 ss., che
riconduce l’ipotesi ad una violazione del dovere di fedeltà (in senso ampio), nonché, insieme,
degli obblighi di correttezza e buona fede.
(463) V. Cass. civ., sez. lav., 16 dicembre 1986, n. 7568, in MGI, 1986, che ha
ravvisato in tal caso la violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza.
(464) Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 1987, n. 2846, in NGL, 1987, p. 413 ss., che ha
ravvisato la legittimità del licenziamento per violazione del dovere di fedeltà da parte del
dipendente, che, sia pur in una sola occasione, aveva utilizzato locali e attrezzature
dell’impresa per lavori propri, seppure modesti.
(465) V. Trib. Milano, 17 dicembre 2004, in LG, 2005, p. 1175 ss., con nota di Zilli, che
ha considerato legittimo il recesso in tronco del datore di lavoro, (ma) per violazione
dell’obbligo di fedeltà da parte del custode notturno del proprio magazzino, che, sottraendo
tempo considerevole al lavoro, aveva abusato del telefono aziendale con lunghissime
chiamate (oltre due ore, per qualcuna) al servizio di cartomanzia, provocando un danno
economico pari a euro 420; v. anche Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2002, n. 10062, in MGL,
2002, p. 644 ss., con nota di Bertocco, che si è pronunciata per la legittimità del licenziamento irrogato in conseguenza di un utilizzo smodato, costante e reiterato del telefono
aziendale, stante « la perdita di fiducia » verso il lavoratore, che ne sarebbe conseguita; ma
v. anche Trib. Torino, 9 gennaio 2004, in GP, 2004, p. 131 ss., che, valutando secondo
parametri di ragionevole elasticità i principi dell’immediatezza della contestazione disciplinare e delle tempestività del recesso, ha ritenuto « contrario ai canoni di buona fede e
correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro il comportamento dell’azienda, che
essendone a conoscenza, non interrompe subito l’abuso telefonico praticato dal lavoratore
contestandone la illegittimità e irrogandogli la sanzione conservativa ».
330
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
11.2. Comportamenti diretti alla salvaguardia dell’organizzazione in senso “gestionale” (doveri di avviso, informazione, comunicazione e altri doveri di protezione dell’organizzazione tecnico-produttiva).
Possono ricondursi all’area governata dalla correttezza e dalla
buona fede anche quei comportamenti diretti alla salvaguardia del
complesso produttivo, riguardato dal punto di vista gestionale,
cioè con riferimento alle regole chiamate a presiedere sia l’organizzazione, sia la disciplina del lavoro.
Deve ritenersi che il lavoratore sia tenuto, per il rilievo accordato a correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, a
tenere comportamenti, i quali, al di là di quanto richiesto ex art.
1176, 1° comma, c.c. ai fini dell’adempimento dell’obbligazione
principale di prestare lavoro, risultino altresì improntati al soddisfacimento dell’interesse del datore di lavoro creditore alla salvaguardia del buon funzionamento dell’organizzazione tecnica del
lavoro (466).
Pertanto, anche in assenza di espresse prescrizioni legali o
convenzionali, configurerà violazione degli obblighi accessori di
protezione ex artt. 1175 e 1375 c.c. ogni condotta del lavoratore —
colposa, ma anche dolosa, visto che non si fa questione di “diligenza” — volta a pregiudicare la posizione dell’imprenditore nella
gestione e nel coordinamento dei fattori produttivi, con inutili
aggravi o disservizi vari, nei limiti in cui ciò non comporti un
apprezzabile sacrificio a proprio carico; il che certamente esclude
che risponda di inadempimento ai sensi delle norme ora menzionate il prestatore che tali aggravi e disservizi provochi in ragione
dell’adesione ad uno sciopero legittimo.
Non sembra, invece, potersi qualificare corretto il comportamento, ad esempio, del caposquadra che volutamente occulti in
vario modo gli scarti della produzione dei lavoratori da lui coordinati, al fine di poter comunque consentire a lui e all’intera squadra
di percepire un premio di risultato, e determinando, con ciò, una
(466) Nulla esclude, peraltro, che con uno stesso comportamento il lavoratore violi,
anzitutto, l’obbligo di prestazione e, poi, anche quello di protezione: così accade nell’ipotesi
in cui egli abbia, ad esempio, momentaneamente abbandonato il posto di lavoro in orario
notturno per trattenersi nei locali aziendali attigui, determinando un blocco sia pur
temporaneo delle macchine: il caso è stato deciso, ma sulla scorta di diversa impostazione,
da Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2009, n. 14586, in LG, 2009, p. 1165 ss.
331
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
seria disorganizzazione produttiva, per le informazioni dolosamente errate fornite al sistema di controllo di gestione e di miglioramento della qualità aziendale.
Nell’ambito dei contegni orientati alla protezione dell’organizzazione del lavoro, possono essere inquadrati anche gli obblighi di
avviso, informazione e comunicazione per la loro funzione « di
produrre, a vantaggio di una delle parti, uno stato di conoscenza
intorno a circostanze ritenute essenziali » (467), al fine di preservare da disservizi la buona gestione dei fattori produttivi e dello
stesso personale.
Così, risponde alle direttive di correttezza e buona fede il
contegno del lavoratore che comunichi tempestivamente un ritardo, o il rientro anticipato dalle ferie, e che fornisca immediato
« avviso di un sopravvenuto impedimento incidente sulla prestazione », come la malattia (468). A tal stregua, pur in assenza
disposizioni contrattuali espresse sul punto, si è legittimato il
licenziamento di un pilota d’aereo che, comunicando di essersi
ammalato nell’imminenza del volo, aveva determinato notevoli
disservizi (469). È stato, invece, ritenuto passibile di mera sanzione
disciplinare il dipendente, che, non avendo comunicato la causa
della sua patologia, riconducibile a infortunio in itinere, aveva
provocato nel datore l’erroneo convincimento del superamento del
(467) Così Giugni, 1963, p. 153, sia pur nell’ambito di una diversa ricostruzione di tali
obblighi.
(468) Del Punta, 1992, p. 111; Mazzotta, 1983, p. 6; con riguardo specifico all’impiego
pubblico, da ultimo, Casale, 2013, p. 141; in giurisprudenza, per la corretta riconduzione
dell’obbligo di tempestiva comunicazione della malattia agli artt. 1175 e 1375, v. Cass. civ.,
sez. lav., 9 marzo 1987, n. 2452, in FI, 1987, I, c. 3082 ss.; nonché nell’ambito del pubblico
impiego “non privatizzato”, Cass. civ., Sez. Un., 5 agosto 2002, n. 11724, in GDA, 2003, p.
241 ss., con nota di Mainardi; Cass. civ., sez. lav., 1° marzo 2004, n. 4163, in RIDL, 2004,
II, p. 827 ss., con nota di Barraco, a cui avviso « l’obbligo di comunicazione e giustificazione
della malattia si pone su un piano diverso rispondendo a doveri di correttezza nei confronti
del datore di lavoro, non solo per fornirgli un’informazione utile al fine di consentirgli di
richiedere la visita di controllo, ma anche, ad esempio, per informarlo della presumibile
durata dell’assenza e metterlo in grado, tra l’altro, di sopperire tempestivamente alla
carenza di forza lavoro determinata dall’assenza del lavoratore »; in tema v. anche Cass. civ.,
sez. lav., 19 agosto 1986, n. 5088, in Not. giur. lav., 1986, p. 707 ss.; Trib. Milano, 2 aprile
2008, in RCDL, 2008, 1272, con nota di Lotti.
(469) Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1984, n. 1977, in GC, 1984, I, p. 2170 ss., con nota
di Poso.
332
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
periodo di comporto, inducendolo a procedere al licenziamento (470).
Analogo dovere di comunicazione vige, poi, con riguardo alla
certificazione dell’evento morboso, ma come è stato a ragione
osservato, « la normativa positiva in materia è talmente fitta e
sviluppata da rendere di fatto largamente superfluo il ricorso alla
clausola generale della buona fede » (471).
A detta clausola si deve, invece, far richiamo, senza bisogno di
invocare la fedeltà “in senso ampio” dell’art. 2105 c.c., nel caso di
mancata denuncia da parte di un bancario vice-direttore di filiale
delle gravi irregolarità commesse dal direttore, suo superiore gerarchico, poiché condotta tale da violare il dovere di preservare
l’organizzazione del lavoro da elementi che ne ostacolino il buon
funzionamento (472).
Allo stesso modo, può considerarsi, e a ragione, comportamento contrario a buona fede quello del lavoratore, che, avendo
stipulato con altra azienda un contratto di lavoro ad efficacia
differita e « meditando di rassegnare successivamente le dimissioni
nei termini del preavviso, ometta di darne comunicazione al datore, pur consapevole che il silenzio serbato, ancorché non colpevole, provoca a costui danni e disagi » (473).
Sono, invece, riconducibili alla violazione dell’art. 2105 c.c. i
casi in cui il lavoratore abbia « omesso di comunicare al datore di
lavoro che i lavori sottoposti al suo controllo, quale supervisore,
erano svolti da società partecipate da propri familiari » (474)
oppure abbia stipulato, senza comunicarlo, un contratto di consulenza con un’altra società avente interessi configgenti rispetto alla
propria impresa (475).
Sono sempre le clausole generali di correttezza e buona fede a
imporre al lavoratore un obbligo non solo di fornire avvisi e
comunicazioni, ma anche di riceverli. La cosa non è stata colta del
(470) Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2005, n. 17780, in MGI, 2005.
(471) Del Punta, 1992, p. 113 s.
(472) Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2001, n. 7819, in ADL, 2003, p. 151 ss., con nota
di Fiata.
(473) Saffioti, 1999, p. 217.
(474) V. Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6957, cit., che invece invoca a tal fine
la classica nozione “allargata” di fedeltà.
(475) Trib. Roma, 18 novembre 1996, in OGL, 1996, p. 923 ss.
333
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tutto dalla giurisprudenza, che, affermando il dovere del dipendente di accettare la consegna a mano della lettera di licenziamento, ha preferito innervarlo nella « soggezione che lega il prestatore al datore », limitandone peraltro (curiosamente) l’ambito
applicativo all’interno dei locali dell’impresa e durante l’orario di
lavoro (476). È interessante, però, notare come l’orientamento in
commento sottolinei particolarmente proprio la reciprocità del
citato obbligo, a conferma (implicita) della sua collocazione nell’area governata dagli artt. 1175 e 1375 c.c., ritenendo che non
possa escludersi un complementare « obbligo di ascolto, e quindi
anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore » (477).
Tale reciprocità va, peraltro, tenuta ben presente quando si
discuta a proposito dell’esistenza di un dovere dell’imprenditore di
avvertire il lavoratore, assente da lungo tempo per malattia,
dell’approssimarsi della scadenza del comporto, anche allo scopo
eventuale di richiedere un periodo di aspettativa o di ferie. L’orientamento dominante nega fermamente tale dovere, in assenza di
esplicita previsione del contratto collettivo e individuale (478). Ma
regole di correttezza desumibili dalla comune coscienza generale
vorrebbero che si operasse quantomeno un distinguo a riguardo, sì
da prestare particolare attenzione a casi particolari, ove l’esigenza
di solidarietà e di salvaguardia della persona del prestatore è molto
sentita e prevale rispetto all’interesse di controparte. Va, pertanto,
salutata con favore la tesi recentemente emersa presso la giurispru(476) Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2007, n. 23061, in LG, 2008, p. 307 ss.; Trib.
Genova, 14 dicembre 2013, in ADL, 2014, p. 798 ss., con nota di Biagiotti; conforme anche
Cass. civ., sez. lav., 5 giugno 2001, n. 7620, in RIDL, 2002, II, p. 141 ss., con nota di Vincieri,
che, tuttavia, sia pur non persuasivamente, quantomeno accenna alla questione della buona
fede, affermando che un obbligo di ricevere comunicazioni del datore « non sussiste al di
fuori dell’orario e del posto di lavoro », né, nel caso di specie, si poteva dire esistente un
obbligo della lavoratrice « di ricevere la missiva offertale dal fattorino della datrice di lavoro,
sulla base delle intese al riguardo raggiunte con la medesima o, comunque, di ragioni di
correttezza o buona fede desumibili da particolarità della fattispecie ».
(477) Cass. civ., sez. lav., 5 giugno 2001, n. 7620, cit.; Trib. Genova, 14 dicembre
2013, cit.; analogamente Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2007, n. 23061, cit.
(478) Cass. civ., sez. lav., 1° agosto 2014, n. 17538, in CED Cass., 2014; Cass. civ., sez.
lav., 21 settembre 2011, n. 19234, in LG, 2011, p. 1260, con nota di Giovanardi; Cass. civ.,
sez. lav., 22 aprile 2008, n. 10352, in Leggi d’Italia, 2008; Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2006,
n. 14891, in CED Cass., 2006; Trib. Milano, 12 novembre 2012, in http://
www.unico.lavoro.ilsole24ore.com.
334
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
denza di merito, secondo cui « se è vero che ordinariamente il
lavoratore è in grado di verificare l’approssimarsi della scadenza
del periodo di comporto », non lo stesso accade a fronte di « situazioni di salute particolarmente delicate e gravi », che impongono
« un diverso e più attivo comportamento » da parte dell’azienda,
per il rispetto che si deve ai precetti derivanti dall’art. 1175 c.c.,
nonché ai più generali principi di solidarietà sociale dell’art. 2
Cost. (479).
Resta ferma, inoltre, alla luce di quanto finora detto, che
devono ritenersi funzionalizzati al soddisfacimento dell’interesse di
protezione del prestatore anche gli obblighi di informazione in
tema di sicurezza (480), che, tuttavia, gravando sul datore ai sensi
di legge (artt. 18 e 36 d.lgs. n. 81 del 2008), rendono superfluo ogni
richiamo alle clausole generali.
Sono ascrivibili, inoltre, alla categoria degli obblighi di protezione anche tutti quei comportamenti diretti — al di là dell’esecuzione della prestazione — a salvaguardare l’organizzazione produttiva dal punto di vista delle regole che presiedono al corretto
uso e funzionamento degli spazi, dei locali, nonché alla civile
coabitazione tra le persone.
La violazione di tali obblighi si tradurrà in condotte, che,
siccome non immediatamente collegate allo svolgimento della prestazione, riguarderanno per lo più i momenti di pausa dal lavoro,
come, ad esempio, il caso, riportato in dottrina, della rissa avvenuta all’interno della mensa (481). Tuttavia, essa potrà anche
concretizzarsi nell’impiego di modalità relazionali scorrette, ingiuriose, aggressive, pure per il lessico utilizzato (482), nei confronti
(479) Trib. Bologna, 15 aprile 2014, in Leggi d’Italia, 2014, concernente il licenziamento per scadenza del periodo di comporto di una lavoratrice assentatasi dal lavoro per
l’insorgere di una neoplasia con necessità di interventi chirurgici, e operata nuovamente,
dopo essere rientrata al lavoro, fino ad entrare anche in coma in quello stesso periodo;
analogamente Trib. Milano, 21 maggio 2005, in RCDL, 2005, p. 887 ss., con nota di Bordone.
(480) Su tali obblighi, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377, in
MGL, 2004, p. 76 ss.
(481) Pisani, 2004, p. 126.
(482) V. Cass. civ., sez. lav., 26 ottobre 1982, n. 5618, cit., che ricollega al dovere di
correttezza, ma anche a quello di « fedeltà (in senso ampio) » il « dovere (diverso dall’esecuzione della prestazione lavorativa) che il dipendente è tenuto ad osservare — in forza del
contratto — » a non tenere « atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri lavoratori »; cfr.
pure Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2000, n. 8313, in RIDL, 2001, II, p. 122 ss., con nota di
335
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dei colleghi, dei superiori gerarchici, se non dello stesso datore, fino
al limite della molestia sessuale e del mobbing, punibili, tuttavia,
senza ricorso alle clausole generali, considerato il dovere di cura
delle persone presenti sul luogo di lavoro, gravante sul prestatore
ex artt. 2087 c.c. e 20 d.lgs. n. 81 del 2008. Allo stesso modo, sarà
sufficiente un richiamo a detta norma, per il caso in cui il lavoratore si sottragga all’obbligo di segnalare situazioni di pericolo o di
malfunzionamento della struttura produttiva incidenti sull’igiene
e la sicurezza del lavoro.
Rappresenta, infine, condotta contraria a correttezza e buona
fede, sub specie di violazione dell’interesse imprenditoriale al rispetto dell’organizzazione produttiva e gestionale, quella di dipendenti di un’azienda produttrice e distributrice di mobili, i quali,
fuori dall’orario di lavoro e a pagamento, curino il montaggio del
mobilio stesso, svolgendo così, in proprio, un servizio appaltato
invece (in esclusiva) dall’azienda medesima a società esterna (483).
11.3. Comportamenti diretti alla salvaguardia dell’organizzazione in senso “dinamico” (dovere di protezione dell’organizzazione dal punto di vista economico e di mercato).
Vi sono tutta una serie di comportamenti di protezione che
possono essere pretesi dall’impresa nell’ambito del rapporto di
lavoro, siccome diretti alla salvaguardia dell’organizzazione da un
punto di vista strettamente economico: del suo patrimonio, della
Vallauri, per la quale « il livello culturale e le abitudini lessicali » del prestatore e degli altri
« addetti all’azienda non rilevano ai fini di escludere che l’aver proferito espressioni ingiuriose nei confronti del superiore gerarchico sia qualificabile come giusta causa di licenziamento »; in tema Montuschi, 2001a, p. 1051, il quale osserva come « attraverso la “lente”
della giusta causa, i giudici sono chiamati a censurare il costume degli italiani e le “abitudini
lessicali degli operai, non disdegnate neppure dagli impiegati e dai dirigenti”. In una parola,
conoscono le miserie e il degrado dei rapporti interpersonali che consegue alla generale
sotto-stima dei valori etico-morali, considerati un retaggio ottocentesco, buono per “il
salotto di nonna Speranza” »; cfr. pure Gragnoli, 1996, p. 71.
(483) Cfr. Trib. Genova, 11 aprile 2013, cit., che, tuttavia, insiste — inutilmente, a
nostro avviso, sussistendo una violazione dell’obbligo di protezione indipendentemente
dalla produzione di un danno (v. retro, in testo, § 3.2.) — soprattutto sul pregiudizio
provocato all’azienda dai prestatori, che, avendo svolto il montaggio senza la necessaria
perizia, avevano danneggiato il cliente, costringendo a quel punto l’azienda stessa a
intervenire, ma con aggravio di costi non previsti, su richiesta del medesimo cliente, per
riparare alla cosa ed evitare così un vulnus all’immagine aziendale.
336
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
sua proiezione sul mercato, dell’avviamento, del prestigio e dell’immagine, del buon nome dei prodotti e servizi. Taluni di questi
contegni sono già qualificabili come vincolanti in forza dell’art.
2105 c.c., il quale tipizza, come si diceva, due doveri di non fare,
finalizzati alla tutela della capacità di concorrenza dell’impresa e
della sua posizione di mercato. È giusto quindi ritenere che, in
quest’ambito, i doveri di correttezza e buona fede dovranno spartirsi il campo con quello di fedeltà, stavolta inteso “in senso
stretto”, secondo quanto contemplato dal legislatore, quando vieta
al prestatore di lavoro di « trattare affari per conto proprio o di
terzi, in concorrenza con l’imprenditore » (obbligo di non concorrenza), nonché di « divulgare notizie attinenti all’organizzazione e
ai metodi di produzione dell’impresa », o « di farne uso in modo da
poter recare ad essa pregiudizio » (obbligo di riservatezza). Si vedrà
se e in che misura la tipizzazione di tali obblighi renda superfluo
ogni richiamo agli artt. 1175 e 1375 c.c., esaurendo così gli spazi
riservati a correttezza e buona fede, allorché dette clausole siano
volte a proteggere l’organizzazione imprenditoriale in senso dinamico.
Si cercherà altresì di comprendere se condotte idonee a porre a
repentaglio l’immagine, il buon nome e il generale il progetto
organizzativo dell’impresa possano dirsi contrarie agli obblighi di
protezione gravanti sul dipendente, allorché siano tenute al di fuori
dell’orario di lavoro e ineriscano alla vita privata del medesimo.
11.3.1. Dovere di protezione dell’organizzazione dal punto di
vista economico.
Configurano violazione dei doveri di protezione ex artt. 1175 e
1375 c.c. tutti quei comportamenti volti a pregiudicare il patrimonio del datore di lavoro, attraverso l’appropriazione di somme di
danaro dell’azienda, il tentativo di truffa (484), o altre analoghe
azioni. È stato, del resto, lo stesso Giudice delle leggi a pronunciarsi
espressamente in tal senso, quando ha rilevato come « l’illecito
impossessamento del contenuto della corrispondenza operato da
agenti del servizio postale al fine di trarne profitto per sé o altri »
non configura un’ipotesi di negligenza nell’adempimento della
prestazione, bensì costituisce inottemperanza « dell’obbligo speci(484)
Cass. civ., sez. lav., 17 giugno 1991, n. 6814, in MGI, 1991.
337
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
fico di evitare nell’esecuzione del contratto comportamenti pregiudizievoli alla persona e ai beni del creditore: obbligo pure derivante
dal contratto in virtù della regola di correttezza sancita dall’art.
1175 c.c. » (485).
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha, al contrario,
sempre privilegiato diverse ricostruzioni a riguardo. Di solito, ha
richiamato la lesione del vincolo fiduciario, con l’effetto, ad esempio, di ritenere valido il licenziamento irrogato alla cassiera di un
supermercato che aveva indebitamente utilizzato una tessera
punti-sconto riservata ai clienti, nonostante il « tenue valore economico » del danno arrecato al datore di lavoro (486). All’opposto,
ha reputato illegittimo il recesso nei confronti del dipendente della
società Aeroporti di Roma per aver venduto a terzi, anziché
utilizzarli direttamente, due biglietti aerei acquistati a tariffa
ridotta, anche in ragione della « tenuità » del pregiudizio sopportato dall’azienda.
Talora i giudici hanno, invece, valutato la gravità della condotta del prestatore sotto il singolare profilo del suo « disvalore
ambientale ». Hanno così giudicato legittimo il licenziamento irrogato al responsabile della piccola cassa di uno stabilimento industriale per essersi appropriato « di due importi di vecchie lire
1.200.000 e 500.000 senza autorizzazione e senza giustificativi,
omettendo di restituirli » e così rappresentando, con la sua condotta, un « modello diseducativo o comunque disincentivante nei
confronti degli altri dipendenti della compagine aziendale, specialmente se a lui sottoordinati », data la sua specifica posizione
professionale e la responsabilità nel servizio svolto (487).
11.3.2. Doveri di protezione e atti preparatori della concorrenza.
Si discute circa la riconduzione, nell’ambito delle condotte
vietate dall’art. 2105 a tutela della competitività dell’impresa, dei
c.d. atti preparatori della concorrenza.
La nozione ampia di affari concorrenziali (488) e la configurazione del divieto di concorrenza nei termini di un divieto di
(485)
(486)
(487)
(488)
Corte Cost., 17-28 febbraio 1992, n. 74, cit.
Trib. Milano, 16 novembre 2000, in OGL, 2000, p. 962 ss.
Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 2002, n. 17208, cit.
Bellomo, 2013, p. 317.
338
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
“pericolo” (489) porta la giurisprudenza prevalente a concludere
che detti atti rappresentano l’avvio dell’attività concorrente con
violazione, pertanto, della citata norma codicistica (490). Rimarrebbero, di conseguenza, estranee al suddetto divieto le sole esternazioni intenzionali non accompagnate dal compimento di atti
preparatori strictu sensu intesi.
In quest’ottica costituirebbero, tra gli altri, inadempimento
dell’art. 2105 c.c. la costituzione di una società il cui oggetto sociale
prevalente coincida totalmente o parzialmente con l’attività del
datore di lavoro (491), l’acquisto, da parte della moglie del dirigente, di alcune quote della società concorrente (492), il c.d. storno
di dipendenti (493) e, secondo parte della dottrina, lo svolgimento
di attività lavorativa a carattere subordinato ovvero autonomo in
favore di impresa concorrente (494), a prescindere dalle mansioni
cui il lavoratore viene adibito (495).
Le opinioni non appaiono comunque del tutto unanimi in
materia (496); ma la cosa dovrebbe scarsamente rilevare ai nostri
fini, poiché ciò di cui si discute è la riconducibilità o meno di taluni
comportamenti nella nozione di “atti preparatori”, non l’ascrivibilità di questi ultimi — ossia degli atti preparatori medesimi —
alla fattispecie vietata dell’art. 2105. Ne deriva che non v’è alter(489) Menegatti, 2012a, p. 83.
(490) Cass. civ., sez. lav., 1° febbraio 2008, n. 2474, cit.; Trib. Bologna, 31 gennaio
2006, n. 690, in GD, 2006, 37, p. 87 ss.; App. Milano, 20 febbraio 2004, in LG, 2004, p. 1009
ss.; Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2003, n. 19132, ivi, 2004, p. 593 ss.; Cass. civ. sez. lav.,
17 febbraio 1987, n. 1711, in NGL, 1987, p. 413 ss.; Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 1987, n.
595, in MGI, 1987.
(491) App. Milano, 15 febbraio 2001, in LG, 2001, p. 895 ss.; Cass. civ., sez. lav., 20
gennaio 1987, n. 495, in MGI, 1987; Cass. civ., sez. lav., 2 febbraio 2004, n. 1878, cit..; Cass.
civ., sez. lav., 26 agosto 2003, n. 12489, cit..; Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2006, n. 16377, in
MGI, 2006.
(492) Cass. civ., sez. lav., 1° giugno 1988, n. 3719, cit.
(493) App. Milano, 20 febbraio 2001, cit.; in dottrina, Mattarolo, 2000, p. 115.
(494) Bellomo, 2013, p. 319.
(495) Boscati, 2012, p. 990 s.; contra, in giurisprudenza, Trib. Milano, 28 novembre,
1998, in OGL, 1998, p. 909 ss., il quale ritiene che « non configura giusta causa di licenziamento
per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., il semplice svolgimento di mansioni esecutive in favore di una impresa concorrente da parte di un lavoratore impiegato a
tempo parziale, non essendo tale attività idonea ad arrecare danno al datore di lavoro »;
condivide questa impostazione giurisprudenziale Mattarolo, 2000, p. 89.
(496) V. sul punto Mattarolo, 2000, p. 111 ss.
339
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
nativa: o una condotta configura “atto preparatorio” e allora è
vietata ex art. 2105 oppure, se non può dirsi tale, sarà senz’altro
legittima anche ai sensi degli artt. 1175 e 1375, perché insuscettibile di determinare quei pericoli anche potenziali all’organizzazione produttiva intesa in senso dinamico, che il richiamo alle
clausole generali intende evitare, col prescrivere condotte del prestatore ispirate a correttezza e buona fede. Con il che è implicitamente dimostrato che quando la posizione di mercato dell’imprenditore è posta a repentaglio da comportamenti atti a nuocere anche
solo potenzialmente all’impresa sul piano concorrenziale, l’art.
2105 c.c. esaurisce ogni spazio riservato alle clausole sopramenzionate, costituendone, appunto, la specificazione, e ne rende superfluo il richiamo.
11.3.3. Doveri di protezione e denuncia, critica o divulgazione
di notizie pregiudizievoli per l’impresa.
Vi sono ipotesi in cui gli obblighi di protezione, posti a salvaguardia dell’organizzazione in senso dinamico, devono fare i conti
con specifici diritti o interessi assicurati alla persona del prestatore
da norme preminenti rispetto a quelle che tutelano l’interesse
dell’imprenditore. A ragione si è osservato che le aspettative economiche dell’impresa prevalgono « su esigenze del lavoratore della
medesima natura, cioè patrimoniali », ma « sono subordinate a
quelle personali del dipendente » (497). Ciò è coerente con la stessa
funzione attribuita a detti obblighi, di salvaguardare l’utilità della
controparte, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile
sacrificio dell’interesse proprio.
Si tratta di un interesse che non può declinare, tanto se più
corrispondente a posizioni soggettive attive del prestatore, riconosciute nella forma di diritti: il diritto alla difesa in sede giurisdizionale; il diritto alla denuncia alle autorità competenti di vicende
collegate all’esigenza di tutela dei lavoratori o di terzi; il diritto alla
libera manifestazione del proprio pensiero, attraverso la diffusione
di fatti ovvero l’espressione di giudizi e opinioni in ambito extraaziendale.
In senso contrario, non è invocabile il richiamo ad un supposto
vincolo fiduciario sussistente tra i contraenti, utilizzato in connu(497) « Salva la tutela dei diritti, anche giurisdizionale »: Gragnoli, 1996, p. 59.
340
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
bio con la solita nozione “allargata” di fedeltà, sì da accreditare
l’esistenza di un dovere di leale comportamento a carico del dipendente (498). Neppure è pertinente un generico riferimento alla
correttezza e alla buona fede, considerato che dette clausole, nella
loro funzione di salvaguardia della posizione economica di mercato
dell’azienda, hanno ricevuto apposita specificazione e tipizzazione
all’art. 2105 c.c. (499), dando vita a due precisi obblighi di non
facere. Pertanto, è con riferimento a questi ultimi che andranno
valutate vicende come quelle inerenti, ad esempio, all’utilizzo
processuale di documenti aziendali.
Se il prestatore ne è venuto in possesso legittimamente, ossia
ne abbia avuto accesso nel corso dell’esercizio delle sue funzioni,
allora non dovrebbero rinvenirsi particolari restrizioni nell’esibizione di tali documenti sia in ambito giurisdizionale, sia all’interno
di tentativi di conciliazione o « di interventi apprestati dalle organizzazioni sindacali a vario titolo » (500).
Anche la loro materiale riproduzione in fotocopia (501) non
può essere illegittima, qualora ricorrano ragioni di difesa del prestatore. D’altronde, la fattispecie è lungi dal comportare una
violazione del divieto di divulgazione della documentazione aziendale ai sensi dell’art. 2105 c.c. La produzione in giudizio, infatti,
non integra gli estremi della « divulgazione », considerato il numero
limitato di persone che vengono a conoscenza di detta documentazione, nonché il contesto in cui ciò avviene (502). Si può semmai
rientrare nella diversa ipotesi dell’uso delle notizie aziendali (503),
(498) Così, invece, Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2009, n. 16000, in GL, 2009, 41, p. 46
ss.; Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2004, n. 11220, cit.; in senso critico, da ultimo Papa, 2010,
p. 810 ss.; Dessì, 2013, p. 402 ss.
(499) Sull’obbligo di fedeltà come specificazione delle clausole generali di buona fede
e correttezza V. Mancini, 1957, p. 131; Grandi, 1987, p. 343; Mengoni, 1965, p. 477; Pisani,
2004, p. 121 s.
(500) Gragnoli, 1996, p. 59.
(501) Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2004, n. 12528, cit., ove espressamente si afferma
che la fotocopia di documenti non integra gli estremi della sottrazione degli stessi; in
dottrina, Pisani, 2004, p. 142 ss.; Mattarolo, 2000, p. 201.
(502) Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3038, in MGC, 2011, p. 197 ss.; Cass. civ.,
sez. lav., 4 maggio 2002, n. 6420, cit.; in dottrina Mattarolo, 2000, p. 200; Boscati, 2012, p.
1005.
(503) V. Mattarolo, 2000, p. 203, la quale precisa che « non sempre la riproduzione di
documentazione contenente notizie anche riservate può essere ricompresa nel concetto di
uso di notizie (...), giacché spesso si tratta di una mera conservazione di documenti »; in
341
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
il cui carattere ipoteticamente pregiudizievole per il datore è
destinato a cedere, di necessità, a fronte delle esigenze processuali
del prestatore, espressione del diritto di difesa di cui all’art. 24
Cost. (504)
Diverso è il discorso ove vi sia stata sottrazione di documenti
aziendali, siccome estranei alla disponibilità del prestatore, secondo modalità illegittime — sottrazione ai colleghi, forzature
degli archivi, ecc. — qui venendo effettivamente in rilievo il
mancato rispetto degli artt. 1175 e 1375, sub specie di violazione
degli obblighi “atipici” di protezione, posti a salvaguardia dell’organizzazione imprenditoriale in senso sia “statico”, sia “gestionale”, ossia del patrimonio complessivo dell’impresa e del normale
funzionamento dell’attività aziendale (505).
Chiamano in causa l’art. 2105 c.c. anche quei comportamenti
del prestatore, che si concretino nella presentazione di denunce o
esposti alle autorità competenti circa eventuali irregolarità commesse dal datore di lavoro (506). Se si guarda a una recente
pronuncia (507), emblematica tuttavia di un orientamento consolidato, è facile riscontrare come la giurisprudenza tenda a escludere
il contrasto con la norma codicistica sopra menzionata, giungendo
pertanto a ritenere invalido il licenziamento disciplinare irrogato
in tali casi dal datore (508). Lo fa, però, sullo sfondo di una
ricostruzione teorica del rapporto di lavoro che non si allontana,
almeno formalmente, dal richiamo persistente al “vincolo fiduciario”. Così, la denuncia di fatti illeciti commessi all’interno dell’asenso contrario Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 1993, n. 2560, in RIDL, 1993, II, p. 476 ss., con
nota di Poso, Mammone.
(504) Sulla produzione in giudizio di documentazione aziendale come esercizio del
diritto di difesa ex art. 24 Cost., v. Marinelli F., 2005, p. 527.
(505) Pisani, 2004, p. 142 s.; invece la giurisprudenza fonda anche l’illegittimità di
tali condotte sui doveri di lealtà e correttezza dell’art. 2105, trascurando dunque il fatto che
in questo caso l’antigiuridicità del comportamento del lavoratore deriva dalle modalità di
sottrazione del documento, e non dall’uso dello stesso: v. Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre
2001, n. 13188, in NGL, 2002, p. 45.
(506) In tema, v. Carinci M.T., 2014b, p. 6 ss. anche se con un approccio, che è tipico
di coloro i quali si occupano di whistleblowing teso a porre sullo stesso piano le denunce
all’autorità competenti con le denunce a giornali e mass media, le quali invece si connettono
al tema del diritto di critica.
(507) Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2013, n. 6501, cit.
(508) Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2013, n. 1814, in CED Cass., 2013; Cass. civ., sez.
lav., 12 dicembre 2012, n. 22798, in CED Cass., 2012.
342
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
zienda è, per i giudici, contegno incapace di giustificare il recesso
del datore, in quanto inidoneo a ledere la fiducia dell’imprenditore.
È peraltro curioso notare come il riferimento alla fiduciarietà
della relazione di lavoro non precluda ai magistrati un successivo
confronto con il « dovere di riservatezza », contemplato all’art.
2105 c.c. La giurisprudenza ne offre, a questo punto, una lettura
restrittiva, ritenendo tale dovere circoscritto al solo « divieto di
abuso di posizione mediante condotte concorrenziali e/o violazioni
di segreti produttivi (non già segreti tout court non meglio specificati) ».
La posizione può essere comprensibile, se si considera che i
giudici, con il consueto pragmatismo, tentano in ogni modo di
offrire tutela giuridica a chi denunci illeciti alle autorità competenti anche all’interno del rapporto di lavoro (privato) (509), salvo
il carattere calunnioso della denuncia stessa o dell’esposto. « Diversamente », affermano gli stessi giudici, « si correrebbe « il rischio
di scivolare » in « una sorta di dovere di omertà (ben diverso da
quello di fedeltà di cui all’art. 2105) », il quale, « ovviamente non
può trovare la benché minima cittadinanza nel mostro ordinamento » (510).
La posizione può essere comprensibile, ma non è appagante,
perché così argomentando, si finisce per arrivare al paradosso di
una fiduciarietà del rapporto ormai del tutto mancante di fondamento, giacché privata persino del suo più consolidato aggancio
normativo alla fedeltà “in senso lato”, e di un dovere di riservatezza, letto secondo criteri assai stringenti, ben più di quelli comunemente invalsi presso la dottrina.
Piuttosto sarebbe il caso di ragionare sul fatto che l’art. 2105
impone un obbligo — di « non divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, né (di) farne
uso » secondo modalità pregiudizievoli per l’impresa — obbligo
(509) Nel settore pubblico, l’art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 tutela espressamente il
dipendente che segnala illeciti, disponendo che non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Sul punto v.
Carinci M.T., 2014b, p. 4 che rileva che la norma si limita ad affermare esplicitamente per
il pubblico impiego principi già ricavabili dal sistema nel suo complesso e valevoli anche per
i dipendenti del settore privato.
(510) Cass., civ., sez. lav., 14 marzo 2013, n. 6501, cit.
343
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
che, in quanto ascrivibile alla categoria degli obblighi di protezione, cede a fronte di un apprezzabile sacrificio dell’interesse del
prestatore; sicché un dovere di astensione da denunce alle autorità
competenti non potrà mai ravvisarsi di fronte a prevalenti interessi
personali del medesimo e della stessa collettività. A tal stregua,
bisognerebbe considerare al riparo da legittime reazioni disciplinari
dell’imprenditore il comportamento del lavoratore, che denunci il
proprio datore per atti illeciti, anche qualora questi non afferiscano
strettamente alla tutela dei lavoratori e delle loro aspettative, ma
solo ad interessi pubblici (diversi) (511).
Potrebbe, invece, fondatamente pretendersi dal lavoratore,
stavolta sì ai sensi di correttezza e buona fede, che una tale
denuncia non cali sul datore come una sorta di “doccia fredda”, ma
rappresenti piuttosto l’extrema ratio, ossia l’esito finale, almeno ove
possibile, di un dialogo interno della struttura imprenditoriale teso
a sollevare preventivamente il problema, affinché l’organizzazione
produttiva medesima, nella persona del datore e dei suoi collaboratori vi possa, volendo, reagire e porvi rimedio.
Discorsi non del tutto diversi debbono compiersi allorché gli
obblighi di protezione siano chiamati a fare i conti con la necessità
di garantire l’esercizio del diritto di critica del lavoratore, estrinsecazione della più generale libertà di espressione del pensiero di
cui all’art. 21 Cost., libertà ribadita dall’art. 1 St. lav. e attinente
alla manifestazione e alla divulgazione delle proprie opinioni.
Per i motivi sin qui prospettati, la questione non può essere
affrontata sulla scorta di una presunta “connotazione fiduciaria”
del rapporto, come ha, invece, sovente ritenuto la giurispru(511) V. Carinci M.T., 2014b, p. 8, la quale rileva come la denuncia del lavoratore
possa riguardare condotte del datore di lavoro che concretino o possano concretare illeciti
sul piano penale, amministrativo o civile; sul punto v., in giurisprudenza, Cass. civ., sez.
lav., 16 gennaio 2001, n. 519, in RIDL, 2001, II, p. 453 ss., con nota di Di Paola; in senso
contrario Gragnoli, 1996, p. 61 s., secondo cui « in casi gravi », il datore di lavoro « può anche
recedere dal rapporto con chi gli provochi misure sanzionatorie, qualora gli illeciti denunciati non afferiscano alla tutela dei lavoratori, della loro sicurezza o delle loro aspettative.
Nel caso consueto in cui il dipendente riconosca trasgressione alla disciplina tributaria o ad
altre previsioni, l’imprenditore può pretendere una astensione, se tale silenzio è irrilevante
per il prestatore di opere e non incide sulla sua sfera giuridica, seppure in via ipotetica. La
fedeltà si estende fino al divieto della sollecitazione di interventi punitivi delle autorità
pubbliche, qualora non rilevino prevalenti interessi personali, anche di terzi ».
344
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
denza (512). Né si può pensare di doversi indirizzare verso la
valorizzazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., perché questi, ove
orientati alla salvaguardia dell’organizzazione intesa in senso dinamico, cioè alla tutela della posizione di mercato dell’imprenditore, trovano specificazione e tipizzazione nell’art. 2105 c.c., la cui
previsione di un dovere di riservatezza a carico del prestatore
appare sufficientemente ampio per ridurre alquanto gli spazi applicativi delle clausole generali.
È ben vero che non tutte le accuse o critiche anche pesanti
« comportano necessariamente la divulgazione di notizie attinenti
all’organizzazione o ai metodi di produzione dell’impresa o possano
favorire direttamente la concorrenza a danno del datore di lavoro
medesimo » (513). Ciò se non altro perché ci si può trovare pur
sempre di fronte a giudizi, ad esempio, relativi alla sola persona del
datore di lavoro, che non involgano quindi la sua struttura produttiva, comportando semmai un danno economico a quest’ultima
solo di riflesso. In tal caso saranno certo gli artt. 1175 e 1375 c.c. a
far da argine a comportamenti scorretti del prestatore.
Più spesso, tuttavia, l’esternazione di fatti e opinioni chiama
immediatamente in causa l’art. 2105 c.c., considerata soprattutto
la lettura ampia che si fa del dovere di riservatezza ivi contemplato. Da un lato, si ritiene che esso tuteli la posizione economica
dell’impresa nel suo complesso, mirando a salvaguardare quest’ultima da qualsiasi pregiudizio, anche non tipo strettamente concorrenziale (514), incluso, pertanto, a questo punto, quello relativo
all’immagine aziendale presso i consumatori (515). Dall’altro lato,
si è generalmente offerta una lettura particolarmente ampia dell’oggetto della prescrizione, ritenendosi che il legislatore abbia
inteso riferirsi « a tutte le cognizioni concernenti i “metodi di
(512) Cass. civ., sez. lav., 18 settembre 2013, n. 21362, in CED Cass., 2013; Cass. civ.,
sez. lav., 10 dicembre 2008, n. 29008, ivi, 2008; Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2004 n. 11220,
cit.; Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2003 n. 14179, ivi, 2003; Cass. civ., sez. lav., 17 settembre
2009, n. 20048, in GD, 2009, 44, p. 59 ss.; Trib. Palermo, 24 maggio 1995, in OGL, 1995, p.
316 ss.
(513) Mattarolo, 2000, p. 190.
(514) Ibidem, p. 160; Gragnoli, 1996, p. 56.
(515) Diversamente parrebbe Pisani, 2004, p. 137 quando afferma che il pregiudizio
all’avviamento, all’immagine, il discredito al buon nome dell’azienda, ai suoi prodotti e
servizi sia coperto dagli obblighi di protezione atipici di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c.
345
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
produzione” e “la organizzazione”, senza riguardo esclusivo per le
soluzioni tecniche, per le strategie di presenza sul mercato, per i
profili finanziari, ma con la considerazione di ogni aspetto significativo per l’iniziativa economica » (516).
Di fronte alla necessità di garantire l’esercizio del diritto di
critica, il dovere di riservatezza deve, ad ogni modo, cedere il
passo. Al contrario di quanto ritiene la giurisprudenza, non v’è
alcun bilanciamento tra diritti costituzionali da operare: da un
lato, l’art. 21 Cost.; dall’altro, l’art. 2 Cost. Né si tratta di evocare
criteri tratti dal c.d. decalogo dei giornalisti (517), per elaborare, su
tale falsariga, il c.d. decalogo del buon lavoratore (518), il cui
dissenso potrà essere legittimamente esercitato solo quando i fatti
denunciati siano veri (519) o ritenuti tali dallo stesso, vengano
espressi con toni improntati a correttezza e misura (520) e la loro
divulgazione sia connessa ad un interesse di rilevanza sociale (521).
Nel contesto del rapporto di lavoro, tuttora condizionato da una
concezione prettamente fiduciaria del rapporto, questi criteri sono
spesso serviti per affermare la legittimità del diritto di critica, nei
limiti segnati da una non meglio precisata esigenza di tutelare il
decoro, nonché l’immagine dell’azienda (522).
Bisognerebbe, invece, prendere atto del fatto che quello alla
riservatezza è obbligo di protezione, destinato a dover essere
ottemperato solo nei limiti segnati dall’inesistenza di un apprezzabile sacrificio dell’interesse proprio. Come per la denuncia di
illeciti all’autorità competente, anche in questo caso, allora, è la
(516) Gragnoli, 1996, p. 55.
(517) Dessì, 2013, p. 398.
(518) Cfr. Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 1986, n. 1173, in RIDL, 1987, II, p. 127 ss.,
con nota di Trioni; in dottrina, Aimo, 2003, p. 246 ss.
(519) Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2009, n. 16000, cit.; Cass. civ., sez. lav., 15 maggio
1998, n. 4952, cit..
(520) Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2004, n. 11220, cit.; Cass. civ., sez. lav., 15 maggio
1998 n. 4952, cit..
(521) In tema, Carinci M.T., 2014a, p. 521; per la giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez.
lav., 10 dicembre 2008, n. 29008, cit.; Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2004, n. 11220, cit.; Trib.
Milano, 6 febbraio 2014, in RIDL, 2014, II, p. 504 ss., con nota di Carinci M.T.
(522) Non è neppure corretto, peraltro, risolvere coi medesimi criteri il problema
dell’esercizio del diritto di critica, quando questo riguardi il singolo prestatore e il sindacalista, prestandosi, tal ultimo caso, a considerazioni assai diverse, anche nell’ipotesi in cui il
rappresentante dei lavoratori sia un RLS, che è pur sempre figura avente natura lato sensu
sindacale.
346
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
tutela di interessi personali del prestatore e di terzi a rilevare,
determinando così la prevalenza del diritto di critica. Il fatto che
il lavoratore debba astenersi da dichiarazioni mendaci e diffamatorie nella manifestazione del proprio pensiero e, quindi, nella
divulgazione di notizie relative all’organizzazione d’impresa, è
regola valevole non in ossequio all’art. 2105, ma ai principi generali
del comune vivere civile e, pertanto, prescinde anche dal livello di
inquadramento del prestatore. Ciò che rileva « non è l’aderenza
stretta alle posizioni datoriali », ma la formulazione di dichiarazioni, anche di dissenso, in modo irrispettoso dell’organizzazione
datoriale e dei suoi vertici (523).
Ciò che, invece, occorrerebbe richiedere è che il lavoratore,
questa volta sì a stregua di correttezza e buona fede, si adoperasse,
ove possibile, per attivare un dialogo preventivo interno alla
struttura imprenditoriale sui fatti oggetto di critica, prima ancora
di rivolgersi all’esterno, presso gli organi di stampa. Sarebbe bene
che i giudici indagassero più a fondo su questo aspetto, per capire
se il lavoratore avrebbe potuto discutere del problema nell’ambito
della struttura produttiva e invece vi si sia astenuto. Ciò per
quanto non possa probabilmente prospettarsi un obbligo generalizzato, a carico del prestatore, di informazione, scritta o orale, al
datore o ai suoi collaboratori in ordine ai fatti oggetto della
successiva denuncia ex artt. 1175 e 1375 c.c. Ciò perché si finirebbe
forse per scoraggiare eccessivamente l’esercizio della critica ad
opera del prestatore, specie in contesti organizzativi tradizionali,
connotati da uno scarso coinvolgimento del personale e dei suoi
rappresentanti alla gestione dell’impresa, per volontà, spesso, dello
stesso management, poco incline allo sviluppo di sistemi partecipativi di tal fatta. Eppure, tali sistemi sono oggi richiesti dallo stesso
legislatore in più occasioni, se si considera quanto disposto dal
d.lgs. n. 231 del 2001 e dallo stesso d.lgs. n. 81 del 2008 in materia
di sicurezza. Essi rappresenterebbero effettivamente un buono
strumento preventivo rispetto a simili fenomeni. È, tuttavia, frequente che gli stessi codici etici e di comportamento eludano la
questione e risultino privi di procedure dirette a favorire il dialogo
nell’ambito dell’organizzazione, nonché la stessa denuncia ad
opera dei prestatori, sicché non è escluso che la critica “rabbiosa”
(523)
Gragnoli, 1996, p. 71.
347
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
formulata dai dipendenti all’esterno possa ritenersi in certi casi la
spia di un più generale “malessere” organizzativo della struttura
produttiva nel suo complesso.
11.3.4. Doveri di protezione, vita privata e qualità personali del
prestatore.
Benché nell’economia del presente lavoro non sia possibile
trattare la questione con il dovuto rilievo, si può escludere che gli
obblighi di protezione abbiano una portata espansiva tale da
richiedere al lavoratore la tenuta, anche nella vita privata, di
comportamenti di salvaguardia dell’altrui utilità. Le condotte
extralavorative possono effettivamente incidere negativamente
sull’organizzazione imprenditoriale intesa in senso dinamico, determinando discredito, lesione dell’immagine e, dunque, inficiandone il buon nome, nonché la posizione di mercato. Tuttavia, non
può ritenersi che esse costituiscano inadempimento di obblighi
contrattuali e che, pertanto, giustifichino una reazione disciplinare
dell’imprenditore.
Se si eccettua l’ipotesi del pubblico impiego, “privatizzato” e
non, dove il discorso è diverso e peculiare, non esiste un dovere di
“buona condotta” a carico del debitore di opere e questo non può
certo ricavarsi dalla clausole generali di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto.
Senza dubbio, alcune vicende e qualità del prestatore, non
strettamente tecniche, ma personali possono rilevare in rapporto al
tipo di prestazione dovuta. Tuttavia, anche qui non è persuasivo
« parlare di lesione del vincolo di fiducia » (524) per giustificarne
l’idoneità a incidere negativamente sulla prosecuzione del rapporto. Simili evenienze non tollerano di essere ricondotte all’inadempimento di obblighi contrattuali, giacché quel di cui si discute
è il venir meno dell’idoneità personale (e non tecnica) del lavoratore, richiesta dal tipo di prestazione dovuta. Ciò legittima certo il
recesso imprenditoriale, ma in quanto causa idonea a riverberarsi
(524) Così, invece, di recente, tra le tante, Trib. Trento, 10 giugno 2014, in RIDL,
2014, II, p. 780 ss., con nota di Dagnino, relativa al licenziamento per lesione del vincolo
fiduciario di un autoferrotranviere, che su Facebook — in parte sul profilo personale e in
parte sul profilo del gruppo dedicato al trasporto pubblico locale — si era reso autore di
gravi affermazioni di stampo razzista e neo fascista, secondo quanto emerso dalla pubblicazione della vicenda sui giornali locali.
348
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
negativamente sul progetto organizzativo del datore e a costituirne
una minaccia.
Quando vicende attinenti alla persona del prestatore determinino effetti obiettivamente negativi sull’azienda è ammissibile la
configurabilità di una giusta causa “oggettiva”, intesa proprio
« come tutto ciò che non è inadempimento, ma che invece attiene
alle ragioni aziendali » (525), con conseguente licenziabilità del
prestatore nel rispetto delle procedure di cui all’art. 7 della l. n. 604
del 1966 — qualora si versi nell’ambito applicativo dell’art. 18 St.
lav. — e non, invece, delle procedure sancite all’art. 7 St. lav. Quel
che, infatti, l’ordinamento sollecita in tali casi è una verifica di
compatibilità tra gli scopi del datore, alias il suo progetto organizzativo, e le qualità personali del prestatore, che devono evitare di
porre in discussione quel progetto.
Non depone, del resto, in senso contrario l’art. 3 l. n. 604 del
1966, nel cui ambito non sembrano potersi rinvenire ragioni ostative all’accoglimento della tesi qui sostenuta, nonostante alcune
opinioni affermino il contrario, ritenendo che una tal norma
avrebbe consacrato una distinzione netta tra eventi attinenti alla
persona del lavoratore (giustificato motivo soggettivo) e vicende
che vi prescindono completamente (giustificato motivo oggettivo) (526).
Se così stanno le cose, non si può, allora, pensare che il venir
meno delle menzionate qualità, in relazione alla prestazione dovuta, possa di per sé causare il licenziamento, dovendo quest’ultimo pur sempre giustificarsi alla luce di esigenze inerenti all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Sicché il
giudice non sarà tanto chiamato, in dette ipotesi, a interrogarsi sul
particolare disvalore sociale dei contegni tenuti dal prestatore,
bensì sull’idoneità degli stessi a ledere l’interesse organizzativo del
datore (527).
(525) Pisani, 2004, p. 148; contra Napoli, 1980, p. 108 ss.
(526) Napoli, 1980, p. 358 ss. e più di recente Pantano, 2012.
(527) Sicché, se ad esempio, il datore di lavoro lamenti un’incompatibilità di talune
vicende personali del lavoratore con l’immagine aziendale, bisognerà capire se effettivamente una lesione dell’interesse organizzativo da tal punto di vista possa dirsi sussistente e
ciò alla luce di una serie di elementi, tra cui in primis, la notorietà delle vicende, ma anche
la loro collocazione nel tempo: Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 1999, n. 3645, cit., ha ad esempio
giudicato illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente bancario per passati trascorsi di
tossicodipendenza, ma lo ha fatto, in modo poco persuasivo, sulla scorta di un bilanciamento
349
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Riferimenti bibliografici.
AA.VV. (2013), Il controllo della Cassazione sulle norme generali, in CGL, 1, pp. 5-89.
AIMO M.P. (2003), Privacy, libertà di espressione e diritto del lavoro, Napoli, Jovene.
ALBI P. (2008), Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona. Art.
2087, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da
BUSNELLI F.D., Milano, Giuffrè.
ALESSI R., MAZZARESE S., MAZZAMUTO S. (a cura di) (2013), Persona e diritto.
Giornate di studio in onore di Alfredo Galasso, Milano, Giuffrè.
ALPA G. (1971), Pretese del creditore e normativa di correttezza, in RDC, II, pp.
277-298.
ALPA G. (2003), Fonti del diritto, clausola generale di buona fede, diritto giurisprudenziale, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=6180.
ANGELICI C. (2011), Responsabilità sociale dell’impresa, codici etici e autodisciplina,
in GC, pp. 159-176.
ANGELINI L. (2013), La sicurezza del lavoro nell’ordinamento europeo, in WP
Olympus, n. 29, pp. 1-48.
ASTONE F. (2011), Le clausole generali tra diritto civile e filosofia analitica, in GI, pp.
1713-1716.
BALLESTRERO M.V. (2014), Tra confusione e sospetti. Clausole generali e discrezionalità del giudice del lavoro, in LD, pp. 389-411.
BARASSI L. (1901), Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Roma, Società
editrice libraria.
BARCELLONA M. (2006), Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede
tra codice civile e diritto europeo, Torino, Giappichelli.
BAVARO V. (2008), Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla deoggettivazione del tempo-lavoro, Bari, Cacucci.
BELLAVISTA A. (1994), Abbigliamento del dipendente e poteri del datore di lavoro, in
RGL, II, pp. 226-234.
BELLOMO S. (2013), Art. 2105. Obbligo di fedeltà, in CAGNASSO O., VALLEBONA A. (a
cura di), Dell’impresa e del lavoro, vol. II, in GABRIELLI E. (diretto da),
Commentario del codice civile, Milanofiori Assago, Utet giuridica, pp. 284-344.
BELVEDERE A. (1988), Le clausole generali tra interpretazione e produzione di norme,
in PD, pp. 631-653.
tra gli artt. 4 e 41 Cost.; tra le altre, v. pure, più recentemente, Cass., sez. lav., 30 gennaio
2013, n. 2108, ivi, 2014, II, p. 525 ss., con nota di Di Noia, che ha confermato la sentenza
di appello, volta a statuire la legittimità del licenziamento del dipendente di Poste italiana,
a seguito di sentenza “di patteggiamento” per il reato di violenza sessuale perpetrata a
danno di minori abusando della qualità di responsabile di una comunità religiosa. Per la
Suprema Corte, il giudice di merito ha, in tal caso, ben coordinato e valutato tutti gli
elementi processuali, sì da concludere « che i fatti, per il “forte disvalore sociale” (...) erano
″indubbiamente idonei ad avere negativi riflessi sull’immagine dell’azienda, (...) e sulla
fiducia della clientela nella correttezza nella correttezza dei suoi dipendenti, tanto più ove
si consideri il notevole rilievo dato alla vicenda dagli organi di stampa, taluni dei quali anche
a diffusione nazionale, i cui articoli hanno dato particolare risalto alla qualità di dipendente
delle Poste » del lavoratore in questione.
350
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
BENASSI G. (2012), Clausole generali e giudice del lavoro: l’art. 30, primo comma,
della legge n. 183 del 2010, in ADL, pp. 91-109.
BENATTI F. (1960), Osservazioni in tema di “doveri di protezione”, in RTDPC, pp.
1342-1363.
BENATTI F. (1991), Doveri di protezione, in DDPCiv., VII, Torino, Utet, pp.
221-227.
BESSONE M. (1969), Adempimento e rischio contrattuale, Milano, Giuffrè.
BESSONE M., D’ANGELO A. (1988), Adempimento, in EGT, I, Roma, Istituto
Poligrafico dello Stato, pp. 1-8.
BETTI E. (1940), Sui principi generali del nuovo ordine giuridico, in RDC, I, pp.
217-223.
BETTI E. (1943), Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Utet.
BETTI E. (1953), Teoria generale delle obbligazioni, I. Prolegomeni: funzione
economico-sociale dei rapporti d’obbligazione, Milano, Giuffrè.
BETTI E. (1955), Teoria generale della interpretazione, Milano, Giuffrè.
BIANCA C.M. (1983), La nozione di buona fede quale regola di comportamento
contrattuale, in RDC, pp. 205-216.
BIGLIAZZI GERI L. (1988), Buona fede nel diritto civile, in DDPCiv., II,Torino, Utet,
pp. 154-189.
BIGLIAZZI GERI L. (1991), L’interpretazione del contratto, Milano, Giuffrè.
BOLLANI A. (2013), Lavoro a termine, somministrazione e contrattazione collettiva in
deroga, Padova, Cedam.
BONGIOVANNI B. (2013), I l neocostituzionalismo: i temi e gli autori, in PINO G.,
SCHIAVELLO A., VILLA V. (a cura di), Filosofia del diritto. Introduzione critica al
pensiero giuridico e al diritto positivo, Torino, Giappichelli, pp. 84-116.
BOSCATI A. (2012), Obbligo di fedeltà ed il patto di non concorrenza, in MARTONE M.
(a cura di) Trattato di diritto del lavoro, diretto da PERSIANI M., CARINCI F., IV,
Contratto di lavoro e organizzazione, t. 1, Contratto di lavoro e organizzazione, t.
1, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, Cedam, pp. 959-1057.
BRECCIA U. (1968), Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio,
Milano, Giuffrè.
BRECCIA U. (2007), Clausole generali e ruolo del giudice, in LD, pp. 443-463.
BROLLO M. (1997), La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e
trasferimento. Art. 2103, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI F.D., Milano, Giuffrè.
BROLLO M. (2014), La nuova flessibilità “semplificata” del lavoro a termine, in ADL,
pp. 566-591.
BUECKLING A. (1983), Der Fluch der Generalklauseln, in Zeitschr. f. Rechtspolitik,
pp. 190-194.
BUONCRISTIANO M. (1986), Profili della tutela civile contro i poteri privati, Padova,
Cedam.
CALCATERRA L. (2000), Sindacato di legittimità e norme elastiche in materia di lavoro,
in GC, pp. 315-344.
CALCATERRA L. (2014), Brevi riflessioni sulle tecniche normative nella legislazione
della flessibilità, in ADL, pp. 1286-1320.
CAMPANELLA P. (2010), La riforma del sistema prevenzionistico: le definizioni, in
CARINCI F., GRAGNOLI E. (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul
lavoro, Torino, Utet, pp. 72-105.
351
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
CAMPANELLA P. (2013), Prestazione di fatto e contratto di lavoro. Art. 2126, in Il
Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI
F.D., Milano, Giuffrè.
CARABELLI U. (2004), Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su
contratto di lavoro e post-taylorismo, in GDLRI, pp. 1-99.
CARINCI F. (2000), Presentazione a GRAGNOLI E., Profili dell’interpretazione dei
contratti collettivi, Milano, Giuffrè, pp. XI — XVI.
CARINCI F. (2007a), Diritto privato e diritto del lavoro, Torino, Giappichelli.
CARINCI F. (2007b), Un diritto del lavoro “classico” ala vigilia del terzo millennio, in
ZOLI C. (a cura di), Diritto del lavoro. Commentario, diretto da CARINCI F., I,
Le fonti. Il diritto sindacale, 2a ed., Torino, Utet, pp. XLV-LVI.
CARINCI F. (2012), Complimenti, dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo
in materia di riforma del mercato del lavoro, in LG, pp. 529-549.
CARINCI F. (a cura di) (2012), Contrattazione in deroga. Accordo Interconfederale del
28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, Milano, Ipsoa.
CARINCI F. (2013), Ripensando il “nuovo” art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in
ADL, pp. 461-505.
CARINCI F. (2014) La legge n. 78/2014 fra passato e futuro, in Working Paper
ADAPT, 15 ottobre 2014, n. 164, pp. 1-38.
CARINCI F. (2015), Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti (a’ sensi della bozza del decreto legislativo 24
dicembre 2014), LG, di prossima pubblicazione.
CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI G., TREU T. (2013), Diritto del lavoro, 2, Il
rapporto di lavoro subordinato, Torino, Utet giuridica.
CARINCI M.T. (2005), Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro subordinato: ragioni tecniche, organizzative, produttive (e sostitutive) come limite a
poteri e libertà del datore di lavoro, Padova, Cedam.
CARINCI M.T. (2012), Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei e
flexicurity “all’ italiana” a confronto, in GDLRI, pp. 527-572.
CARINCI M.T. (2014a), Whistleblowing alla Scala di Milano: una ballerina denuncia
il rischio di anoressia fra i componenti del corpo di ballo, in RIDL, II, pp.
511-524.
CARINCI M.T. (2014b), Whistleblowing in Italy: right and protection for employees, in
WP Massimo D’Antona.INT, 106, pp. 1-25.
CARINGELLA F., DE MARZO G. (2008), Manuale di diritto civile, III, Il contratto,
Milano, Giuffrè.
CARO M. (1992), Ancora sui comportamenti del lavoratore incompatibili col suo stato
di malattia, in RIDL, II, pp. 678-679.
CARUSI D. (2011), Clausole generali, analogia, paradigma della legge, in GI, pp.
1690-1692.
CARUSI F. (1962), Correttezza (obblighi di), in ED, X, Milano, Giuffrè, pp. 709-715.
CASALE D. (2013), L’idoneità psicofisica del lavoratore pubblico, Bologna, BUP.
CASTELVETRI L. (2001), Correttezza e buona fede nella giurisprudenza del lavoro.
Diffidenza e proposte dottrinali, in DRI, pp. 237-248.
CASTRONOVO C. (1986), L’avventura delle clausole generali, in RCDP, pp. 21-30.
CASTRONOVO C. (1990), Obblighi di protezione, in EGT, XXI, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, pp. 1-9.
CASTRONOVO C. (2006), La nuova responsabilità civile, 3a ed., Milano, Giuffrè.
352
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
CATAUDELLA A. (1972), Intuitus personae e tipo negoziale, estratto da Studi in onore
di Francesco Santoro Passarelli, Napoli, Jovene, pp. 3-38.
CATTANEO G. (1958), La responsabilità del professionista, Milano, Giuffrè.
CATTANEO G. (1971), Buona fede obbiettiva e abuso del diritto, in RTDPC, pp.
613-659.
CESTER C. (2007), La diligenza del lavoratore, in CESTER C., MATTAROLO M.G.,
Diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro. Art. 2104, in Il Codice Civile.
Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI F.D., Milano,
Giuffrè, pp. 3-265.
CICCARELLO S. (1988), Dovere di protezione e valore della persona, Milano, Giuffrè.
CORRADINI D. (1970), Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato,
Milano, Giuffrè.
CORRIAS M. (2008a), L’obbligo di sicurezza del lavoratore tra prestazione e protezione,
in Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell’Olio, Torino, Giappichelli,
pp. 347-364.
CORRIAS M. (2008b), Sicurezza e obblighi del lavoratore, Torino, Giappichelli.
COTTINO G. (1955), L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità
del debitore. Problemi generali, Milano, Giuffrè.
CRUCIANI L. (2011), Clausole generali e principi elastici in Europa: il caso della
buona fede e dell’abuso del diritto, in RCDP, pp. 473-502.
D’AMICO G. (1989), Note in tema di clausole generali, in Iure praesentia, pp. 427-461.
D’AMICO G. (2007), Clausole generali e ragionevolezza, in AA.VV., La Corte costituzionale nella costruzione dell’ordinamento attuale, Principi fondamentali, t. I,
Napoli, Esi, pp. 429-467.
D’AMICO G. (2011), Clausole generali e controllo del giudice, in GI, pp. 1704-1713.
DEL PUNTA R. (1992), La sospensione del rapporto di lavoro: malattia, infortunio,
maternità, servizio militare. Artt. 2110-2111, in Il Codice Civile. Commentario,
fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI F.D., Milano, Giuffrè.
DEL PUNTA R. (1997), Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in
MONTUSCHI L. (a cura di), Ambiente, Salute e Sicurezza. Per una gestione
integrata dei rischi da lavoro, Torino, Giappichelli.
DEL PUNTA R. (1999), Tutela della sicurezza del lavoro e questione ambientale, in
DRI, pp. 151-160.
DEL PUNTA R. (2010), Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè.
DEL PUNTA R. (2012), Il giudice del lavoro tra professioni legislative e aperture di
sistema, in RIDL, I, pp. 461-479.
DEL PUNTA R. (2013), Intervento, in AA.VV., Il controllo della Cassazione sulle norme
generali, in CGL, n. 1, pp. 23-24.
DEL PUNTA R. (2014), Il giudice e i problemi dell’interpretazione: una prospettiva
giuslavoristica, in RIDL, 2014, I, pp. 373-395.
DEL PUNTA R., ROMEI R. (a cura di) (2013), I rapporti di lavoro a termine, Milano,
Giuffrè.
DENOZZA F. (2011), Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale:
un’analisi funzionale, in RCDP, pp. 379-397 e in http://
www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/10581/denozza_calusole_gene
rali_2.pdf, pp. 11-22.
DESSÌ O. (2013), Il diritto di critica del lavoratore, in RIDL, I, pp. 395-425.
353
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
DI MAJO A. (1983), Limiti ai poteri privati nell’esercizio dell’impresa, in RGL, I, pp.
339-361.
DI MAJO A. (1984), Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in RCDP, pp.
539-571.
DI MAJO A. (1988), Delle obbligazioni in generale, in Commentario Scialoja-BrancaGalgano, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano.
DI MAJO A. (1991), Principio di buona fede e dovere di cooperazione contrattuale, in
CG, pp. 791-795.
DI MAJO A. (1992), Incontro di studio civil-lavoristico, in SANTORO-PASSARELLI G. (a
cura di), Diritto del lavoro e categorie civilistiche, Torino, Giappichelli, pp.
17-31.
ENGISCH K. (1968), Einführung in das juristische Denken, 4. Auflage, W. Kohlammer, Stuttgart, trad. it. di BARATTA A., GIUFFRIDA RÉPACI F. (1970), Introduzione al pensiero giuridico, Milano, Giuffrè.
ESSER J. (1972), Vorverständniss und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt am Main, Fischer Athenäum Taschenbücher,, trad. it. di PATTI S.,
ZACCARIA G. (1983), Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto: fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del
giudice, Napoli, Esi.
FABIANI E. (2004), Il sindacato della Corte di Cassazione sulle clausole generali, in
RDC, II, pp. 581-620.
FABIANI E. (2012), Clausola generale, in ED, Annali V, Milano, Giuffrè, pp.
183-252.
FADDA C., BENSA P.E. (1902), Diritto delle Pandette, di WINDSCHEID B., prima
traduzione italiana con note e riferimenti al Diritto Civile italiano, Torino,
Utet.
FALERI C. (2007), Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, Milano,
Giuffrè.
FALZEA A. (1987), Gli standards valutativi e la loro applicazione, in RDC, I, pp.
1-20.
FERGOLA P. (1990), I poteri del datore di lavoro nell’amministrazione del rapporto, in
LD, pp. 463-483.
FERRANTE V. (2004), Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato: eccezione
di inadempimento, rifiuto di obbedienza, azione diretta individuale, Torino,
Giappichelli.
FERRANTE V. (2012), Direzione e gerarchia nell’impresa (e nel lavoro pubblico
privatizzato). Art. 2086, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI F.D., Milano, Giuffrè.
FERRARESI M. (2012), Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, Padova, Cedam.
FERRI G. (1963), Diritto agli utili e diritto al dividendo, in RDComm., I, pp. 405-416
FORCELLINI F., IULIANI A. (2013), Clausole generali tra struttura e funzione, in EDP,
pp. 395-456.
FRANZA G. (2010), Il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento, Milano,
Giuffrè.
GALASSO A. (1974), La rilevanza della persona nei rapporti privati, Napoli, Jovene.
GAROFALO D. (2004), Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e
tecnica risarcitoria, in LG, pp. 521-544.
354
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
GAZZONI F. (2006), Manuale di diritto privato, Napoli, Esi.
GHERA E. (2006), Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, Bari, Cacucci.
GHERA E. (2011), Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, Bari, Cacucci.
GHERA E., VALENTE L. (2010), Un primo commento al collegato lavoro, in MGL, pp.
864-873.
GHEZZI G. (1965), La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 1965
GHEZZI G., MANCINI G.F., MONTUSCHI L., ROMAGNOLI U. (a cura di) (1972), Statuto dei
diritti dei lavoratori, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano.
GIUGNI G. (1963), Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, Jovene.
GIUGNI G. (1979), Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia), in GDLRI, pp.
11-49.
GIUGNI G. (diretto da) (1979), Lo Statuto dei lavoratori. Commentario, Milano,
Giuffrè.
GRAGNOLI E. (1993), L’uso di abbigliamento informale ed il potere disciplinare del
datore di lavoro, in MGL, pp. 426-431.
GRAGNOLI E. (1996), L’informazione nel rapporto di lavoro, Torino, Giappichelli.
GRAGNOLI E. (1997), Considerazioni sul risarcimento del danno per perdita di chance
nei concorsi privati, in Studi in onore di Gustavo Romanelli, Milano, Giuffrè,
pp. 619-640.
GRAGNOLI E. (2004), L’interpretazione del contratto collettivo e gli orientamenti della
dottrina, in L’interpretazione del contratto collettivo, Dialoghi fra Dottrina e
Giurisprudenza, Quaderni di Diritto del lavoro, n. 1, pp. 161-213.
GRAGNOLI E. (2006), La riduzione del personale fra licenziamenti individuali e
collettivi, in GALGANO F. (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di Diritto
pubblico dell’economia, XL, Padova, Cedam.
GRAGNOLI E. (2007), L’obbligo di sicurezza e la responsabilità del datore di lavoro, in
BESSONE M. (diretto da), Trattato di diritto privato, XXIV, Il lavoro subordinato, a cura di CARINCI F., II, Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e
svolgimento, coordinato da PERULLI A., Torino, Giappichelli, pp. 443-483.
GRAGNOLI E. (2010), La tutela della persona e delle condizioni di lavoro del prestatore
di opere (art. 2087 c.c.), in CARINCI F., GRAGNOLI E. (a cura di), Codice
commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, Utet, pp. 27-53.
GRAGNOLI E. (2010), Le clausole generali e il rapporto di lavoro subordinato. I poteri
del datore di lavoro e il sindacato giudiziale, dattiloscritto, pp. 1-38.
GRAGNOLI E. (2014), L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La libera
apposizione del termine, in LG, pp. 429-439.
GRANDI M. (1972), Le modificazioni del rapporto di lavoro, I, Le modificazioni
soggettive, Milano, Giuffrè.
GRANDI M. (1987), Rapporto di lavoro, in ED, XXXVIII, Milano, Giuffrè, pp.
313-363.
GRANDI M. (2004), Riflessioni sul dovere d’obbedienza nel rapporto di lavoro subordinato, in ADL, pp. 725-748.
GROSSO G. (1959), Buona fede (dir. rom.), in ED, V, Milano, Giuffrè, pp. 661-663.
GUARNIERI A. (1988), Clausole generali, in DDPCiv., II, Torino, Utet, pp. 403-413.
HEDEMANN J.W. (1933), Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr für Recht
und Staat, Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
KLARE K.E. (1994), Abbigliamento e potere: il controllo sull’aspetto del lavoratore
subordinato, in GDLRI, pp. 567-626.
355
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
KLINDER P. (1998), Il ricorso dei giudici alle clausole generali in Germania, in
CABELLA PISU L., NANNI L. (a cura di), Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, Padova, Cedam, pp. 55-63.
ICHINO P. (2003), Il contratto di lavoro, 3, in CICU A., MESSINEO G., MENGONI L.
(diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, continuato da SCHLESINGER
P., Milano, Giuffrè.
ICHINO P. (2011), Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipazione dal
diritto civile e ritorno al diritto civile, in http://www.pietroichino.it, pp. 1-41.
LAI M. (2010), Diritto della salute e della sicurezza del lavoro, Torino, Giappichelli.
LAMBO L. (2007), Obblighi di protezione, Padova, Cedam.
LAZZARI C. (2012a), Datore di lavoro e obbligo di sicurezza, in WP Olympus, n. 7, pp.
1-42.
LAZZARI C. (2012b), Il potere direttivo oltre la subordinazione? Prime osservazioni dal
punto di vista dell’obbligo datoriale di sicurezza, in WP Olympus, n. 16, pp.
1-37.
LECCESE V. (2012), Il diritto sindacale al tempo della crisi. Intervento eteronomo e
profili di legittimità costituzionale, in GDLRI, pp. 479-525.
LIBERTINI M. (2011), Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto
indeterminato. Una proposta di distinzione, in RCDP, pp. 345-378.
LISO F. (1982), La mobilità del lavoratore in azienda. Il quadro legale, Milano,
Franco Angeli.
LISO F. (2012), Osservazioni sull’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e sulla
legge in materia di « contrattazione collettiva di prossimità », in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT, n. 157, pp. 1-42.
LUCIANI V. (2007), Danni alla persona e rapporto di lavoro, Napoli, Esi.
LUNARDON F. (2009), La legislazione lavoristica dalla fine dell’800 al primo decennio
2000, in PERSIANI M., CARINCI F. (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, I,
in PERSIANI M. (a cura di), Le fonti del diritto del lavoro, Padova, Cedam, pp.
137-179.
LUNARDON F. (2014), I contenuti della contrattazione collettiva di secondo livello negli
Accordi Interconfederali 2009-2013, in Prisma, n. 1, pp. 35-52.
LUZZATI C. (2013), La “normalizzazione” delle clausole generali. Dalla semantica alla
pragmatica, in RCDP, pp. 163-192.
MAJELLO U. (1958), Custodia e deposito, Napoli, Jovene.
MAGNANI M. (2014), La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato: novità
e implicazioni sistematiche, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n.
212, pp. 1-13.
MAINARDI S. (2002), Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico. Art. 2106, in
Il Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI
F.D., Milano, Giuffrè.
MANCINI G.F. (1957), La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano,
Giuffrè.
MANCINI G.F. (1993), Intervista, a cura di ICHINO P., in RIDL, I, pp. 143-187.
MARAZZA M. (2002), Saggio sull’organizzazione del lavoro, Padova, Cedam.
MARINELLI F. (2005), L’antinomia tra obblighi del lavoratore e garanzie costituzionali
nella produzione in giudizio di documentazione aziendale, in LG, pp. 517-533.
MASSETTO G.P. (2006), Buona fede nel diritto medievale e moderno, in DDPCiv., II,
Torino, Utet, pp. 133-154.
356
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
MASTRANDREA P. (1994), L’obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone,
Padova, Cedam.
MATTAROLO M.G. (2000), Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Art. 2105, in Il
Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI
F.D., Milano, Giuffrè.
MATTAROLO M.G. (2007), Il dovere di obbedienza, in CESTER C., MATTAROLO M.G.,
Diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro. Art. 2104, in Il Codice Civile.
Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI F.D., Milano,
Giuffrè, pp. 267-594.
MATTAROLO M.G. (2012), I tempi di lavoro, in PERSIANI M., CARINCI F. (diretto da),
Trattato di diritto del lavoro, IV, in MARTONE M. (a cura di), Contratto di lavoro
e organizzazione, t. 1, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, Cedam, pp.
604-709.
MAZZAMUTO S. (2003), Una rilettura del mobbing: obbligo di protezione e condotte
plurime d’inadempimento, in EDP, pp. 627-695.
MAZZAMUTO S. (2011), Il rapporto tra clausole generali e valori, in GI, pp. 1697-1700.
MAZZOTTA O. (1983), Accertamenti sanitari, eccessiva morbilità e contratto di lavoro,
in GDLRI, pp. 1-41.
MAZZOTTA O. (1989), Variazioni su poteri privati, clausole generali e parità di
trattamento, GDLRI, pp. 583-596.
MAZZOTTA O. (1994), Diritto del lavoro e diritto civile: i temi di un dialogo, Torino,
Giappichelli.
MAZZOTTA O. (2008), Diritto del lavoro, 3a ed., Milano, Giuffrè.
MENEGATTI E. (2012a), I limiti alla concorrenza del lavoratore subordinato, Padova,
Cedam.
MENEGATTI E. (2012b), L’obbligo di diligenza, in PERSIANI M., CARINCI F. (diretto
da), Trattato di diritto del lavoro, IV, in MARTONE M. (a cura di), Contratto di
lavoro e organizzazione, t. 1, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, Cedam,
pp. 907-958.
MENGONI L. (1954), Obbligazioni di « risultato » e obbligazioni di « mezzi » (Studio
critico), in RDC, I, pp. 185-209, 280-320, 366-396.
MENGONI L. (1965), Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA.VV., Il contratto
di lavoro nel diritto dei paesi membri della CECA, Milano, Giuffrè, pp. 407-504.
MENGONI L. (1984), La parte generale delle obbligazioni, in RCDP, pp. 507-522.
MENGONI L. (1986), Spunti per una teoria delle clausole generali, in RCDP, pp. 5-19.
MENGONI L. (1988), Responsabilità contrattuale (diritto vigente). in ED, XXXIX.
Milano, Giuffrè, pp. 1071-1099.
MENGONI L. (1990a), Diritto civile, in MENGONI L., PROTO PISANI A., ORSI BATTAGLINI
A., L’influenza del diritto del lavoro su diritto civile, diritto processuale civile,
diritto amministrativo, in GDLRI, pp. 5-23.
MENGONI L. (1990b), Diritto vivente, in DDPCiv., VI, Torino, Utet, pp. 445-451.
MENGONI L. (1997), Autonomia privata e Costituzione, in BBTC, I, pp. 3-20.
MENGONI L. (2000), Il contratto individuale di lavoro, in GDLRI, pp. 181-200
MESSINEO F. (1961), Contratto (dir. priv. — teoria generale), in ED, IX, Milano,
Giuffrè, pp. 749-979.
MISCIONE M. (2014a), I contratti di lavoro « acausali », a termine ed interinali. (d.l.
34/2014), in LG, supplemento, pp. 5-32.
MISCIONE M. (2014b), I sindacati nella crisi, in DPL, pp. 1243-1254.
357
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
MONTEL A. (1958), Buona fede, in Noviss.DI, Torino, Utet, pp. 599-611.
MONTUSCHI L. (1973), Potere disciplinare e rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè.
MONTUSCHI L. (1986), Diritto alla salute e organizzazione del lavoro. Milano, Franco
Angeli.
MONTUSCHI L. (1996), L’applicazione giurisprudenziale del principio di correttezza e
di buona fede nel rapporto di lavoro, in LD, pp. 139-152.
MONTUSCHI L. (1999), Ancora sulla rilevanza della buona fede nel rapporto di lavoro,
in ADL, pp. 723-742.
MONTUSCHI L. (2001a), Lessico operaio e “civiltà del lavoro”, in ADL, pp. 1051-1054.
MONTUSCHI L. (2001b), Regolamenti aziendali, etica del lavoro e ricerca del consenso,
in ADL, pp. 413-423.
MONTUSCHI L. (2006), I l contratto a termine e la liberalizzazione negata, in DRI, pp.
109-129.
MORMILE L. (2013), Vincoli familiari e obblighi di protezione, Torino, Giappichelli.
MUSIO I. (2010), Breve analisi comparata sulla clausola generale della buona fede, in
http://www.comparazionedirittocivile.it, pp. 1-42.
NAPOLI M. (1980), La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, Franco Angeli.
NAPOLI M. (2008), Categorie generali e specialità nel diritto privato: il diritto del
lavoro, in PLAIA A., Diritto civile e diritti speciali. Il problema dell’autonomia
delle normative di settore, Milano, Giuffrè, pp. 253-276.
NATOLI U. (1951), Diritto al lavoro, inserzione del lavoratore nell’azienda e recesso ad
nutum, in RGL, I, pp. 105-119.
NATOLI U. (1954), Sui limiti legali e convenzionali della facoltà di recesso « ad
nutum » dell’imprenditore, in RGL, I, pp. 281-293.
NATOLI U. (1974), L’attuazione del rapporto obbligatorio. I. Il comportamento del
creditore, in CICU A., MESSINEO G. (diretto da), Trattato di diritto civile e
commerciale, Milano, Giuffrè.
NATOLI U. (1984), L’attuazione del rapporto obbligatorio. II. Il comportamento del
debitore, in CICU A., MESSINEO G. (diretto da), Trattato di diritto civile e
commerciale, continuato da MENGONI L., Milano, Giuffrè.
NAVARRETTA E. (2012), Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo,
in EDP, pp. 953-980.
NEUMANN F.L. (1983), Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, Bologna, il
Mulino.
NICOLÒ R. (1960), Codice civile, in ED, VII, Milano, Giuffrè, pp. 240-250.
NICOLUSSI A. (2000), Recensione a RANIERI F., Europäisches Obligationenrecht, in
EDP, pp. 701-710.
NOGLER L. (2007), La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in GDLRI, pp. 598-694.
NOGLER L. (2009), Clausole generali e diritto del lavoro, in Clausole generali e
discrezionalità del giudice, Convegno trentino del 2009, Associazione Civilisti
Italiani, dattiloscritto, file audio in internet.
NOGLER L. (2011), Prime considerazioni sulla disciplina legislativa delle « clausole
generali » in materia di diritto del lavoro, in Studi in onore di Tiziano Treu,
Milano, Giuffrè, pp. 927-936.
NOGLER L. (2013), (Ri)scoprire le radici giuslavoristiche del “nuovo” diritto civile,
in EDP, pp. 959-1013.
358
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
NOGLER L. (2014a), L’interpretazione giudiziale del diritto del lavoro, in RIDL, I,
pp. 115-135.
NOGLER L. (2014b), Contratto di lavoro e organizzazione al tempo del post-fordismo,
in ADL, pp. 884-902.
OCCHINO A. (2010), Il tempo libero nel diritto del lavoro, Torino, Giappichelli.
OCCHINO A. (2011), Il diritto del lavoro di fronte alla questione del merito, in AA. VV.,
Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale. Studi in onore di Tiziano Treu,
Napoli, Jovene, pp. 173-186.
PANDOLFO A. (1991), La malattia nel rapporto di lavoro, Milano, Franco Angeli.
PANTANO F. (2012), Il rendimento e la valutazione del lavoratore subordinato,
Padova, Cedam.
PANUCCIO V. (2000), Applicazione giurisprudenziale degli standards valutativi, in
GC, pp. 85-94.
PASCUCCI P. (2011), 3 agosto 2007-3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per
la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 modificato
dal d.lgs. n. 106/2009, in Quaderni di Olympus, 3, Aras edizioni.
PASCUCCI P. (2013), La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto
alla salute vs diritto al lavoro?, in WP Olympus, n. 27, pp. 1-17.
PASCUCCI P. (2014), Alcol e droghe nel sistema della sicurezza sul lavoro, Relazione al
convegno su “La gestione delle dipendenze da alcol e droga nei luoghi di
lavoro”, Pesaro 7 maggio 2014, pp. 1-31.
PATTI S. (2013), Ragionevolezza e clausole generali, Milano, Giuffrè.
PEDRINI F. (2014), Le “clausole generali”. Profili teorici e aspetti costituzionali,
Milano, Giuffrè.
PERSIANI M. (1966), Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, Cedam.
PERSIANI M. (1971), La tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto.
In RIVA SANSEVERINO L., MAZZONI G. (diretto da), Nuovo Trattato di diritto del
lavoro, II. Padova, Cedam, pp. 593-713.
PERSIANI M. (1995a), Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore
di lavoro, in DL, I, pp. 135-151.
PERSIANI M. (1995b), Diritto del lavoro e razionalità, in ADL, pp. 1-36.
PERULLI A. (1992), Il potere direttivo dell’imprenditore, Milano, Giuffrè.
PERULLI A. (2002), La buona fede nel diritto del lavoro, in RGL, I, pp. 3-20.
PERULLI A. (2007), Obbligazione di lavoro, diligenza e rendimento, in CARINCI F.
(diretto da), Diritto del lavoro. Commentario, II, in CESTER C. (a cura di), Il
rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, pp. 593-610.
PERULLI A. (a cura di) (2013), La responsabilità sociale di impresa: idee e prassi,
Bologna, il Mulino.
PERULLI A., SPEZIALE V. (2011), L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e
la “rivoluzione di Agosto” del Diritto del Lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT, n. 132, pp. 1-72.
PIRAINO F. (2010), Diligenza, buona fede e ragionevolezza nelle pratiche commerciali
scorrette. Ipotesi sulla ragionevolezza nel diritto privato, in EDP, pp. 1117-1194.
PISANI C. (2004), Licenziamento e fiducia, Milano, Giuffrè.
POLI R. (2013), L e modifiche relative al giudizio di cassazione, in PUNZI C., Il
processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013,
Torino, Giappichelli, pp. 193-217.
359
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
PONTE F.V. (2014), La tutela del diritto alle ferie: dalla protezione della salute alla
realizzazione delle esigenze della vita non lavorativa della persona, in ADL, pp.
1205-1219.
PROIA G. (1991), Doveri preparatori della prestazione ed obbligo positivo di fedeltà, in
RIDL, II, pp. 832-839.
PROSPERETTI U. (diretto da) (1975), Commentario dello statuto dei lavoratori, Milano, Giuffrè.
PUGLIESE G. (1950), Relazione sul libro delle obbligazioni, in Annuario di diritto
comparato e di studi legislativi, XXIV, pp. 175-207.
RANIERI M. (2010), L’abbigliamento nei luoghi di lavoro: dalla tuta blu al velo usa e
getta, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 100, pp. 1-46.
RATTI L. (2013), Alla ricerca dei fondamenti teorici del sindacato di legittimità sulla
giusta causa di licenziamento, in RIDL, II, pp. 888-903.
REDENTI E. (1992), Massimario della giurisprudenza dei probiviri, riproduzione
dell’edizione del 2006 a cura e con l’introduzione di CAPRIOLI S., Torino,
Giappichelli.
RESCIGNO P. (1965), L’abuso del diritto, in RDC, I, pp. 205-290.
RESCIGNO P. (1987), Notazioni generali sul principio di buona fede, in Il principio
di buona fede, Milano, Giuffrè, pp. 31-39.
RESCIGNO P. (1998), Appunti sulle clausole generali, in RDC, pp. 1-18.
RESCIGNO P. (2011), Una nuova stagione per le clausole generali, in GI, pp.
1689-1690.
RESCIGNO P. (2013), Codificazione civile. Drafting delle leggi, in ALPA G., ROPPO V.
(a cura di), La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà,
Bari, Laterza, pp. 303-323.
RESTIVO C. (2007), Contributo ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, Giuffrè.
RODOTÀ S. (1964), D iligenza, in ED, XII, Milano, Giuffrè, pp. 539-546.
RODOTÀ S. (1967), Ideologie e tecniche nella riforma del diritto civile, in RDC, I, pp.
83-125.
RODOTÀ S. (1969), Le fonti di integrazione del contratto, Milano, Giuffrè.
RODOTÀ S. (1987), Il tempo delle clausole generali, in RCDP, pp. 709-733.
ROMAGNOLI U. (1995), Il lavoro in Italia: un giurista racconta, Bologna, il Mulino.
ROMANO S. (1959), Buona fede (dir. priv), in ED, V, Milano, Giuffrè, pp. 677-699.
ROSELLI F. (1983), Il controllo della Cassazione civile sull’uso delle clausole generali,
Napoli, Jovene.
ROSELLI F. (1988), Clausole generali: l’uso giudiziario, in PD, pp. 667-681.
ROSELLI F. (2011), Clausole generali. Iura novit curia. Contraddittorio, in GI, pp.
1701-1704.
ROSELLI F. (2013), Clausole generali e nomofilachia, Corte di Cassazione, Ufficio dei
Magistrati referenti per la Formazione decentrata, Incontro di studio del 10
ottobre 2013, pp. 1-21.
RUSCIANO M. (2000), La diligenza del prestatore di lavoro, in SI, pp. 656-663.
RUSCIANO M., ZOPPOLI L. (a cura di) (2014), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge
delega 10 dicembre 2014, n. 183, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” —
Collective Volumes, n. 3, pp. 1-170.
SAFFIOTI M.T. (1999), Le clausole generali di buona fede e correttezza e la posizione del
lavoratore subordinato, Torino, Giappichelli.
360
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
SALVI C. (1988), Abuso del diritto. I) Diritto civile, in EGT, I, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, pp. 1-6.
SANTORO-PASSARELLI F. (1967), Specialità del diritto del lavoro, in RDL, I, pp. 3-23.
SANTORO-PASSARELLI G. (a cura di) (1992), Diritto del lavoro e categorie civilistiche,
Torino, Giappichelli.
SARACINI P. (2013), Contratto a termine e stabilità del lavoro, Napoli, Esi.
SCOGNAMIGLIO M. (2010), L’economia di scambio nell’antica Roma, http://
rivista.ssef.it/site.php?page=20041220082543419&edition=2010-02-01.
SCOGNAMIGLIO R. (1960), La specialità del diritto del lavoro, in RGL, I, pp. 83-95.
SCOGNAMIGLIO R. (1968), Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in NDI,
XV, Torino, Utet, pp. 670-679.
SCOGNAMIGLIO R. (1994), Il codice civile e il diritto del lavoro, in RDC, I, pp. 245-275.
SENIGAGLIA R. (2013), La vincolatività dei codici etici: ossimoro o sineddoche?, in
PERULLI A. (a cura di), La responsabilità sociale di impresa: idee e prassi,
Bologna, il Mulino, pp. 73-118.
SENN P.D. (1988), Buona fede nel diritto romano, in DDPCiv., II, Torino, Utet, pp.
129-133.
SERPETTI A. (2007), Doveri di buona fede e diligenza nell’adempimento delle obbligazioni e somministrazione (nota a Cass. 10 ottobre 2003, n. 15273), in
http://www.diritto.it/docs/23577-doveri-di-buona-fede-e-diligenza-nelladempimento.
SMURAGLIA C. (1965), Doveri complementari, « intuitus » e fiducia nel rapporto di
lavoro, in RGL, pp. 239-264.
SMURAGLIA C. (1967), La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano,
Giuffrè.
SPEZIALE V. (2012), La riforma del licenziamento tra diritto ed economia, in RIDL,
I, pp. 521-566.
SPEZIALE V. (2014), Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma
dei contratti e di altre discipline dei rapporti di lavoro, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT, n. 233, pp. 1-64.
STOLFA F. (2010), Le definizioni, in ZOPPOLI L., PASCUCCI P., NATULLO G. (a cura di),
Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Milano, Ipsoa, pp.
52-83.
STOLFA F. (2014), L’individuazione e le responsabilità del datore di lavoro e dei
dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in WP Olympus, n. 33, pp. 1-43.
SUPPIEJ G. (1963), La struttura del rapporto di lavoro, 2, Padova, Cedam.
TARUFFO M. (1989), La motivazione delle decisioni fondate su standard, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (a cura di), L’analisi del ragionamento giuridico:
materiale ad uso degli studenti, II, Torino, Giappichelli, pp. 311-344.
TARUFFO M. (2003), Prefazione, in FABIANI E., Clausole generali e sindacato della
Cassazione, Torino, Utet, pp. I-XXI.
TARUFFO M. (2014), Addio alla motivazione?, in RTDPC, pp. 375-388.
TESTA F. (2012), Il diritto alle ferie del lavoratore subordinato, Torino, Giappichelli.
TOSI P. (1974), Il dirigente d’azienda: tipologia e disciplina del rapporto di lavoro,
Milano, Franco Angeli.
TOSI P. (2012), Intuitus personae e fiducia, in ADL, pp. 539-546.
TREMOLADA M. (2011), Norme della l. n. 183/2010 in materia di certificazione e di
limiti al potere di accertamento del giudice, in MISCIONE M., GAROFALO D. (a cura
361
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
di), Il Collegato Lavoro 2010. Commentario alla Legge n. 183/2010, Milano,
Ipsoa, pp. 145-190.
TROIANO S. (2013), Ragionevolezza (diritto privato), in ED, Annali VI, Milano,
Giuffrè, pp. 763-808.
TULLINI P. (1988), Su di una nozione allargata di “fedeltà”, in RIDL, II, pp.
981-993.
TULLINI P. (1990), Clausole generali e rapporto di lavoro, Rimini, Maggioli.
TULLINI P. (2013), Riforma della disciplina dei licenziamenti e nuovo modello
giudiziale di controllo, in RIDL, I, pp. 147-170.
VALENTE L. (1999), Capelli corti e acconciature classiche: quando la sanzione
disciplinare è legittimamente connessa alla violazione delle direttive in materia
di aspetto estetico, in RGL, II, pp. 619-626.
VALLEBONA A. (2010), Una buona svolta del diritto del lavoro: il “collegato” 2010, in
MGL, pp. 210-216.
VALLEBONA A. (2011), Istituzioni del diritto del lavoro, 2, Il rapporto di lavoro,
Milanofiori Assago, Cedam.
VARDARO G. (1986), Il potere disciplinare giuridificato, in GDLRI, pp. 1-42.
VELLUZZI V. (2006), O sservazioni sulla semantica delle clausole generali, in http://
www.units.it/etica/2006_1/VELLUZZI.htm.
VELLUZZI V. (2010), Le clausole generali: semantica e politica del diritto, Milano,
Giuffrè.
VIESTI L. (1946), L’autonomia scientifica del diritto del lavoro, in DL, I, pp. 8-14.
VISCOMI A. (1997), Diligenza e prestazione di lavoro, Torino, Giappichelli.
VISCOMI A. (2011), L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e
principi civilistici, in A.I.D.LA.S.S., Il diritto del lavoro nel sistema giuridico
privatistico. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Parma 4-5
giugno 2010. Milano, Giuffrè.
VISINTINI G. (2006), Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218-1222, 2a ed., in
Il Codice Civile. Commentario, fondato da SCHLESINGER P., diretto da BUSNELLI
F.D., Milano, Giuffrè.
WEGERICH C. (2004), Die Flucht in die Grenzenlosigkeit. Justus Wilhelm Hedemann
(1878-1963), Mohr Siebeck.
WENDT O. (1906), Die exceptio doli generalis im heutigen Recht, in Archiv für die
civilistische Praxis.
WIEACKER F. (1956), Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB, Tübingen, Mohr.
WULZER K.G. (1924), Das juristische Denken, 2a ed., Wien-Leipzig.
ZITELMANN E. (1879), Irrtum und Rechtsgeschäft: eine psychologisch-juristische
Untersuchung, Leipzig, Duncker & Humblot.
ZOLI C. (1988), La tutela delle posizioni strumentali del lavoratore: dagli interessi
legittimi all’uso delle clausole generali, Milano, Giuffrè.
ZOPPOLI L. (1991), La corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli, Esi.
ZOPPOLI L. (2005), La fiducia nei rapporti di lavoro, in AA. VV., Diritto del lavoro.
I nuovi problemi. Studi in onore di Mattia Persiani, I, Padova, Cedam.
ZOPPOLI L. (2014), Il “riordino” dei modelli di rapporto di lavoro tra articolazione
tipologica e flessibilizzazione funzionale, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 213, pp. 1-30.
362
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
INTERVENTI
FABIO PANTANO
Clausole generali e contratto di lavoro: l’interesse dell’impresa e la
natura dell’obbligazione caratteristica
In una recente lettera al “Financial Times”, il Prof. Philip G.
Cerny, Emerito di Politics and Global Affairs presso l’Università di
Manchester affermava che “le ore lavorative sono un indicatore
molto fuorviante della reale entità del lavoro svolto” e che “i lavori
più retribuiti sono incentrati sull’intensità, creatività e originalità
— in buona sostanza, sulla qualità del risultato”. Aggiungeva che
tali valutazioni “involgono una concezione sociale del lavoro”,
secondo la quale, ai fini di una più efficace valutazione delle
attività, “occorrerebbero criteri qualitativi e non quantitativi”.
Concludeva chiedendosi “quali” dovessero essere questi criteri,,
“qualitativi” e non “quantitativi”, per una più efficace valutazione
del lavoro e ponendosi dei dubbi sulla eventuale loro attendibilità.
Io ritengo che, se esiste un ruolo che la dottrina giuridica, e in
particolare quella giuslavorista, possono ancora svolgere, è di rispondere a questa domanda. Più in generale, gli studiosi di diritto
sono chiamati a cogliere le istanze provenienti dalla realtà — nel
nostro caso dalla realtà produttiva — attraverso il confronto con le
scienze sociali e a leggerla alla luce delle categorie sistematiche
tramandate dalla tradizione.
Tuttavia, è necessario che tali categorie generali siano sottoposte a continua verifica. Laddove ciò non avvenisse vi è il rischio
di una ricostruzione falsata; di una lettura non veritiera della
realtà e, di conseguenza, della restituzione di ricostruzioni inadeguate alla risoluzione dei problemi concreti.
Per questo ringrazio i relatori per il loro sforzo ricostruttivo
363
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
originale. In particolare ringrazio la Prof.ssa Campanella, anche
per essere stata una dei più generosi tra i miei lettori.
Anche alla luce degli spunti di riflessione suggestivi offerti
dalle relazioni, sono convinto che, per cogliere a pieno le trasformazioni repentine e continue del tessuto socio-economico e produttivo, sia necessaria una radicale inversione di rotta rispetto a
certe tendenze che mi paiono assai diffuse nel ragionamento dei
giuslavoristi italiani: sia nella dottrina, sia nella giurisprudenza. Al
centro della ricostruzione giuridica della relazione lavorativa deve
essere riportato l’interesse dell’impresa quale elemento caratterizzante di tutta l’operazione economica dell’art. 2094 del codice
civile e nelle disposizioni a esso correlate.
Per tali ragioni, ad esempio, non mi sento di condividere
impostazioni per le quali “il vincolo obbligatorio primario non è
riducibile ‘alla sola prestazione di lavoro in sé considerata’ in
relazione al solo interesse del datore di lavoro, poiché vanno
considerati pure gli interessi del lavoratore”, come sostiene la
Prof.ssa Campanella.
Sono invece convinto che, all’interno dell’equilibrio causale del
contratto di lavoro, la ricostruzione della natura e del contenuto
dell’obbligo di lavorare debba essere proprio centrata sull’interesse
dell’impresa, in quanto è la realizzazione di quell’interesse che
costituisce la ragione sociale della stipulazione del negozio. Gli
interessi di rilievo costituzionale del lavoratore, legati alla tutela
della sua persona, restano esterni al nucleo centrale dell’operazione
economica definita dalle parti e, non a caso, trovano tutela e
riconoscimento attraverso il meccanismo eteronomo dell’inderogabilità.
Soprattutto, resto convinto che sia necessario prendere atto
che l’obbligazione di lavoro è un’obbligazione di risultato e che solo
attraverso questa ricostruzione la regolamentazione del rapporto
possa trovare un assetto equo, corrispondente alla natura concreta
degli interessi perseguiti con la sua stipulazione. E ciò non tanto e
non solo perché la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di
risultato sia stata abbandonata dalla dottrina e dalla giurisprudenza civiliste, seppure, in effetti, da quest’ultima con orientamenti altalenanti. Ma soprattutto perché soltanto attraverso il
risultato l’obbligazione lavorativa raggiunge gli esiti per i quali è
riconosciuta e regolata dall’ordinamento, cioè la realizzazione di un
momento di congiunzione tra l’apporto del singolo prestatore di
364
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
opere e il disegno organizzativo dell’imprenditore, cioè il suo progetto.
È evidente che il paziente nutre un’aspettativa giuridicamente
tutelata a una “buona cura” e non alla guarigione e che il cliente
dell’avvocato non può vedersi assicurata la vittoria della causa, ma
soltanto una strategia difensiva adeguata. Nondimeno, una
“buona cura” e una strategia difensiva adeguata costituiscono di
per sé un risultato, e non una mera condotta conforme a diligenza.
È per questi motivi che la lettera del Prof. Cerny al Financial
Times mi ha suscitato il mio interesse. Perché attesta un’effettiva
domanda sociale di riconsiderazione delle categorie generali tramite le quali il contenuto del rapporto di lavoro deve essere
ricostruito.
Da una simile impostazione è agevole dedurre che la diligenza
non costituisce il criterio giuridico per l’accertamento dell’adempimento, che invece si concentra sulla realizzazione del risultato,
“misurato attraverso il rendimento, concepito (...) come capacità
del prestatore di rispondere nel tempo al risultato atteso dal
datore”, come scrive, illustrando le mie teorie, la Prof. Campanella.
Alla diligenza spetta il ruolo di misurare l’adeguatezza dei
comportamenti posti in essere dal lavoratore per preservare la
possibilità di adempiere. Essa costituisce il criterio di verifica degli
sforzi o delle condotte omissive imposte al prestatore di opere,
anche attraverso l’esercizio del potere direttivo, affinché egli non
interferisca con il substrato organizzativo su cui si innesta il
risultato dovuto, minimizzandone l’utilità ricevuta dall’imprenditore o impedendone del tutto la realizzazione.
In tal senso, la diligenza dell’art. 2104 c.c. svolge, nel rapporto
di lavoro, un ruolo del tutto speculare rispetto a quello designatole,
per le obbligazioni in generale, dall’art. 1176, in conformità allo
schema definito dall’art. 1218. Nel caso dell’art. 1176, è la buona
fede, secondo una nota impostazione civilistica, ad adattare la
realizzazione dell’impegno richiesto alla dinamicità della vita economica contemporanea. Nell’ambito del rapporto di lavoro tale
funzione è invece svolta dall’art. 2014 e, quindi, dalla diligenza,
anche per via delle direttive fornite dall’imprenditore tramite
l’esercizio del potere direttivo.
In questo scenario ricostruttivo, non restano spazi per la
correttezza e la buona fede quali fonti di integrazione del contenuto obbligatorio. Mi sembra, infatti, che la gran parte dei com365
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
portamenti che comunemente sono ricondotti agli obblighi di
protezione, possano invece rientrare tra i doveri connessi alla
conservazione della possibilità di adempiere, intesa appunto quale
non interferenza con la concretizzazione delle utilità attese dall’impresa.
Sul versante datoriale, le stesse clausole generali costituiscono
regole per l’esercizio del potere, affinché esso sia esercitato secondo
modalità conformi alle finalità per cui è riconosciuto all’imprenditore dall’ordinamento. Sul piano dell’esecuzione del lavoro, esse
possono, se mai, indicare norme sulle modalità di adempimento
degli obblighi o di godimento di prerogative (a tale schema si
possono ricondurre le prescrizioni relative alla fruizione delle ferie
o al godimento dei periodi di sospensione per malattia), ma sempre
in via di principio, senza un reale contenuto precettivo, che può
sempre essere ricondotto alla regola della diligenza, in senso, appunto, “conservativo”.
Riprendendo dal punto da cui sono partito, ritengo — e mi
auguro — che gli spazi di rielaborazione del nostro consueto
armamentario dogmatico e concettuale non si fermino ai temi di
oggi, ma si debbano invece aprire verso altri problemi, per i quali
gli studiosi delle discipline economiche e organizzative invocano
una ricostruzione giuridica più consona al reale andamento dei
processi di organizzazione del lavoro.
Se si guarda, ad esempio, al tema della flessibilità, la dottrina
pare troppo incline a seguire gli orientamenti del legislatore, concentrati su quella in entrata e in uscita. Al contrario, restano
inascoltate le richieste di una radicale revisione delle norme che
regolano la mobilità interna. Occorrerebbe, a sentire e leggere i
commenti degli studiosi di organizzazione e degli stessi imprenditori, una più profonda riflessione sull’art. 2103 c.c., che si rivela
ormai, nonostante i tentativi di adeguamento operati dalla giurisprudenza, foriero di rigidità incompatibili con una più evoluta
rielaborazione della nozione di professionalità.
Fintanto che tali richieste di revisione e adattamento della
rielaborazione giuridica resteranno inascoltate, il pensiero giuslavorista non avrà raggiunto la sua finalità essenziale, che è quella di
fornire gli strumenti teorici per un equo contemperamento dei
conflitti che insorgono nello svolgimento delle attività produttive,
e, in ultima analisi, di delinearne le soluzioni secondo un criterio di
giustizia.
366
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ENRICO GRAGNOLI
Credo che non si debba solo ringraziare gli amici per le tre
bellissime relazioni, ma anche il Consiglio direttivo per avere colto
un tema aperto, perché vi è stata una varietà di opinioni sul punto
nodale della questione, non tanto che cosa siano le clausole generali, ma a che cosa dobbiamo attribuire il nome di “clausole
generali”. Né il prof. Loy, né il prof. Bellomo misconoscono la
differenza tra le clausole generali intese dalla tradizione e le norme
a struttura elastica, ma ritengono che ci siano elementi prevalenti
tali da portare a una rilettura sintonica delle norme a struttura
elastica rispetto alla clausole generali della tradizione e, in particolare, al principio di buona fede.
Pure apprezzando molto i contributi del prof. Bellomo e del
prof. Loy, la tesi tradizionale mi convince di più per tre ordini di
motivazioni, una di carattere strutturale, una di carattere funzionale e una di ordine storico. La terza è la più evidente; di fronte al
contratto tipico con la regolazione più intensa del nostro ordinamento, nel senso che le norme dedicate al nostro contratto tipico
sono dieci volte tutte le altre messe insieme, è necessario distinguere la tradizione civilistica e il suo riferimento ai parametri
relazionali sociali rispetto all’intervento eteronomo di contenimento del potere del datore di lavoro e volto a ripristinare una
maggiore parità all’interno del rapporto.
L’equiparazione o la ricerca di una simmetria più stretta tra le
norme a struttura elastica e la buona fede o, comunque, le clausole
generali della tradizione civilistica è un po’ singolare a proposito
del contratto di lavoro, nel quale il contenimento del potere
dell’impresa e il ripristino di condizioni di maggiore tutela per il
lavoro eterodiretto è svolto dalla legge e dalla contrattazione
collettiva, quindi dalle scelte dell’ordinamento democratico, più
che dalle scelte affidate alla valutazione giudiziale nell’incontro
con l’esperienza sociale.
367
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
C’è un problema di ordine strutturale che la prof. Campanella
mette bene in luce; bisogna distinguere il rinvio all’esperienza
sociale al fine dell’identificazione del precetto con il rinvio all’esperienza sociale ai fini dell’applicazione al caso concreto di un precetto che trova la sua ragione di essere all’interno del tessuto
normativo. Regolato il matrimonio, bisogna vedere chi si è sposato,
ma questo non significa che il matrimonio è desunto dall’esperienza
sociale; se mai, occorre applicare l’istituto del matrimonio all’interno dell’esperienza sociale. Non possiamo dire che sia la stessa
cosa rinviare all’esperienza sociale e al sistema relazionale dei
rapporti tra privati, al fine dell’identificazione del precetto o al fine
dell’identificazione della premessa minore del sillogismo giuridico.
Altro è rimandare all’esperienza sociale per cogliere la premessa
maggiore, altro è fare riferimento all’esperienza sociale per cogliere
la premessa minore.
C’è una terza considerazione, tipica del diritto del lavoro; noi
abbiamo molte norme elastiche, le quali rimettono di sicuro (e
hanno del tutto ragione il prof. Bellomo e il prof. Loy) al giudice un
ampio spettro di valutazioni attente al caso specifico, ma rispetto
ai parametri dell’organizzazione aziendale, per capire dove stia la
corretta struttura e fino a che punto si possa spingere nei confronti
dei diritti dei lavoratori. Questo ha poco a che vedere con la buona
fede che rimanda alla dimensione relazionale dei rapporti tra
privati per la scoperta di regole di condotta che non inglobano la
considerazione dell’organizzazione aziendale, ma momenti assiologici inerenti a regole di condotta. Per esempio, con un effettivo
ricorso alle clausole generali, per una sentenza ineccepibile, un
malato terminale non è in grado di calcolare il periodo di comporto
e, se c’è un principio generale secondo cui non bisogna avvertire il
lavoratore dell’approssimarsi della fine dello stesso periodo di
comporto, questo principio subisce una deroga per la persona
sottoposta a chemioterapia. A tale riguardo, si invoca il principio
di buona fede e non si guarda tanto alla dimensione organizzativa,
ma a regole di condotta a ragione desunte dalla vita sociale, regole
le quali si impongono per la dimensione relazionale dei rapporti tra
privati.
È del tutto diverso il ragionamento rispetto alla giusta causa e
al giustificato motivo. Queste norme, con maglie larghe nella loro
applicazione, sono diverse dalla buona fede, perché non c’è nessun
raccordo con l’esperienza sociale, ma se mai con questioni organiz368
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
zative. Le vere clausole generali con impatto sul rapporto di lavoro
sono molte o poche? Quando, a proposito dell’art. 2105 c.c., per la
Suprema Corte, oltre a violare l’obbligo legale, alcuni inadempimenti sono anche contrari alla buona fede, cade in un pleonasmo.
La violazione della norma legale implica il disvalore giuridico senza
la necessità di invocare le clausole generali.
Ma non è sempre così, e richiamo un caso che, dimostra come
l’esatta identificazione di quella che sia la buona fede porta a
conseguenze rilevanti dal punto di vista economico. Qual è il
problema? La violazione del dovere di applicazione dei criteri di
scelta nel caso del licenziamento individuale. Ci sono massime della
Suprema Corte che risalgono al 2000 e ascrivono questo principio
all’applicazione del criterio di buona fede. Se hanno ragione e se nel
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo si discute di buona fede, cioè dell’applicazione di criteri che derivano
dal vivere sociale mediante l’osmosi nel sistema legale, ha ragione
la maggioranza dei giudici di merito che nega l’applicabilità dell’art. 18, quarto comma, St. lav.. Se non si discute del giustificato
motivo, in quanto tale, ma dell’applicazione di criteri di buona
fede che vengono dopo l’identificazione del giustificato motivo
oggettivo, deve ricorrere la tutela indennitaria.
Ma è così? È un problema di buona fede? Credo di no e che
dalla buona fede, intesa come osmosi delle regole del vivere civile
all’interno del sistema legale, non si possa dedurre l’applicabilità
dei criteri di scelta al giustificato motivo oggettivo, che sono
sicuramente applicabili. Invece, soccorre l’applicazione analogica
al licenziamento individuale dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991,
in tema di licenziamenti collettivi. In tale caso, si deve invocare in
via analogica anche la norma sulla sanzione, quindi l’art. 18,
quarto comma, St. lav.. Potete essere d’accordo o no, ma l’esatta
delimitazione del concetto di buona fede sposta entità economiche
significative, perché, a seconda che voi aderiate alla tesi della
Suprema Corte, ci sono conseguenze evidenti su un problema con
gravissime ricadute patrimoniali.
Grazie.
369
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
GIULIO PROSPERETTI
Il principio di correttezza e buona fede assume una nuova
particolare rilevanza allorchè, per così dire, si incorpora in determinate fattispecie produttive di diritti: uno è l’esempio dell’antisindacalità, l’altro è l’esempio del mobbing a ben vedere anche la
nuova disciplina dei licenziamenti.
L’antisindacalità di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori
di per sé ricomprende il principio di correttezza e buona fede,
perché l’intenzionalità del comportamento del datore finisce per
qualificare la fattispecie, quindi la norma generale, il principio di
correttezza e buona fede non sta sopra alla fattispecie, ma ne
diventa proprio il contenuto.
Anche se per la verità non condivido la dottrina processualistica e la giurisprudenza che hanno trasformato in un giudizio
ordinario quello che nell’intenzione di Giugni era una sorta di
“injunction”, proprio perché che poteva essere richiesta da organismi senza personalità giuridica e che consentiva al giudice di
emettere provvedimenti di urgenza senza valore anticipatorio, ma
assistiti da sanzione penale.
Altro fenomeno è quello del mobbing, che alla fine riusciamo a
rendere giustiziabile tramite il concetto di costrittività organizzativa, il 2087 c.c., il danno biologico. Per esempio capita spessissimo
di trovare lavoratori che lamentino la violazione del principio di
parità: hanno promosso tutti i suoi colleghi alla qualifica superiore
tranne loro. La tutela di questa situazione di per sé è difficile
perché non esiste un principio di parità, ma ci si può arrivare
considerandola una discriminazione, ma anche questa via è problematica, perché non siamo difronte ad una discriminazione tabellata; comunque proprio tramite il mobbing si può arrivare a
rendere giustizia in queste fattispecie.
Anche in questa situazione fa da padrone proprio il principio di
correttezza e buona fede, senza il quale non potremmo costruire
370
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
un’efficiente fattispecie di mobbing, come invece ha provato a fare
la giurisprudenza.
Aggiungerei che anche la nuova disciplina dei licenziamenti è
retta dal principio di correttezza e buona fede riferito al datore di
lavoro, sicché una volta valutata la irrilevanza dell’inadempimento del lavoratore le conseguenze in ordine alla reintegrazione
non riguardano più la fattispecie a carico del lavoratore, ma
l’apprezzamento della buona o mala fede da parte del datore di
lavoro.
Purtroppo i giudici non sembrano essere culturalmente attrezzati a giudicare sulla base dei principi generali e normalmente si
rifugiano in uno sterile formalismo, che non rende giustizia sostanziale.
371
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
CARLO PISANI
Il “costo” in termini di incertezza delle norme inderogabili a precetto
generico
1. Mi chiedo se in questo nostro Paese, pieno di debiti e di
disoccupati, che nel 2013 ha avuto il 54% di incremento della
disoccupazione giovanile, il record di fallimenti, 54 al giorno; in cui
hanno chiuso 330 imprese artigiane al giorno; mi chiedo, dunque,
se in questa situazione possiamo ancora permetterci il lusso che gli
aspetti più delicati del rapporto di lavoro siano regolati esclusivamente da norme generali.
Qui mi riferisco alle norme generali, alle norme elastiche, a
quelle vaghe, ecc.; parlo di giusta causa, di giustificato motivo
soggettivo, di equivalenza, ecc; invece le clausole generali in senso
tradizionale sono buona fede e correttezza; la confusione l’ha fatta
l’art. 30, comma 1 della legge n. 183/2010, laddove usa il termine
“clausole generali”, mentre doveva esprimersi in termini di norme
generali. Pertanto io voglio soffermarmi sulle norme generali che
regolano importanti aspetti del rapporto di lavoro e sappiamo
quali sono.
2. Mi chiedo, allora: possiamo ancora permetterci di pagare il
prezzo, in termini di incertezza e di imprevedibilità, delle decisioni
giudiziarie che interpretano e applicano norme come la giusta
causa, il giustificato motivo soggettivo, l’equivalenza, la subordinazione, l’art. 2087? Siamo condannati a morire con queste
norme?
Il costo in termini di incertezza di queste norme lo conosciamo
tutti e qui vi faccio una carrellata velocissima di esempi noti,
soprattutto per i più giovani.
Fa sorridere che una norma anti incertezza, come l’art. 30,
comma 1 della legge 183, sul giustificato motivo oggettivo (che,
come tutti sanno, prevede che il giudice non può sindacare il
372
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive del
datore di lavoro), venga sistematicamente disattesa da un filone
consistente di sentenze perfino della Cassazione, le quali ritengono
legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo se
è attuato per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti e
non per aumentare profitti, invece di limitarsi, come prevede
testualmente la norma, a controllare il presupposto di legittimità e
il nesso di casualità tra la motivazione organizzativa, l’esigenza
organizzativa e il posto soppresso del lavoratore.
Io sospetto che ci sia di mezzo, più che sottili e articolate
interpretazioni, l’ideologia; e già il mio maestro Gino Giugni, negli
anni ’90, sosteneva che le norme generali aprono le porte all’ideologia nelle sentenze, se tali norme non vengono utilizzate — e mi è
piaciuta questa espressione di Loy — in modo educato.
Tutto ciò incide, ovviamente, su tasso di incertezza, in relazione ad un aspetto del rapporto, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, che risulta una norma cardine, come diceva
Mario Napoli, della dimensione dell’organico del datore di lavoro,
oltre ad essere una norma spartiacque tra il sistema capitalistico e
un sistema diverso.
3. Mi veniva da sorridere anche a pensare che, se una norma
del genere, così chiara, non è servita a dare un poco di certezza,
figuriamoci che fine ha fatto l’altra norma, emblema di manifestazione di impotenza del legislatore, quella del 3° comma del 30,
quando si limita a prescrivere che il giudice deve soltanto “tener
conto” delle tipizzazioni del contratto collettivo nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; ed
infatti questa norma non è servita assolutamente a niente!
Ancora adesso dobbiamo osservare incertezze clamorose su
tipici motivi disciplinari di licenziamento: si pensi alle oscillazioni
della Cassazione sul furto o appropriazione indebita di modico
valore da parte del dipendente, o a quelle in materia di insubordinazione del dipendente.
Alcune sentenze sono troppo interessanti per essere sottaciute;
ad esempio la Cassazione ha negato la giusta causa, in un caso in
cui il marito aveva preso a schiaffi la moglie in azienda, durante
l’orario di lavoro; a quel punto era intervenuto il superiore per
dividerli ed il lavoratore aveva cominciato ad inveire anche contro
di lui; la Cassazione ha sostenuto che non sussisteva la giusta causa
373
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
perché, innanzitutto, si trattava di un fatto privato tra marito e
moglie; quanto alle offese nei confronti del superiore, insomma,
costui si è messo in mezzo tra moglie e marito, come si era
permesso?
Questa diventa una commedia; però, in realtà, la cosa è molto
seria perché ci sono fior di sentenze che hanno affermato l’ingiustificatezza del licenziamento del lavoratore che si rifiuti di adempiere a un ordine, qualora il rifiuto posto dal datore si configuri
“solo” come un atto di insofferenza del lavoratore.
Io non voglio entrare neppure nella disputa se l’appropriazione
di modico valore da parte del dipendente costituisca giustificazione
del licenziamento oppure no; a me interesserebbe soltanto mettere
il datore nelle condizioni di sapere ex ante se questo fatto integra o
no il giustificato motivo.
L’imputato principale di questo danno è, appunto, questa
nefasta norma a struttura aperta che lascia spazio al soggettivismo
giudiziario.
4. Che dire, poi, come altro esempio significativo delle oscillazioni della Cassazione, dell’ampiezza del repechage del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ora esteso anche alle
mansioni inferiori e non solo a quelle equivalenti. In un mio
articolo ho parlato della creazione che si espande al pari dell’incertezza. Si consideri che il datore di lavoro, in caso di effettiva
soppressione del posto e di assenza di mansioni equivalenti libere,
deve preoccuparsi di dimostrare l’assenza di posti liberi in tutte le
altre mansioni inferiori della scala classificatoria, tanto più numerose se il dipendente licenziato aveva un’alta qualifica.
Si potrebbe dire che questo è “il bello della creatività”, che
rende la vita meno monotona. Peccato però che questa attività
creativa non si riversa nel mondo dell’estetica ma in quello del
diritto, dove l’esistenza di regole giuridiche dovrebbe impedire
l’ingresso del principio nichilistico del “tutto è permesso”.
5. Per quanto riguarda l’altra norma a precetto generale
fonte di innumerevole contenzioso, l’equivalenza, non mi sento di
condividere le opinioni secondo cui la giurisprudenza faccia riferimento al contratto collettivo per ridurre l’incertezza. Non mi
risulta.
374
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Anzi, in materia di mansioni promiscue le Sezioni Unite del
2006 hanno imposto pesanti limiti all’autonomia collettiva, in
modo del tutto creativo, sostenendo la legittimità di tali mansioni
promiscue solo se le diverse mansioni appartengono alla stessa
qualifica e la modifica sia giustificata da esigenze aziendali. Il che
rappresenta un regresso, in quanto in precedenza le mansioni
promiscue avevano il solo limite del loro consolidamento e della
frode alla legge.
6. In materia di mansioni nel lavoro pubblico contrattualizzato, ci si è messo anche il legislatore ad eliminare una delle poche
norme che devolveva interamente la materia dell’equivalenza alla
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi: come
è noto il d.lgs. 150 del 2009 ha modificato tale norma prevedendo
che il lavoratore può essere adibito alle “mansioni equivalenti
nell’ambito delle aree di inquadramento”.
Il che ovviamente non significa che tutte le mansioni inquadrate in ciascuna area siano equivalenti; altrimenti, se avesse
voluto dire questo, non sarebbe stato più necessario il riferimento
all’equivalenza in quanto sarebbe stato sufficiente sancire il solo
limite costituito dall’area di inquadramento.
7. Come se non bastasse vi è stata anche la modifica del 360
n. 50 c.p.c.: sparisce l’impugnazione in Cassazione per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, che costituiva lo strumento principale per sottoporre al giudice di legittimità il controllo
in ordine all’applicazione da parte del giudice di merito delle norme
generali.
Sicché i cittadini a cui tali norme generali sono applicate, si
ritrovano nella totale incertezza, abbandonati alla mercé dei giudici di merito.
8. Incertezza, dunque, e problema occupazionale. Io dubito
fortemente che questo quadro incentivi le assunzioni e incentivi a
far investire in Italia.
Qualche anno fa parlavamo sempre di incertezza del diritto,
però era una nobile battaglia di principio; alcuni ci prendevano un
po’ in giro sostenendo fosse una nostra fissazione anacronistica; e
noi rispondevamo con alcune belle citazioni; per esempio quella di
Grossi, tratta dal suo libro “Mitologie giuridiche della modernità”,
375
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
in cui dice: “Il giurista è un cercatore d’ordine, un tessitore
d’ordine, perché il diritto è essenzialmente scienza ordinante. Egli
si sforza di individuare e segnare la ragnatela dell’ordine che
soggiace invisibile, ma reale, al di sotto dell’incomposta rissa delle
cose”; sembra una frase sapienziale.
Il problema, però, oggi, non è neppure più questo, ma è molto
più concreto perché si tratta di incentivare gli imprenditori ad
assumere ed io temo fortemente che questa regolazione per norme
generali sia uno dei più forti disincentivi.
Gli economisti ci dicono che agli investitori stranieri occorre
sapere e sentire che l’Italia sia un’entità prevedibile; quindi per
creare un ambiente favorevole agli investimenti vi è l’aspetto
cruciale della prevedibilità delle regole.
Anche se non vogliamo andare dietro ai sacri principi, sussiste
comunque l’interesse concreto di combattere questa emergenza
della disoccupazione. Di questi tempi sono gli imprenditori privati
che debbono assumere, in quanto la Pubblica Amministrazione
non assume più nessuno; sono finiti i tempi in cui i governi
gonfiavano di personale inutili Enti e Ministeri per ragioni di
consenso elettorale, contribuendo così a creare l’attuale montagna
di debito pubblico.
9. Chiudo con una parola di speranza: in questi ultimi mesi
qualcosa si è cominciata a fare; finalmente hanno tolto le causali
generali del contratto a termine, ovviamente con adeguati contrappesi: il limite del 20% dell’organico e la durata di 3 anni.
Queste soluzioni alcuni le proponevano da anni, tanto erano
logiche e scontate; ma è chiaro che c’era l’ideologia di mezzo;
quindi si sono fatte solo ora e questa è già una buona cosa, però
altamente insufficiente; come insegnava Giugni negli anni ’90, la
strada maestra è quella della devoluzione al contratto collettivo in
funzione di integrazione della norma.
In verità vi sarebbe già, in proposito, una norma di questo
tipo, ed è il noto art. 8, sugli accordi di prossimità, che non viene
applicata forse — ritengo — più per pregiudizi ideologici che per
problemi tecnico-giuridici; ma di quella norma io vorrei sottolineare non tanto la potenzialità derogatoria che pure c’è, ma mi
accontenterei della funzione integrativa di aspetti e materie come
“equivalenze e recesso” ai fini della certezza. Ad esempio, che si
preveda pure, in questi accordi di prossimità, che la sanzione per il
376
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
furto di modico valore è solo la sospensione di 10 giorni, invece del
licenziamento; ma almeno il datore di lavoro lo riesce a sapere ex
ante e non ex post da un giudice, anni dopo.
In conclusione, io credo che occorra sfatare il mito che le norme
generali siano indispensabili al diritto del lavoro; si tratta soltanto
di una delle varie tecniche utilizzabili, neanche delle migliori, forse
tra le peggiori se coniugata con la norma inderogabile.
377
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
SIMONE VARVA
Sul sindacato di ragionevolezza nell’esperienza spagnola
Nella sua relazione scritta il professor Stefano Bellomo riporta
l’efficace espressione secondo cui a « fonti fluide corrispondono
giudici potenti » (Cordero, 1981). Anche sulla base di questo suggestivo e condivisibile assunto, intendo affrontare il tema dell’applicazione delle “formule elastiche” (termine a cui faccio riferimento in senso atecnico) nell’ambito del controllo sul licenziamento per ragioni oggettive.
Più specificamente, vorrei soffermarmi brevemente (nei limiti
in cui cioè lo consente l’intervento) sul ricorso da parte della
giurisprudenza ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità:
nozioni sulla cui incerta natura hanno indagato ampiamente i
relatori e sulla cui analisi, perciò, non indugio ulteriormente.
In tema di utilizzo giurisprudenziale di tali principi trovo
significativo richiamare in particolare l’esperienza offerta dall’ordinamento spagnolo in merito controllo sul “licenziamento economico”. Tengo a precisare che non vi è alcuna velleità di procedere
ad una indagine di tipo comparatistico e ricorderò, prima di tutto
a me stesso, quanta estrema prudenza occorra adottare laddove si
tenti di raffrontare situazioni apparentemente analoghe che, tuttavia, fanno riferimento a differenti esperienze giuridiche nazionali.
In ordine al licenziamento per ragioni oggettive, il legislatore
spagnolo è più volte intervenuto negli anni recenti. Mi riferisco in
particolare alle modifiche introdotte all’art. 51 dello Statuto dei
lavoratori nazionale (più precisamente del “Texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores”, d’ora innanzi ET), prima
nel 2010 e, successivamente, nel 2012.
Procedendo all’analisi del suddetto articolo, vi è in primo luogo
da rilevare come sia stata da subito chiara l’intenzione del legislatore di delineare e di tenere separate le diverse species di recesso,
378
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
pure tutte riconducibili al genus del licenziamento per ragioni
oggettive. In particolare, da una parte è stato definito il recesso
fondato su cause economiche; dall’altra parte i licenziamenti connessi a cause tecniche, organizzative e produttive (fattispecie poi,
a loro volta, distintamente individuate in via legale).
Su questo impianto normativo il legislatore è intervenuto una
prima volta nel 2010, innestando una nuova disposizione con cui si
impone all’imprenditore che recede di dimostrare la ragionevolezza
della decisione. Tale obiettivo è stato attuato attraverso la valorizzazione del nesso causale tra recesso, ad un capo, ed esigenza
economica, tecnica, organizzativa o produttiva, all’altro capo. Alla
luce di come tale disposizione è stata intesa dalla giurisprudenza,
all’interprete sembra venga sostanzialmente richiesto di effettuare
un vaglio di “coerenza funzionale” fra mezzo e fine.
A due anni di distanza il legislatore, tornando sullo stesso art.
51 ET, ha rimosso dal testo il riferimento alla nozione di ragionevolezza. Nel contempo egli ha tentato di introdurre in via legale (e
perciò in termini predefiniti e generali) una specifica ipotesi di
licenziamento economico giustificato: alludo a quella fattispecie,
piuttosto conosciuta anche in Italia, secondo cui la persistenza di
una situazione economica sfavorevole sarebbe dimostrata dalla
sussistenza di perdite per tre trimestri consecutivi rispetto ai tre
trimestri corrispondenti dell’anno precedente (nell’originale: « en
todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante
tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de
cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año
anterior »).
Merita di essere enfatizzato il fatto che il legislatore del 2010,
nell’intervenire cercando di meglio definire le species di licenziamento per ragioni oggettive, nel contempo introduce positivamente nell’ordinamento il principio di ragionevolezza. Di primo
acchito, si potrebbe allora dedurne che in quel frangente il legislatore abbia ottenuto l’effetto contestuale di affinare gli aspetti
definitori e (quasi come tecnica di “bilanciamento”) di aggiungere
allo strumentario del giudice un elemento che ne amplia i margini
d’apprezzamento. In termini generali, l’esplicito riconoscimento
del sindacato di ragionevolezza potrebbe qui essere considerato
quasi una “valvola di sfogo” dell’ordinamento, un elemento di
elasticità che permette al potere giudiziario di adattare il controllo
e la valutazione alla fattispecie concreta e alle caratteristiche
379
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
specifiche del caso reale. In via puramente incidentale è curioso
notare come, paradossalmente, nella intentio del legislatore storico
fosse invece da riscontrare il fine di circoscrivere il sindacato
giudiziale, considerato che all’interprete si chiedeva (nella formulazione originaria del decreto legge, da cui è stato poi rimosso
l’avverbio in fase di conversione) di verificare che dalle allegazioni
probatorie potesse dedursi « mínimamente » la ragionevolezza della
decisione di porre fine al rapporto di lavoro.
Al di là dei rilievi formali e delle questioni interpretative, mi
pare interessante passare a verificare se l’inserimento (prima, nel
2010) o la rimozione del riferimento al controllo di ragionevolezza
(poi, nel 2012) abbiano inciso concretamente sull’ampiezza del
sindacato giudiziale. In termini estremamente sintetici si può
rilevare come, sotto questo aspetto, i margini per le prerogative
giudiziali non sembrino essere sensibilmente mutati. L’analisi delle
pronunce consente infatti di mettere in luce come i giudici continuino a fare riferimento e a rivendicare l’utilizzo di “principi
elastici” e “concetti valvola”, quali sono per l’appunto la ragionevolezza e la proporzionalità.
Si possono riportare, ad esempio, alcuni argomenti utilizzati
dal Tribunale Superiore di Giustizia di Madrid in una pronuncia
dell’inizio del 2014, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 51
ET nella versione post 2012 (Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sala de lo Social, Sección 1a, Sentencia num. 29/2014 de 10
enero). Il Tribunale ritiene in primo luogo che « il controllo di
ragionevolezza è consustanziale al potere costituzionale garantito
di giudicare e di assicurare una tutela giudiziale effettiva »; aggiunge che « la ragionevolezza stessa si erge quale manifestazione
della giustizia come valore superiore dell’ordinamento giuridico,
essendo proprio l’imprenditore per primo colui che è interessato al
fatto che i mezzi adottati siano razionali e proporzionali ». Il
giudice, poi, indugia nell’elencazione di una pletora di formule
elastiche, statuendo che il licenziamento deve rispettare i criteri di
ragionevolezza, razionalità, congruenza, proporzionalità e ponderazione. In conclusione, dall’autorità giudicante viene confermato
come il test di proporzionalità e di adeguatezza sui motivi di
licenziamento sia sopravvissuto all’abrogazione del riferimento
normativo esplicito; d’altro canto, viene negato « il controllo di
proporzionalità in senso stretto che presupporrebbe, invece, l’in380
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dispensabilità del licenziamento stesso considerato secondo la prospettiva del licenziamento quale extrema ratio ».
Anche l’Audiencia Nacional, peculiare organo giurisdizionale
superiore dell’ordinamento spagnolo a cui sono riconosciute ampie
competenze di materia, ha confermato che il controllo sulla connessione funzionale tra esigenze economiche e licenziamento sopravvive alla soppressione del riferimento alla ragionevolezza (Audiencia Nacional, Sala de lo Social, Sección 1a, Sentencia num.
40/2013 de 11 marzo). Controllo, in ogni caso, reso necessario anche
al fine di rispettare la Convenzione n. 158 dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (Convenzione che, a differenza di
quanto accaduto in Italia dove non è stata ratificata, la Spagna ha
da tempo recepito); l’art. 4 della medesima, in particolare, prevede
che per porre termine a un rapporto di lavoro occorre che sussista
una valida giustificazione connessa a elementi soggettivi (attitudine o condotta) relativi al lavoratore ovvero legata a esigenze
organizzative. Sempre secondo l’Audiencia Nacional, la scelta
abrogativa del legislatore del 2012 comporterebbe al più l’opportunità di intendere la ragionevolezza « declinata soprattutto in
termini di proporzionalità ». Si tratterebbe perciò di un controllo di
ragionevolezza e proporzionalità sui mezzi impiegati ovvero, sotto
un’altra prospettiva,di una tecnica di bilanciamento tra sacrifici e
interessi contrapposti.
Può dedursi da questi rapidi cenni che è sempre rinvenibile a
favore del giudice un margine di apprezzamento del caso concreto
in definitiva insopprimibile; margine che diviene peraltro particolarmente ampio dinnanzi a disposizioni che fanno riferimento a
formule generali: formule generali tra le quali si può certamente
annoverare il licenziamento economico.
Forse allora non è un caso se le opzioni normative adottate nei
diversi ordinamenti per definire e limitare il potere di licenziamento sono accomunate da connotati di elasticità e indeterminatezza. Il riferimento all’esperienza spagnola, in questo senso, ci
conforta sul fatto che il delicato rapporto di bilanciamento (ovvero
di “check and balance”) tra competenze e prerogative del legislatore, da un lato, e del giudice, dall’altro, non sia affatto una cura
esclusivamente italiana e ci conferma nuovamente come, specialmente in alcuni ambiti dell’ordinamento, un significativo margine
per il sindacato giudiziale sia fondamentalmente irrinunciabile.
381
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
FRANCESCA MARINELLI
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione nell’ambito dei c.d.
poteri datoriali e, dunque, ponendomi in linea di continuità con la
relazione del Prof. Loy, due clausole generali che a mio avviso
meritano di essere ricordate.
Si tratta di due clausole inserite nell’art. 18 St. lav. dalla
riforma Fornero e mi riferisco a quella parte della norma che
sancisce la nullità — con conseguente reintegrazione — del licenziamento determinato da motivo illecito determinante ai sensi
dell’art. 1345 c.c.
Sebbene le clausole generali non siano immediatamente visibili
nella norma appena citata, esse affiorano non appena si svolga il
rinvio fatto all’art. 1345 c.c.
Come è stato infatti già rilevato dalla dottrina lavoristica (mi
riferisco alla Relazione Aidlass di Maria Teresa Carinci del 2012),
negli atti unilaterali — qual è l’atto di licenziamento — causa e
motivo determinante finiscono per coincidere. Da un lato, infatti,
il motivo determinante di licenziamento viene inteso come la
ragione individuale che ha spinto il datore di lavoro a compierlo;
dall’altro, la causa di licenziamento viene intesa da tempo non più
solo come la funzione economico-sociale del negozio (che, come
noto, nei negozi tipici come gli atti unilaterali è sempre lecita,
essendo di creazione legale), quanto, piuttosto, come l’interesse
comune alle parti che la singola operazione sottesa al negozio è
diretta a soddisfare, ossia, nel caso dell’atto unilaterale di licenziamento, l’interesse del datore di lavoro sotteso al licenziamento
stesso.
Ma se le cose stanno così, cioè se è lecito — come tutti
ritengono — sovrapporre, nel caso dell’atto unilaterale di licenziamento, causa e motivo determinante, è chiaro anche che quest’ultimo sarà illecito tutte le volte in cui risulti illecita la causa, ossia,
come afferma lo stesso codice civile agli artt. 1343 e 1344, tutte le
volte in cui il motivo determinate del recesso datoriale sia o illegale
382
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
(ossia contrario a norme imperative o in frode alla legge), o antigiuridico (ossia contrario all’ordine pubblico) o immorale (ossia
contrario al buon costume).
Ed ecco affiorare le clausole generali.
Ordine pubblico e buon costume, infatti, possono senz’altro
essere riguardate — come ricordato poc’anzi dalla stessa Prof.
Campanella — come direttive predisposte dal legislatore a favore
del giudice, affinché quest’ultimo fondi la decisione sullo standard
di ordine pubblico e di buon costume presente in una data realtà
storica.
Quale sia il contenuto di queste clausole generali è dunque un
compito volutamente lasciato al giudice dal legislatore (tramite
appunto l’utilizzo di tali clausole) e che pertanto varierà caso per
caso a seconda dei valori in gioco.
Tutta questa premessa per arrivare a dire che è proprio questa
voluta genericità della nozione di motivo illecito di licenziamento
— dovuta, come visto, al suo stretto collegamento con le clausole
generali di ordine pubblico e buon costume — ad imporci di non
trattarla come una variante semantica del licenziamento discriminatorio (come invece tende a fare una parte della dottrina e della
giurisprudenza).
Se, infatti, le ragioni discriminatorie, essendo elencate dallo
stesso legislatore, non ammettono un sindacato di merito sulla loro
intrinseca riprovevolezza, essendo esse sempre contra legem — a
meno che non sia provata l’esistenza di una esimente —, la categoria dei motivi illeciti in quanto, come detto, categoria aperta,
necessita di un controllo caso per caso con attenzione alla giustizia
del caso singolo.
Ciò significa che, mentre una volta provata la discriminazione
il giudice sarà sempre (cioè indipendentemente dall’interesse del
creditore della prestazione) tenuto a dichiarare la discriminatorietà
del licenziamento (salvo esimente), nel caso del licenziamento per
motivo illecito, il giudice sarà chiamato a verificare di volta in
volta se quel motivo — ritenuto indispensabile per il datore di
lavoro ai fini della realizzazione del suo interesse creditorio — non
sia in realtà contrario alle clausole generali di ordine pubblico o
buon costume; e non mi sembra, questa, una differenza da poco.
383
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
PIERA LOI
Ragionevolezza e clausole generali
Il mio breve intervento è stato sollecitato in particolare dalle
relazioni di Gianni Loy e di Stefano Bellomo e dai riferimenti
contenuti in queste relazioni al tema del ruolo della ragionevolezza
nell’interpretazione giudiziale delle clausole generali.
Gianni Loy, ad un certo punto, parlando del rischio di arbitrarietà della decisione del giudice chiamato a dare contenuto alla
clausola generale, ha ricordato che l’ultimo limite che il giudice ha
è quello di assumere una decisione non irragionevole. Emerge,
chiaramente, in quest’affermazione il tema della ragionevolezza
della decisione giudiziale quando il giudice sia chiamato ad applicare una clausola generale. Anche Stefano Bellomo ha fatto riferimento alla ragionevolezza come criterio, come canone, per valutare
la contrattazione collettiva, individuata come standard per dare
contenuto alle clausole generali.
In uno degli interventi di chi mi ha preceduto è stata citata
una recente sentenza del Tribunale di Madrid in materia di licenziamento collettivo, nella quale i giudici spagnoli riaffermano la
necessità di sottoporre al vaglio del principio di ragionevolezza e
proporzionalità la sussistenza della causa oggettiva di licenziamento, onde valutare la legittimità stessa del licenziamento.
Il tema della ragionevolezza emerge ogni volta che si debbano
interpretare “nozioni a contenuto variabile nel diritto”. Credo sia
preferibile adottare, come fa Gianni Loy, la categoria di “nozione
a contenuto variabile nel diritto” elaborata dal filosofo del diritto
Chaim Perelman, anziché limitarsi all’esame delle sole clausole
generali. Innanzitutto perché semplifica una serie di problemi
tassonomici. Com’ è stato evidenziato, infatti, ad ogni teoria sulle
clausole generali corrisponde normalmente una indicazione di
quali locuzioni rientrino nelle clausole generali, quali nei principi,
o quali nelle norme generali. Uno dei criteri utilizzabili per giusti384
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ficare le proprie scelte tassonomiche è senz’altro quello del diverso
tipo di attività che il giudice compie nell’interpretare e applicare le
diverse locuzioni, ma è preferibile, almeno in questa sede e data la
brevità del mio intervento, non concentrarsi su tali aspetti. Il
vantaggio della categoria “nozione a contenuto variabile nel diritto” risiede nel fatto che ha un campo di applicazione molto
ampio che ricomprende tutte le categorie di cui oggi si discutono i
rispettivi confini: clausole generali, principi generali e standard.
L’elemento caratterizzante della categoria consiste nella specificità
dell’intervento giudiziale nell’interpretazione e applicazione delle
nozioni a contenuto variabile, caratterizzato da una maggiore
discrezionalità, ma soprattutto da un’attività considerata creativa
del diritto. Inevitabili sorgono le domande su come vincolare il
giudice, su come limitarne gli eccessi creativi, soprattutto in un
terreno come quello del diritto del lavoro, nel quale, al contrario, si
assiste ad una chiara volontà da parte del legislatore di limitare il
più possibile il controllo giudiziale in presenza di clausole generali
in materia di lavoro. Il riferimento è sicuramente all’art. 30 della l.
n. 183 del 2010, che circoscrive il controllo giudiziale alla sussistenza dei requisiti di legittimità degli atti datoriali e non può
essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche,
organizzative e produttive.
Nella stessa direzione, tuttavia, si trovano ampi riferimenti nel
diritto comparato, come la Ley n. 3 del 2012 che, nel modificare
l’art. 51.1 dell’Estatuto de los Trabajadores, ha formalmente eliminato il controllo di ragionevolezza del giudice nei licenziamenti
economici, dovendosi il giudice limitare a verificare che vi siano
state per tre mesi consecutivi perdite consistenti.
Questa tipologia di interventi legislativi non fa che limitare il
campo delle possibili argomentazioni giuridiche utilizzabili dal
giudice nella sua attività interpretativa, escludendone alcune,
perciò, in definitiva, il tema delle nozioni a contenuto variabile,
anche nel diritto del lavoro, implica l’esposizione delle rilevanti
teorie dell’interpretazione e dell’argomentazione giuridica.
A partire dalla descrizione del diritto come argomentazione
giuridica (sulla base delle teorie di Alexy, riprese da Atienza), nei
sistemi a carattere costituzionale che si fondano su principi tra cui
occorre effettuare un bilanciamento, si deve evidenziare l’emergenza — sempre più chiara sia nell’ordinamento comunitario, che
385
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
negli ordinamenti nazionali — della ragionevolezza come canone di
legittimazione stessa dell’ordinamento giuridico.
La ragionevolezza, come nozione variabile nel diritto, che
peraltro alcuni civilisti, un po’ apoditticamente, classificano come
clausola generale, (mentre al più potremmo dire che si tratta di un
principio generale) è un tratto tipico del diritto moderno.
Il diritto ottocentesco era caratterizzato da una razionalità di
tipo cartesiano, per cui il giurista nell’applicare il diritto era
chiamato a compiere operazioni di tipo logico-matematico, di qui
l’idea che il giudice fosse la bouche de la loi. Il diritto moderno,
invece, è lo specchio di società complesse in cui la crisi regolativa
si manifesta, da un lato, attraverso eccessi di iper-regolazione e,
dall’altro, attraverso un abuso delle clausole generali. È un diritto
profondamente trasformato dalle Costituzioni che hanno positivizzato una molteplicità di valori spesso confliggenti tra di loro. È
inevitabile che nel diritto così trasformato il mito della razionalità
e della certezza del diritto manifestino dei cedimenti e si faccia
spazio, invece, il bisogno del diritto di essere ragionevole, di
proporre tecniche e modalità di argomentazione giuridica che
consentano di contemperare gli interessi contrapposti. In questo
senso la ragionevolezza è veramente la chiave di volta dei moderni
ordinamenti giuridici nei quali non sempre il legislatore può determinare attraverso una norma generale ed astratta l’assetto definitivo degli interessi e rimanda al giudice la concreta determinazione
degli stessi. E quando, come nel diritto del lavoro, il legislatore non
sia in grado di predeterminare in una norma tale assetto degli
interessi, che spesso rimandano a diritti costituzionalmente garantiti, si fa ricorso a nozioni a contenuto variabile, affinché sia il
giudice ad individuare, in concreto, tale assetto tra interessi e
diritti contrapposti. Nell’effettuare questa operazione, comunque
la si intenda, — e abbiamo visto che i tre relatori si richiamano a
diverse teorie ricostruttive sul grado maggior o minore di apertura
verso criteri esterni all’ordinamento giuridico — il giudice è vincolato al rispetto di un principio generale dell’ordinamento che è il
principio di ragionevolezza. La ragionevolezza oltre a svolgere un
ruolo determinante nel giudizio di eguaglianza, come attributo
delle legittime differenze di trattamento, è declinabile come proporzionalità quando una determinata misura comporti la limitazione di un diritto fondamentale da parte del legislatore, ma anche
da parte di un privato. In questa seconda accezione il principio di
386
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
ragionevolezza-proporzionalità implica che il giudice sottoponga la
misura adottata, secondo la prassi applicativa del principio fattane
dalla Corte Costituzionale tedesca, ma anche da molte altre Corti,
compresa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ad un test in
più fasi: il primo diretto a valutare la legittimità dei fini, il secondo
l’adeguatezza al raggiungimento dei fini, il terzo la necessità della
misura (secondo certe ricostruzioni queste due fasi coincidono) e
per ultimo la proporzionalità in senso stretto, attraverso la quale si
realizza un vero e proprio bilanciamento tra diritti confliggenti.
L’esempio dei licenziamenti economici o per giustificato motivo oggettivo è da questo punto di vista illuminante. Il giustificato motivo oggettivo è una nozione a contenuto variabile, in
quanto la legge non ne definisce il contenuto, che dovrà essere,
invece, completato dal giudice al fine di definire la fattispecie
astratta e, dunque, il campo di applicazione al caso concreto.
Perché l’art. 3 della l. n. 604 del 1966, nel descrivere le ragioni
oggettive che possono legittimare il licenziamento fa riferimento a
“ragioni inerenti all’attività produttiva all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, cioè ad una nozione a
contenuto variabile? Perché non può fare diversamente, in quanto
la complessità della realtà, come ha evidenziato Gianni Loy, è
talmente elevata che non ha più senso né aumentare la produzione
normativa con legislazione di dettaglio, anche di carattere amministrativo — pena il rischio di colonizzazione della realtà denunciato da Habermas — ed è invece è fondamentale, al fine di
garantire l’adattabilità delle norme alla mutevolezza delle situazioni sociali, inserire nozioni a contenuto variabile del diritto ed è
altrettanto imprescindibile assegnare al giudice un ruolo così pregnante.
Naturalmente questa centralità del giudice non deve sfociare
nell’arbitrio. In questo caso la ragionevolezza è fondamentale, in
quanto si tratta di un canone che il giudice deve utilizzare ogni
qualvolta vi sia la restrizione di un diritto fondamentale, e che lo
vincola ad un’argomentazione giuridica solida, strutturata e valutabile nei suoi esiti, dopo aver effettuato un bilanciamento di
interessi contrapposti che il legislatore in anticipo non può fare.
La giurisprudenza spagnola ha dimostrato come, concretamente, si applica il principio di ragionevolezza nei licenziamenti
economici: nella sentenza del giudice madrileno del 2012 nel caso
Telemadrid, al fine di definire cosa si intenda per licenziamento
387
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
economico giustificato, si afferma che il giudice debba comunque
effettuare un controllo di ragionevolezza intesa come proporzionalità, qualificata come tecnica di ponderazione dei sacrifici.
Anche nel nostro ordinamento al fine di determinare cosa si
intenda nel singolo caso concreto per licenziamento giustificato per
motivo oggettivo, il giudice deve, a mio parere, far riferimento al
principio di ragionevolezza intesa come proporzionalità e applicare
il relativo test: i fini economici sono legittimi? I mezzi per raggiungere questi fini economici sono adeguati? Vi erano altri strumenti
per limitare al minimo la limitazione dei diritti fondamentali, in
questo caso del diritto fondamentale del lavoratore all’occupazione. Questa è la fase nella quale si realizza il bilanciamento,
perché appunto il bilanciamento è tra principi, la libertà di iniziativa economica e privata e il diritto al lavoro.
Mi sento, quindi, di difendere questa posizione e mi sento di
affermare che se il tempo della certezza del diritto non è finito: non
dobbiamo pensare che la certezza sia l’unico mito da salvare, nel
diritto del lavoro forse bisogna pensare di più alla giustizia, abbiamo bisogno di giustizia più che di certezza.
388
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
MASSIMO CORRIAS
Clausole generali e responsabilità (contrattuale) del datore di lavoro
in materia di sicurezza sul lavoro
Dalle relazione che abbiamo appena ascoltato è emerso che uno
dei numerosi problemi che le clausole generali (intese in senso lato
come categoria nella quale rientrano differenti disposizioni tutte
caratterizzate dalla presenza di espressioni o “sintagmi indeterminati”) sollevano è quello dei criteri di integrazione.
A tale riguardo, è condivisibile l’opinione di chi ritiene che la
concretizzazione delle clausole generali debba avvenire non con
criteri extragiuridici bensì ricorrendo a principi e valori riconosciuti dall’ordinamento, ossia con l’interpretazione sistematica
che, come noto, richiede il ricorso a fonti e, in particolare, a principi
di diritto positivo. L’argomentazione per principi, come criterio di
giustificazione delle decisioni giuridiche, è preferibile perché impone di portare su un livello elevato di razionalità la motivazione
delle decisioni giuridiche e ad esplicitare i giudizi di valore condivisi dall’interprete.
Tuttavia, quando l’applicazione delle clausole generali o delle
norme a contenuto variabile si inserisce in un rapporto obbligatorio, come accade anche nel caso del rapporto di lavoro, si pone
anche il problema del coordinamento con le regole della responsabilità contrattuale. Quest’ultima, secondo autorevole dottrina,
deve essere intesa come responsabilità da violazione di obblighi e si
contrappone alla responsabilità ex art. 2043 del c.c. che è una
responsabilità da lesione di diritti.
Ciò posto, dunque, la responsabilità per violazione di obblighi
è configurabile esclusivamente nel caso in cui il comportamento del
debitore costituisca inadempimento di una regola di condotta
preesistente al fatto lesivo. In altri termini, l’elemento fondante
della responsabilità — e della conseguente reazione dell’ordinamento — è la violazione di una regola di condotta conosciuta o
389
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
conoscibile e non la lesione (per quanto grave essa sia) di una
diritto.
L’operatività delle clausole generali nel rapporto obbligatorio,
quindi, non solleva solo il problema della limitazione della discrezionalità del Giudice ma anche quello relativo alla necessità di
ricostruire le posizioni di vincolo delle parti in modo coerente con
l’assetto di interessi dedotto nell’accordo negoziale e con le disposizioni legali e contrattuali che disciplinano quel determinato rapporto.
Sotto questo profilo il settore della sicurezza offre notevoli
spunti di riflessione. Si pensi alla interpretazione e all’applicazione
dell’art. 2087 c.c. proposte da quella parte della giurisprudenza che
afferma il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile.
Ancorare l’adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di
lavoro all’osservanza di tutte le misure in tecnologicamente disponibili trasforma, di fatto, la responsabilità ex art. 2087 c.c. in una
responsabilità di tipo oggettivo (alla stregua di quella per esercizio
di attività pericolosa). Infatti, il principio della massima sicurezza
tecnologicamente possibile non è e non può essere un parametro
per determinare le misure di sicurezza che ciascun imprenditore è
tenuto ad osservare nello svolgimento della propria attività in
quanto non ne consente la preventiva individuazione.
Questa interpretazione della disposizione in esame sembra
violare, quindi, la regola fondamentale della responsabilità per
inadempimento prima esaminata proprio perché comporta il riconoscimento della responsabilità (contrattuale) del datore di lavoro
per la violazione di una regola di condotta individuata ex post.
Ci sono poi anche gli aspetti processuali. L’obbligo di sicurezza
ex art. 2087 c.c. è un obbligo diretto ad un risultato negativo, ossia
evitare la lesione dell’integrità psico-fisica e della personalità morale del creditore-lavoratore. Per tale ragione esso, sotto il profilo
probatorio, deve essere assimilato alle obbligazioni negative, con
riferimento alle quali la giurisprudenza prevalente (per tutte, Cass.
Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533) ritiene che la prova dell’inadempimento sia a carico del creditore che, in questo caso, dovrà
dimostrare oltre al titolo del proprio diritto, il fatto positivo
dell’inadempimento.
Questo significa che in caso di evento dannoso il lavoratore che
voglia dimostrare la violazione da parte del datore di lavoro
390
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
dell’obbligo di sicurezza dovrà provare il danno subito e il nesso di
causalità tra questo e le specifiche misure di sicurezza che si
assumono violate che, quindi, dovranno essere concretamente individuate (Cass. 11 aprile 2007 n. 8710; Cass. 18 gennaio 2007 n.
8710, in MGL, 2007; Cass. 1 giugno 2004 n. 10510; Trib. Monza, 12
maggio 2009, n. 241); solo a questo punto scatterà, per il datore di
lavoro, l’onere della prova (liberatoria) consistente nella dimostrazione di aver predisposto ogni misura idonea ad evitare l’evento.
Non è condivisibile, quindi, il differente orientamento giurisprudenziale (Cass. 16 dicembre 2005 n. 27838; Cass., 3 luglio 2003
n. 10548; Cass., 7 ottobre 2002 n. 14323) secondo il quale il
lavoratore si può limitare a dimostrare il rapporto di lavoro, il
danno e il nesso di causalità tra questo e l’ambiente in cui è svolta
la prestazione.
L’adesione al primo dei due indirizzi giurisprudenziali appena
indicati non rileva solo con riferimento ad una diversa configurazione dell’onere della prova nel caso di evento dannoso ma comporta significative conseguenze anche sul piano della ricostruzione
del contenuto dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.: richiedere
al creditore — lavoratore la specifica allegazione della disposizione
o della misura di sicurezza violate dal debitore — datore di lavoro
comporta che quest’ultimo non potrà più essere considerato responsabile per l’omissione di una condotta idonea ad escludere ogni
possibile fonte di pericolo (Cass., 18 gennaio 2007 n. 8710, cit., 635),
ossia per la violazione di un obbligo di sicurezza inteso quale
obbligo di rispettare ogni cautela innominata diretta ad evitare un
qualsiasi danno e quindi, di una regola di condotta non preventivamente individuata o individuabile.
391
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
LUCA CALCATERRA
Moriremo con le clausole generali e le norme elastiche?
Il dibattito ha fornito stimoli innumerevoli ed è impossibile dar
conto di tutte le riflessioni che ha suscitato. Questo intervento, tra
l’altro, non era preordinato, ma nasce spontaneamente dal desiderio di rispondere all’interrogativo proposto dal professor Pisani:
“Moriremo con le clausole generali e i concetti giuridici indeterminati?”. La sollecitazione vuole provocatoriamente indurre una
riflessione sulla indefettibilità della normazione cd. elastica nel
diritto del lavoro.
La risposta non può in realtà essere univoca. Con alcuni
concetti elastici utilizzati nella disciplina giuslavoristica (e non solo
giuslavoristica...) direi che moriremo, nel senso che l’ordinamento
non può in alcun modo fare a meno di essi. Il ricorso a questa
tecnica normativa è in alcuni casi indefettibile. Condivido la sottolineatura di Piera Campanella e di Enrico Gragnoli sulla necessità di distinguere tra clausole generali e altri tipi di norme elastiche, poichè soltanto nel caso delle clausole generali possiamo dire
che l’opzione del legislatore per questa tecnica normativa è inevitabile. Ciò perché le clausole generali sono norme prive di fattispecie, che attraversano l’ordinamento trasversalmente consentendogli di recepire dei valori come vivi in quel determinato luogo e
momento storico. Gli altri tipi di norme che, con espressione
riassuntiva, possiamo indicare come “norme elastiche” sono invece
delle disposizioni normative a fattispecie aperta, quindi ancorate a
una singola fattispecie, della quale però il legislatore omette di
completare gli elementi, lasciandone alcuni aperti all’integrazione
da parte dell’interprete e, in primo luogo, del giudice.
Delle clausole generali, che da qualcuno, come Rodotà, sono
state definite “le branchie attraverso cui l’ordinamento respira”,
l’ordinamento non può fare a meno del tutto. Esistono degli
standards valutativi immanenti nella realtà sociale di un dato luogo
392
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
in un dato momento storico che non è possibile cristallizzare in via
definitiva, incapsulare in una costruzione normativa di diritto
positivo. E ciò non è possibile sia perché essi mutano al mutare
delle condizioni di luogo e di tempo, sia perché essi fanno propriamente riferimento a valori che rilevano in diverse fattispecie. Si
pensi, per intenderci, alla classica espressione del comportamento
secondo buona fede o del comportamento corretto e diligente,
espressioni che ritroviamo in tutto l’arco del diritto dei contratti.
È possibile invece, probabilmente, fare a meno di molti concetti giuridici indeterminati, delle cosiddette norme elastiche, cioè
di quelle norme a fattispecie “aperta”, che il legislatore sceglie
consapevolmente, in base a un’opzione di politica del diritto, di
non completare, ritraendo la potestà legislativa e rinviando il
perfezionamento della disciplina ad altri soggetti.
È in particolar modo il caso dei rinvii all’autonomia collettiva,
che molto a lungo hanno caratterizzato il diritto del lavoro italiano. Il rinvio all’autonomia collettiva, pur scontando i noti
problemi derivanti dall’informalità del nostro diritto sindacale,
presenta l’indubbio vantaggio di conferire, almeno tendenzialmente, a una voce sola la potestà di integrare la disciplina legale.
La valorizzazione dell’autonomia collettiva, al di là di altri pregi
pure indiscutibili, consente di evitare quella estrema frastagliatura
degli esiti dell’applicazione della norma, che discende, invece, dal
rinvio alla autorità giurisdizionale, frutto inevitabile dell’ampliamento del ricorso alla tecnica normativa per concetti giuridici
indeterminati. Per ragioni di ordine diverso si sta oggi rinunciando,
nel riformare la disciplina dei rapporti flessibili, al sistema del
rinvio all’autonomia collettiva, che avrebbe potuto garantire l’esigenza di certezza del diritto senza alterare i rapporti di forza e gli
equilibri tra le parti. A mio modesto avviso questo indebolimento
del sistema sindacale deriva non solo da una scarsa capacità del
sindacato italiano di farsi protagonista dell’evoluzione del sistema
produttivo e di consentire la strutturazione di robuste forme di
partecipazione dei lavoratori (come mi pare si possa dire sia
accaduto in altri paesi, in primis in Germania), ma anche all’informalità del nostro sistema di relazioni industriali, che andrebbe
superata. Ma non è questa la sede per discuterne.
La normazione per clausole generali ha incontrato l’entusiastica adesione di una parte della dottrina a partire dai primi anni
’60, adesione ancora ferma oltre un ventennio dopo (penso in
393
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
particolare, ma non solo, agli scritti di Stefano Rodotà degli anni
ottanta). Di questo entusiasmo, pure talora temperato da maggiore consapevolezza delle possibili distorsioni indotte dal ricorso
alle clausole generali (Castronovo scrisse un saggio che chiamò
“L’avventura delle clausole generali”, nel quale tracciò la parabola
storica di questa tecnica normativa e dei problemi connessi), hanno
però beneficiato non solo le clausole generali, ma la normazione
elastica in senso ampio, cioè tutta quella che si avvale di concetti
giuridici indeterminati.
La enucleazione della categoria delle norme elastiche in senso
ampio, intese appunto come norme contenenti concetti la cui
valenza semantica varia in ragione delle condizioni di tempo e di
luogo (e, più in generale, della specifica situazione contrattuale cui
il concetto va riferito), e, più propriamente, l’entusiasmo che ha
sostenuto il ricorso a questa tecnica normativa hanno fruttato
danni notevoli all’ordinamento giuridico, in special modo perché i
concetti elastici sono serviti in molti casi al potere politico, come
strumento per una legislazione di compromesso e poco trasparente
in settori delicati.
In particolare le norme elastiche sono servite (e servono spesso
tuttora) per attuare delle forme di flessibilizzazione dell’impiego di
manodopera in modo seminascosto o, comunque, per evitare di
assumere una chiara responsabilità politica rispetto a delle decisioni che erano poco digeribili sul piano del consenso.
Il ricorso alla famosa clausola delle ragioni tecniche organizzative e produttive, già sperimentata nella disciplina della mobilità
interna, poi diffusasi nella disciplina delle forme di impiego flessibile della manodopera, trasformandosi, a partire dalla riforma
della disciplina del contratto a tempo determinato introdotta con
il d.lgs. n. 368/2001, con l’aggiunta delle ragioni sostitutive (con un
italiano assolutamente discutibile), ha portato alla situazione attuale, vale a dire all’estrema parcellizzazione dei risultati dell’applicazione della normativa. Una parcellizzazione che significa assenza, pressochè totale in questi campi, di certezza del diritto e
incremento esponenziale del contenzioso.
Considerati gli enormi costi che si riverberano sul sistema
giudiziario, questa distorsione non poteva essere trascurata, tanto
più che nel nostro ordinamento l’assenza del valore vincolante del
precedente e un debolissimo ruolo nomofilattico della Cassazione
non hanno aiutato a contenerne le conseguenze più negative.
394
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Dobbiamo, allora, morire così? Probabilmente no, prima di
tutto perché la tecnica normativa che fa uso (e abuso) dei concetti
giuridici indeterminati non è indefettibile, come è dimostrato —
una volta tanto in positivo — dalla disposizione della Legge
Fornero che, ribadendo il contenuto dell’art. 12 della l. n. 604 del
1966, valorizza le clausole di contratto collettivo che prevedono
sanzioni conservative a fronte di inadempimenti disciplinari, attribuendo a queste previsioni carattere vincolante per il giudice su
un duplice piano, quello della valutazione della illegittimità del
licenziamento e quello della necessità della sanzione reintegratoria.
Questa disposizione, sebbene ribadisca il contenuto di una
norma più risalente, è comunque indice di un cambiamento di
rotta, perché il legislatore dopo moltissimi anni segna il verso
“meno” sull’uso dei concetti giuridici indeterminati e stringe il
campo in cui il giudice è libero di valutare la giustificatezza o meno
del licenziamento.
In secondo luogo, un’indicazione molto importante in questo
stesso senso e una conferma di un trend più generale verso la
riduzione dell’uso legislativo dei concetti giuridici indeterminati, e
sul punto devo dissentire dal pur pregevole intervento di Simone
Varva, viene proprio dal caso della recente legge spagnola n. 3 del
2012, che proprio l’altro ieri è stata valutata come legittima da un
Comitato tripartito, nominato in sede OIL e presieduto da Raffaele De Luca Tamajo nella parte in cui cristallizza nelle perdite
continue per più trimestri la nozione di crisi persistente che giustifica il licenziamento.
Il Comitato è tripartito, quindi composto anche da rappresentanti sindacali, che hanno ritenuto non costituisca compressione
indebita del potere giurisdizionale il fatto che un legislatore canonizzi il contenuto di una nozione indeterminata come quella di
giustificatezza del licenziamento indicando in modo univoco
quando questa sussista effettivamente. Ciò conferma ulteriormente che il ricorso a concetti giuridici indeterminati nella normazione non rappresenta una necessità indefettibile, perché delle
alternative esistono e sono praticabili e legittime. E il caso della
legge spagnola mi sembra particolarmente interessante poiché
concerne delle fattispecie, come quelle giustificative del licenziamento, tradizionalmente considerate necessariamente elastiche.
Ancora, e per concludere, il Decreto Renzi-Poletti (d.l. n.
34/2014, conv. in l. 78/2014), seguendo un orientamento politico
395
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
che qualcuno ha definito come post-ideologismo, fa quello che
nessuno finora aveva osato. Con il decreto n. 34/2014 il Governo
liberalizza il ricorso al contratto a termine e alla somministrazione
di lavoro a tempo determinato. Non è più necessario giustificare
l’impiego di queste forme contrattuali con la sussistenza di ragioni
tecniche o produttive. Il Governo dismette così lo schermo del
concetto giuridico indeterminato e assume la responsabilità di una
scelta che è eminentemente politica, ovverosia la liberalizzazione
piena di queste forme contrattuali flessibili attraverso il superamento dell’infausta formula delle ragioni o esigenze tecnicoproduttive e organizzative. Una formula che, come hanno evidenziato anche Piera Campanella, Piera Loi e altri, è stata introdotta
nell’ordinamento non in modo neutro, ma con l’intento chiaro di
flessibilizzare la disciplina, quindi di favorire la parte datoriale,
finendo tuttavia per provocare a quest’ultima molti più problemi
di quanto si sarebbe potuto immaginare e, forse, di quanti se ne
siano risolti.
Al di là di ogni valutazione del merito, vale a dire sulla
condivisibilità o meno di questa ulteriore liberalizzazione del ricorso alle forme contrattuali flessibili dell’impiego dei lavoratori, il
decreto n. 34/2014 evita infingimenti e supera con un atto di
coraggio, in fondo, la prassi dell’uso delle norme elastiche quale
schermo per rendere più accettabili delle decisioni politicamente
poco digeribili.
La sostituzione di un sistema di valutazione ex post affidato al
giudice e fondato su una norma, come quella delle causali giustificative del ricorso al contratto a termine e alla somministrazione a
tempo determinato, di contenuto giuridico indeterminato è un
indubbio passo in avanti dal punto di vista della tutela della
certezza del diritto e della deflazione del contenzioso.
Del resto si tratta di una norma di incerta portata garantistica,
perché in molti casi è assolutamente dubbio che il lavoratore sia
più tutelato perché un giudice può sindacare le ragioni per cui
l’utilizzatore ricorre alla somministrazione. La sua sostituzione con
l’individuazione di un tetto — per il contratto a termine almeno —
del 20% dei lavoratori complessivamente impiegati ha probabilmente un’efficienza maggiore sul piano delle tutele del lavoratore
e, in più, non ha gli enormi costi in termini di sacrificio della
certezza del diritto che si è cercato di evidenziare. Certamente si
può discutere sulla quantificazione del tetto, ma senza dubbio
396
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
questa disciplina semplifica l’applicazione della normativa e garantisce la prevedibilità degli esiti delle decisioni imprenditoriali.
Dunque, per rispondere all’interrogativo di Carlo Pisani, spero
che non moriremo così e, tutto sommato, credo ci siano dei margini
di miglioramento, in termini di certezza del diritto, nella tensione
verso una regolamentazione più completa e, soprattutto, verso una
disciplina conformata in modo da non scaricare sulla magistratura
l’ingrato compito della mediazione politica, che non spetta ai
giudici e per la quale non sono, naturalmente, attrezzati.
Per concludere, mi sembra quindi, riassumendo quanto detto,
che la distinzione fra clausole generali e norme elastiche vada
riaffermata, perché le seconde vengono normalmente utilizzate per
disciplinare una fattispecie che esiste e che può essere precisata dal
legislatore in tutti i suoi elementi risolvendo i problemi di cui
stiamo discutendo. Il ricorso a una normazione elastica è frutto di
una decisione eminentemente di politica del diritto (e non solo),
rispetto alla quale esistono alternative. Al contrario, quando siamo
in presenza di buona fede, correttezza e di clausole generali in senso
proprio il legislatore non ha scelta rispetto alla tecnica normativa
da utilizzare e dunque i margini di incertezza applicativa che
derivano naturalmente dal deferimento al giudizio del caso concreto della creazione della regola di diritto sono un male necessario
e inevitabile per consentire il funzionamento del sistema, o, riprendendo la metafora citata all’inizio di questo intervento, la sua
“respirazione”.
397
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
MARIA TERESA CARINCI
Clausole generali e frammentazione dei contratti collettivi
Ho ascoltato con grande interesse le relazioni molto approfondite ed interessanti di Stefano Bellomo, Gianni Loy e Piera Campanella.
Per parte mia vorrei ritornare con qualche interrogativo — più
che con qualche risposta — sul nodo teorico fondamentale che tutti
e tre i relatori hanno affrontato: la distinzione fra clausola generale
e norma generale. Mi sembra che sulla questione le posizioni dei
relatori si siano divaricate: da una parte Stefano Bellomo e Gianni
Loy propendono per una accezione ampia ed allargata dei due
concetti, che sostanzialmente finisce per sovrapporli; dall’altra
invece Piera Campanella con grande nettezza accoglie la lettura
mengoniana secondo la quale, al contrario, i due concetti sono
chiaramente distinti.
Com’è a tutti noto, infatti, secondo la ricostruzione di Luigi
Mengoni (1986), solo le clausole generali sono norme incomplete,
che rinviano a parametri sociali esterni al sistema giuridico per il
completamento del loro precetto; al contrario le norme generali,
pur se riferite ad una classe di casi, contemplano per intero il
precetto che l’interprete deve dunque ricostruire nell’ambito dell’ordinamento.
A me pare che la scelta dei relatori per l’una o l’altra impostazione non sia per nulla neutra. E non lo è a mio parere soprattutto
nella lettura di Stefano Bellomo.
Anticipo subito che concordo con la tesi di Luigi Mengoni.
In particolare mi sembra che la lettura mengoniana aiuti a
chiarire due concetti importanti per il diritto del lavoro e sui quali
ho avuto modo di soffermarmi nei miei studi in tema di licenziamento: il concetto di giustificato motivo oggettivo di tipo economico, da una parte, ed i concetti di giusta causa e giustificato
motivo soggettivo, dall’altra.
398
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
Come ho cercato di illustrare altrove, a mio parere in entrambi
i casi non vengono in rilievo clausole generali, ma norme generali,
cioè concetti i cui elementi sono tutti interni al sistema giuridico.
Le nozioni di giustificato motivo oggettivo, di giusta causa e di
giustificato motivo soggettivo danno infatti positivo rilievo all’interesse del datore di lavoro a disporre di una organizzazione in
vista dello svolgimento di una attività.
In breve danno rilievo all’interesse tipico del contratto di
lavoro e dell’atto di licenziamento e dunque alla loro causa (Carinci
M.T., 2012).
Più in particolare il giustificato motivo oggettivo di tipo economico — declinando in modo più specifico l’interesse a disporre di
una organizzazione — dà rilievo all’interesse a modificare o estinguere una organizzazione esistente (Carinci M.T., 2005). Esso infatti evidenzia come a seguito di una riorganizzazione — e dunque
nel nuovo assetto organizzativo disposto dal datore di lavoro
nell’esercizio della propria libertà d’impresa (art. 41 Cost.) o di
altra libertà costituzionalmente riconosciuta (artt. 18,19, 39, 49
Cost.) — venga meno l’interesse datoriale alla prestazione di quello
specifico lavoratore. In questo contesto il cd. “obbligo di repechage” non solo non configura propriamente un obbligo, ma soprattutto non è elemento esterno, ma interno al concetto di giustificato motivo oggettivo. Il cd. “obbligo di repechage” impone
infatti di riguardare da una particolare prospettiva il collegamento
fra nuova organizzazione predisposta dal datore e mansioni del
lavoratore (il cd. nesso causale negativo) e così saggiare ancora una
volta il venir meno della causa del contratto di lavoro subordinato:
se le mansioni del lavoratore non sono utilizzabili in nessuna delle
articolazioni della nuova organizzazione produttiva predisposta
dal datore di lavoro va evidentemente escluso in radice il persistere
dell’interesse datoriale a ricevere la prestazione di quel lavoratore.
Così ragionando dunque il giustificato motivo oggettivo economico di licenziamento — comprensivo di tutte le sue componenti: riorganizzazione effettiva, nesso causale, cd. obbligo di
repechage — richiama un concetto tutto interno all’ordinamento
giuridico. Se così è esso configura una norma generale e non una
clausola generale. Dunque un concetto che non necessità di essere
completato per il tramite di parametri extragiuridici.
Ugualmente bisogna ragionare, a mio parere, con riferimento
ai concetti di giusta causa e giustificato motivo soggettivo di
399
Copia riservata ai soci AIDLASS© Giuffrè Editore
licenziamento (Carinci M.T., 2012). Anch’essi danno positivo rilievo alla causa del contratto di lavoro e dell’atto di licenziamento
e cioè all’interesse a disporre di una organizzazione, qui declinato
nel più specifico interesse ad assicurare la funzionalità della organizzazione esistente.
Anche in questo caso dunque gli elementi cui l’interprete deve
fare riferimento sono tutti interni all’ordinamento giuridico. Si
tratta in particolare del concetto di inadempimento delineato in
generale dal Codice civile (art. 1218 c.c.) ed al contenuto dei singoli
obblighi che gravano sul lavoratore, individuati da specifiche
norme (per es. obbligo di diligenza art. 2104 c.c.; obbligo di fedeltà
art. 2015 c.c. ecc.).
Questa è la mia opinione.
Diversa invece è la posizione espressa da alcuni dei Relatori, in
particolare di Stefano Bellomo che al contrario allarga la portata
delle clausole generali — così da ricondurvi anche la giusta causa,
il giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, — vincolando però al
contempo l’interprete al rispetto del contratto collettivo inteso
come parametro sociale di riferimento per colmare le lacune ed
indeterminatezze della norma giuridica.
Quale è il senso di questa proposta? Il contratto collettivo può
oggi, nella situazione in cui ci troviamo, costituire effettivamente
parametro sociale generalmente condiviso cui attingere per colmare le lacune della norma giuridica? Può dunque permettere
ancora oggi di utilizzare al meglio le clausole generali come “polmoni del sistema giuridico” e dunque come strumenti volti a
permettere all’ordinamento di progredire?
Come altri ha già osservato prima di me il contratto collettivo
è oggi indebolito dagli effetti della globalizzazione che determina
una concorrenza al ribasso fra ordinamenti e nell’ambito del medesimo ordinamento e sfiancato dalla crisi economica che lo costringe a soluzioni differenziate e frammentarie nel tentativo di
tamponare l’emorragia occupazionale.
Il sistema contrattual-collettivo si sfrangia dunque in una
miriade di contratti, a vari livelli.
In questo panorama diventa difficile pensare ad un contratto
collettivo che possa costituire parametro generale affidabile per
l’interprete e prima di tutt