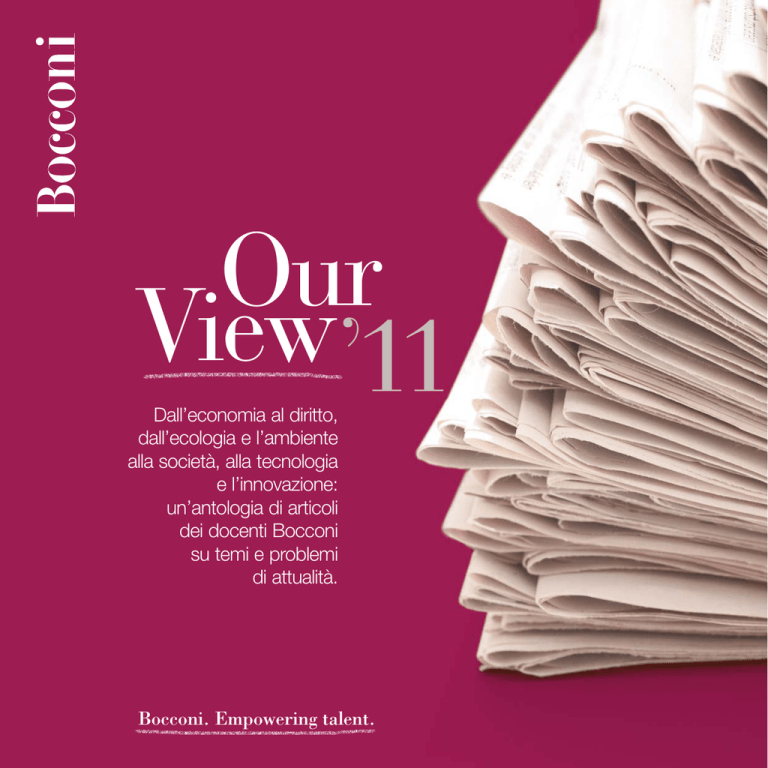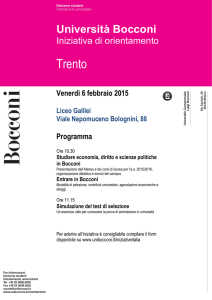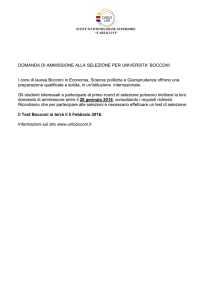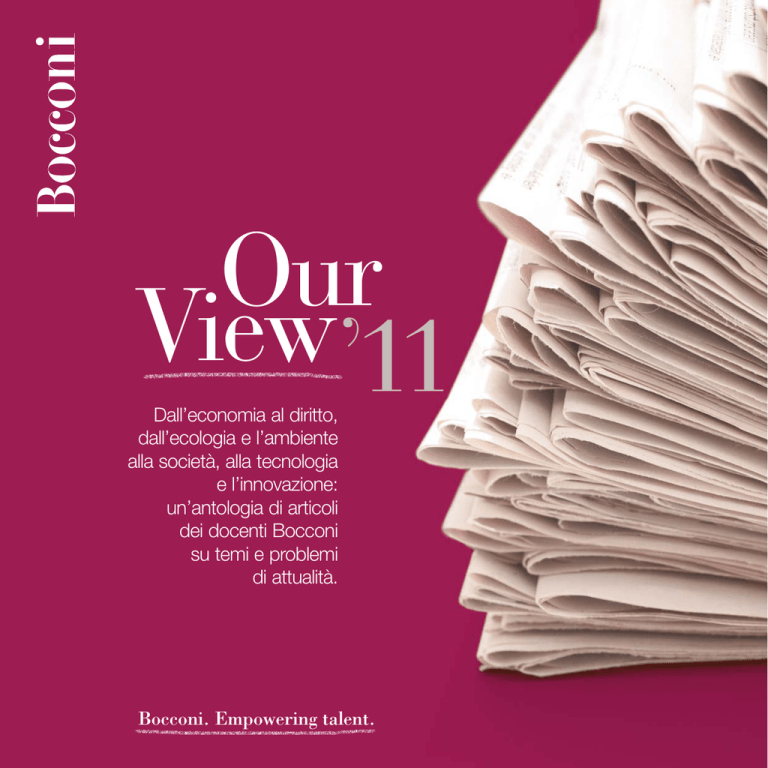
Our
View’11
Dall’economia al diritto,
dall’ecologia e l’ambiente
alla società, alla tecnologia
e l’innovazione:
un’antologia di articoli
dei docenti Bocconi
su temi e problemi
di attualità.
Bocconi. Empowering talent.
Indice*
Economia
Per la lotta alla povertà un bilancio in grigio
di Giorgio Sacerdoti
3
Quando investe lo straniero
di Giorgio Sacerdoti
5
L’immigrato non ruba lavoro
di Gianmarco Ottaviano
7
Il gran direttore
di Franco Bruni
9
La lotta dell’uomo per dominare la natura
di Giorgio Brunetti
11
La storia d’Italia e le multinazionali. Apertura tardiva
di Fabrizio Onida e Giuseppe Berta
13
Un compleanno più sereno
di Carlo Secchi e Carlo Altomonte
15
Il Vietnam dalla povertà all’internazionalizzazione
di Claudio Dordi
17
Primavera araba: aspettiamo di vedere l’estate
di Francesco Passarelli
19
Il Mattarellum non basta
di Tommaso Nannicini
21
________________________________________________________
* Our View è una selezione di articoli precedentemente pubblicati su Bocconi Newsletter, e consultabili online su ViaSarfatti25, il quotidiano
della Bocconi, all’indirizzo www.viasarfatti25.unibocconi.it.
La lunga via di Doc Obama
di Giovanni Fattore
23
Management
Due rebus per comprendere i consumi
di Bruno Busacca
27
Consumption crossover, ed ecco i balli latini
di Luca M.Visconti
29
Metodo più immaginazione
di Arianna Biroschi e Anna Uslenghi
31
Mobbing, quando la malata è l’organizzazione
di Roberto Vaccani e Paola Vaiozzo
33
Le emozioni che possono far risparmiare 300 miliardi
di Isabella Soscia
35
Servono progetti per togliere la muffa dall’azienda
di Alfredo Biffi
37
Venderà di più chi porta il cliente nella stanza dei bottoni
di Emanuela Prandelli e Martin Schreire
39
La corporate social responsibility difende l’impresa dagli attacchi
di Barbara del Bosco e Nicola Misani
41
Le vie dello shopping non hanno mai parlato italiano
di Elisabetta Merlo
43
Project followership, i progetti per tutti gli altri
di Marco Sampietro
45
Il consumatore che non si gode l’esperienza
di Antonella Carù e Bernard Cova
47
Umani che non sbaglino
di Elisabetta Trinchero
49
Cinque regole per trasmettere l’imprenditorialità
di Carlo Salvato
51
La moda vuole essere mobile. Ma non sfonda
di Gabriella Lojacono e Paola Varacca Capello
53
Dove il capo si importa
di Guido Corbetta e Alessandro Minichilli
55
Quanto è cara la buonuscita
di Arnaldo Camuffo
57
Il lusso piace di più se è responsabile
di Erica Corbellini e Elisabetta Marafioti
59
Chi dorme sul web non piglia nuovi clienti
di Francesca Romana Rinaldi
61
Per un multibusiness forte a fine crisi
di Giorgio Invernizzi
63
Risultati negativi, guadagni positivi
di Arnaldo Camuffo
65
Scelte d’acquisto: tra semplicità e olismo
di Andrea Ordanini
67
Sei ampio o focalizzato?
di Stefano Brusoni
69
Società e Cultura
Anche la politica fa le bolle
di Fabrizio Pezzani
73
Molto più che uno specchio
di Luca Massimiliano Visconti
75
I giovani precari diventeranno anziani bisognosi
di Vincenzo Galasso
77
La spirale che assolve i bamboccioni
di Bruno Arpino
79
L’età dell’apprendimento
di Francesco Billari e Michele Pellizzari
81
L’inquinamento costa 10 miliardi e 8.200 morti
di Marco Percoco
83
Energia, Ambiente & Infrastrutture
Chi ci guadagna paga. Ecco la cattura del valore
di Chiara Sumiraschi
87
Co2. Diplomazia e mercato decideranno il futuro
di Stefano Pogutz
89
Tecnologia e Innovazione
Telefonini, un caffè con il check-in
di Stefano Pace
93
La tua identità vale. Perciò cercano di rubartela
di Oreste Pollicino
95
Il navigatore vive in un altro spazio di attenzione
di Luigi Proserpio
97
Il cittadino 2.0 è più soddisfatto e consapevole
di Luca Buccoliero e Elena Bellio
99
Beni virtuali, nuovo modello di business in rete
di Silvia Vianello e Franco Denari
101
Quando duemila computer possono non bastare
di Emanuele Borgonovo
103
Finanza
Dammi tre parole e le banche cambieranno
di Stefano Caselli
107
Le borse hanno paura dei disastri,anche poco probabili
di Nicola Misani
109
Le strade dei soldi
di Giorgio Fiorentini e Giuseppe Ambrosio
111
Chi deve pagare per il consulente
di Paolo Cucurachi
113
Così non si cura la febbre
di Andrea Resti
115
Piccolo è bello a Piazza Affari, vedi le small caps
di Alberto dell’Acqua
117
Pericolo longevità? L’arma in più sono i bond
di Carlo A.Favero
119
Fondi sovrani, sfida globale
di Bernardo Bartolotti
121
Diritto
Che fare in aeroporto se siamo morti
di Arianna Vedaschi
125
La democrazia come risposta
di Piergaetano Marchetti
127
Pensiamo collettivo o perderemo sempre la guerra
di Leonardo Borlini
130
Dove osano le sardine. Purché siano europee
di Giorgio Sacerdoti
132
La Commissione europea dichiara guerra alla corruzione
di Giulio Nessi
134
Economia
0B
Economia
Per la lotta alla povertà un bilancio in grigio
di Giorgio Sacerdoti
Nel 2000 venne lanciata la campagna mondiale per vincere,
entro il 2015, l’estrema povertà. A che punto siamo oggi? Per
Giorgio Sacerdoti, docente Bocconi di Diritto internazionale,
sono stati fatti dei progressi, ma in modo diseguale tra le
nazioni, e non per merito dell’Italia.
A settembre, a New York, il Vertice Onu del Millennium Development Goals si è concluso con una parata di
stelle e di capi di Stato. Ma al di là della retorica, a che punto sta la campagna lanciata nel 2000, proprio
all’alba del nuovo millennio, per eradicare la estrema povertà e le sue più tragiche manifestazioni nel mondo
entro il 2015? Il bilancio non è tutto nero, siamo più sul grigio, ma cinque anni sono veramente pochi per
colmare almeno in parte un gap che è tuttora consistente.
Ricordiamo anzitutto gli otto ambiziosi obbiettivi del 2000, di cui il G-8 in Scozia del 2005 si fece paladino,
auspice Tony Blair. Il primo era l’eliminazione dell’estrema povertà, dimezzando la parte di popolazione
mondiale che vive con meno dell’equivalente di un dollaro e 25 centesimi al giorno, portandola dal 46% al
23% dell’umanità. Siamo oggi al 27%, un dato che appare incoraggiante se non fosse per l’estrema
disuguaglianza di ripartizione tra paese e paese. Il calo è infatti dovuto in massima parte alla Cina (che con
l’India conta il 62% della popolazione del pianeta): qui i molto poveri sono crollati dal 60% al 16%. Nel plotone
di testa anche sei paesi africani tra i più poveri, ma in molti altri la miseria resta altissima. Per altri indicatori i
progressi su scala globale sono buoni in termini numerici ma resta il problema di disaggregare i dati per paese
e i dubbi sotto il profilo qualitativo.
È così per l’obiettivo dell’istruzione elementare universale, con una percentuale di bambini a scuola passata
dall’82% all’89%. La malnutrizione colpisce tuttora il 16% della popolazione mondiale (era il 20% e dovrà calare
al 10%). In molti paesi questa piaga colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni: dal 48% dell’India (un
valore che desta scandalo in una nazione in rapido sviluppo) a percentuali sempre sopra il 40% in Pakistan,
Bangladesh, Etiopia, Congo. Più soddisfacenti i progressi per la mortalità infantile, l’accesso all’acqua
potabile, le cure mediche. Ma restano sfuggenti obiettivi difficilmente misurabili, ma fondamentali per le loro
ricadute ad ampio raggio. Così per la promozione della donna e la lotta al suo sfruttamento: un moltiplicatore
della crescita, essenziale per il benessere della famiglia e della società.
3
Economia
A New York molti paesi, organizzazioni internazionali, imprese ed enti non profit hanno annunciato nuovi
impegni per azioni mirate. In massima parte si tratta di contribuzioni economiche in partnership con organismi
dei paesi beneficiari, ma è positivo che in gran parte essi si indirizzino al sostegno di programmi mirati, per
settore e per paese. Così per il miglioramento agricolo, obiettivo prioritario della Banca Mondiale, per la lotta
alle pestilenze dalla malaria all’aids (Francia, Giappone e Regno Unito) e per l’energia e la sostenibilità
ambientale. Un grave limite è che questi impegni, di carattere volontario, spesso non sono mantenuti.
Gravissimo il caso dell’Italia, in coda ai paesi Ocse (ci salva la Corea dalla maglia nera) con aiuti allo sviluppo
pari ad appena lo 0,16% del pil, contro un obiettivo dello 0,7% ed una media dello 0,4%. La guardia non deve
essere abbassata, la risonanza mediatica è importante. Fondamentale, in un mondo globalizzato, tener
presente che non c’è solo competizione economica tra paesi sviluppati ed emergenti ma diffusa esigenza di
cooperazione e solidarietà. Anzi, come ha detto Obama, “Gli aiuti allo sviluppo non sono solo un imperativo
morale, ma anche un imperativo economico e strategico”. Speriamo che a Roma qualcuno se ne ricordi.
L’Autore
Giorgio Sacerdoti è professore ordinario di Diritto internazionale alla Bocconi, cattedra Jean Monnet di Diritto
Europeo.
Aree di interesse scientifico
Diritto internazionale, comunitario e del commercio internazionale. Investimenti. Arbitrato. Contratti
internazionali.
Da Bocconi Newsletter no. 101/2011
4
Economia
Quando investe lo straniero
di Giorgio Sacerdoti
I fondi stranieri di investimento sono sempre più protagonisti del
panorama finanziario mondiale, in modo spesso anche molto
aggressivo. Una disciplina internazionale stenta però a
decollare, come spiega Giorgio Sacerdoti, docente di Diritto
internazionale alla Bocconi.
I fondi sovrani sono una realtà relativamente recente nel panorama dell’economia mondiale. Questi nuovi
attori nel flusso transnazionale degli investimenti raggruppano realtà finanziarie diversificate per origine, veste
istituzionale, dotazione, politiche di investimento. A livello globale si calcola che dispongano dello stratosferico
importo di 2.400 miliardi di dollari. Denominatore comune è che si tratta di entità che fanno capo alla mano
pubblica, controllati e gestiti da governi o enti pubblici e che i loro capitali sono di proprietà pubblica. Le fonti
di queste ricchezze sono diverse. Inizialmente era quasi solo il ricavato accantonato dalla vendita delle
materie prime spettanti allo stato sui mercati internazionali, soprattutto petrolio e gas. È il caso del fondo della
Norvegia (il più grande), della Libia, dei paesi del Golfo persico.
In questi casi l’investimento delle risorse accumulate nell’economia privata all’estero è motivata dall’esigenza
di diversificarle e preservare un “tesoretto” per quando le risorse naturali si saranno esaurite. Quest’ottica
suggerisce una politica d’investimento prudente, con gestione trasparente, ispirata da considerazioni tipiche
di un investitore privato, alieno dall’assumere posizioni dominanti nelle imprese in cui le partecipazioni
vengono acquisite. Un’ottica privatistica e non motivata da intendimenti politici quindi, anche se gli importi in
gioco e il peso delle quote di capitale sottoscritte rendono a volte difficile misurare in termini privatistici i
relativi investimenti. Il caso degli investimenti libici in Unicredit ne è testimonianza.
Il quadro si è modificato con l’ingresso nel club della Cina e di altri paesi che accumulano risorse dallo
sbilancio tra export e import e che non sono in grado, per ora, di assorbire il surplus con l’espansione della
domanda interna, con investimenti infrastrutturali o accrescendo le importazioni. Qui l’investimento
nell’economia reale non è solo un’alternativa all’accumulo di treasury bills americani. Alle preoccupazioni
sull’impatto degli investimenti nelle imprese si sono aggiunte preoccupazioni sulle motivazioni degli
investimenti; non più tanto la sicurezza dei capitali investiti ma una strategia del paese per acquisire il controllo
di materie prime necessarie all’economia nazionale (es. minerali e legname in Africa) e l’accesso a
5
Economia
tecnologie avanzate. Quando l’investimento si rivolge a settori strategici nel paese destinatario, dai porti Usa
in cui la Port Authority di Dubai voleva entrare, ai paventati investimenti cinesi nel settore energetico della
Germania, non stupiscono reazioni di bloccaggio (Usa) o la proposta di controlli preventivi (Germania).
Simili iniziative richiamano però reazioni non amichevoli da parte dei padroni dei fondi, mentre una disciplina
internazionale stenta a decollare per il contrasto di interessi tra paesi e l’eterogeneità degli attori. Molto
trasparente il fondo norvegese, che non investe in imprese di armamenti o che non rispondono a determinati
criteri etici. Del tutto opache le strategie generali e la gestione dei singoli investimenti da parte di gran parte
degli altri fondi, che appartengono a paesi non democratici. L’unica disciplina internazionale, peraltro non
vincolante, sono i Principi di Santiago promossi dal Fondo monetario nel 2008, che richiedono trasparenza
delle politiche di investimento e che esse siano basate su logiche privatistiche e di mercato. Più facile a dirsi
che a farsi e, soprattutto, difficile da controllare e sanzionare. Nell’attuale contesto economico, in cui capitali
freschi sono necessari a molte grandi imprese per resistere alla crisi, si sviluppa un’obbiettiva concorrenza per
catturare queste nuove risorse. I governi dei paesi sviluppati che si preoccupano dell’indipendenza della loro
economia si trovano quindi a fronteggiare una concorrenza al ribasso sul piano della regolamentazione. Non
possono però ignorare le richieste dei loro settori industriali e finanziari a favorirne l’afflusso. Un nodo che non
troverà facile soluzione, neppure a livello europeo.
L’Autore
Giorgio Sacerdoti è professore ordinario di Diritto internazionale alla Bocconi, cattedra Jean Monnet di Diritto
Europeo.
Aree di interesse scientifico
Diritto internazionale, comunitario e del commercio internazionale. Investimenti. Arbitrato. Contratti
internazionali.
Da Bocconi Newsletter no. 102/2011
6
Economia
L’immigrato non ruba lavoro
di Gianmarco Ottaviano
È vero, come spesso si ritiene, che delocalizzazione e
immigrazione distruggono posti di lavoro? Gianmarco
Ottaviano, docente Bocconi di Economia politica, commenta
un recente studio sui settori manifatturieri negli Stati Uniti, i cui
risultati sono per certi aspetti sorprendenti.
Delocalizzazione e immigrazione sono spesso ritenute responsabili della distruzione di posti di lavoro nei settori
manifatturieri in Italia. Tuttavia, mentre la contrazione di questi settori negli ultimi decenni è innegabile,
valutare la responsabilità della globalizzazione è difficile. Da un lato, la delocalizzazione dei processi produttivi
o l’impiego di immigrati per svolgerli riduce direttamente il numero di posti disponibili per i lavoratori italiani.
Dall’altro, la riduzione di costi associata a queste forme di riorganizzazione promuove la competitività delle
imprese, che a loro volta possono generare nuovi posti di lavoro anche per i lavoratori italiani. L’effetto netto
dipende da svariati fattori, anche istituzionali, tra cui non solo la flessibilità del mercato del lavoro e del
prodotto, ma anche la capacità di reinventare l’organizzazione e la divisione dei compiti all’interno
dell’impresa.
Per meglio capire come gestire efficacemente queste sfide e opportunità sarebbero di straordinaria
importanza analisi empiriche comparate a livello internazionale in grado di evidenziare i punti di forza e di
debolezza dei vari sistemi paese. In attesa di tali analisi, per ora indisponibili, lo stato del dibattito può essere
esemplificato da un recente studio effettuato negli Stati Uniti su 58 settori manifatturieri dal 2000 al 2007
(Ottaviano, Peri, Wright, “Immigration, offshoring and American jobs”, National Bureau of Economic Research,
working paper No. 16439, Cambridge, Mass., 2010).
Lo studio tiene dovuto conto di un fatto noto ma spesso dimenticato, e cioè che, come gli altri paesi
occidentali, anche gli Stati Uniti hanno conosciuto nelle ultime decadi un calo strutturale dell’occupazione
manifatturiera, dovuto alla transizione da un’economia industriale a un’economia di servizi, che quindi poco
ha a che fare con la globalizzazione di per sé. In quest’ottica, la domanda giusta da porsi è se i settori
manifatturieri più esposti a delocalizzazione o immigrazione abbiano perso più o meno posti di lavoro per
americani rispetto agli altri settori.
7
Economia
Secondo lo studio, la delocalizzazione ha ridotto la quota di posti di lavoro per americani e immigrati, mentre
l’immigrazione ha sì intaccato la quota di posti di lavoro delocalizzati, ma senza avere effetti significativi sulla
quota di posti di lavoro per americani. In termini di mansioni svolte, la delocalizzazione ha spinto i lavoratori
americani verso mansioni in media più complesse e meno routinarie e gli immigrati verso mansioni meno
complesse e più routinarie. Al contrario, l’immigrazione non sembra aver avuto effetti rilevanti sul tipo di
mansioni svolte dai lavoratori americani. Guardando, tuttavia, ai livelli di occupazione, invece che alle quote,
la delocalizzazione non ha avuto alcun effetto rilevante sul numero di posti di lavoro per americani mentre
l’immigrazione sembra aver avuto su di essi un piccolo impatto positivo. Questo testimonia l’effettiva esistenza
di un effetto positivo della delocalizzazione e dell’immigrazione sulla competitività delle imprese, manifestatosi
in un’espansione relativa dell’occupazione di lavoratori americani nei settori più esposti a tali fenomeni.
Nel loro insieme questi risultati indicano che, specializzandosi nelle mansioni meno complesse, gli immigrati
hanno ridotto la gamma di mansioni delocalizzate senza influenzare granché il livello di occupazione e il tipo
di mansioni dei lavoratori americani. I lavoratori all’estero, invece, hanno sottratto mansioni di complessità
intermedia ai lavoratori americani, spingendoli verso mansioni più complesse e meno routinarie.
Ciononostante, l’effetto positivo della delocalizzazione sulla competitività e la capacità di espansione delle
imprese ha più che indirettamente neutralizzato qualunque effetto negativo sul livello complessivo di
occupazione dei lavoratori americani.
Questo è quanto è successo negli Stati Uniti dal 2000 al 2007. Se sia accaduto o possa accadere anche in
economie meno flessibili (dentro l’impresa e fuori da essa) come quelle dell’Italia e di altri paesi dell’Europa
continentale, è ad oggi una questione aperta.
L’Autore
Gianmarco Ottaviano è professore ordinario di Economia politica alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Commercio internazionale. Integrazione economica (Asia, Europa, America Latina). Immigrazione,
Innovazione e crescita. Movimenti dei capitali e multinazionali. Squilibri regionali. Urbanizzazione.
Da Bocconi Newsletter no. 103/2011
8
Economia
Il gran direttore
di Franco Bruni
La scomparsa di Tommaso Padoa-Schioppa come metafora
della crisi dei contesti economici e politici ai quali il
bocconiano dedicò tutta la vita. Per Franco Bruni, docente
Bocconi di Teoria e politica monetaria internazionale, forse
oggi l’economista avrebbe lavorato a una nuova Bretton
Woods.
La scomparsa di Tommaso Padoa-Schioppa non è stata solo un grande dispiacere. È anche parsa balenare
come un simbolo della crisi dei contesti economici e politici ai quali egli ha dedicato la sua generosa
intelligenza. Fra l’altro, le gravi difficoltà dell’eurozona e del sistema monetario internazionale.
Il suo contributo alla costruzione dell’euro è stato di grande rilievo. In una conferenza del 1987 (The European
Monetary System: a long-term view, 17 ottobre, Perugia) aveva presentato la moneta unica come la soluzione
più naturale del problema del “quartetto inconciliabile”, ossia dell’insieme di mercato unico, cambi stabili,
libertà di movimento internazionale dei capitali e autonomia delle politiche monetarie nazionali. L’euro
eliminava alla radice l’ultimo elemento del quartetto inconciliabile. Entro il ’92 l’Europa si era proposta un salto
di qualità nel “mercato unico”, nell’integrazione commerciale e finanziaria. Se le politiche monetarie fossero
rimaste diverse, con diversi tassi d’interesse, la libera circolazione di capitali li avrebbe spostati verso i tassi più
alti, verso le monete create in modo meno accomodante o che erano previste rivalutarsi, alimentando la
speculazione e rendendo impossibile un ordine duraturo dei cambi. Ne avrebbe sofferto lo stesso mercato
unico dei beni e dei servizi. Nel ’92 l’Europa ebbe il Trattato di Maastricht, che fissò la meta e la data della
moneta unica. Subito dopo vi fu una grave crisi valutaria che mostrò ancor più chiaramente che, senza il
presidio di una sola banca centrale, la mobilità dei capitali porta all’instabilità dei cambi con inutili disordini
speculativi.
Nella conferenza dell’87 Padoa-Schioppa affiancava agli elementi del quartetto la disciplina coordinata dei
deficit e dei debiti pubblici, necessario supporto della disciplina monetaria comune. Essa fu introdotta nel
Trattato e ribadita dal Patto di stabilità e crescita. Ma si rivelò debole e il suo mancato funzionamento è una
causa della crisi dell’eurozona, che colpisce i paesi con i governi più indebitati. Un “quintetto” stonato. Ma
l’orchestra da far suonare è ancor più numerosa. Padoa-Schioppa fu tra i più impegnati con il sesto
strumento: regole e vigilanze finanziarie comuni, senza le quali l’integrazione finanziaria, resa più intensa dalla
9
Economia
moneta unica, favorisce l’opportunismo di chi cerca il regolatore più permissivo, assume rischi eccessivi, causa
instabilità finanziaria. La segmentazione della vigilanza finanziaria europea lungo i confini nazionali è un’altra
radice della crisi dell’eurozona. Come ministro dell’Economia Padoa-Schioppa richiamò il Consiglio europeo a
un’attenzione più tempestiva per questo tema. Siamo arrivati in ritardo ma siamo in cammino.
Proprio all’inizio di quest’anno sono state istituite le autorità europee di vigilanza. All’orchestra che vuole
ottenere stabilità monetaria e finanziaria nell’area dell’euro la crisi ha aggiunto un elemento di necessaria
solidarietà economico-finanziaria fra i paesi membri. Padoa-Schioppa si è adoperato nell’ideazione tecnica
di tale solidarietà e per aiutare il governo greco nello straordinario sforzo di aggiustamento intrapreso.
Stanno dunque riunendosi tutti gli strumenti perché l’orchestra suoni bene. La salute dell’area dell’euro tornerà
migliore di come l’ha lasciata la preoccupazione di Tommaso. Il quale però, in una conferenza dell’anno
scorso (The Ghost of Bancor, Louvain-la-Neuve, 25 febbraio 2010), ha ricordato come la moneta europea non
sia da sola al mondo. Per il suo successo è “vitale”, ha detto, inserirla in un ordinato sistema monetario
globale. Un’impresa difficilissima che deve mutare il ruolo del dollaro. Ultimamente era molto attento alle
riflessioni della Cina sull’ordine monetario internazionale. Il network di colleghi e amici con i quali discuteva in
tutto il mondo, lo avrebbe forse visto, nei prossimi anni, impegnato a pensare una “nuova Bretton Woods”. A
questa costruzione globale, era convinto, l’Europa era in grado di offrire il grande “repertorio di esperienze”
accumulato nella ricerca del suo ordine monetario interno.
L’Autore
Franco Bruni è professore ordinario di Teoria e politica monetaria internazionale alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Central Banking and Monetary Policy. Banking and Financial Regulation. The International Monetary and
Financial System. European Economic and Financial Integration.
Da Bocconi Newsletter no. 104/2011
10
Economia
La lotta dell’uomo per dominare la natura
di Giorgio Brunetti
Israele: dove la scarsità dell’acqua si vince grazie a tecnologie
avanzatissime. Giorgio Brunetti, docente presso il Dipartimento
di Analisi istituzionale e management pubblico della Bocconi,
spiega come la mano dell’uomo abbia reso fertile un
ambiente in cui la natura è inospitale.
Sbarcando al porto di Eliat, in terra di Israele, non si può far a meno di volgere lo sguardo a Oriente.
All’orizzonte, ai piedi di una montagna, si estende Aqaba, la città giordana che dà il nome al golfo che dal
Mar Rosso penetra tra il Sinai e l’Arabia nella terra promessa, da tempo area di guerre, di tensioni tra popoli e
nazioni. Sembra di entrare in una grande città se non ci fosse il confine che le separa. Sull’area portuale una
distesa di auto giapponesi e coreane. Sono là in attesa di essere trasferite in Europa. Tra Eliat e Ashdod, altro
porto israeliano ma sul Mediterraneo, vi è un ponte terrestre di 300 chilometri, utilizzato quando il canale di
Suez era chiuso al traffico marittimo israeliano, ma sempre utile per non essere schiavi dei voleri e dei poteri
altrui.
Da Eliat, come da Aqaba, partono due strade parallele, la prima verso Gerusalemme e l’altra per Amman.
Entrambe costeggiano il Mar Morto. Per gli israeliani è il quarto mare, dopo il Mar Rosso, il Mediterraneo e il
Mar di Galilea, così chiamato nel Nuovo Testamento, che in realtà è il lago di Tiberiade. Prima di arrivare al
Mar Morto lungo la strada israeliana, a differenza di quella giordana, si incontra l’antico e il moderno, la
natura ricevuta come tale da secoli e quella modificata dall’opera dell’uomo.
Dopo le saline vicine al mare ecco il deserto del Negev, un tenue giallino punteggiato da rari arbusti a
ombrello. Tante testimonianze archeologiche a cominciare dalle antiche miniere di rame di Re Salomone. Tra
le montagne “nude” anche serre che sembrano bastimenti alla fonda. Sono gli avamposti della lotta contro
la scarsità di acqua. L’agricoltura in Israele è il risultato della felice sintesi tra scienziati, agricoltori e industrie
dei prodotti agricoli. Una tecnologia molto avanzata per consentire un’agricoltura di alto livello in un paese
per metà desertico.
Più oltre si scende gradualmente fino a raggiungere il Mar Morto che si trova a oltre 400 metri sotto il livello del
mare. Un mare che sta morendo per lo scompenso tra il limitato afflusso del Giordano e la forte evaporazione
11
Economia
tanto che si sta progettando, contro il parere degli ambientalisti, un canale artificiale che convogli l’acqua
dal Golfo di Aqaba.
La ricchezza in questa zona sono i sali e i minerali – cloruro di magnesio e potassio – ma anche le alghe termominerali che trattengono calore e i fanghi originati da depositi millenari. Si consideri poi l’assenza di
inquinamento e l’evaporazione continua, che crea un’invisibile nube di protezione dalle radiazioni. Un
microclima quindi che attrae turisti, così come le cure estetiche. Dieci minuti di galleggiamento sono sufficienti
per ottenere un effetto sulla pelle di 48 ore. Sali e fanghi del Mar Morto hanno proprietà curative
scientificamente riconosciute. Hanno effetti positivi sulle malattie della pelle e sono indicati per lenire dolori
muscolari e articolari. Alberghi e centri termali si sono affiancati alle saline ed è fiorita un’industria cosmetica e
farmaceutica a base di prodotti naturali. Sono una cinquantina le aziende che utilizzano prodotti del Mar
Morto in gran parte esportatrici. Imprese che scommettono sull’innovazione, nonché sulle risorse locali.
Andando verso nord si arriva a Masada e alla fortezza di Erode il Grande, inerpicata in cima al “sentiero del
serpente”, simbolo della resistenza ebraica alla conquista romana. Da queste parti si dice che sorgesse la
perversa Sodoma, si scorge anche una roccia, chiamata la moglie di Lot, la sventurata che, presa dalla
curiosità, si gira durante la fuga a osservare l’incendio della città, viene colpita dall’ira divina e trasformata in
una colonna di sale. Dalla cima della Fortezza si gode una vista indimenticabile. Un tetto del mondo dove si
incrociano e si confondono i colori diversi del mare, del deserto e dei monti lontani.
L’Autore
Giorgio Brunetti è professore emerito di Strategia e politica aziendale in Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Economia delle piccole e medie imprese. Governance aziendale e controlli aziendali. Politiche di facilitazione
per le piccole e medie imprese. Applicazione delle tecnologie di rete nei distretti.
Da Bocconi Newsletter no. 104/2011
12
Economia
La storia d’Italia e le multinazionali. Apertura tardiva
di Fabrizio Onida e Giuseppe Berta
Un’Italia veramente multinazionale, e non solo fortemente
esportatrice, fino ad ora ha tardato a emergere. I docenti
Bocconi Fabrizio Onida (Dipartimento di Economia) e
Giuseppe Berta (Storia contemporanea) spiegano perché
adesso ci troviamo a inseguire l’Europa.
L’Italia multinazionale non è nata ieri, affonda le sue radici nei primi 40 anni dello scorso secolo con nomi
come Fiat, Pirelli, Snia Viscosa, Montecatini, Olivetti, Cirio, Martini&Rossi. E se prima della Prima Guerra
mondiale gli investimenti diretti esteri (ide) italiani erano presenti soprattutto in America Latina (Argentina in
particolare), nel periodo fra le due guerre si sono rivolti prevalentemente in Francia, Germania e Usa. Il
secondo dopoguerra col miracolo economico ha visto prima il boom delle esportazioni e, dalla metà degli
anni ’80, l’accelerarsi degli ide, anche da parte di imprese di media dimensione. Il rapporto fra stock (flussi
cumulati al netto dei disinvestimenti) di Ide e Pil è cresciuto da poco più del 5% nel 1990 al 28% del 2009. Ma
non va trascurato il fatto che nello stesso anno questo indice toccava il 41% in Germania, 44% in Spagna, 65%
in Francia, 76% in Uk: l’Italia inseguiva in ritardo un obiettivo di crescita internazionale comune a tutti i paesi
avanzati.
Vi sono almeno cinque ragioni di questo ritardo nell’emergere di una Italia multinazionale e non solo
fortemente esportatrice: a) una quota alta di micro e piccole imprese, poco capaci di sopportare i costi di
entrata sui mercati esteri come investitori; b) una struttura dei vantaggi comparati dominata da settori
tradizionali di consumo e della meccanica specializzata, le cui imprese sono per loro natura meno “costrette”
a diventare multinazionali rispetto a quelle che operano nei settori a elevata intensità di scala e ad alta
tecnologia come chimica, elettronica, autoveicoli; c) proprio nei settori di scala e a maggiore dinamismo
tecnologico, un peso elevato (fino alle privatizzazioni degli anni ’90) di imprese a partecipazione statale che
(con l’eccezione di Eni-Agip) erano rivolte a investire in Italia, nel Mezzogiorno in particolare; d) un contesto
macroeconomico degli anni ’70 e ’80 poco favorevole agli Ide (inflazione, lira debole e volatile, restrizioni ai
movimenti internazionali di capitali, scarsità di credito a medio-lungo termine); e) il noto dualismo nello
sviluppo, per cui imprese del Nord hanno trovato per anni manodopera abbondante, affidabile e a basso
costo nel Mezzogiorno, con forti agevolazioni finanziarie statali.
13
Economia
L’ultima ricognizione del rapporto annuale “Italia multinazionale”, basato sulla banca dati Reprint (IcePolitecnico di Milano) registra all’inizio del 2009 ben 6.426 imprese italiane investitrici, con 18.692 affiliate
all’estero sotto pieno controllo, di cui più di metà (9.605) di natura commerciale-distributiva, oltre 4.000 legate
ad attività estrattive-energia-costruzioni e solo 5.052 unità manifatturiere, che però pesano per circa il 70%
degli addetti all’estero (più di un milione nelle sole affiliate sotto pieno controllo). Negli ultimi 20 anni sono
scomparsi o sono stati assorbiti una decina di gruppi medio-grandi come Stet-Italtel, IRI-Ilva, Bonomi-Saffa, CIRValeo, Cragnotti Partners: circa un terzo dei 27 gruppi multinazionali con almeno 500 addetti censiti da Reprint
alla fine del 1991.
Nella storia dei pochi grandi gruppi multinazionali, tra cui gli unici sopravvissuti di antica data (Fiat, Pirelli),
colpiscono i tentativi falliti di fusioni-alleanze, a causa di errori strategici e di interferenze della politica. Si pensi
a Fiat con Citroen (1970-73), Ford (1984-85), GM (2000-05) così come a Pirelli con Michelin (anni ’60) o Olivetti
con Underwood (1960-68) e AT&T (1984-89).
Il testimone dell’Italia multinazionale è passato ormai a numerosi esponenti del “quarto capitalismo”: imprese
familiar-manageriali che puntano a eccellere nella loro nicchia di specializzazione, con intensa attività
innovativa, diversificazione di prodotti e servizi, basso indebitamento rispetto al capitale proprio. Si va da
grandi gruppi (Ferrero, Luxottica, Riva, Italcementi) a gruppi con fatturato anche inferiore a 2 miliardi di euro,
come Mapei e Mossi&Ghisolfi (chimica delle specialità), Brembo-Coesia-IMA-Carraro (meccanica), RecordatiZambon-Bracco-Dompé (farmaceutica) o Zegna-Benetton-Miroglio (abbigliamento).
Gli Autori
Fabrizio Onida è professore a contratto senior del Dipartimento di Economia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Economia internazionale. Commercio internazionale. Integrazione economica. Imprese multinazionali. Aiuto
pubblico allo sviluppo. Macroeconomia aperta. Sviluppo economico. Innovazioni tecnologiche e
competitività
Giuseppe Berta è professore associato di Storia contemporanea alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Storia dell'industria. Storia delle élite economiche e delle rappresentanze degli interessi. Business and politics.
Da Bocconi Newsletter no. 107/2011
14
Economia
Un compleanno più sereno
di Carlo Secchi e Carlo Altomonte
Il 9 maggio 2011 l’Unione Europea ha festeggiato i 61 anni.
Carlo Secchi e Carlo Altomonte, docenti di Politica economica
europea alla Bocconi, ricordano il compleanno più
drammatico, quello del 2010, quando si evitò il default della
Grecia e, forse, si salvò anche la moneta unica.
In maggio del 2010 l’Unione Europea festeggiava 60 anni. Tanto era passato dal 9 maggio 1950, data dello
storico discorso con cui il ministro degli esteri francese Schuman, su ispirazione di Jean Monnet, apriva alla
collaborazione istituzionale tra Francia e Germania per formare la Comunità europea del carbone e
dell’acciaio, nucleo fondante di quello che sarebbe poi diventata, nel 1957, la Cee e poi l’Ue.
Tornando indietro al 9 maggio 2010, si trattò di un compleanno a suo modo memorabile: dopo mesi di
incertezza istituzionale, la Grecia era a rischio di default sul suo debito pubblico, e le tensioni avevano
rapidamente coinvolto il mercato interbancario europeo, che il venerdì 7 maggio rivedeva i fantasmi di
Lehman Brothers. Le voci di un drammatico rischio di rottura dell’unione economica e monetaria iniziavano
ad avere un qualche fondamento. Messi con le spalle al muro, i leader europei riuscirono tuttavia quella
domenica sera a tirare fuori una soluzione in extremis: un fondo bilaterale di salvataggio per la Grecia di 110
miliardi di euro; un fondo di stabilità aggiuntivo (lo European financial stability facility, Efsf) capace di
mobilitare in caso di rischio di default risorse sino a 440 miliardi di euro di prestiti ad altri stati dell’eurozona (a
fronte di circa 700 miliardi di garanzie); il coinvolgimento della Bce nell’acquisto sul mercato secondario di
titoli del debito pubblico degli stati in difficoltà, per stabilizzarne il prezzo. Quel giorno, secondo molti, si salvò la
moneta unica, gettando il primo seme di un federalismo fiscale europeo. Tuttavia, la soluzione trovata era
evidentemente provvisoria (fino al 2012) e con molti punti dubbi o incompleti.
Che ne è dunque oggi di quell’accordo, e quale lo stato di salute dell’Unione al suo sessantunesimo
compleanno? Il 24 e 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha finalmente approvato le linee guida della nuova
governance economica. Da un punto di vista strutturale, l’accordo prevede l’implementazione di sei
proposte legislative. In particolare, quattro mirano a riformare il Patto di crescita e stabilità per migliorare la
disciplina fiscale degli stati, prevedendo esplicitamente una riduzione quantitativa anche dell’indebitamento
pubblico (che si aggiunge quindi al deficit). A tal fine vengono introdotte ulteriori sanzioni e la loro
15
Economia
applicazione è resa più stringente. Il pacchetto legislativo contiene anche un nuovo meccanismo di controllo
degli squilibri macroeconomici, con indicazioni precise sul monitoraggio di variabili chiave per la recente crisi
quali i deficit commerciali o i prezzi degli immobili, insieme a un meccanismo di ‘early warning’ e di sanzioni
simile a quello dell’attuale Patto. Circa la gestione dell’attuale fase di instabilità del debito pubblico, il
Consiglio europeo ha deciso un’eccezione, rispetto al principio che vieta in linea generale l’aiuto finanziario
tra Stati, per introdurre un European stability mechanism (Esm) che dal 2013 rimpiazzerà l’Efsf. In particolare
l’Esm sarà dotato di un capitale di 700 miliardi di euro in grado di concedere sino a 500 miliardi di prestiti ai
paesi dell’Eurozona in difficoltà, in cambio di una stretta condizionalità sulla riforma delle finanze pubbliche
dello stato interessato. L’Esm in casi straordinari potrà anche intervenire nei mercati per comprare titoli di
debito, dunque in linea teorica rilevando di quest’onere la Bce. Non si tratta però di aiuti a fondo perduto: i
tassi di interesse da applicare saranno al di sopra dei costi di finanziamento, conseguendo così un ‘mark-up’
legato alla rischiosità dell’operazione per gli stati (tra cui ovviamente l’Italia) che contribuiranno all’Esm. Gli
stessi investitori privati saranno inoltre chiamati a condividere il rischio di queste operazioni, onde evitare
fenomeni di azzardo morale.
Questi elementi costituiscono una profonda riforma di tutta la governance non-monetaria dell’Ue,
allineandola, 20 anni dopo Maastricht, alle mutate caratteristiche della finanza globale. I prossimi mesi
consentiranno di capire i dettagli legislativi della riforma e le reazioni dei mercati, ma possiamo già affermare
che per l’Unione si prospetta un compleanno meno movimentato, ma certamente più sereno.
Gli Autori
Carlo Secchi è professore ordinario di Politica economica europea alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Teoria del commercio internazionale e dell’integrazione economica. Evoluzione del commercio mondiale e
dei rapporti finanziari internazionali. Problemi e politiche dell’Ue. Economia dei paesi in via di sviluppo con
particolare riferimento all’America latina.
Carlo Altomonte è professore associato di Politica economica europea alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Politica economica europea. Economia industriale e commercio internazionale. Analisi delle imprese
multinazionali. Geografia economica.
Da Bocconi Newsletter no. 108/2011
16
Economia
Il Vietnam dalla povertà all’internazionalizzazione
di Claudio Dordi
Solo 15 anni fa, il Vietnam era una delle nazioni più povere del
pianeta. Claudio Dordi, docente Bocconi di Diritto
internazionale, racconta la trasformazione di un paese che
esporta oggi quasi il 70% del Pil, e in cui il reddito pro capite
supera ora per la prima volta i 1.000 dollari l’anno.
Vi è una nazione che 15 anni fa era fra le più povere del pianeta: il Vietnam. Isolato politicamente anche
dopo la fine del bipolarismo, era ancora dotato di un sistema normativo socialista, poco favorevole allo
sviluppo dell’economia di mercato e poco appetibile per gli investimenti stranieri. A quasi dieci anni
dall’abbandono del collettivismo che aveva condotto la popolazione sotto il livello di povertà, il paese era
ancora sprovvisto di qualsiasi legislazione di base utile a promuovere le iniziative imprenditoriali e il commercio
internazionale. Nel 1995, a vent’anni dalla conclusione della guerra, il paese ha riallacciato i rapporti
diplomatici con l’(ormai) ex nemico e ha timidamente cominciato una serie di riforme del sistema giuridico e
dell’ordinamento economico. Le riforme hanno affiancato la progressiva apertura nei confronti del
commercio e degli investimenti esteri, stimolati e guidati anche dalla partecipazione ad accordi internazionali
commerciali, prima regionali (l’Associazione dei paesi del sud est Asiatico – Asean), poi multilaterali. Tuttavia,
ancora nel 2000, nonostante le riforme, il paese ristagnava nelle ultime posizioni mondiali in materia di qualità
della vita e reddito pro capite. Così, dal 2001, il Partito che è ancora, almeno nel nome, un vero partito
comunista, ha rivoluzionato il diritto economico introducendo una nuova disciplina commerciale e sugli
investimenti, il codice di diritto dell’impresa e il diritto doganale, un moderno sistema di tassazione, la tutela
della proprietà intellettuale, un nuovo codice civile e di procedura civile, una legislazione moderna in materia
di tecnologie dell’informazione, di regole delle istituzioni finanziarie, norme moderne sulla concorrenza,
protezione del consumatore, regime dei beni immobiliari, ordini professionali e nuove discipline in tutti gli altri
settori rilevanti.
I risultati non sono mancati: Il Vietnam ora esporta quasi il 70% del Pil e, per la prima volta, i suoi cittadini hanno
un reddito pro capite superiore ai mille dollari l’anno. Nell’anno della crisi economica internazionale il Pil è
cresciuto di oltre il 5%. La politica commerciale estera stupisce non poco: con l’adesione all’Organizzazione
mondiale del commercio, nel 2007, il paese ha definitivamente aperto il proprio mercato alle merci straniere (i
dazi medi all’importazione sono circa al 9%), tanto che nel 2009 ha registrato un importante deficit
17
Economia
commerciale (12 miliardi di dollari). Tutte le principali banche europee sono presenti (anche Unicredit e
IntesaSanPaolo), e i grandi investitori dell’elettronica e della meccanica sono ormai installati nel paese,
sfruttando il basso costo del lavoro e la disponibilità di manodopera. Tuttavia, è l’instancabile marcia
all’apertura del mercato all’esterno che sorprende. Con l’adesione all’Afta, la zona di libero scambio
dell’Asean (10 paesi e oltre mezzo miliardo di persone), e poi, sempre nell’ambito dell’Asean, con la
conclusione di accordi di libero scambio con i principali paesi vicini (Cina, Giappone, Corea, India, Australia e
Nuova Zelanda) il paese è divenuto parte di un mercato di oltre tre miliardi e mezzo di persone in cui le merci
circolano quasi esenti da dazi. È vero, in apparenza l’abito non è di prima qualità: il Vietnam è un paese
lontano, ancora guidato da un partito comunista, non è ancora dotato di adeguate infrastrutture e
tecnologia e lo scarsissimo afflusso d’investimenti italiani (l’Italia è oltre la trentesima posizione quanto a
provenienza degli investimenti) testimonia il tenue interesse dei nostri imprenditori. Tuttavia, chi ha investito nel
paese ha riscontrato la presenza di un monaco devoto: Ariston e Piaggio insegnano.
L’Autore
Claudio Dordi è professore associato di Diritto internazionale alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Diritto internazionale dell’economia (commercio internazionale e rapporti monetari internazionali). Diritto delle
comunità europee. Diritto internazionale pubblico. Diritto delle organizzazioni internazionali.
Da Bocconi Newsletter no. 109/2011
18
Economia
Primavera araba: vediamo l’estate
di Francesco Passarelli
Dell’ondata di rivolte che hanno coinvolto i paesi arabi di
Medio Oriente e sud del Mediterraneo si può dire che nulla
sarà più come prima, ma parlare di democratizzazione è
prematuro, spiega Francesco Passarelli, docente Bocconi di
Scenari economici internazionali.
Ha già un nome, primavera araba, l’enorme ondata di proteste che sta attraversando i paesi arabi del medio
oriente e della sponda sud del Mediterraneo. A partire dallo scorso dicembre le proteste hanno già
provocato vere e proprie rivoluzioni, come nel caso di Tunisia ed Egitto, rivolte, in Yemen, Siria e Barhain e
guerre civili, come in Libia. Quello che ha accomunato queste proteste in un evento senza precedenti è
l’impressionante effetto-contagio che è stato generato e il ruolo determinante dei social network come
fattore di coordinamento. Nonostante la violenta risposta delle autorità, le proteste hanno portato in alcuni
casi al rapido rovesciamento dei governi, e negli altri casi a una forte pressione nei confronti dei leader in
carica. Quello che stanno segnando queste rivolte è un momento storico di rottura strutturale con il passato.
Le ragioni sono da ricercare nel crescente grado di insoddisfazione delle popolazioni di fronte al declino
economico, alla povertà diffusa, alla disuguaglianza distributiva e alla sistematica negazione delle libertà
fondamentali. L’insoddisfazione non è tuttavia un dato assoluto, ma dipende dalla capacità di immaginare
un mondo alternativo; una sorta di punto di riferimento rispetto al quale valutare la situazione corrente.
Probabilmente internet ha offerto a giovani con elevati livelli di istruzione una finestra aperta sul mondo che
ha mostrato quanto misera fosse la loro condizione. La protesta ha componenti psicologiche molto
importanti. Il distacco dal passato è probabilmente più facile per i giovani e l’indignazione e il risentimento si
rafforzano all’interno di un processo collettivo.
I paesi occidentali hanno salutato con favore le proteste, offrendo appoggio politico, finanziario e in alcuni
casi anche militare alla popolazione civile e ai ribelli. L’obiettivo è giungere il prima possibile a una
stabilizzazione politica, garantendosi fin da subito il dialogo con i nuovi governi. I singoli paesi europei hanno
forti interessi economici e sono interessati alla stabilità delle relazioni commerciali. La politica estera
dell’Unione è stata tuttavia timida rispetto alle azioni intraprese singolarmente dai partner europei.
19
Economia
Le prospettive economiche sono sicuramente positive. Si tratta di un’area fortemente integrata al suo interno.
I fondamentali dei paesi in molti casi sono buoni e in crescita. C’è da augurarsi tuttavia che il loro grado di
integrazione nella comunità economica internazionale aumenti progressivamente per il futuro.
Molti hanno parlato di processo di democratizzazione, facendo riferimento al fatto che in tutti i casi l’obiettivo
delle rivolte sono stati governi autoritari, caratterizzati da livelli di corruzione interna molto alti e dalla
negazione di diritti e libertà fondamentali. Forse è prematuro prevedere per questi paesi una svolta irreversibile
verso sistemi politici e sociali di tipo democratico. Quello di cui invece si può già parlare è l’emergere di una
dinamica sociale fra interessi contrapposti di tipo culturale, politico e religioso. Il futuro di questi paesi non
somiglierà mai più al loro passato. L’intera società sarà interessata da un profondo processo di rinnovamento.
I nuovi governi dovranno tenere conto degli interessi delle minoranze, dovranno procedere a una
redistribuzione più equa delle risorse, dovranno confrontarsi con una nuova classe sociale intermedia dotata
di capacità di critica ed in grado di esercitare una forte pressione politica.
L’Autore
Francesco Passarelli è docente di Scenari economici internazionali alla Bocconi e professore associato
all'Università di Teramo.
Da Bocconi Newsletter no. 114/2011
20
Economia
Il Mattarellum non basta
di Vincenzo Galasso e Tommaso Nannicini
Riforma della legge elettorale: per Vincenzo Galasso, direttore
del Centro Dondena Bocconi, e Tommaso Nannicini, docente
del Dipartimento di Economia Bocconi, un ritorno al
maggioritario sarebbe nell’interesse dei cittadini solo se fatto
insieme a un ridisegno dei collegi.
Scandali, corruzione, indecisioni e ritardi nel rispondere alla crisi, ma precisione e caparbietà nel difendere i
privilegi della casta hanno ridotto la fiducia degli italiani nella classe politica. Il clima sembra quello degli anni
Novanta, con la crisi finanziaria del 1992 e Tangentopoli. E come allora si torna a parlare di riforma della legge
elettorale. Per superare i limiti dell’attuale legge proporzionale con liste bloccate, il Porcellum, un gruppo di
politici e intellettuali sta promuovendo un referendum per ritornare al sistema misto (75% maggioritario, 25%
proporzionale) in vigore nelle elezioni del 1994, 1996 e 2001: il Mattarellum, secondo l’espressione coniata da
Giovanni Sartori. Per i promotori, i vantaggi sarebbero due: difendere il bipolarismo, grazie a una legge
prevalentemente maggioritaria, e migliorare la selezione dei politici, restituendo agli elettori la scelta del
candidato nel proprio collegio uninominale.
Migliorare la selezione dei politici è necessario, ma tornare al Mattarellum potrebbe non essere sufficiente.
Con il sistema maggioritario le segreterie dei partiti potrebbero ‘nominare’ un parlamentare con la stessa
facilità dell’attuale sistema di liste bloccate: basta servirsi dei collegi (uninominali) sicuri. Nel maggioritario, il
potere di scelta dei cittadini dipende dalla contestabilità dei collegi uninominali. Anche nei paesi con una
lunga tradizione di elezioni maggioritarie (Usa e Uk), i politici di schieramenti opposti trovano facilmente un
accordo collusivo sul ridisegno dei collegi (il cosiddetto redistricting) in modo tale che ogni partito (e
parlamentare uscente) renda il proprio collegio di appartenenza elettoralmente sicuro. è prevedibile che in
Italia ciò diventi la norma.
Per superare queste distorsioni, la California ha proposto di affidare il redistricting a una commissione
indipendente che ridisegni i collegi su basi demografiche e socio-economiche, astraendo da considerazioni
politiche. La nostra proposta va oltre. Bene usare considerazioni politiche nel disegnare i collegi, ma per il
bene dei cittadini, non dei politici! Il ritorno al maggioritario deve essere accompagnato da una scelta dei
collegi operata in maniera indipendente e in modo da rendere incerto l’esito elettorale in ogni collegio.
21
Economia
Sulla falsariga della commissione presieduta dal presidente dell’Istat incaricata di adeguare le remunerazioni
dei nostri politici a standard europei, bisognerebbe nominare una commissione indipendente che disegni
nuovi collegi uninominali per aumentare la competizione elettorale. Ridotto il numero dei collegi, per ridurre
così anche il numero di parlamentari, la commissione utilizzerebbe le serie storiche dei risultati elettorali per
rendere i collegi il più possibile omogenei e contestabili, per esempio bilanciando gli zoccoli duri di elettori di
centrodestra e centrosinistra in ogni collegio.
Solo così il ritorno al maggioritario sarebbe davvero nell’interesse dei cittadini.
Gli Autori
Vincenzo Galasso è direttore del Centro Dondena di ricerca sulle Dinamiche sociali.
Aree di interesse scientifico
Political Economics. Macroeconomia. Economia pubblica. Sistemi pensionistici.
Tommaso Nannicini è assistant professor presso il Dipartimento di Economia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Political economics. Econometria applicata. Economia del lavoro
Da Bocconi Newsletter no. 118/2011
22
Economia
La lunga via di Doc Obama
di Giovanni Fattore
A 18 mesi dal sì del Congresso, la riforma sanitaria Usa è
lontana dall’attuazione. Giovanni Fattore, docente del
Dipartimento di Analisi istituzionale e management pubblico
della Bocconi, mette in evidenza i fronti sui quali lo scontro è
ancora aperto.
Quando Obama riuscì a far passare dal Congresso americano la riforma del sistema sanitario furono in molti a
stupirsi. Dopo decenni di riforme fallite e una situazione che sembrava quasi compromessa, il presidente mise
in campo tutta la sua forza e quella dei democratici per fare approvare la riforma. Oggi ci si rende conto che
la battaglia non è finita e che la legislazione voluta da Obama è ancora in discussione con il concreto rischio
di una situazione di stallo.
La riforma prometteva di affrontare i due problemi strutturali della sanità: l’assenza di copertura assicurativa
per 40 milioni di cittadini e la crescita incontrollata della spesa. L’esistenza di una parte della popolazione
senza copertura è sentita come una grave mancanza della società americana e una fonte di inefficienza. I
cittadini senza assicurazione non sono gestiti in modo appropriato, perché ricevono pochi servizi di
prevenzione e medicina di base e invece affollano i pronto soccorso perché solo in emergenza hanno diritto
all’assistenza. Si stima che la mancata universalità del sistema sanitario Usa sia causa di circa 40.000 morti
premature all’anno. La legislazione Obama introduce dispositivi per ridurre, anche se non azzerare, il numero
di persone non assicurate: prevede la copertura pubblica delle famiglie sotto il 133% della soglia di povertà,
l’introduzione di benefici fiscali e l’obbligo della copertura assicurativa. Sulla riduzione dei costi gli interventi
riguardano la promozione dei sistemi di managed care, il rafforzamento delle attività di valutazione
dell’efficacia degli interventi sanitari, lo sviluppo della medicina preventiva e interventi per rendere efficiente
la produzione dei servizi. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti con una produzione legislativa che richiede un
enorme sforzo attuativo. I risultati di questa riforma dipenderanno dal processo attuativo e dall’esito di uno
scontro ancora aperto su tre fronti: la Costituzione, la politica e l’implementazione.
Il primo scoglio è la costituzionalità della riforma e in particolare della parte che chiede l’obbligo della
copertura assicurativa. Gli oppositori sostengono che l’obbligo di assicurarsi lede la libertà individuale ed è in
contrasto con le disposizioni sulle competenze attribuite agli stati dalla Costituzione. La Corte Suprema si
23
Economia
esprimerà su questo aspetto nel 2012. Solo allora si saprà se un importante meccanismo che sorregge l’intero
impianto riformatorio sarà cancellato.
Il secondo terreno di scontro è politico. Per far passare la riforma Obama ottenne il pieno supporto di deputati
e senatori democratici, ma anche la netta opposizione del partito repubblicano che è compatto nel volerla
cambiare o boicottare. Per ora un cambiamento della legge non appare possibile, per il potere di veto del
presidente. Ma in futuro, se la presidenza passasse ai repubblicani, è probabile una nuova legislazione che
ribalti le disposizioni principali della riforma. Il fronte politico è polarizzato, come l’opinione pubblica: i
repubblicani e un 40% della popolazione, spaventata dai possibili maggiori costi dell’estensione della
copertura assicurativa, contro un altro 40% e il partito democratico che difendono la riforma argomentando
di giustizia sociale e razionalità economica. Si tratta di uno scontro duro, che apre un solco ideologico tra
posizioni libertarie ed economicamente liberiste e posizioni ispirate a giustizia sociale e maggiore regolazione
pubblica.
Il terzo nodo riguarda l’implementazione. La riforma prevede una serie d’interventi fino al 2018. Essa necessita
di regolamenti, costituzioni di nuovi enti, risorse finanziarie e collaborazione da parte degli stati. È qui che si sta
giocando la guerra più sporca, con boicottaggi burocratici e battaglie su specifici passaggi amministrativi e
politici.
Oggi quindi la riforma è ancora principalmente sulla carta, tutto dipenderà dalla Corte Suprema, dal
consenso che Obama e il suo partito manterranno e dalla capacità di gestione del tortuoso percorso per
rendere operative le disposizioni.
L’Autore
Giovanni Fattore è professore associato presso il Dipartimento di Analisi delle politiche e management
pubblico della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Management sanitario. Politica sanitaria. Analisi comparata dei sistemi sanitari. Politica del farmaco. Analisi
costi-efficacia e costi-benefici. Metodi di ricerca in management. Performance management nelle istituzioni
pubbliche. Mentalità e strumentazioni di governo.
Da Bocconi Newsletter no. 119/2011
24
Management
Management
Due rebus per comprendere i consumi
di Bruno Busacca
Secondo Bruno Busacca, docente Bocconi di Economia e
gestione delle imprese, per comprendere gli effetti della crisi
economica sui consumi è necessario risolvere due enigmi: uno
relativo alle dinamiche economiche internazionali, l’altro al
recupero della fiducia dei consumatori.
Gli effetti della crisi economica sui consumi permangono incerti, pur nel contesto generalizzato di autorevoli
opinioni che sottolineano molteplici segnali di cambiamento e prevedono una radicale discontinuità per molti
business. Le nostre ricerche evidenziano alcuni enigmi e alcuni punti fermi, sui quali è necessario riflettere in
modo approfondito. I principali enigmi si riferiscono alla soluzione di due rebus, il primo relativo alla dinamica
dei consumi a livello internazionale, il secondo al recupero della fiducia dei consumatori.
Il rebus dei consumi non è di facile soluzione perché chiama in causa da un lato l’evoluzione del tasso di
risparmio nelle economie mature e dall’altro i possibili effetti di compensazione fra queste ultime e le
economie emergenti. Il prevedibile incremento del tasso di risparmio in paesi come gli Stati Uniti e l’Inghilterra
sarà compensato da una maggiore propensione al consumo dei paesi emergenti? Pur considerando questa
ipotesi probabile, il rebus da risolvere riguarda sia i tempi necessari perché il suddetto bilanciamento avvenga
(alla luce delle attuali dimensioni relative delle economie) sia le innovazioni da proporre per stimolare la
domanda, e difendere i margini di profitto, in contesti socio-culturali assai diversi da quelli che caratterizzano
le economie a capitalismo maturo.
Il secondo rebus, di natura relazionale, si riferisce alle possibilità di recupero della fiducia dei consumatori nelle
imprese. Com’è noto, in genere le difficoltà economiche erodono questa fondamentale risorsa intangibile e
nell’attuale scenario le preoccupazioni al riguardo sono accresciute dall’analisi delle percezioni dei
consumatori in merito alle azioni adottate dalle imprese per fronteggiare la crisi economica. Da una recente
ricerca condotta in Italia dal Cermes Bocconi su “Crisi economica e marketing” emerge infatti che il 20,2% dei
consumatori intervistati ha percepito una diminuzione della qualità dei prodotti, il 23,3% una riduzione delle
innovazioni, il 40,5% un incremento dei prezzi. In sintesi, la crisi sembra avere ulteriormente indebolito il valore
percepito nei prodotti e rafforzato le percezioni di opportunismo nei comportamenti delle imprese,
destabilizzando brand trust e brand loyalty.
27
Management
Le certezze, evidenziate con chiarezza dalla ricerca suddetta, riguardano l’aumento dell’autodeterminazione
dei consumatori, la rinnovata sensibilità al reale “value for money” di beni e servizi, la crescente centralità
attribuita alle tematiche ambientali. In particolare, i consumatori ritengono che, quando la crisi sarà finita,
diventeranno più esperti negli acquisti (89,5%), più consapevoli nei confronti delle imprese (80,2%), più attenti
ai prezzi (84,8%), alla qualità (88,3%) e all’ecologia (81%), più orientati al risparmio (79%), alle promozioni (79%)
e all’innovazione (57,4%). D’altro canto, le imprese avranno maggiori difficoltà a influenzare i comportamenti
di consumo (80,2%) e dovranno attuare comportamenti più etici e rispettosi delle persone e dell’ambiente
(86,7%).
Queste evidenze impongono alle imprese risposte decise in termini di trasparenza, equità relazionale,
verticalità e orizzontalità della proposizione di valore offerta al mercato, sostenibilità.
Tutto ciò implica la riorganizzazione dell’intero value network, a partire dalle attività di progettazione e design
di beni e servizi, e un costante orientamento all’attivazione di processi di innovazione collaborativi, che si
estendano oltre i consolidati partner orizzontali e verticali, coinvolgendo anche i clienti finali. Il potenziale
creativo di consumatori più consapevoli e self-confident rappresenta un’importante leva per rifondare le
relazioni di mercato intorno a solidi valori. Le nuove tecnologie aiutano a raggiungere questo obiettivo
favorendo la realizzazione di piattaforme collaborative aperte, che sempre più dovranno essere utilizzate per
mettere al centro della strategia d’impresa il benessere autentico delle persone e della società.
L’Autore
Bruno Busacca è professore ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Analisi del consumatore. Marketing strategico. Gestione del valore per il cliente. Customer satisfaction.
Customer Relationship Management. Gestione strategica della marca. Politiche di prezzo.
Da Bocconi Newsletter no. 100/2011
28
Management
Consumption crossover, ed ecco i balli latini
di Luca M. Visconti
Perché si consumano servizi e prodotti di un’altra cultura? Luca
M. Visconti, direttore del Master in Marketing e comunicazione
della Bocconi, spiega che alla base di questo fenomeno ci
sono ragioni di diversa natura, dal desiderio di evasione dal
quotidiano alle motivazioni sociali.
Crossover Dreams, così si intitola uno dei pochi contributi sul consumption crossover. L’espressione poco userfriendly descrive un fenomeno in realtà quotidiano: il consumo, da parte del gruppo culturalmente
dominante, di servizi, prodotti, brand, esperienze che pertengono a un gruppo di minoranza. Grier,
Brumbaugh e Torton, autori dell’articolo citato, esplorano l’altro lato dell’immigrazione e, così facendo,
ricordano che i processi di acculturazione non riguardano solo gli “altri”.
Come italiani, consumiamo sempre più spesso alimenti, musica e arte, design, servizi di medicina alternativa,
vestiario e accessori moda, che arrivano da molto lontano. Solo pochi decenni fa sarebbe stato impensabile
indossare un maglione peruviano (magari firmato Prada, come succede nell’ultima collezione “Made in Perù”
della nota griffe milanese), fare colazione con mango fresco ascoltando musica macedone, pranzare a base
di sushi, lavorare con colleghi di varie nazionalità, prendere lezione di balli latini, per chiudere la giornata
sorseggiando mojito, magari distesi su di un futon.
La presenza di più consumatori stranieri ha inevitabilmente consentito alle imprese di elaborare un’offerta
connotata in termini etnici. Parallelamente, gli italiani hanno osservato, testato, esplorato nuove forme di
consumo, restando spesso affascinati. Da una nostra recente ricerca (“Factory Outlet Center: relazioni con la
marca e place attachment”), emerge che gli italiani aperti ai consumi esotici sono guidati da un desiderio di
evasione dal quotidiano. Per alcuni, questo consumo ha una forte valenza sociale, differenziandoli dalla
massa. Se, un tempo, le teorie di Veblen ci insegnavano che la classe agiata viene imitata per bisogno di
omologazione, oggi c’è chi preferisce sentirsi diverso, e per ragioni indipendenti dal reddito! Diversamente,
c’è anche chi sposa il consumo etnico con motivazioni più intime, quale atto ideologico di apertura alle
nuove culture e di tutela delle minoranze. Verrebbe da dire “Mangio cinese e difendo la legittimità di questo
gruppo nel mio quartiere”.
29
Management
Gli studi condotti riconoscono che le potenzialità del consumption crossover si legano tanto al fronte
dell’offerta quanto a quello della domanda. Le imprese, infatti, possono accrescere l’appeal dell’offerta
“etnica” lavorando su leve quali l’esplicitazione del target di riferimento, i testimonial, il ricorso nella
comunicazione a pratiche o rituali simbolicamente evocativi. La ricettività dei consumatori, poi, varia in
funzione della loro appartenenza ad altri gruppi di minoranza, alla volontà di distinguersi, alla ricerca di
varietà. Il contesto di consumo (pubblico vs privato, individuale vs collegiale) può enfatizzare la
spettacolarizzazione delle scelte di acquisto (se voglio distinguermi, questo sarà ancor più marcato in
presenza di un’ampia audience) così come il timore di essere giudicati.
Una provocazione finale. Il consumption crossover interessa noi italiani ben prima dell’arrivo in massa dei
migranti dell’ultimo ventennio. Da molto più tempo, infatti, consumiamo tecnologia giapponese, alimenti
americani (“Have a Coke!”), formule distributive anglosassoni, per arrivare ai recenti social network. Tuttavia,
mai abbiamo qualificato questi consumi come etnici, anche se Coca Cola ci è tanto estranea quanto un
piatto di wanton. Non sarà che, come consumatori, inconsciamente creiamo gerarchie tra culture e
consideriamo etnici solo i consumi riferibili a culture per noi inferiori? A ben guardare, i consumi raccontano
molto di più di semplici storie di mercato.
L’Autore
Luca M. Visconti è direttore del Mimec, il Master in Marketing e comunicazione della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 100/2011
30
Management
Metodo più immaginazione
di Arianna Brioschi e Anna Uslenghi
Cinque modi per avere buoni ritorni da budget ridotti: Arianna
Brioschi e Anna Uslenghi, docenti del Dipartimento di Marketing
Bocconi, mostrano come le piccole imprese (e non solo)
possono incanalare la creatività in modo concreto ed efficace,
per emergere in mercati sempre più liquidi.
Il proprietario di una piccola libreria ebbe un giorno la sfortuna di vedere il suo negozio schiacciato in mezzo
alle filiali di due grandi catene di librerie. Un giorno, arrivando al lavoro, incappò nell’enorme striscione
esposto dal concorrente alla sua destra, “Grandi saldi di anniversario. Tutti i libri al 50%!”. Il poster era più
grande dell’intera vetrina del negozietto. Peggio che mai, la libreria alla sua sinistra scoprì uno striscione
ancora più vistoso, “Fuori tutto! Prezzi in caduta libera. Sconti del 60% e oltre”; anche in questo caso la
bottega era sovrastata dall’immenso manifesto del rivale. Non sparire sembrava una missione impossibile. Il
libraio invece stampò un cartello da appendere sulla propria insegna con una scritta a lettere giganti,
“ENTRATA PRINCIPALE”.
L’ispirazione e la creatività possono davvero fare la differenza, per le piccole imprese innanzitutto ma non
solo. La chiave per emergere in mercati sempre più liquidi non sta tanto nella “forza bruta” dei grandi budget
quanto nella capacità di immaginare soluzioni uniche e rilevanti per i consumatori. Non si parla qui di pura
fantasia o stravaganza: la creatività che produce valore per l’azienda, ovvero ritorni economici, si basa su
una conoscenza profonda della marca e su una comprensione autentica degli individui.
Vediamo almeno cinque modi in cui la creatività può essere concretamente ed efficacemente incanalata.
Primo, guardare il mondo con occhi diversi e scovare opportunità nelle tendenze che si diffondono dal basso.
Un effetto della crisi è che ora si cucina di più e si mangia a casa, quando però il frigo è pieno di cose mezze
scadute improvvisare la cena è problematico. Un paio di blogger americani hanno lanciato la sfida di “usare
quello che si ha già, a partire dagli ingredienti più vicini alla scadenza” ottenendo tantissime adesioni: che i
consumatori siano in cerca di qualcuno che li aiuti a pianificare la spesa? Un insight fecondo per le marche
alimentari.
31
Management
Secondo, scegliere nella categoria un posizionamento di rottura. Tutti i detersivi sporcano l’ambiente con i loro
componenti nocivi: in un mercato dominato dalle multinazionali, Method ha lanciato detergenti puliti sul serio,
a base di sostanze bio, e belli da vedere, grazie al packaging di design. Dopo pochi anni questa piccola
azienda occupa le posizioni più alte delle classifiche delle imprese più innovative del mondo e a crescita più
rapida.
Terzo, al posto del mero denaro, investire tempo, energie e idee. Offrendo un posto di lavoro come guardiano
di un’isola della grande barriera corallina, l’ente del turismo del Queensland ha probabilmente realizzato la
campagna di comunicazione con il tasso di rendimento migliore del 2010. Il concorso “The Best Job in the
World” ha generato, con un investimento media contenuto, un buzz planetario.
Quarto, essere rapidi nel recepire il futuro, anzi il presente. Kogi Taco, un ristorante coreano itinerante di Los
Angeles, ha conquistato oltre 50.000 clienti fedeli che seguono su Twitter gli spostamenti imprevedibili (perché
non posteggiano mai nello stesso posto) dei suoi quattro furgoncini. Un uso intrigante e realmente innovativo
dei social media.
Quinto, reinventare le best practice. Un artigiano del cioccolato di San Francisco ha coinvolto i propri clienti
nel miglioramento della versione Beta del suo fondente, sull’esempio degli sviluppatori di software. Dopo oltre
mille iterazioni, la release definitiva Thco 1.0 è ora in vendita online.
La chiave per un marketing di successo si basa dunque sul metodo accompagnato sempre
dall’immaginazione creativa. Ed è questa la direzione da seguire per avere sempre più ritorni.
Gli Autori
Arianna Brioschi è lecturer presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Comunicazione. Filantropia aziendale e marketing filantropico. Ambiti applicativi: settore della moda e dei
beni di lusso.
Anna Uslenghi è lecturer presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 101/2011
32
Management
Mobbing, quando la malata è l’organizzazione
di Roberto Vaccani e Paola Caiozzo
Ecco l’identikit delle organizzazioni che favoriscono il mobbing:
gerarchiche, poco trasparenti nelle politiche del personale e
autoritarie nella direzione. Lo dice una ricerca Croma Bocconi,
illustrata da Roberto Vaccani e Paola Caiozzo, docenti SDA
Bocconi di Organizzazione e personale.
Stress e lavoro sono temi di particolare attualità per due motivi: in primo luogo in rispetto all’accordo
comunitario europeo sullo stress e sul lavoro del 2004, recepito dall’Italia nel 2008. Tale impianto normativo è
teso alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In secondo luogo in base ai risultati di
un’indagine del Croma Bocconi (Center for research in organization and management) in collaborazione
con la Clinica del lavoro “Luigi Devoto” di Milano. L’indagine è stata condotta su un doppio campione di 285
persone: 121 lavoratori mobbizzati o affetti da stress e un gruppo di controllo di 164 lavoratori senza problemi
di questo genere e associata a un’analisi qualitativa con interviste mirate a testimoni del mondo del lavoro
(responsabili del personale, amministratori delegati, giuslavoristi, sindacalisti).
La ricerca (Le cause organizzative del mobbing. Se il malato fosse l’organizzazione?, a cura di Paola Caiozzo
e Roberto Vaccani, Franco Angeli, 2010) ha validato un modello di diagnosi teso a rintracciare i predittori
organizzativi del mobbing partendo dalla consapevolezza che l’organizzazione può essere causa sistemica di
malessere, oltre che di benessere. I dati ci dicono che l’organizzazione piatta (pochi ed essenziali livelli
gerarchici) e la trasparenza delle politiche del personale risultano essere tra i migliori antidoti organizzativi al
mobbing. Il loro contrario, i maggiori predittori. Funzionano da antidoto anche l’effettiva implementazione del
disegno organizzativo (organigramma, funzionigramma, procedure) e il suo grado di utilità percepito dai
lavoratori. Inoltre, politiche del personale orientate allo sviluppo (selezione, sviluppo carriere, meritocrazia,
formazione), riducono la probabilità di mobbing, mentre le pratiche orientate esclusivamente al controllo
(amministrazione, rapporti sindacali, vigilanza), ne aumentano il rischio.
Un risultato significativo riguarda poi il comportamento dei capi. Lo stile di direzione è una variabile critica.
Una gestione autorevole orientata alla partecipazione, alla negoziazione e al confronto è un forte antidoto al
mobbing. Al contrario, uno stile di direzione autoritario improntato al comando e alla prescrizione è un fattore
di rischio mobbing.
33
Management
Si è inoltre indagata la possibilità che variabili organizzative che, prese individualmente, non influiscono sul
fenomeno, diventino significative quando combinate tra loro. Ne risulta che un forte accentramento
decisionale funziona da amplificatore se associato a uno stile autoritario orientato al comando. La stessa
variabile contribuisce invece a ridurre il rischio quando è associata a uno stile di direzione negoziale e
autorevole. In altri termini, al vertice gestionale delle organizzazioni è la personalità di chi comanda a fare la
differenza.
Considerando le configurazioni organizzative nel loro complesso, risultano a minor rischio di mobbing le
imprese che si possono definire a “democrazia flessibile”, improntate a una struttura piatta, sistemi di gestione
delle persone trasparenti e orientati allo sviluppo, stili di direzione autorevoli, con una buona implementazione
del disegno organizzativo, alla quale è associato un alto livello di utilità percepita. A tali contesti aziendali
sono opposte le organizzazioni gerarchizzate, burocratiche, ispirate da stili gestionali autoritari, che risultano
ambienti facilitanti il mobbing.
Riguardo alle caratteristiche dei mercati, la ricerca ha individuato un nesso logico di causalità che lega l’etica
degli affari all’etica di convivenza organizzativa. Infatti, a caratteristiche di mercato aperto concorrenziale e
normato, sembrano corrispondere sistemi organizzativi essenziali, trasparenti e dinamici, tesi a massimizzare
efficacia ed efficienza produttiva. Tali formule organizzative prosciugano spazi alle dinamiche sociali perverse.
A mercati protetti, con processi monopolistici o politiche di cartello, corrispondono più di frequente
organizzazioni statiche, ispirate da culture autoritarie e autoreferenziali.
Gli Autori
Roberto Vaccani è SDA Bocconi professor di Organizzazione e personale.
Aree di interesse scientifico
Comportamento organizzativo. Climi organizzativi. Stili di leadership. Modelli didattici. Epistemologia
dell’apprendimento.
Paola Caiozzo è SDA Bocconi professor di Organizzazione e personale.
Aree di interesse scientifico
Comportamento organizzativo. Comportamento alla vendita. HR. Formazione Formatori. Metodologie,
gestione e valutazione dei processi di apprendimento nell’ambito del CESDIA (Centro per lo sviluppo delle
capacità Didattiche e di Apprendimento)
Da Bocconi Newsletter no. 102/2011
34
Management
Le emozioni che possono far risparmiare 300 miliardi
di Isabella Soscia
In Giappone i costi economici della depressione sono così alti
che il governo è corso ai ripari con misure di prevenzione che
includono anche leve di marketing. Perché la felicità, osserva
Isabella Soscia, docente del Dipartimento di Marketing
Bocconi, non si compra certo con i soldi. Però...
Un curioso e macabro articolo del Sole24Ore, alcune settimane fa, riportava i costi economici delle forme
patologiche della tristezza in Giappone: suicidi e perdite di lavoro legate alla malattia varrebbero quanto una
manovra di stimolo fiscale. Aziendalisti ed economisti che si interrogano, perplessi, sulla rilevanza delle variabili
emotive in ambito economico, dovrebbero superare le prime diffidenze di fronte alla perdita di 300 miliardi di
euro sostenuta dall’economia giapponese negli ultimi 12 anni causata proprio dalla malattia della
depressione. Il governo giapponese è corso ai ripari varando una task force di prevenzione della malattia,
misure preventive che coinvolgono anche... leve di marketing! È stata pianificata, infatti, una campagna di
comunicazione interpretata da un testimonial celebre: Kengo Nakamura, amato centrocampista del
Kawasaki Frontale.
La ricerca della gioia è, in generale, la chimera della nostra società, addirittura un diritto, almeno secondo la
Dichiarazione di indipendenza americana. E se ci può far sorridere lo spazio dedicato nelle librerie ai manuali
che ci istruiscono sul raggiungimento della felicità, dall’altro, quantomeno come studiosi di marketing, non
possiamo non interrogarci seriamente su questi clamorosi successi editoriali e su che cosa ci renda felici o tristi.
Se è vero (e la ricerca scientifica lo dimostra) che i soldi e il materialismo non comprano la felicità, è anche
vero che ciò che ci rende felici, tipicamente le attività creative individuali e le relazioni con gli altri, sono
pervase dalla dimensione del consumo.
Con riferimento alle seconde, un recente studio condotto negli Usa sostiene che fra i momenti più gioiosi della
giornata, rientrino le occasioni di socializzazione extralavorative, come può essere proprio la visione collettiva
di una partita di calcio.
35
Management
La felicità può poi risiedere nell’attività in sé, piuttosto che nel raggiungimento di un obiettivo e, in particolare,
nell’attività individuale di immersione in un processo creativo. Ci sentiamo felici quando riusciamo a realizzare
noi stessi in un’attività che ci esprime appieno. L’esecuzione di una coreografia per un’appassionata di
danza, la preparazione di un piatto prelibato per un gourmet, la stesura di un libro o l’interpretazione di un
brano musicale possono rappresentare momenti felici per chi si cimenta in queste attività. Lo psicologo
ungherese Mihaly Csikszentmihalyi ha definito ‘flow’ questo stato di totale immersione che accompagna
l’attività creativa, l’espressione di un talento piuttosto che l’esecuzione di un compito sfidante: in questo senso
la felicità può essere considerata come la prima conseguenza di questo stato di immersione.
Tali occasioni di condivisione e di realizzazione personale non prescindono, quindi, da una dimensione di
consumo.
Un’esperienza di acquisto connotata da forti emozioni positive non fa solo la felicità del cliente, ma anche
quella delle imprese che la promuovono. Una recente ricerca intersettoriale realizzata dal Cermes (Valdani,
Soscia, Zarantonello, “ExTra: Experience and Trust”), che ha previsto il coinvolgimento di 32 realtà aziendali e
più di 2.000 consumatori, ha verificato come la realizzazione di una dimensione esperienziale generi una
relazione di fiducia fra i clienti e le imprese che l’hanno sostenuta.
Dunque, un management accorto ma cauto nel ricorso persuasorio delle leve di marketing e un cliente
consapevole possono divenire felicemente complici di un’esperienza di consumo memorabile.
L’Autore
Isabella Soscia è assistant professor del Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Le ricerche di mercato. La comunicazione di marketing e il comportamento del consumatore, con particolare
riferimento alle emozioni nei processi di acquisto e di consumo.
Da Bocconi Newsletter no. 103/2011
36
Management
Servono progetti per togliere la muffa dall’azienda
di Alfredo Biffi
Il pensiero per progetti è di fatto quasi assente nella media
delle aziende. Eppure, saper lavorare per progetti è
indispensabile perché un'azienda innovi e competa. Per
Alfredo Biffi, SDA Professor di Sistemi informativi, è il modo di
pensare delle persone a fare la differenza.
Se l’innovazione è un imperativo per la competitività dell’impresa moderna allora questa deve investire sulle
condizioni necessarie a favorirla. Il dubbio è solo una provocazione, la soluzione è una certezza. Favorire
l’innovazione significa mettersi nella logica di sviluppare le capacità di “vedere” in quali ambiti può crearsi
l’innovazione (prodotto, processo, sistema, relazione; grande o piccola che sia…), di sapere orientare gli attori
necessari alla realizzazione appartenenti al sistema azienda, di saper fare direttamente, ossia realizzare i
contenuti tecnici dell’innovazione, di saper trovare la soluzione insieme agli altri (persone come colleghi; unità
organizzative complementari alla propria; persone e organizzazioni esterne).
Tra le condizioni necessarie vi è quella di avere un sistema azienda che sa pensare per progetti per realizzarli
nell’azione. Innovare comporta, infatti, dar vita a un progetto, per quanto semplice possano essere l’attività
da svolgere e il risultato da ottenere. E questo si sviluppa con le persone che hanno il senso di un obiettivo
operativo a cui tendere e di un metodo sistematico, oggettivamente insieme definito, per perseguirlo.
È impressionante osservare come nella media delle aziende il pensiero del lavoro per progetti sia quasi
assente e come le persone possiedano prevalentemente paradigmi da processo, ossia pensati per le pure
routine d’efficienza e di controllo anziché d’efficacia, la qual cosa porta spesso ad amplificare attività di
forma più che di sostanza. È incredibile verificare come la frammentazione fra le parti dell’organizzazione
aziendale governata per norme e regole di compliance, talvolta concepite a puro scarico di responsabilità,
stiano irretendo anche quelle realtà che per vocazione di business eseguono l’innovazione per conto terzi,
cioè le aziende che eseguono complessi progetti su commessa. L’efficienza nel lavoro è un dovere per tutte
le imprese ma l’adozione di forme esasperate di regolamentazione operativa sembra essere una ricetta
illusoria di fronte alle necessità di fare cose nuove.
37
Management
Una possibile risposta, complementare alla standardizzazione dei comportamenti, sta nella disponibilità di
persone capaci di osare a modificare il processo, proponendo alternative oggettivamente dimostrabili: ma
questo richiede persone che sappiano pensare per progetti. L’accettazione di proposizioni alternative
richiede un management che sappia osare, di fronte a fatti oggettivi anche se rischiosi, nel rimettere in
discussione assetti di lavoro ritenuti conformi; anche questo necessita di persone che sanno pensare per
progetti. Quando queste persone esistono, anche domini d’efficienza diventano ambiti di innovazione.
Diffondere conoscenze e capacità del lavoro di progetto uscendo dalle nicchie in cui questo è spesso
confinato (unità di ricerca e sviluppo, sistemi informativi, ingegnerie varie) aumenta la possibilità sia che le
persone “vedano” opportunità di innovazione anche nel normale fluire del processo sia, e soprattutto, che
siano protagoniste nell’emersione dell’opportunità e consapevoli della modalità con cui compartecipare
all’esecuzione dell’innovazione.
Molte aziende stanno investendo in attività tese ad aumentare la conoscenza del project management fra i
propri collaboratori; altre stanno pensando di rivitalizzare lavoro process based ormai stantio inserendovi
logiche di lavoro per progetti; altre pensano, nell’ambito delle scelte di governance, ad assetti organizzativi
che sono project based fin dall’origine. Queste ultime, a partire dal top management possiedono il pensiero
per progetti: così facendo aumentano anche la loro capacità di utilizzare il cosiddetto capitale umano, ossia
la persona, condizione prima per l’efficacia nell’innovazione.
L’Autore
Alfredo Biffi è professore associato all'Università dell'Insubria e SDA Bocconi professor di Sistemi informativi.
Aree di interesse scientifico
Evoluzione degli assetti organizzativi aziendali in logica project based. Sviluppo di profili di competenza project
& process based. Impiego delle ICT per la modellazione di assetti organizzativi orientati alla innovazione.
Da Bocconi Newsletter no. 103/2011
38
Management
Venderà di più chi porta il cliente nella stanza
dei bottoni
di Emanuela Prandelli e Martin Schreier
Il design della maglietta e il colore delle caramelle? Le sceglie il
cliente. Emanuela Prandelli e Martin Schreier, docenti Bocconi
del Dipartimento di Management e tecnologia, spiegano quali
benefici portino alle imprese le sempre più diffuse strategie di
empowerment del consumatore.
Immaginiamo di essere invitati a votare non per scegliere un partito, bensì i nuovi concetti di prodotto che
un’impresa dovrebbe lanciare sul mercato. Immaginiamo poi che quell’impresa, proprio come un’istituzione
politica in democrazia diretta, si impegni a realizzare i concetti che conquistano la maggior quota di
preferenze nella votazione. Quale sarebbe la nostra reazione nei confronti di una simile impresa?
La domanda merita risposte puntuali, dato che un numero crescente di imprese, grazie anche alle
opportunità di interazione offerte dalla rete, si sta oggi orientando a favore della democrazia: Threadless, ad
esempio, consente agli utenti di esprimere le proprie preferenze in merito a T-shirt create da altri utenti e
commercializza poi solo le più gettonate; M&Ms consente ai consumatori di contribuire alla scelta dei colori
delle caramelle da lanciare sul mercato, Mountain Dew dei nuovi gusti per i propri soft drink.
Si tratta solo di una nuova moda o vi sono motivazioni manageriali razionali a giustificare questa nuova
disponibilità a dar voce al cliente? La letteratura tende a spiegare il fenomeno attraverso una serie di benefici
strumentali: la riduzione di rischi e costi impliciti nel processo innovativo, la contrazione del time-to-market e la
miglior rispondenza dei prodotti creati alle esigenze del mercato. Insieme a Christoph Fuchs dell’Università di
Rotterdam, abbiamo dimostrato in realtà come vi siano anche sottili reazioni psicologiche scatenate
dall’empowerment del cliente a suggerire l’adozione di simili strategie, rese sempre più facilmente
implementabili dalla diffusione dei contesti digitali.
In un primo articolo pubblicato su Journal of Marketing nel 2010 (The Psychological Effects of Empowerment
Strategies on Consumers’ Product Demand), proviamo come i clienti coinvolti dall’impresa nella selezione dei
prodotti da commercializzare palesino poi una superiore domanda (intesa quale intenzione di acquisto e
39
Management
disponibilità alla spesa) per gli stessi prodotti, nonostante essi siano oggettivamente identici a possibili
alternative. Questo comportamento apparentemente irrazionale è il risultato del maggior senso di
responsabilità e possesso, sotto il profilo psicologico, nei confronti di prodotti che si è contribuito a scegliere.
Un simile effetto è tanto più evidente quanto più il processo decisionale congiunto riflette le preferenze del
singolo (ragion per cui il coinvolgimento del cliente pare preferibile in situazioni di preferenze omogenee nel
mercato) e quanto più il singolo percepisce di avere competenze adeguate a supportare la propria scelta (a
suggerire che il coinvolgimento paga soprattutto laddove una buona parte della domanda ha sufficienti
conoscenze per esprimere valutazioni puntuali).
In una serie di esperimenti successivi, che hanno coinvolto un migliaio di utenti, dimostriamo poi come gli
effetti dell’apertura democratica al cliente si estendano al di là del mero incremento di domanda per il
prodotto stesso che si è contribuito a identificare. Il coinvolgimento attivo del consumatore migliora in senso
più ampio la relazione con l’impresa, inducendo atteggiamenti più favorevoli, anche una volta che l’iniziativa
di customer empowerment si è conclusa.
In particolare, proviamo tre effetti cruciali a giustificare l’investimento nel coinvolgimento del cliente. In primo
luogo, aumenta il livello di identificazione nel brand, nel breve e nel lungo periodo. In secondo luogo, tale
effetto permane anche se il coinvolgimento riguarda decisioni non attinenti al prodotto, come nel caso della
scelta delle iniziative di Csr che l’impresa potrebbe supportare. Da ultimo, quanto maggiore è la
corrispondenza tra il risultato del processo di scelta congiunta e le preferenze individuali, tanto più forte è
l’effetto quando la decisione è presa non da pochi (con la conseguente consapevolezza di poter incidere di
più sul risultato finale, come nelle elezioni politiche), bensì da una comunità estesa, dove predomina la
consapevolezza di fare tutti parte di un unico “grande movimento”.
Gli Autori
Emanuela Prandelli è professore associato presso il Dipartimento di Management e tecnologia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Internet marketing e commercio elettronico. Innovazione nel marketing. Analisi del consumatore. Fashion
Management. Management delle aziende editoriali.
Martin Schreier è associate professor presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Marketing. Comportamento del consumatore. Sviluppo di nuovi prodotti. Innovazione dell’utente.
Da Bocconi Newsletter no. 105/2011
40
Management
La corporate social responsibility difende l’impresa
dagli attacchi
di Barbara Del Bosco e Nicola Misani
Il crimine è un serio rischio per le imprese e ha cause
complesse. Secondo i docenti di Economia e gestione delle
imprese Nicola Misani (Bocconi) e Barbara Del Bosco (Università
di Bergamo), le politiche di Csr influenzano in positivo gli
stakeholder e aiutano a prevenire atti criminosi.
Il crimine è un serio rischio per le imprese. Un recente studio internazionale di Price Waterhouse Coopers rivela
che un’impresa su tre ha subito un crimine nei dodici mesi precedenti il sondaggio, mentre tre executive su
quattro intervistati da KPMG prevedono che nell’arco di un anno i rischi di frode rimarranno stabili o
cresceranno.
Il crimine contro le aziende ha cause complesse. I fattori di rischio sono a livello individuale (carenze di
integrità morale, stati di bisogno personali), organizzativo (difetti nelle procedure di sicurezza, errate politiche
del personale) e sociale (subculture criminali, vuoti di sicurezza pubblica). Pertanto è indispensabile che le
imprese modulino le loro risposte in funzione di chi le minaccia, delle ragioni sottostanti e del contesto.
Vi sono quattro tipologie di crimine. A un estremo vi è quello ‘puro’, in cui l’impresa è attaccata per intenti
meramente criminali da soggetti che non hanno alcuna relazione con essa. Rientrano in questa categoria le
azioni della criminalità organizzata e dei professionisti del crimine.
All’estremo opposto vi sono le ‘reazioni legittime’, situazioni in cui il crimine è commesso da membri di una
categoria ‘tradizionale’ di stakeholder (dipendenti, clienti, fornitori) che agiscono illecitamente ma sulla base
di un’istanza socialmente legittima, ossia motivati da bisogni, aspettative e diritti che meritano rispetto e
considerazione. Nel 2009, gli operai francesi presero in ostaggio i manager di diverse aziende (tra cui Sony,
Caterpillar e 3M) come forma estrema di lotta ai licenziamenti e ai tagli salariali. Secondo un sondaggio, il 45%
dei francesi ritenne accettabili queste azioni illegali. Questo supporto sociale aiutò i lavoratori a ottenere
importanti concessioni.
41
Management
Una situazione differente è il ‘tradimento della fiducia’, in cui il crimine è commesso da membri di una
categoria tradizionale di stakeholder che però perseguono finalità non legittime, come il guadagno
personale. Costoro sfruttano la relazione esistente con l’impresa, l’accesso alle strutture e ai sistemi informativi
aziendali per commettere furti, frodi e altri crimini.
Infine, c’è ‘l’eroismo canaglia’, crimini commessi da chi non è uno stakeholder legittimo ma si batte per uno
scopo approvato dalla società. Per esempio, quando un regime autoritario impedisce ai gruppi politici locali
di perseguire uno scopo socialmente legittimo (come la difesa delle libertà civili) con mezzi legali, questi
gruppi possono ricorrere alla violenza in nome della loro causa (ad esempio col rapimento di dirigenti stranieri
di multinazionali operanti nel paese).
Le imprese possono rispondere a questi rischi con tecniche classiche di security, ma anche influenzando in
positivo gli stakeholder. In un recente paper (“Keeping the enemies close: The contribution of corporate social
responsibility to reducing crime against the firm”, Scandinavian Journal of Management, n. 1, 2011) abbiamo
esplorato come le politiche di Csr possono servire a difendersi dal crimine, aiutando le imprese ad acquisire
legittimità, a soddisfare gli interessi degli stakeholder e a rispondere alle attese di giustizia verso i
comportamenti aziendali.
Grazie alla Csr, un’impresa può ridurre l’incentivo a commettere crimini contro di essa ed evitare che i
colpevoli possano fabbricare giustificazioni convincenti per le loro azioni; inoltre, si procura il sostegno degli
stakeholder legittimi, che possono ostacolare gli attacchi esterni attraverso il controllo sociale e una maggior
cura nell’applicare le regole interne. Questi effetti sono più o meno importanti secondo il tipo di crimine cui
l’impresa è soggetta: la Csr è poco efficace contro il crimine puro, ma può scoraggiare le reazioni legittime,
perché contiene le insoddisfazioni e i sentimenti di ingiustizia che le originano.
Ne deriva un vantaggio non solo per le imprese ma anche per le comunità dove sono insediate, perché la
prevenzione del crimine riduce la conflittualità sociale e la violenza.
Gli Autori
Barbara Del Bosco è ricercatore di Economia e gestione delle imprese presso l’Università di Bergamo.
Nicola Misani è ricercatore di Economia e gestione delle imprese presso l’Università Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Strategia, responsabilità sociale d’impresa. Corporate governance. Gestione del rischio. Imprenditoria
sostenibile.
Da Bocconi Newsletter no. 105/2011
42
Management
Le vie dello shopping non hanno mai parlato italiano
di Elisabetta Merlo
Un viaggio nel rapporto (difficile) tra i grandi magazzini e gli
Italiani, che per anni hanno preferito i negozi al dettaglio. Per
Elisabetta Merlo, docente del Dipartimento di Analisi
istituzionale e management pubblico della Bocconi, in Italia nel
settore manca, di fatto, un vero modello di impresa.
È il 1877. I fratelli Luigi e Ferdinando Bocconi aprono a Milano i grandi magazzini “Aux ville d’Italie” ispirati al
prototipo francese. Al loro interno, tutto è all’insegna della modernità. L’ampiezza dell’assortimento
merceologico, le dimensioni delle superfici di vendita, la suddivisione in reparti, i prezzi esposti, le vetrine
allestite per catturare lo sguardo dei passanti più frettolosi, le occasioni di intrattenimento della clientela (la
sala da tè, le sfilate, le rappresentazioni teatrali) segnano una netta cesura con il negozio di stampo
tradizionale.
Eppure, il grande magazzino non fa breccia nelle abitudini di spesa del consumatore italiano che per decenni
continuerà a preferirgli il negozio al dettaglio. Pochi dati bastano per documentare il fenomeno. All’inizio degli
anni Sessanta (quando scoccava il centenario dell’Unità) in Italia esistevano 10 grandi magazzini, in Francia
83, in Germania 230 e 277 nel Regno Unito. Nel 1980 i divari erano ancora lontani dall’essere colmati. In
Germania i grandi magazzini, in competizione con i formati distributivi moderni, si accaparravano una quota
del mercato pari al 7,8%, in Italia invece sottraevano al commercio tradizionale una quota di mercato pari
allo 0,4%.
1955. Boogart, un manager della americana Ibec, arriva in Italia con il mandato di introdurre il self service
nella distribuzione alimentare. La corrispondenza intrattenuta con la casa madre fornisce la fotografia di un
paese, anzi, di una delle sue aree più avanzate (o meno arretrate), che ancora esita a imboccare la strada
della modernizzazione. “A Milano non conosco famiglie che abbiano due auto, se non la mia e quella di uno
dei nostri partners […] Non possiamo sopravvivere acquistando da questi avidi produttori […] Questo è un
paese in cui anche un americano può confondersi. Abbiamo aspettato e lavorato per ottenere dal Comune
la licenza di vendita. È stata approvata e da allora tutti sembrano essere scomparsi, ma l’amiamo” al punto
da riuscire a fondare, insieme a Crespi e Caprotti, il nucleo originario della futura Esselunga.
43
Management
Grande magazzino e supermercato evidenziano che la storia del sistema distributivo italiano è avanzata su
due binari paralleli. Da una parte il commercio al dettaglio, polverizzato in una miriade di imprese individuali
proliferate per assorbire la disoccupazione generata dagli altri settori. Dall’altra, una manciata di pionieristiche
iniziative imprenditoriali costrette a muoversi all’interno di un contesto legislativo, economico e sociale
avverso.
Nel corso degli ultimi decenni molta strada è stata percorsa nella direzione della razionalizzazione del sistema
distributivo italiano e della sua apertura a nuovi formati.
L’Italia ha attratto imprese straniere, ma le imprese commerciali italiane faticano a varcare i confini nazionali.
Il made in Italy distributivo è ancora alla ricerca di un modello di impresa con cui identificarsi. La ricorrenza del
150° anniversario dell’unificazione può essere l’occasione per apprendere dalla storia che in mancanza di
una forte identità nazionale il processo di modernizzazione del sistema distributivo italiano corre il rischio di
restare incompiuto.
L’Autore
Elisabetta Merlo è professore associato di Storia economica alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Storia dell'impresa e dell'industria.
Da Bocconi Newsletter no. 106/2011
44
Management
Project followership, i progetti per tutti gli altri
di Marco Sampietro
Quasi tutti gli studi sul project management si rivolgono al
project manager. Per Marco Sampietro, docente di Project
management e informatica per l’economia alla Bocconi, è
necessario e utile affrontare anche il punto di vista di chi ai
progetti partecipa come membro del team.
Il project management è una disciplina relativamente giovane (poco più di 50 anni) e in continua evoluzione
che ha dimostrato di saper rispondere con concretezza alle richieste delle aziende moderne e per questo ha
visto la sua popolarità crescere con decisione negli ultimi anni. Le pubblicazioni sul project management sono
cresciute di pari passo e forse sono divenute quasi eccessive. La numerosità non corrisponde però né a
varietà né a completezza.
In effetti, facendo una classificazione del patrimonio di conoscenza pubblico sul project management, la
situazione può essere sintetizzata così: una fortissima presenza di pubblicazioni su aspetti generali del project
management, che toccano le principali metodologie e alle volte aggiungono qualche contenuto
organizzativo, tipicamente sulla gestione dei team; una buona presenza di approfondimenti su aspetti
metodologici o organizzativi particolari, come la leadership nei progetti; qualche verticalizzazione su specifici
settori, come i sistemi informativi o le costruzioni; qualche approfondimento su discipline affini al project
management come il project portfolio management, il program management o la gestione multi progetto.
Già da questa breve recensione si possono notare delle aree non ben coperte ma la cosa più peculiare, e
forse preoccupante, è che la quasi totalità delle pubblicazioni e dei ragionamenti sul project management si
rivolgono direttamente ed esclusivamente al project manager. A questa ‘legge’ si sottraggono solo
pochissime eccezioni, che prendono in considerazione anche i comportamenti che gli executive dovrebbero
adottare nella gestione dei progetti mentre il team è sempre proposto con una visione top down: il project
manager deve selezionare il team, lo deve coordinare, lo deve motivare, deve gestirne eventuali conflitti etc.
Intendiamoci bene, ci sono tantissimi contenuti di qualità ma se si guarda la disciplina con gli occhi di chi
semplicemente collabora ai progetti, magari con molto impegno ma senza esserne il coordinatore, la
situazione è un po’ desolante. Nessuno, infatti, ha mai affrontato il tema del project management prendendo
45
Management
in considerazione le conoscenze che dovrebbe avere ed i comportamenti che dovrebbe adottare un
collaboratore che partecipa ad un progetto come team member. Ecco allora l’idea di leggere il project
management con una visione bottom up, al fine di offrire ai collaboratori le conoscenze utili per partecipare
con soddisfazione ai progetti. In effetti, quello che si è notato fino ad oggi è che troppo spesso i progetti
vengono subiti dalle persone. Non si tratta tanto del fatto che la nascita del progetto non sia
compartecipata, ma quanto del fatto che molte persone si sentono spaesate in quanto digiune delle
conoscenze che permettono loro di leggerne e comprenderne le dinamiche e quindi di esserne
maggiormente coinvolte e consapevoli. Ecco allora che durante le riunioni di progetto si pongono domande
fuori luogo che ne fanno aumentare il tasso di conflittualità e che ne minano la futura partecipazione, che il
kick off meeting viene vissuto come perdita di tempo o semplicemente come occasione di mangiare
qualche panino gratis, che le riunioni di pianificazione si trasformano in riunioni tecniche dove ognuno parla
una lingua incomprensibile agli altri, con reciproca insoddisfazione.
La reinterpretazione del progetto in logica bottom up cerca quindi di rispondere a queste problematiche
dando gli strumenti corretti in funzione del ruolo di partecipante e non di coordinatore o responsabile di
progetto. In linea con la nascente disciplina organizzativa della followership, complementare alla più famosa
leadership, questo nuovo approccio al project management prende il nome project followership. La parola
followership non deve essere letta negativamente, come inferiore e succube del concetto di leadership ma
sottolinea invece la necessità di aumentare la consapevolezza del proprio ruolo in modo da promuovere una
piena integrazione con la funzione di leadership affidata al project manager.
L’Autore
Marco Sampietro è SDA Bocconi professor di Sistemi informativi.
Aree di interesse scientifico
Project Management. Impatto dello humor sulla gestione progetti. Process Management.
Internazionalizzazione dei sistemi informativi. Adozione e management dei sistemi informativi.
Da Bocconi Newsletter no. 108/2011
46
Management
Il consumatore che non si gode l’esperienza
di Antonella Carù e Bernard Cova
Sempre più imprese nel fare marketing offrono al consumatore
l’opportunità di vivere esperienze ed emozioni. Ma per i docenti
Bocconi Antonella Carù (Economia e gestione delle imprese) e
Bernard Cova (Marketing), il rischio che le persone si sentano
spaesate è forte, e va evitato.
Il marketing esperienziale ha dedicato molta attenzione a come creare esperienze di consumo straordinarie
per i consumatori. L’idea è che le imprese per differenziarsi debbano evolvere dalla produzione di beni e
servizi verso la creazione di esperienze eccezionali, indimenticabili. E di questo le imprese appaiono essere via
via più consapevoli, con un’attenzione sempre più evidente alla creazione di stimoli sensoriali ed emozionali (si
pensi a eventi, siti web, temporary store). Ciò che è trascurato, invece, è che a volte questi contesti non
generano nei consumatori l’esperienza eccezionale che si era immaginata. La ragione è che per vivere
esperienze servono competenze da parte del consumatore: non si tratta di comprenderne i bisogni, ma di
capire e lavorare con le competenze da questo possedute.
Abbiamo svolto una ricerca in un ambito particolare, quello artistico, che per sua natura è considerato
esperienziale, e i risultati emersi sono interessanti anche con riferimento ai contesti di mercato tradizionali. Si
tratta della mostra organizzata a Milano alla Triennale nel 2008, “Anni ’70: il decennio lungo del secolo breve”,
strutturata proprio per consentire al pubblico di fare esperienza di quegli anni, come dichiarato nelle
presentazione del curatore, indipendentemente dall’averli vissuti direttamente.
La mostra presentava più di 20 sale dedicate a vari temi legati agli anni Settanta. Nella ricerca emerge
chiaramente come le persone che possedevano conoscenze e riferimenti relativi a quegli anni (tipicamente
di mezza età che li hanno vissuti) sono riuscite a immergersi totalmente nel contesto, le altre (in particolare
giovani, che ne hanno sentito parlare ma avevano una conoscenza limitata di quegli anni) hanno avuto
difficoltà in tal senso, manifestando una sensazione di “spaesamento” e di “non comprensione”: la
mancanza, o meglio l’insufficienza, di riferimenti ha impedito loro di vivere pienamente l’esperienza. In
particolare, tutte le persone riconoscevano alcuni elementi che riuscivano a legare agli anni ’70 (quali, ad
esempio, la stanza che raffigurava la cella della prigionia di Moro, l’area dedicata a Fiorucci), ma i più
giovani riuscivano ad identificarne troppo pochi per cogliere il filo rosso della mostra e la natura di quegli anni.
47
Management
In generale, la condizione necessaria affinché le persone riescano ad accedere alle esperienze pensate per
loro è dunque è il possesso di competenze, tema che spesso è dato per scontato o che non riceve adeguata
attenzione da parte delle imprese. Le competenze dei consumatori, considerate elemento di impedimento o
di facilitazione dell’esperienza, richiedono un approccio ad hoc, così come accade per l’analisi dei bisogni.
Per questo è possibile prevedere un processo che guidi le imprese nel percorso di gestione della relazione con
il cliente basata sulle competenze. Il primo step è dato dall’identificazione delle conoscenze del cliente: la
cosa importante è che l’analisi sia fatta adottando gli schemi mentali dei clienti, non dell’impresa. In questo
senso sono utili gli approcci basati sull’analisi etnografica e sull’ascolto dei consumatori.
È poi necessario capire come mobilizzare le competenze dei consumatori, come fare in modo che queste
competenze siano usate dalle persone nel percorso esperienziale: proporre riferimenti comprensibili e
appartenenti al vissuto delle persone, decodificare elementi simbolici.
Da ultimo, se le competenze possedute non sono adeguate per accedere all’esperienza, è necessario farsi
carico del loro incremento, utilizzando riferimenti e linguaggi che i consumatori conoscano e strumenti di
facilitazione adeguati (come le app su Iphone).
Il riferimento alle competenze del consumatore può andare anche oltre: le aziende sempre più spesso usano
tali conoscenze nei propri processi, non solo di innovazione di prodotto (come nel caso di My Starbucks
Ideas.com), ma anche di marketing in generale. Alfa Romeo, ad esempio, ha creato una piattaforma su cui
gli alfisti potessero interagire per creare l’evento celebrativo del centenario della marca, che si è svolto il 26 e
27 giugno 2010 a Milano.
Gli Autori
Antonella Carù è ordinario di Marketing presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Marketing e management dei servizi. Consumption experience and experiential marketing. Marketing delle
istituzioni artistiche e culturali. Performance di marketing.
Bernard Cova è visiting professor presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 108/2011
48
Management
Umani che non sbaglino
di Elisabetta Trinchero
In sanità il rischio di errore umano è aumentato dalla
complessità sia delle situazioni operative sia delle tecnologie
utilizzate. Il Piano Sanitario Nazionale mette ora la sicurezza del
paziente tra le priorità, come spiega Elisabetta Trinchero,
docente SDA dell’Area Public Management and Policy.
Trapianto di organi Hiv positivi, scoppio di camera iperbarica, asportazione di rene sano: sono eventi noti
accaduti negli ultimi anni in ospedali italiani che hanno provocato danni permanenti o la morte ai pazienti
coinvolti. Situazioni problematiche ed errori si verificano in molti settori ‘ad alto rischio’ quando la fallibilità
umana interagisce con tecnologie complesse in condizioni di elevata complessità operativa. Il management
della sicurezza, finalizzata alla riduzione e al governo dei rischi e malfunzionamenti, diviene in questi casi una
variabile determinante per il successo dell’azienda.
La sanità è a pieno titolo annoverata tra le “high risk industries” e il management ospedaliero è in questi ultimi
anni sollecitato a migliorarne l’affidabilità per i pazienti, per gli operatori e per la società. A richiamare
l’attenzione sulla rilevanza del fenomeno è stato nel 2000 il rapporto dell’Institute of Medicine “To Err Is Human:
Building a Safer Health System”; da allora sono stati condotti numerosi studi e sperimentazioni a livello italiano
e internazionale, che hanno contribuito allo sviluppo di modelli di governo della sicurezza (safety) in ambito
sanitario.
Il tema della safety costituisce in questo momento una priorità per la governance anche del sistema sanitario
italiano. La bozza provvisoria del Piano Sanitario Nazionale 2011-13 inserisce la promozione della sicurezza del
paziente e la gestione del rischio clinico tra le linee prioritarie di sviluppo del sistema di clinical governance.
Spetta poi alle regioni italiane orientare i sistemi e le strutture per la gestione della sicurezza e del rischio delle
aziende sanitarie del proprio territorio, correlandoli ai sistemi di valutazione e certificazione della qualità. Oltre
al rischio clinico, che impatta sulla sicurezza del paziente, le aziende sanitarie sono chiamate a presidiare
diverse aree di rischio (operativo, patrimoniale, finanziario), dai confini non sempre ben delineati e spesso
sovrapposti e dalle responsabilità in molti casi frammentate.
49
Management
Per un efficace governo a livello aziendale della dimensione della sicurezza è dunque necessario rafforzare
cultura e meccanismi operativi di management. A tale scopo le azioni intraprese per la gestione dei rischi
dovrebbero essere integrate (e non separate) dai processi di planning delle attività. Il tema del
coordinamento può essere critico anche per la governance regionale, ove spesso i diversi ambiti di rischio
riscontrabili nelle aziende sanitarie sono presidiati in modo verticale da diversi organi e funzioni. Inoltre il tema
della sicurezza dovrebbe essere percepito come un problema di tutti e non solo responsabilità di alcuni: è
fondamentale che il top management si impegni nel difficile compito di creare nell’azienda sanitaria una
cultura della sicurezza pervasiva, che permetta di individuare i punti di debolezza nei comportamenti, nelle
attitudini e nelle pratiche degli operatori. Infine, la progettazione di processi sicuri richiede la conoscenza delle
fonti di errore: questo è possibile attraverso l’analisi prospettica delle diverse aree di rischio potenziale, ma
soprattutto attraverso l’analisi retrospettiva degli eventi o dei quasi eventi che si sono verificati nel recente
passato. Risulta evidente come le metodologie di analisi dell’errore che verificano retrospettivamente l’attività
clinica, possano essere utilizzate solamente in quelle realtà sanitarie in cui la documentazione clinica e
amministrativa siano compilate e archiviate secondo standard qualitativi accettabili (previsti dai sistemi di
accreditamento).
Inoltre, flussi informativi altrettanto rilevanti ai fini dell’analisi sono quelli relativi alle diverse dimensioni del
contenzioso, come il numero e l’entità delle cause in essere e il valore dei risarcimenti richiesti e liquidati.
L’Autore
Elisabetta Trinchero è SDA Bocconi professor di Public Management and Policy.
Aree di interesse scientifico
Analisi dei problemi logici, metodologici e tecnici nel processo di progettazione e di introduzione di sistemi di
internal auditing nelle aziende sanitarie. Analisi dei sistemi di misurazione, rilevazione e gestione dei rischi
sanitari a livello ospedaliero e territoriale e valutazione dell’impatto economico. Studio di modalità di gestione
dell’assistenza e di integrazione tra le diverse figure professionali. Analisi degli strumenti e dei processi di
rendicontazione esterna delle aziende sanitarie.
Da Bocconi Newsletter no. 109/2011
50
Management
Cinque regole per trasmettere l’imprenditorialità
di Carlo Salvato
Come trasmettere l’imprenditorialità alle nuove generazioni?
Ecco cinque fattori chiave, che emergono dal progetto di
ricerca internazionale STEP, promosso dalla cattedra AIdAF
Bocconi. Li spiega Carlo Salvato, docente del Dipartimento di
Management e tecnologia Bocconi.
La capacità di rinnovamento imprenditoriale attraverso l’introduzione di nuovi prodotti, processi e mercati è
essenziale ai fini del successo e della sopravvivenza nel tempo delle imprese. La trasmissione
dell’imprenditorialità alle giovani generazioni deve quindi essere una priorità per le aziende familiari. Il ruolo
più importante a tal fine è svolto dalla famiglia controllante. Essa può incoraggiare o scoraggiare il
perseguimento di attività imprenditoriali da parte dei suoi membri più giovani in diversi modi. Lo studio di
decine di casi nell’ambito del progetto di ricerca internazionale STEP, di cui l’Università Bocconi è uno dei
fondatori attraverso la Cattedra AIdAF-Alberto Falck, evidenzia almeno cinque fattori-chiave.
Innanzitutto, l’educazione al business e alla vita. Gli imprenditori innovativi sono caratterizzati da personalità e
competenze articolate. Tali caratteristiche personali possono svilupparsi solo nel tempo, attraverso
l’esposizione a numerose e sfaccettate esperienze di vita, oltre che d’impresa. Contrariamente a quanto
avveniva nel passato, le famiglie imprenditoriali oggi comprendono che il training ‘on-the-job’ è solo uno dei
tanti elementi che devono costituire il background di un imprenditore di successo. Di conseguenza, è
essenziale che ai membri delle giovani generazioni vengano offerte, nel rispetto dei talenti e degli interessi di
ciascuno, opportunità di studio ed esperienze personali e di lavoro che ne arricchiscano il profilo umano,
prima che professionale.
In secondo luogo, il rispetto delle regole, dei ruoli e delle responsabilità. Le famiglie imprenditoriali di successo
comunicano con grande chiarezza ai propri membri le regole di comportamento. Il ruolo della famiglia nel
business e le relative responsabilità sono quindi ben comprese, seguite e monitorate da tutti. Quando i giovani
iniziano a lavorare nell’impresa di famiglia dispongono quindi di un fondamento di regole condivise sulle quali
costruiscono la fiducia e la comunicazione aperta necessarie affinché sboccino iniziative imprenditoriali.
51
Management
Terzo, il rispetto delle differenze tra membri della famiglia. Le famiglie imprenditoriali di successo
comprendono che non tutti i propri componenti sono uguali. Le differenze in termini di desideri e competenze
sono capite, rispettate e sviluppate. È essenziale comprendere che le abilità dimostratesi critiche nelle fasi
iniziali del ciclo di vita di un’impresa familiare non sono necessariamente quelle essenziali nelle fasi successive.
Vengono quindi fatti continui sforzi per far leva sui talenti, sulle abilità e sugli interessi di ciascun membro della
famiglia, in modo da svilupparne appieno il potenziale e le abilità imprenditoriali.
Quarto, la presenza di modelli da seguire. Le nostre ricerche dimostrano che più della metà degli imprenditori
innovativi ha avuto la possibilità di seguire da vicino il comportamento imprenditoriale di un membro più
anziano della famiglia. Ciò consente di apprendere come applicare i valori chiave dell’integrità, della
coscienziosità, dell’apertura a nuove idee, del ricevere e del condividere, che si dimostrano essenziali ai fini
dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.
Quinto, la pratica delle abilità imprenditoriali. Infine, le famiglie imprenditoriali di successo offrono opportunità
ai propri membri di sviluppare le proprie competenze in tutti gli stadi della vita. Questo avviene, ad esempio,
attraverso la possibilità di mettere in pratica il proprio desiderio di innovazione in ambiti specifici del business di
famiglia. Ma in molti altri casi queste capacità sono sviluppate semplicemente garantendo sufficiente
autonomia e responsabilità nelle multiformi esperienze di vita attraversate dai membri più giovani della
famiglia.
In sintesi, la capacità di trasmettere lo spirito imprenditoriale alle giovani generazioni è compito e
responsabilità delle famiglie di origine. Con il loro atteggiamento e ruolo educativo esse possono sostenere o
ridurre le competenze e i desideri di sviluppo imprenditoriale dei membri delle giovani generazioni.
L’Autore
Carlo Salvato è professore associato presso il Dipartimento di Management e tecnologia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Strategia aziendale. Imprenditorialità interna. Imprese familiari e medie imprese. Imprese nel settore del
design.
Da Bocconi Newsletter no. 110/2011
52
Management
La moda vuole essere mobile. Ma non sfonda
di Gabriella Lojacono e Paola Varacca Capello
Quando la moda cerca di sconfinare nel mondo dell’arredo:
Gabriella Lojacono e Paola Varacca Capello, docenti del
Dipartimento di Management e tecnologia della Bocconi, si
chiedono perché l’arredamento faccia oggi così gola alle
case di moda.
La moda le ha tentate tutte anche quest’anno per emergere durante il Salone del Mobile e guadagnarsi i
suoi spazi a suon di cocktail e comunicati stampa: Hermès lancia il progetto casa, Armani dalle cucine passa
agli armadi, Moroso e Foscarini lavorano con Renzo Rosso (Diesel) per una collezione di mobili. Forse per
compensare l’alea di mistero e l’esclusività delle sfilate, le varie maison hanno partecipato sfavillanti a questa
importante kermesse. Nella lista degli opening cocktail troviamo Ferragamo, Trussardi, Versace e molti altri.
Tutti hanno sperimentato l’ingresso nel settore arredo anche solo con una collezione tessile o mettendo a
disposizione lo showroom per la presentazione di prodotti.
Da un punto di vista manageriale questa è l’occasione per riflettere sul connubio, più volte proclamato, tra
moda e arredamento. Purtroppo, non abbiamo dati puntuali per valutare il successo economico e
competitivo di queste iniziative, ma si può esprimere qualche commento qualitativo. Come mai l’arredo fa
così gola? E come mai non è avvenuto il contrario, ossia che il sistema arredo abbia deciso di occuparsi
anche di moda?
Nonostante il successo mediatico delle numerose iniziative di collaborazione, restano perplessità sull’effettiva
consistenza di questi progetti. Eccellenti operazioni di comunicazione, ma non sappiamo fino a che punto
brillanti idee di business.
Una prima considerazione attiene all’oggetto di questa sperimentazione che può essere connotato da diversi
gradi di complessità. Un conto è creare qualche particolare tessuto, proporre qualche linea di biancheria,
firmare casalinghi o oggetti per la casa, altra cosa è proporre elementi di arredo come armadi e cucine. Per
non parlare poi di chi lancia il “total look”, che il consumatore già respinge nel vestirsi. Il tema in discussione è
fino a che punto il consumatore, sempre più refrattario a proposte totalizzanti e preconfezionate, desideri
53
Management
legarsi per tempi lunghi (dettati dalla durabilità del prodotto) a salotti e camere con un total look fortemente
identificato, rinunciando a mescolare e personalizzare l’arredo con pezzi di varia provenienza.
Se è vero che la complessità produttiva può essere esternalizzata, la gestione della distribuzione è forse
l’elemento più problematico. Dove vendere questi prodotti che necessitano spesso di competenze distintive
forti? Come avere spazio in una distribuzione matura e satura? E ha una ratio economica ovviare al problema
investendo in negozi monomarca? Pensiamo di no, anche perché dobbiamo ricordarci che rotazioni e prezzi
unitari sono notevolmente diversi.
Il mondo dell’arredo in generale ha sempre lavorato con designer “industriali”, seguendo modalità operative
piuttosto diverse dalla moda. Quest’ultima si caratterizza per l’unicità del riferimento creativo; nell’arredo
invece la relazione con i designer è spesso multipla e non necessariamente continuativa. E proprio questo
arricchisce il valore dell’azienda e della sua produzione.
Le difficoltà legate allo sviluppo sono quindi molteplici, legate agli spazi di mercato comunque ristretti, in
comparti già affollati da produttori e marche specializzate. Ovviamente gli ostacoli legati alle specificità dei
singoli business possono essere superati con l’individuazione di un partner industriale ad hoc, ne è un esempio
la collaborazione tra Armani e Dada per le cucine.
Una particolare opportunità si individua inoltre in quelle esperienze dove la collaborazione o l’unione tra i due
mondi sfrutta le competenze di base dell’azienda. E qui un insegnamento è rintracciabile più nell’arredo che
nella moda. Kartell ha lanciato le sue Glue Cinderella (ballerine), Lady (calzature con la zeppa) e Sofia (stivali
da pioggia), non tanto per diventare una fashion house, ma per sfruttare ulteriormente, in questo caso
guadagnando, le sue consolidate competenze tecnologiche nella lavorazione delle materie plastiche. Un
prodotto che ha avuto riscontro positivo anche nei tradizionali negozi di calzature e di abbigliamento.
Gli Autori
Gabriella Lojacono è docente del Dipartimento di Management e tecnologia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Strategie di internazionalizzazione. Design Management.
Paola Varacca Capello è docente del Dipartimento di Management e tecnologia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Strategia. Economia aziendale. Settori: moda, design, oreficeria.
Da Bocconi Newsletter no. 110/2011
54
Management
Dove il capo si importa
di Guido Corbetta e Alessandro Minichilli
Aziende familiari: meglio i manager di famiglia o esterni? Per
Guido Corbetta (titolare della cattedra AIdAF Bocconi) e
Alessandro Minichilli (docente Bocconi del Dipartimento di
Management e tecnologia) i manager esterni funzionano
meglio, ma solo nelle imprese più grandi.
L’effetto della leadership familiare rispetto a quella di manager esterni alla famiglia di controllo ha da sempre
costituito oggetto di riflessione a proposito della valutazione dei risultati economici delle aziende familiari, non
solo in ambito accademico, ma anche e soprattutto da parte degli imprenditori. Si ritiene infatti che la scelta
di un leader aziendale familiare rispetto a quella di un manager esterno possa avere notevoli conseguenze
sulla gestione aziendale per via del diverso bagaglio di competenze, esperienze, valori e priorità di cui
manager familiari e non familiari sono rispettivamente portatori. Per questi motivi, dunque, c’è ampia
convergenza nel considerare tale scelta come una delle decisioni più importanti che le famiglie
imprenditoriali si trovano ad affrontare.
Sia la teoria che la pratica hanno mostrato incertezze nel definire la superiorità della leadership familiare (o
non familiare). Al fianco di studi e ricerche che esaltano la guida di un leader familiare, ve ne sono altrettanti
che esprimono dubbi sulla bontà di tale scelta. Mentre i primi sono spiegati soprattutto dalla naturale
convergenza di interessi dei leader familiari con quelli delle aziende da loro controllate, i secondi dimostrano
come la sovrapposizione tra controllo e gestione familiare determini le precondizioni per fenomeni di
nepotismo ed espropriazione a danno dell’azienda.
Tale controversia sembra essere motivata dall’incapacità di tenere in dovuta considerazione la varietà di
aziende familiari. La tendenza a generalizzare i risultati delle ricerche, infatti, ha portato a considerare alla
stessa stregua aziende familiari grandi e piccole, e con proprietà familiare molto concentrata o
maggiormente frazionata, circostanze che richiedono profili manageriali e capacità di relazionarsi con la
compagine proprietaria radicalmente diversi.
Nel tentare di dirimere tale controversia, un nostro recente working paper (“Is family leadership always
beneficial?”, con Danny Miller di HEC Montreal), mostra come sia proprio la varietà delle aziende familiari a
55
Management
determinare quanto un particolare contesto sia favorevole o meno alla leadership familiare. Facendo leva
sull’ampiezza dei tipi di aziende censite dall’Osservatorio AUB (AIdAF-Unicredit-Bocconi) su tutte le circa 2.500
aziende a controllo familiare di dimensioni medie e grandi del nostro paese tracciate per dieci anni (20002009), lo studio mostra come la leadership familiare produca risultati addirittura opposti in aziende con
caratteristiche diverse in termini di dimensione aziendale e diffusione della proprietà.
In particolare, mentre i leader familiari sembrano apportare notevoli benefici in termini di redditività operativa
(misurata con il Roa) nelle aziende di minori dimensioni e con proprietà fortemente concentrata, spesso nelle
mani di una sola persona o di una famiglia imprenditoriale molto ristretta e coesa, nelle aziende più grandi e
con proprietà maggiormente frazionata accade il contrario.
Esistono diverse motivazioni che possono spiegare tali risultati. Nelle aziende più piccole e con proprietà molto
concentrata, infatti, i leader familiari godono dei vantaggi legati alla conoscenza tacita del business, alla
coesione della compagine proprietaria e a una profonda identificazione con la cultura aziendale che
sarebbe più difficile per manager esterni. Al contrario, nelle aziende più grandi e con proprietà composita, la
complessità gestionale rende le abilità manageriali più importanti della conoscenza tacita del business;
inoltre, il maggiore frazionamento della proprietà fa sì che il leader familiare finisca per rappresentare un ramo
familiare o una fazione, creando tensioni difficili da gestire. In questi contesti, una leadership esterna alla
famiglia sembrerebbe avere il duplice vantaggio di apportare le competenze manageriali richieste e di
mediare in modo più efficace tra possibili conflitti proprietari.
Gli Autori
Guido Corbetta è titolare della cattedra Aidaf-Alberto Falck di Strategia delle aziende familiari alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Strategia aziendale. Imprese familiari e medie imprese. Imprese nei settori moda e design.
Alessandro Minichilli è assistant professor presso il Dipartimento di Management e tecnologia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Corporate governance. Top management teams nei diversi tipi di imprese. Corporate elites, profili di carriera
dei CEO e leadership. Meccanismi di governo e gestione delle imprese a controllo familiare.
Da Bocconi Newsletter no. 111/2011
56
Management
Quanto è cara la buonuscita
di Arnaldo Camuffo
5,6 milioni di euro: questo il valore medio delle buonuscite degli
Ad di società FTSE/MIB che emerge da uno studio Bocconi. Per
adeguarsi alle nuove normative servono sobrietà e
trasparenza, spiega Arnaldo Camuffo, docente Bocconi di
Organizzazione aziendale.
L’eco della notizia che meno di un anno alla guida di Generali ha fruttato a Cesare Geronzi una buonuscita
da 16,65 milioni di euro si è già spento. Si tratta, però, solo dell’ultimo di una lista di casi che, anche in Italia,
hanno reso i severance packages la componente più controversa del pacchetto retributivo di amministratori
esecutivi e top manager.
Come è noto, le cosiddette “buonuscite” sono componenti retributive differite previste da clausole
contrattuali individuali con le quali l’azienda si impegna a versare una somma di denaro in caso di
interruzione del rapporto di lavoro o di collaborazione. Fino a un recente passato, tali clausole erano di fatto
inderogabili e la buonuscita era dovuta anche se un top manager aveva mal operato e era rimosso o si
dimetteva dall’incarico, ovvero anche se i risultati aziendali erano negativi. È proprio questo diritto
incondizionato a ricevere consistenti somme di denaro indipendentemente da come si concluda il rapporto
di lavoro e dalla performance aziendale ad aver reso sgradita ad azionisti e opinione pubblica questa
componente retributiva. In tal senso si sono mossi, a livello europeo e nazionale, gli enti regolatori. Negli ultimi
anni anche l’impianto normativo italiano si è adeguato, prevedendo alcune norme per le società quotate. In
sostanza, le novità introdotte si concretano in tre aspetti: limiti massimi in termini di multipli del base salary; la
possibilità/necessità di prevedere clausole di claw-back (di sospensione dell’erogazione o di richieste di
restituzione delle somme erogate a fronte di performance aziendali, anche ex post, negative); una maggiore
trasparenza informativa sulla natura, l’entità e le clausole relative alle buonuscite.
Anche se tali innovazioni andranno a regime nel 2012, sorge spontanea la domanda se e come le società
quotate si stiano adeguando alle nuove norme. Una ricerca del Dipartimento di Management e Tecnologia
Bocconi sulle buonuscite degli amministratori delegati delle società afferenti al FTSE/MIB per il decennio 20002009, fornisce dati interessanti. Nel campione esaminato si sono verificati 24 casi di erogazione di severance
packages. Quasi la metà dei casi si riferiscono a società appartenenti al settore bancario assicurativo. Il
57
Management
valore medio delle buonuscite è di 5,6 milioni di euro. Le direttive europee fissano in 2 annualità di base salary
l’ammontare massimo delle buonuscite e la normativa italiana ha recepito questo vincolo fornendo (art.7
Codice di Autodisciplina) un’indicazione generica di ammontare massimo determinato come numero di
multipli del base salary. La ricerca ha calcolato l’ammontare delle buonuscite nel decennio in termini di
multipli del base salary, per verificare quanto siano distanti le pratiche delle imprese italiane dalle nuove
direttive. Ebbene, il calcolo è stato possibile solo per 19 casi su 24, e di questi 19 solo 4 (21%) sarebbero in linea
con il limite di 2 annualità. Con riguardo al tema delle clausole di claw-back, ovvero di correlazione tra
corresponsione delle buonuscite e performance aziendali, la ricerca mostra che nessuna società del FTSE-MIB
le prevede e che nel 20% dei casi la buonuscita è stata erogata anche a fronte di risultati negativi.
Lo studio evidenzia che, sebbene non si siano verificati gli eccessi che hanno caratterizzato i severance
packages degli executives di altri Paesi, tuttavia è evidente che le pratiche attuali devono essere adeguate
lungo tre direttrici: maggiore sobrietà; maggiore correlazione ai risultati aziendali anche di lungo periodo;
maggiore trasparenza informativa.
Sulla trasparenza informativa, i risultati mostrano che, in molti casi, l’ammontare delle buonuscite non è
predeterminato e non è parte integrante della politica retributiva che dovrebbe essere messa a punto dai
compensation committees. Le informazioni nei bilanci sono scarse e non standardizzate, e, sebbene le società
adottino il medesimo prospetto informativo, solo in alcuni casi la voce relativa alla buonuscita è scomposta
nelle sue componenti, indicando ad esempio, la quota di tfr o gli eventuali istituti accessori (premio operosità,
patto di non concorrenza). Nè le Relazioni sulla corporate governance sono di grande aiuto: nel 2009 solo 10
società su 40 hanno incluso informazioni relative a indennità previste per l’amministratore delegato in caso di
cessazione anticipata del rapporto di lavoro, indicando i criteri utilizzati per calcolarne l’ammontare. I golden
handshakes non sono buoni o cattivi di per sé, ma vanno utilizzati in modo appropriato. Non vanno concepiti
come surrogati di incentivi a lungo o breve o, peggio ancora, come emolumenti addizionali slegati da ogni
logica. Possono invece essere utili in due casi: quando si voglia evitare e/o rendere certi i costi di contenziosi
nel caso di interruzioni del rapporto di lavoro o di amministrazione o quando si vogliono evitare
comportamenti non allineati con l’interesse della Società da parte di amministratori e top manager che si
sentono minacciati nella propria posizione in caso di takeovers (M&As). Si tratta di due aspetti importanti al
fine di garantire processi rapidi di turnover imprenditoriale e manageriale.
L’Autore
Arnaldo Camuffo è professore ordinario di Organizzazione aziendale alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Lean production. Modularità. Architetture organizzative. Gestione delle risorse umane. Sistemi retributivi.
Formazione. Knowledge management. Modelli di competenze.
Da Bocconi Newsletter no. 113/2011
58
Management
Il lusso piace di più se è responsabile
di Erica Corbellini e Elisabetta Marafioti
Aspetti come l’etica, il rispetto dell’ambiente e la creazione di
valore per gli stakeholder sono sempre più importanti per
l’identità di una marca. Per Erica Corbellini ed Elisabetta
Marafioti, docenti Mafed Bocconi, la strada della Csr porta al
successo anche in tempi di crisi.
Negli anni del lusso ‘democratico’ (legato a prodotti di larga distribuzione) le imprese del sistema moda
hanno mirato quasi esclusivamente al successo reddituale, con lo sfruttamento crescente del marchio per
raggiungere i nuovi clienti dei mercati emergenti e i quelli desiderosi di diventarlo dei mercati maturi (cd.
‘aspirazionali’). Di conseguenza è cresciuta la spesa in comunicazione, è aumentato il numero di punti
vendita controllati direttamente (e dei costi fissi ad essi collegati), l’offerta è proliferata, con più collezioni,
linee, prodotti.
Tuttavia, all’aumentare della componente immateriale della marca, hanno fatto da contraltare una
banalizzazione e un impoverimento degli attributi intrinseci di prodotto. Da qui la crescente pressione alla
delocalizzazione delle attività produttive, a relazioni poco corrette con i propri fornitori, a una perdita di
significato del valore reale del sistema d’offerta in quanto non percepito dal cliente trade e dal consumatore
finale, fenomeni accentuati dal controllo della finanza di molti marchi e da una visione a breve termine del
successo di impresa da parte dei manager che si sono sostituiti agli imprenditori.
La recessione economica ha però agito da catalizzatore: per continuare ad attirare clienti, con l’opzione
degli outlet o anche quella di non comprare affatto, i marchi sono stati costretti a proporre nuovi significati su
cui creare ‘reason why’ innovative ed emozionali come l’etica, l’ecologia e l’esperienza. I nuovi clienti ‘valuedriven’ hanno cominciato a chiedere non solo contenuti forti di prodotto che giustifichino il prezzo ma anche
un valore della proposta aziendale nel suo complesso. Questa nuova sensibilità ha premiato quelle aziende
della moda che hanno deciso di costruire l’identità di marca in maniera diversa, allargando la prospettiva
dalla mera gestione del business per generare profitto, alla gestione dell’azienda e del rapporto con tutti i suoi
interlocutori. Per queste imprese la corporate social responsibility va oltre approccio interno alla gestione
dell’impresa ed è ben più di un elemento di marketing istituzionale. È una strategia concreta e credibile di
59
Management
posizionamento intorno ai concetti di etica, rispetto dell’ambiente e creazione di valore per tutti gli
stakeholder.
Un esempio di tale impostazione è il caso di Brunello Cucinelli, azienda leader per il cachemire di qualità
made in Italy. L’imprenditore umbro ha messo al centro della gestione aziendale i dipendenti e, nella
convinzione che la cultura sia centrale per la produzione di cose belle, ha restaurato il borgo medioevale in
cui ha sede l’azienda dotandolo anche di un teatro. Il concetto di ‘impresa umanistica’, come definita da
Cucinelli, si esprime in un modello economico che prevede che un terzo del profitto sia destinato ai lavoratori
(che ricevono stipendi superiori alla media di settore), un terzo al territorio e un terzo alla remunerazione
dell’investimento dell’imprenditore. Il risultato di tale impostazione è stato un successo di mercato che ha visto
l’azienda crescere anche durante gli anni della crisi. L’aumento reddituale è andato di pari passo con
l’accrescimento della reputazione.
Essere un’azienda socialmente responsabile significa, quindi, porsi il problema della sostenibilità della propria
value proposition nei confronti delle persone e dell’ambiente, non essere un filantropo. Il buon cittadino, prima
di pensare alla beneficenza, si preoccupa del rispetto dei consumatori, che significa offrire loro un prodotto a
prezzo rapportabile alla qualità, che non è solo costo industriale ma anche design. Fa parte dell’essere un
bravo cittadino anche non imporre ai clienti trade dei minimi di acquisto, così come evitare il “ricatto” alle
riviste togliendo la pubblicità se non si mette il prodotto nel redazionale. La Csr diventa allora un approccio
olistico che porta l’azienda a comportarsi in modo socialmente responsabile a 360 gradi con sistematicità e
credibilità. Ed è proprio facendo leva su questa impostazione che la Brunello Cucinelli si quoterà nel 2012.
Gli Autori
Erica Corbellini è SDA Bocconi professor di Strategia e imprenditorialità e docente del Mafed, il Master in
Fashion, Experience and Design Management della SDA Bocconi School of Management.
Aree di interesse scientifico
Strategie di branding e comunicazione nei settori moda, accessori e cosmetica. Il lusso: concetti, mercati,
clienti. Valore e sostenibilità del Made in Italy.
Elisabetta Marafioti è SDA Bocconi professor di Strategia e imprenditorialità e docente del Mafed, il Master in
Fashion, Experience and Design Management della SDA Bocconi School of Management.
Aree di interesse scientifico
Alleanze strategiche e acquisizioni. Strategie di internazionalizzazione. Mercati emergenti. Creazione di valore.
Modellazione di sistemi. Settori del trasporto aereo e moda.
Da Bocconi Newsletter no. 114/2011
60
Management
Chi dorme sul web non piglia nuovi clienti
di Francesca Romana Rinaldi
Secondo una ricerca Bocconi, ben il 40% delle aziende della
moda e del lusso sfrutta poco e male Internet e i social media.
Eppure un buon uso del web 3.0 può fare davvero la differenza,
spiega Francesca Romana Rinaldi, docente SDA di Strategia e
imprenditorialità.
Tra i paradossi che le aziende del lusso stanno cercando di risolvere ve ne è uno particolarmente attuale:
come preservare i codici aspirazionali della comunicazione attraverso i social media, strumenti democratici
per definizione?
Vuole rispondere al quesito il “Social Media Fashion Monitor”, osservatorio sviluppato dal febbraio 2011
all’interno del Mafed, Master in fashion, experience & design management della SDA Bocconi su un
campione di oltre cento aziende della moda e del lusso. Fanno parte del campione quelle aziende con
fatturato superiore ai 10 milioni di euro, che sono presenti a Milano con una boutique monomarca nel
quadrilatero della moda o hanno un corner alla Rinascente-Duomo, differenti per posizionamento e modello
di business. Questa varietà ha reso possibile confrontare il diverso modo di comunicare attraverso i social
media di marchi come Hermes o Armani (luxury e fashion), Diesel e Miss Sixty (premium), Zara ed H&M (mass).
L’osservatorio si propone poi di classificare le aziende a seconda del grado di avanzamento digitale da Web
0.0 (minimo) a Web 3.0 (massimo).
Tra i primi risultati, sorprende che il 40% circa delle aziende del campione sia ancora nel Web 0.0 e Web 1.0,
rispettivamente senza alcuna piattaforma o con un’unica piattaforma social. La maggior parte delle aziende
del lusso monitorate è nel Web 2.0-basic, con almeno una piattaforma social, linguaggio web-oriented ma
basso livello di interazione con i fan. Nel Web 2.0-advanced troviamo aziende come Louis Vuitton e Tommy
Hilfigher che propongono sfilate virtuali e garantiscono un livello di interazione più elevato con i fan. L’ultimo
livello (Web 3.0) è caratterizzato dal massimo livello di interazione con i fan, efficacia dell’info-commerce e
personalizzazione dei servizi di e-tailing attraverso i social media. È il caso di aziende come Gucci e Burberry,
rappresentative di una percentuale minima del campione (5%).
61
Management
Dallo studio emerge che attraverso gli strumenti social le aziende del lusso possono differenziarsi su tre diversi
livelli: contenuti, linguaggio e servizi.
I contenuti devono garantire un’apertura sull’azienda, sul lavoro dei creativi, sulla creazione e/o presentazione
delle collezioni, devono essere esclusivi per la piattaforma social e cercare di portare il fan/follower dal
mondo virtuale al mondo fisico (il negozio). A seconda dei casi si potrà proporre una sfilata in diretta web su
Facebook con contenuti speciali dedicati ai fan, come nel caso di Gucci e Louis Vuitton oppure un contest,
ad esempio la caccia al tesoro geolocalizzata di Jimmy Choo a Londra, che coinvolga Facebook, YouTube,
Twitter e FourSquare. I post dell’azienda non dovranno riguardare unicamente i prodotti: l’obiettivo è
coinvolgere e creare una relazione stimolando la comunicazione su vari argomenti potenzialmente
interessanti per il fan/follower.
Il linguaggio deve essere web-oriented, ovvero diretto, informale, intrigante, non autoreferenziale. Tag line e
post in forma di domanda sono la regola d’oro. Per rispondere può bastare anche solo un ‘mi piace’!
Sul piano dei servizi per l’e-tailing i social media offrono numerose possibilità: personal shopper, direct mail di
update sulla disponibilità di un prodotto (magari con possibilità di ritiro offline) e uso della tecnologia sono
alcuni strumenti per lavorare sulla differenziazione.
Nei prossimi anni, nel lusso come nel mass, le aziende dovranno lavorare sul transmedia-storytelling, ovvero la
creazione di una narrazione senza fili ottenuta adattando i concept di comunicazione attraverso i diversi
media, sia offline che online.
Nel corso del suo viaggio, il cliente dovrà sentirsi avvolto da un racconto coerente che percorra tutti i punti di
contatto, dal mobile al negozio.
L’Autore
Francesca Romana Rinaldi è SDA assistant professor di Strategia e imprenditorialità e docente del Mafed, il
master in FASHION, Experience and Design Managament della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Management delle aziende moda (retail management, CSR nella moda). Management dei settori creativi.
Da Bocconi Newsletter no. 115/2011
62
Management
Per un multibusiness forte a fine crisi
di Giorgio Invernizzi
Le aziende diversificate hanno resistito meglio delle altre
durante la crisi. Ma secondo Giorgio Invernizzi, docente di
Strategia e politica aziendale alla Bocconi, il futuro sarà roseo
solo se sapranno unire i propri vantaggi competitivi con quelli
delle imprese monobusiness.
Le aziende multibusiness hanno resistito meglio delle altre durante la crisi, come mostrano indagini svolte sulla
dinamica delle performance economico-finanziarie delle imprese statunitensi negli ultimi quattro anni. Ma il
recuperato vantaggio delle imprese multibusiness, non solo negli Usa, persisterà anche al termine della crisi
che stiamo vivendo? Alcuni sostengono che le imprese diversificate si diffonderanno con successo dopo la
crisi poiché nel periodo 2007-2010 hanno colto opportunità di investimento migliori rispetto alle loro rivali
focalizzate. Questa argomentazione non è però generalizzabile.
In verità i gruppi multibusiness avranno un futuro roseo solo unendo i propri vantaggi con quelli tipici di
un’impresa monobusiness. Come? Coniugando le due logiche di fondo che orientano in modo alternativo le
imprese diversificate: la logica finanziaria e quella sinergica.
La prima mira a combinare la crescita con il mantenimento di un soddisfacente equilibrio finanziario, la
seconda sviluppa la competitività dell’impresa mediante il potenziale sinergico esistente fra diversi business.
La logica finanziaria si è presentata quando il problema della strategia aziendale è stato considerato come
un problema di generazione di valore per gli azionisti. Di conseguenza, il vertice aziendale ha percepito ogni
arena competitiva come un’entità specifica con proprie caratteristiche e ha assegnato la responsabilità della
gestione delle diverse strategie competitive a unità organizzative autonome. I business sono quindi considerati
come titoli azionari nell’ambito di un portafoglio. Nel caso di imprese quotate l’attenzione della logica
finanziaria ricade sul mercato azionario con il rischio di un eccessivo orientamento al breve termine.
All’estremo opposto è la logica sinergica, che concepisce l’azienda come un albero di cui i business sono i
rami. Lo sviluppo, allora, è l’effetto di un continuo accrescimento delle competenze conseguente a una
prioritaria attenzione ai “mercati di approvvigionamento delle conoscenze”.
63
Management
Nell’approccio finanziario gli obiettivi quantitativi prevalgono sui traguardi qualitativi; nell’approccio sinergico
è l’opposto. In quest’ultimo orientamento l’impresa opera in pochi business correlati, frutto di crescita
organica, mentre nella logica finanziaria i business possono essere molti e non correlati, conseguenza di
acquisizioni.
In termini organizzativi l’approccio sinergico ha una struttura funzionale, sistemi di controllo sui comportamenti
dei responsabili di business e intensi meccanismi di coordinamento. L’organizzazione secondo la logica
finanziaria è invece divisionale, con sistemi di controllo sui risultati dei singoli business e sono assenti
meccanismi di coordinamento. Qui le unità centrali sono piccole, svolgono solo attività infrastrutturali (legale,
fiscale) con un mero ruolo di controllo e di allocazione delle risorse finanziarie, mentre le unità centrali della
logica sinergica sono grandi, svolgono attività anche di tipo operativo e di supporto ai business con un ruolo
di facilitatori delle sinergie. Anche le caratteristiche del ceo sono opposte: l’approccio finanziario chiede un
valutatore asettico delle performance finanziarie; la logica sinergica esige un leader con conoscenze nel
settore coinvolto anche emotivamente con i responsabili dei business.
Ma come coniugare nella stessa azienda due logiche che appaiono rivali? Si deve partire dall’unica certezza
sulla strategia nelle imprese multibusiness: la determinante della performance a medio-lungo termine in una
impresa diversificata è la qualità del general management, indipendentemente dal grado di diversificazione.
E la qualità del general management è elevata quando utilizza le due logiche a seconda della caratteristica
del business con cui ha a che fare. Tutto ciò in un’architettura organizzativa che vede nei piani alti i business
gestiti con approccio finanziario e nei piani bassi le attività condotte con approccio sinergico. Solo così,
gestendo questo apparente paradosso, si eviteranno i rischi della logica finanziaria (orientamento al breve
termine, speculazione) e di quella sinergica (deresponsabilizzazione e inefficienza).
L’Autore
Giorgio Invernizzi è ordinario di Strategia e politica aziendale alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Stategia. Strategia economico-finanziaria. Imprenditorialità interna. Corporate Strategy. Strategic
Management Accounting.
Da Bocconi Newsletter no. 117/2011
64
Management
Risultati negativi, guadagni positivi
di Arnaldo Camuffo
Il merito in azienda va premiato, su questo tutti sono
d’accordo. Ma come inserirlo con efficacia nelle logiche
retributive dei manager? Arnaldo Camuffo, docente di
Organizzazione aziendale in Bocconi, porta i casi di alcune
aziende virtuose, da cui trarre almeno cinque lezioni.
Che il merito debba essere premiato in azienda, anche e soprattutto per chi svolge ruoli manageriali, trova
tutti d’accordo. Ma sul come farlo è necessaria qualche riflessione. Nel 2010, un quinto dei ceo delle società
del Ftse Mib ha conseguito incrementi retributivi rispetto al 2009 pur in presenza di peggioramenti nell’utile
netto e tale frazione sale a quasi un terzo se si considera il peggioramento del total shareholder return. Per i
cda di tali società, quelli erano i soldi che i ceo si meritavano (stock option a parte) alla luce dei risultati
aziendali, ma questa situazione non sembra né appropriata nel contesto di crisi, né coerente con i frequenti
richiami al merito. La questione è più generale: chi sono e come e quanto vanno remunerati i manager
meritevoli, ai diversi livelli aziendali?
Sul primo punto, non c’è dubbio che oggi identificare il management meritevole significa misurare i risultati
aziendali in un’ottica ampia di sostenibilità e riconoscere il contributo di ciascun manager alla creazione di
valore per gli stakeholder. Con riguardo al come e quanto, le esperienze più ammirate come Google, Apple,
Nestlè o Walt Disney insegnano che valutare il merito del management in questo contesto più complesso
significa essere esigenti senza fare compromessi, usare moderatamente gli incentivi economici, assumere
esplicitamente la responsabilità dei processi di valutazione, non fermarsi ai risultati una tantum ma verificare se
i processi organizzativi sono in grado di garantirne il raggiungimento anche in futuro, creare una cultura del
merito associandolo all’equità percepita.
Ma come iniettare logiche meritocratiche nei sistemi retributivi del management?
Primo, considerando la retribuzione come un tutt’uno, nel senso che remunera il management per il ruolo che
svolge, le sue competenze e i risultati di breve e lungo periodo. In pratica, però, è invalso l’approccio di
separare il ‘fisso’ dal ‘variabile’. Incoerente con logiche meritocratiche è la situazione in cui, a retribuzioni fisse
65
Management
ampiamente sopra la mediana di mercato si aggiungono bonus semi-fissi legati a obiettivi impegnativi ma
non impossibili, con l’implicazione di aumentare ingiustificatamente le retribuzioni.
Secondo, effettuando confronti con il mercato, ovvero scegliendo un peer group di riferimento per settore,
business model, attrition potenziale in uscita e in entrata. Scegliere male il gruppo di confronto o posizionare
acriticamente il base salary del management sopra la mediana di mercato, al fine generico di favorire la
retention (come si usa dire in azienda), può indurre una spirale ingiustificata di incrementi.
Terzo, rendendo i bonus meno casuali. Includere componenti variabili legate ai risultati nella retribuzione
manageriale (bonus) è funzionale ad allineare gli interessi del management a quelli di azionisti e stakeholder,
rendendolo compartecipe del rischio di impresa. Spesso, però, tali sistemi privilegiano il risultato rispetto al
processo, orientando le azioni del management verso la forzatura di risultati spot e non verso il miglioramento
dei processi per ottenere riscontri solidi nel tempo.
Quarto, è bene valutare le prestazioni del management senza pregiudizi. Spesso tale processo presenta 3
distorsioni: chi valuta si crede esperto e dedica troppa poca attenzione; le valutazioni diventano una
procedura burocratica che dimentica il fine (logica del merito); le valutazioni si concentrano sulla sanzione
del passato e non sulle opportunità di miglioramento per il futuro.
Quinto, si deve verificare la coerenza organizzativa. Riconoscere il merito è un processo complesso: non è
coerente inserire nel modello di leadership aziendale l’orientamento al team e poi mantenere un differenziale
retributivo di 1 a 6 tra l’amministratore delegato e la sua prima linea di manager. Delle due l’una: o il sistema
retributivo è incoerente con il modello di leadership, o il modello di leadership non è caratterizzato da
orientamento al team. Aspetti tecnici, ma che si traducono in credibilità organizzativa.
Oggi il management ha perso parte della propria credibilità, è spesso considerato sovra pagato e
immeritevole. Per modificare questa situazione è necessario che le regole divengano più stringenti, che chi
valuta svolga il proprio lavoro in modo rigoroso, che i criteri e le misure colgano tutti gli aspetti delle
performance aziendali anche di lungo periodo e che esista un senso di comunità e di equità diffuso a tutti i
livelli.
L’Autore
Arnaldo Camuffo è professore ordinario di Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di Management e
tecnologia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Lean production; modularità. Architetture organizzative. Gestione delle risorse umane. Sistemi retributivi.
Formazione. Knowledge management. Modelli di competenze.
Da Bocconi Newsletter no. 118/2011
66
Management
Scelte d’acquisto: tra semplicità e olismo
di Andrea Ordanini
Come si sceglie il prodotto da acquistare? Secondo gli ultimi
approcci di ricerca, il comportamento dei consumatori può
andare in due direzioni: semplicità o complessità. Lo spiega
Andrea Ordanini, docente Bocconi di Economia e gestione
delle imprese.
Cosa succede quando intendiamo acquistare un telefonino, una racchetta da tennis, una bevanda
energetica? A proposito delle scelte d’acquisto, la letteratura di marketing ci spiega che ogni prodotto può
essere visto come un mix di attributi in grado di soddisfare uno o più bisogni, e che il consumatore effettua le
sue scelte valutando tale mix di attributi. Per il telefonino, gli attributi possono essere la qualità dello schermo,
la convenienza, la durata della batteria, il marchio; per la racchetta da tennis, il peso, la tipologia di gioco
che la racchetta consente, i campioni che la usano, etc.
L’approccio più diffuso, nella teoria e nella pratica di marketing, per analizzare il processo di valutazione di un
prodotto è la conjoint analysis. In breve, la conjoint analysis definisce alcune configurazioni di prodotto sulla
base di diversi mix di attributi, e poi sottopone un campione di consumatori a selezionate configurazioni di
prodotto, raccogliendo le loro preferenze su queste. Sebbene importante e diffusa, la conjoint analysis non
riesce sempre a rappresentare il processo di scelta del consumatore e, come ogni approccio analitico, ha
limitazioni ed assunzioni. Recentemente, nuovi approcci di ricerca stanno infatti emergendo per cercare di
rappresentare il più fedelmente possibile i processi di scelta del consumatore, in due diverse direzioni:
maggiore semplicità e maggiore complessità.
In alcuni casi, infatti, i consumatori adottano criteri “non compensatori” nelle loro scelte, vale a dire non
scambiano un attributo per l’altro: ad esempio, non considerano nessun telefonino la cui batteria non duri
almeno 10 ore; oppure considerano attrattiva una bevanda che sponsorizzi un evento sportivo femminile, a
prescindere dagli altri elementi. In sostanza, spesso, i consumatori usano euristiche molto più semplici per
valutare le proprie opzioni d’acquisto, e basate su condizioni necessarie e/o sufficienti.
In altri casi, invece, la situazione di scelta è così complessa e i parametri in gioco così tanti (ad esempio un
pacchetto turistico), che il consumatore non è in grado di identificare e valutare singoli attributi, né sarebbe in
67
Management
grado di valutare 30 o 40 diverse alternative di prodotto in logica conjoint, ma ciò che percepisce, e ciò che
considera, è la congruenza complessiva fra i vari attributi. In questi casi il consumatore valuta “olisticamente”
l’esperienza d’acquisto, e diverse configurazioni di attributi possono risultare equivalenti per l’intenzione
d’acquisto. Nuovi approcci e modelli sono necessari per identificare come il consumatore valuti il grado di
“fitness” fra numerosi elementi di un prodotto.
Su questi due filoni, il dipartimento di marketing, ed il suo centro di ricerca Cermes, stanno attivando vari
progetti di tipo sperimentale, sia di natura “lab” che “field”, per il Marketing Science Institute, e sviluppando
una partnership con Kellogg School of Management per la creazione di un osservatorio globale sul
“Consumer Spending”.
L’Autore
Andrea Ordanini è professore ordinario presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Economia e gestione d'impresa. Vantaggio competitivo e teoria d’impresa. Commercio elettronico e
strategie di e-business. Economia e gestione imprese di servizi.
Da Bocconi Newsletter no. 119/2011
68
Management
Sei ampio o focalizzato?
di Stefano Brusoni
Secondo una ricerca Bocconi-San Raffaele, manager e
imprenditori, per prendere una decisione, attivano parti del
cervello diverse. Ne parla Stefano Brusoni, docente di
Technology and Innovation Management presso l’Eth di Zurigo.
La capacità di lavorare in parallelo, di svolgere diversi compiti contemporaneamente, è spesso indicata
come un tratto di competenza e di successo professionale. La crescente gamma di segnali che riceviamo
attraverso i più svariati mezzi di comunicazione ha reso la discussione sul ‘multitasking’ molto attuale. Di pari
passo sono emerse preoccupazioni relativamente ai problemi derivanti dalla necessità di prestare attenzione
a sempre più cose al tempo stesso. Nel dare attenzione a molte cose, finiamo col prestare scarsa attenzione a
tutto.
Questa discussione ha notevole impatto sia sulla nostra vita quotidiana, sia in quella professionale. Per capire
cosa consente al cervello umano di gestire i livelli di attenzione erogata a diverse attività, di svolgere diversi
compiti in parallelo o di spostare la propria attenzione su attività diverse, un team di ricerca Bocconi-San
Raffaele ha studiato in risonanza magnetica un campione di manager e imprenditori per capire cosa
consente a dei decisori esperti di svolgere molteplici attività in parallelo. L’idea di base è molto semplice: un
manager in un contesto aziendale deve prendere decisioni importanti e di grande impatto, ma all’interno di
una struttura ben definita che consente la specializzazione per aree funzionali, per esempio. Un imprenditore
impegnato nell’avvio della sua impresa deve prestare attenzione a tutto simultaneamente. Possiamo
tracciare queste differenze a livello neurologico?
Per poter rispondere a questa domanda, imprenditori e manager sono stati recentemente sottoposti a una
risonanza magnetica mentre giocavano un semplice ‘gambling task’: dovevano scegliere fra varie ‘slot
machine’ possibili quella da cui ottenevano il punteggio più alto. I punteggi emessi variavano nel tempo e
quindi i partecipanti dovevano decidere se focalizzarsi sulla stessa macchina oppure se esplorare i punteggi
delle altre macchine disponibili. Nel primo caso si parla di ‘exploitative behavior’, cioè focalizzato. Nel
secondo caso si parla di ‘explorative behavior’, cioè volto a cercare nuove soluzioni, attento a varie e diverse
fonti di informazione potenzialmente utili. I primi risultati mostrano forti differenze fra i due gruppi. Cosa non
banale, considerando che i due gruppi sono formati da individui sani, simili per composizione in termini di
69
Management
genere, età e titolo di studio. La carriera professionale sembra quindi un indicatore affidabile di differenze
neuropsicologiche.
Il secondo risultato riguarda le differenze. Che non riguardano tanto la tendenza a essere focalizzati
(exploitation) o ampi (exploration) nel modo di gestire la propria attenzione. Le differenze riguardano i sistemi
neurali attivati, cioè come il cervello si attiva, per prendere lo stesso tipo di decisione. Per decisioni di
esplorazione, per esempio, gli imprenditori attivano maggiormente sistemi neurali connessi con il controllo
dell’attenzione, la resistenza all’appagamento immediato e l’anticipazione di eventi futuri. Questo indica che
gli imprenditori tendono a modificare più efficacemente la gamma di cose a cui prestano attenzione,
“vedendo” le conseguenze ultime delle loro decisioni, rispetto ai manager. Non fanno più cose in parallelo,
ma si spostano da una attività all’altra con maggiore efficienza. Questi risultati, per quanto preliminari, ci
aiutano a capire un tratto fondamentale del comportamento imprenditoriale, con possibili implicazioni anche
per la vita quotidiana, sempre più frammentata da molteplici attività che competono per la nostra
attenzione.
L’Autore
Stefano Brusoni è professore di Technology and Innovation Management presso l’Eth di Zurigo.
Da Bocconi Newsletter no. 119/2011
70
Società
e Cultura
Società e Cultura
Anche la politica fa le bolle
di Fabrizio Pezzani
Non ci sono solo le bolle finanziarie, ma anche quelle politiche:
per Fabrizio Pezzani, docente Bocconi di Amministrazione e
controllo nelle pubbliche amministrazioni, si verificano quando
si scrivono i programmi elettorali con i desideri degli elettori. E
prima o poi sono destinate a scoppiare.
La crisi finanziaria ed economica ha contribuito a diffondere il termine di bolla finanziaria. In realtà questi
eventi si sono sempre manifestati da quando è stato possibile l’investimento in valori mobiliari e immobiliari,
ma l’estensione e il volume delle transazioni finanziarie, oggi, hanno aumentato enormemente il loro numero e
la loro intensità. La formazione delle bolle finanziarie è legata a una componente più emozionale che
razionale dell’animo umano, infatti quando vengono a formarsi condizioni economiche e finanziarie che
alimentano aspettative di crescita dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e immobiliari (prezzi degli immobili) i
risparmiatori sono spinti ad approfittare del momento favorevole per comperare questi titoli e questi beni
contribuendo così a farne aumentare il valore. In questo modo, si viene a formare un processo euforico che si
autoalimenta illudendo tutti che questa condizione positiva non finirà mai e così il mercato comincia a vivere,
sempre più, una sua vita indipendente dalla realtà, la bolla finanziaria. Fino a quando qualcuno comincia a
vendere in modo da invertire la tendenza e così si precipita nella paura e nel caos delle perdite, che rendono
quasi tutti perdenti.
Le bolle, però, per la loro natura emozionale, sono estensibili a tutti quei settori dove l’uomo viene condotto a
decidere da fattori emozionali più che da quelli razionali; la sensibilità a questo tipo di messaggi ha ispirato,
spesso, le campagne di marketing delle imprese orientandole verso un modello di consumismo diffuso.
L’attenzione al consumo di beni e servizi, spesso voluttuari, non è dettato da un bisogno razionale ma
dall’emozione che l’acquisto genera. Questa modalità emozionale dell’acquisto, promossa da una pubblicità
che genera modelli di benessere illusorio, fa stare bene perché aiuta a identificarsi in un’immagine di se stessi
che non corrisponde alla realtà ma ne anestetizza la possibile percezione dolorosa.
Tale modalità di comunicazione si è da tempo estesa alla comunicazione politica, indistintamente per partiti
e per paesi; i politici hanno imparato a fare appello ai desideri degli elettori invece di proporre politiche in cui
credevano. Gli elettori finiscono per scegliere quei candidati che dicono quello che loro desiderano, ma non
73
Società e Cultura
necessariamente la verità, che può essere dolorosa e quindi da evitare. In questo modo, come nelle bolle
finanziarie, il consenso va crescendo su aspettative illusorie ma non realistiche e i due fattori si alimentano a
vicenda. Come nelle bolle finanziarie, però, si corre il rischio che le aspettative promesse possano essere
sempre più lontane dalla realtà e la loro distanza può crescere fino a creare una bolla politica che, prima o
poi, inesorabilmente scoppia, facendo aumentare la distanza tra paese ed istituzioni. Già Tocqueville
rimarcava il rischio di un potere politico che penetrando insensibilmente nell’interiorità degli individui potesse
dirigerne le azioni, orientarne le scelte e indebolirne le volontà.
Il rischio di un evento di questo genere in una fase di grande confusione e incertezza dovrebbe indurre tutti a
una maggiore prudenza nei comportamenti e nelle dichiarazioni, al fine di favorire un dialogo e un confronto
costruttivo. Le risposte a una crisi che ha un risvolto economico immediato ma un’origine più profonda e
lontana, legata a un modello di società che è diventata sempre più individualista e antiegalitaria, vanno
ricercate attuando comportamenti più collaborativi e condivisi al fine di ricomporre le diversità verso un bene
comune non solo dichiarato ma anche realizzato.
L’Autore
Fabrizio Pezzani è professore ordinario di Amministrazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni alla
Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Determinazioni quantitative di natura contabile nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Sistemi di
pianificazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni. Relazioni fra imprese e pubblica amministrazione.
Da Bocconi Newsletter no. 102/2011
74
Società e Cultura
Molto più che uno specchio
di Luca Massimiliano Visconti
Quanto hanno inciso i consumi nel processo di unificazione
sociale dell’Italia? Molto, secondo Luca Massimiliano Visconti,
direttore Mimec, Master in Marketing e comunicazione della
Bocconi, che avverte: se i consumi hanno aiutato a costruire
l’Italia unita, ora possono anche dividerla.
Il concetto di unità nazionale è sempre associato a una buona componente di ideologia, di scelta, di
rappresentazione. Le nazioni non nascono unite, semmai lo diventano. Questa evidenza è spesso
dimenticata, facendoci così perdere di vista quanta volontà serve per costruire nel tempo senso di
appartenenza, motivare l’altruismo e sviluppare una cultura comune.
Anche l’Italia ha costruito la propria unitarietà a partire da azioni e attorno a narrative, che si intersecano sin
dall’inizio con quelle del mercato. I consumi che hanno accompagnato i primi 150 anni della nostra storia
nazionale sono, allo stesso tempo, parte del processo di unificazione e suo specchio. In quanto specchio, la
storia del paese emerge con chiarezza, ad esempio, da un confronto tra le varie pubblicità che ogni marchio
ha prodotto. Nel 2009, Barilla ha firmato uno spot televisivo che celebrava in 132 secondi i 132 anni della storia
della marca. Pressoché la storia dell’Italia unita. Da una nazione accomunata dall’agricoltura si è passati a
una nazione via via più industrializzata e con un sistema distributivo che affianca alle piccole botteghe
familiari catene distributive dall’assortimento ampio e profondo. La stessa estetica si modifica, passando da
un lettering graziato e decorato a forme pulite, grafiche. A sua volta, il prodotto perde progressivamente di
realismo per diventare astratto, onirico, come nelle magnifiche campagne firmate da Giuseppe Venturini nel
1938 o da Erberto Carboni nel 1952. La pasta diviene nota su un pentagramma musicale o elemento ludico
per la tavola.
Per quanto possa risultare affascinante osservare la storia italiana riprodotta dai consumi, in questo articolo
sono più interessato a rilevare come i consumi abbiano attivamente favorito o rallentato il processo di
unificazione sociale.
Probabilmente il ruolo dominante, a riguardo, è stato ed è quello afferente ai consumi mediatici. Stampa,
radio, televisione, cinema, e oggi la rete hanno progressivamente alfabetizzato gli italiani su più fronti. In
75
Società e Cultura
primis, hanno letteralmente costruito una lingua condivisa, che è andata a sostituirsi ai vari dialetti locali. Non
solo. La capillare diffusione di messaggi pubblicitari all’interno dei media, oltre che negli spazi pubblici, ha nel
tempo alimentato un immaginario comune, stimolando simili bisogni, emozioni, comportamenti. All’interno
della brand economy, sempre più consumatori si sono trovati a desiderare il medesimo prodotto e si sono
sentiti come il proprio vicino perché indossano capi uguali, mangiano lo stesso cibo, ballano con la medesima
musica, viaggiano nelle stesse località. Alcuni prodotti, poi, hanno davvero facilitato la messa in connessione
del popolo italiano, basti pensare alla diffusione dell’automobile, al settore dei trasporti ferroviari e aerei, ai
social network, alle telecomunicazioni, e così via. Infine, determinati prodotti locali sono stati resi icone
dell’italianità nel mondo: la pasta, la pizza o il caffè sono diventate segno di Italia anche per la gente del
Nord, esattamente come il design o la moda sono passati nel dna consumistico del Sud.
Su tutt’altro versante, sono ancora una volta i consumi a minacciare la conservazione dell’unità d’Italia. In
tempi recenti, si assiste al parallelo radicamento di due trend opposti, e proprio per questo necessari l’uno
all’altro. Da una parte, la diffusione di consumi globali, a volte adattati ai gusti locali (si pensi ai menù speciali
di McDonald’s) a volte no (la Coca Cola ha lo stesso gusto dappertutto). Dall’altra, la rinascita dei localismi
(sagre e fiere locali, prodotti doc e dop, etc.) che parlano di un’Italia fatta di microcosmi, ancora oggi non
del tutto interconnessi.
Per quanto il tema necessiti di assai più spazio e articolazione, si può tuttavia concludere che sarebbe miope
pensare al consumo come a un puro specchio della storia comune. Anche nei 150 anni di unità italiana, il
consumo ha partecipato a costruire questa storia.
L’Autore
Luca Massimiliano Visconti è direttore del Mimec, il Master in Marketing e comunicazione della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 107/2011
76
Società e Cultura
I giovani precari diventeranno anziani bisognosi
di Vincenzo Galasso
Il problema del precariato che colpisce le giovani generazioni
è sotto gli occhi di tutti. Non tutti, però, immaginano le
conseguenze negative che provocherà sul futuro dei giovani e
sulle loro pensioni. Lo spiega Vincenzo Galasso, direttore del
Centro Dondena Bocconi.
Il precariato che colpisce le giovani generazioni è sotto gli occhi di tutti. Su dieci persone che si affacciano al
mercato del lavoro in Italia prima dei 30 anni, solo tre ottengono un lavoro a tempo indeterminato, le altre
entrano con una delle oltre quaranta tipologie di contratto a tempo determinato esistenti.
E passare da un contratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato non è semplice: ogni anno
riesce solo a poco più del 10% di giovani. Si rimane dunque a lungo in questo limbo, con un salario in media
inferiore del 25% a quello dei più fortunati, senza sussidi di disoccupazione e con un percorso lavorativo
accidentato, fatto anche di disoccupazione, magari accompagnata dal ritorno a casa dei genitori.
Ma forse non tutti sanno che il precariato lascia un’eredità pesante anche sul futuro delle giovani generazioni,
un sigillo che li segue fino alla pensione. Anzi, proprio al termine della loro vita lavorativa, i giovani di oggi
scopriranno di dover pagare ancora una volta il conto lasciato loro dai genitori. Le loro pensioni saranno
molto meno generose di quelle dei loro padri, e dunque i giovani di oggi saranno verosimilmente forzati, non
dalle leggi del parlamento ma da quelle dell’economia, ad andare in pensione più tardi, per potersi garantire
un reddito previdenziale adeguato.
Per avere un’idea dell’impatto del precariato di oggi sulle pensioni di domani, consideriamo le carriere
lavorative di due ipotetici giovani: Lorenzo e Pierpaolo.
Per le donne, il calcolo sarebbe ancora più impietoso, poiché, almeno in Italia, esse hanno carriere lavorative
più discontinue e dunque pensioni tipicamente più basse degli uomini.
Lorenzo è un ragazzo fortunato: inizia a lavorare a 25 anni con un contratto a tempo indeterminato e uno
salario mensile di 1.000 euro. Alla fine della sua carriera lavorativa, il suo salario reale supera i 2.000 euro. Se
77
Società e Cultura
decidesse di andare in pensione a 60 anni, otterrebbe un beneficio previdenziale mensile reale compreso tra i
1.023 e 1.112 euro, con un tasso di sostituzione (il rapporto tra pensione e salario pre-pensionamento) attorno
al 55%. Ma, ritardando a 67 anni l’uscita dal mercato del lavoro, la sua pensione reale mensile oscillerebbe
attorno ai 1.600 euro, con un tasso di sostituzione dell’80%. Con 42 anni di contributi, Lorenzo otterrebbe
dunque lo stesso trattamento previdenziale del padre (ovvero un tasso di sostituzione dell’80%), che di anni ne
aveva lavorati 40.
A Pierpaolo le cose vanno meno bene: entra nel mercato del lavoro a 25 anni con un contratto temporaneo,
che riesce a mantenere fino ai 28 anni. Per un anno è disoccupato, poi ottiene un lavoro a tempo
determinato che tiene fino ai 32, quando si ritrova nuovamente disoccupato. A 33 anni l’ultimo contratto
temporaneo che dopo due anni si trasforma in tempo indeterminato. Inoltre Pierpaolo ha un salario mensile di
soli 800 euro, che rimane quasi costante, in termini reali, fino a quando ai 33 anni approda al contratto a
tempo indeterminato. Alla fine della sua carriera lavorativa, il suo salario reale mensile supera di poco i 1.300
euro. Le difficoltà di inserimento di Pierpaolo hanno dunque segnato la sua carriera lavorativa. Il suo salario
reale finale è solo del 62,5% più alto di quello iniziale. Il salario di Lorenzo è invece raddoppiato. Con un
sistema previdenziale a contributi definiti, come quello introdotto in Italia dalla riforma Dini del 1995, una
carriera lavorativa discontinua e una scarsa crescita salariale si riflettono fortemente sui benefici previdenziali.
Se andasse in pensione a 60 anni (come suo padre), Pierpaolo percepirebbe un assegno mensile reale
compreso tra i 638 e i 690 euro. È solo lavorando fino a 67 anni che Pierpaolo potrebbe ottenere una pensione
mensile reale attorno ai 1.000 euro.
Al momento dunque ai giovani di oggi non rimane che puntare su un forte aumento della longevità che
consenta loro di posticipare la pensione e di continuare a lavorare. Tuttavia, una riduzione del dualismo sul
mercato del lavoro, ad esempio attraverso l’introduzione di un contratto unico che riduca le differenze tra
contratti temporanei e permanenti, consentirebbe ai giovani un migliore inizio della loro vita lavorativa e una
vecchiaia più serena.
L’Autore
Vincenzo Galasso è direttore del Centro Dondena Bocconi di ricerca sulle Dinamiche sociali.
Aree di interesse scientifico
Political Economics. Macroeconomia. Economia pubblica. Sistemi pensionistici.
Da Bocconi Newsletter no. 110/2011
78
Società e Cultura
La spirale che assolve i bamboccioni
di Bruno Arpino
La tolleranza sociale per i trentenni che vivono con i genitori è
molto alta nei paesi del Mediterraneo, dov’è influenzata da
problemi come la carenza di posti di lavoro. Per Bruno Arpino,
docente del Centro Dondena Bocconi, si crea una sorta di
spirale che in parte scagiona i bamboccioni.
La ricerca sulla transizione allo stato adulto ha chiaramente posto in rilievo le considerevoli differenze esistenti
tra i vari paesi europei nell’età media alla quale i giovani lasciano il nido parentale. Meno studiate, invece,
sono le norme sociali sull’età limite ritenuta accettabile per continuare a restare a casa. Questo è l’oggetto di
un lavoro condotto presso il centro Dondena della Bocconi da Arnstein Aassve, Bruno Arpino e Francesco
Billari (“Age norms on leaving home: Multilevel evidence from the European Social Survey”, Dondena Working
Paper 32; www.dondena.unibocconi.it/wp32).
Il lavoro utilizza dati su 25 paesi europei (European Social Survey, round 3), tra i quali purtroppo manca l’Italia,
che però ci si può aspettare simile agli altri paesi mediterranei.
Agli intervistati è stato chiesto: “Dopo quale età lei direbbe che una persona è troppo vecchia per continuare
a vivere coi propri genitori?”. I risultati variano notevolmente trai paesi europei. Da un lato si hanno i paesi
dell’Europa meridionale (Cipro, Portogallo e Spagna) con valori medi dichiarati superiori ai 30 anni.
All’estremo opposto troviamo i paesi nordici (Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia) ed ex-sovietici (Russia e
Ucraina), con valori medi compresi tra 24 e 26,5 anni.
Invece di fornire una specifica età limite, gli intervistati potevano rispondere che “non si è mai troppo vecchi
per restare a vivere con i propri genitori”.
Se si combinano le persone che hanno dichiarato un’età limite non inferiore a 30 anni con quelle che hanno
dichiarato che non c’è limite, si ottiene la percentuale di quelli che è possibile definire come “tolleranti” verso
i bamboccioni. La graduatoria risultante vede primeggiare il Portogallo, dove l’85% ritiene che non ci sia un
termine per i giovani per lasciare la casa dei genitori o che si possa accettare la co-residenza tra genitori e
79
Società e Cultura
figli anche oltre i 30 anni. In Danimarca, al contrario, il 74% delle persone pensa che non sia accettabile
restare a casa oltre i 30 anni.
Gli autori si interrogano sui fattori di contesto, regionali e nazionali, che influenzano l’età limite ritenuta
accettabile per vivere in casa dei genitori. Dai risultati emerge che fattori culturali, misurati ad esempio dal
tasso di persone che si dichiarano religiose nelle varie regioni e stati europei, sono importanti nell’influenzare le
differenze tra regioni e paesi in termini di norme sociali. Le aree più religiose sono anche quelle più tradizionali,
dove i legami familiari sono più forti, e questo può spiegare la tendenza ad accettare una più lunga
permanenza nella casa dei genitori. Anche fattori istituzionali svolgono un ruolo importante. La carenza di
posti di lavoro, la difficoltà ad accedere al mercato creditizio e bassi livelli di istruzione aumentano la
tolleranza verso il posticipo dell’indipendenza residenziale da parte dei giovani.
Da quest’analisi si deduce che i fattori che limitano le possibilità dei giovani di costruirsi un proprio futuro di là
delle mura genitoriali influenzano anche le opinioni sull’accettazione del prolungamento del periodo di
dipendenza. Si instaura così una spirale tra fattori culturali, istituzionali e norme sociali che rinforza certe
attitudini. Da quest’analisi i bamboccioni sembrano uscire, quindi, almeno parzialmente scagionati perché in
fondo, come dice Fo nell’incipit del Paese dei mezaràt, “tutto dipende da dove sei nato”.
L’Autore
Bruno Arpino è ricercatore presso il Centro Dondena Bocconi di ricerca sulle Dinamiche sociali.
Da Bocconi Newsletter no. 111/2011
80
Società e Cultura
L’età dell’apprendimento
di Francesco Billari e Michele Pellizzari
Una ricerca dimostra che chi ha qualche mese in meno dei
compagni di corso ottiene migliori risultati accademici: un dato
che sorprende forse solo in apparenza, come spiegano
Francesco Billari (docente Bocconi di Demografia) e Michele
Pellizzari (Dipartimento di Economia Bocconi).
Le ricerche sul ruolo dell’età nei processi di apprendimento indicano che in generale gli studenti di età più
elevata tendono a ottenere risultati migliori dei loro compagni più giovani, e giustificano questo risultato
argomentando che gli studenti più grandi sono più sviluppati dal punto di vista cognitivo. Differenze di età
anche contenute, come quelle in una stessa classe scolastica, rappresentano un divario consistente quando
si è molto giovani. Per esempio, 11 mesi di differenza rappresentano oltre il 15% dell’età assoluta a 6 anni. Si
spiega così anche il fatto che tali effetti si diluiscano nel corso della crescita e che scompaiano nella prima
adolescenza.
In questi studi, tuttavia, nessuno ha ancora analizzato gli effetti dell’età nel contesto dell’istruzione
universitaria. È l’obiettivo di un nostro recente lavoro sugli studenti dell’Università Bocconi (Billari e Pellizzari,
2011, “The younger, the better? Age related differences in academic performance at university”, Journal of
Population Economics, di prossima pubblicazione). Nel nostro lavoro troviamo al contrario che sono gli
studenti più giovani all’interno di ogni coorte ad avere i risultati accademici migliori, soprattutto nelle materie
scientifiche. Si tratta di effetti relativamente piccoli, nell’ordine di circa mezzo punto percentuale per ogni 11
mesi di differenza, ma statisticamente significativi.
Questo risultato non è dovuto a un effetto di selezione, ovvero al fatto che solo i giovani più bravi facciano
domanda e vengano ammessi in Bocconi, e nemmeno al fatto che i più giovani siano quelli che hanno
anticipato l’ingresso a scuola. Per esempio, notiamo che la distribuzione per mese di nascita dei nostri studenti
non è significativamente diversa da quella della popolazione nel suo complesso o degli studenti universitari.
Perché allora questi effetti dell’età si invertono per gli studenti universitari? Certamente, l’effetto di crescita
cognitiva che favoriva gli studenti più anziani alla scuola materna e primaria qui scompare, ma è difficile
pensare che tale effetto cambi segno (anche se prima o poi al crescere dell’età tale inversione si verificherà).
81
Società e Cultura
A riprova, i nostri risultati rimangono invariati anche confrontando studenti che hanno ottenuto punteggi simili
al test d’ingresso, che è un test di abilità cognitiva.
Ipotizziamo quindi un meccanismo alternativo. Studi psicologici mostrano che essere fisicamente piccolo
rispetto a un proprio gruppo di riferimento in età molto giovane porta a sviluppare meno rapidamente tratti
quali la leadership o l’autostima. Si può allora ipotizzare che i più giovani abbiano un set di abilità
d’interazione sociale meno sviluppate e che quindi, nel decidere come allocare il proprio tempo tra attività di
intrattenimento sociale e attività di studio, diano peso maggiore alle seconde. Dedicandosi di più allo studio,
ottengono risultati migliori. A sostegno di questa ipotesi, analizziamo un’indagine sui comportamenti sociali e
sessuali di un campione di studenti universitari italiani e troviamo che i più giovani in ogni coorte di nascita
vanno meno in discoteca, fanno meno sport e hanno meno rapporti sessuali (International Survey of
Affectivity and Sex, Max Planck Institute e Università di Padova). Coerentemente, anche nei dati PISA gli
studenti più giovani dedicano più tempo allo studio a in casa rispetto ai loro compagni più anziani
(Programme for International Student Assesment, Ocse).
Nell’ottica di ridurre le differenze nei risultati accademici non direttamente dovute a differenze in abilità o
impegno (ciò che forse definiremmo meritocrazia), si può pensare allora di modificare i criteri di formazione
delle classi materne ed elementari per non avere nella stessa classe studenti con differenze di età superiori ai
6 mesi invece di 11. Una soluzione che si potrebbe realizzare a costo zero in tutte le scuole con almeno due
classi per grado. Così gli effetti indotti da differenze nello sviluppo delle abilità sociali e cognitive sarebbero
ridimensionati a favore dell’uguaglianza delle opportunità.
Gli Autori
Francesco Billari è professore ordinario di Demografia in Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Demografia. Politiche sociali. Corso di vita. Statistica sociale. Economia e popolazione. Dinamiche sociali.
Geografia. Sanità pubblica.
Michele Pellizzari è assistant professor presso il Dipartimento di Economia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Economia del lavoro. Microeconometria.
Da Bocconi Newsletter no. 111/2011
82
Società e Cultura
L’inquinamento costa 10 miliardi e 8.200 morti
di Marco Percoco
L’inquinamento causa 8.200 morti in Italia, con un costo sociale
di almeno 10 miliardi di euro. La stima della World Health
Organization deve indurre a cercare soluzioni anche radicali,
spiega Marco Percoco, docente Bocconi del Dipartimento di
Analisi istituzionale e management pubblico.
La World health organization ci ha ricordato, se mai ve ne fosse bisogno, che la qualità dell’ambiente urbano
in Italia è scadente. Delle quattro città più inquinate d’Europa, tre sono italiane. La maglia di più inquinata del
Vecchio Continente va a Plovdiv in Bulgaria, seguita da Torino, Brescia e Milano. Quest’ultima è nel gruppetto
di testa, nonostante decenni di interventi di lotta allo smog più o meno efficaci.
Le città hanno conosciuto e mostrato un interesse nei confronti del problema inquinamento altalenante e non
sempre sostenuto da una visione di lungo periodo. Ultimamente, sembra aver prevalso la rassegnazione sia
dal lato dei cittadini sia da quello degli amministratori locali, come se la famigerata concentrazione di PM10 e
di NOx fosse un inevitabile prodotto dello sviluppo economico. Ma la Who ha stimato in 8.200 i decessi
attribuibili all’inquinamento nelle 13 città italiane più grandi; ben 2.000 di queste morti avvengono a Milano.
Tutto ciò ha un costo per la collettività, un costo invero significativo in questo caso. Se si considera che la
stima del valore sociale di una vita umana è di circa 1,2 milioni di euro, si ottiene che il costo sociale
dell’inquinamento è di quasi 10 miliardi di euro, di cui 2,4 per la sola Milano.
Sebbene questa cifra possa sembrare enorme, va detto che essa rappresenta una stima per difetto sia
perché lo studio fornisce dati anche sulle malattie indotte dallo smog e non necessariamente mortali (si pensi
all’asma), non ricomprese nel costo sociale, sia perché l’analisi della Who considera solo il territorio comunale
e non quello metropolitano.
Le città italiane hanno fatto qualcosa negli ultimi anni per far fronte all’inquinamento, ma hanno fatto poco e
male. Gli interventi di regolazione del traffico (che contribuisce per oltre il 50% alla produzione di PM10) a
mezzo di zone a traffico limitato, targhe alterne, domeniche a piedi, si sono rivelati generalmente inefficaci.
83
Società e Cultura
Milano ha adottato, al pari di altre città europee, una tassa per le automobili che entrano nel centro della
città, il cosiddetto Ecopass. Tale intervento ha abbassato il livello medio di concentrazione di polveri sottili del
17-18%, con evidenti e significative ricadute per la salute pubblica. Studi recenti dimostrano che
l’applicazione dell’Ecopass ha prodotto una variazione positiva del benessere sociale, in alcuni casi
addirittura superiore a quella generata dalla tassa sulla congestione londinese.
Ma è necessario fare di più a Milano come nelle altre città italiane. L’introduzione di una tassa
sull’inquinamento può apportare significativi guadagni per la collettività purché applicata in maniera
estensiva. Inoltre, incentivi all’acquisto di mezzi ecologici (o disincentivi all’acquisto di auto più inquinanti
come i suv, così come paventato dal recente decreto sul federalismo fiscale) potrebbero garantire sicuri
benefici sociali, sebbene solo nel lungo periodo.
Infine, il consumo di suolo nelle aree periurbane va limitato. La dispersione urbana produce un incremento dei
chilometri percorsi dalle persone che si spostano dalle periferie verso il centro, con un conseguente
deterioramento dell’ambiente. Una città metropolitana più compatta garantirebbe, invece, una migliore
gestione della mobilità e un minor ricorso all’automobile e, di conseguenza, un minore inquinamento.
Questi interventi sono necessari, anche se sembrano estremamente costosi, ma forse un problema da circa 10
miliardi di euro all’anno vale un’attenzione e un attivismo superiori a quelli attuali.
L’Autore
Marco Percoco è assistant professor presso il Dipartimento di Analisi istituzionale e management pubblico
della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 112/2011
84
Energia,
Ambiente
e Infrastrutture
Energia, Ambiente e Infrastrutture
Chi ci guadagna paga. Ecco la cattura del valore
di Chiara Sumiraschi
Realizzare nuove infrastrutture di trasporto costa. Perché non
farle finanziare da chi, grazie a queste, guadagnerà? Per
Chiara Sumiraschi, docente Certet Bocconi, forme di
finanziamento innovative già testate all’estero potrebbero
valere anche per la metropolitana di Milano.
Esiste un crescente interesse nella letteratura accademica (e nelle pratiche amministrative) sul meccanismo di
‘cattura del valore’, che prova a tradurre concretamente il principio, dotato di un considerevole fascino
intuitivo, in base al quale coloro che traggono benefici dalla realizzazione di un’infrastruttura di trasporto (ma
anche dalla valorizzazione dell’ampio patrimonio di aree ed edifici terziari e industriali obsoleti all’interno dei
tessuti urbani) dovrebbero pagare per il vantaggio che ottengono.
Partendo dal presupposto che la costruzione (o il miglioramento) di un’infrastruttura stradale o di trasporto
pubblico produca dei benefici per il settore immobiliare, per quello commerciale, per gli imprenditori e per
alcune fasce della popolazione, le politiche di cattura del valore prefiggono di catturare tali guadagni di
valore per pagare il costo dell’infrastruttura e, così facendo, ridistribuire i benefici generati dagli investimenti
pubblici alla comunità.
In effetti, seppur con diverse varianti, la cattura dei plusvalori fondiari e immobiliari derivanti dalla realizzazione
di infrastrutture di trasporto costituisce una forma di finanziamento diffusa nella maggior parte dei paesi che,
una volta o l’altra, hanno sperimentato questo sistema. Le amministrazioni locali degli Stati Uniti utilizzano
ampiamente le Development Exactions, gli Special Assessment District e i Tax Increment Financing; in Spagna
e in America Latina si impiegano contribucíon de valorizacíon. Il land banking si è sviluppato nel Nord Europa
a partire dall’inizio del ventesimo secolo per poi diffondersi in modo sperimentale nel resto del mondo, in
particolare in Cina. Il Giappone, invece, adopera da lungo tempo meccanismi di linkage capture.
Per quanto riguarda l’Unione Europea, il dibattito sulle politiche di cattura del valore è quanto mai attuale.
Recentemente, la scelta di Sarkozy di presentare all’opinione pubblica Grand Paris Express, la linea della
metropolitana che collegherà tutti i principali centri della cintura parigina nell’ambito del più ampio progetto
Grand Paris 2020 di riqualificazione delle periferie urbane, è andata di pari passo con la decisione di
87
Energia, Ambiente e Infrastrutture
promuovere per tale intervento un modello che identificasse nuove risorse per l’investimento infrastrutturale. E,
infatti, auspicando l’apertura a un’ampia gamma di fonti di finanziamento e ponendo come condizione che
il ricorso alle risorse nazionali potesse verificarsi solo come ultima possibilità, il presidente ha incaricato una
commissione di identificare possibili fonti di finanziamento innovative per la metropolitana. D’altronde, anche
in Italia nel corso del 2010 si sono intravisti dei segnali che potrebbero innescare un confronto sull’opportunità
di prevedere un contributo di miglioria per finanziare le nuove tratte della metropolitana di Milano, sulla
falsariga di quanto avvenuto negli anni Sessanta nella metropoli milanese per il finanziamento della
costruzione della linea rossa.
Pertanto, considerato il crescente interesse per l’utilizzo delle politiche di cattura del valore per finanziare le
infrastrutture di trasporto è bene ricordare al policy maker la regola aurea per la corretta implementazione dei
diversi meccanismi. Infatti, poiché non esiste uno strumento perfetto, è necessario che egli disponga di una
cassetta degli attrezzi scientificamente rigorosa, che gli consenta di scegliere lo strumento maggiormente
adeguato, tenendo conto del contesto istituzionale, amministrativo, politico ed economico, del livello di
urbanizzazione dell’area e del contributo alla crescita che può fornire lo strumento prescelto, nella
consapevolezza che sussiste un trade off tra la massimizzazione l’efficienza, il rispetto dell’equità, la
minimizzazione dei costi di amministrativi e l’innovatività dello schema di finanziamento.
L’Autore
Chiara Sumiraschi è collaboratrice del Certet, Centro di Economia regionale, dei trasporti e del turismo della
Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Valutazione delle politiche di sviluppo locale.
Da Bocconi Newsletter no. 106/2011
88
Energia, Ambiente e Infrastrutture
Co2. Diplomazia e mercato decideranno il futuro
di Stefano Pogutz
Il 2010 ha segnato un record storico nella crescita delle
emissioni di Co2. Stefano Pogutz, direttore Mager Bocconi, si
chiede se i prossimi vertici di Durban e Rio riusciranno dove
Copenhagen ha fallito: trovare un erede della convenzione
globale sul clima.
I dati sulla crescita delle emissioni di Co2, che nel 2010 hanno segnato un record storico dopo la pausa del
2009 sotto la spinta dell’economia cinese e del ricorso a fonti fossili di molti Pvs, ripropongono con forza la
questione della sostenibilità ambientale e climatica del nostro modello di sviluppo. Al contempo, stimolano la
nostra intelligenza per cercare di individuare nuovi strumenti di policy, nuove tecnologie, nuovi modelli di
business in grado di rompere la stretta relazione esistente tra crescita economica, consumi e impiego di risorse
naturali. Ciò significa, in primo luogo, capire i meccanismi di funzionamento del nostro pianeta; una sfida
complessa, che vede da anni coinvolti gli studiosi.
In questo quadro, Johan Rockström e alcuni colleghi dello Stockholm Resilience Centre hanno coinvolto
scienziati di vari campi per capire quali sono le funzioni fondamentali prodotte dagli ecosistemi e quali sono i
limiti di sicurezza che dobbiamo rispettare se non vogliamo andare incontro a trasformazioni planetarie. Il
risultato di questa ricerca, pubblicata su Nature nel 2009, è duplice: da un lato, sono stati identificati nove
processi naturali fondamentali che influenzano la vitalità e la produttività degli ecosistemi da cui dipendiamo
(come l’inquinamento da agenti chimici, l’utilizzo di acqua potabile, l’impiego della superficie terrestre);
dall’altro, si è rilevato che ben tre di questi processi (perdita di biodiversità, cambiamento climatico e
dinamica dei cicli di azoto) si sono modificati in modo radicale, uscendo dalla banda di oscillazione definita
spazio di sicurezza.
Il tema dei limiti non è nuovo nella discussione sulla sostenibilità del nostro modello di produzione e consumo.
Un meccanismo come il cap and trade, introdotto nel 1997 con il Protocollo di Kyoto per disciplinare le
emissioni climalteranti, rappresenta il tentativo di porre un limite alla nostra generazione di gas serra. Ciò
significa che se vogliamo continuare a crescere e rispettare i limiti naturali, è necessario disaccoppiare la
crescita dall’impatto ambientale, o de-carbonizzare tecnologie e consumi.
89
Energia, Ambiente e Infrastrutture
La diplomazia internazionale ha stabilito che lo spazio di sicurezza per evitare variazioni climatiche tali da
determinare rischi sociali ed economici inaccettabili è quello delle 450 parti per milione in volume di Co2 (al
2035). Questo scenario si dovrebbe accompagnare a un aumento medio di temperatura di 2 gradi
centigradi. Secondo le stime dell’Intenational energy agency lo scenario 450 presuppone una riduzione
significativa della nostra carbon intensity, che dovrebbe dimezzarsi su base annua nel periodo 2008-2020, e
ridursi di un quarto ogni anno nel periodo 2020-2035. Questo obiettivo richiede che nel periodo 2010-2035 il
50% del taglio delle emissioni cumulate di gas serra provenga da Stati Uniti e Cina, l’8% dall’Europa e il 7%
dall’India, il resto dalle altre economie. L’obiettivo richiederebbe una rivisitazione sostanziale del nostro
modello energetico, la rapida diffusione delle energie rinnovabili, delle tecnologie di carbon capture and
storage, del nucleare, e soprattutto, aumentare l’efficienza energetica.
Il fallimento del vertice di Copenhagen (2009) rispetto alla possibilità di trovare un erede della convenzione
globale sul clima, che si estinguerà nel 2012, ha lasciato una grande incertezza sulla possibilità di raggiungere
l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura al 2020 a 2 gradi rispetto all’era preindustriale. L’idea di un
framework vincolante che impegna tutti i paesi nella riduzione delle emissioni, determinando di fatto un unico
mercato per la Co2, rappresenta secondo molti la soluzione più efficace. Tuttavia questa strada appare
sempre più complessa e, ad eccezione della Ue, il partito dei paesi che preferisce altre forme di accordi,
come agreement bilaterali, settoriali e bottom-up, sembra prevalere, come emerso a Cancun.
Nei prossimi 10 mesi, a Durban prima e a Rio dopo, si terranno due appuntamenti determinanti per lo sviluppo
sostenibile e il clima. Vedremo se diplomazia, economia e mercato riusciranno a trovare un modo per
ritornare a collocare l’umanità nei limiti che la natura ci impone.
L’Autore
Stefano Pogutz è direttore del Mager, il Master in Green Management, Energy and Csr della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Corporate Sustainability. Environmental Management. Csr. Management della Tecnologia e dell'Innovazione.
Da Bocconi Newsletter no. 115/2011
90
Tecnologia
e Innovazione
Tecnologia e Innovazione
Telefonini, un caffè con il check-in
di Stefano Pace
Marketing: le applicazioni per smartphone basate sul
rilevamento della posizione, come FourSquare, aprono la
strada a iniziative di loyalty innovative. Stefano Pace, docente
del Dipartimento di Marketing Bocconi, illustra le ultime
tendenze di business basate sulla geolocalizzazione.
Vi piacerebbe diventare sindaco in pochi giorni? È semplice: frequentate il ristorante o locale che preferite,
fate “check-in” ogni volta che andate e, se sarete il cliente che avrà accumulato più check-in, sarete
nominati “mayor” del luogo. Non stiamo parlando di un nuovo sistema elettorale o di un servizio aeroportuale
in città. Si tratta di una delle tendenze di business e di marketing delle tecnologie mobili: la geolocalizzazione.
Le piattaforme come Internet e le tecnologie mobili sono spesso associate a mondi paralleli e virtuali rispetto a
quello reale. La stessa distinzione fra i termini online e offline mostra la divergenza fra un mondo fatto di bit e
un mondo tangibile e reale composto da atomi. Questa distinzione non è più così valida come in passato. Le
tecnologie stanno riscoprendo latitudine e longitudine, diventando “geo”.
Torniamo al nostro check-in: si tratta di una funzione di FourSquare, applicazione per smartphone lanciata nel
marzo del 2009 e che annovera già 3 milioni di utenti. Tramite il check-in, l’utente di FourSquare può
commentare e segnalare alla sua rete di amici il luogo in cui si trova (ad esempio una piazza, una libreria, un
concerto). FourSquare può interfacciarsi con social network come Twitter e Facebook, creando una sinergia
fra applicazioni per smartphone e Web. Il semplice gesto di localizzarsi con il check-in porta valore per l’utente
sotto diverse forme. Innanzitutto, può aggiornare la propria rete sociale e mantenere il contatto con essa. Può
ottenere dei badge, ossia dei riconoscimenti dati a chi effettua check-in a condizioni particolari. I badge
formano un medagliere da collezionare sul telefono. Tra i più ambiti c’è quello di mayor, assegnato all’utente
col maggior numero di check-in per un dato luogo. Può poi contattare altre persone che siano presenti nello
stesso luogo in quel momento e, un ulteriore vantaggio, può usufruire di iniziative di marketing delle imprese
che scelgano di affiliarsi al programma business di FourSquare. Le aziende possono concedere sconti o altri
benefici ai clienti che si dimostrino più fedeli, misurandone la loyalty tramite la frequenza dei check-in. In tutto
il mondo sono per ora 15.000 i punti vendita di diverso genere che sperimentano iniziative basate su
FourSquare. Starbucks, ad esempio, offre il badge Barista a chi effettui 5 check-in in altrettanti locali Starbucks.
Con tale badge si ha diritto a una consumazione gratuita.
93
Tecnologia e Innovazione
FourSquare non è l’unico sistema ad avere applicato la geolocalizzazione come cuore dell’offerta.
Concorrenti agguerriti si vedono all’orizzonte, come Gowalla, applicazione lanciata nel dicembre del 2009.
Facebook non poteva naturalmente mancare a questa transizione verso il “geo”, con il suo Facebook Places.
Google Latitude indica invece la localizzazione dell’utente sulle mappe di Google Maps.
Fra i fattori che determinano l’aumento dei servizi location-based possiamo citare l’ormai ampia base di
smartphone di ultima generazione e l’istinto da collezionista che spinge l’utente a estrarre valore dalla mera
frequentazione di un dato luogo, il valore insito nel semplice ‘esserci’. Shopping experience e servicescape
rimangono concetti essenziali, ma anche il solo essere presente in un luogo offre qualcosa.
Le best practice che stanno emergendo dal mondo “geo” suggeriscono che non è necessario pensare a
iniziative di marketing radicali, ma all’abbinamento fra programmi di loyalty in atto e sistemi di
geolocalizzazione. Un caffè con check-in...
L’Autore
Stefano Pace è assistant professor presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 101/2011
94
Tecnologia e Innovazione
La tua identità vale. Perciò cercano di rubartela
di Oreste Pollicino
I dati personali e sensibili di chi naviga sono il vero oro nero
dell’economia di Internet, e noi spesso li rilasciamo
gratuitamente. Oreste Pollicino, docente Bocconi di Diritto
pubblico, richiama alla consapevolezza dei rischi, e propone in
certi casi l’astinenza digitale di massa.
L’identità personale è quel complesso d’idee, convinzioni, attitudini relazionali che caratterizzano la
proiezione del sé nel sociale. È un nostro diritto costituzionale pretendere che tale proiezione sia fedele a
quanto ci caratterizza e che non sia artificialmente distorta. Ma se nel mondo materiale il rischio è quello della
distorsione, nel mondo digitale il rischio è più grosso: l’appropriazione indebita di alcuni segmenti della nostra
identità elettronica.
La ragione alla base è molto semplice: mentre l’identità personale offline si caratterizza per una unitarietà di
base che la rende immune da asporti selettivi, al contrario l’identità digitale è per definizione esposta alla
inevitabile frammentarietà e contingenza di tracce, percorsi e preferenze che caratterizzano il nostro
navigare sul web. Una molteplicità di forme e modalità che facilita l’emersione di almeno due situazioni di
‘torsione’ della proiezione del nostro sé online, una di natura fisiologica, la seconda, più grave, di natura
patologica.
La prima, è la possibile asimmetria tra l’identità personale che ci caratterizza nel mondo reale e quella che
invece ci rappresenta nella realtà virtuale. Asimmetria che non implica solo un rischio di schizofrenia tra il
nostro essere offline e quello online, ma che è anche un’opportunità di evasione e di riscrittura (virtuale) del
nostro vissuto. Un servizio come Second life ne è l’esempio emblematico.
La seconda situazione, dalle conseguenze più dannose perché spesso inconsapevoli e che mette molto più a
rischio la protezione della privacy di utenti e consumatori sul web, implica una premessa: il denominatore
comune, nella molteplicità e frammentarietà in cui si afferma la proiezione del nostro sé digitale, è costituito
dalla posizione cruciale occupata dai dati personali e sensibili del navigatore.
95
Tecnologia e Innovazione
Sono questi, pur se troppo spesso siamo così inconsapevoli del loro inestimabile valore da rilasciarli
gratuitamente, il vero oro nero dell’economia di internet, fonte di guadagni stratosferici per i giganti del web
e privilegiati strumenti per il furto di identità perpetrato dai nuovi cyber criminali del web 2.0.
Le tracce, spesso inconsapevoli ma comunque ineliminabili, dei nostri dati, preferenze e attitudini diventano la
materia prima alla base della pubblicità mirata con cui gli intermediari scandiscono i nostri percorsi di
navigazione online.
Una fonte di proventi di ammontare stratosferico spesso ottenuta a costo zero. Due le cautele da
raccomandarsi: consapevolezza che l’anonimato in internet è una chimera e attenzione a non rilasciare i
propri dati personali se non dopo aver trovato (è sempre ben nascosta), letto e approvato l’informativa
predisposta dagli internet provider sulle modalità, la durata e i fini del trattamento dei propri dati.
Se non si condividono le operazioni cui andranno incontro i nostri dati ci sono due possibilità: o trascurare le
conseguenze dannose che ‘regalando’ quei dati si avrebbero per la protezione della nostra privacy e
identità online, oppure rinunciare, con fermezza e consapevolezza, al servizio offerto. L’astinenza digitale (di
massa) è forse l’unico rimedio per costringere gli operatori del web a prendere più seriamente la normativa
europea (all’avanguardia) in materia di dati personali.
In riferimento invece all’amplificazione della possibilità di commettere crimini attraverso l’appropriazione
indebita della identità digitale altrui, basta ricordare che, secondo un’indagine presentata lo scorso gennaio
a Milano, commissionata da Cpp Italia all’Unicri, il 29,5% degli intervistati è stato esposto a una potenziale
frode di identità nel corso dell’ultimo anno.
Dal punto di vista tecnologico il furto d’identità può essere praticato tramite il trashing, che prevede il prelievo
dei dati da un vecchio pc abbandonato, il phishing, in cui l’esca è rappresentata da email con finte
comunicazioni e richieste da istituti di credito di cui siamo clienti, e il meno diffuso, ma già temuto nei paesi
anglosassoni, vishing. Quest’ultimo combina l’idea del phishing alle caratteristiche tecniche del Voip: chi lo
utilizza simula il call center di una banca, chiamata dall’utente per esempio tramite Skype, per carpirne i dati.
Cautele in quest’ultimo caso? L’unica è andare di persona alla filiale più vicina. In fondo un po’ di moto fa
solo bene.
L’Autore
Oreste Pollicino è professore associato di Diritto pubblico comparato alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Diritto costituzionale europeo. Diritto dell'informazione e della comunicazione. Diritto di Internet.
Da Bocconi Newsletter no. 104/2011
96
Tecnologia e Innovazione
Il navigatore vive in un altro spazio d’attenzione
di Luigi Proserpio
L’attenzione che una notizia può ricevere è molto diversa, a
seconda che sia diffusa sui media tradizionali o su Internet. Luigi
Proserpio, docente del Dipartimento di Management e
tecnologia Bocconi, spiega come cambia lo spazio di
attenzione sul web e sui social network.
È più difficile che una notizia riceva attenzione su Internet o sui media tradizionali? È una domanda importante
perché fa riflettere sull’influenza che il contenitore ha sul contenuto. E sulle differenze tra vecchio e nuovo
mondo per chi produce contenuti di qualsiasi tipo.
La prima pagina o il servizio di apertura sono gli spazi più ambiti per giornali e telegiornali e la competizione
per accaparrarseli è elevata. Se un pezzo è collocato in prima si ha maggiore attenzione da parte dei lettori,
si è più influenti sul giudizio che essi hanno della vita politica, della qualità del giornale etc.
La struttura dell’informazione tradizionale è in qualche modo rigida: decisa l’impaginazione e la scaletta,
quelle rimangono e sono pronte a essere utilizzare in maniera standard da centinaia di migliaia di lettori o da
milioni di telespettatori. In Internet è molto diverso. Una volta immessa un’informazione, essa può essere
incasellata in maniera multiforme: un pezzo di un quotidiano può essere tradizionalmente etichettato dal
direttore come “cronaca”, “politica”, “sport”. Il pezzo può essere caratterizzato da parole chiave scelte dal
direttore o dall’autore, “sbarchi”, “Lampedusa”, “nave”. E può essere anche affiancato da parole chiave
scelte dai lettori, “bene”, “male”, “poveri”.
I criteri di classificazione influenzano la ricercabilità dell’informazione e aumentano la possibilità di rintracciare
qualcosa che si potrebbe perdere con facilità nel mare della rete.
Le prime pagine dei giornali in rete sono tante, i blog sono molti di più, i commenti degli utenti agli articoli sono
migliaia. La potenza cognitiva, di analisi, di digestione degli individui è variabile, ma in generale molto minore
di quella necessaria per ordinare tutte le informazioni di cui stiamo parlando.
Quindi, per un autore, competere per lo spazio di attenzione del lettore su Internet non è come competere
per avere il proprio pezzo in prima pagina.
97
Tecnologia e Innovazione
Lo spazio di attenzione sul web è un concetto diverso da quello tradizionale. Diego Maradona combina una
marachella che è citata sulla home page della Gazzetta dello Sport. Poi Schumacher cerca di investire
Barrichello che lo vuole sorpassare e anche questo trova spazio sulla pagina iniziale, scalzando dal primo
posto Maradona. Lo stesso accade con Bolt che migliora il record del mondo sui cento metri. A un certo
punto Maradona sparisce dalla home page e la notizia si ‘raffredda’. Non è più nello spazio di attenzione del
lettore che se ne dimentica o che la ricorda con nitidezza minore.
Anche sui social network lo spazio di attenzione è limitato. Nella pagina principale del nostro profilo, Facebook
mostra cosa stanno facendo i nostri amici. Giorgio: “Oggi incontro con tortellini d’autore”; Massimiliano: “Il mio
barolo di XYZ è ottimo”.
Quando lo spazio della pagina principale di Facebook finisce, i primi commenti escono di scena lasciando il
posto agli ultimi, in una logica First In First Out. E magari io non saprò mai, se ho molti amici e non mi sono
collegato per qualche ora, che Massimiliano ha passato un pomeriggio con un buon vino.
Purtroppo si perdono informazioni interessanti e importanti che ci sarebbe piaciuto poter leggere. La posta
elettronica esemplifica bene il problema: una pagina di messaggi ne contiene cinquanta, cento. Quando ci
dimentichiamo di salvare un messaggio importante in una cartella dedicata e questo esce dalla prima
pagina ed entra tra i messaggi vecchi, esso diventa praticamente irrecuperabile.
In Internet lo spazio di attenzione appare dunque come un concetto cognitivo, più che fisico. Influenzato
dalla difficoltà di ricercare le informazioni utili e dalle caratteristiche tecnicamente limitate delle pagine
Internet. Questo porta a un modo diverso di catturare l’attenzione del lettore e porta il lettore stesso a mettere
in atto comportamenti di fruizione differenti rispetto al passato. Comportamenti ‘digitali’ che rappresentano il
portato sociale delle tecnologie su cui si basa Internet e che sono un interessante terreno di ricerca per
comprendere il mondo nuovo.
L’Autrice
Luigi Proserpio è professore associato presso il Dipartimento di Management e tecnologia della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Internet Startup Companies. Impatti delle tecnologie su individui, gruppi e organizzazioni. Apprendimento
mediato dalla tecnologia.
Da Bocconi Newsletter no. 106/2011
98
Tecnologia e Innovazione
Il cittadino 2.0 è più soddisfatto e consapevole
di Luca Buccoliero ed Elena Bellio
I cittadini che riescono a far sentire la loro voce grazie agli
strumenti del web 2.0 sono molto più soddisfatti e fiduciosi verso
le amministrazioni pubbliche, ma chiedono loro anche più
trasparenza, come spiegano Luca Buccoliero ed Elena Bellio,
docenti del Dipartimento di Marketing Bocconi.
La crescita delle potenzialità del web ha ridefinito profondamente lo scambio di beni o servizi tra
amministrazioni locali e cittadini, favorendo l’empowerment di questi ultimi, i quali manifestano crescenti
esigenze di accesso a informazioni qualificate, personalizzate e immediatamente fruibili. Il Journal of Egovernance ha pubblicato i primi risultati della ricerca avviata dal Dipartimento di Marketing della Bocconi
nell’ambito del ‘nuovo’ fronte di studi sul social marketing, che ha proposto una prima valutazione della
maturità della presenza online delle pubbliche amministrazioni europee, con riferimento alla capacità di siti e
portali di alimentare un effettivo empowerment dei cittadini. Inoltre, analizzando un caso concreto, la ricerca
ha indagato gli impatti delle strategie di web 2.0 sulla fiducia e sulla soddisfazione dei cittadini.
Riguardo al primo obiettivo, è stato elaborato un indicatore di sintesi (Citizen Web Empowerment Index CWEI) che ha attribuito un punteggio ai siti web istituzionali delle 42 amministrazioni municipali selezionate (in
20 paesi europei), individuate nell’ambito del network Major Cities of Europee. Per la valutazione sono stati
considerati: la natura e la tipologia delle informazioni disponibili; la presenza di elementi di web 2.0 e di servizi
erogati attraverso il canale mobile; la presenza di strumenti di e-consultation; la trasparenza online dei
processi decisionali e l’evidenza del ruolo rivestito dalle valutazioni espresse dai cittadini (ad esempio con la
pubblicazione online delle diverse fasi di procedimenti di particolare rilievo).
Rispetto a un valore massimo teorico pari a 100, la media dei siti si attesta ancora sul valore di 37,8. Mentre il
contenuto informativo è ormai piuttosto strutturato (74/100), più modesta è la diffusione degli strumenti di econsultation (32,4/100) e di elementi di web 2.0 (23,2/100). Infine, circa la trasparenza dei processi decisionali,
il dato mostra una profonda immaturità (8,3/100).
La prima città italiana nella graduatoria è Venezia (con il punteggio di 66), preceduta dalla greca Trikala (87),
un laboratorio di innovazione di reale eccellenza in Europa, da Amburgo (83) e da Vienna (79).
99
Tecnologia e Innovazione
Proprio sul Comune di Venezia è stato condotto un approfondimento volto a mostrare il ‘valore’ creato per i
cittadini attraverso gli strumenti del web 2.0 (analizzando un servizio per la raccolta georeferenziata di
segnalazioni da parte dei cittadini, con l’obbligo per il comune di gestirlo in modo trasparente sul web). In
questo caso il confronto tra due gruppi di cittadini (utilizzatori e non utilizzatori del servizio) ha consentito di
dimostrare che il primo gruppo esprime un più elevato livello di soddisfazione nei confronti
dell’amministrazione, un migliore giudizio sulle relazioni con il comune, una maggiore fiducia sul buon esito
della propria segnalazione e, soprattutto, uno spiccato interesse verso le segnalazioni effettuate dagli altri
cittadini e verso i relativi tempi di gestione da parte dell’amministrazione.
Tuttavia, come testimoniato dai valori complessivamente ancora limitati dell’indice, le amministrazioni
stentano a comprenderne il vero potenziale e a investire adeguate risorse e progettualità. La situazione
italiana è poi resa critica da limiti infrastrutturali, tra i quali l’assenza di connettività wi-fi gratuita (si noti che
Venezia, prima città italiana nel nostro ranking, è anche il primo capoluogo ad aver realizzato una rete wi-fi
per i propri cittadini e per i visitatori) e i limiti delle reti mobili per il traffico dati. Un superamento di questi limiti è
l’auspicabile condizione per lo sviluppo di progettualità innovative volte alla creazione di valore per il
cittadino-cliente. Ma, forse, il limite più rilevante è la difficile accettazione, da parte di molti amministratori,
dell’elevato grado di trasparenza nei confronti dei cittadini che la rivoluzione digitale rende inevitabile.
Gli Autori
Luca Buccoliero è lecturer presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Marketing e scienza dei servizi pubblici. Innovazione nei servizi pubblici e Citizen Relationship Management.
Healthcare, Government e Non Profit Marketing. E-Government. E-Health. Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle aziende sanitarie e ospedaliere e negli enti locali: sistemi informativi contabili e direzionali
nelle aziende sanitarie e ospedaliere e negli enti locali. Management Pubblico e sanitario.
Elena Bellio è borsista presso il Dipartimento di Marketing della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 107/2011
100
Tecnologia e Innovazione
Beni virtuali, nuovo modelli di business in rete
di Sivia Vianello e Franco Denari
Nel 2011 negli Usa si spenderanno oltre 2 miliardi di dollari
nell’acquisto di beni virtuali, da usare online nelle community o
nei game. Per Silvia Vianello (SDA professor di Marketing) e
Franco Denari (Country Manager di Sulake Italia) si tratta di un
mercato che in Italia è ancora sotto tono.
L’economia virtuale, nonostante abbia raggiunto livelli interessanti in altri paesi, in Italia deve ancora
esprimersi nelle sue piene potenzialità. Nel 2011 negli Usa si stima che le vendite di beni virtuali tramite micropagamenti garantiranno 2,1 miliardi di dollari in revenue alle aziende. Infatti, i beni virtuali, e le aziende in
grado di crearli, costituiscono la disruptive innovation del secolo nel mondo della comunicazione e
dell’entertainment. L’esplosione della vendita dei beni virtuali all’interno dei social network, dei mondi virtuali
e dei giochi multiplayer, ma anche nelle mobile application e nelle consolle di videogiochi, è uno dei trend
principali ai quali abbiamo assistito nel 2010 e che dimostrerà le sue piene potenzialità a livello mondiale
presumibilmente proprio nel 2011 e negli anni a venire. Quali saranno le opportunità per le aziende da questi
business digitali? L’economia virtuale è quella emergente online all’interno della quale vengono scambiati
beni interamente virtuali. A differenza dell’economia reale le persone approcciano l’economia virtuale non
per reale necessità dei beni virtuali, ma per divertimento, con una spesa media mensile assimilabile ai micro
pagamenti, che si attesta tra i 10 e i 20 euro al mese, ma sono i volumi di utenti a fare davvero la differenza. In
particolare, i beni virtuali sono quelle tipologie di oggetti intangibili nel mondo reale e che vengono acquistati
per essere utilizzati online ad esempio nelle community o negli online game (arredamento per la propria
stanza virtuale, o abbigliamento per il proprio avatar). I beni virtuali stanno sradicando i tradizionali modelli di
business: nel 2010 la vendita di beni virtuali ha superato gli introiti da pubblicità nell’iPhone. La Apple ha infatti
introdotto poco più di un anno fa la possibilità per gli utenti di comprare beni virtuali all’interno delle
applicazioni.
Le aziende italiane stanno perdendo opportunità straordinarie non sfruttando pienamente questo fenomeno,
che si sta verificando ad esempio nelle varie app di Facebook, con i virtual gift (con revenue passate da 600
milioni di dollari nel 2008 a 1,6 miliardi nel 2010). Ad esempio nella community Habbo gli utenti che acquistano
beni virtuali generano il 90% delle revenue. A livello mondiale, poi, il 23% degli utenti di queste community
acquista almeno mensilmente. In Italia la cifra varia dall’8 al 10% degli utenti, lasciando intravedere ottimi
spazi di crescita di questo business. Attualmente in Habbo vengono venduti 13 mila diversi oggetti in 90 linee
101
Tecnologia e Innovazione
di design. Gli Item che Habbo disegna vengono decisi con l’azienda cliente e possono essere regalati agli
utenti in numero limitato per aumentare la brand awareness e la fidelizzazione dei clienti al brand, dando loro
il carattere di esclusività. In alcuni altri casi il bene virtuale è ottenibile grazie all’acquisto offline proprio dei
prodotti dell’azienda e quindi il mondo virtuale traina le vendite del mondo reale.
Il punto di svolta per le aziende nel mondo digitale sta nel comprendere che i tradizionali modelli di business
online, quali l’advertising, non sono più profittevoli, e in realtà non sono mai stati profittevoli come attualmente
la vendita di beni virtuali tramite micro-pagamenti. Questo nuovo modello di business permette alle aziende
di avere meno pressione in ambito digitale, non dovendosi più basare esclusivamente sulla pubblicità. Inoltre
le potenzialità di traino del mondo digitale sul mondo reale sono molteplici, in quanto permettono una
comunicazione integrata dei valori del brand, aumentano la brand awareness e guidano all’acquisto di beni
virtuali o alla ricerca dell’omaggio da parte dell’azienda del bene virtuale oggetto del desiderio, grazie
all’acquisto offline di un prodotto. Questo per riprodurre fedelmente nel mondo online il proprio status, la
propria personalità e le preferenze del mondo reale, tutti fenomeni che le aziende non possono più ignorare.
Gli Autori
Sivia Vianello è SDA Bocconi professor di Marketing.
Aree di interesse scientifico
Digital marketing. Pricing. Marketing farmaceutico. Marketing strategico. Green Marketing.
Franco Denari è Country manager di Sulake Italia.
Da Bocconi Newsletter no. 112/2011
102
Tecnologia e Innovazione
Quando duemila computer possono non bastare
di Emanuele Borgonovo
Disponiamo di modelli quantitativi a supporto delle decisioni
sempre più raffinati. Emanuele Borgonovo, direttore del Centro
Eleusi Bocconi, richiama però l’attenzione sulle insidie celate
nell’eccesso di fiducia e nell’uso acritico degli schemi
matematici.
Come ci insegnano le più recenti e anche le più classiche monografie di svariati settori, dalla climatologia alla
finanza, il moderno processo di decisione ha, tra le sue principali leve informative, il modello quantitativo
costruito a supporto della soluzione del problema. Mediante il modello, lo scienziato, l’ingegnere, il manager
riescono a mettere a fuoco gli aspetti principali del problema, a ricomporli in un unico pezzo di carta (o di
calcolatore) e vengono aiutati a scegliere la migliore tra le alternative disponibili.
È indubbio che un buon modello sia uno strumento indispensabile. Ne sono esempi i modelli idrologici e
meteorologici. Quelli disponibili per la nostra regione avrebbero previsto in anticipo l’esondazione del Seveso
di qualche mese orsono. Se i loro risultati fossero stati presi in considerazione per tempo, si sarebbero evitati i
parecchi milioni di euro di danni. Purtroppo, nessun modello ad oggi sarebbe stato in grado di prevedere il
terremoto e il conseguente tsunami che hanno colpito Fukushima. Nemmeno la grave rottura della
piattaforma nel golfo del Messico della British petroleum o il fallimento della Lehman Brothers sono stati previsti
da modelli, in questi ultimi casi forse per la mancanza di modelli dedicati a questo tipo di problemi. La
mancanza di un modello o la sua inadeguatezza, tuttavia, portano alla medesima conseguenza: una cattiva
o parziale informazione. Non a caso, si parla di rischio di modello, ovvero di una decisione subottimale a
causa di una non completa considerazione dell’incertezza legata alle previsioni numeriche. Un recente
dibattito nella climatic change community sottolinea la necessità che allo sviluppo di modelli sia
contrapposta un’analisi di incertezza che sia in grado di evitare il rischio di overconfidence nei risultati del
modello. L’Agenzia per la protezione ambientale statunitense (Us Epa) raccomanda l’utilizzo di tecniche di
analisi di incertezza e sensibilità affinché il grado di confidenza nel risultato del modello sia reso trasparente ai
policy maker. La questione si complica ancora se si cerca di prevedere eventi rari e catastrofici come le
conseguenze dell’uragano Katrina. In quel caso, le sfide per i modelli numerici sono notevoli.
103
Tecnologia e Innovazione
Quando l’evento da cogliere ha probabilità bassa occorre forzare le simulazioni Monte Carlo (un metodo
statistico non parametrico) nella giusta direzione. Le tecniche che si propongono di raggiungere questi scopi
sono costose dal punto di vista computazionale. Etienne de Rocquigny, deputy vice rector of research a
Ecole Centrale Paris e membro dello steering committee del centro Eleusi Bocconi, ha spiegato in un recente
seminario come Electricité de France, una delle maggiori industrie energetiche europee, abbia circa 1800
computer che corrono in parallelo per proiezioni e analisi di rischi ambientali. Ma anche questo sforzo di
calcolo potrebbe non bastare. Dall’errore di sovrastima o sottostima di un modello occorre imparare per
costruirne uno migliore. In questo senso, i passi avanti sono stati molti. Un esempio su tutti è rappresentato
dalla migliore accuratezza dei modelli meteorologici moderni rispetto a quelli di 15 anni fa.
Per costruire modelli numerici ancora migliori occorre tuttavia un’analisi dettagliata degli aspetti anche
realistici che hanno condotto all’errore della versione precedente. Per esempio, una delle conclusioni intuitive
dopo l’incidente di Fukushima è quella di elevare l’altezza sul mare di certi componenti critici, che eviterebbe
loro di essere travolti dalle onde. Un recente report del Mit riporta i risultati di un’analisi coreana che ha
mostrato come aumentando l’elevazione al suolo di questi componenti ne si diminuisce la resistenza agli
shock sismici; dunque, in Corea, tali componenti sono interrati, una scelta che, in primis, sembra
controintuitiva.
L’uso di un modello deve quindi essere accompagnato da una visione critica, sia nel momento della sua
costruzione sia dello sfruttamento del contenuto informativo che è parte integrante del processo di decisione
ormai della vita di tutti noi: chi non guarderà il meteo domani mattina?
L’Autore
Emanuele Borgonovo è direttore dell’Eleusi Bocconi, il Centro per l’Elaborazione logica e l’utilizzazione
sistematica dell’informazione.
Aree di interesse scientifico
Metodi matematici per l’analisi di sensibilità locale e globale. Analisi di incertezza. Analisi del rischio.
Modellazione finanziaria. Valutazione di Investimento. Opzioni Reali. Project Financing. Teoria delle decisioni.
Da Bocconi Newsletter no. 116/2011
104
Finanza
Finanza
Dammi tre parole e le banche cambieranno
di Stefano Caselli
Territorio, persone e buon governo: per Stefano Caselli,
direttore della Divisione Banche e intermediari finanziari della
SDA Bocconi, attorno a questi tre temi ruota l’innovazione delle
banche italiane, con le sfide dell’individuazione del modello di
offerta e del posizionamento strategico.
Il tema delle regole e quello dei risultati hanno fortemente caratterizzato il dibattito e la vita quotidiana delle
banche italiane negli ultimi tre anni. Giunti alla fine del 2010, la sensazione è che ci si appresti a un cambio di
pagina e all’apertura di un nuovo capitolo.
Sul fronte dei risultati le banche hanno raggiunto una stabilità dignitosa, combinando un mix di guadagni
provenienti dall’attività creditizia, dal sistema retail e della componente dell’asset management non più
fondato su una prospettiva di accelerazione e di euforia ma piuttosto di difesa e di equilibrio, in presenza di
tassi stabilmente allineati verso il basso. Ciò accompagnato da un’attenzione ai costi e da un controllo del
credito che ha permesso di contenere le potenziali perdite. Sul fronte regole, il varo di Basilea 3 ha definito
una road map di medio termine che disegna una strada di crescita dei requisiti di patrimonializzazione.
Il nuovo è invece la sfida dell’individuazione del modello di offerta e del posizionamento strategico di
ciascuna banca per i prossimi anni, che ruota intorno a tre temi fondamentali: il territorio, le persone, il buon
governo.
Sul fronte del territorio, la sfida è il ritorno alla comprensione delle specifiche economiche locali. Per le banche
più piccole, il territorio è da sempre il campo di gioco principale; tuttavia, la vicinanza ai clienti e la
personalizzazione non sono sufficienti se a questi valori non è data una prospettiva di internazionalizzazione,
che permetta anche alle piccole aziende di partecipare a una sfida imprenditoriale sempre più globale. Per
le banche più grandi, la riconquista del territorio può fondarsi sulla promozione della qualità dei prodotti,
sull’efficienza e sulla scala più ampia, ma deve essere coniugata con una prospettiva di compatibilità
economica. Grandi e piccole banche dovranno contemperare punti di partenza molto diversi, evitando che
il territorio diventi un alibi per non offrire quei servizi e quella prospettiva internazionale di cui le imprese (e il
sistema paese) necessitano.
107
Finanza
Sul tema delle persone, la sfida è la riconquista della fiducia e la manifestazione di una progettualità chiara. E
le persone sono sia i clienti, sia le risorse umane. Pur con diversità sostanziali, le sfide aperte sui due fronti sono
molto simili in quanto la fiducia e la progettualità diventano solide quando si pongono le persone al centro
del sistema produttivo e valoriale della banca. Per i clienti, la semplicità dei prodotti e la chiarezza sostanziale
per il pubblico al dettaglio da un lato, la personalizzazione spinta, la sofisticazione del prodotto e la
professionalità della relazione per i clienti corporate e private dall’altro, sono le direzioni da perseguire. Sul
versante del personale, la sfida più complessa è la valorizzazione dei talenti.
Sul tema del buon governo, il percorso di capitalizzazione e di irrobustimento patrimoniale richiede
un’attenzione forte alla governance e al ruolo degli azionisti che dovranno sostenere il percorso stesso
attraverso o l’utilizzo di proprie risorse o l’accettazione di nuovi soci e rapporti di potere fra i soci esistenti.
Peraltro, se il tema della governance si riduce a un mero equilibrio fra posizioni, gli aspetti del territorio e della
rilevanza dei clienti assumono un ruolo di comparse. Il tema decisivo è invece quello del ruolo dei soci e della
loro capacità di indirizzo e di determinazione chiara degli obiettivi strategici delle loro banche. Come
sottolineava Giorgio Ruffolo quasi trent’anni fa, gli shareholder di istituzioni complesse, come i banchieri,
hanno nelle loro mani una straordinaria potenza: sostenere imprese e istituzioni, finanziarle, contribuire in modo
decisivo alla crescita del sistema economico. Ma tale potenza deve essere accompagnata dalla saggezza.
In questo senso, è ancora valida la riflessione di Cesarini, Monti e Scognamiglio nel loro rapporto al Ministero
del Tesoro negli anni ’80, che apriva la via a una strada di privatizzazioni: non è rilevante chi agisca come
azionista della banca, ma quale sia la sua visione nitida, trasparente e a lungo termine dell’utilizzo delle risorse
disponibili nonché di responsabilità nella guida di un’istituzione-chiave per il sistema economico.
L’Autore
Stefano Caselli è professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari alla Bocconi e direttore della
Divisione Banche e intermediari finanziari della SDA Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Corporate Banking e Corporate Finance. Credit Risk Management. Finanza delle piccole e medie imprese e
delle imprese familiari. Leasing. Private equity e venture capital.
Da Bocconi Newsletter no. 100/2011
108
Finanza
Le borse hanno paura dei disastri,
anche poco probabili
di Nicola Misani
Costruire un reattore nucleare può costare dai 5 ai 10 miliardi di
euro: una cifra paragonabile al valore di borsa dell’impresa
che vuole realizzarlo. Nicola Misani, docente Bocconi di
Economia e gestione delle imprese, mostra come sia arduo
trovare finanziamenti nei settori a rischio di catastrofe.
Secondo i dati raccolti da Swiss Re, negli ultimi dieci anni il numero di catastrofi naturali o di origine umana è
stato oltre il doppio di quello degli anni Ottanta. Un aumento ancora maggiore si è verificato per i danni
economici a carico di persone e organizzazioni.
Questa tendenza sembra irreversibile, a causa di alcuni fenomeni. Intanto, i mutamenti del clima dovuti al
riscaldamento globale, che sembrano influire sulla frequenza e l’intensità degli uragani e di altri disastri
meteorologici. E poi la crescita della popolazione mondiale, con un conseguente incremento della densità
demografica in aree esposte a eventi catastrofici, e l’incremento del valore complessivo delle unità a rischio,
in particolare della proprietà immobiliare privata e commerciale, come conseguenza dell’aumento del
reddito pro-capite e delle attività industriali e di servizi. L’incidente della centrale nucleare di Fukushima
suggerisce che anche certe tecnologie intrinsecamente pericolose possono registrare nel tempo un aumento
degli incidenti, in conseguenza dell’allargamento della base installata e dell’invecchiamento degli impianti.
Ciò che contraddistingue un rischio catastrofale è il combinarsi di un’elevata severità delle perdite potenziali
e di una bassissima probabilità di accadimento. La ricerca psicologica ha rivelato che gli esseri umani
faticano ad adottare atteggiamenti razionali verso questo tipo di eventi. Per esempio, uno studio di qualche
anno fa mostrava che i residenti dei paesi che si trovano a valle di una diga sono certi che il crollo sia
impossibile; si fidano delle rassicurazioni dei tecnici e attribuiscono i crolli del passato a errori irripetibili. Tuttavia,
le persone cancellano dalla mente solo i pericoli esistenti, cui sono già esposti e che non potrebbero evitare.
Al contrario, i rischi catastrofali nuovi ed evitabili suscitano fortissimi rifiuti emotivi, come se l’eventualità di un
incidente fosse certa.
109
Finanza
I rischi catastrofali sono difficili da trattare anche sul piano scientifico. La probabilità di accadimento
dovrebbe dipendere dalla frequenza con cui l’evento si è verificato in un arco di tempo abbastanza lungo.
Nel caso di catastrofi, l’evento può però essere così raro da determinare un’assenza o una povertà di dati
storici. Le stime di probabilità devono quindi essere ricavate per via ingegneristica, con tutti i limiti della
capacità umana di calcolare situazioni imprevedibili. È qui inevitabile un parallelo fra l’incidente di Fukushima
e la crisi bancaria del 2008, in quanto in entrambi i casi gli esperti ci avevano rassicurato che la catastrofe era
impossibile.
Per definizione, i rischi catastrofali possono compromettere la sopravvivenza stessa di un’impresa. Per la loro
dimensione, risulta inoltre difficile trasferirli ai mercati assicurativi o finanziari. Per citare di nuovo il caso del
nucleare, è noto che il solo costo di costruzione di un reattore nucleare può essere così grande (dai 5 ai 10
miliardi di euro) da essere paragonabile al valore di borsa dell’impresa che vuole realizzarlo. Di conseguenza,
le borse considerano i reattori nucleari un rischio eccessivo che rifiutano di finanziare; quando interviene lo
stato, comunque può chiedere alle imprese costi troppo alti. Nello scorso ottobre l’azienda elettrica
americana Constellation Energy ha rinunciato a costruire un nuovo impianto nucleare nel Maryland dopo che
il governo aveva chiesto una fee di 880 milioni di dollari per garantire un finanziamento di 7,6 miliardi di dollari
(per un costo percentuale di 11,6%). Questo costo non considera tutti gli oneri di risarcimento che
potenzialmente ricadrebbero su un’impresa in caso di incidente nucleare con danni alle persone o a terze
organizzazioni.
È pertanto difficile che rischi catastrofali di queste dimensioni possano essere gestiti dai privati, anche se le
forme di collaborazione (finanziaria e tecnica) con il settore pubblico sono ancora in gran parte da definire
L’Autore
Nicola Misani è ricercatore di Economia e gestione delle imprese alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Strategia. Responsabilità sociale d'impresa. Corporate governance. Gestione del rischio. Imprenditoria
sostenibile.
Da Bocconi Newsletter no. 109/2011
110
Finanza
Le strade dei soldi
di Giorgio Fiorentini e Giuseppe Ambrosio
Le emergenze umanitarie richiedono grandi risorse economiche
e finanziarie. Giorgio Fiorentini (docente Bocconi di Economia
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche) e Giuseppe
Ambrosio (Unicredit Foundation) spiegano a quali condizioni il
fund raising è più efficace.
Di fronte alle emergenze umanitarie sono necessari enormi quantitativi di beni di primo soccorso come tende,
coperte, medicine, alimenti per la popolazione e di risorse economiche e finanziarie. Anche la post
emergenza richiede risorse importanti, ma i bisogni, e quindi gli obiettivi e il metodo di intervento, mutano. Il
fabbisogno finanziario fra emergenza e post emergenza ha una dinamica diversa e, di conseguenza, cambia
il modo di fare fund raising.
Le poche organizzazioni private al mondo che agiscono in prima emergenza (la più grande è Medici Senza
Frontiere) devono quindi avere investito preventivamente in attrezzature e stock di beni prima dell’utilizzo e
attivare il fund raising per poter essere pronti per future calamità. In caso di post emergenza invece il fund
raising può essere attivato ad hoc e raccogliere in maniera finalizzata. Per comprendere i differenti obiettivi di
fund raising basta citare un episodio eclatante che avvenne il 4 gennaio 2005 quando MSF bloccò la raccolta
fondi per lo tsunami in Indonesia perché in meno di 10 giorni a livello mondiale furono raccolti 40 milioni di
euro che superavano di gran lunga le necessità di spesa di MSF per la prima emergenza di tale calamità.
Affinché il fund raising per le emergenze umanitarie sia efficace e produttivo vi sono infatti alcune condizioni
da gestire. Innanzitutto, l’emergenza deve essere seguita in maniera continuativa dai principali mass media
(cd. media driven emergency). Per esempio in Italia, nell’ultimo periodo non vi è stata attenzione mediatica
prevalente per la catastrofe Giappone. Inoltre, un’organizzazione umanitaria coglie il beneficio di
comunicare velocemente ai propri donatori e all’opinione pubblica la gravità della situazione e il proprio
ruolo di aiuto se esiste un focus mediatico di contesto. Questo permette l’uso di immagini e testi più essenziali:
la loro funzione, in questo caso, non è quella di spiegare nel dettaglio l’emergenza in corso, poiché i media
hanno già informato circa l’accaduto, bensì comunicare i microprogetti d’intervento.
111
Finanza
In secondo luogo, il fund raising è solitamente facilitato dalla presenza di associazioni, comitati, ong che nel
territorio colpito dalla catastrofe svolgono una funzione di mediazione e organizzazione degli investimenti
donativi e offrono una fiducia ‘terza’ (rispetto alle istituzioni) di corretta gestione.
Infine, poiché le emergenze nascono da eventi improvvisi, di riflesso anche gli strumenti di fund raising devono
caratterizzarsi per immediatezza di reazione. Per esempio, gli sms solidali sono lo strumento più usato: oltre al
semplice messaggio, sono stati sviluppati una serie di servizi ad esso legati, come l’sms che autorizza la
donazione tramite paypal o carta di credito. Oppure una donazione chiamata ‘airtime’, con la quale anche
persone temporaneamente presenti in una nazione diversa da quella d’origine possono effettuare donazioni
alla causa locale. Un’altra applicazione è Cause World: una sorta di ‘check-in’ in negozi che aderiscono a
una campagna, con cui si possono accumulare punti da donare a specifiche cause umanitarie. Non sono
richiesti acquisti o versamenti di denaro, in quanto sono gli sponsor di CauseWorld a pagare.
Gli Autori
Giorgio Fiorentini è professore associato di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche in
Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Gestione del personale. Management e marketing non profit. Marketing per fornitori dello Stato. General
management. Marketing pubblico.
Giuseppe Ambrosio lavora presso Unicredit Foundation.
Da Bocconi Newsletter no. 112/2011
112
Finanza
Chi deve pagare per il consulente
di Paolo Cucurachi
L’FSA, l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari britannici, ha
vietato alle società prodotto di corrispondere ai consulenti
commissioni o pagamenti: una norma coraggiosa, secondo
Paolo Cucurachi, docente SDA di Intermediazione finanziaria e
assicurazioni.
Un significativo numero di banche italiane si sta interrogando su quale impostazione dare al servizio di
consulenza finanziaria ridisegnato dalla normativa Mifid che, sebbene non recente, ha sinora spesso trovato
delle risposte di adesione formale più che sostanziale al dettato normativo. In questo quadro si inserisce una
normativa varata dalla Fsa inglese (l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari britannici) che nel ridisegnare il
rapporto tra consulente e cliente ha ulteriormente rafforzato la già presente disciplina sugli incentivi pagati
all’intermediario da un soggetto diverso dal cliente (inducement), vietando a partire dal 2013 alle società
prodotto di corrispondere ai consulenti commissioni, pagamenti o altre forme di incentivo.
La ratio della normativa è chiara e coraggiosa allo stesso tempo: è chiara in quanto la migliore garanzia che il
consulente eroghi un servizio nel pieno interesse del cliente è che lo stesso riceva la propria remunerazione
soltanto dal fruitore del servizio non potendo essere condizionato da alcuna forma di pagamento da parte
delle società prodotto; è coraggiosa in quanto il conto economico delle banche (soprattutto italiane) riposa
largamente sulle retrocessioni riconosciute dalle società prodotto e pertanto questo cambiamento di
approccio mette in discussione uno schema consolidato di funzionamento di quest’area di business.
Sebbene la normativa inglese non abbia alcun impatto nel nostro paese, è inevitabile che si sia avviata una
discussione sull’opportunità di andare anche in Italia in questa direzione valutando le conseguenze che
l’adozione di una simile regola potrebbe avere sull’industria dell’asset management.
La strada che la nuova disciplina inglese indica con chiarezza e che potrebbe essere avviata anche a
normativa vigente è quella del collocamento alla clientela delle sole classi istituzionali con il conseguente
venir meno della distinzione rispetto alle classi retail che sono caratterizzate dalla presenza di commissioni di
gestione più elevate finalizzate esclusivamente alla remunerazione, per il tramite delle cosiddette
retrocessioni, delle reti distributive.
113
Finanza
L’effetto immediato e dirompente di una simile scelta sarebbe, dal lato della distribuzione, quello di obbligare
le banche a chiedere al cliente una remunerazione esplicita per il servizio offerto che necessariamente
dovrebbe essere allineata con la qualità (effettiva e percepita) dello stesso e, dal lato della produzione,
quello di perdere un’arma commerciale nella promozione dei propri prodotti e di rendere esplicita la
capacità di creare valore rispetto al benchmark dei gestori attivi.
Un corollario importante di una simile scelta sarebbe infatti quello di indurre ad effettuare delle scelte di
campo tra gestione attiva e gestione passiva che, dal lato della distribuzione, non dovrebbero essere guidate
da finalità legate alla maggiore remunerazione ottenuta quanto piuttosto alla effettiva capacità di generare
rendimenti differenziali positivi rispetto ai mercati di riferimento. Ciò dovrebbe favorire l’uscita dal mercato di
tutti quei prodotti che dichiarano obiettivi di investimento finalizzati al superamento del benchmark
esclusivamente per giustificare le maggiori commissioni di gestione (da retrocedere ai distributori) piuttosto
che per comprovate capacità gestionali e che proprio per recuperare un po’ di redditività propria riescono
grazie alla scelta di opportuni parametri di riferimento (indici price index versus total return) a caricare sui
clienti commissioni di incentivo chiaramente non motivate dalle performance realizzate.
La sensazione è che una disciplina in linea con quella varata dall’Fsa potrebbe dare un ulteriore importante
contributo nel senso della trasparenza anche all’interno di un segmento, quello dei fondi comuni, che già si
caratterizza per standard particolarmente elevati rispetto ad altre tipologie di prodotti. Il vero obiettivo da
centrare però sarebbe quello di recidere il cordone ombelicale che collega produzione e distribuzione per il
tramite delle retrocessioni e che troppo spesso determina comportamenti commerciali product driven
piuttosto che customer driven.
L’Autore
Paolo Cucurachi è SDA Bocconi professor di Intermediazione finanziaria e assicurazioni e ordinario di
Economia degli intermediari finanziari all'Università del Salento.
Aree di interesse scientifico
Asset management.
Da Bocconi Newsletter no. 115/2011
114
Finanza
Così non si cura la febbre
di Andrea Resti
Le agenzie di rating sono state di recente al centro di molte
polemiche, sia negli USA sia in Europa. Ma secondo Andrea
Resti, docente del Dipartimento di Finanza Bocconi, è come se
qualcuno, non riuscendo a curare la febbre, suggerisse di
spezzare il termometro.
La scorsa estate le agenzie di rating sono state al centro di polemiche su entrambe le sponde dell’Atlantico.
Negli Usa ha fatto discutere la decisione di Standard & Poor’s di tagliare il rating del debito pubblico,
tradizionalmente pari a AAA, per segnalare un limitato incremento del rischio; in Europa, Moody’s ha rivisto
pesantemente il giudizio assegnato al Portogallo suscitando critiche anche da parte del presidente
(portoghese) della Commissione Europea.
Sorprendono, per certi versi, le accuse dei politici e dei grand commis di Stato alle agenzie di rating, cui
spetta l’ingrato compito di segnalare per tempo l’inasprimento dei rischi per i risparmiatori. Proprio la politica,
mostrandosi indecisa nell’arginare la tempesta dei mercati, ha contribuito all’aggravarsi dei timori degli
investitori (dipinti dai telegiornali come orridi speculatori intenti a bombardare le borse con granate di vendite
allo scoperto, quando spesso si tratta solo di gestori del risparmio preoccupati di portare a casa la pelle,
propria e dei piccoli clienti). Da una parte il mediocre compromesso raggiunto alla tredicesima ora dal
parlamento statunitense per scongiurare, in agosto, il rischio di insolvenza sui bond del Tesoro; dall’altra le
difficoltà dei governi dell’area euro nel costruire un argine alla crisi del debito sovrano che fosse insieme
efficace e politicamente accettabile per l’opinione pubblica tedesca. Di fronte a rinvii e balbettii sintomatici
di una limitata e tardiva capacità di intervento, sarebbe stato difficile per i custodi del rating restarsene inerti;
a maggior ragione dopo che, nel 2008, furono accusati di non aver segnalato per tempo ai mercati il
progressivo aggravarsi della crisi finanziaria.
Rileggendo le dichiarazioni estive dei politici europei si ha l’impressione che qualcuno, forse perché incapace
di curare la febbre, stia accarezzando l’idea di spezzare il termometro. Due proposte sono singolari.
La prima (condivisa, si dice, anche da figure come il commissario europeo Michel Barnier e Christine Lagarde,
direttrice del Fmi) è quella di imporre alle agenzie di non diffondere indicazioni di rating sui paesi oggetto di
115
Finanza
piani di salvataggio. Oltre che inquietante (perché vieta a qualcuno di manifestare la propria opinione),
l’idea è potenzialmente controproducente: se alle agenzie si proibisce di comunicare col mercato, esse non
potranno tagliare il rating quando necessario, ma nemmeno rassicurare gli investitori in caso di novità positive.
Di fronte a un simile blackout è improbabile che il mercato reagisca con compostezza, accontentandosi dei
comunicati stampa di qualche vertice europeo che assicurano che tutto è (per ora...) sotto controllo.
La seconda è quella di creare con capitali europei (pubblici?) un’agenzia di rating “de noantri”, da
contrapporre allo strapotere dei perfidi analisti americani. La proposta non convince. Primo, il declassamento
del debito Usa dimostra che le agenzie non hanno timori reverenziali verso il paese dove hanno sede legale.
Secondo, un’agenzia finanziata (e controllata) dal settore pubblico potrebbe peccare di benevolenza verso
il proprio azionista. Infine, un rating ‘promosso’ dallo Stato o dall’Ue avrebbe, agli occhi dei risparmiatori, il
valore di un sigillo di qualità, una sorta di garanzia implicita che sgombra il campo dai timori di default (ma
non dal rischio che il default avvenga lo stesso).
La riforma più urgente non riguarda le agenzie ma la regolamentazione. In passato normative hanno
assegnato ai rating una sorta di valore legale, consentendo ad esempio risparmi patrimoniali alle banche che
acquistavano bond provvisti di tripla A. Tali normative andrebbero alleggerite, riportando i rating al loro ruolo
originario: un’opinione emessa da un operatore specializzato. Sarà difficile però smantellarle, visto che prima
di togliere ai rating il loro ruolo regolamentare si dovrebbe sostituirli con un sistema migliore per misurare il
rischio. Che per ora non si vede.
L’Autore
Andrea Resti è professore associato del Dipartimento di Finanza della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Sistemi di rating, VaR creditizio e Accordo di Basilea sul Capitale. Fusioni e aggregazioni tra banche. Asset
management e private banking. Misura dell'efficienza degli intermediari finanziari.
Da Bocconi Newsletter no. 116/2011
116
Finanza
Piccolo è bello a Piazza Affari,vedi le small caps
di Alberto Dell’Acqua
Uno studio Bocconi dimostra che le imprese a ridotta
capitalizzazione hanno un sovra-rendimento medio del 581% su
10 anni. Lo spiega Alberto Dell’Acqua, docente di
Amministrazione, controllo, finanza aziendale e immobiliare alla
SDA Bocconi.
Lo slogan “Piccolo è bello!” capace di caratterizzare l’economia italiana e le performance sorprendenti della
sua struttura di piccole e medie imprese, spesso organizzate in distretti o reti, sembra ormai essere passato di
moda. La globalizzazione, la delocalizzazione e non ultima la crisi del sistema finanziario e creditizio sembrano
aver colpito al cuore il sistema produttivo basato sulla piccola e media industria, per sostituirlo con i nuovi
modelli di impresa su scala globale. Esiste però un luogo dove lo slogan in questione non è passato di moda.
Questo luogo è la Borsa italiana.
Uno studio empirico sulle imprese di ridotta capitalizzazione, c.d. small caps, quotate sul listino azionario di
Milano ha permesso di evidenziare una sovra-performance dei titoli di minore capitalizzazione rispetto ai titoli
di maggiore dimensione e rispetto all’indice borsistico. Tale sovra-rendimento è presente sia nel breve che nel
medio-lungo periodo. Lo studio (Economia & Management, settembre-ottobre 2011) è stato condotto su tutte
le azioni ordinarie quotate sul mercato azionario italiano nel periodo 21 Dicembre 1988 - 21 Dicembre 2009,
per un orizzonte temporale complessivo di 21 anni (252 mesi) e per un totale di 560 società. L’analisi
comparata del decile contenente i titoli di minore capitalizzazione (“small portfolio”) con il decile che
comprende quelli di maggiore capitalizzazione (“big portfolio”) mostra un sovra-rendimento medio del primo
rispetto al secondo pari al 14% su un periodo di detenzione di un anno. Tale sovra-rendimento sale al 66%
sull’orizzonte di tre anni e del 183% sull’orizzonte di cinque anni, mentre su un orizzonte di 10 anni il sovrarendimento è addirittura del 581% (in pratica in 10 anni un euro investito nel portafoglio dei titoli a più bassa
capitalizzazione ne rende quasi sei in più dello stesso euro investito nel portafoglio dei titoli a più elevata
capitalizzazione). La frequenza di sovra-rendimento mostra inoltre che su un periodo di un anno i titoli small
sovra-performano i titoli big per il 70% delle volte; tale percentuale sale all’84% in 5 anni e al 100% in 10 anni.
Diverse possono essere le motivazioni alla base della sovra-performance dei titoli a più bassa capitalizzazione
che la letteratura in campo finanziario ha già ampiamente indagato soprattutto con studi condotti sui
117
Finanza
mercati azionari più evoluti, come quello Usa. Le cause di questo fenomeno sembrano essere solo in parte
riconducibili al solo ‘effetto dimensione’ ma sono da ascrivere ad altre cause come il maggiore rischio non
catturato dai più noti modelli di rischio-rendimento, i maggiori costi di transazione, la presenza di
un’informazione limitata e l’illiquidità dei titoli small cap. Sul mercato azionario italiano non erano stati ancora
condotti studi simili e i risultati dell’analisi stimolano future ricerche sulle motivazioni della sovra-performance
delle small caps sul nostro listino.
L’analisi ha poi cercato di posizionare l’investimento in small caps da parte di un investitore comparandone i
rendimenti con un investimento in fondi di private equity, assimilabile per il sottostante che è spesso
rappresentato da piccole e medie imprese con profilo di rischio medio-alto. La comparazione dei rendimenti
al netto delle tasse dei fondi di private equity italiani con quelli del portafoglio small analizzato nello studio
mostra una sostanziale equivalenza nel periodo 1999-2009 (entrambi rendono circa il 18%). Questo riscontro
posiziona gli investimenti in small cap in una classe d’investimento assimilabile a quella dell’investimento in
fondi di private equity. Sarà forse una casualità, ma negli ultimi anni sono nati operatori specializzati che
investono capitali privati in piccole e medie imprese quotate, i c.d. Pipe (Private investment in public equity). Il
fenomeno già sviluppatosi da qualche anno nel mercato statunitense sta conoscendo un primo sviluppo
anche in Italia. Forse grazie a questi nuovi modi d’investire i capitali finanziari, piccolo continuerà a essere
bello sul mercato azionario italiano.
L’Autore
Alberto Dell'Acqua è SDA Bocconi professor di Amministrazione, controllo, finanza aziendale e immobiliare.
Aree di interesse scientifico
Finanza d’impresa. Valutazione d’azienda. Operazioni di M&A. Finanza delle Piccole e Medie Imprese.
Entrepreneurial Finance. Real Estate. Private Equity e Venture Capital. Corporate Governance.
Da Bocconi Newsletter no. 117/2011
118
Finanza
Pericolo longevità? L’arma in più sono i bond
di Carlo A. Favero
La vita media aumenta, e i sistemi pensionistici devono
prevedere il rischio di pagare rendite vitalizie sempre più
lunghe. Carlo A. Favero, titolare in Bocconi della Deutsche Bank
Chair, spiega che cosa sono i “longevity bond” e chi potrebbe
emetterli.
Le recenti tendenze di riforma dei sistemi pensionistici si orientano verso piani a contribuzione definita. In
questo contesto le pensioni assumono la forma tipica di rendita vitalizia, la quale è basata su contributi
corrisposti dal soggetto assicurato prima del pensionamento ed è pagata finché l’individuo è in vita. Se la vita
dell’individuo risulta più lunga di quella attesa al momento in cui sono stati pagati i contributi le compagnie di
assicurazione e le istituzioni che offrono i piani pensionistici sono soggetti a un particolare tipo di rischio: il
rischio di longevità.
Il rischio di longevità ha due componenti, una individuale e l’altra aggregata. La componente individuale
dipende dal fatto che ognuno può vivere più a lungo della media degli individui della sua età, mentre quella
aggregata dipende da come si evolve nel tempo la durata della vita di tutta la popolazione. La componente
individuale del rischio di longevità è diversificabile offrendo piani pensione a gruppi ampi e diversificati (in
termini di rischio di mortalità) di persone. La componente aggregata è invece per sua natura non
diversificabile attraverso un ampio portafoglio, proprio perché per sua natura influenza tutti gli individui.
L’esistenza di questa componente aggregata del rischio di longevità genera tre questioni. Quanto è
importante tale componente? Come si misura il rischio aggregato di longevità? È possibile creare strumenti
per diversificarlo? I dati ci dicono che la componente aggregata del rischio di longevità è importante. La
probabilità di morire entro un anno dopo i 65 anni si è grandemente ridotta per tutta la popolazione negli
ultimi 40 anni. Ma tale riduzione non è avvenuta in maniera uniforme. I dati per il Regno Unito ci dicono che i
miglioramenti nella mortalità a età avanzata sono stati più drastici di quelli per gli individui tra i 65 ed i 70 anni.
Nel 1971 un individuo di 65 anni aveva una probabilità di essere vivo a 69 anni del 81%, di essere vivo a 79 anni
del 34% e di essere vivo ad 89 anni del 5%. Queste probabilità si sono spostate rispettivamente al 92%, 64 %, e
20 % nel 2009.
119
Finanza
Diventa quindi importante chiedersi come si evolverà la mortalità nel futuro. I modelli stocastici di mortalità ci
permettono di misurare il rischio di longevità indicando previsione per la mortalità futura e intervalli di
confidenza intorno a queste previsioni. L’ampiezza degli intervalli di confidenza definisce il rischio di mortalità.
La simulazione previsiva di un modello a fattori per la mortalità ci dice che nel 2020 la probabilità che un
individuo in vita a 65 anni raggiunga i 90 anni avrà un valore atteso del 25%, ma l’intervallo di confidenza al
95% su questo valore atteso è compreso tra il 17 ed il 33%. Il fatto che il 33% piuttosto che il 25% dei 65enni sia
in vita a 90 anni espone le istituzioni che pagano rendite vitalizie a un rischio notevole.
La questione che ci si pone è come sia possibile diversificare questo rischio. La proposta emersa in letteratura
e che è già stata occasionalmente implementata è quella di creare un mercato per i ‘longevity bond’, cioè
obbligazioni indicizzate alla longevità. I longevity bond sono prodotti finanziari che pagano una cedola
indicizzata alla mortalità realizzata per una specifica coorte di individui. Un longevity bond emesso nell’anno
2012 indicizzato alla mortalità dei 65enni nel 2012 paga una cedola proporzionale alla mortalità
effettivamente osservata dal 2012 in poi di coloro che nel 2012 hanno 65 anni. Ovviamente se i 65enni hanno
una sopravvivenza superiore alle aspettative nel 2012 la cedola risulta essere più elevata di quella attesa nel
2012. Questo meccanismo permette all’acquirente di longevity bond di avere nel suo portafoglio uno
strumento di diversificazione del rischio di longevità. La questione spinosa legata ai longevity bond è quale
istituzione sia la più indicata per emetterli. Una corrente di pensiero nota che tali bond sono uno strumento per
risolvere un fallimento del mercato che è generato dal fatto che le generazioni future sono per loro natura
escluse dai mercati delle assicurazioni. In questo contesto il benessere della collettività migliora con un
intervento del governo perché il potere di tassazione consente ai governi di fare redistribuzione tra le diverse
generazioni. Quest’argomento porterebbe a indicare il governo come l’emittente naturale di longevity bond.
Ma la questione è dibattuta per due ragioni: la prima è che non è ovvio che i governi redistribuiscano tra le
generazioni in maniera ottimale perché le generazioni contemporanee votano e quelle future no, la seconda
è che l’emissione di longevity bond aumenterebbe l’esposizione dei governi al rischio di longevità. Il rischio di
longevità pone interessanti questioni di misurazione, di previsione e di costruzione di un mercato per la sua
diversificazione. Tutte questioni sulle quali il dibattito è ancora molto aperto all’interfaccia tra demografia,
finanza ed economia pubblica.
L’Autore
Carlo A. Favero è professore ordinario titolare della Deutsche Bank Chair in Quantitative Finance and Asset
Pricing della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Econometric Modelling of Bond and Stock Prices. Applied Econometrics, Monetary Policy and Time-series
Models for Macroeconomics and Finance.
Da Bocconi Newsletter no. 117/2011
120
Finanza
Fondi sovrani, sfida globale
di Bernardo Bortolotti
I fondi sovrani sono i nuovi protagonisti della finanza mondiale,
con oltre 2.700 miliardi di dollari di valore. Per Bernardo
Bortolotti, direttore del Sovereign Investment Lab Bocconi, sono
molti gli interrogativi posti dal ritorno, di fatto, del capitalismo di
stato su scala globale.
I fondi sovrani sono i nuovi protagonisti della finanza globale. Secondo le stime, oggi gestiscono un patrimonio
di oltre 2.700 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai trend di altri investitori istituzionali, quali i fondi
pensione, i fondi comuni o gli hedge funds, e che potrebbe superare i 7.000 miliardi nel 2017. Ma la crescita
dei fondi sovrani non interessa solo il mondo della finanza: in realtà, essi sono un segnale anticipatore di una
grande riallocazione del potere economico globale verso i paesi emergenti che in termini di dimensione,
velocità e flussi direzionali non ha precedenti nella storia economica recente.
I dati mostrano chiaramente la crescita impetuosa dei fondi sovrani nel corso degli ultimi 10 anni. Si è passati
da un controvalore di poco meno di 4 miliardi di dollari nel 2000 fino ai 52 miliardi registrati nel 2010, grazie
soprattutto alle operazioni dei fondi del Golfo, che rappresentano circa la metà del valore totale. Ad
alimentare l’investimento ha contribuito l’accumulazione delle riserve valutarie, che nel 2010 hanno superato i
9.000 miliardi di dollari, e le opportunità emerse nel settore bancario americano durante la crisi. Il settore fino
al 2008 ha infatti attratto circa 90 miliardi di dollari di investimento dei fondi sovrani.
Al di là dei dati, è interessante notare che la crisi finanziaria ha cambiato l’atteggiamento del mondo
occidentale verso i fondi sovrani. Inizialmente dipinti dai media come i nuovi “barbarians at the gate”
intenzionati a scalare in maniera ostile i baluardi del capitalismo occidentale, sono poi stati acclamati come
“cavalieri bianchi” di Wall Street appena hanno cominciato a offrire capitali freschi e liquidità alle grandi
banche nella fase più grave della crisi.
L’entusiasmo non è durato a lungo, perché a cavallo della crisi i fondi sovrani, avendo subito forti perdite,
hanno ridotto il volume degli investimenti soprattutto negli Usa e contestualmente modificato l’allocazione
settoriale e internazionale. Nel 2009 e 2010 si registra una riduzione significativa dei deals nel settore finanziario,
121
Finanza
a favore di un ventaglio più diversificato di comparti fra cui spiccano l’energia, le risorse naturali, l’ingegneria
e l’high tech.
La crisi ha anche modificato il profilo internazionale dell’investimento sovrano. Negli anni più recenti, si è
accentuata la preferenza verso i mercati europei, che oggi pesano sull’intero portafoglio delle transazioni per
il 30% del totale. I fondi sovrani hanno anche allargato il loro campo di azione e diversificato in America
Latina, Africa Sub-Sahariana e in Asia, senza mai smettere per sostenere le economie nazionali durante la crisi.
I dati evidenziano in modo inequivocabile la rilevanza presente e futura dei fondi sovrani nell’economia e nel
sistema finanziario globale, ma non devono offuscare il vero elemento di discontinuità di questo fenomeno,
cioè come questo prefiguri un ritorno prepotente e su scala globale del capitalismo di stato, dopo la grande
ondata delle privatizzazioni di fine secolo. Quali saranno i rischi e le opportunità di questa sfida lanciata dai
paesi emergenti alla logica stessa del capitalismo occidentale, fortemente ancorato almeno nei principi se
non nella pratica al libero mercato e all’iniziativa privata? Sapranno i nuovi azionisti sovrani creare valore e
garantire la crescita?
Il quadro che emerge è piuttosto negativo: gli investimenti sovrani finora non hanno creato valore, anzi: nei
due anni successivi all’acquisizione di un fondo sovrano, il titolo della società target perde in media dal 6 al
10% sui peers. Inoltre, la performance risulta tanto più negativa, quanto maggiore è la partecipazione
acquisita, e se il fondo ha un rappresentante nel board. I risultati ottenuti suffragano l’ipotesi del fondo
sovrano come azionista di minoranza rilevante ma spesso passivo e riluttante a controllare il management
della società ospite.
La questione fondamentale sarà capire se, quando e come i fondi sovrani decideranno di giocare un ruolo
più attivo nella corporate governance. La sfida è economica e al tempo politica, e su questa si gioca il futuro
dei fondi sovrani.
L’Autore
Bernardo Bortolotti è professore associato all’Università di Torino e direttore del Sovereign Investment Lab del
Centro Paolo Baffi della Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 118/2011
122
Diritto
Diritto
Che fare in aeroporto se siamo morti
di Arianna Vedaschi
Dopo l’11 settembre, sono state proposte misure di sicurezza
lesive della privacy e discusse, come il body scanner. Arianna
Vedaschi, docente Bocconi di Diritto pubblico comparato,
esamina il presupposto di base: che per esercitare altre libertà
sia necessario innanzitutto rimanere vivi.
Il problema della sicurezza, drammaticamente esploso l’11 settembre 2001 e da allora rimasto irrisolto, è
sempre di grande attualità, come dimostrano recenti articoli apparsi su diversi giornali statunitensi. Da ultimo
David Cole, costituzionalista della Georgetown University, ha denunciato l’invasività di alcune normative tese
a colpire i fiancheggiatori delle attività terroristiche.
Il caso sollevato da Cole conferma un quadro generale ormai chiaro e preoccupante, sotto il profilo della
garanzia dei diritti.
Tutti ricordiamo la polemica sull’introduzione del body scanner, che sembra essere lo strumento più adatto a
prevenire l’allarme-terrorismo, almeno per le esplosioni in volo. Data l’invasività dell’apparecchiatura, la sua
introduzione ha suscitato perplessità e riserve, manifestate da associazioni per la difesa dei diritti e anche dalle
autorità garanti della privacy. Alle critiche di violazione della privacy (e non solo), il ministro degli Esteri Franco
Frattini ha risposto che si tratta di un “sacrificio che vale la pena fare”, perché “il diritto a non saltare in aria è
la precondizione a tutte le libertà”. (ex multis: L’Italia apre ai body scanner. Frattini: strumento più sicuro, in La
Stampa, 5 gennaio 2010).
La frase a effetto del ministro (peraltro simile alle esternazioni di esponenti dei principali esecutivi europei)
sottende l’idea di primazia del bene giuridico ‘sicurezza’ rispetto a qualsiasi altro bene. Esso sta al vertice
dell’ipotetica scala gerarchica dei diritti, viene prima e quindi sta sopra a tutti gli altri beni giuridici: tutte le
altre libertà e diritti, anche se fondamentali, diventano deboli e il loro esercizio recessivo, in omaggio al fine di
tutelare la sicurezza collettiva. E ciò a prescindere dalla posizione soggettiva interessata.
125
Diritto
L’affermazione sottende l’essenziale domanda: quale libertà si può esercitare da morti? Nessuna, quindi prima
di tutto bisogna rimanere vivi, rinunciando a ciò cui è necessario rinunciare, anche alla privacy, il cui esercizio,
senza quella precondizione (cioè il restare vivi), sarebbe impossibile.
È evidente che il ministro si rivolge a organi di stampa e non a un pubblico di giuristi, ma se si prova a
considerare in senso tecnico il ragionamento proposto, si scopre che più che una boutade l’affermazione del
ministro sembra l’eco di una tendenza presente nell’azione politica dei principali paesi a democrazia matura.
In effetti, nel prendere atto che la società post-moderna richiede forme di protezione, anche limitative delle
più elementari libertà, gli esecutivi dei principali paesi democratici del dopo 11 settembre sembrano
rinunciare a ricondurre il rapporto tra due esigenze entrambe meritevoli di tutela sul classico binario del
bilanciamento, né si sforzano di cercare, secondo il criterio della ragionevolezza, l’equilibrio tra la garanzia di
un’esigenza collettiva e la tutela di altri diritti, conquiste intoccabili della civiltà umana prima che giuridica.
Le normative sul terrorismo internazionale rivelano la tendenza del pubblico potere a far prevalere le esigenze
della sicurezza su quelle della libertà. E questa tendenza dei governi non sempre ha trovato freno nella
giurisprudenza delle Corti, basti pensare all’ampia deferenza mostrata dalla Suprema Corte nei confronti
dell’esecutivo americano (amministrazione Bush).
La medesima tendenza ha anzi trovato favorevole sponda in quella parte (minoritaria) della dottrina che
giustifica pratiche quali la tortura (Dershowitz’s theory). Ma anche parte della dottrina non minoritaria è
disposta a legittimare pratiche discutibili, benché dal nome meno odioso, (interrogatori ‘rafforzati’ e metodi
anti-resistenza), ‘legalizzate’ grazie all’interpretazione restrittiva del concetto di tortura o a quella estensiva
delle scriminanti.
In ultima analisi, la gerarchia dei valori verticalizzata sulla sicurezza che sembra emergere nell’era post 11
settembre rischia di introdurre elementi di democrazia autoritaria e pare poco compatibile con il modello
della democrazia liberale agganciato al pluralismo dei valori e alla garanzia forte dei diritti e delle libertà.
L’Autrice
Arianna Vedaschi è professore associato di Diritto pubblico comparato alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Diritto pubblico comparato. Diritto pubblico. Diritto costituzionale.
Da Bocconi Newsletter no. 105/2011
126
Diritto
La democrazia come risposta
di Piergaetano Marchetti
Il tema del buongoverno affascina il pensiero occidentale, e
non solo, da più di due millenni. Piergaetano Marchetti,
docente di Diritto commerciale alla Bocconi, si sofferma
sull’eterno interrogativo: meglio il governo degli uomini o delle
leggi?
Il “buongoverno” un tema banale e ovvio a prima vista, ma altissimo. Un tema che nelle più varie declinazioni
ha affascinato il pensiero e non solo occidentale da più di due millenni. Il “buon governo” – è stato scritto – è
un mito, una grande narrazione che da Licurgo sino alla riproposizione della governance, della good
governance non ha mai smesso di rappresentare il problema dell’uomo e del vivere collettivo nelle sue varie
sfaccettature. Il buongoverno dell’impresa oggi ripropone l’interrogativo pure più che bimillenario del
governo delle leggi o governo degli uomini.
Dibattito più che bimillenario. Rileggiamo Platone e Aristotele e scopriamo l’enorme attualità, la bruciante
attualità di allora.
È povero e infecondo il Paese senza memoria. È arido e col fiato corto lo studioso senza consapevolezza della
storia e del pensiero da cui viene.
Credo che al fondo di tante riflessioni sulla governance, alle aspettative, alle delusioni, alle mistificazioni, alla
retorica, a volte, il giurista legga il dilemma: governo delle leggi e governo degli uomini. Già, il giurista. Ma
quale è il suo ruolo? Credo che prima ci si debba chiedere chi è il giurista? È possibile trovare un minimo
comun denominatore tra il giurista ricercatore (qualcuno lo dubita, ma credo che anche il giurista possa
appartenere al mondo della scienza senza cambiar pelle), il giurista professionista, il giurista giudice, il giurista
d’impresa, il giurista consigliere del principe, il giurista di istituzioni?
Credo di sì. Credo che due compiti gli spettino. Il primo, banale, ricordare che le norme, le regole sono una
variabile da prendere in considerazione ex ante nella condotta, nelle scelte, nella programmazione, non un
dato con qui confrontarsi a cose fatte ex post. Il secondo, quello di interpretare la norma, adattarla al caso
concreto, individuare che cosa sta sotto la regola, l’assetto di interessi, coordinarla con il sistema, vedere cosa
127
Diritto
l’applicazione o la violazione muove nel delicato equilibrio di un sistema. È evidente che in questo lavoro il
costo della violazione, la sanzione, rivestirà un’importanza fondamentale. Se volessimo riprendere il filo del
buon governo, potremmo dire che al giurista spetta rammentare le istanze del governo delle leggi al troppo
dilatato spazio che il governo degli uomini spesso si arroga.
E vorrei subito togliere di mezzo un equivoco. L’equivoco che legge sia antitesi di libertà, che legge sia
mortificazione dell’iniziativa. Non c’è bisogno di scomodare un esercito di classici da John Stuart Mill a Isaiah
Berlin per ricordare come proprio la legge possa essere garanzia di libertà. Garanzia di concordia e
convivenza. Ambrogio Lorenzetti nel suo celebre affresco nel Palazzo di Siena pone al sommo della sua
allegoria del buongoverno la giustizia, l’applicazione della legge. Se dovessi continuare nell’allegoria direi che
il pregiudizio spesso non infondato sul male delle troppe e vane leggi è il frutto del malgoverno, di un
eccessivo peso di un cattivo governo di uomini, di uomini che nella politica non coniugano, come Max Weber
vorrebbe, passione, lungimiranza, responsabilità.
Se volessi tentare un difficile e certo discutibile raccordo tra polis e impresa, direi che l’impresa negli ultimi anni
ha dato troppo spazio al governo degli uomini, al capo-azienda, alla retorica dell’efficienza manageriale,
con un’eclisse del governo della legge, delle norme, delle regole. E ciò in parallelo, ma le mie sono
osservazioni grezze, con un mercato che troppo spesso ha rotto l’equilibrio tra libertà e regole del gioco. Il
problema dell’esaltazione sproporzionata degli incentivi ai manager assume valore emblematico dello
squilibrio verso un’esasperata concezione del governo degli uomini ed insieme, come è pacificamente
riconosciuto, una grave incrinatura del sistema del funzionamento e del ruolo del mercato. Qui il governo
delle leggi, come assoggettamento ex ante della condotta a regole generali, verificabili, conoscibili, avrebbe
potuto far molto ed ora cerca di guadagnare terreno.
Certo, il problema del governo delle leggi è che le leggi funzionino; è il problema della loro effettività. È un
problema enorme, in parte interno e in parte esterno alle regole. È un problema di incentivi e disincentivi,
anzitutto; e qui possiamo essere ancora all’interno della norma. C’è una parte dell’enforcement che è norma
stessa, non è un dopo. Ma c’è poi il problema dell’applicazione per il caso che la barriera preventiva
dell’incentivo e del disincentivo non abbia funzionato. Qui siamo di fronte a un problema di struttura più
ampio; qui si innesta il discorso sul sistema della giustizia per l’impresa. Siamo sicuri che dopo settant’anni non
si debba tornare a un sistema di giustizia dell’impresa e verso l’impresa?
I problemi che il nostro tema suscita sono enormi e nulla è peggio che il teorico generale dilettante: e allora
spaventato arretro.
Non senza evocare un altro problema cruciale. Governo delle leggi, dicevo, più governo delle leggi
nell’impresa. Sorge naturale la domanda. Ma quali sono le leggi giuste, chi è il filosofo “saggio” delle leggi di
Platone? È anche questo un interrogativo che ha millenni sulle spalle. Sgombro il campo e dico subito che
non è il giurista. E dico subito che non è neppure né l’economista, né il filosofo, né lo scienziato politico, pur
raffinati e convincenti che possano essere i loro modelli. Il legislatore che garantisce il buon governo, il buon
128
Diritto
governo delle leggi che tempera il governo degli uomini, dico con Norberto Bobbio, è il sistema democratico,
è la politica fondata, a sua volta, su quel delicato equilibrio di regole che (pur nella grande varietà che può
assumere) sintetizziamo con il termine di democrazia. Un equilibrio, quello della democrazia, insieme forte e
fragile che ha bisogno continuo di cura e dedizione.
Nel gioco democratico che dà vita al governo delle leggi non esistono formule magiche, verità inconfutabili,
neppure per disegnare il modello perfetto di governo dell’impresa. Regole, e per nulla disprezzabili, ne
abbiamo, occorre interpretarle e applicarle. A volte sono regole banali, si pensi, ad esempio, a un’effettiva
dialettica tra organi collegiali e executives, così come ai conflitti di interesse. E si faccia ancora l’esempio del
parametro della “corretta amministrazione” cui il nostro codice chiede agli amministratori di ispirarsi,
parametro che non è affatto detto che in un quadro costituzionale come il nostro non debba lasciare più
robusto spazio alla responsabilità sociale, alla considerazione di più vaste platee di stakeholders. Mi verrebbe
da dire che esiste una banalità del buongoverno tutta da scoprire, da applicare con un lavoro di riflessione e
irrobustimento etico e culturale delle nostre classi dirigenti.
Fra questo lavoro c’è quello indubbiamente di una promozione del merito, merito che per me significa strada
sbarrata alla prevalenza del demerito. Ma premiare il merito non significa dividere il mondo in salvati e
dannati. Merito significa premiare in proporzione corretta tutti coloro che danno tutto quanto possono dare
anche se non sono i primi a tagliare il traguardo. Il merito poi non può seppellire l’eguaglianza dei punti di
partenza, dei diritti, della dignità. Se fossi francese non proporrei l’abolizione dell’art. 2 della loro Costituzione,
laddove afferma che il motto della repubblica è “liberté, egalité, fraternité”. Ma ciò che dobbiamo anzitutto
noi giuristi e docenti perseguire è quello che chiamerei un positivo scetticismo costruttivo. Contribuiamo al
“governo delle leggi” ma senza arroganza e vanagloria, non a caso raffigurate da Ambrogio Lorenzetti,
come simboli del malgoverno.
“La nostra divisa è una sola: noi non conosciamo, ma cerchiamo la verità, noi non siamo mai sicuri di
possederla e torneremo ogni giorno a ricercarla, sempre insoddisfatti e sempre curiosi”, così scriveva Luigi
Einaudi.
E mi piace aggiungere e concludere con Voltaire che l’onore dei giudici, e aggiungo dei giuristi, come quello
degli altri uomini, consiste nel riconoscere e riparare i propri errori.
L’Autore
Piergaetano Marchetti è professore a contratto senior alla Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Diritto comunitario. Diritto dell’informazione (mass media). Diritto societario. Diritto dei mercati mobiliari e dei
mercati finanziari. Proprietà industriale e intellettuale.
Da Bocconi Newsletter no. 113/2011
129
Diritto
Pensiamo collettivo o perderemo sempre la guerra
di Leonardo Borlini
Corruzione: secondo una stima della Corte dei Conti, nel 2010
in Italia è costata 60 miliardi di euro. Per Leonardo Borlini,
docente di Diritto dell’Unione Europea in Bocconi, il punto è
trovare e attuare meccanismi politici che superino l’interesse
individuale.
L’adozione di numerosi strumenti giuridici anti-corruzione da parte delle principali organizzazioni internazionali
con competenza in materia (Banca Mondiale, Ue e Ocse, per citarne tre) si innesta su una solida
comprensione economica del fenomeno. L’analisi economica, che può farsi risalire agli studi di Kruger e
Bhagwati del 1974, è oggi molto articolata: non solo sono periodicamente stimate voci diverse di “costo”
della corruzione con riferimento a singoli contesti statuali (ad esempio, inefficienze dei mercati reali e
finanziari, riduzione del gettito fiscale, insufficienza dei beni pubblici, perdita di performance
macroeconomica, erosione di fiducia nelle istituzioni, aumento della disuguaglianza sociale, riduzione di
investimenti esteri), ma, utilizzando la formulazione di un’ardita nota proposta in un recente lavoro di tesi
supervisionato, “è stata prodotta una valanga di carta” sulle cause, gli effetti e, soprattutto, i canali attraverso
cui pratiche corruttive reiterate arrivano a minare le fondamenta dei moderni sistemi economici e sociali.
Così, ad esempio, secondo la Banca Mondiale i paesi che tengono sotto controllo la corruzione possono
aumentare il reddito procapite del 300% e, ciò che ci riguarda più direttamente, secondo una recente stima
della Corte dei conti, la corruzione in Italia è costata 60 miliardi di euro nel 2010, con una crescita di circa il
30% di casi di corruzione rispetto all’anno precedente.
Sappiamo dunque quanto (ci) costa, quali sono gli oneri e, di riflesso, quanto ci conviene contrastarla. Inoltre,
da più di un decennio sono stati conclusi trattati internazionali, cui l’Italia ha aderito, che obbligano
all’adozione di efficaci strumenti giuridici di lotta al fenomeno e indicano i principali settori di intervento.
Nonostante ciò, non diminuiscono i rilievi critici provenienti dalla comunità internazionale. Secondo la NGO
Transparency International, l’Italia è scesa dal 29esimo posto nel 2001 al 67esimo posto nel 2010 in quanto a
livello di corruzione percepita, dietro a Ghana, Samoa e Ruanda, tallonata da Georgia, Panama e Trinidad e
Tobago. Secondo le istituzioni intergovernative il quadro non migliora, anzi. Gli ultimi rapporti dell’Ocse e del
Consiglio d’Europa relativi all’attuazione dei rispettivi accordi internazionali da parte dell’Italia, evidenziano
130
Diritto
numerose e gravi criticità di sistema; la prossima pubblicazione del terzo rapporto Greco (Group of States
against Corruption) del Consiglio d’Europa, che si attende per la fine del 2011, rileverà, pare, ulteriori
deficienze.
Lasciando da parte le esortazioni morali, sempre apprezzabili ma sostanzialmente inefficaci, mi sembra che la
spiegazione dello iato tra analiticità dei dati disponibili circa i costi del fenomeno e degli impegni
internazionali a contrastarlo, da un lato, e peggioramento dello stesso denunciato con costanza dalla
comunità internazionale, dall’altro, si trovi ancora nell’estrema difficoltà a identificare e attuare meccanismi
politici che obblighino a raggiungere l’interesse individuale solo dopo un percorso che assicuri l’ottimo
collettivo. Questo nodo costituisce evidentemente una delle problematiche di fondo, non solo dell’azione
anti-corruzione, ma di ogni politica nazionale e internazionale volta a limitare talune conseguenze
dell’assunzione, secondo il modello economico classico, dell’individuo e del personale interesse come punto
di riferimento principale dell’agire umano. In ambito di attività anti-corruzione, non sembra che il margine di
azione delle organizzazioni internazionali sia ampio. A questo livello, politiche incisive nel senso appena
indicato, sia pur perfettibili, sono state già attuate; il lavoro deve essere nel senso della mera continuità.
Rimangano infine gli stati, enti collettivi per eccellenza.
L’Autore
Leonardo Borlini è assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Studi giuridici
della Bocconi.
Aree di interesse scientifico
Diritto dell’Unione Europea, Diritto internazionale pubblico e dell’economia. Diritto e politica della
concorrenza e tutela del mercato. Regolazione dei servizi economici di interesse generale (focus: energia).
Analisi di impatto della regolazione. Contrasto ai crimini transnazionali.
Da Bocconi Newsletter no. 113/2011
131
Diritto
Dove osano le sardine. Purché siano europee
di Giorgio Sacerdoti
Nel 2001 la controversia tra Perù e Comunità Europea sulle
sardine di importazione arrivò al Wto, e fu vinta dal paese
sudamericano. Tuttavia nei negozi europei non c’è traccia di
sardine peruviane, osserva Giorgio Sacerdoti, docente di diritto
internazionale alla Bocconi.
Correva l’anno 2001 quando una catena di supermercati tedeschi pensò di aver rotto il monopolio dei
produttori spagnoli di sardine in scatola sul mercato germanico, importando dal Perù le sardine di quel paese.
Una manna per la sua industria conserviera in crisi e quindi alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali. Una
alternativa per i consumatori germanici che avrebbero trovato sugli scaffali un prodotto diverso ad un prezzo
più basso. Ma gli importatori non avevano fatto i conti con le occhiute dogane che implacabili bloccarono
subito le scatolette: regolamenti comunitari alla mano quelle non erano sardine, ma un prodotto diverso, che
venduto come sardine avrebbe potuto indurre in errore l’ignaro acquirente europeo!
Si scoprì così che in Europa solo la specie di sardina che si trova nell’Atlantico, la “sardina pilchardus
Walbaum”, pescata guarda caso solo dai pescatori iberici, può fregiarsi del nome di sardina. Vade retro tu
“Sardinops sagax” del Pacifico, cugina similissima dallo stesso gusto ma diversamente classificata da qualche
pignolo naturalista tedesco dell’Ottocento seguace di Linneo.
Fu così che il Perù non ebbe altra scelta che iniziare una causa contro l’Europa comunitaria davanti alla
neonata Organizzazione mondiale del commercio, la ben nota Wto. Se non c’è un giudice a Berlino, lo si
troverà a Ginevra! Quali gli argomenti del Perù? Le due specie sono sì diverse ma secondo le classificazioni
internazionalmente valide del Codex alimentarius della Fao fanno parte della stessa famiglia, e quindi anche
la cugina del Pacifico deve essere ammessa dall’Europa come sardina. E la protezione del consumatore
invocata dalla Commissione europea a propria difesa? Bè, se anche fosse proprio vero che la massaia
tedesca quando compra sardine al supermercato si aspetta di trovare solo la gustosa tradizionale sardina
atlantica (ma sarà davvero così?), basterà che la scatola indichi il prodotto come “sardina del Pacifico”.
Senza che le scatolette debbano portare scritte in latino, come la Commissione pretendeva, suscitando i lazzi
di qualche commentatore inglese sempre critico con le manie regolamentari degli eurocrati di Bruxelles.
132
Diritto
I giudici di Ginevra trovarono che la difesa europea puzzava di protezionismo, alla faccia della conclamata
apertura dei nostri mercati ai prodotti del Terzo mondo. La Comunità perse dunque la causa. Il nuovo “oro del
Perù”, cioè le sue sardine, potevano dunque nuotare tranquille (ma in scatola) fino alle rive del Reno. Ma i
pescatori iberici devono aver remato in qualche modo misterioso di nuovo contro: vi sfido di trovare le sardine
peruviane sugli scaffali dei negozi europei! Controllate voi stessi: solo marche spagnole, portoghesi e del
Marocco, un paese che non a caso si schierò a favore dell’Europa nella causa ginevrina al Wto. Che si
debba interpellare questa volta l’antitrust di Bruxelles per liberalizzare davvero il mercato e dare una chance
ai pescatori peruviani.
L’Autore
Giorgio Sacerdoti è professore ordinario di Diritto internazionale alla Bocconi, cattedra Jean Monnet di Diritto
Europeo.
Aree di interesse scientifico
Diritto internazionale, comunitario e del commercio internazionale. Investimenti. Arbitrato. Contratti
internazionali.
Da Bocconi Newsletter no. 114/2011
133
Diritto
La Commissione europea dichiara guerra
alla corruzione
di Giulio Nessi
Siamo a una svolta nella politica UE di lotta contro la
corruzione? Secondo Giulio Nessi, PhD candidate in Diritto
internazionale dell’economia in Bocconi, le misure presentate
recentemente dal commissario europeo Cecilia Malström
fanno ben sperare.
Se in Italia, come ha dichiarato di recente il procuratore generale della Corte dei conti, sembra essersi
imposta una “vera e propria cultura della corruzione”, è da leggersi con favore la presentazione da parte
della Commissione europea di una serie di misure che l’Unione europea intende mettere in atto nei prossimi
anni per stimolare la carente volontà politica degli stati membri contro un crimine che, nelle sue molteplici
forme, si stima comporti un costo di 120 miliardi di euro a livello europeo (60 miliardi solo in Italia secondo la
Corte dei conti).
Considerando che oggi i trattati europei indicano la corruzione come una priorità da affrontare su basi
comuni, la presentazione del c.d. “pacchetto anti-corruzione” risulta essere il primo segnale concreto delle
istituzioni europee in questa direzione. Finora, infatti, l’impegno dell’Unione europea contro questo problema si
è limitato a interventi disorganici e scarsamente vincolanti, ma soprattutto incapaci di generare il necessario
impulso politico in capo agli stati membri.
Proprio sotto quest’ultimo aspetto le misure presentate il 6 giugno dalla commissaria europea agli Affari interni,
Cecilia Malström, sembrano segnare una svolta. A partire dal 2013 e con cadenza biennale, verrà pubblicata
una “Relazione anti-corruzione europea” in cui si analizzeranno i risultati, le lacune e l’impegno degli stati
membri contro la corruzione, sulla base dei quali la Commissione valuterà l’opportunità di ulteriori iniziative, tra
cui non è esclusa l’armonizzazione di fattispecie penali. A supporto e completamento di questo meccanismo
di controllo è, inoltre, prevista la partecipazione dell’Unione europea al sistema di monitoraggio Greco (Group
of states against corruption), creato nel 1999 all’interno del Consiglio d’Europa.
134
Diritto
La proposta di introdurre il primo sistema di verifica dell’Unione europea nella lotta alla corruzione attraverso le
relazioni anticorruzione costituisce un sensibile passo in avanti contro tale fenomeno, considerato che gli unici
controlli operativi sono oggi diretti ai soli stati candidati ad entrare nell’Unione europea. Ciononostante
l’efficacia di tale meccanismo dipenderà molto dal modo in cui sarà definita la partecipazione dell’Unione
europea al Greco: se nella strategia della Commissione questa forma di cooperazione contribuirà ad
aumentare la pressione politica sugli stati membri, sarà fondamentale evitare la creazione di sovrapposizioni e
confusione tra i due sistemi. Inoltre, dal grado di coinvolgimento dell’Unione europea al Greco dipenderà un
altro importante aspetto della politica anticorruzione europea quale la valutazione delle istituzioni europee,
un passo che risulta auspicabile alla luce degli scandali che in passato hanno coinvolto la Commissione e, più
di recente, il Parlamento europeo.
Se, dunque, le misure proposte prospettano un più intenso impegno contro la corruzione, solo sfruttando le
sinergie con i sistemi di monitoraggio predisposti dagli altri organismi internazionali (in primis con il Greco del
Consiglio d’Europa), l’Unione europea potrà proporsi come un nuovo protagonista sullo scenario
internazionale della lotta alla corruzione. Forse così gli stati membri saranno tenuti ad affrontare con maggior
rigore un reato che sottrae ingenti risorse alle finanze pubbliche oggi più che mai in stato di difficoltà. Dubbi
rimangono sulla possibilità che ciò basti agli italiani per ridurre sostanzialmente quell’assuefazione alla
corruzione che sembra sempre più diventare cifra culturale del nostro paese.
L’Autore
Giulio Nessi è PhD Candidate in Diritto internazionale dell’economia alla Bocconi.
Da Bocconi Newsletter no. 116/2011
135