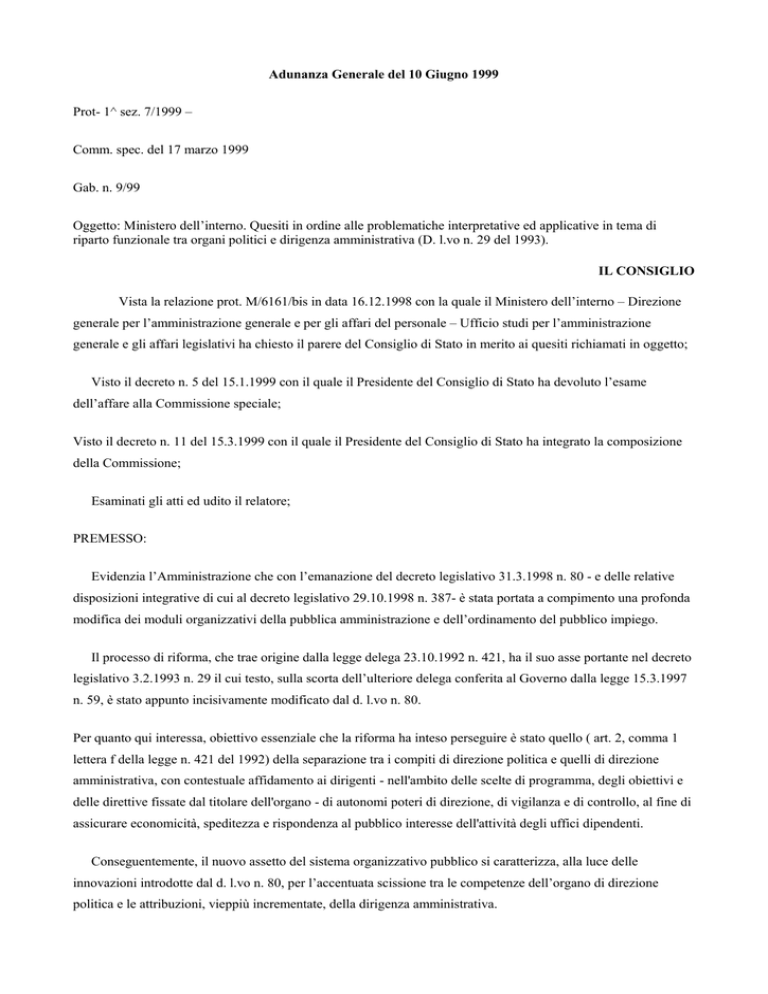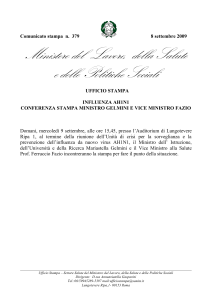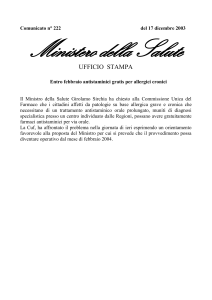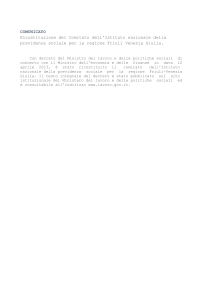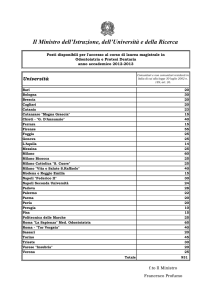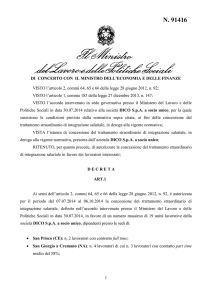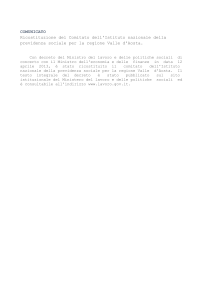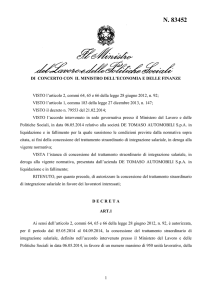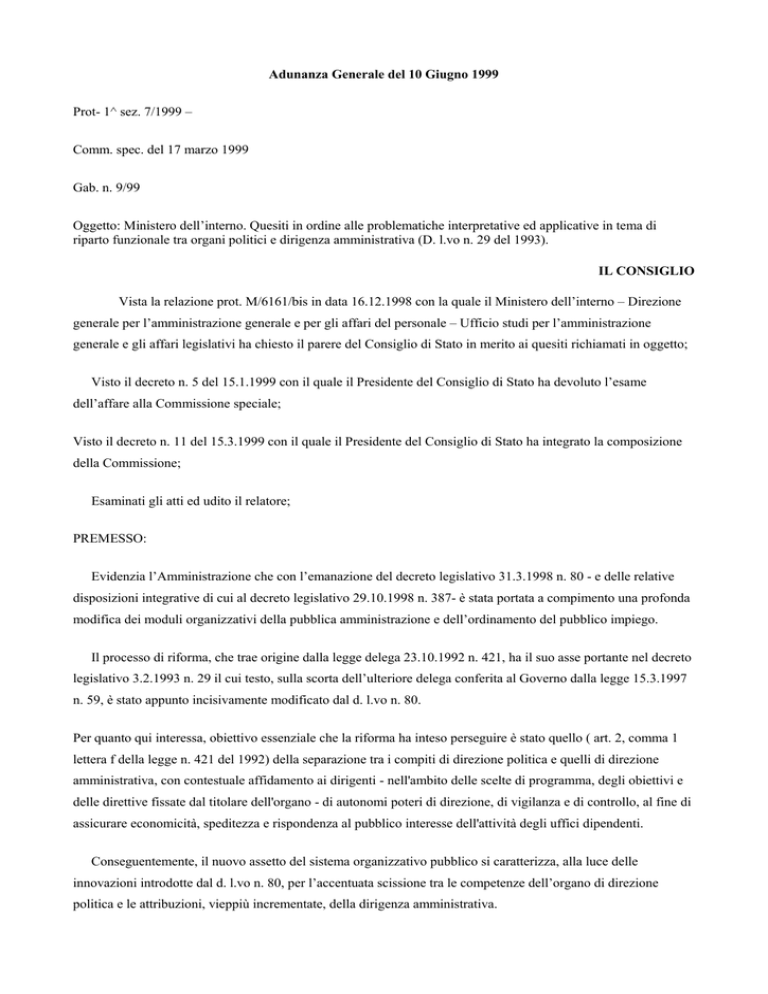
Adunanza Generale del 10 Giugno 1999
Prot- 1^ sez. 7/1999 –
Comm. spec. del 17 marzo 1999
Gab. n. 9/99
Oggetto: Ministero dell’interno. Quesiti in ordine alle problematiche interpretative ed applicative in tema di
riparto funzionale tra organi politici e dirigenza amministrativa (D. l.vo n. 29 del 1993).
IL CONSIGLIO
Vista la relazione prot. M/6161/bis in data 16.12.1998 con la quale il Ministero dell’interno – Direzione
generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale – Ufficio studi per l’amministrazione
generale e gli affari legislativi ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito ai quesiti richiamati in oggetto;
Visto il decreto n. 5 del 15.1.1999 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha devoluto l’esame
dell’affare alla Commissione speciale;
Visto il decreto n. 11 del 15.3.1999 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha integrato la composizione
della Commissione;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
PREMESSO:
Evidenzia l’Amministrazione che con l’emanazione del decreto legislativo 31.3.1998 n. 80 - e delle relative
disposizioni integrative di cui al decreto legislativo 29.10.1998 n. 387- è stata portata a compimento una profonda
modifica dei moduli organizzativi della pubblica amministrazione e dell’ordinamento del pubblico impiego.
Il processo di riforma, che trae origine dalla legge delega 23.10.1992 n. 421, ha il suo asse portante nel decreto
legislativo 3.2.1993 n. 29 il cui testo, sulla scorta dell’ulteriore delega conferita al Governo dalla legge 15.3.1997
n. 59, è stato appunto incisivamente modificato dal d. l.vo n. 80.
Per quanto qui interessa, obiettivo essenziale che la riforma ha inteso perseguire è stato quello ( art. 2, comma 1
lettera f della legge n. 421 del 1992) della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione
amministrativa, con contestuale affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma, degli obiettivi e
delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, al fine di
assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.
Conseguentemente, il nuovo assetto del sistema organizzativo pubblico si caratterizza, alla luce delle
innovazioni introdotte dal d. l.vo n. 80, per l’accentuata scissione tra le competenze dell’organo di direzione
politica e le attribuzioni, vieppiù incrementate, della dirigenza amministrativa.
Infatti, come rileva l’Amministrazione riferente, accanto alle funzioni afferenti all’area gestionale, già devolute
nel ’93 alla dirigenza, il recente provvedimento delegato attribuisce a questa in via esclusiva l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi rilevanti verso l’esterno e le riconosce la responsabilità, oltre che della gestione e
dei relativi risultati, anche dell’attività amministrativa nel suo complesso. ( art. 3, comma 2, d. l.vo n. 29 del 1993
che nel prosieguo si cita nel testo appunto modificato dal d. l.vo n. 80)
L’integrale devoluzione alla dirigenza delle riferite funzioni appare confermata dalla immediata operatività del
trasferimento di competenze, sancita dall’art. 45, comma 1, del d. l.vo n. 80.
Nel contesto del superamento del vecchio modello organizzativo, improntato al tradizionale criterio
gerarchico, la configurazione giuridica delle relazioni funzionali intercorrenti tra organi politici e dirigenza
amministrativa risulta ulteriormente incisa dalla caducazione ( art. 14, comma 3, d. l.vo n. 29 ) dei poteri
ministeriali di revoca, riforma, riserva o avocazione degli atti dirigenziali.
Parallelamente, a completamento della ridefinizione del nuovo ruolo riconosciuto al plesso dirigenziale, è
espressamente sancita la definitività degli atti e dei provvedimenti adottati dai dirigenti di vertice, ormai non più
suscettibili - fatte salve particolari disposizioni per l’Autorità di PS - di ricorso gerarchico.
In tale complesso contesto e con specifico riferimento all’amministrazione statale, il Ministero dell’interno
domanda se il conferimento ai dirigenti di attribuzioni innanzi riferite agli organi di direzione politica investe
anche provvedimenti la cui adozione implica valutazioni di carattere ampiamente discrezionale o aventi riflessi di
natura anche politica: è questo, in particolare, il caso dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli
enti locali, degli atti di concessione della cittadinanza italiana nonché delle autorizzazioni alla consultazione dei
documenti d’archivio di carattere riservato.
Ulteriormente, l’Amministrazione chiede di conoscere il parere del Consiglio in ordine alla precisa
connotazione e alla latitudine del potere ministeriale di annullamento per motivi di legittimità, espressamente fatto
salvo dall’art. 14, comma 3, del d. l.vo n. 29.
Il successivo quesito concerne l’individuazione dei provvedimenti dell’Autorità di PS tuttora impugnabili in
sede gerarchica, ai sensi della disposizione ora citata.
L’amministrazione chiede poi di conoscere se, in un sistema che espressamente riconosce la definitività degli
atti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, siano tuttora esperibili avverso taluni atti del Prefetto i ricorsi
gerarchici impropri previsti da specifiche normative di settore.
Da ultimo, l’Amministrazione sottolinea che, sotto un aspetto diverso da quelli sinora considerati, punto
rilevante della riforma è la riconduzione sotto la disciplina del diritto civile del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, ora regolato mediante contratti individuali e collettivi, e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle norme sui rapporti di lavoro privato nell’impresa ( cfr. art. 11, comma 4 lettera
a) della legge n. 59 del 1997).
In tale contesto, di assoluto rilievo è la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro c.d. “ privatizzati” ( art. 68 d. l.vo n. 29) per questioni attinenti al
periodo successivo al 30.6.1998 ( art. 45, comma 17. D. l.vo n. 80).
Alla luce del nuovo riparto di giurisdizione, l’Amministrazione pone uno specifico quesito in ordine alla
persistente ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli atti con i quali gli
organi preposti provvedono alla gestione dei rapporti di lavoro.
Nell’adunanza del 3.2.1999 la Commissione ha chiesto di conoscere sulle problematiche in rassegna l’avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha poi fornito il proprio
parere con analitica relazione dell’Ufficio legislativo pervenuta il 2.3.1999.
Nell’adunanza del 17.3.1999 la Commissione ha approvato il preavviso per l’Adunanza generale.
CONSIDERATO:
1. Il Ministero dell’Interno domanda innanzi tutto se, all’esito della radicale riforma dei moduli organizzativi della
pubblica amministrazione sopra richiamata nei tratti salienti, il conferimento ai dirigenti di attribuzioni innanzi
riferite agli organi di direzione politica investe anche provvedimenti la cui adozione implica valutazioni di
carattere ampiamente discrezionale o aventi riflessi di natura in qualche modo politica.
Sul punto si ritiene di svolgere le seguenti considerazioni di carattere preliminare.
Nelle sue linee generali, la normativa in rassegna distingue con chiarezza le competenze degli organi di
governo dalle attribuzioni della dirigenza amministrativa.
Per quanto riguarda l’amministrazione statale, spettano dunque senza dubbio al Ministro le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica della
rispondenza dei risultati gestionali agli indirizzi impartiti.
Al Ministro spetta in particolare ogni decisione negli ambiti specificamente richiamati dalle lettere da a) a g)
del comma 1 dell’art. 3 del d. l.vo n. 29 nel testo novellato.
Spetta invece ai dirigenti l’adozione degli atti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, da attuarsi mediante
autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane a disposizione.
La demarcazione delle competenze ora richiamata è dunque prima facie assai chiara: come rileva il
Dipartimento per la Funzione Pubblica, ai dirigenti compete ( ovviamente nel quadro degli indirizzi prefissati)
tutta l’attività di amministrazione concreta, anche ove essa si estrinsechi attraverso atti di imperio; rimangono
invece attratte nelle attribuzioni degli Organi di direzione le attività che “ involgono l’esercizio di puissance
publique” ovvero gli atti di discrezionalità politica.
Sul punto si osserva che la questione, avuto riguardo alla concreta realtà organizzativo-funzionale della
pubblica amministrazione come disegnata da normative tuttora vigenti, presenta profili meno facilmente
decifrabili.
In primo luogo, è da sottolineare che le nuove attribuzioni – tendenzialmente onnicomprensive – della
dirigenza incontrano un limite nella diffusa presenza in seno alla P.A. di comitati, commissioni, consigli e simili
organi collegiali aventi competenze amministrative: la legge ( art. 41, comma 1, legge 27.12.1997 n. 449), pur
auspicandone la riduzione, demanda all’autorità di direzione politica di individuare – e correlativamente di
mantenere in vita – quelli fra tali organi collegiali che svolgano funzioni amministrative ritenute indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali.
Esistono dunque funzioni, pur oggettivamente amministrative, che per il loro intrinseco carattere
l’ordinamento continua a non volere devolute alla dirigenza.
In secondo luogo, va rilevato che il punto da dirimere non riguarda la distinzione fra atti politici ed atti
amministrativi, quanto piuttosto l’esatta individuazione dell’ambito entro il quale si esplica la funzione di
indirizzo politico-amministrativo.
Stando ai testi ed utilizzando nozioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, detta funzione dovrebbe costituire
il raccordo fra la funzione di governo ( o di direzione politica: art. 2, comma 1, legge n. 421/1992) e la funzione
amministrativa.
Ciò detto, un primo punto da tenere fermo è che il decreto legislativo n. 29 non detta un elenco esaustivo degli
atti attraverso i quali si esprime l’ indirizzo politico amministrativo.
Sicuramente fanno parte di detta funzione ( art. 3 comma 1 d. l.vo n. 29) la definizione degli obiettivi, la
verifica dei risultati nonché l’adozione degli atti specificamente indicati dalla legge ( art. 3, comma 1 lettere da a)
a g) d. l.vo n. 29): ma di detta funzione fanno parte – come espressamente prevede la disposizione ora citataanche gli altri atti che nello svolgimento di essa rientrano.
Secondo il ripetuto art. 3, comma 1, la funzione di indirizzo politico amministrativo è dunque un genus del
quale fanno parte species non a numero chiuso.
Tanto chiarito, si evidenzia allora esattamente il vero problema interpretativo: che è quello di individuare,
nell’ampio novero dei provvedimenti non meramente gestionali, quegli atti i quali, nel senso anzidetto, attengono
alle scelte di fondo dell’azione amministrativa discrezionale.
Al riguardo, il Ministero dell’interno propone un criterio distintivo in sostanza fondato su un apprezzamento
circa la latitudine della discrezionalità normativamente commessa all’organo adottante.
Si ritiene che tale criterio, indubbiamente valido, vada usato con parsimonia e tenuto a disposizione in sede
ermeneutica quale ultima ratio.
Empirica, ma in prima battuta preferibile, sembra invece la diversa opzione interpretativa che si affida ad un
vaglio analitico delle normative di settore, le quali spesso – direttamente o implicitamente –forniscono indicazioni
trancianti per la soluzione dei problemi in rassegna.
A tale criterio metodologico si ispira l’impostazione e la soluzione di seguito illustrata ai quesiti specifici
sottoposti dall’Amministrazione.
2.1 Il primo quesito riguarda l’individuazione dell’organo competente ad adottare le misure di rimozione e
sospensione di amministratori degli enti locali previste all’art. 40 della legge n. 142 del 1990.
Il testo vigente dell’art. 40, comma 1, della legge 8.6.1990 n. 142 così recita:
“ Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti
dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.”.
Il Ministero dell’interno formula il quesito partendo dalla ipotesi che detti provvedimenti siano da adottare con
DM, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 12.1.1991 n. 13 che così recita: “Gli atti amministrativi, diversi da
quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del
decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con
decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla
data di cui sopra.”.
Il Ministro della Funzione Pubblica esprime l’avviso che la competenza – qualora i provvedimenti non
presentino carattere di assoluta discrezionalità – spetti ai dirigenti.
Sul punto si impongono alcuni chiarimenti preliminari.
Nessun problema si profila per quanto concerne lo scioglimento dei consigli, al quale si provvede con DPR su
proposta del Ministro dell’interno ex art. 39 legge n. 142/1990 e art. 1 legge n. 13/1991.
Per quanto concerne la rimozione e sospensione degli amministratori degli enti locali, l’art. 40 della legge n.
142 prevedeva la necessità del DPR..
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 13/1991 la competenza risultava passata al Ministro dell’interno,
in precedenza proponente.
L’art. 40, comma 1, è stato poi sostituito dall’art. 4 della legge 18.1.1992 n. 16, che ha nuovamente fatto
riferimento al DPR.
La giurisprudenza non ne ha tratto la conclusione che l’art. 2, comma 1, fosse stato implicitamente abrogato in
parte qua, perché la legge n. 13/1991 prevede, con una clausola di fissità, che le disposizioni da essa recate non
possano essere abrogate se non espressamente.
Tuttavia la Giurisprudenza di questo Consiglio in sede giurisdizionale ha valorizzato la circostanza che, dopo
l’entrata in vigore della legge 25.3.1993 n. 81 sull’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, la
rimozione o decadenza dell’organo monocratico comporta lo scioglimento del relativo consiglio ( art. 37 bis legge
n. 142/1990 come introdotto dall’art. 20 legge n. 81/93) traendone la conclusione che alla rimozione del sindaco o
del presidente della provincia deve provvedersi con DPR ( CS sez. IV 28.5.1997 n. 582).
In effetti è incongruo ritenere che possa il Ministro autonomamente adottare un atto ( la rimozione del sindaco)
cui consegue di necessità lo scioglimento del Consiglio, al quale invece provvederà il Presidente della Repubblica.
A tali conclusioni si è adeguata la prassi amministrativa, che prevede ora rimozione del sindaco e scioglimento
del consiglio con unico DPR.
Per quel che qui interessa, il problema riguarda dunque solo gli altri amministratori di enti locali la cui
rimozione è prevista dall’art. 40 legge n. 142/1990 e cioè: presidenti dei consorzi e delle comunità montane,
componenti dei consigli e delle giunte, presidenti dei consigli circoscrizionali.
Ragioni sistematiche inducono a ritenere che in tali casi la competenza a provvedere permanga in capo al
Ministro.
In tal senso, va innanzi tutto considerato che l’ordinamento ben conosce una ampia serie di ipotesi nelle quali
la sospensione o la decadenza degli amministratori locali consegue di diritto al verificarsi di determinati
presupposti, secondo il vigente testo dei commi 4 bis e 4 ter dell’art. 15 della legge 19.3.1990 n. 55 recante Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale.
Ora, se il Legislatore, pur avendo codificato fattispecie peculiari in cui la sanzione consegue ope legis, ha
espressamente previsto una generale misura sanzionatoria - la rimozione di cui all’art. 40 della legge n. 142 – deve
dedursi che tale misura abbia un carattere di chiusura e come tale non possa che essere il frutto di un
apprezzamento “ latamente discrezionale” ( cfr. C. Cost. 19.3.1993 n. 103).
In un contesto in cui la promozione delle autonomie e il diritto degli eletti a svolgere il munus loro affidato
hanno sicuro rilievo costituzionale, all’Autorità procedente è affidato dunque un delicato giudizio in ordine alla
compatibilità di un concreto comportamento in ipotesi posto in esser da amministratori locali con il bisogno di
conservazione dell’integrità istituzionale, con il necessario rispetto di valori basilari per la convivenza sociale e
l’ordine costituzionale.
Le precise espressioni adoperate dal Legislatore – identiche a quelle dell’art. 39 comma 1 lettera a) della stessa
legge n. 142, relative allo scioglimento dei consigli comunali – postulano apprezzamenti che si riferiscono a valori
essenziali per la convivenza organizzata: l’adozione delle relative misure – che possono assolvere anche una
funzione preventiva e quindi basarsi, oltre che sulla avvenuta lesione dei valori costituzionali tutelati, sul concreto
pericolo di compromissione degli stessi- sembra configurarsi appunto come uno degli “altri atti” che rientrano a
pieno titolo nella funzione di indirizzo politico amministrativo e come tali spettano all’Organo di governo.
Le conclusioni ora rassegnate trovano conforto nelle recenti acquisizioni della giurisprudenza costituzionale.
Giudicando del conflitto di attribuzione sollevato da una regione a statuto ordinario avverso il provvedimento
con il quale è stato in parte delegato ai soprintendenti territorialmente competenti l’esercizio dei poteri di
autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni regionali rilasciate ex art. 82 del DPR n.
616 del 1977, come modificato dalla legge n. 431 del 1985, la Corte ( sentenza n. 333 del 24.7.1998) ha
individuato il proprium dell’ attività tecnico amministrativa in ciò che essa si svolge “ al di fuori di compiti e
responsabilità di direzione politica” e “ in materia non riservata ad organi costituzionalmente rilevanti in funzione
di garanzia”.
Deve dedursene, conclusivamente, che ove – come nel caso della rimozione discrezionale di amministratori
locali che ne occupa - vengano in rilievo i tratti distintivi anzidetti ( responsabilità di direzione politica, funzione
di garanzia) è configurabile “ una riserva di poteri statali in capo al Ministro quale organo responsabile politico “ (
sentenza cit.) a garanzia dei rapporti fra Stato e autonomie.
2.2 Il secondo quesito riguarda l’individuazione dell’Organo competente ad adottare i provvedimenti in materia di
cittadinanza.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica osserva che la concessione dello status di cittadino presuppone
l’emanazione di un DPR ( art. 1, comma 1 lettera a) della legge n. 13 del 1991) il che esclude la competenza
dirigenziale.
La questione presenta però ulteriori profili.
In effetti, ai sensi dell’art. 9 della legge 5.2.1992 n. 91 ( Nuove norme sulla cittadinanza) la concessione della
cittadinanza avviene con DPR, nei casi ivi elencati al comma 1 lettere da a) a f) tutti legati alla residenza per
determinati periodi o nel caso, di cui al comma 2, dello straniero che ha reso eminenti servizi alla Repubblica.
Gli articoli da 5 a 8 della stessa legge disciplinano però in modo peculiare la fattispecie relativa al coniuge del
cittadino, cui la cittadinanza si trasmette ( art. 5) in via per così dire automatica.
Se non esistono motivi ostativi, nel caso del coniuge di cittadino la cittadinanza si acquista ( art. 7) con decreto
del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato.
I motivi ostativi sono elencati all’art. 6 comma 1 che così dispone:
“ Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo
a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno
da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.”.
Ai sensi dell’art. 8, ove sussistano le cause ostative ora elencate, il Ministro dell’interno, con decreto motivato,
respinge l’istanza.
Sempre ai sensi dell’art. 8, ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su
conforme parere del Consiglio di Stato.
La normativa in rassegna configura quindi le seguenti differenziate ipotesi nelle quali sino ad ora era pacifica la
competenza ministeriale:
-
acquisto della cittadinanza da parte del coniuge del cittadino;
-
diniego per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5;
-
diniego, su conforme parere del Consiglio di Stato, per ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica.
Nel caso da ultimo richiamato, già ragioni formali del tutto assorbenti convincono della perdurante
competenza del Ministro.
Sul punto va intanto ricordato che, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il parere in
questione – in quanto vincolante – deve essere richiesto pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 17 comma 26 della
legge n. 127 del 1997, che ha abrogato le diverse disposizioni di legge che prevedevano il parere obbligatorio del
Consiglio di Stato. ( CS Sez. I 21.5.1997 n. 3/97).
Il parere deve dunque essere richiesto e non può chiederlo altri che il Ministro, come espressamente previsto
dall’art. 36 del R.D. 21.4.1942 n. 444 (Regolamento di esecuzione della legge sul consiglio di Stato).
Conferma l’art. 3, comma 1 lettera f) del d. l.vo n. 29 che le richieste di parere al Consiglio di Stato spettano al
Ministro.
Ne consegue che, ove vengano in rilievo ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, al diniego non può che
provvedere il Ministro: diversamente opinando, verrebbe a configurarsi un procedimento composito e non
razionale, in cui il Ministro interviene nella fase preparatoria, richiedendo con atto rientrante nelle funzioni di
indirizzo politico amministrativo il parere del Consiglio, mentre il Dirigente adotta il provvedimento finale.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto concerne le ipotesi del conferimento della
cittadinanza al coniuge e del diniego della stessa per i motivi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 della legge n. 91.
Come sopra detto, la legge n. 91 del 1992 disciplina la posizione del coniuge del cittadino in modo del tutto
peculiare, in sostanza collegando al matrimonio una automatica comunicazione dello status civitatis.
Non a caso, mentre in tutte le altre ipotesi ( cfr. art. 9) la cittadinanza è frutto di una concessione, il coniuge del
cittadino invece acquista tale status: il che spiega perché il Legislatore del 1992, proprio nel riconfermare che la
cittadinanza si concede in generale con DPR, abbia in deroga previsto che il coniuge del cittadino la acquisti con
decreto ministeriale.
In definitiva, deve ritenersi che il coniuge del cittadino sia titolare – in generale - di un vero e proprio “ diritto
soggettivo all'emanazione del decreto, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da
parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto. ( SS.UU. sent. n. 1000 del 27-01-1995, Frenopolus c.
Ministero dell'interno).
In tale contesto, fatta salva l’eventuale sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, l’acquisto o
il diniego sono atti del tutto vincolati, restando esclusa ogni forma di apprezzamento discrezionale e ogni
valutazione che possa avere riflessi di natura politica: sembra perciò doversi concludere che tali atti rientrano
pleno iure nella competenza gestionale del dirigente.
Concludendo sul punto, sarà il Ministro a denegare l’acquisto per ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica
o ad accogliere l’istanza se il Consiglio ritiene che le dette ragioni non sussistono; sarà invece il Dirigente ad
accogliere l’istanza di acquisto o a respingerla per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della legge
n. 91 o per ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 5 (scioglimento o annullamento del matrimonio, cessazione effetti
civili etc).
2.3 Un ulteriore quesito riguarda l’autorizzazione alla consultazione di documenti di carattere riservato conservati
negli archivi di Stato.
Ad avviso del Dipartimento per la Funzione Pubblica, l’autorizzazione alla consultazione di documenti
riservati conservati negli archivi di Stato integra una competenza di tipo gestionale, devoluta quindi alla
responsabilità dirigenziale, conclusione a favore della quale certamente sono prospettabili considerazioni
enucleabili da una prima lettura della normativa in questione.
Ed invero l’art. 21, commi primo e secondo, del DPR 30.9.1963 n. 409 così recita: “ I documenti conservati
negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla
politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati
relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali
sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.
Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere
riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.”.
Le norme ora trascritte, nel mentre presuppongono il carattere riservato di determinati documenti, si limitano
dunque a conferire al Ministro la facoltà di autorizzare la consultazione di detti documenti per motivi di studio
prima che sia decorso un cinquantennio: ad una prima lettura non sembrerebbe perciò che nella fattispecie
ricorrano i presupposti per ritenere che l’autorizzazione in questione implichi valutazioni di carattere ampiamente
discrezionale, aventi riflessi di natura anche politica.
Considerazioni ulteriori, appunto conseguenti all’esame di carattere sistematico della normativa di settore,
inducono però a ritenere preferibile la opposta conclusione, alla stregua della quale il potere autorizzatorio in
questione pertiene tuttora al Ministro.
In primo luogo è da rilevare che nel procedimento è previsto l’intervento consultivo di un organo ( la Giunta
del Consiglio superiore degli archivi) che ha sì composizione prevalentemente tecnico-accademica ma è
presieduto dal Ministro stesso: è evidente una certa disarmonia nella tesi che qui si disattende, perché il Ministro
interverrebbe nel procedimento, mentre il provvedimento finale sarebbe invece adottato da un Dirigente.
Ma anche a voler superare tale obiezione, ritenendo che la presidenza ministeriale dell’organo consultivo abbia
carattere prevalente di garanzia, dirimente appare una ulteriore considerazione.
Come è noto, storicamente le attribuzioni in materia di archivi erano devolute al Ministero dell’interno ed
erano espletate per il tramite della Direzione generale degli archivi.
Il decreto legge 14.12.1974 n. 657, istitutivo del Ministero per i beni culturali, non incideva sulla materia.
Il Parlamento però, in sede di conversione, riteneva di includere nelle competenze del Ministero anche le
attribuzioni già spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti
considerati come eccezione alla consultabilità dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409 ( art. 2, comma secondo lettera c), del d. l. citato introdotto dalla legge di conversione
29.1.1975 n. 5).
Nel devolvere l’intera materia ad un distinto Dicastero, il Legislatore ha dunque tenuto ferma la speciale
competenza autorizzatoria del Ministro dell’interno: è questo il segno palese che l’autorizzazione può comunque
involgere profili peculiari e comporta apprezzamenti correlati a parametri – l’indirizzo politico in senso stretto, le
linee guida di politica interna ed estera – che fuoriescono dall’ambito della competenza dirigenziale.
3. Un ulteriore quesito riguarda l’oggetto del potere ministeriale di annullamento per motivi di legittimità, fatto
salvo dall’art. 14, comma 3, d. l.vo n. 29.
L’art. 14, comma 3, del d. l.vo n. 29/1993, come sostituito dall’art. 9 d. l.vo n. 80/1988, dopo aver previsto che
“ il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti” reca tre proposizioni ai sensi delle quali resta salvo il potere di annullamento
governativo in ogni tempo degli atti illegittimi, resta salvo il potere del Ministro dell’interno di annullare gli atti
definitivi dell’Autorità di PS e “ Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità”
Il Ministero dell’interno dà per scontato che la disposizione ora trascritta in corsivo abbia mantenuto in capo al
Ministro il potere di annullare atti dirigenziali illegittimi e chiede lumi in ordine alle modalità di esercizio di tale
potere.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica dà invece della disposizione una interpretazione diametralmente
opposta, riferendola all’annullamento da parte del Ministro degli atti da lui stesso adottati.
La tesi del Dipartimento poggia sui seguenti argomenti:
-
intervenuta abrogazione ( art. 74 comma 2 d. l.vo 80) dell’intero capo I del DPR n. 748/1972, nel cui seno l’art. 3
disciplinava l’annullamento ministeriale di atti dirigenziali;
-
insussistenza, nel nuovo sistema ordinamentale, di un rapporto di gerarchia in senso formale fra organo di
direzione politica e dirigenza amministrativa.
Nonostante l’indubbio spessore di tali rilievi, la tesi proposta dal Dipartimento non appare convincente.
In primo luogo c’è infatti da chiedersi perché nel contesto di un articolo tutto volto a disciplinare i poteri del
Ministro al cospetto di atti dirigenziali, il Legislatore avrebbe dovuto inserire una disposizione relativa
all’autoannullamento da parte dell’Organo di direzione politica di atti dallo stesso emanati.
In secondo luogo, accedendo all’interpretazione che qui si contrasta, la disposizione in rassegna finisce per
essere al tempo stesso tautologica ( per quel che dice espressamente ) e dirompente ( per ciò che presuppone).
Tautologica perché essendo il potere c.d. di autoannullamento connaturato alla funzione amministrativa, è
pacifico che esso pertenga anche al Ministro riguardo gli atti da lui emanati.
Dirompente perché ( ubi voluit dixit, ubi non dixit non voluit ) così interpretata la disposizione lascia supporre
– come in effetti fa il Ministero dell’interno – che il Dirigente sia stato spogliato di tale potere di
autoannullamento dei propri atti.
Premesso dunque che la tesi del Dipartimento per la Funzione Pubblica suscita forti perplessità, è il caso allora
di saggiare l’insuperabilità degli argomenti ermeneutici che tale tesi supportano, valutando la possibilità di
approdare ad una diversa ricostruzione della materia.
Secondo i principi acquisiti, all’annullamento degli atti amministrativi invalidi – cioè per quanto qui interessa
non conformi alle regole di legittimità – la Pubblica Amministrazione può procedere d’ufficio o su ricorso.
L’annullamento di ufficio a sua volta può esser pronunciato nell’esplicazione di poteri di controllo o di poteri
di autotutela.
Sempre secondo i principi e non considerando l’ipotesi eccezionale dell’annullamento governativo di cui all’art. 6
TULCP, la potestà di annullamento in sede di autotutela pertiene indiscutibilmente alla stessa autorità che ha
posto in esser l’atto invalido ( c.d. autoannullamento).
Come è stato efficacemente precisato, il provvedimento di autoannullamento è la principale espressione
dell'autonomo e discrezionale potere generale di autotutela spettante all'amministrazione. ( C. Stato, sez. IV, 1203-1992 n. 275). Ed in effetti se la necessità – inerente al principio di buon andamento – della continua
rispondenza dell’assetto dei rapporti amministrativi all’interesse pubblico fa sì che alla PA ( diversamente che ai
privati) sia riconosciuta la potestà, quante volte l’interesse pubblico lo esiga, di tornare sulle proprie statuizioni
anche se non invalide ( revoca di atti difettosi nel merito), a maggior ragione l’ autorità emanante deve poter
annullare, a certe condizioni, gli atti da essa emanati i quali si rivelino ab initio viziati.
E’ perciò da escludersi che il dirigente sia stato spogliato, per l’effetto della disposizione in esame, del potere
di autoannullamento.
Sempre secondo i principi, la potestà di annullamento di cui si discute compete però, oltre che all’organo che
pose in essere l’atto invalido, anche alle autorità dotate di poteri gerarchici rispetto al primo.
La regola dell’annullamento gerarchico – ancorché espressamente enunciata solo nell’art. 6 Testo Unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773- ha comunque portata generale, derivando da
potestà connaturata all’esplicarsi della funzione amministrativa in ordinamenti contrassegnati da una struttura
gerarchica in senso proprio.
In tal senso in passato si riteneva pacificamente che il Ministro, in virtù della sua posizione di supremazia
gerarchica, disponesse di una generale potestà di annullamento in qualunque tempo degli atti adottati dagli organi
del dicastero dipendente, anche se definitivi ( cfr. appunto penultimo e ultimo comma art. 6 TULPS).
Su tale consolidato assetto dei poteri, ha inciso profondamente l’art. 3 del DPR 30.6.1972 n. 748, che ha
soppresso – per quel che concerne gli atti dirigenziali - la generale potestà di annullamento ministeriale,
eccezionalmente mantenendola solo ( art. 3 comma quinto) nei confronti dell’autorità di PS cui si riferisce l’art. 6
TULPS.
Nel contesto di una attenuazione del ruolo gerarchico del Ministro, l’art. 3, comma terzo, del DPR n. 748
prevedeva come è noto che il Ministro potesse soltanto entro quaranta giorni annullare gli atti adottati dai
dirigenti del dicastero per vizi di legittimità o riformarli per vizi di merito.
Se questo è il quadro sul quale cala l’art. 14 del d. l.vo n. 29 come novellato, sembrerebbe ragionevole
ipotizzare – in prima approssimazione - che l’annullamento ministeriale per motivi di legittimità fatto salvo dalla
novella sia proprio quello di cui all’art. 3, terzo comma, DPR n. 748.
Depone in tal senso innanzi tutto il locus materiae, poiché l’art. 14 comma 3 appare tutto volto a disciplinare i
poteri ministeriali nei confronti di atti o attività o inerzie dirigenziali.
Depone in tal senso, ulteriormente, il rilievo che il comma in questione nella parte in cui sottrae al Ministro
poteri prima riconosciutigli si riferisce analiticamente e minuziosamente alla revoca, alla riforma, alla riserva o
all’avocazione ma nulla dice circa l’annullamento per vizi di legittimità, che è invece il provvedimento di secondo
grado per eccellenza.
A fronte di tale conclusione ermeneutica, le obiezioni del Dipartimento per la Funzione Pubblica, relative al
venire meno del rapporto gerarchico fra dirigente e Ministro appaiono, come anticipato, non insuperabili.
Va infatti ricordato che l’ordinamento conosce ipotesi non marginali nelle quali il potere di annullamento
d’ufficio è disgiunto da un rapporto di supremazia gerarchica.
In disparte ogni riferimento al caso eccezionale dell’annullamento governativo, va però rilevato che le regioni
possono annullare entro dieci anni dal rilascio le concessioni edilizie rilasciate illegittimamente dai comuni ( art. 7
legge 22.10.1971 n. 865) e che soprattutto il ministro può, nei casi previsti e con specifiche procedure, in sostanza
annullare taluni atti illegittimi adottati da enti sottoposti alla sua vigilanza e da lui quindi non gerarchicamente
dipendenti.
Posto dunque che il Ministro può annullare gli atti dei dirigenti, resta da definire se ciò egli possa fare solo
entro quaranta giorni o in ogni tempo.
La prima ipotesi, che comprime il potere ministeriale entro stretti termini, ha per ciò stesso il pregio di affidare
al Ministro una valutazione esclusivamente appuntata sul profilo di legalità.
Sul piano testuale a tale tesi deve però muoversi l’obiezione che fa leva sulla indiscussa abrogazione del Capo
I del DPR n. 748, nel cui ambito appunto l’art. 3 disciplinava quello speciale annullamento soggetto al limite
temporale di quaranta giorni.
E’ poi da dire che nel contesto del DPR n. 748 l’annullamento entro quaranta giorni era in qualche modo
procedimentalizzzato e si inseriva in un sistema relazionale Ministro-Dirigente puntualmente disciplinato: basti
ricordare che ( in virtù della disposizione ora abrogata di cui all’art. 3, comma 2, DPR 748/1972) il Ministro
poteva disporre in via generale e preventiva che i dirigenti gli comunicassero in visione determinate categorie di
atti da essi adottati.
In tale problematico contesto deve ritenersi che nel nuovo quadro ordinamentale, l’annullamento in questione
non possa non configurarsi che come evento eccezionale.
Se così è, la disposizione in argomento riveste allora un carattere di chiusura: esclusa ogni possibilità di
revoca, di riforma, di riserva o di avocazione, il Legislatore ha voluto conservare al Ministro il potere –
meramente demolitorio - di annullare gli atti dirigenziali per motivi di legittimità in ogni tempo.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'esercizio di tale potere di annullamento d'ufficio, di natura squisitamente
discrezionale, sarà condizionato, oltre che alla sussistenza di un vizio di legittimità, anche a ragioni di pubblico
interesse che giustifichino l'eliminazione del precedente atto, e che sono da individuarsi, al di là del mero
ripristino della legalità, in una particolare ed attuale esigenza che, a giudizio del Ministro, meriti una maggiore
considerazione e tutela delle posizioni giuridiche nel frattempo acquisite dai terzi sulla base dell'atto viziato.
Allo stato dunque, pur riconoscendo l’indubbio carattere ellittico della disposizione, si conclude nel senso della
sopravvivenza in capo al Ministro di un preciso potere – in qualche modo extra ordinem e come tale non
puntualmente disciplinato – di annullamento in ogni tempo degli atti dirigenziali per motivi di legittimità, potere
che evidentemente il Legislatore correla alle responsabilità politiche e costituzionali (art. 95 comma terzo Cost.)
di tale Organo.
4. Un ulteriore quesito concerne l’individuazione dei provvedimenti adottati dall’autorità di pubblica sicurezza
avverso i quali è tuttora esperibile il ricorso gerarchico al Ministro.
L’amministrazione riferente, premesso che la riforma ha mantenuto l’istituto del ricorso gerarchico al Ministro
esclusivamente avverso i provvedimenti dirigenziali adottati dall’autorità di PS, pone il quesito se la fattispecie
ricomprenda i soli provvedimenti adottati in base al TULPS oppure ogni atto concernente la tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, a prescindere dalla fonte normativa che lo regola.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, avuto riguardo in via sistematica alla delicatezza delle problematiche
coinvolte, propende per l’interpretazione estensiva, che appare senz’altro da condividere.
In effetti la lettera della norma- che richiama espressamente l’art. 6 TULPS e l’art. 10 del relativo regolamento
R.D. 6.5.1940 n. 635 – milita in tal senso.
L’art. 6 TULPS così dispone:” Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di
pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del
provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno”.
Le norme ora trascritte, con evidenza, non si riferiscono a provvedimenti nominati dell’Autorità di PS, ma a
tutti gli atti da essa adottati ai sensi del TULPS e delle leggi speciali.
Se la fonte primaria genericamente intesa ( la legge, non il solo TULPS) può predicare la definitività di tali
atti, è segno evidente che sussistono provvedimenti dell’Autorità di PS ( ad es. l’avviso orale ) disciplinati
sostanzialmente al di fuori del TULPS stesso.
Non si vede in conclusione alcuna ragione né letterale né sistematica in virtù della quale l’esperibilità del
ricorso gerarchico al Ministro debba circoscriversi ai provvedimenti dell’Autorità di PS emanati ai sensi del
TULPS.
In tale contesto, resta ovviamente fermo nella sua integralità il sistema sin ora vigente, nel senso che tutti i
provvedimenti del questore sono ricorribili presso il prefetto, e non ovviamente presso il Ministro ( art.1 comma 1
DPR 24.11.1971 n.1199) e che i provvedimenti del prefetto sono invece impugnabili presso il Ministro solo se
non definitivi, ai sensi del TULPS o delle leggi speciali.
5. Un ulteriore quesito concerne la persistente esperibilità di taluni ricorsi gerarchici impropri.
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d. l.vo n. 29 “ gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali…. non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.”.
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d. l.vo n. 80 “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.
Il Ministero dell’interno si domanda come il combinato disposto delle norme in argomento incida sul regime
dei cosiddetti ricorsi gerarchici impropri ed in particolare:
a) sul ricorso al Ministro dei Trasporti avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di cui
all’art. 223, comma 5, del Codice della strada (d. l.vo 30.4.1992 n. 285);
b) sul ricorso al Ministro dell’interno ( che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti) avverso il
provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida di cui all’art. 120, comma 3, C.d.S.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica esprime l’avviso che la peculiarità del rimedio in questione ne consenta
la conservazione anche nel nuovo ordinamento: sembra doversi intendere, se si interpreta correttamente l’ avviso
del Dipartimento, che la potestà decisionale del gravame improprio rimane in capo al Ministro.
Da tale conclusione dissente la II Sezione di questo Consiglio di Stato la quale, nell’esprimersi su un quesito
analogo a quello in rassegna, considera assodato, sulla scorta di un complesso iter argomentativo, che ai sensi
della riforma il Ministro è comunque privato della capacità decisoria di qualsivoglia ricorso gerarchico, sia pure
improprio.
In sintesi, secondo tale tesi, la riforma, accentuando la scissione tra livello di responsabilità politica e livello di
responsabilità amministrativa, ha devoluto il potere di esprimere la parola ultima dell’amministrazione ( vale a
dire: di emettere atti definitivi) non più al Ministro ma al dirigente generale.
Al tempo stesso, avendo il decreto legislativo n. 80 tolto al Ministro la potestà decisoria dei ricorsi avverso gli
atti del plesso amministrativo a lui sottoposto, a fortiori deve ritenersi che di tale potestà il Ministro sia stato
privato per quel che riguarda gli atti di differenti plessi amministrativi.
Fermo tale profilo, resterebbero problematicamente aperte le seguenti alternative soluzioni ermeneutiche:
a) salvezza del ricorso gerarchico improprio, con traslazione dei poteri decisori in capo al dirigente generale
competente per materia. (In favore di tale soluzione si è incidentalmente espressa la Sezione terza con parere del
13/10/1998 n.1028)
b) Incompatibilità del ricorso gerarchico improprio con un sistema nel quale l’atto prefettizio, prima impugnabile, è
ora ope legis definitivo.
Procedendo all’esame della complessa questione, va preliminarmente precisato che quelli in esame sono – in
senso tecnico – ricorsi gerarchici impropri: tale è il ricorso al Ministro dei trasporti ex art. 223 perché il Prefetto,
ancorchè rappresenti il Governo nell’ambito provinciale, è pur sempre incardinato nell’Amministrazione
dell’interno; tale è il ricorso ex art. 120, perché deciso di concerto dai due Ministri.
Ciò detto, deve affermarsi la persistente esperibilità dei gravami in argomento.
Invero, ricordato che le norme che contemplano il ricorso gerarchico improprio sono norme speciali che
rimandano ad una relazione interorganica fra plessi diversi dell’amministrazione più che ad un vero e proprio
rapporto di gerarchia fra autorità decidente ed autorità emanante, non vi è dubbio in primo luogo che la norma
primaria, laddove prevede l’esperibilità del ricorso improprio, demanda la decisione sulla controversia ad un
organo o ad una amministrazione che istituzionalmente cura un interesse diverso da quello devoluto all’organo o
amministrazione adottante.
E’ evidente dunque la specialità del rimedio che prevale sulla definitività, predicata dalla riforma in via
generale, degli atti dirigenziali.
In secondo luogo, dirimente è il rilievo che il venir meno del vecchio ricorso improprio indubbiamente
depotenzierebbe gli strumenti di tutela di cui il cittadino può valersi, in una materia nella quale per norma i profili
di merito, non conoscibili in sede giurisdizionale, hanno grande peso: e non si vede perché – in difetto di espressa
previsione normativa, esistente solo per i ricorsi gerarchici propri – debba sopprimersi in via interpretativa un
rimedio previsto dalle normative di settore.
Quanto all’individuazione dell’Autorità alla quale i ricorsi impropri possono tuttora essere proposti, pur
non disconoscendosi il valore delle argomentazioni prospettate a favore di una soluzione di segno opposto, le
stesse non si appalesano idonee a supportare la conclusione che il Ministro sia stato spogliato al riguardo di ogni
potere decisorio.
L’ipotesi della traslazione di detti poteri decisori al Dirigente sembra da contrastare innanzi tutto per ragioni
formali.
Una norma o è speciale ( e quindi resiste alla posteriore generale ) o non lo è: ma sembra da escludere una
specialità ad effetti limitati.
Questo risultato e non altro si avrebbe, infatti, se si mantenesse il ricorso improprio ( qui la specialità rileva e
la legge speciale resiste) e contestualmente si trasferisse il potere decisorio dal Ministro al dirigente ( qui prevale
la norma generale posteriore).
In disparte tale rilievo formale, a contrastare una siffatta conclusione depone l’ulteriore considerazione che il
potere giustiziale di cui fa uso l’autorità decidente in sede contenziosa ( pur restando oggettivamente
amministrativo) ha comunque tratti caratteristici, non meramente gestionali, proprio perché orientati a realizzare
una massima garanzia di imparzialità compatibilmente con i caratteri della funzione amministrativa.
Inoltre, come sopra si è detto, se si vuole individuare un tratto comune distintivo in quelli che tradizionalmente
si denominano ricorsi gerarchici impropri, ebbene tale tratto deve rinvenirsi in ciò che la legge li prevede in casi
eccezionali nei quali non esiste un rapporto di gerarchia fra autorità emanante e autorità decidente, ma solo
l’occasionale rapporto funzionale che si estrinseca nella potestà di decisione del gravame, quale riflesso di una più
ampia posizione di supremazia o di controllo.
Il decidente – giova ribadire - non giudica del gravame improprio perché si trova in posizione di supremazia
rispetto all’emanante: in virtù di una espressa previsione legale, il decidente giudica nella sua qualità di organo
preposto alla considerazione di un interesse pubblico diverso da quello in cura all’autorità che emette l’atto.
E’ per questo che il fondamento del ricorso improprio risiede non in una norma generale implicita
nell’ordinamento gerarchico, bensì in una norma particolare e speciale, di diritto positivo.
E così disposizioni speciali ( cfr. l’elencazione pacificamente non esaustiva di cui all’art. 1, comma secondo,
DPR 24.11.1971 n.1199) prevedono ricorsi amministrativi di tipo impugnatorio da un ente ad un altro ente, da un
organo collegiale ad un altro o a un organo individuale, nonché contro provvedimenti di autorità poste al sommo
della scala gerarchica.
In tale prospettiva, la definitività dell’atto non rileva dunque: ciò di cui si deve tenere conto è della espressa
volontà del Legislatore di sottoporre, nel limite dei motivi di legittimità e di merito dedotti, quell’atto alla
valutazione di un altro Organo, precisamente individuato dalla normativa primaria di riferimento, ancorchè non
gerarchicamente sovraordinato all’autorità emanante.
Alle conclusioni sovraesposte che evidenziano come al problema, proprio perché di carattere squisitamente di
diritto positivo, non possa essere data una soluzione di carattere generale dovendo la stessa essere verificata caso
per caso, va aggiunto il rilievo, sul piano sistematico, della differenza funzionale tra i due rimedi (abbinati
tradizionalmente sul piano lessicale) che impedisce, in assenza, come si è sopra precisato, di un dato normativo di
segno opposto, di arrivare ad una soluzione in termini generali basata sulla traslazione di risultati propri di un
rimedio all’altro.
Il ricorso gerarchico invero si colloca nell’ambito delle norme organizzative di carattere verticale caratterizzate
dalla presenza di poteri omogenei e solo collocati su piani diversi, sicchè l'eliminazione di uno o più livelli di
revisione obbedisce innanzitutto ad esigenze di semplificazione.
Il ricorso gerarchico improprio si colloca, invece, nell’ambito delle norme di riesame proprie di un apparato
non organizzato verticalmente e caratterizzato dalla diversità funzionale dei poteri attribuiti alla diversa autorità,
sicchè l’abolizione del rimedio si colloca in una prospettiva non già di semplificazione orgnizzativa ma di una
diversa articolazione del sistema dei controlli.
In conclusione, si ritiene che il sistema di impugnazioni gerarchiche improprie di cui agli artt. 120 e 223 del
Codice della strada non sia stato inciso dalla riforma.
6.1 L’Amministrazione si domanda infine se sia ancora esperibile il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica avverso gli atti relativi al rapporto di lavoro del personale c.d contrattualizzato.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, considerato che presupposto indefettibile per la proponibilità del
gravame straordinario è l’impugnazione di un atto amministrativo, ritiene che, dopo l’entrata in vigore del d. l.vo
n. 80, tale rimedio non sia più ammissibile se proposto avverso gli atti contrattuali di gestione del rapporto e
avverso quelle presupposte determinazioni organizzative che sono anch’esse, entro certi limiti come si vedrà,
ricondotte nella sfera privatistica e imprenditoriale.
6.2. Per completezza, si premette che è incontestata la persistenza in via transitoria della previgente disciplina per
quel che concerne le controversie, relative al rapporto di lavoro di tutti i dipendenti pubblici, antecedenti il
30.6.1998.
Del pari incontestata è la persistenza anche dopo tale data della vecchia disciplina per quel che concerne
l’impugnativa di atti relativi a personale c. d. non contrattualizzato.
Le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, commi 4 e 5, d. l.vo n. 29 restano devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto rispetto ad esse permane il regime dell’alternatività
fra ricorso giurisdizionale e straordinario.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per ciò che concerne l’impugnazione di atti relativi alle “procedure
concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” che restano anch’esse devolute alla
giurisdizione del G.A..
Ugualmente deve ritenersi per quel che concerne gli atti amministrativi presupposti al momento di concreta
gestione del rapporto di lavoro privatizzato.
Con riserva di ulteriore approfondimento nel prosieguo, al novero di tali atti sembrano appartenere innanzi
tutto i regolamenti concernenti l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri e i decreti di natura non
regolamentare che definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali ( art.
17, comma 4 bis, legge 23.8.1988 n. 400): sono questi i più importanti fra gli atti organizzativi ( art. 2 comma 1 d.
l.vo n. 29) nell’ordinamento specifico dell’Amministrazione statale..
Tali atti, in quanto amministrativi, sono già per definizione impugnabili davanti al giudice amministrativo,
ricorrendone le condizioni: di ciò comunque l’art. 68, comma 1, d. l.vo n. 29 dà espressa conferma, prevedendo
anzi che l’impugnazione dell’atto presupposto davanti al G.A. non è causa di sospensione del processo civile.
6.3. Il problema riguarda quindi l’ammissibilità del ricorso straordinario nelle controversie che l’art. 68 del d. l.vo
n. 29 ( come modificato prima dal d. l.vo n. 80 e da ultimo dal d. l.vo n. 387 del 1998) devolve al giudice
ordinario.
Per affrontare gradatamente la complessa questione, può partirsi dal rilievo che la tesi dell’inammissibilità
tradizionalmente poggia su due argomenti, in realtà logicamente distinti:
a) impossibilità di adire la sede straordinaria se non mediante l’impugnativa di un atto;
b) necessità che tale atto sia – tradizionalmente – qualificabile come amministrativo in senso oggettivo e soggettivo.
La fondatezza attuale di tali postulati va separatamente verificata.
6.4 Per quanto concerne il primo argomento, va rilevato come in realtà le norme che da lungo tempo governano il
processo innanzi al giudice amministrativo ( ad es. art. 26 R.D. 26.6.1924 n.1054 ) fanno sempre riferimento
all’impugnazione di un atto o provvedimento, copia del quale doveva essere depositata in allegato al ricorso a
pena di inammissibilità dello stesso ( art. 18 Regolamento di procedura R.D. 17.8.1907 n. 642).
In tempi più recenti e pur quando, alla luce delle svolte giurisprudenziali di cui ora si dirà, nessuno dubitava
della possibilità che il giudice amministrativo giudicasse non dell’atto ma del rapporto, il Legislatore sempre e
solo all’impugnazione dell’atto entro termini stretti a pena di decadenza ha continuato a riferirsi ( cfr. artt. 3, 4 e 5
legge 6.12.1971 n.1034).
Per superare la evidente aporia, possono richiamarsi le conclusioni cui già nel 1940 era pervenuta l’Adunanza
Plenaria di questo Consiglio.
“ Le disposizioni sulla giurisdizione esclusiva in materia di alcuni diritti sono venute dopo molto tempo ad
innestarsi nel vecchio tronco di una legge sorta e dominata unicamente o quasi dal concetto degli interessi
legittimi lesi, quindi congegnata, anche per il rito, in vista di essi. Cosicché se si dimostra che tale congegno in
certi casi non si adatta o repugna all’indole del nuovo compito assegnato agli organi di giustizia amministrativa,
piuttosto che supporre nel Legislatore… il cosciente proposito di sacrificare gli attributi sostanziali di quei diritti
ai presupposti e alle esigenze del vecchio rito, è naturale pensare ad una mancanza di coordinamento o di
saldatura fra l’antico e il nuovo istituto e le correlative norme, mancanza a cui l’interpretazione logica deve
sforzarsi di supplire” ( CS Ad. Plen. 18.12.1940 n. 4).
In questo spirito, da lungo tempo, in sede di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo, sulla scorta
della nota distinzione fra atti autoritativi ed atti paritetici, ha esteso il suo sindacato dall’atto al rapporto, per
conseguenza ammettendo azioni ( non già costitutive ma) di accertamento e da proporsi nel termine di
prescrizione.
“ Quando l’impiegato vanti un diritto contro l’amministrazione ad una pura prestazione patrimoniale, la
dichiarazione di rifiuto che l’amministrazione emette in proposito non assume di regola carattere autoritario, ma si
assomiglia al rifiuto del debitore di pagare il suo debito… le dichiarazioni non autoritarie dell’amministrazione
sono equiparabili alle dichiarazioni di parte in un rapporto fra privati.
Conseguentemente, se sianvi controversie su diritti soggettivi devolute agli organi di giustizia amministrativa
sulle quali l’amministrazione provveda senza emettere atti autoritativi, si deve ritenere che quella qualsiasi
dichiarazione che l’amministrazione emetta al riguardo non metta in movimento il termine di decadenza e che si
possa ricorrere anche se nessuna dichiarazione esista. Questi casi di eccezione alla regola dell’impugnazione di un
atto amministrativo … si devono ritenere impliciti nell’ordinamento”.( Sez. V 1.12.1939, n. 795).
Per ragioni connesse all’inesistenza di un ambito di giurisdizione esclusiva e al perdurante richiamo alla
definitività dell’atto ( art. 8 DPR 1199/1971), una analoga evoluzione non si è così chiaramente registrata nella
sede straordinaria.
Ciò non vuol dire che in questa sede, allorquando l’azione è proposta a difesa di diritti soggettivi non
affievoliti da provvedimenti, il rapporto controverso sia inconoscibile nel suo spessore unitario.
Al giudizio sul rapporto, infatti, si perviene ugualmente, sia pure attraverso un passaggio intermedio:
l’ammissibilità del ricorso straordinario in materia paritetica è infatti per norma subordinata al previo esperimento
da parte del ricorrente della procedura per far constare il silenzio rifiuto, come individuata dall’Ad. Plen.
10.3.1978 n. 10.
Peraltro di recente la Commissione speciale per il pubblico impiego ha aperto la via – omisso medio - all’
azione di accertamento in sede straordinaria e, giudicando in tema di negata attribuzione di competenze ai sensi
artt. 34 e segg. CCNL comparto ministeri, senza alcun riferimento al silenzio rifiuto, ha dichiarato il diritto dei
dipendenti alla corresponsione delle somme controverse (CS Comm. spec. P.I. 13.7.1998 n. 411/98).
A conclusione di questo excursus, può dunque fissarsi un primo punto: come è da decenni pacifico in sede
giurisdizionale, anche in sede straordinaria nulla preclude all’organo consultivo di giudicare del rapporto
direttamente o passando per quel surrogato di atto definitivo ( inventato nella attuale configurazione dalla
giurisprudenza per tutelare il privato da inerzie e omissioni della PA) che è il silenzio rifiuto, anche in assenza di
un atto amministrativo.
Ciò stabilendo, si è dunque compiuto un primo tratto del percorso argomentativo.
6.4 - La riflessione deve però essere ulteriormente sviluppata dovendosi verificare se ( non già l’assenza di un
vero e proprio atto amministrativo ma piuttosto) la presenza di un atto di diritto privato, inerente la gestione del
rapporto di lavoro, precluda o meno la proponibilità del ricorso.
Diversamente detto, il punto da esaminare è quello relativo all’ammissibilità del ricorso straordinario proposto
avverso “determinazioni” definitive adottate dalla P.A. facendo uso di poteri privatistici.
In proposito, l’art. 4, comma 2, del d. l.vo n. 29 così dispone: “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro.”.
Da tale disposizione discende il rilievo del Dipartimento: posto che il ricorso straordinario consente
l’impugnativa solo di atti amministrativi e posto altresì che quelli in questione non hanno tutti i connotati dell’atto
amministrativo, ne segue logicamente che essi non sono impugnabili con detto rimedio.
In proposito, la lettera della legge è prima facie chiara ( art. 8 DPR 24.11.1971 n.1199): con il ricorso
straordinario possono impugnarsi solo atti amministrativi definitivi.
La dottrina prevalente conferma trattarsi di atti soggettivamente ed oggettivamente amministrativi: in tali sensi,
tradizionalmente si precisa che la necessità di proporre la contestazione contro un provvedimento soggettivamente
ed oggettivamente amministrativo e quindi avverso un atto assunto dalla PA nella esplicazione di competenze
pubblicistiche rende non utilizzabile il ricorso straordinario per conseguire riparazioni nei riguardi di lesioni non
riconducibili alla PA quale autorità ( fatti illeciti, attività di diritto privato).
Contra, si sottolinea però sempre in dottrina che il ricorso straordinario è concesso – restando offuscata la
chiarezza dei concetti – anche nei confronti di un atto di diritto privato, quale la dichiarazione della PA di non
voler adempiere.
In giurisprudenza, non mancano pronunce che ammettono l’impugnabilità in sede straordinaria di atti di diritto
privato della PA o, per meglio dire, di atti che non costituiscono esercizio di potestà amministrativa.
(Così Sez. I 17.1.1986 n. 92 ha ammesso l’impugnativa della disdetta di un contratto di locazione; così Sez. III
1.4.1980 n. 858 ha ammesso il ricorso straordinario proposto avverso un diniego di equo indennizzo da un
dipendente del Banco Napoli – E.P.E. il cui personale ha rapporto di lavoro privatistico; così soprattutto
Adunanza generale 12.4.1984 n. 7 ha ammesso il ricorso straordinario contro un atto di rescissione di un contratto
di appalto ( art. 27 R.D. 25.5.1895 n. 350), per norma ritenuto privatistico.
L’indirizzo giurisprudenziale prevalente è però in senso contrario e di esso deve dunque tenersi conto nella
presente sede.
L’indirizzo ora richiamato si è consolidato in un contesto in cui la distinzione fra atto amministrativo e atto
negoziale della PA era netta, il primo costituendo la regola ed il secondo l’eccezione.
Se si considera che l’attività contrattuale più rilevante è sempre stata normalmente doppiata o comunque
potenzialmente intersecata da determinazioni autoritative della PA e se si eccettua il settore della responsabilità
aquiliana, l’attività di diritto privato vera e propria – la cui conoscenza risultava preclusa al G.A. ed al Consiglio
in sede giustiziale – appariva senz’altro recessiva, rispetto al soverchiante prevalere di moduli pubblicistici.
Da tempo non è più così.
Senza nessuna pretesa di completezza può richiamarsi il prevalere, a livello normativo, di nuovi modelli
procedimentali fondati sull’accordo fra PA e privati e governati dai principi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti ove compatibili ( art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241).
Può altresì richiamarsi la crescente prevalenza del modello organizzativo societario di diritto comune, il quale
ormai si è diffuso in decisivi settori dell’Amministrazione centrale e locale, soppiantando Aziende, Enti pubblici e
addirittura Enti pubblici economici: il richiamo d’obbligo è alle Ferrovie, alle Poste, ai Monopoli, alle
municipalizzate etc..
Interi comparti di quella che un tempo era la pubblica amministrazione tradizionale sono transitati nell’area
privatistica, come avviene oggi per il pubblico impiego.
A fronte di fenomeni di tale portata e di scelte legislative dal carattere permanente e strutturale, non sembra
che la vecchia distinzione fra l’attività di diritto pubblico della PA e quella di diritto privato sia rimasta immutata.
Queste tematiche, che attendono ancora una sistemazione definitiva in sede dottrinale, sono state
affrontate dalla giurisprudenza.
Così la Corte costituzionale, posta di fronte al problema se la trasformazione di un ente in società per azioni
facesse venir meno ipso facto il regime dei controlli ordinariamente previsti per gli enti pubblici, ha concluso per
la negativa, facendo dunque prevalere le ragioni sostanziali su quelle formali.
Secondo la Corte, la semplice trasformazione, disposta dall’art. 15 della legge n. 359 del 1992 di taluni enti
pubblici economici in società per azioni, ( INA, ENEL, ENI etc.), non può essere infatti ritenuta motivo
sufficiente a determinare l’estinzione del controllo della Corte dei conti, fino a quando rimanga inalterato nella
sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi
nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o
prevalente al capitale azionario delle stesse ( C. cost. 28.1.21993 n. 466).
Così il giudice amministrativo, posto di fronte al problema ( ora positivamente risolto in radice dall’Adunanza
Plenaria) se l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’ art. 22 della legge n. 241 riguarda anche l’attività di
diritto privato della pubblica amministrazione, ha cercato di individuare, nell’ampio novero degli atti di diritto
privato posti in essere da un soggetto pubblico, quei particolari atti che accedono ad un attività la quale,
indipendentemente dal suo regime giuridico formale, costituisce nella sua essenza cura concreta di interessi della
collettività (CS sez. VI 3.6.1997 n. 843), in tal modo distinguendo casi di attività privatistica effettivamente
disancorata dall’interesse di settore e casi in cui tale attività è finalizzata immediatamente all’interesse collettivo. (
CS sez. IV 15.1.1998 n. 14).
Così la Cassazione, posta di fronte al problema di giurisdizione nel caso delle concessioni per la realizzazione
di opere pubbliche, ha chiarito che gli atti posti in essere dal concessionario non sono atti di diritto privato, per il
solo fatto di essere stati adottati da un soggetto privato: infatti, l’attività svolta dai privati concessionari conserva
la natura di attività amministrativa in senso obiettivo dato che la sua funzione è quella di assicurare la protezione
dell’interesse pubblico, istituzionalmente spettante al concedente e poi trasferita al concessionario (SS.UU.
29.12.11990 n. 12221).
Infine, è noto che la normativa comunitaria privilegia qualificazioni sostanziali dell’attività amministrativa
pubblica: basti pensare, per quel che riguarda le procedure di appalto ad es. nei settori esclusi, come la nozione di
“ soggetto aggiudicatore” ricomprenda indifferenziatamente amministrazioni pubbliche in senso stretto, imprese
pubbliche, società private da queste direttamente o indirettamente controllate, soggetti privati che si avvalgono di
diritti di esclusiva o speciali ( art. 2 d. l.vo 17.3.1995 n. 158 e art. 2 direttiva del Consiglio 93/38 CEE)
Da quanto sin qui esposto consegue che nel nuovo, complesso contesto ordinamentale l’espressione “atto
amministrativo” può essere considerata di carattere “neutro” ( cfr. CS sez. VI ord. 2.9.1998 n. 1205) e, ai fini che
ne occupano, si presta a ricomprendere – diversamente dall’insegnamento dottrinale e giurisprudenziale ricevuto –
anche atti soggettivamente provenienti dalla PA ed evidentemente finalizzati all’attuazione degli obiettivi
individuati dal Legislatore, ma da essa adottati in regime privatistico, come gli atti organizzativi e, nell’ambito
degli atti concernenti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, quelli che costituiscono espressione di
funzioni aventi rilievo pubblicistico.
Quanto ora esposto sembra trovare conferma nella stessa lettera dell’art. 68, comma 2, d. l.vo n. 29, sopra
richiamato nella parte in cui mantiene “ devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in
materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Sul punto, nessun aggancio testuale consente di opinare che le suddette procedure siano in concreto espletate dalla
PA con poteri diversi da quelli del privato datore di lavoro.
Eppure, il Legislatore ha mantenuto le relative controversie nella giurisdizione generale di legittimità ( stando
al dato testuale, univoco, non sarebbe giurisdizione esclusiva), prefigurando quindi davanti al GA un contenzioso
su impugnazione di atti i quali – secondo l’impostazione tradizionale – non sarebbero dunque oggettivamente
amministrativi.
6.5 - Può dunque concludersi che la natura solo soggettivamente amministrativa di un atto non ne preclude
l’impugnazione mediante il ricorso straordinario.
Ai fini della impugnabilità in sede straordinaria fermo restando il requisito della definitività, solo conta che
l’atto della P.A., indipendentemente dal suo regime giuridico formale, risulti direttamente ed immediatamente
finalizzato alla cura di un interesse pubblico specifico.
Ma, se non esistono preclusioni, allora vale la regola consolidata secondo la quale il ricorso straordinario è un
rimedio amministrativo di carattere generale, il che ne comporta l’esperibilità in tutti i casi in cui ciò non sia
escluso dalla legge (cfr. Ad. Gen. Del 29/5/1997 n.72, ma cfr. anche C. Cost. nn. 31 del 1975 e 298 del 1986) o in
cui il rimedio sia incompatibile con il sistema.
6.6. - Con riferimento alla ipotesi della oggettiva incompatibilità da ultimo richiamata, deve ora esaminarsi un
diverso profilo del problema.
Prima, però, va ricordato l’insegnamento consolidato secondo il quale il ricorso straordinario può essere
proposto anche nelle materie che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. ( CS Ad. Gen. 29.4.1971 n.
45).
Fuori dall’ambito della giurisdizione esclusiva, esistono infatti casi in cui, pur in presenza di un atto
amministrativo, la tutela del diritto - non affievolito – che si pretenda leso va domandata al giudice ordinario e non
al giudice amministrativo: si pensi alla ripartizione vincolata degli incentivi per l’editoria o provvidenze consimili,
all’adempimento da parte della PA di obbligazioni nascenti direttamente dalla legge.
In questi, come in altri casi nei quali è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, la lesione del diritto
risulta spesso inferta da un atto amministrativo, come tale impugnabile con il ricorso straordinario: detto ricorso
infatti è esperibile a tutela non solo di interessi legittimi ma anche di diritti.
Entro questi limiti, il ricorso straordinario per l’annullamento dell’atto e l’azione civile per l’accertamento del
diritto sono rimedi concorrenti e non alternativi, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di
disapplicare l’eventuale decisione del ricorso e ferma restando l’improcedibilità del ricorso stesso ove
previamente si formi il giudicato in sede civile (CS Ad. Gen. n.72/1997 citata).
Ben diverso invece è il caso in cui il giudice ordinario o amministrativo siano titolari di competenza funzionale
e inderogabile (ad es. per il GA materia elettorale, accesso; per il GO opposizione a sanzioni amministrative): per
giurisprudenza consolidata, in tal caso la devoluzione della materia ad un determinato giudice con carattere di
esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario.
Tanto chiarito, in linea generale, specialmente dopo le modifiche al c.p.c. introdotte dal decreto legislativo n.
80 e dopo l’istituzione in primo grado del giudice unico, la devoluzione al giudice del lavoro della materia in
argomento (salva la condizione di procedibilità del previo esperimento di procedure di conciliazione) non sembra
avere alcun carattere di specialità, nel senso anzidetto.
Esclusa quindi in generale la specialità della competenza del giudice del lavoro, riprende vigore anche nella
materia de qua, e nell’ambito così delineato, il consolidato principio della concorrenza fra il ricorso al GO e il
ricorso straordinario, non ostando a tale conclusione gli indubbi inconvenienti connessi istituzionalmente alla
concorrenza dei rimedi in questione, che peraltro non avranno nel comparto de quo connotati diversi da quelli da
tempo individuati relativamente alla tutela riconosciuta in sede straordinaria ad altri diritti soggettivi.
Allo stato, di competenza speciale può e deve invece parlarsi per quel che riguarda le controversie in materia
di comportamenti antisindacali della PA, avuto riguardo ai poteri che l’art. 28 Statuto dei lavoratori demanda al
Giudice e alla peculiare procedura ivi disegnata.
6.7 - Un ultimo aspetto della questione riguarda l’eventuale ricorribilità in sede straordinaria:
a) delle decisioni pronunciate dal collegio di conciliazione avanti al quale possono essere impugnate le sanzioni
disciplinari ( art. 59 bis d. l.vo n. 29)
b) delle decisioni del collegio cui sia stata deferito arbitrato irrituale per la soluzione della controversia ai sensi
dell’art. 412- ter c.p.c..
Qui nessun dubbio è possibile, avendo già chiarito la Comm. spec. per il pubblico impiego che le pronunce in
argomento sono lodi, come espressamente ora si desume per il caso sub b) dall’art. 412 quater c.p.c., il che
esclude la proponibilità del ricorso straordinario. ( CS Comm. spec. PI 7.12.1998 n. 404).
P.Q.M.
Nei suesposti termini è il parere.
Per estratto dal Verbale
Il Segretario Generale
Visto
Il Presidente