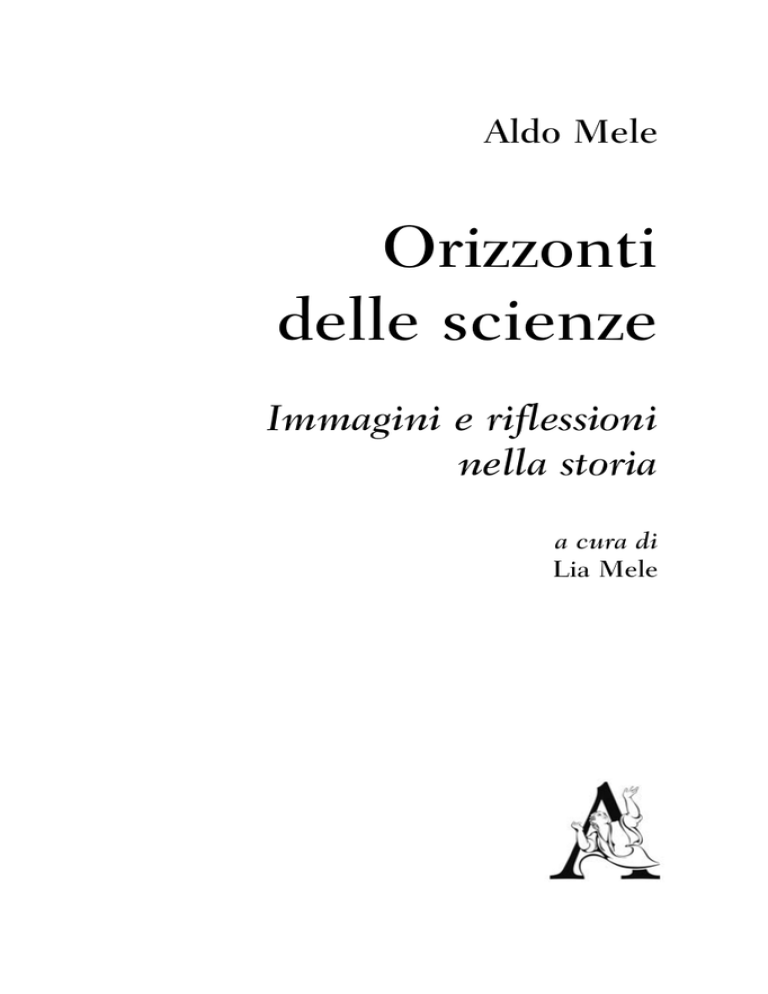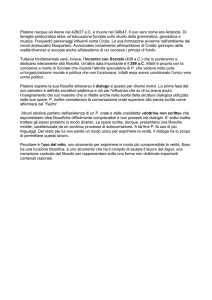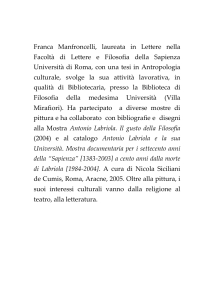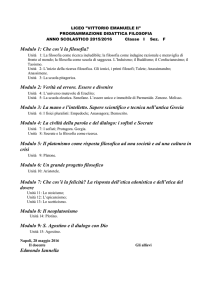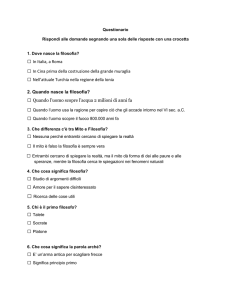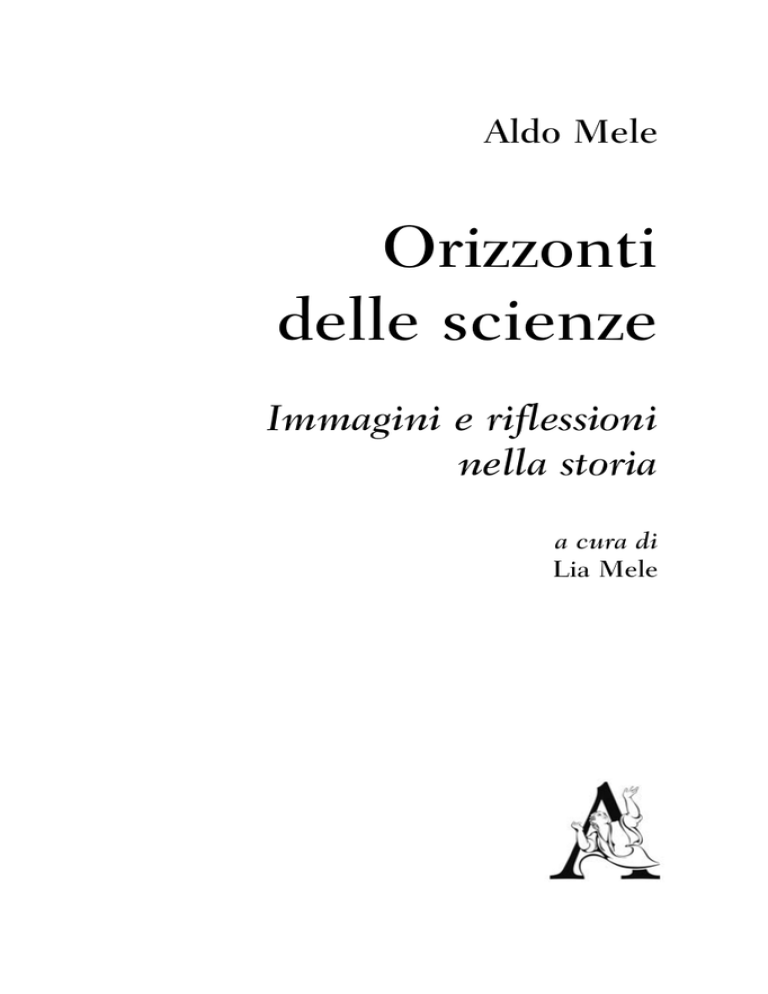
Aldo Mele
Orizzonti
delle scienze
Immagini e riflessioni
nella storia
a cura di
Lia Mele
Copyright © MMIX
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–2761–5
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: settembre 2009
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
19:16
Pagina 7
Indice
Prefazione
p.
9
Ringraziamenti
p.
13
Introduzione
p.
15
I.
Scienza e filosofia
p.
21
II.
La Scienza dalle origini all’Ottocento
p.
37
III.
Complessità, caos e frattali
p.
61
IV.
La ricerca attuale
p.
79
V.
Ricerca Sperimentale e Teorica
p.
111
VI.
Il ricercatore
p.
121
VII. Collaborazioni
p.
137
VIII. Memorie e futuro delle Scienze
p.
147
Glossario
p.
165
Bibliografia
p.
171
7
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
19:16
Pagina 8
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
19:16
Pagina 21
I
Scienza e filosofia
La parola“causa” è così fuorviante che è meglio
eliminarla dal vocabolario filosofico.
(Bertrand Russel)
La storia della filosofia della scienza occidentale ha inizio all’epoca dei filosofi presocratici (per il loro avvento temporale precedente la figura di Socrate). Con essi la civiltà greca inizia a
dare i suoi grandi frutti. Essi furono i primi a porsi domande
propriamente scientifiche. Innanzitutto, qual è il principio delle
cose e dell’universo (in greco arché)? Le loro domande non
riguardavano solo la fisica, ma miravano a dare una spiegazione dell’intero cosmo. Infatti nel loro caso più che di una fisica
si parla di una cosmologia. Diverse furono le risposte alla
domanda riguardante l’elemento primo: chi lo pose nell’acqua
(Talete 634-548 a.C.), chi nell’aria (Anassimene 560-528 a.C.),
chi nel fuoco (Eraclito 540-480 a.C.). Anassimandro (610-546
a.C.), invece, diede una spiegazione più astratta e parlò di un
indeterminato, un senza confini (greco àpeiron). Tutti questi
filosofi furono anche scienziati e uomini coinvolti nella politica, fatto che attesta il coinvolgimento della loro riflessione nelle
questioni del tempo.
Uno dei nodi fondamentali della filosofia occidentale é il rapporto tra il soggetto e l’oggetto (in questo caso fra scienziato e
21
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
22
30-11-2008
19:16
Pagina 22
Capitolo I
Figura 1. La costa delle scienze raccoglie le varie discipline in un
idilliaco contesto.
natura). In filosofia, con questi termini si vuole distinguere fra la
persona che osserva la realtà e il dato naturale stesso, in quanto
opposto all’osservatore2. Questa relazione è per noi talmente
ovvia che non vi riflettiamo più. La filosofia è una forma di risveglio, ma questo non può aver luogo senza l’aiuto della storia.
Nell’antica Grecia era difficile distinguere con precisione il
soggetto dall’oggetto, per la naturale predisposizione dell’uomo
greco all’apertura estatica nei confronti della natura: l’uomo
greco aveva una capacità molto maggiore della nostra di identificarsi con la fenomenicità della natura che si illuminava di dei e
di fenomeni meravigliosi. Naturalmente questo è valido anche
per l’uomo di altre culture all’inizio della loro formazione
(l’uomo africano, asiatico, arabo). I presocratici sono stati i primi
scienziati dell’umanità e il loro dire è soffuso anche di grande
poesia e religiosità; sono stati i primi a riflettere sulla natura
(physis) concetto che in loro è molto ampio, includente gli esseri umani, il mondo e perfino gli dei. Dai maggiori pre-socratici
2
Emblematico, in questo senso, è il termine usato nella lingua tedesca per
dire “cosa”: gegenstand, che letteralmente indica ciò che sta davanti.
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
Scienza e filosofia
19:16
Pagina 23
23
Talete, Anassimene, Anassimandro, Eraclito, Parmenide (520440 a.C.), Democrito (460-370 a.C.), Pitagora (571-497 a.C.)
hanno per secoli preso ispirazione i filosofi e gli scienziati dei
secoli seguenti. In essi la scienza (epistème) è la conoscenza nel
senso più ampio possibile. All’interno non c’erano ancora le
frammentazioni a cui siamo ormai abituati (poesia, filosofia,
religione, arte, le differenti scienze teoriche e applicate). I presocratici si ponevano di fronte al fenomeno della realtà (al Tutto)
liberamente, in apertura di spirito, sensibili alle cause delle cose,
ma anche all’interconnessione di tutte le cause dell’universo.
Una disposizione che è andata perduta nel tempo, e alla quale si
sta faticosamente cercando di tornare oggi più da parte degli
scienziati che non dei filosofi.
Parmenide fu il primo ad avere la visione di un cosmo la cui vera
realtà andava oltre l’apparenza dei fenomeni. Solo apparentemente le cose cambiano e mutano forma, in realtà tutto è uno,
tutto è essere, pieno, perfetto, immobile. La scuola che seguì
ebbe un bel da fare per spiegare matematicamente queste asserzioni, ma attraverso questo sforzo si affinarono anche le capacità
di analisi e le logiche del paradosso. Eraclito si pose invece all’estremo opposto della concezione parmenidea, con
l’affermazione che la realtà era un continuo fluire, e che non si
poteva affondare il piede nello stesso fiume per due volte consecutive. Questo però non fece di lui un relativista scettico: anch’egli pensava ad una struttura comune a tutte le cose, che chiamò
Logos, ragione intrinseca del cosmo, sebbene misteriosa e invisibile a tutt’oggi. I frammenti delle opere di Parmenide e di
Eraclito esercitano un grande fascino, e ad essi si sono ispirati
filosofi e scienziati, per le diverse interpretazioni possibili del
loro pensiero, come fecondo lo è ogni pensiero importante.
Come si vede, tratto comune delle filosofie dei presocratici fu il
pensiero del Tutto, una ricerca completa, un amore della sapienza (filosofia), all’interno della quale non vi erano settori e neanche una netta delimitazione fra filosofia e scienza.
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
24
30-11-2008
19:16
Pagina 24
Capitolo I
Figura 2. Platone. Particolare della “Scuola di Atene” di Raffaello
Sanzio.
A seguito delle concezioni eraclitee, sorse lo scetticismo,
scuola critica importante, i cui dibattiti erano ancora ben vivi al
tempo di Platone. Svolse un’importante opera di controcanto alle
tentazioni di dogmatismo, presenti sia nella filosofia di
Parmenide che nella filosofia platonica, il più importante esempio di pensiero dell’antichità greca, dell’intero Occidente3.
Tuttavia è soltanto con Socrate (469-399 a.C.) che si inizia a
intravedere la formazione del soggetto filosofico moderno, sebbene non vi sia ancora nel suo insegnamento nessuna critica nei confronti dell’ispirazione divina in quanto illusione o irrazionalità.
Socrate parla addirittura di un misterioso “demone” (figura
divina, ma non propriamente un dio) che lo ispira e gli impedisce di non esprimere ciò che gli viene suggerito. Per l’antico
3
Nel Medioevo europeo e anche successivamente era in uso dire che
l’intero pensiero filosofico era l’opera di un nano (il pensatore dell’epoca in
questione) ritto sulle spalle di un gigante (Platone).
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
Scienza e filosofia
19:16
Pagina 25
25
greco l’oggetto, come l’oggetto religioso per così dire, non è
ancora relegato a quella invalicabile distanza che noi moderni
sperimentiamo. La storia del nostro percepire si mescola alla storia socio-culturale. Socrate è il primo pensatore della storia a
porsi la domanda “cosa è”: cos’è la giustizia, il sacro, l’essere. Il
cosa è – l’essenza (ousia) di Aristotele – concetto fondante del
meditare filosofico, si affaccia sulla scena con questo grande,
enigmatico personaggio. Socrate non scrisse nulla, ma insegnò
gratuitamente ai giovani ateniesi, trasmettendo loro quello che
aveva acquisito ragionando con se stesso e con i suoi contemporanei. Socrate è anche l’attore principale di quasi tutti i Dialoghi
di Platone (427-347 a.C.), suo esimio discepolo e vertice del
pensiero occidentale classico. Senza Aristotele, Socrate e
Platone non esisterebbe né la filosofia, così come la conosciamo
nella sua storia plurimillenaria, né la scienza.
La triade classica verrà per così dire a ripetersi, con i tre grandi pensatori della modernità occidentale Cartesio (1596-1650),
Kant (1724-1804) e Hegel (1770-1831). Dopo di loro, non riusciamo più a vedere le cose con uno sguardo ingenuo – e sarebbe davvero ingenuo pensare che potremmo: nessuno nasce tabula rasa, nemmeno l’analfabeta.
La cultura di oggi, anche quella scadente e di terza mano di
certa pubblicità e televisione, fa convergere la capacità di vedere verso una prospettiva, che, per quanto banale, è in realtà il
risultato del peso intero della complessità accumulata nel corso
di più di venti secoli di civilizzazione.
Platone formò il suo pensiero negli anni trascorsi alla scuola
del suo maestro Socrate. Secondo una metodologia di pensiero
che sviluppò quella del suo maestro, Platone cercò di identificare e fissare per iscritto nei suoi celebri Dialoghi gli elementi
strutturali della realtà che non muta. Ci riuscì partendo dalla
domanda socratica cos’è? Socrate chiedeva ai suoi concittadini
poco consapevoli di quel che vivevano cosa fossero per loro la
giustizia, l’equità, la santità, la virtù, e tramite delle domande
giuste convinceva il suo interlocutore che non era in grado di dare
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
26
30-11-2008
19:16
Pagina 26
Capitolo I
una definizione di queste concetti. Il “cos’è” porterà gradualmente Platone alla sua concezione dell’essenza, l’idea. L’idea è
un elemento stabile di conoscenza intellettuale tratto sperimentalmente dalla realtà ma formatosi nell’interiorità dell’anima.
L’uomo esce dalla sua ignoranza quando apprende che tutta la
conoscenza è dentro di lui e che bisogna soltanto risvegliarla. Nei
Dialoghi, il cui personaggio principale è quasi sempre Socrate,
Platone vuole dimostrare, ascendendo verso una teorizzazione
sempre più complessa e ardita, come la realtà “vera” sia, come
sosteneva Parmenide, nascosta agli occhi degli uomini, ma accessibile mediante e grazie alla realtà sperimentabile quotidianamente. Ciò che Platone cerca di mostrarci attraverso la sua opera
è che esiste, una stabilità e una unitarietà del tutto, discernibile
attraverso le idee in un cammino filosofico arduo e affascinante
che passa attraverso la matematica e la geometria.
Aristotele4 (384-323 d.C.), il più importante discepolo di
Platone, se ne allontanò gradualmente e decisamente, criticandone soprattutto la dottrina delle idee. Il generale non poteva spiegare l’individuale, e l’individuale era ciò che andava definito con
precisione. L’essere delle cose, parola chiave dell’intera filosofia
platonica, non poteva consistere nell’approccio alla realtà, in
qualcosa di unitariamente valido per tutte le singole cose.
L’essere doveva potersi dire, e cioè spiegare, comprendere in
molti modi. Questa concezione, che sta al centro della sua opera
maggiore, la Metafisica, sicuramente veniva ad Aristotele dalla
sua maggiore propensione all’osservazione della natura, soprattutto della biologia marina, mentre Platone era più propenso ad
una riflessione astratta. Sommariamente, si potrebbe dire che
Platone è stato il più grande fra i filosofi ad aver usato un metodo deduttivo, e Aristotele il più grande ad aver utilizzato un
metodo induttivo, anche se, certamente, un solo elemento non
4
Diogene Laerzio nelle sue Vite dei filosofi narra che Platone chiamava
Aristotele “la mente”.
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
Scienza e filosofia
19:16
Pagina 27
27
può render giustizia alla profondità e complessità del loro pensiero. Aristotele aprì l’unità granitica dell’essere senza infrangerla, dando ad ogni campo dello scibile una sua dignità. Si può
affermare con sicurezza che è stato la prima vera figura di scienziato-filosofo della storia.
Le cause efficienti e finali di Aristotele, d’altra parte, corrispondono da vicino al nostro uso di “causa”. L’idea è che ogni
cosa fa quello che fa (è in movimento) perché sta tentando di
raggiungere il suo scopo. In particolare, ogni movimento si spiega come dovuto a un tentativo di raggiungere il suo naturale riposo o equilibrio.
La filosofia trasse origine da una ricerca sul perché del Tutto, ma
procedette in questa ricerca totale soltanto fino all’età ellenistica, epoca in cui la scienza propriamente detta subì un tracollo,
con Plotino (204-270 d.C.) e con la sua scuola, detta NeoPlatonica. Prima dei neoplatonici bisogna però soprattutto ricordare la grande figura di Euclide (323-285/283 a.C.), che con i
suoi Elementi pose le fondamenta della scienza matematica e
della geometria, generando un modo di vedere il mondo che
durerà per secoli, fino cioè all’epoca di Newton. Ci vorrà la
ripresa e la critica della scienza geometrica che ebbe luogo del
XIX secolo, con David Hilbert, per costituire una prospettiva differente. La teoria della relatività di Einstein metterà ancora più
profondamente in crisi questa prospettiva fondante, immettendo
l’elemento tempo e l’elemento dell’osservatore nel campo apparentemente intoccabile della fisica classica.
Euclide, fu fondamentale perché usò un metodo interamente
deduttivo, partendo da alcuni pochi assiomi centrali per dedurre
un sistema perfetto. La concezione dello spazio dell’uomo occidentale ne trarrà la sua visuale. Quello euclideo è un sistema che
dipende molto poco da considerazioni pratiche, anche se in esse
troverà la sua applicazione, e trae la sua ragion d’essere dal rigore con cui giunge a decisioni inoppugnabili da quei pochi principi che erano stati posti all’inizio del suo procedere.
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
28
30-11-2008
19:16
Pagina 28
Capitolo I
Il Medioevo europeo fu invece un’epoca in cui la ricerca
scientifica subì un ribasso e la speculazione umana si concentrò
sugli aspetti filosofici puri, soprattutto in relazione alla ricerca
teologica, che raggiunse in questo periodo un vertice ineguagliato, soprattutto con figure quali S. Agostino (354-430), S.
Tommaso d’Aquino (1225-1274) e Duns Scoto (1266-1308).
Anche Aristotele venne letto soprattutto in relazione alla sua
metafisica e alle opere sull’etica.
Bisogna quindi aspettare la fine del Medioevo per vedere sorgere le prime figure di scienziati veri e propri, per es. Copernico
(1473-1543), che osò per primo mettere in questione la centralità
della terra nel sistema solare (derivante dall’interpretazione di un
passo biblico, che si tendeva a leggere in funzione realistica oltre
che teologica).
Ma per riprendere, anche se solo per brevi tratti, la storia del
nostro diventare soggetti, vediamo come, col tempo, attraverso
Platone e Aristotele, il filosofo, prima vera figura del cittadino del
mondo, avanza sulla scena. È in lui che dobbiamo per prima vedere le fattezze dell’uomo moderno e contemporaneo, che ragiona
(anche se con poco rigore) per sé. Una lunga e avvincente storia,
attraverso la filosofia ellenistica (scetticismo, stoicismo, Plotino e
la scuola dei Neo-Platonici), la filosofia araba ed ebraica, e la grande filosofia cristiana medioevale, giunge alle prime prove di vera
emancipazione dell’individuo, con i Saggi di Montaigne (15331592), gli scritti di René Descartes (Cartesio, 1596-1650) e di
Spinoza (1632-1677), fino a giungere – con l’aiuto della scuola
empiristica inglese, Locke (1632-1704), Berkeley (1685-1753) e
Hume (1711-1776) alla figura eminente di Kant (1724-1804). È a
lui che dobbiamo la prima chiara formulazione dell’autonomia dell’individuo, rispetto alla figura dell’uomo dipendente (eteronomo),
la quale aveva trovato la sua prima formulazione filosofica nel pensiero platonico, aristotelico e neoplatonico. Con Kant, l’individuo
può dichiararsi pienamente libero da qualsiasi influenza esterna, e
determinare se stesso unicamente in base ai criteri della ragione
vista nel suo modo di essere trascendentale (Ragion Pura).
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
Scienza e filosofia
19:16
Pagina 29
29
Prima di Kant, nell’epoca moderna, Cartesio è stata la figura
più grande di filosofo e di scienziato, al punto che si è detto, non
a torto, che con lui nasce la modernità vera e propria. Mentre
nelle altre figure del XVII secolo, anche figure di scienziati, la
critica alla Scolastica era sottaciuta o indiretta, Cartesio le sferrò
contro un vero ed aperto attacco. Eminentemente matematico e
teorizzatore delle scienze naturali, fu un filosofo di prima grandezza, con cui si dovranno inevitabilmente cimentare le più grandi figure della filosofia del suo secolo e di quello seguente.
Cartesio è il primo individuo che ha osato avventurarsi con la
massima audacia nel territorio dell’Io, operando
un’introspezione rigorosa ed accurata dei suoi fondamenti, e
scendendo, si potrebbe dire, nei suoi abissi, con una meditazione interamente laica sulla personalità. Senza il Discorso sul
metodo e le meditazioni metafisiche di Cartesio, non ci sarebbe
stata la filosofia europea moderna e, quindi, neanche la grande
filosofia kantiana. Kant rappresenta il culmine del pensiero
dell’Illuminismo e, al contempo, la sintesi di tutto il pensiero
precedente. Potremmo paragonare la sua filosofia alla musica di
Bach, per lo sguardo d’insieme e per l’abilità concettuale nell’aver raccolto insieme tutti i materiali precedenti in una sintesi che
fu infine portata avanti da Hegel (1770-1831), per quanto possa
essere utile, anzi ingannevole, parlare di “progresso” nel caso di
pensatori di questa enorme importanza.
La più importante figura di scienziato italiano fu Galileo Galilei
(1564-1642). Scrittore di talento ed esperimentatore tenace oltre
che teorico, condusse una lotta, non voluta e sofferta con le autorità ecclesiastiche che non vedevano di buon occhio una conseguenza delle sue inoppugnabili scoperte, l’apparente contraddittorietà di alcuno passi biblici.
Per la nascita della sperimentazione vera e propria Francesco
Bacone (1561-1626) fu invece una figura essenziale: egli teorizzò
per primo la necessità di rivolgersi all’osservazione della natura
senza pregiudizi, senza formare teorie definitive sulla realtà.
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30
30-11-2008
19:16
Pagina 30
Capitolo I
Mise in luce con estremo vigore l’importanza di non affrettarsi a
giungere ad una conclusione, mentre si osserva lo svolgimento
dei fenomeni della natura. Rimase invece nebulosa la parte propriamente finale del suo metodo induttivo. La filosofia di Bacone
corre il rischio di accumulare osservazioni sopra osservazioni,
esperimenti sopra esperimenti, senza giungere al momento generalizzatore, cioè senza trarre le somme di quello che si è osservato. Per questo la si può definire una forma di empirismo radicale.
Figura 3. Immanuel Kant.
Ma è Kant ad esplicitare per primo la completa indipendenza,
come pure la libertà, della ragione nel cercare in se stessa i fondamenti del suo conoscere5, del suo sentire morale6 ed estetico7.
Nel pensiero precedente, la ragione assumeva il suo stato dalla
sua dipendenza dal mondo, dalla società, dai sensi, nel fatto della
sua creaturalità. Ora Kant, dopo aver cercato i confini del suo Io
internamente a se stesso, alla pari di Cartesio, fonda la possibilità della ragione in se stessa.
5
Critica della ragion pura
Critica della ragion pratica
7
Critica del giudizio
6
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
Scienza e filosofia
19:16
Pagina 31
31
Il tribunale della ragione – come lo chiama il nostro autore –
deve giustificare soltanto di fronte a se stesso la validità e
l’apoditticità del suo operare. Non ha da misurarsi con altri. Egli
trova internamente alla ragione la giustificazione della scienza
e del pensiero, invece di far dipendere la ragione dal mondo
esterno, dai dati offertigli dai sensi. Dentro trova un intero
mondo, che precedentemente era stato trovato fuori. Il fuori
(l’oggetto) e il dentro (il soggetto) erano mantenuti in equilibrio
a favore dell’esterno, fino ad almeno a S. Agostino e S.
Tommaso, per poi essere messi in discussione gradualmente, ma
decisamente a partire da Cartesio in poi. Il soggetto aveva
acquistato così, in una relazione tutta da definire con
l’avanzamento delle tecniche, delle istituzioni giuridiche e statuali, una posizione di primo piano, che lo aveva messo però in
attrito e in crisi con le istituzioni che gli avevano fornito ogni
sicurezza (la Chiesa e lo Stato per esempio). Si può dire insomma che la storia dell’uomo europeo è la storia di un uomo che
si trova sempre più solo, privo di sicurezze. Si può facilmente
immaginare quale tipo di conflitti interni ed esterni tale processo possa aver causato.
Non che Kant neghi alcuno dei ritrovamenti concettuali e spirituali che lo hanno preceduto, però sposta il fulcro della verità
internamente al soggetto, facendone un sovrano; al tempo stesso,
e questo è il suo genio, non facendo dell’individuo un soggetto
irresponsabile ed istintivo, ma anzi, anche per l’influenza del suo
credo religioso protestante, ne sposta internamente il fulcro della
responsabilità, rendendo l’individuo un soggetto pienamente
responsabile delle sue azioni e dei suoi interventi nella società.
Tutto questo si potrà comprendere meglio prendendo in considerazione una distinzione fondamentale del pensiero kantiano,
quella fra fenomeno e noumeno. Il fenomeno è il mondo che ci
viene presentato dai sensi e raccolto dalla nostra esperienza quotidiana, al quale si oppone il noumeno, il mondo dei concetti pienezza del mondo intelligibile, vero mondo in un certo senso, cui
il soggetto è chiamato ad operare.
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
32
30-11-2008
19:16
Pagina 32
Capitolo I
È l’intelletto, in base ad alcune categorie fondamentali, che dà
forma al mondo, alla possibilità del mondo così come lo concepiamo. Il problema di Kant era infatti anche quello di fondare
una scienza apodittica, cioè evidente, che si salvasse dalle obiezioni ad ogni intellettualismo che erano state formulate dal suo
grande predecessore scozzese Hume (1711-1776). Questi, criticando il concetto di causalità, aveva sostenuto che qualsiasi legame causa-effetto reperibile nel mondo sensibile ha, quanto alla
sua validità apodittica, un valore relativo al momento e a tutti i
momenti in cui lo percepiamo. Il fatto che abbiamo osservato
centinaia di volte il fenomeno sensibile per cui l’acqua (di uno
stagno, di un lago), all’abbassarsi della temperatura, si trasforma
in ghiaccio, non ci assicura del fatto che questo fenomeno debba
avvenire ogni volta che la temperatura si abbassa sotto un certo
livello. Potrebbe darsi, sosteneva Hume, che una volta, anche una
sola volta, ciò non avvenga.
Le conseguenze per qualsiasi fondamento scientifico e filosofico erano evidenti. Veniva infatti abolita l’idea stessa di un
sapere stabile, capace di strutturarsi in leggi e in ordinamenti
perenni. Kant trovò la strada per uscire da questo vicolo cieco
dimostrando come ad essere legislatore sia l’intelletto, e come il
metodo della scienza e della filosofia si fondi sulla innata capacità e fondatezza dell’intelletto di legiferare. L’intelletto umano
insomma non era più in balia degli eventi esterni, ma era esso ad
imporre alla realtà le leggi che, al contempo, aveva trovato come
loro struttura, nel mondo esterno. Questi concetti, di estremo
interesse nelle scienze del periodo newtoniano e post-newtoniano, verranno esaminati nei capitoli che seguono.
Non si possono ignorare alcuni aspetti della filosofia che,
presenti nelle filosofie da Hegel, Locke e gli esistenzialisti
hanno un ruolo nelle scienze moderne.
L’esistenzialismo ci libera dalle abitudini del passato fondato sul
mito (una verità culturale, piuttosto che verità assoluta). Per citare Jean Paul Sartre (1905-1980), l’Esistenza precede e comanda
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
Scienza e filosofia
19:16
Pagina 33
33
l’Essenza: è il fondamento dell’esistenzialismo. Io esisto come
essere umano. Nella mia esistenza, definisco me stesso e il
mondo intorno a me. La popolarità di questa filosofia (in particolare per i giovani) può essere compresa per la sua libertà di
scelta personale e di individualismo in un contesto moderno
dove non esiste una verità assoluta. L’Essere e il Nulla (1943) è
il maggior documento dell’esistenzialismo. Il quesito primario è:
cosa vuol dire appartenere alla razza umana?
Nello svolgersi del pensiero filosofico che ha avuto sempre
un riscontro nelle scienze non poteva mancare una corrente di
filosofia che ci liberasse dall’abitudine di un passato fondato su
un mito di una verità culturale piuttosto che una verità assoluta,
quale può essere cercata in un contesto scientifico. Questa corrente di pensiero ha trovato la sua espressione nell’esistenzialismo di Sartre, Camus (1913-1960), Simone de Beauvoir (19081986) e altri autori della prima metà del XX secolo. In termini
epistemologici si viene a negare che vi possa essere una assoluta e oggettiva descrizione del mondo senza che vi sia l’intervento
di un interesse umano. I concetti di libertà e scelta sono di cruciale importanza nell’esistenzialismo e questo porta ad affermare che le scelte autentiche sono completamente indeterminate.
È giusto chiedersi se in questo ambito sia possibile trovare una
verità nel nostro rapporto con la natura. Le verità in filosofia,
infatti, sono verità di fede; le verità delle scienze sono vere
obbiettivamente e sono caratterizzate dalla loro certezza e dalla
loro validità universale.
Questi argomenti vengono sviluppati poi da Edmund Husserl
(1859-1938) fondatore della teoria della fenomenologia dove si
afferma che una ricerca va condotta in modo da mettere assieme
i vari aspetti positivi e negativi. Essi tendono ad esaminare
l’accettazione della materia inosservabile e i grandi sistemi eretti nel sistema speculativo, cioè ad opporsi al naturalismo (chiamato anche positivismo e oggettivismo), una visione del mondo
che deriva dalle moderne scienze naturali e tecnologiche. I fenomenologisti quindi tendono a riconoscere il ruolo di una descri-
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
34
30-11-2008
19:16
Pagina 34
Capitolo I
zione in termini universali, a priori, oppure in termini eidetici
come una spiegazione a priori a mezzo di cause e scopi.
La fenomenologia si è diffusa nel secolo XX in quasi tutti i
paesi del mondo e nei più vari settori: nella geografia, la psicologia, l’ecologia, la medicina la danza e in molti altri. Per il suo
continuo sviluppo e diffusione ad altre discipline e in tutto il pianeta, molti ritengono, anche se ciò è opinabile, che sia il movimento filosofico più significativo del XX secolo.
È difficile mettere insieme fenomenologia, esistenzialismo e
scienze. La fenomenologia rispecchia quanto si può osservare
dal verificarsi di un qualche fenomeno in natura, in quale che sia
il settore, sia delle scienze dell’uomo che di altre discipline.
Nel XIX secolo il filosofo danese Soren Kierkegaard (18131855), il primo scrittore a definirsi esistenzialista, reagì contro la
tradizione classica insistendo che il più alto valore per
l’individuo è di trovare la sua unica vocazione. Scrisse infatti nel
suo diario: «Devo trovare una verità che è vera per me... l’idea
per la quale possa vivere o morire». Altri scrittori esistenzialisti
hanno fatto eco al credo di Kierkegaard che ognuno deve scegliere la propria via senza l’aiuto dell’universale o altri obbiettivi
standard. Contro la tradizionale visione che la scelta morale
implica un giudizio obbiettivo di giusto o sbagliato, gli esistenzialisti hanno argomentato che non possono essere trovate basi
razionali obbiettive per decisioni morali.
Il filosofo tedesco Nietzsche (1844-1900) a sua volta contesta che sia l’individuo a dover decidere quale situazione deve
contare come situazione morale. Prima di lui Leibniz (16461716) a questo proposito aveva affermato di fare una distinzione
fra idee vere e idee false, e di non attribuire troppa libertà all’immaginazione dell’uomo con il pretesto che egli possiede un intelletto chiaro e distinto e crede proprio per questo di essere libero
di inseguire le sue chimere.
Nella storia della filosofia un commento di Hegel (17701831) in un certo modo può trovarci d’accordo con quanto afferma l’esistenzialismo a proposito dell’abitudine fondata su un
mele_aracne_finale_04.qxd:mele_aracne
30-11-2008
Scienza e filosofia
19:16
Pagina 35
35
mito culturale. Hegel sostiene che «la storia della filosofia
mostra che le filosofie, che sembrano diverse, sono una medesima filosofia in diversi gradi di svolgimento. La filosofia che è
ultima nel tempo, è il risultato di tutte le precedenti». Sartre e gli
altri non sarebbero probabilmente d’accordo con queste idee.
Forse sarebbe il caso di ripensare a questi condizionamenti. Un
filosofo all’inizio dei suoi pensamenti probabilmente cercherebbe di aggiornarsi nei dettagli su quanto è stato detto prima, e oggi
può farlo con maggiore speditezza che non in passato aprendo il
suo computer e consultando i vari autori speditamente. Le sue
idee, cioè il pensiero del futuro filosofo potrebbero di conseguenza essere perfezionate dalla sua consultazione e probabilmente raggiungerebbero una maggiore completezza. Questa idea
vuole rivolgersi al pensiero dei vari autori dell’esistenzialismo.
Kierkegaard, Nietzsche e altri scrittori che sono stati deliberatamente non sistematici nell’esposizione della loro filosofia,
potrebbero non essere più convinti della loro posizione antirazionale, ma solo che alcune importanti questioni nella vita non sono
accessibili alla ragione o alla scienza. È forse illuminante riportare a questo proposito quanto ha detto Kant: «la scienza è la
conoscenza organizzata, la sapienza è la vita organizzata».
Questo forse ci fa ritrovare il bandolo che potrebbe essere andato perduto. Nel suo saggio sulla filosofia della natura, Hegel
riporta che Kant su questo argomento rivive l’idea stessa di filosofia della natura, che non è niente altro che la comprensione
stessa della natura, oppure, il che è lo stesso, la conoscenza del
concetto di natura.