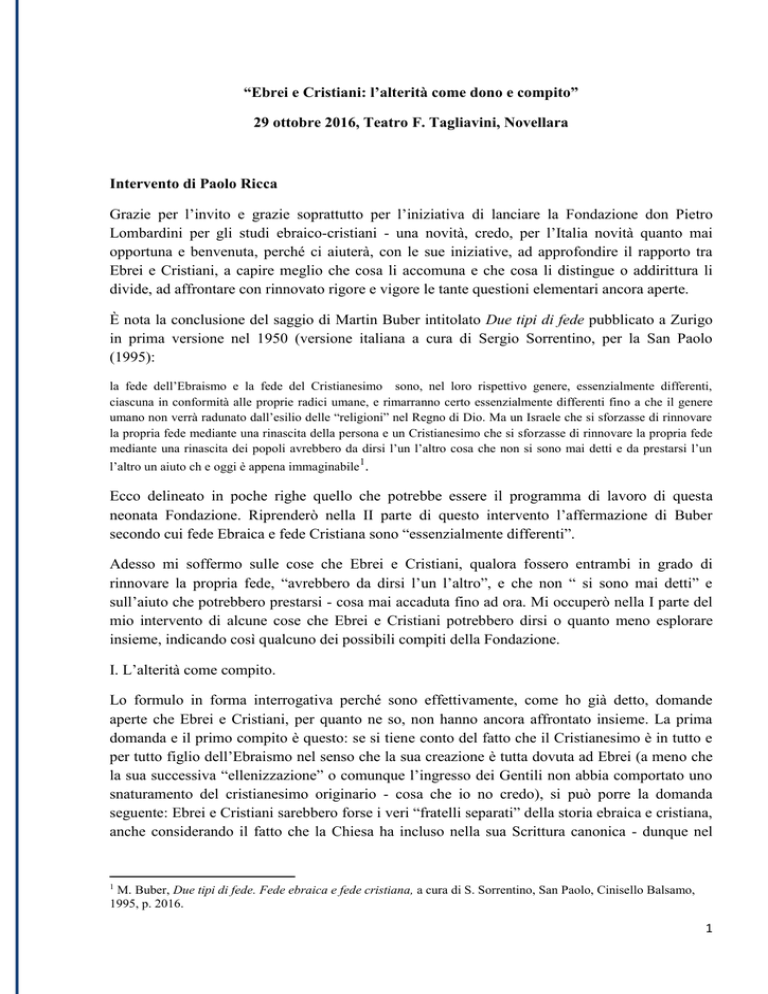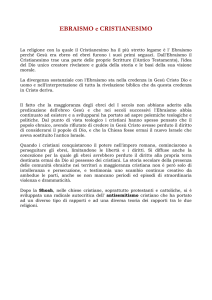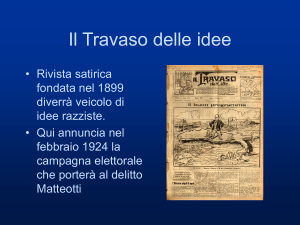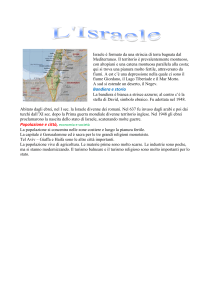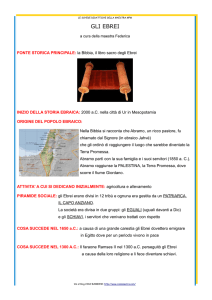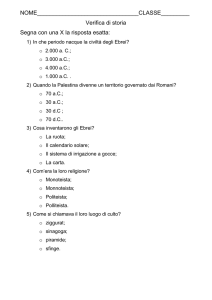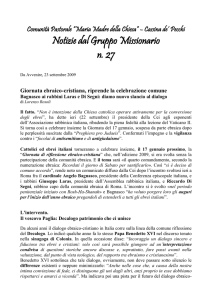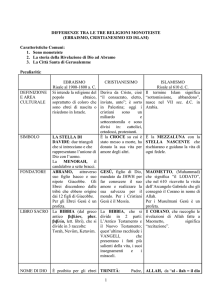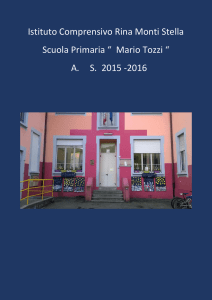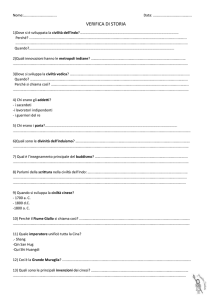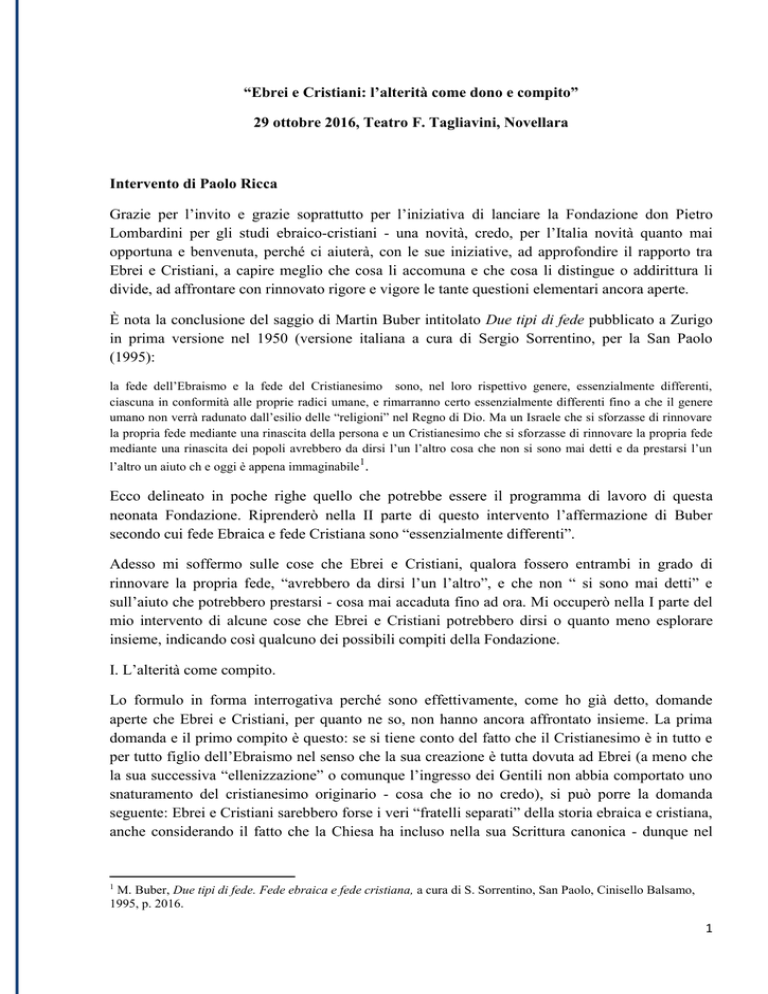
“Ebrei e Cristiani: l’alterità come dono e compito”
29 ottobre 2016, Teatro F. Tagliavini, Novellara
Intervento di Paolo Ricca
Grazie per l’invito e grazie soprattutto per l’iniziativa di lanciare la Fondazione don Pietro
Lombardini per gli studi ebraico-cristiani - una novità, credo, per l’Italia novità quanto mai
opportuna e benvenuta, perché ci aiuterà, con le sue iniziative, ad approfondire il rapporto tra
Ebrei e Cristiani, a capire meglio che cosa li accomuna e che cosa li distingue o addirittura li
divide, ad affrontare con rinnovato rigore e vigore le tante questioni elementari ancora aperte.
È nota la conclusione del saggio di Martin Buber intitolato Due tipi di fede pubblicato a Zurigo
in prima versione nel 1950 (versione italiana a cura di Sergio Sorrentino, per la San Paolo
(1995):
la fede dell’Ebraismo e la fede del Cristianesimo sono, nel loro rispettivo genere, essenzialmente differenti,
ciascuna in conformità alle proprie radici umane, e rimarranno certo essenzialmente differenti fino a che il genere
umano non verrà radunato dall’esilio delle “religioni” nel Regno di Dio. Ma un Israele che si sforzasse di rinnovare
la propria fede mediante una rinascita della persona e un Cristianesimo che si sforzasse di rinnovare la propria fede
mediante una rinascita dei popoli avrebbero da dirsi l’un l’altro cosa che non si sono mai detti e da prestarsi l’un
l’altro un aiuto ch e oggi è appena immaginabile1.
Ecco delineato in poche righe quello che potrebbe essere il programma di lavoro di questa
neonata Fondazione. Riprenderò nella II parte di questo intervento l’affermazione di Buber
secondo cui fede Ebraica e fede Cristiana sono “essenzialmente differenti”.
Adesso mi soffermo sulle cose che Ebrei e Cristiani, qualora fossero entrambi in grado di
rinnovare la propria fede, “avrebbero da dirsi l’un l’altro”, e che non “ si sono mai detti” e
sull’aiuto che potrebbero prestarsi - cosa mai accaduta fino ad ora. Mi occuperò nella I parte del
mio intervento di alcune cose che Ebrei e Cristiani potrebbero dirsi o quanto meno esplorare
insieme, indicando così qualcuno dei possibili compiti della Fondazione.
I. L’alterità come compito.
Lo formulo in forma interrogativa perché sono effettivamente, come ho già detto, domande
aperte che Ebrei e Cristiani, per quanto ne so, non hanno ancora affrontato insieme. La prima
domanda e il primo compito è questo: se si tiene conto del fatto che il Cristianesimo è in tutto e
per tutto figlio dell’Ebraismo nel senso che la sua creazione è tutta dovuta ad Ebrei (a meno che
la sua successiva “ellenizzazione” o comunque l’ingresso dei Gentili non abbia comportato uno
snaturamento del cristianesimo originario - cosa che io no credo), si può porre la domanda
seguente: Ebrei e Cristiani sarebbero forse i veri “fratelli separati” della storia ebraica e cristiana,
anche considerando il fatto che la Chiesa ha incluso nella sua Scrittura canonica - dunque nel
1
M. Buber, Due tipi di fede. Fede ebraica e fede cristiana, a cura di S. Sorrentino, San Paolo, Cinisello Balsamo,
1995, p. 2016.
1
canone della sua fede - tutto l’Antico Testamento?. Non è forse l’Antico Testamento quel grande
grembo comune dal quale sono nati il Cristianesimo e l’Ebraismo successivo al 70 d. C.?
II compito. Il fatto che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il Dio nel quale Gesù ha
creduto e che ha confessato come sue Padre vivendo con lui una comunione particolarmente
intima ed intensa, fino a che punto questo fatto si riflette o non si riflette nella fede in Dio dei
Cristiani? Fino a che punto la fede in Dio dei Cristiani corrisponde alla fede in Dio di Gesù?
III compito: che rapporto c’è tra il popolo d’Israele che tante volte nell’Antico Testamento è
chiamato “figlio di Dio”: così Mosè è incaricato di dire al Faraone “Così dice l’Eterno: Israele è
il mio figlio, il mio primogenito; e io ti dico: lascia andare il mio figlio affinché mi serva”
(Esodo 4, 22-23); e nel profeta Osea, Dio dice: “ Ho chiamato mio figlio fuori dall’Egitto” (11,
1). E in Geremia: “ Efraim [cioè Israele] è dunque per me un figlio così caro, un figlio prediletto,
per cui se parlo contro di lui è più vivo e continuo il ricordo che ho di lui, perciò le mie viscere si
commuovono per lui, e io certo ne avrò pietà, dice l’Eterno”(31, 20). E in Malachia, l’ultimo
libro dell’Antico Testamento, Dio dice: “ Io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo
serve”(3, 17). E nel Deuteronomio l’affermazione più esplicita: “Voi siete i figli dell’Eterno, il
vostro Dio” (14, 1). Ecco allora la domanda tra Israele figlio di Dio e Gesù Figlio di Dio,
secondo la voce celeste al momento del Battesimo: “Questo è il mio Figlio diletto; nel quale mi
sono compiaciuto” (Matteo 3, 11), e della trasfigurazione: “Questo è il mio Figlio diletto;
ascoltatelo” (Marco 9, 7). Ecco dunque: che rapporto c’è tra queste due filialità: Israele figlio di
Dio, e Gesù (l’israelita Gesù) anche lui figlio di Dio? Non può essere che la filialità di Gesù
sostituisca quella di Israele, dato che i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento
(Romani 11, 29); non solo, ma l’apostolo Paolo dice espressamente che gli ebrei del suo tempo,
quelli, cioè, che non hanno riconosciuto Gesù come messia: “per quanto concerne l’elezione,
sono amati per via dei loro padri (11, 28). Il che significa che per loro l’elezione è tuttora
operante: Israele è ancora il figlio “così caro che le viscere di Dio si commuovono per lui”, il
figlio prediletto e perciò l’eletto; ci sono dunque DUE figli prediletti ed eletti, Gesù ed Israele,
senza che l’uno sostituisca l’altro, pretendendone il posto? In questo caso potremmo pensare che
la filialità di Gesù riassume quella di Israele, con l’unica differenza che mentre Israele è stato
anche disubbidiente a Dio ( e tutte le pagine dell’Antico Testamento lo documentano), l’israelita
Gesù avrebbe fatto dell’ ubbidienza a Dio il contenuto esclusivo della sua vita, senza però che
questo pregiudichi la filialità di entrambi? Ripeto: in che rapporto stanno tra loro queste due
filialità?
IV compito. Qual è il senso della storia del popolo ebraico, assolutamente unica nel panorama
della storia dei popoli, sorprendente ed enigmatica come nessun’altra? Ha scritto Karl Barth: “ la
storia degli ebrei è un segno straordinariamente eloquente. È più facile passare accanto alla storia
della Bibbia e della Chiesa che accanto alla storia degli ebrei [senza fermarsi]. Ed è difficile
rinunciare a dare di questa storia una spiegazione teologica”2. Barth da questa “spiegazione
teologica” della storia del popolo ebraico che riassume in due affermazioni: la prima è che se il
popolo ebraico ha resistito a tutti i tentativi, reiterati attraverso i secoli, di sopprimerlo attraverso
la loro dispersione, ghettizzazione, persecuzione e a tutti i tentativi di assimilazione e di
2
K. Barth, Dogmatique, vol. 13, Labor et Fides, Ginevra, 1962, p. 202. Tutto il punto 3, pp. 202-216 è dedicato al
popolo ebraico. Il volume tedesco è del 1950.
2
meticciato tra popoli e razze – un popolo che tra l’altro non costituisce una razza, non ha
un’unica “lingua materna” così come non si può parlare di una cultura propriamente ebraica,
mentre gli Ebrei contribuiscono grandemente alla cultura dei popoli nei quali essi vivono, e
neppure si può parlare di una storia comune del popolo ebraico, che non esiste più dall’anno 70
della nostra era con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, dato che neppure la creazione
dello Stato di Israele è stata sufficiente ad unificare la storia degli Ebrei, dato che solo una
minoranza di Ebrei vive oggi nello Stato di Israele – dunque che cosa spiega la sopravvivenza di
questo piccolo popolo diverso? Dal punto di vista biblico, la spiegazione è una sola e cioè
questa: “la decisione di Dio di scegliere questo popolo e di legarsi a lui è una decisione eterna,
deinitiva”. La sopravvivenza di Israele non è dunque “un qualunque enigma storico o un
qualunque miracolo” nessun mistero che coincide col “mistero rivelato di Dio, il mistero della
sua fedeltà e della sua grazia, della costanza della sua volontà e della permanenza della sua
decisione"3. Non è dunque a motivo della loro razza, né alla loro lingua, né alla loro cultura, e
meno ancora alla loro religione, che gli Ebrei devono la loro esistenza e sopravvivenza, ma
unicamente alla fedeltà e alla grazia di Dio – gli Ebrei che dopo aver ricevuto le Tavole del Patto
hanno costruito il vitello d’oro, e che ciò nondimeno Dio chiama “la pupilla del mio occhio” e
(“chi tocca voi – dice il Signore – tocca la pupilla del suo occhio” Zaccaria 2, 9) – popolo ribelle
e dalla dura cervice, eppure amato come nessun altro, e perciò popolo di Dio per sempre4. Ed è
sicuramente a motivo di questo amore un po’ folle e comunque inesauribile che Dio, quando ha
deciso di diventare uomo, è diventato ebreo nella persona di Gesù di Nazareth, “ della stirpe di
Davide secondo la carne” (Romani 1, 4), “ebreo figlio di ebrei” come il suo grande apostolo
Paolo, quello che, pur non essendo dei Dodici, l’ha capito meglio di chiunque altro (Filippesi 3,
5). E questo allora spiega anche l’antisemitismo, questa “strana malattia” ricorrente, che appare,
scompare e di nuovo riappare “come una peste”5, che non ha nessuna ragione plausibile tranne
questa : la nostra insofferenza davanti all’ebreo, l’eletto di Dio, rivela la nostra insofferenza
davanti a Dio, non sopportiamo l’ebreo perché non sopportiamo Dio, sempre di nuovo vogliamo
escludere, ghettizzare e, al limite, cancellare l’ebreo perché vogliamo cancellare Dio, anche
proprio per il suo amore ostinato per l’uomo che la storia del popolo ebraico, pur con tutti i suoi
drammi, manifesta. Ecco, tutta questa tematica meriterebbe di essere ripresa, approfondita e
chiarita insieme: la domanda è: i cristiani e gli ebrei – ma soprattutto gli ebrei – si riconoscono in
questa lettura teologica della loro storia? E se non si riconoscono, qual è la loro lettura, quella
nella quale si riconoscono?
V compito. Il nodo principale dei rapporti tra ebrei e cristiani, almeno dal punto di vista
cristiano, è questo: Israele continua ad essere il popolo eletto, ma anche i cristiani sono chiamati
ripetutamente “eletti di Dio” (Romani 8, 33: “chi accuserà gli eletti di Dio”; I Pietro 2, 9: “voi
siete una generazione eletta”; II Giovanni 1 : “l’anziano alla signora eletta”; I Pietro 1, 1: “Pietro,
agli eletti che sono nella dispersione”) ; dunque, secondo la Scrittura, Ebrei e Cristiani sono
accomunati nella elezione di Dio. Ma allora: ci sono due popoli eletti, il popolo ebraico e quello
cristiano? Oppure Ebrei e Cristiani appartengono allo stesso popolo eletto, ma vivono da venti
secoli come se così non fosse, o perché non lo sanno, non l’hanno mai saputo, oppure l’hanno
3
Ivi, 208 e 209.
Ivi, p. 209.
5
Ivi, 211.
4
3
saputo, ma l’hanno dimenticato, oppure rimosso, oppure non l’hanno creduto? E collegata a
questi interrogativi c’è tutta la tematica di come gli Ebrei si considerano sia in se stessi, in sia in
rapporto ai Cristiani.
Si riconoscono nella classificazione del Vaticano II dell’Ebraismo come “religione non cristiana”
(Nostra Aetate è una “Dichiarazione conciliare nelle “relazioni della Chiesa con le religioni non
cristiane”) e in particolare con l’affermazione che “la Chiesa è il nuovo popolo di Dio” ,
implicando che gli Ebrei sono il vecchio popolo di Dio, anche se “gli Ebrei non devono essere
presentati come rigettati da Dio né come maledetti” (n. 4)? Anche queste domande meritano di
essere accolte in una nuova riflessione, possibilmente dialogica.
Come si vede, la neonata Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani avrà il suo
daffare, un grande lavoro da svolgere. Sin qui ho indicato alcuni dei possibili “compiti” della
Fondazione, come strumento del dialogo ebraico-cristiano, svolgendo così, sia pure solo molto
sommariamente, la seconda parte del tema che ci è stato proposto: “Ebrei e Cristiani, l’alterità
come dono e compito”. Ho parlato del compito, ora parlo del dono.
II L’alterità come dono.
Un dono davvero singolare, che si è rivelato altamente conflittuale, proprio come: due fratelli
gemelli Esaù e Giacobbe, nati dallo stesso grembo allattati dallo stesso seno, eppure diventati a
lungo nemici mortali. Un dono dunque non riconosciuto come tale fino ai nostri giorni, e ancora
oggi riconosciuto da pochi. Più che di “alterità” si deve parlare di sostanziale estraneità, oppure,
se si vuole, di “alterità” vissuta come “estraneità”. Ma è la nozione stessa di alterità che merita
qualche considerazione ulteriore. Che un ebreo sia “un altro” rispetto ad un cristiano, e
viceversa, è una verità incontestabile, per non dire che è una ovvietà. Anche Esaù era un “altro”
rispetto a Giacobbe, pur essendo suo fratello gemello. Ma parlare semplicemente di “alterità” è
un po’ poco, nel senso che non dice nulla di quello che questo “altro” può avere in comune con
colui rispetto al quale è un altro. Ritorniamo alla domanda iniziale: che cos’hanno in comune
Ebrei e Cristiani, che cosa li distingue, che cosa li divide. Martin Buber, nel testo citato
all’inizio, dice che la fede ebraica e la fede cristiana sono “essenzialmente differenti”, il che vuol
dire che sono differenti nella loro essenza. A me non pare che le cose stiano proprio così. Può
darsi naturalmente che un certo modo di vivere la fede ebraica e un certo modo di vivere la fede
cristiana siano tra loro “essenzialmente differenti”. Ma anni fa lessi un romanzo indimenticabile,
intitolato L’ultimo dei giusti, di André Schwarz Bart (Feltrinelli 1964) che riferisce l’antica
tradizione ebraica secondo la quale il mondo riposerebbe su 36 Giusti, in nulla distinti dai
comuni mortali; spesso non sanno di esserlo neppure loro. Ma se uno mancasse, la sofferenza
degli uomini avvelenerebbe persino l’anima dei neonati e l’umanità soffocherebbe in un grido.
Perché i lamed-waw sono il cuore moltiplicato del mondo, e in essi si versano tutti i nostri dolori
come in un ricettacolo… Un vecchissimo testo della Haggadàh racconta che quelli che più
ispirano pietà sono i lamed-waw ignoti a se stessi… nel VII secolo gli ebrei andalusi veneravano
una roccia a forma di lacrima, che essi credevano essere l’anima, impietrita dal dolore, di un
lamed-waw “ignoto”… Quando un Giusto ignoto sale al cielo, dice un racconto chassidico, è
così ghiacciato che Dio deve riscaldarselo tra le dita per mille anni prima che la sua anima possa
dischiudersi al Paradiso. L’autore racconta poi, in brevi ritratti, la vita di alcuni di questi 36
4
Giusti, prima di narrare la storia dell’ultimo, che finisce nel forno crematorio di Auschwitz:
bene, questi ritratti sembrano altrettante fotocopie (se si può dire così) di aspetti di Gesù: manca
solo il nome, ma lui c’è. Qui c’è una vera e propria coincidenza tra fede ebraica e fede cristiana:
si direbbe che sono fedi sorelle, certo diverse, ma uscite dallo stesso grembo. Quindi: alterità, si,
ma non alterità completa, radicale, come se si appartenesse a due mondi diversi, ma è un’alterità
relativa, di chi sa di avere una matrice comune.
Ma in che senso si può e si deve parlare dell’alterità come dono? In tre sensi che non ho il tempo
di illustrare, ma che desidero menzionare. 1. Il primo è generale e riguarda la struttura dialogica
dell’Essere in tutti i suoi aspetti e il dialogo è possibile solo con un tu, con l’altro, con una
alterità. Ecco perché l’essere umano è stato creato maschio e femmina: non due umanità, ma due
poli di un’unica umanità. Nella relazione si realizza l’essere umano, e non solo quello umano.
L’Essere è relazione, come lo è Dio nella versione biblica di Dio, dato che uno dei suoi nomi –
Elohim – è plurale; il Cristianesimo precisa questa pluralità in senso trinitario.
2. Scrive M. Buber nel suo celebre saggio intitolato Io e Tu del 1923: “le linee delle relazioni, nei
loro prolungamenti, si intersecano nel Tu eterno. Ogni singolo tu è una breccia aperta sul Tu
eterno”6. Il “Tu eterno” è Dio. Non tutti e non sempre sanno risalire dal tu caduco e perituro al
Tu eterno ed immortale. Ma noi riteniamo che l’esistenza del tu caduco e perituro sia possibile
grazie all’esistenza del Tu eterno, di cui quello caduco è un riflesso e un (spesso inconsapevole)
messaggero.
3. in terzo luogo l’altro è un dono perché da un lato rivela a me stesso la mia parzialità, il fatto
che sono solo me stesso e non anche l’altro, ho quindi bisogno dell’altro per accrescere la mia
conoscenza ed esperienza dell’umano. D’altro lato, l’altro mi interpella, mi può anche mettere in
questione oppure mi può aiutare ad essere per me una benedizione, una presenza benefica che
completa la mia umanità.
Concludo dicendo che per capire a fondo in che senso Ebrei e Cristiani, con la loro indubbia
alterità, sono dono e possono essere un aiuto (come dice Buber) gli uni per gli altri, è necessario
chiarire che tipo di alterità esiste tra loro.
6
M. Buber, Il principio dialogico e altri saggi, a cura di Andrea Poma, San Paolo, Ghisello Balsamo 1993, p. 111.
5