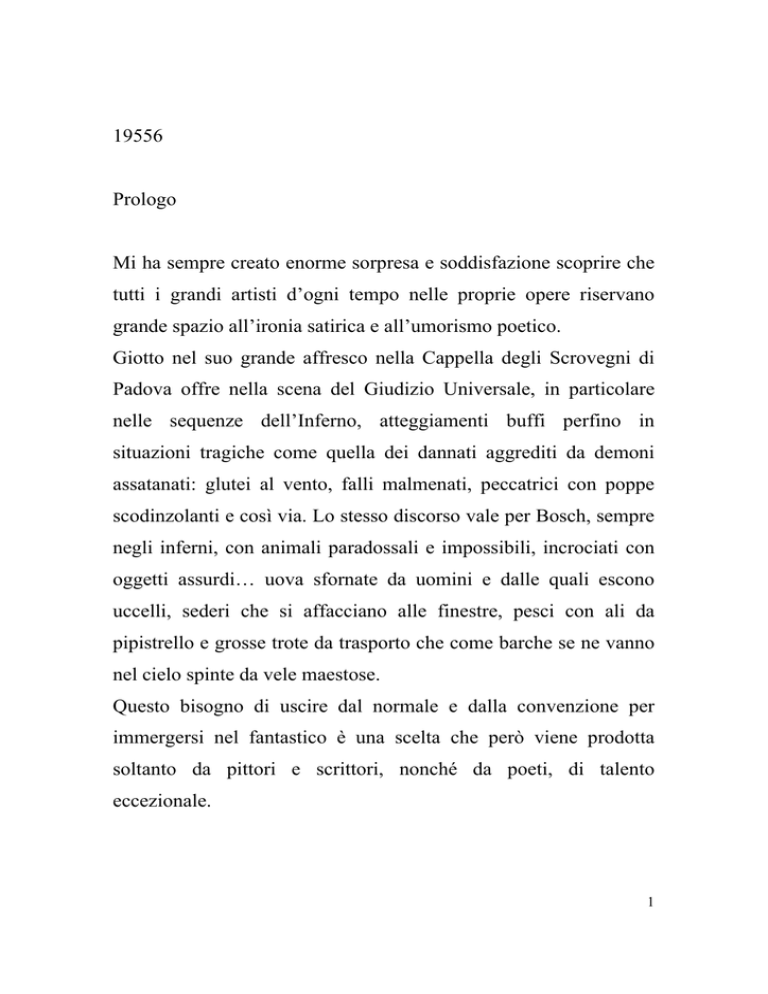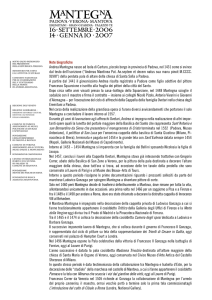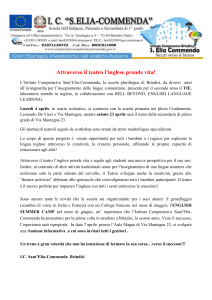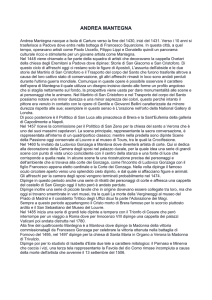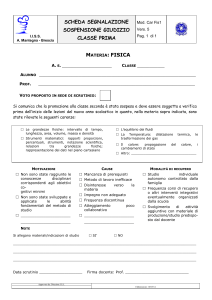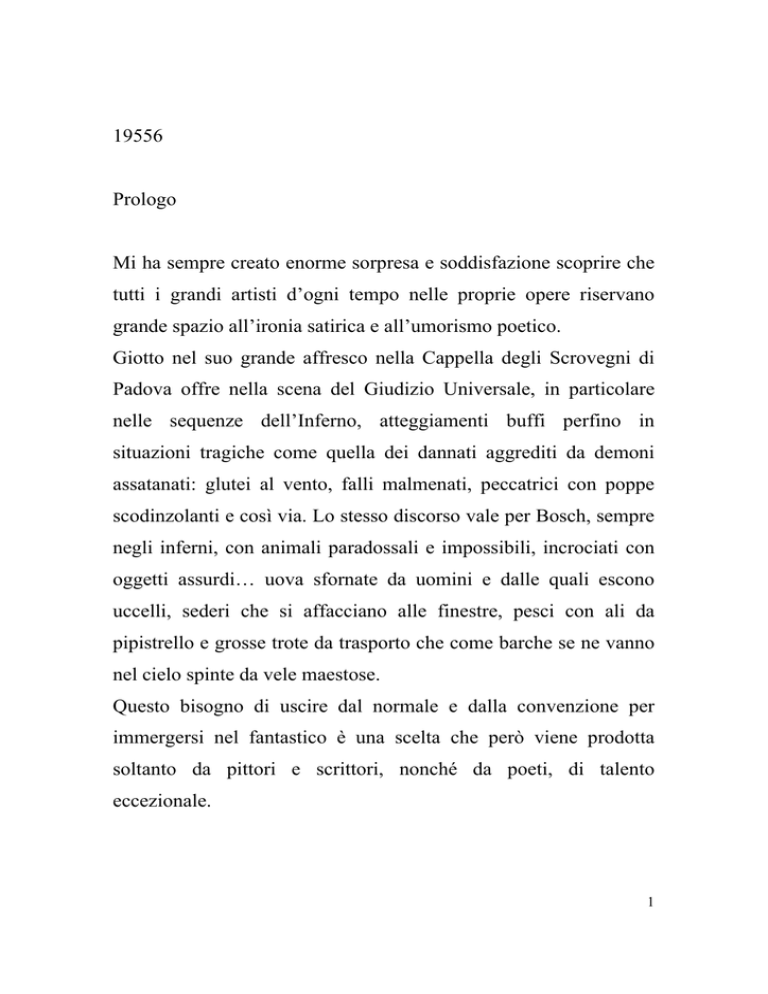
19556
Prologo
Mi ha sempre creato enorme sorpresa e soddisfazione scoprire che
tutti i grandi artisti d’ogni tempo nelle proprie opere riservano
grande spazio all’ironia satirica e all’umorismo poetico.
Giotto nel suo grande affresco nella Cappella degli Scrovegni di
Padova offre nella scena del Giudizio Universale, in particolare
nelle sequenze dell’Inferno, atteggiamenti buffi perfino in
situazioni tragiche come quella dei dannati aggrediti da demoni
assatanati: glutei al vento, falli malmenati, peccatrici con poppe
scodinzolanti e così via. Lo stesso discorso vale per Bosch, sempre
negli inferni, con animali paradossali e impossibili, incrociati con
oggetti assurdi… uova sfornate da uomini e dalle quali escono
uccelli, sederi che si affacciano alle finestre, pesci con ali da
pipistrello e grosse trote da trasporto che come barche se ne vanno
nel cielo spinte da vele maestose.
Questo bisogno di uscire dal normale e dalla convenzione per
immergersi nel fantastico è una scelta che però viene prodotta
soltanto da pittori e scrittori, nonché da poeti, di talento
eccezionale.
1
Dante è un vero e proprio campione dell’impossibile, del
sovraumano. Chi ha mai immaginato e messo in scena grappoli di
amanti ignudi che abbracciati appassionatamente se ne vanno per
l’aria sospinti da un vento amoroso, come stormi di volatili travolti
dalla passione, se non il sommo poeta?
Per non parlare della traversata del fiume degli Inferi, con Caronte
sulla sua barca, stracolma di dannati: “Batte col remo chiunque
s’adagia…”
Ma lo stesso discorso lo possiamo riservare per Leonardo che in
diecine di suoi disegni e pitture racconta con feroce sarcasmo la
bieca violenza degli uomini, come nell’Adorazione dei Magi agli
Uffizi di Firenze. In primo piano vediamo la Madonna con il suo
bambino appena nato, con appresso i tre re magi che si
inginocchiano. Sul fondo, in contrapposizione all’inchinarsi dei tre
re, vediamo guerrieri a cavallo con lance e spade caricare uomini e
donne, cadaveri gettati dalla scalinata e gente che fugge atterrita, il
tutto mentre è appena nato il Figlio di Dio, che come sappiamo è
venuto apposta per portare la pace in terra… Cominciamo bene!
In un altro bozzetto scorgiamo un angelo che soffiando dentro una
lunga
tromba
spernacchia
nell’orecchio
di
un
cherubino
stordendolo.
In un codice, sempre Leonardo mostra una bellissima donna
ignuda che abbraccia e bacia il suo amante, ma frammezzo i suoi
2
glutei spunta un pungiglione ritorto pronto a scattare come la coda
di uno scorpione. A sua volta l’innamorato completamente nudo ha
già sollevato il braccio per trafiggere con un pugnale l’innamorata.
Ma Leonardo ha inventato anche il disegno di satira politica. Qui
vediamo infatti i personaggi del potere del suo tempo seduti a una
tavola imbandita presentati con feroce sarcasmo: la Francia che
adula la Spagna invitandola a guardarsi allo specchio. La
doppiezza della Spagna viene rappresentata da una donna con due
teste. I vari duchi italiani rappresentati come piccoli cani famelici
al servizio di ogni potere si danno un gran daffare per azzannare gli
avanzi; un’aquila che allude all’altro regno, l’Austria, che si getta a
capofitto sulle prede; e il demonio che se la ride beato. Badate
bene, il demonio è la caricatura del Papa di allora. Per favore,
niente censura, è di Leonardo.
Potremmo continuare per ore a elencare dipinti e disegni
grotteschi,
da
Michelangelo
a
Caravaggio.
Lui
invece
Michelangelo è stato censurato, non qua che offre glutei al vento,
ma più sopra dove i censori hanno appunto a Michelangelo stesso
di infilare ai suoi personaggi delle braghe perché non si godessero
queste natiche troppo evidenti.
Qui ancora c’è la denuncia dell’uso troppo facile della croce a
scopi non propriamente religiosi. Il risultato è che la croce frana
addosso a coloro che cercavano di giovarsene, schiacciandoli in un
3
tonfo generale. Per non parlare di Dürer e Brueghel, dove un
pescatore per veder il mondo in modo corretto lo osserva affacciato
fra le proprie natiche. (ruotea il foglio) Eh già, si vede meglio.
Ma forse la palma del gioco satirico dovremmo consegnarla a
Mantegna, che è capace in ogni situazione, anche la più
drammatica, di catapultare dentro le sue opere donne, uomini,
cavalli, bimbi che rovesciano la logica dentro un mondo di follia
perché lo sghignazzo dentro il dramma è un contrappunto
essenziale e determinante in ogni opera d’autentico valore come
qui ci insegna anche Michelangelo.
Ma a proposito di Mantegna, attraverso la sua ironia, cercheremo
di presentarvi un personaggio davvero sconosciuto, carico di
sarcasmo, perché ognuno possa finalmente scoprire che, come
diceva Voltaire, la punta più alta dell’intelligenza umana sta
proprio nel gioco umoristico della vita.
Bene, andiamo a incominciare…
Qual è l’immagine fisica che abbiamo di Andrea Mantegna? Di lui
conosciamo più di un autoritratto, a cominciare da questo, che lo
vede ancora giovane nella Presentazione al tempio, proprio alle
spalle del sacerdote. Ma il primo autoritratto che di lui ci viene in
mente risale a più di quindici anni prima. Il suo viso presente nella
cappella Ovetari a Padova è una maschera grottesca. Ancora
4
grottesco e tragico insieme è l’altro autoritratto, sempre nella
cappella Ovetari nel giudizio di San Giacomo, dove lo troviamo
corrucciato, triste e invecchiato, per una ragione che vedremo
appresso.
Un altro autoritratto lo troviamo nella Camera degli Sposi a
Mantova dove si presenta in forma di maschera silvestre in mezzo
a pennacchi di rami e fiori.
Ma il ritratto più conosciuto è il busto in bronzo che appare sulla
sua tomba: ci mostra un Mantegna possente, aggressivo, un
personaggio con il quale non è certo consigliabile aprire una
disputa.
Infatti di Andrea Mantegna si dice tout-court che fosse irascibile,
attaccabrighe, prepotente… insomma un Caravaggio ante litteram.
Aggressivo e duro anche nel dipingere. Di lui si diceva “Egli è uso
scolpir pittando”. Per alcune opere di un certo periodo questo
scolpire dipingendo fu un elemento palese del suo linguaggio,
quasi una ricerca di monumentalità delle figure e del paesaggio.
Non per niente all’inizio della sua carriera Andrea si scelse come
maestro uno scultore, esattamente Donatello toscano, che in quel
tempo si trovava a Padova per realizzare il monumento equestre a
Gattamelata ed altre sculture.
5
Questo era il tempo in cui i maestro toscani arrivavano
numerosissimi nel Veneto, incontrandosi con altri grandi artisti
veneziani, ai quali Mantegna guardava con attenzione.
Qui vediamo Piero della Francesca, Filippo Lippi, Leon Battista
Alberti, Andrea del Castagno, e qui Tiziano con la sua Venere e
qui Giorgione con la sua Tempesta.
Ma come era diventato pittore Mantegna?
Cominciamo col dire che era nato nel 1430 0 31 in un paese vicino
a Padova che si chiamava l’Isola, Isola di Carturo, in riva, anzi
completamente avvolta dal Brenta che si allargava intorno a questo
piccolo paese, abbracciandolo.
C’è un’antica ballata che si canta ancora oggi nelle lagune di
peschiera che così si esprime: (cantando) “Tèra e acqua, acqua e
ziélo, drénta e fòra su ‘ste lagune. Spigne la pèrtega pe’ navigare e
no’ cascar de soto de soto al batèl. Voga ligér come fuèsse in del
cielo, sbusa le nivole pe’ navigare”.
Questo è il fondale che ritorna spesso nella memoria del pittore di
Isola di Carturo.
Uno può pensare che con tutta questa acqua intorno il padre di
Andrea fosse come minimo un pescatore… No, era falegname!
Egli per primo si rese conto delle straordinarie doti pittoriche del
piccolo Andrea e venne a sapere che a Padova esisteva una scuola
6
per apprendisti di talento, diretta da un maestro di nome Francesco
Squarcione. Così accompagnò il ragazzino a Padova presentandolo
al maestro. Gli allievi potevano entrare in questa scuola, ben
s’intende, pagando una retta. Se erano poveri, come nel caso di
Andrea, dovevano guadagnarsi il diritto di partecipare alle lezioni
con altri servizi: tener pulita la bottega, preparare colori, tavole ed
eseguire copie di disegni e di sculture in gran numero. Lo
Squarcione si vantava di aver allevato nella sua scuola d’arte ben
137 piccoli pittori di talento, ma nell’ambiente era ritenuto un
mediocre esecutore. A testimonianza di ciò, val la pena di citare il
commento di un suo allievo che diceva: “Ei se sforsa a disegnar
fughe in prospettiva, ma non ce ha vantaggio per lo che non l’è
capace”.
Come in ogni bottega del Quattrocento, anche in quella dello
Squarcione, oltre ad apprendere le numerose tecniche del dipingere
(pittura a tempera, disegno, incisione, pittura a olio, affresco), si
imparava l’anatomia, lo studio del nudo, l’architettura, l’ornato, la
scultura. La bottega di Padova era una specie di museo dove erano
a disposizione degli allievi statue antiche, greche e romane,
bassorilievi, un gran numero di disegni originali e copie di artisti
noti.
Per di più i giovani apprendisti studiavano la prospettiva e la
meccanica.
7
Nella scuola dello Squarcione, compagni di Mantegna erano
Cosmè Tura, diventato il maggiore fra i pittori di Ferrara, poi
Marco Zoppo, e forse per breve tempo persino il Foppa.
Dobbiamo però segnalare che il “maestro” sfruttava in modo
indegno i suoi giovani allievi. Li aveva in gran parte accolti come
figli, ma al solo scopo di trarre comodo vantaggio. Li costringeva a
realizzare copie di sculture e perfino tagliare e cucire abiti
sontuosi… tutto a suo profitto! tant’è che Andrea, giunto all’età di
diciassette anni, denunciò questo suo padre putativo, lo Squarcione
(un nome che è tutto un programma!) per sfruttamento. Il tribunale
di Venezia, sotto la cui giurisdizione Padova era stata da poco
accolta, liberò il ragazzo condannando questa specie di
mangiafuoco a un risarcimento di duecento ducati. Da qui si evince
che nella Repubblica di Venezia, già nel Quattrocento, la giustizia
funzionava rapida e immediata. Niente a che vedere con
l’inefficienza cronica dei tribunali dei nostri giorni.
Nello stesso anno, 1448, il giovane Mantegna poteva finalmente
realizzare un’opera tutta sua e firmarla. Aveva diciassette anni.
E a dimostrazione di quanto il suo valore fosse considerato, nello
stesso anno venne designato come perito per la valutazione di
un’opera di Pietro da Milano. In questa occasione si ritrovò come
parte avversa nel giudizio proprio lo Squarcione. La disputa fu
vinta dal giovane Mantegna, con grande soddisfazione.
8
Ed eccoci arrivati alla sua prima grande commissione: l’affresco
nella cappella Ovetari a Padova. L’opera verrà eseguita con l’aiuto
di Nicolò Pizzolo, un pittore più grande di lui di dieci anni, allievo
di Donatello.
L’affresco venne eseguito in breve tempo ed ebbe grande successo.
Purtroppo è stato fortemente danneggiato da un bombardamento
durante la seconda guerra mondiale. In conseguenza di
quell’attacco aereo, oggi dell’intero affresco rimane leggibile meno
della metà. Per fortuna ci sono pervenute alcune antiche copie di
buona fattura e soprattutto fotografie in bianco e nero, scattate
qualche mese prima del disastro, che ci testimoniano come dovesse
apparire l’affresco integro, che oggi è in corso di restauro metodi
d’avanguardia. Osservando quelle immagini siamo presi dallo
stupore. È incredibile che un ragazzo di quell’età, seppure assistito
da un altro pittore di buona esperienza, fosse già in grado di creare
un capolavoro di simile livello. I personaggi sono visti di scorcio,
dal basso verso l’alto, il che produce un effetto drammatico
straordinario, e alcune volte dall’alto verso il basso. Mai sullo
stesso piano di chi guarda.
La prospettiva segue i dettami scientifici di Piero della Francesca e
di Leon Battista Alberti, divenuto amico fraterno del giovane
9
padovano. Qui vediamo appunto il ritratto dell’Alberti eseguito dal
Mantegna che si trova a Mantova nella camera picta.
Di lì a qualche tempo, esattamente il 23 maggio 1449, odio le date
ma qui bisogna proprio dirle…, il giovane maestro risulta chiamato
a eseguire un lavoro a Ferrara, dove è da immaginare incontrerà
l’amico e compagno di bottega Cosmè Tura con il quale da
ragazzino ha diviso la mortificazione dello sfruttamento imposto
loro dallo Squarcione. Andrea, con la scuola dei Ferraresi,
continuerà per gran parte della sua vita a mantenere rapporto,
anche di lavoro. È il caso della collaborazione con Lorenzo Costa,
Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, cioè gli autori delle
straordinarie pitture nel Palazzo Schifanoia a Ferrara.
Per inciso il significato di Schifanoia, non è provar schifo della
noia, ma schivare la noia alla ricerca di una vita giocosa e carica di
sollazzo non del solo corpo, ma soprattutto del pensiero e dello
spirito. Qui naturalmente stiamo evitando la censura.
Nel settembre dello stesso 1449, sempre all’età di diciotto anni, il
suo compagno di lavoro Pizzolo chiama Andrea in giudizio
chiedendo di sciogliere società. Il Pizzolo non sopporta più la
tendenza al protagonismo di Andrea in particolare quella sua già
evidente volontà di uscire da ogni schema e disciplina, sia per
10
quanto riguarda la composizione scenica sia per la concezione
cromatica dell’opera.
L’anno dopo muore, ahimé ammazzato, Giovanni d’Alemagna, un
giovane pittore amico di Andrea al quale era stata era stata affidata
la realizzazione dell’altra parte degli affreschi sempre nella
cappella Ovetari. I committenti si rivolgono ad Andrea Mantegna
offrendogli la possibilità di completare il ciclo degli affreschi.
Mantegna accetta, però con protervia impone di redigere un nuovo
contratto a lui più vantaggioso.
Quindi si presenta con un nuovo progetto e soprattutto con altri
cartoni da lui disegnati. I responsabili della cappella gli fanno
notare:
“Scusami ma il progetto dell’affresco è già stato preparato da
Giovanni d’Alemagna e così i cartoni.”
“La decisione riguardo l’affresco – risponde Mantegna – da questo
momento tocca a me, sono io che dipingo. Se lo volete come da
progetto iniziale richiamate il morto”. Grazie a questa secca
risposta abbiamo immediatamente il quadro della personalità
piuttosto decisa e allo stesso tempo spietata di Andrea Mantegna
ragazzo. A testimoniare questa sua durezza di carattere ricordiamo
il commento di un suo contemporaneo, che così dichiarava: “Come
homo che fusse incarcerato o engiustamente tegnuto in cattività,
11
esto giovine padovan se vene infastidìo svalza come catapulta che
lanzi p[i]etre”.
Ma come dicono gli uomini di scienza che studiano il formarsi del
carattere dei fanciulli, tutto dipende da dove essi nascono, dove
vivono e crescono nella prima infanzia. Ora, che cosa ci si poteva
aspettare da un ragazzino costretto a sopravvivere in quella
condizione di schiavitù, sfruttato per anni e costretto a subire
castighi e vessazioni? Un fanciullo che da sé solo riesce a
riguadagnare la propria libertà è chiaro che difenderà sempre i
propri diritti con una grinta giusta e sacrosanta.
È straordinario come l’infanzia della gran parte degli artisti del
Rinascimento sembri spuntare da uno stesso ramo e ognuna si
sovrapponga all’altra quasi in una impossibile copia di stampa.
Piero della Francesca non ebbe padre che lo riconoscesse, tanto è
vero che portava il nome della madre, Francesca appunto. (forse a
soggetto) Lo stesso capitò a Beolco, detto Ruzzante, il quale era
figlio di un dottore diventato il rettore massimo dell’Università di
Padova, che aveva fatto l’amore con una servetta di casa e poi si
era guardato bene dal riconoscerlo figlio legittimo, ma solo
naturale. La vita di Leonardo è una fotocopia di quella di Piero e
simile è l’infanzia di Raffaello, rimasto orfano di padre e di madre
a pochi anni di età, privo di una famiglia, allevato prima da uno zio
e poi dal suo maestro che divenne un autentico padre, il Perugino.
12
Così è per Mantegna, carcerato in una scuola nella giovinezza con
una terribile, costante nostalgia di una tenerezza di cui non ha mai
goduto, la tenerezza della madre che egli riversa immancabilmente
in ogni Madonna con bimbo che dipinge. Ed è proprio il caso di
questa Madonna dove si rappresenta l’insostituibile tenerezza della
madre.
Come recita un detto del Rinascimento, se volete allevare dei geni
sceglieteli fra gli orfani e gli abbandonati.
Abbiamo già accennato come in quel tempo Padova fosse stata
incorporata nel dominio della Serenissima. Venezia era il centro
più importante, dell’economia e delle arti, di tutto il nord Italia. Era
logico quindi che ogni giovane del mestiere vi facesse visita ad
ogni occasione. A Venezia Andrea ventiduenne incontra una
prestigiosa famiglia di maestri, i Bellini: il padre Jacopo e i due
figli, Giovanni, detto il Giambellino, e Gentile. Qui nella
Presentazione al Tempio dipinto da Mantegna vediamo il padre
ritratto nelle vesti di San Giuseppe e l’autoritratto giovanissimo di
Andrea,
laggiù
(indica)
e
qui
vediamo
l’ingrandimento.
All’opposto nella stessa posizione c’è una giovane, la figlia di
Bellini, Nicolosia, una fanciulla di straordinaria bellezza.
Mantegna se ne innamora e la chiede in sposa.
13
Tutta la bottega dei Bellini è affascinata dal giovane padovano e
soprattutto dalla sua personalità e dal suo nuovo linguaggio
pittorico, tant’è ne vengono fortemente influenzati.
Nello stesso anno del matrimonio con Nicolosia muore il Pizzolo,
suo ex socio nella cappella Ovetari, e ancora a Mantegna vengono
affidate le parti che avrebbe dovuto dipingere il deceduto. Sembra
la sequenza di una tragedia greca di Euripide dove tutti gli
antagonisti dell’eroe vengono tolti di mezzo dalla solita terribile
Atena, che parteggia per il protagonista.
Ritornando alla cappella degli Ovetari, questo che vi mostro è lo
stato in cui si trovavano gli affreschi dopo il bombardamento. Ora,
in attesa del nuovo restauro mi sono permesso di iniziare un
restauro indicativo.
Ecco la scena in cui il despota, lassù alla finestra, ordina agli
arcieri di trafiggere san Cristoforo, che qui non si vede perché è
stato distrutto dai bombardamenti. Eccolo qua (mostra immagine)
Il gigante Cristoforo è chiamato così, Cristoforo, proprio perché
sulle sue spalle ha trasportato il piccolo Gesù al dilà del fiume.
Infatti Cristofòros in greco significa portatore di Cristo.
San Cristoforo è legato alla colonna nel momento in cui stanno
scoccando le frecce. Ecco però che si realizza un prodigio: le
14
frecce si rifiutano di colpire san Cristoforo. Giunte in prossimità
del suo corpo eseguono un repentino dietro front e schizzano a
rovescio in tutte le direzioni. Uno di quei dardi impazziti va a
conficcarsi proprio nell’occhio del tiranno affacciato alla finestra.
Nell’affresco è raccontato esattamente il momento in cui gli arcieri
si guardano intorno stupiti, storditi per tanto capovolgimento fuor
d’ogni logica.
Qualcuno di loro volge lo sguardo in alto verso il palazzo e resta
sconvolto per la grottesca disgrazia capitata al loro padrone.
C’è una donna che s’affaccia attonita alla finestra, c’è un
personaggio che urla inorridito guardando in alto e se pur di
scorcio riconosciamo essere questo un ritratto dello Squarcione.
Dei ragazzi si sporgono stupiti dal balcone. Alla fine san
Cristoforo viene ucciso e trascinato nella piazza tirato per i piedi.
Ciò nonostante gran parte del pubblico se ne sta lontana dal
gigante ucciso… non si sa mai! La gamba e il piede del gigante
vengono sollevati ed esibiliti come un trofeo. Un guerriero, forse il
capo dell’operazione militare, che indossa un’armatura di ferro,
dialoga con il proprio figlioletto che evidentemente gli chiede “Chi
è quello?!” E il padre gli risponde: “E’ un gigante, cattivo
naturalemnte. E come vedi noi, i cattivi, anche se son giganti, li
ammazziamo sempre”.
15
Concludiamo con la scena in cui viene condannato a morte San
Giacomo. Abbiamo già visto l’immagine di Mantegna affranto
nell’angolo. Poi vediamo un bambino che in basso vicino al
giudice che si è truccato da guerriero, ha raccolto uno scudo e s’è
calzato un elmo in capo. Lassù – e non potevano mancare ci sono
bambini – che si lanciano dai cornicioni e si appendono ai festoni
di frutta come piccoli Tarzan.
Nella scena successiva si racconta del santo portato al martirio.
Siamo in un campo alle porte della città. C’è il boia che sta
menando fendenti terribili sul collo del santo.
In un testo della ricercatrice Erika Tietze-Conrat, abbiamo scoperto
che questo carnefice ha un volto ben riconoscibile: il suo viso è il
ritratto di Marsilio de’ Pazzi, forse considerato allora dalla
tradizione popolare un emerito criminale. Ma tutto il dipinto è
pretestualmente inteso a colpire personaggi del potere ben
conosciuti e invisi alla popolazione. Infatti il cavaliere che sta
entrando in campo da destra altri non sarebbe che messer
Bonramino e così di seguito gli altri partecipanti alla scena hanno
tutti un nome – abbiamo visto perfino Squarcione – I malnati ci
sono proprio tutti…
Ma si insiste dicendo “Ma no… figurati se il Mantegna…… E’ lui
stesso con la sua immagine nell’affresco che ce lo dice: Ma figurati
se io metto la mia faccia in mezzo ai criminali. È uno scherzo!”
16
Alt! Ma costoro non dicono che lo sguardo, l’atteggiamento del
Mantegna è del tutto particolare, disperato, si sente colpevole a sua
volta dell’omicidio che si sta per consumare.
Eh dico: in una società dove, davanti a ogni infamia, tutti
scantonano biascicando “Io non c’entro, non c’ero e se c’ero
dormivo”, questa presa di responsabilità di Mantegna ci fa davvero
ragionare.
Avevamo accennato poco fa alla tenerezza della madre… è il caso
di riprendere il discorso osservando questo dipinto che sta a
Bergamo. Qui per la prima volta il Bimbo non è rappresentato nel
suo aspetto di divino fanciullo simile a un putto greco, sveglio e
benedicente. È un neonato, dall’espressione quasi ubriaca di latte e
di sonno, la bocca addirittura spalancata in un lieve, leggero
russare soddisfatto, come stesse ancora nel ventre della madre.
È rappresentato mentre si addormenta proiettando anche un ruttino.
Egli dorme con gli occhi aperti, le pupille che si nascondono a
metà della palpebra. Lo stesso atteggiamento è anche in quest’altra
Madonna con Bambino dormiente.
È chiaro che quello stato d’animo non nasce in Mantegna per caso:
sono immagini che ha osservato, vissuto giorno dopo giorno nel
comportamento dei propri numerosi figlie anche dei propri nipoti.
17
Esistono anche disegni preparatori di Maternità. Ve ne proponiamo
uno di straordinaria suggestione. In evidenza è la sola testa del
Bambino disegnata con una attenzione e precisione di segno degna
di Leonardo. Il Bambino anche in questo caso dorme ad occhi
aperti e bocca semichiusa. In un secondo tempo ci si rende conto
che dietro il viso del piccolo Gesù spunta appena indicata
l’immagine della Madonna. Di lei si leggono solo i segni delle
pupille, delle narici e un lieve filo che indica le labbra. Il disegno
non dà la sensazione d’esser stato abbandonato durante
l’esecuzione. L’averlo interrotto a quel punto – puoi giurarci – è
stata una decisione cosciente e definitiva di Mantegna. Aggiungere
altri segni, ombre o colore non avrebbe mai sortito quella
irripetibile magia.
L’orazione nell’orto
Nel 1455, a ventiquattro anni, Mantegna dipinge l’Orazione
nell’orto.
In primo piano tre apostoli dormono sdraiati su una roccia. Un
albero secco, dove solo un ramo butta un pugno di foglie, sale
torcendosi dalla terra e produce vieppiù un senso di angoscia che
già incombe su tutto il dipinto. Sulla cima di un ramo un avvoltoio
sta aggrappato puntando lo sguardo verso Gesù. I tre apostoli
18
stanno sdraiati come affranti in un sonno da incubo. Sembrano
plasmati come la roccia che fa loro da giaciglio. Poco più in alto,
inginocchiato su una larga pietra, Gesù prega. La sua tristezza è
insopportabile, disperata. La stessa che ci comunica il getto delle
rupi che s’innalzano al cielo, contrappuntate dalle torri e dalle
mura di una città da incubo. Ed è Gerusalemme! Sul fondo,
lontano, una truppa di soldati e sacerdoti sta salendo verso il teatro
della cattura. Quegli uomini sono condotti da Giuda. In
opposizione nell’angolo in alto appaiono degli angeli, mandati dal
padre in soccorso di Gesù. Ma l’avvoltoio sul suo ramo se ne sta
sicuro di vincere la scommessa.
Tutto è silenzio. L’unico suono che possiamo immaginarci sono le
parole di Cristo rivolte a suo padre. L’uomo Gesù ha paura.
Nella Pala di San Zeno a Verona Mantegna ci offre una
dimostrazione da autentico maestro della capacità di organizzare lo
spazio.
Vogliamo sottolineare subito che qui l’impianto geometrico è il
maggior motore di questa drammatizzazione, specie se ci
soffermiamo sulla scena della Crocifissione.
La croce dove è issato Gesù sta esattamente nel centro del dipinto
dividendolo in due parti uguali: sul lato sinistro sotto la croce del
primo ladrone sta il gruppo delle donne che sorreggono Maria.
Questo ci fa venire in mente un pezzo recitato da Franca tratto da
19
una passione lombarda in cui San Giovanni urla verso le Marie
perché allontanino la Madonna a quel luogo e soprattutto che la
reggano evitando che crolli al suolo così da produrre maggior
dolore a Cristo. Sull’altro lato quattro soldati si giocano a dadi la
veste rossa di Gesù.
Un pazzo sta convincendo il soldato perché gli permetta di giocare
a sua volta. Lui è pronto a perdere i quattrini che tiene in una
mano. Sono le monete che ha ritrovato sotto l’albero di Giuda
impiccato. Il soldato acconsente. Il pazzo va sotto la croce e parla a
Cristo, lo prega di farlo vincere, non è mai successo di vincere una
partita a dadi (…)
DARIO RECITA IL MATTO SOTTO LA CROCE
E’ matto non ascoltatelo!”
Ma il fatto drammatico dell’impianto è determinato un’altra volta
dalla geometria.
Eccovela: sono cerchi e diagonali che compongono il movimento
dinamico dell’opera. Studiatevelo!
Qui Mantegna anticipa di una buona decina d’anni l’invenzione di
Antonello da Messina. Entrambi allungano enormemente i pali
delle tre croci issando Cristo e i due suoi compagni di patibolo in
alto così che le tre figure inchiodate si trovino a galleggiare sole
nel cielo, solcato da bave di nuvole.
20
Mantegna e i Gonzaga
Nel 1456, all’età di venticinque anni, Mantegna viene invitato
come pittore di corte dal marchese Ludovico III di Mantova.
Accetta ma non vi si reca subito. Prende tempo, soprattutto per
trattare con maggior vantaggio il proprio contratto. Tant’è che due
anni dopo riesce a stabilire un nuovo accordo: il Gonzaga si
impegna a elargirgli uno stipendio di 15 ducati annui, cui
aggiungere alloggio, una bella casa, grano per sei persone, viaggio
e trasloco di mobili, bauli di casa e di bottega, e inoltre tutto il
materiale per dipingere. Il marchese metterà anche a disposizione
uno studio vasto dove preparare cartoni e ritratti.
Mantegna prometteva: “Sto arrivando… sono quasi lì, prima però
debbo liberarmi di certi impegni presi qui a Padova. Tengo una
casa da vendere, una tela da terminare… Abbiate pazienza, mio
signore, sarò da voi al più presto. Son qua… eccomi, giungo… No,
rimando…”. “E no basta! Non si decide mai quel tanghero! Io
faccio una spedizione e lo faccio rapire!”
Qui è il caso di domandarci: ma perché tanta passione da parte del
Gonzaga per quel pittore, che oltretutto si permette a ogni piè
sospinto di mancargli di rispetto?
È semplice. In quel tempo, alla nascita dell’Umanesimo e del
Rinascimento, per un signore che volesse darsi una reputazione di
21
uomo illuminato ed esser considerato almeno magnificente, era
assolutamente d’obbligo poter ricevere ospiti illustri in luoghi
adeguati, cioè palazzi progettati da architetti di fama, offrire una
straordinaria cucina, approntare in piazze incantevoli spettacoli
degni di una corte regale, con compagnie di attori che sapessero
recitare tanto i classici greci e latini che la farsa dei mariazzi. E
soprattutto sculture monumentali, giardini da favola e pitture da far
gridare alla meraviglia.
Insomma per questa operazione era determinante riuscire ad
accaparrarsi artisti di genio.
Per comprendere cosa portasse i signori del Rinascimento a questa
ansia, non ci resta che paragonare quel clima con l’attuale
fanatismo per i grandi campioni di calcio. Così come oggi un uomo
di potere sborsa miliardi per acquistare un attaccante brasiliano che
dia prestigio alla sua squadra e a se stesso, similmente nel QuattroCinquecento conti, marchesi e duchi per non parlare dei pontefici
letteralmente si svenavano pur di acquistare i servizi di valenti
artisti che decorassero le stanze dei loro palazzi e le chiese delle
loro città.
In quel tempo noi italiani, grazie alla munificenza dei nostri
padroni, eravamo i maestri del bel vivere. All’estero, da Carlo VIII
a Ferdinando di Spagna, si diceva “Il faut regarder bien à la leçon
des italiens”.
22
Attenti, non si creda che questi nostri signori fossero tutti
magnanimi e comprensivi verso gli uomini d’arte e scienza. La
cronaca del Rinascimento è stracolma di atti di ferocia e disprezzo
verso artisti d’alto valore, perfino Leonardo dovette subire forti
umiliazioni, così come teatranti di fama, capocomici e grandi
autori ai quali i signori non versavano i compensi pattuiti e gli
artisti quando si lamentavano venivano scacciati a calci nel sedere
o addirittura imprigionati.
Intanto Mantegna continua a rimandare la sua partenza verso
Mantova. Ha da terminare il dipinto della Presentazione al tempio
con l’episodio della circoncisione. Il sacerdote si avvicina al
bambino tenendo una lama affilata fra le dita. Gesù si spaventa e
ha una reazione del tutto inattesa. Il bambino si divincola e cerca
disperatamente protezione fra le braccia della madre, quasi
arrampicandosi sul suo corpo. Ma il sacerdote non demorde, ha già
afferrato fra le dita il piccolo sesso del bambino. Ma il piccolo
Gesù scalcia e grida. Guardatelo, ha la bocca spalancata.
Nella parte sinistra del dipinto un ragazzino nei panni d’assistente
solleva verso il sacerdote un piatto d’argento con una benda
arrotolata. Il suo atteggiamento è solenne, tutto compreso nel rito.
Sul lato opposto della scena ci sono due donne, una anziana – la
madre di Maria – e un’altra più giovane che tiene in gesto di
23
protezione una mano sul capo del bambino che le sta accanto. Il
bambino, che preoccupato si succhia un dito, si intuisce abbia da
poco subito lo stesso intervento. La memoria troppo recente della
circoncisione lo turba non poco. Infatti volge il viso dall’altra parte
per non vedere.
Attraverso queste semplici annotazioni Mantegna riesce a
comunicare uno stato d’animo di intensa commozione che
contrasta con l’autorità solenne del tempio, teatro del rito.
Nel 1460 Mantegna decide finalmente di accogliere l’invito di
Ludovico Gonzaga e si reca, armi e bagagli, famiglia compresa e
bimbi in quantità, a Mantova.
Ma prima di presentare la nuova condizione di pittore di corte
vediamo un po’ chi erano questi Gonzaga.
Come dice un antico adagio pavano: “Il buon massaro è quello che
riuscendo ad arricchire il padrone arricchisce anche se stesso”.
Questo proverbio ben s’addice alle origini dei Gonzaga.
La famiglia dei marchesi di Mantova è una stirpe di nobiltà
relativamente recente. Nemmeno un secolo prima della nascita del
ducato di Mantova, i Corradi di Gonzaga, così si chiamavano,
erano ancora contadini che lavoravano e gestivano le terre di un
potente monastero benedettino, lascito di Matilde di Canossa.
Erano lavoratori che servivano con lealtà e soprattutto erano capaci
24
di procurare vantaggio ai monaci. Per questo furono premiati
ricevendo dai monaci terre incolte e da “purificare”. I Gonzaga
riuscirono a bonificarle e a trarne vantaggio. Insomma, divennero a
loro volta possessores, con tanto di case in città, a Mantova. E
anche a Mantova ebbero fortuna e s’arricchirono vieppiù. Quindi il
loro cognome, che proviene da un termine dispregiativo della piana
lombarda, gonzo – stupido, imbranato, babbeo – da cui Gonzaga, si
dimostra ingiusto e completamente errato.
In quel momento a gestire Mantova era la famiglia dei Bonacolsi,
grandi mercatari arraffatori, che avevano da poco, attraverso un
colpo di mano, ottenuto il potere della città. I Gonzaga divennero
loro antagonisti sostenuti da una forte fazione di cittadini. In pieno
mese d’agosto del 1328 i Gonzaga e i loro sostenitori
organizzarono un nuovo golpe con tanto di scontro armato. I
Bonacolsi furono imprigionati e in parte eliminati; altri si
salvarono a fatica. Quindi i Gonzaga divennero i nuovi padroni
della città.
Ma a protezione dell’arraffo occorreva un’investitura. Nel 1433 a
Ludovico, giovane erede dei Gonzaga, fu proposto un affare: il
matrimonio con Barbara di Brandeburgo, nipote dell’imperatore
germanico, più il titolo di marchese. Il tutto in blocco per la
modica cifra di 12.000 fiorini d’oro.
Prendere o lasciare.
25
I Gonzaga presero.
Nel 1462-1464 Mantegna dipinge L’ascensione di Gesù al cielo.
Non dobbiamo dimenticare che Mantegna era anche scultore di
alto valore. Come abbiamo spesso dichiarato i suoi disegni, anche
quando erano preparatori per dipinti, fanno pensare ad abbozzi per
bassorilievi o, addirittura, per altorilievi in pietra.
È il caso di questo disegno preparatorio al dipinto dell’Ascensione
che ha per titolo Otto apostoli assistono alla salita in cielo di
Cristo.
Le figure dei santi sono poste su piani diversi, a scalare in una
grande stesura panneggiata, sotto la quale si indovinano i corpi. Da
quel panneggio a un certo punto vediamo spuntare le teste dei
santi. Nel disegno Gesù Cristo che sale in cielo non c’è, ma noi
indoviniamo dalla tensione e dal movimento dei corpi o meglio del
loro panneggio uno slancio che li porta quasi a salire.
I ritmi e la grafia delle vesti si possono tradurre solo in musica
danzata. Si sente quasi il bisogno che il racconto sia accompagnato
da figure che accennano a un lento ballo mistico.
La Madonna con il Bambino dormiente
26
Questa Madonna con bambino, di cui abbiamo già visto
l’immagine,
potremmo
benissimo
chiamarla
lo
struggente
desiderio della tenerezza.
Lo spunto magico è sempre quello della geometria. Le due figure
sono iscritte dentro una sequenza di ovali e di cerchi che
convergono intorno al viso del bimbo. Le mani della madre
raccolgono contro il proprio petto viso e corpo del bambino.
Il piccolo Gesù dorme sereno, protetto com’è dentro il manto della
Madonna e raccolto dalle sue mani che lo tengono come dentro un
nido sicuro.
Una ninna nanna antica cantata nella bassa Toscana così dice:
(canta) “E dormi dormi che io ti tengo. Non ti crucciar, non tener
spavento: è solo il vento che gira intorno a te. Io ti tengo stretto in
ogni momento. Dentro a sto bozzolo non c’è timore. Dentro a sto
nido c’è tutto il mio amore. Tutto il mio amore, il mio amore per
te”.
La Camera degli Sposi
La Camera degli Sposi, nel castello di San Giorgio a Mantova, è
l’unico grande affresco dipinto da Mantegna che sia giunto a noi
completamente integro.
Il primo punto da segnalare è quello della luce. Mantegna si
preoccupò che l’illuminazione naturale si fondesse con quella
27
pittorica degli affreschi. Per questo fece murare le vecchie finestre
e aprirne due nuove che proiettassero la luce di taglio sulle pareti
dipinte.
I personaggi della rappresentazione erano tutti viventi nel tempo in
cui venivano portati in scena. C’è tutta la famiglia riunita, in più i
parenti acquisiti venuti apposta dall’estero, dalla Germania e dalla
Danimarca, c’è perfino un re e un imperatore.
La presentazione dei personaggi si apre con un potente cavallo da
torneo condotto da un palafreniere che calza un elegante costume.
Un altro giovane, abbigliato allo stesso modo, trattiene alla catena
due cani mastini. È risaputo che i Gonzaga erano appassionati
allevatori di cavalli e cani di gran razza.
Nella seconda arcata è invasa da bambini alati, tre dei quali alla
base reggono una tavola incorniciata. Altri ragazzini svolazzanti
intorno alla tavola aiutano a sostenerla. E per finire sul lato destro
altri due piccoli angeli stanno seduti, quasi affranti, annoiati.
I visi e i corpi dei fanciulli sono illuminati tutti dal basso e questa è
un’invenzione molto suggestiva, anche se del tutto arbitraria,
giacché come può una luce naturale essere proiettata dal basso?
Possiamo pensare che i bambini siano affacciati a un lago che
riflette dal di sotto la luce. ed è probabile giacché Mantova a quel
tempo galleggiava su un grande lago.
28
La scena che segue vede sempre in proscenio tutti i figli maschi del
marchese, dai più piccoli ai maggiori, presentati da lui in persona.
Eccolo sul lato sinistro con addosso un costume che lo indica
subito come uomo d’armi. Infatti dal suo fianco pende una spada.
Di fianco a lui c’è un vescovo. È suo figlio maggiore. In una
famiglia nobile del tempo il vescovo era di regola. Se poi
diventava Papa meglio ancora!
L’incontro si svolge all’aperto, davanti a monumenti classici della
città di Roma, assemblati in modo arbitrario, paradossale: insomma
la città eterna trasferita in Padania.
Sull’altra parete riappare l’intera famiglia, comprese le signore. La
tecnica impiegata per questa scena non è a fresco, bensì una pittura
a olio su muro a secco, ed è straordinario come questo impasto
abbia prodotto una stesura cromatica tanto resistente al tempo.
Quel che non riuscì a Leonardo con il Cenacolo qui ebbe gran
successo.
Ma andiamo per ordine. Sappiamo che la ragione del disastro
dell’Ultima Cena era determinata dal fatto che la parete sulla quale
era dipinta affondava in una falda acquifera. Il muro pompava
perciò continuamente acqua che di fatto impregnò e ammuffì il
dipinto di Leonardo.
29
Qui invece, con tutto che le mura del castello sono immerse in una
vera e propria roggia l’architetto che progettò il castello interpose
fra la base della costruzione e le mura sovrastanti una continua
lastratura di pietra che isolava completamente le pareti, impedendo
il fenomeno del risucchio d’acqua.
Tutto lì.
Stavamo descrivendo il secondo dipinto.
Davanti al pilastro di sinistra un segretario ossequioso si protende
verso il marchese che se ne sta seduto in proscenio.
Sotto la poltrona del signore sta accoccolato un cane il cui muso è
la copia sputata della faccia della marchesa tedesca seduta poco più
in là. Perfino le due bende dell’acconciatura che scendono ai lati
del viso della donna riproducono esattamente la forma delle due
orecchie del cane. È vero che spesso i cani e i loro padroni
finiscono per assomigliarsi, ma qui la similitudine è perlomeno
provocata…
Tornando al segretario che si curva ossequioso a parlare
all’orecchio di Ludovico, notiamo che c’è qualcosa che non quadra
fra le due figure: l’altezza del servitore è stata ridotta al minimo.
Se il marchese si levasse per incanto all’impiedi sovrasterebbe il
suo fido collaboratore di almeno un metro. Si può pensare che il
Mantegna avesse ridotto la statura del segretario per rispetto alla
30
statura morale del marchese. Ma forse c’è un’altra ragione più
credibile: il segretario era davvero piccolo di statura ed era stato
scelto proprio perché potesse più comodamente parlargli
all’orecchio senza doversi inchinare!
Ma bisogna ricordare che nella corte dei Gongaza i personaggi
fuori misura e addirittura deformi erano numerosi.
Non è una maldicenza ricordare che la stirpe dei marchesi di
Mantova era affetta da rachitismo, che produceva qualche gobbo in
più. Per contorno soffrivano anche di malaria, causata dal vivere in
palude. In compenso potevano nutrirsi di rane in abbondanza, cibo
molto raffinato.
Qui le conosciute deformità di alcuni figli sono corrette e
mascherate da Mantegna. Non si sa se per sua scelta o per il dovere
di non dispiacere al principe. Ma palese è la tenerezza che mostra
nel descrivere l’immagine di questi bambini. A questo proposito è
commovente il profilo di Paola, la figlia più piccola del principe,
che mostra alla madre tedesca una mela, chiedendole il permesso
di mangiarsela.
La bambina ha gli occhi cerchiati, lo sguardo sofferente. Non ci si
può trattenere dal provare tenerezza…
Per contrasto, alle spalle della madre, appare una splendida
ragazza. È Barbarina Gonzaga, abbigliata con eleganza. Alle sue
spalle c’è una vecchia e tutto intorno ai due visi scorre una doppia
31
fila di cerchi architettonici come una collana di marmo. Quei
cerchi esaltano il volto della fanciulla. Provate a cancellare il filare
di cerchi e il viso della ragazza perderà all’istante la sua magia.
Sembrerà fermarsi anche il suo respiro.
Ai piedi di Barbarina scopriamo una piccola donna. Ma non è un
trucco dello scorcio, è proprio una nana… che ci guarda quasi con
insistenza. È la classica nana di corte. La composizione dei principi
e dei cortigiani anticipa di più di un secolo l’ensemble della
famiglia reale di Spagna di Velázquez.
È straordinario che proprio in mezzo a questo lazzaretto dei
miracoli, il capostipite sia riuscito a farsi assumere dal duca di
Milano come condottiero dell’armata lombarda. Un condottiero
gobbo… Ma si sa i gobbi portano fortuna!
Passiamo dentro la seconda arcata. La scena sulla destra è
attraversata da una scala sulla quale si ammucchiano giovani
cortigiani che si spingono l’un l’altro nel tentativo di raggiungere il
gruppo dei principi e guadagnarsi uno spazio di prestigio. Ma due
notabili li bloccano risoluti. Sembra di essere a una seduta del
nostro Senato!
Quell’assembramento crea scompiglio rompendo la calma quasi
solenne in cui sembra immersa la corte. Due altolocati volgono il
viso verso la scalinata, distratti da quel gruppo di intrusi. Anche la
32
bella Barbarina volge il viso a sbirciare i giovani colpevoli del
trambusto. Insomma i personaggi che senza quel piccolo incidente
avrebbero rischiato di ritrovarsi esposti in vetrina, inerti e in posa,
ora
godono
di
una
salutare
agitazione.
Poi
torneranno
immancabilmente nella solita, insopportabile noia… Purtroppo non
siamo ancora a Ferrara, dove lo “schifar noia” è un’arte unica di
quella corte: là si danza, si fa festa, si montano carri allegorici, si
fan correre asini e giudei nudi, ci si accoppia come conigli sotto la
protezione di Venere e delle tre Grazie nude e ogni nobile tiene
amanti appassionate…
Intanto lassù nel centro della volta s’è sfondata la cupola ed è
apparso un cielo limpido e luminoso. È la geniale trovata di
Mantegna, copiata dagli antichi di Roma. Infatti anche nella grande
cupola del Pantheon a Roma, lassù un grande disco di luce si apre
nel vuoto.
Questo della cupola è il gran finale, capolavoro della magia
scenografica e dello scorcio. Non bisogna dimenticare che
Mantegna fu il vero inventore dello scorcio nella pittura.
Da quel cerchio di cielo s’affacciano guardando di sotto curiosi e
divertiti gruppi di bimbi alati. I putti si prendono gioco dei simboli
del potere: mostrano a chi li guarda le loro chiappette con sfrontata
e candida esibizione. Uno di loro accenna addirittura a far pipì.
33
Con loro s’affacciano figure che sembrano commentare la scena
che si svolge nella stanza. Ragazze, anche di colore, e perfino un
pavone, che pare il più stupito per quello che sta vedendo nel
mondo di sotto.
Trattando di questo capolavoro più di un noto ricercatore ha
espresso un giudizio deciso su Mantegna, dichiarando che qui il
pittore si sarebbe assuefatto al ruolo di artista di corte. Addirittura
è stato definito pittore di regime. Ma dove sarebbe l’adulazione del
piaggione rituale? Come non leggere l’ironia e la satira in diecine
di immagini? Piuttosto a sto punto ci prende un altro dubbio. Come
potevano il duca di Mantova e la sua corte non cogliere doppio
significato della rappresentazione di Mantegna: la similitudine del
cane con la marchesa, il rimpicciolimento del segretario,
l’atteggiamento ossequioso e servile dei cortigiani, la Roma
impossibile nella laguna…
Ma come diceva Machiavelli che in quegli anni stava già pensando
al Principe: “La vanagloria dei potenti li rende ciechi. Il loro palato
e l’udito non assaporano né odori sgradevoli né suoni stonati. Non
avvertono nemmeno lo spernacchiare delle trombe contro i loro
orecchi, ubriachi come sono di possanza”.
In uno scritto di qualche anno fa Rodolfo Signorini, illustrando la
Camera picta, assicurava che l’ispirazione per questo capolavoro è
venuta a Mantegna da un’opera di Luciano di Samosata, il grande
34
satirico greco. Egli illustrava una sala adorna di pitture. “Osservate
– diceva – come il colore dei panneggi che ornano i gesti delle
figliole danzanti, la pantomima disegnata e il paesaggio
sostengono e abbelliscono ogni nostro discorso, anche il più
banale. Così come un buono strumento ben suonato fa apparire
melodioso anche l’oratore più stonato.” Ma poi ecco che all’istante
Luciano ribalta e contraddice questa sua convinzione: “Ma quale
idiozia vado dicendo? In verità la bellezza del color dipinto e dei
corpi che si muovono sulle pareti distruggono e confondono il
pensiero e lo avviliscono. Il pensiero ha bisogno di silenzio e di
vuoto intorno a sé. Ogni controcanto alla parola diventa gracchiare
di rane in uno stagno.”
L’aver incontrato il pensiero di Luciano di Samosata e i suoi
paradossi satirici è stato determinante per Mantegna, e il suo modo
di raccontare, specie quando dovrà, fra non molto, affrontare i
Trionfi di Cesare.
I disegni
Mantegna, pochi lo sanno, fu un autentico maestro del disegno.
Sono diverse centinaia le incisioni, le punte secche e i bozzetti
preparatori eseguiti di sua mano o a lui attribuiti e giunti fino a noi.
Purtroppo altre centinaia di studi sono andati perduti. Ci sono
pervenute, per fortuna, numerosissime copie eseguite dai suoi
35
allievi e da importanti maestri, anche stranieri. A proposito di
maestri, questa volta italiani, dobbiamo ricordare che disegni per
secoli attribuiti a Raffaello e a Andrea del Castagno si è
recentemente scoperto essere opere di Mantegna.
Per quanto concerne le punte secche e i bozzetti di piccola e media
dimensione Mantegna era un esecutore che si esprimeva in grande.
Quante volte, osservando le riproduzioni dei suoi disegni stampate
su libri d’arte, rimaniamo sorpresi nel constatare che si tratta di
opere che nell’originale misurano pochi centimetri. Giureresti di
trovarti di fronte a un disegno come minimo di un metro e mezzo
di altezza. L’inganno nasce proprio dalla particolare espressione
grafica del Mantenga.
A questo punto mi son detto: “Proviamo ad ingrandire uno di
questi disegni, come se fosse un cartone”. E così ho trasposto un
normale disegno su un grande foglio, di dimensione quindici volte
maggiori, come si fa in scenografia quando si sviluppano i progetti
dei fondali. Il risultato è stato davvero stupefacente. Potrete
sincerarvene di persona visitando la mostra dei settanta cartoni
esposti qui a Mantova, nel tempio di Leon Battista Alberti.
La discesa di Gesù agli Inferi
Il disegno è di gran lunga più drammatico rispetto al dipinto. Qui
vediamo Gesù Cristo di schiena che ha appena sfondato la porta
36
dell’Inferno. L’inferno è cancellato, non c’è più. Cancellato è
quindi non solo il peccato originale, ma ogni colpa, il concetto
primo del castigo sul quale si fonda l’idea di un certo
Cristianesimo. “Liberi tutti!”. Dicevamo che Gesù ci mostra solo le
sue spalle, non si vede il suo viso, la carica espressiva e
drammatica è prodotta dal movimento del panneggio e
dall’atteggiamento di tutto il suo corpo. Nel disegno in totale
vediamo Adamo ed Eva insieme ad altri dannati che escono dal
fondo sotterraneo, storditi, increduli per quello che sta succedendo.
Cristo cammina sul portone appena abbattuto. La storia qui
illustrata proviene dai Vangeli apocrifi e la troviamo prodotta in
pitture e sculture addirittura del nono e decimo secolo. Più tardi
intervenne la censura che cancellò la liberazione dal peccato. E
cambiò il titolo da discesa agli Inferi in discesa al Limbo, che è
molto più gentile.
TRIONFI
Mantegna ha cinquantacinque anni quando nel 1486 su invito di
Francesco Gonzaga inizia a dipingere le grandi tele dei Trionfi di
Giulio Cesare. Quest’opera per secoli appresso fu considerata
insieme all’Ultima Cena di Leonardo e al giudizio universale della
Sistina il più importante dipinto del Rinascimento.
37
Il marchese di Mantova, da poco ingaggiato come condottiero dalla
Repubblica di Venezia, voleva con quella serie di nove grandi
dipinti (tre metri per tre) esaltare l’impresa dell’imperatore romano
e nello stesso tempo glorificare se stesso.
I dipinti divennero subito famosi. Principi e intellettuali illustri
arrivavano appositamente a Mantova per visitarli.
Le opere furono concepite in gruppi di tre. Dopo tre anni il primo
ciclo di tre si interrompe: Mantegna abbandona Mantova per
recarsi a Roma. Si trova evidentemente in polemica con il suo
committente che tardava a pagarlo.
Rimane a Roma per più di due anni, intento ad affrescare la
cappella privata del papa, della quale non conosciamo nulla dal
momento che nel Settecento verrà abbattuta l’intera costruzione
per lasciar posto a un altro progetto. Questo ci dice della brutalità e
dell’indifferenza con cui venivano trattate opere di enorme valore
da parte dei principi, sia del regno di Dio che di quello degli
uomini.
Tornato a Mantova, viene sollecitato a riprendere a riprendere la
serie dei Trionfi. Ma il pittore ha già trovato ingaggi presso altri
committenti per altre opere. Rimanda. Promette che a tempo debito
concluderà la sua opera. Approfittiamo di questa pausa per
descrivere e commentare le prime tre tele dei Trionfi.
38
Cominciamo con Cesare sul carro.
Notiamo che la scena è pervasa da una calma solenne.
L’imperatore sul carro del trionfo se ne sta seduto come in attesa
che il corteo si muova. Ha l’aria stanca, annoiata e il suo
atteggiamento non ha niente di trionfale. Sta lì, come un attore che
suo malgrado è costretto a recitare la parte. Dietro a lui un giovane
alato, evidentemente l’allegoria della Fortuna, sta per incoronare il
vincitore che indossa la clamide d’oro. Il giovane si arresta
volgendo il capo verso il retro, come se qualcuno l’avesse
chiamato con un ordine: “Fra poco si parte!”
Nella stessa direzione guarda anche un altro ragazzo che
scopriamo ritto presso il cavallo. Indossa una corta tunica che gli
lascia nude per intero le gambe. Porta una vistosa collana.
A sottolineare lo stallo della parata, ecco che fra le gambe del
giovane portatore di stendardo appaiono tre bambini tutti ignudi
che brandiscono fronde, forse d’alloro. Uno dei tre putti spunta fra
le stanghe del carro e la zampa del cavallo. Nelle descrizioni di
Plinio e Flavio Biondo riguardo i trionfi non appaiono mai i
ragazzini. Questa quindi è l’immancabile invenzione di Mantegna.
Un altro elemento scenico completamente inventato è l’arco di
trionfo che fa da fondale al carro di Cesare. Infatti a Roma non
esiste un monumento del genere, adornato sul fregio da una folla
39
statuaria, dove appaiono Dioscuri e personaggi di eroi disposti
come in una enorme bancarella d’antiquariato.
In prossimità del ginocchio di Cesare una grande face è già accesa.
Questo vuol dire che sta per fare scuro. Infatti sulla sinistra si
intravede il cielo, solcato all’orizzonte da una luce dorata. In alto le
nubi sono scure, come se si preannunciasse un temporale. È già la
tempesta di Giorgione?
Nella volta dell’arco spunta una enorme mano d’oro spalancata: è
un’immagine allegorica del potere ma anche metafisica, come ne
troveremo in gran numero in tutti gli altri dipinti del Trionfo.
La sfilata dei senatori
Questo è il progetto della tela supplementare che il pittore pensava
di collocare immediatamente dopo la prima, quella di Cesare
annoiato sul carro.
La tela in questione, detta dei “senatori”, di cui possediamo solo un
disegno preparatorio e alcune incisioni, non fu mai eseguita.
Il disegno è realizzato con eleganza ed espresso con una grafica
eccezionale che preannuncia il “segno” di Raffaello.
Osservando i personaggi che compongono la teoria degli altolocati,
ci rendiamo subito conto che Mantegna li veste con abiti
riccamente drappeggiati che alludono sia al costume romano che a
quello rinascimentale. Anche in questa scena Mantegna non può
40
fare a meno di inserire un ragazzino che si trova quasi schiacciato
fra le natiche di un ministro obeso e il ventre del giovane
assistente.
È inutile chiederci che cosa ci stia facendo lì quel bimbo che a sua
volta indossa vesti di foggia romana lunghe fino ai piedi: si tratta
di una delle classiche annotazioni ironiche che abbiamo visto
puntualmente affiorano nei dipinti del Mantegna.
Non s’è mai visto un bambino senatore. Si ricorda un cavallo
senatore… ma un bambino mai!
Lassù nel palazzo si aprono due finestre alle quali si affacciano dei
ragazzini: hanno l’aria di essere imprigionati o perlomeno esclusi
dal rito. In coda al gruppo ci sono dei soldati che calzano pettorali
di bronzo scolpito, simili a quelli disegnati da Piero della
Francesca negli affreschi di Arezzo. Notiamo che il primo soldato
al posto della lancia ha impugnato un lungo ramo con fronde
d’ulivo, cioè un palese segno di pace. Ma, se con la destra regge
l’ulivo, l’altra mano stringe l’impugnatura di una lunga spada.
Ancora, tutto intorno si rizzano lance e alabarde fitte come getti di
un canneto. Ed ecco di nuovo la satira! Si va alla guerra ma per
portar la pace… Vi dice qualcosa questo motto?! È un moto
imbecille ma di grande attualità…
Per inciso c’è chi arrischia che questo dipinto sia stato in verità
eseguito, ma poi tolto dalla sequenza per ordine del committente,
41
Francesco Gonzaga in persona, giacché quei senatori, come
racconta Tacito nella sua cronaca, erano in gran parte avversari
dello stesso Cesare e lo trucidarono con un eccessivo numero di
pugnalate: trentadue! che spreconi…
Insomma, quel capitolo non era proprio di felice augurio.
Terza tela, dedicata ai musici e portinsegna.
Il gruppo degli orchestrali è composto da un suonatore di cetra che
apre la sfilata. Subito appresso vediamo un flautista moro che
suona e danza sollevando a ritmo le gambe. Ci ricorda uno dei tre
Re Magi, Baldassarre. Come nel Vangelo apocrifo dedicato al
primo miracolo di Gesù Bambino – io l’ho recitato per centinaia di
volte – il Re Magio nero è l’unico dei tre che seduto sul suo
cammello canta felice creando fastidio e ira negli altri due che
urlano “Bastaaaa!!!!” e lui imperterrito riprende: “Oh che bel che
bel che bel che l’è andare sul camel… (canta a soggetto)”
Come abbiamo già accennato, Mantegna dopo le prime tre tele dei
Trionfi si arrestò e, se pur sollecitato, non si decideva a concludere
il lavoro.
Sappiamo che nel 1488 Mantegna si reca a Roma dove rimane per
più di due anni, intento ad affrescare la cappella privata del Papa,
di cui non conosciamo quasi nulla dal momento che nel Settecento
42
verrà abbattuta l’intera costruzione per lasciar posto a un altro
progetto. Questo ci dice della brutalità e dell’indifferenza con cui
venivano trattate opere di enorme valore da parte dei principi, sia
del regno di Dio che degli uomini.
Ritornato definitivamente a Mantova (siamo nel 1490), noi
pensiamo che abbia deciso di sospendere per qualche tempo il
progetto dei Trionfi, anche per protestare contro il mancato
pagamento dello stipendio da parte del duca. Quindi è costretto a
ritrovare altri committenti: cosa che non gli è difficile, viste le
innumerevoli richieste.
Ma improvvisamente dopo qualche anno riprende a dipingere una
dietro l’altra le sette tele mancanti, ma con linguaggio e intenti
completamente trasformati.
Che cosa lo ha indotto a questa straordinaria decisione?
Un evento tragico che ha sconvolto l’intiera penisola e coinvolto
molti paesi d’Europa: la battaglia di Fornovo, che ha visto lo
scontro di due potenti eserciti ai piedi dell’Appennino toscoemiliano, non lontano da Parma, e che Mantegna ha vissuto da
spettatore di prima fila, coinvolto, dolente e sdegnato.
Ma seguiamo la cronaca dei fatti.
Per ogni guerra c’è sempre un movente e un interesse, per non dire
rapina, in terre e denaro. Anche il nostro conflitto è mosso da
43
questo pretesto. Carlo VIII, giovane re di Francia, scende in Italia
per raggiungere Napoli. Ha scoperto che gli Angiò da cui discende
furono i reggenti di quelle terre e se le vuole riprendere. La
passeggiata, come lui l’aveva chiamata, è piuttosto facile.
Raggiunge Genova, prosegue per Firenze che in quel tempo ha
cacciato i Medici si è data un orientamento repubblicano. Da ogni
città il re pretende versamenti onerosi di tangenti. A Firenze va in
scena lo scontro tra Carlo VIII e Pier Capponi, rappresentante del
popolo. Lo ricorderete tutti: il re che minaccia “Noi suoneremo le
nostre trombe” e Pier Capponi che risponde: “ E noi suoneremo le
nostre campane”. Lo scontro musicale finisce con un accordo. I
fiorentini otterranno la libertà a fior di fiorini. A migliaia. Carlo
VIII raggiunge Napoli, si fa incoronare re.
Ma i napoletani, dopo una prima accoglienza carica di simpatia,
accortisi che i Francesi badano a far bottino spogliando magazzini
e palazzi – manco fossero Turchi! – si trasformano in ospiti ostili.
Urlano “Vatténne ladrone”. Si mette male… Per di più Carlo viene
a scoprire che Venezia, la Spagna, l’Austria, il Papa e Ludovico il
Moro si sono uniti in una coalizione con lo scopo di costringerlo a
sloggiare e tornarsene da dove è venuto. È la solita pantomima
all’antica italiana: prima tutti gli staterelli in coro, con in testa il
Papa, lo applaudivano, mo’ lo spernacchiano. Carlo e il suo
potente esercito decidono di far fagotto. Il 20 maggio 1495 lascia
44
Napoli e risale la penisola. Con sé porta i regali ottenuti durante la
discesa e soprattutto i “trofei” di cui s’è impossessato in loco.
Quindi raggiunge l’Appennino tosco-emiliano e discende verso
Fornovo dove trova ad attenderlo l’esercito “degli italiani”
affiancato dagli austriaci e dagli spagnoli. La possente armata è
agli ordini di un condottiero a noi familiare: il duca di Mantova
Francesco Gonzaga.
Il re di Francia ha lasciato metà dell’esercito a Pisa. Grave errore!
Ora si ritrova dimezzato, di forza ma non di coraggio. Infatti
scende la valle attaccando. È un massacro da entrambe le parti: più
di tremila morti.
I cronisti del tempo di volta in volta esaltano la vittoria dei
Francesi o il trionfo della Lega italiana, comandata da Francesco
Gonzaga che nella battaglia si è ben distinto, coadiuvato dallo zio
Ridolfo, che però c’ha lasciato le penne. Nella fuga i francesi
hanno abbandonato il loro straripante bottino sul campo. La lotta
per impossessarsene è l’unico momento epico di tutta quella
guerra.
Tornato a Parigi il re molto nervoso attraversa un corridoio con
impeto regale e va a sbattere la fronte contro lo stipite traverso di
una porta. Muore sul colpo! E dire che i suoi soldati lo chiamavano
“l’ariete”!
45
A sua volta Francesco Gonzaga, ritenuto dagli italiani il vincitore,
va via di testa.
Si lascia travolgere dai festeggiamenti e dalle numerose offerte
d’ingaggio come conductor maximus alla testa di armate veneziane
o papaline a scelta.
Finalmente oltre la gloria comincia a circolare anche il denaro!
Mantegna riceve un grosso anticipo per il suo lavoro, il che lo
induce a ritornare alle tele del Trionfo. Quello scontro con morti e
saccheggi lo ha caricato di forza e indignazione.
Affronta la prima nuova tela, la quarta della serie. Sceglie un
argomento altamente provocatorio. Quello è il tempo in cui
Isabella ha raccolto intorno a sé una grande compagnia di attori, la
prima di valore professionale della storia del teatro.
Questa è la scena dove appaiono prigionieri e comici.
Notiamo subito che questo dipinto esprime qualcosa di molto
singolare. Essendo questa processione organizzata per glorificare
Cesare o, per trasposizione allegorica, le gesta guerresche del
marchese Gonzaga, condottiero di eserciti, ci aspettiamo a
proposito del titolo “I prigionieri” di veder sfilare incatenati
guerrieri sconfitti e catturati in battaglia.
Ma non è così. I prigionieri, che a loro volta sono in attesa che il
corteo si muova, sono cittadini, uomini e donne, con i loro pargoli
anch’essi in catene. Uno di loro, personaggio stimabile, tiene in
46
capo una specie di zucchetto o papalina, classica del costume
ebraico. È inutile ricordare che nei secoli dell’Umanesimo in ogni
città italiana gli ebrei erano costretti nel ghetto e spesso brutalizzati
dai vari tribunali religiosi, spogliati dei loro beni e della loro
dignità.
Per inciso va ricordato che Isabella d’Este, sposa di Francesco
Gonzaga, aveva imposto che gli ebrei vestissero di giallo e verde,
colori della loro mortificazione. Infatti questi sono i colori
dominanti negli abiti dei prigionieri.
Le femmine costrette in catene sono quattro e alcune di loro
sfoggiano acconciature esotiche.
Nel bel mezzo del gruppo, in primo piano, c’è un bambino. Il
piccolo “prigione” regge un fiore. È posto quasi di schiena, ma la
sua faccia è girata verso di noi che lo guardiamo e i suoi occhi ci
scrutano proprio come osservassero il pubblico che lo sta a
guardare. Chi può dimenticare la foto del bambino ebreo polacco
catturato dai nazisti? È vero… il tempo spesso si ferma.
Sopra il gruppo nel palazzo si apre una lunga finestra chiusa da
sbarre. Fra le grate si intravedono un’altra volta visi di ragazzini.
Anche loro prigionieri. È l’ossessiva memoria del piccolo
Mantegna che ritorna alla propria infanzia da coatto.
47
Nel centro del dipinto su un’asta in bella vista vediamo issato il
cartello che ci avverte: S.P.Q.R., il senato e il popolo di Roma. Chi
ci vede un’allusione satirica non è un maligno.
Visitando la mostra, uno degli amici che mi accompagnavano si è
stupito e mi chiesto: “Ma come potevano i principi non cogliere i
doppi significati della rappresentazione di Mantegna?”. Come
diceva Machiavelli che in quegli anni stava già pensando al
Principe: “La vanagloria dei potenti li rende ciechi. Il loro palato e
l’udito non assaporano né odori sgradevoli né suoni stonati. Non
avvertono nemmeno lo spernacchiare delle trombe contro i loro
orecchi, ubriachi come sono di possanza”.
L’altra metà del gruppo che segue è composta da commedianti e
clown. Uno di essi, un giullare con il classico costume di maschera
da commedia dell’arte a larghe strisce, guarda a sua volta verso di
noi, che siamo il suo pubblico, con gesti buffoneschi. Davanti a lui,
piegato su se stesso, c’è un uomo-scimmia, che sembra alludere
all’homo selvaticus, classica maschera della Padania di quel
tempo. In posa elegante c’è un giovane, in abbigliamento da
valletto, che regge una lunga asta sulla quale è issato un elmo che
presenta sulla cima un uccello mitico con la faccia da donna. Poco
più sotto spunta il volto di un attore barbuto, che calza a sua volta
un elmo con grande pennacchio. Si tratta sicuramente di un
48
personaggio di rappresentazione teatrale epica, forse il protagonista
di una tragedia.
In basso scorgiamo un cagnolino, affiancato da un bimbo trattenuto
da una vecchia, forse la nonna. Il bambino tenta di sollevare le
braccia verso la madre nel gesto di montarle in grembo e afferrarle
i seni. La giovane madre con l’altro braccio tiene stretto al petto un
altro bimbo da allattare e mostra due seni turgidi e nudi. Dietro a
lei si notano tre giovani donne con strane capigliature di foggia
orientale, proprie della commedia. Tutto il fondo è solcato da rami
di ulivo, che ricamano il cielo ancora attraversato da nubi che
minacciano tempesta.
Abbiamo detto di Isabella e della sua passione per il teatro. Una
passione che diede i suoi frutti… Infatti Mantova continuò a
sfornare autori e compagnie di comici. Fra questi Tristano
Martinelli e Teofilo Folengo. Martinelli fu il primo a calzare
l’abito del più famoso personaggio teatrale di tutti i tempi… stiamo
parlando di Arlecchino. Folengo fu l’inventore del linguaggio
maccheronico, un grammelot composto da latino e dialetto, che
influenzò addirittura Rabelais. (esegue accenno a grammelot) e
che suonava più Uptis fauces nàmite mi a ti, ti a mi… cavérna
suscrìtto fémine bèle gràse lunghe pìcole… E va’ a cagà!
49
È la prima volta che nel Quattrocento un pittore presenta un’intiera
famiglia di comici, preannunciando il Ruzzante e la sua compagnia
che nella vicina Padova di lì a poco daranno inizio al più grande
teatro italiano di tutti i tempi. Una compagnia dove le donne, come
qui le si presenta, sono salite in palcoscenico a sostituire i
femminielli o mariuoli del teatro medievale.
Inoltre, in questo straordinario dipinto, viene ricordato il rito
introdotto dalle prostitute del porto di Venezia che, all’arrivo delle
navi, mostravano ai marinai le proprie zinne nude, a testimoniare
che non si trattava di travestiti ma di autentiche femmine. “Prego:
provare per credere!”
Quinta tela: i portatori di bottino e di trofei
In questo dipinto ci rendiamo conto immediatamente che, rispetto
ai primi Trionfi, ogni enfasi retorica, pur leggera, è completamente
sparita. Più che a una marcia trionfale assistiamo piuttosto a una
fuga di briganti che hanno appena saccheggiato ville e palazzi e si
stanno in tutta fretta allontanando dalla città per darsi ai campi. Il
loro aspetto e gli abiti che indossano non hanno niente di marziale.
Non si tratta di soldati di un esercito di professione e nemmeno di
ventura. Fan parte di bande arraffanti che seguono i combattenti
alla sola ricerca di bottino, pronti dopo ogni strage a spogliar
50
morti. Infatti fra di loro uno solo porta una spada, fuori ordinanza,
certamente rubata.
I primi malnati, pur caricati di refurtiva come facchini, cercano di
tenere un’andatura sostenuta, ma alle loro spalle due compari
stanno crollando sotto il peso di corazze, elmi e spade infilzati
sulle pertiche.
Uno strano mobile simile a uno sgabello, carico di vasi d’oro e di
bronzo di gusto fiorentino, è retto dai primi quattro ladroni. Da
quella specie di portantina pendono collane con diademi di grande
valore e in cima al cumulo della refurtiva un vaso di certo gremito
di monete d’oro. L’allusione allegorica ai saccheggi di Carlo VIII è
del tutto evidente.
Notiamo che tutte le corazze issate sulle pertiche sono mozzate di
netto all’altezza delle reni. Questo particolare ci assicura che
Mantegna le ha volutamente copiate da quelle in uso nelle
rappresentazioni teatrali, giacché l’espediente di dividere il
pettorale dal ventrale permetteva una maggior rapidità nella
vestizione degli attori.
Questo particolare è molto importante, poiché ribadisce l’intento
da parte del Mantegna non tanto di rifarsi scrupolosamente alla
realtà obiettiva e storica, ma piuttosto di rappresentarla. Come in
51
uno spettacolo teatrale, dove i personaggi recitano parti che
alludono criticamente alla cronaca dei fatti.
Per finire facciamo caso alle bandiere che sono issate ma arrotolate
all’asta per evitare che sbattano per il vento. Un vento che pare
proprio di sentire fischiare fra le armi e gli uomini e scuote l’un
contro l’altro vasellame e armamentari, provocando un frastuono
da mercato di pentole e padelle, nelle fiere di paese.
A sto punto, come si usa dire nell’ambiente del cinema: Avanti con
gli elefanti! (a soggetto Dario recita del capo organizzazione che
chiede di girare piccola scena)
Infatti qui, nella sesta tela, un folto gruppo di quei pachidermi
invade la scena. Rimaniamo subito sorpresi per la precisione con
cui sono rappresentati: il movimento delle possenti zampe, le
proboscidi, la testa, le grandi orecchie… tutto è descritto con un
realismo non comune. Ma dove li ha visti Mantegna sti elefanti?
Non è il solo ad averli disegnati in quel tempo: suo cognato, il
Giambellino, e Raffaello ne hanno disegnati alcuni con precisione
vedendoli nei giardini, l’uno del doge, l’altro del Papa.
Ma l’idea di far sfilare quegli enormi animali non è una trovata
visionaria del pittore. Gli è stata suggerita da Svetonio che nella
sua cronaca racconta di come Cesare trionfante ascendendo al
Campidoglio fosse affiancato da due teorie di elefanti. Ma noi
ormai sappiamo come Mantegna decidesse per proprio conto di
52
servirsi delle testimonianze antiche e soprattutto come le
utilizzasse spesso, esaltando o buttando in satira le fonti. Andrea
Mantegna impostava i suoi dipinti, usufruendo di più di un livello
di rappresentazione. Nel nostro caso in superficie poneva il rituale
dei trionfi, ma fra le righe faceva trapelare situazioni e argomenti
in forte contrappunto.
In quest’ultima tela che stiamo osservando gli elefanti irrompono
potenti, come in una battaglia. Ci viene subito in mente la vittoria
di Pirro e ci assale il forte dubbio che attraverso quella memoria
storica si voglia ironizzare sul risultato dello scontro di Fornovo,
dove entrambi i contendenti si proclamarono vincitori, per rendersi
conto alla fine che, come dice Shakespeare, molti eroi in quella
battaglia hanno guadagnato solo il fazzoletto di terra nel quale
sarebbero stati sepolti.
Molte volte nel suo sarcasmo Mantegna gioca con la metamorfosi,
usando degli animali per irridere gli uomini.
Infatti qui a precedere la mastodontica sfilata troviamo un toro,
addobbato per il sacrificio, con le corna pitturate d’oro e in capo
una specie di cappello da vescovo. Un lazzo buffonesco? Di
sicuro! Basta osservare la camminata imponente dell’animale, da
cavallo in parata. Quasi che, compreso nel suo ruolo sacrificale, il
toro esaltato voglia comunicare al pubblico: “Fra poco mi
53
sgozzeranno, ma sarò arrostito sulla brace per la gloria di Cesare,
mica per farne bistecche e cosciotti!”
A concludere con uno sghignazzo verso l’imponente trionfo,
Mantegna sistema nell’angolo destro del dipinto una pecora che
viene montata da un ariete. Si allude al fatto che i trionfi passano,
resta solo la vita, fatta di semplici rituali. Sollazzo triviale ma
anche un prepotente ritorno al naturale, lo snaturale di Ruzzante.
Settima tavola: Portatori del bottino, con tori sacrificali e
trombettieri
Qui Mantegna esegue un trompe d’oeil davvero singolare. Il cielo
è solcato diagonalmente da numerose trombe, ma noi scorgiamo
solo un solo trombettiere dalle gote rigonfie per lo sforzo di
soffiare. E tutte le altre trombe chi le suona? Suonano da sé sole?
Forse appena di là del limite del quadro sta nascosta la banda al
completo.
Con Mantegna l’assurdo è sempre dietro l’angolo. Lassù, in capo
alla collina, ci sono delle costruzioni, addirittura un Colosseo
abbandonato, invaso dalle gramigne. Più sotto un’altra costruzione
imponente sta crollando, proprio nel momento in cui si celebra il
Trionfo. Questa sì che è metafisica!
Eppure sono in pochi i ricercatori che si rendono conto di questa
follia. Così come evitano di sottolineare la figura che sta proprio
54
nel centro del dipinto e che descrive un portatore di bottino che si è
letteralmente abbrancato un grande vaso finemente scolpito e lo
stringe a sé con un abbraccio appassionato, quasi si trattasse della
sua donna o di una splendida femmina rapita nel saccheggio. Il
gaudente vasaio presenta un viso quasi caricaturale: un grosso naso
e un mento che sorpassa il naso stesso. Si tratta evidentemente di
un personaggio ben conosciuto che qui viene posto alla berlina per
certa sua evidente bramosia di vasellame quanto di glutei e fianchi
di femmine.
Ottavo: i carri trionfali
Ecco finalmente un cavaliere: in proscenio appare un giovane
uomo a cavallo che regge l’asta di una bandiera di seta rossa che il
vento spinge a disegnare strani ghirigori nel cielo. Un cielo sempre
più buio. Stavolta la tempesta sta proprio per scatenarsi. Il
cavaliere impettito discute animatamente con un fante, armato di
lancia e spada. Anche il fante discute, cerca di trattenere il
cavaliere che imperterrito come il suo destriero è deciso a
proseguire. Seguono uno appresso all’altro, issati su pali, cartelli
con scritte inneggianti al condottiero e alla vittoria. Anche qui,
nessuno li regge, vengono avanti da soli… per moto proprio.
Sotto i cartelli avanza il bottino, anzi è fermo, statico come le
molte statue di cui è composto.
55
In mezzo a tanti volti scultorei fa capolino una coppia di facchini:
in due soli reggono una quantità di teste scolpite, insegne, busti ed
elmi, pezzi d’armatura in gran quantità. Qui Mantegna sembra
voler alludere a un numero stupefacente da circo equestre.
Lassù in alto, ecco la base circolare di una cupola che s’affaccia
nel vuoto, come un pulpito a getto. Non scorgiamo manco un
pilastro che la regga: una cupola rotante sta prendendo il volo?
Addosso alla città sembrano crollare frammenti di strutture
sconnesse: grossi pali, pilastri, trabeazioni divelte. La responsabile
dello sfondamento è una prepotente testa d’ariete che ha sfondato
la città e sembra puntare dritta verso una lampada, dalla quale
escono fiamme alzate dal vento. Nero è il cielo. Forse le raffiche di
vento affogheranno il fuoco e, come dice il Belli: “Se spegneranno
li lumi e bona notte! Bona notte alle guerre, bona notte a li
saccheggi, a li pernacchi de trombe, al batter di tamburo. Zitti,
silenzio, anche pe’ te, silenzio pe’ tutti. Sta pe’ arrivà er giudizio
de’ Dio. Véne? Arriva el Signore? No’ véne? Cristo! Ce hanno
bugggeràto n’altra volta!”
Calma, noi non siamo ancora al giudizio, ma siamo sotto finale.
No, non sto parlando dell’effetto serra e degli uragani. Sto
parlando delle due ultime tavole dei Trionfi.
I portatori di trofei
56
Guardate: è già una catastrofe. Dal cielo stanno franando scudi,
corazze, elmi, trofei d’ogni genere, vasellame prezioso. Per un
attimo sembra che tutta questa mercanzia ammassata stia lassù
sostenuta da aste. Ma è solo un’impressione, anzi un’illusione
visiva. C’è il trucco. Sotto quell’imminente e fracassosa cascata
vediamo giovani di bel portamento che indugiano in posa e
atteggiamento assente. Tutti presi come sono ad apparire, non si
curano di ciò che si preannuncia. È il rito che conta, il sembrare,
non l’essere.
Lassù nel cielo è apparso un volto fatto di nuvole. È un volto
attonito, ammutolito per ciò che sta accadendo, stupefatto per
l’ottusa indifferenza degli uomini, presi solo dal loro vacuo
gigioneggiare. È un’allegoria chiara, lampante, di grande attualità.
E siamo finalmente all’ultima scena: trombettieri e portatori di
insegne.
Tutto il dipinto è solcato in verticale da aste che reggono cerchi
incatenati, drappi e tele dipinte con immagini di città, mura, torri,
baluardi ed eserciti all’attacco e sopra combattenti che rigettano gli
aggressori. È la prima volta che Mantegna ci offre l’immagine di
una enorme battaglia.
Sembra proprio che gli attori dell’ultimo dipinto siano ben consci
di recitare il gran finale, tant’è che stanno dandoci dentro con foga
57
inaudita. I suonatori di trombe soffiano fino ad esplodere, i
reggitori di insegne spingono in alto i loro simboli con slancio; c’è
anche un protagonista di colore, tanto per fare esotico, che posa in
bella figura. Un guerriero visto di schiena si appoggia all’asta e si
arresta e riprendere fiato.
Fra i buchi del gran bailamme si scorgono brandelli di cielo…
dell’ultima luce.
Questa serie di splendide tele è chiamata da qualche studioso
l’opera invisibile, poiché da quando agli inizi del Seicento fu
acquistata da Carlo I non è mai uscita dall’Inghilterra.
Quindi solo coloro che si sono recati a Londra nel palazzo di
Enrico VIII, Hampton Court, hanno avuto la possibilità di
ammirarli.
Perciò
noi
abbiamo
organizzato
un’operazione
veramente folle. Pur di vederle ritornare da noi, abbiamo riprodotto
con tecnologia molto avanzata quelle dieci tavole, le abbiamo
restaurate e oggi le presentiamo qui a Mantova nel tempio di San
Sebastiano.
Abbiamo detto restaurate e aggiungiamo: non solo abbiamo rifatto
volti, corpi e cieli danneggiati, ma anche i piedi. Avete capito
bene: piedi! Poiché quando gli inviati di Carlo I vennero qui nei
primi del 1600, denaro contante alla mano, ad acquistare l’intiero
ciclo, in un primo momento il duca di Mantova, anche lui Carlo I,
58
Gonzaga, tergiversò. Quindi rifiutò il contratto, poi ci ripensò e
chiese un grosso anticipo: “Pagate e portatevi via in fretta questa
quadreria. In fretta, prima che ci ripensi!”. Preoccupati che davvero
il duca ci ripensasse, gli inviati inglesi si diedero da fare per
staccare rapidamente i dipinti dai rispettivi telai. Purtroppo i bordi
col tempo si erano incollati alle aste, non restava che tagliarli.
Servendosi di lame a rasoio, segarono letteralmente la tela, proprio
in basso e in alto, mozzando anche i piedi dei personaggi.
Noi abbiamo ridato vita e piedi ai dipinti!
A questo punto pretendiamo che tutti vi alziate in piedi e cantiate
insieme a me l’Inno di Mameli. Abbiamo restituito all’Italia quello
che la perfida Albione ci aveva portato via, proprio come dei
briganti! (accenna attacco musicale dell’Inno di Mameli). L’avete
imparata, con tutte le partite cui avete assistito!
Ma il particolare che viene subito in evidenza osservando queste
riproduzioni è la scoperta che finalmente tutti i personaggi che
appaiono in primo piano a figura intiera sono muniti di piedi. Al
contrario nei nove dipinti originali assistiamo a una vera e propria
decapitazione d’arti, o meglio una “depedicazione”…
Che cosa è successo? La terribile amputazione podalica deve
essere stata messa in atto esattamente all’arrivo dei dipinti in
Inghilterra. Le tele, onde facilitare il trasporto come succedeva
59
quasi sempre, erano state tolte dalle tavole su cui erano stese,
quindi arrotolate su se stesse. Giunte a Londra, si sono approntati
supporti e rozzamente i fondi delle tele sono stati inchiodati sui
bordi dei telai. I responsabili non si curarono più di tanto del fatto
che così i piedi dei personaggi si sarebbero trovati rivoltati sotto la
cornice. Col tempo naturalmente quelle strisce di pittura
intrappolate si sono definitivamente perdute.
Nell’eseguire le copie dei Trionfi di Andrea Mantegna, noi, grazie
all’apporto degli allievi dell’Accademia di Brera, ci siamo
preoccupati di ricostruire la tela ripristinando le parti mancanti;
finalmente i protagonisti dell’allegoria epico-satirica di Mantegna
riavranno i loro piedi! Abbiamo letto e studiato decine di saggi e
testi sull’opera in questione e ci siamo stupiti del fatto che nessuno
degli autori e ricercatori da noi incontrati si sia accorto di queste
evidenti mutilazioni del dipinto. Ma non c’è da farsi gran che
meraviglia, giacché ormai ci siamo da tempo assuefatti alla
distrazione paradossale con cui specie i grandi studiosi trattano
particolari determinanti alla lettura e alla comprensione delle opere
che stanno esaminando.
Le tele finali dei Trionfi sono state eseguite nel 1505, anzi pare che
Mantegna le stesse ultimando ancora l’anno successivo, poco
prima di morire.
60
Quindi ha impiegato complessivamente venti anni per realizzare
questo straordinario capolavoro pittorico.
Ma a questo punto, prima di concludere, dobbiamo fare un passo
indietro di almeno dieci anni, cioè dal 1506 al 1496.
Come abbiamo già detto, negli anni 1492-1495 Mantegna si trova
a Roma intento a dipingere gli affreschi per la cappella del
pontefice Innocenzo VIII, con il quale i rapporti si erano deteriorati
a causa del contratto a strozzo che il pittore aveva dovuto subire. A
Mantova intanto moriva Federico Gonzaga, “il più amabile gobbo
che si vedesse mai”, succeduto a Ludovico, il primo grande
mecenate di Mantegna. Il giovane e sfortunato principe era amato
dalla intiera popolazione di Mantova per il suo gusto pratico del
lavoro industriale e per la sua correttezza e abilità nel trattare gli
scambi commerciali. A lui successe Francesco, detto L’allegro, di
bello e sano aspetto, appassionato amante di feste e tornei,
intenzionato a far fortuna come condottiero d’eserciti. Costui
aveva conosciuto, l’anno prima, la rampolla più preziosa degli
Estensi, figlia di Ercole d’Este duca di Ferrara e di Eleonora
d’Aragona, Isabella, che in quei giorni compiva 15 anni. Una
ragazzina di intelligenza e cultura straordinaria, allevata allo studio
da illustri maestri. Forse la donna rinascimentale di maggior
talento e sapienza.
61
Conosceva greco e latino, si interessava d’arte e scienza ed era di
bello e vivace aspetto.
I due ragazzi s’innamorarono con la benedizione dei rispettivi
augusti genitori.
Quando Andrea Mantegna tornò da Roma trovò a Mantova il
nuovo marchese Francesco l’Allegro che s’era appena sposato con
Isabella. La giovane signora fece molto effetto sul pittore e
soprattutto egli fu sorpreso dal festoso benvenuto che la ragazza gli
dedicò.
Il pittore unico della corte dei Gonzaga temeva però che
quell’accoglienza eccessivamente festante nascondesse il progetto
di declassare il suo prestigio nella corte stessa, chiamando a
Mantova altri architetti e pittori quali suo cognato il Giambellino, i
Ferraresi e qualche toscano di gran talento.
Intanto Isabella d’Este posa per lui. Pare che la duchessa non
avesse per niente apprezzato quel ritratto oggi sparito. Non ci
meraviglierebbe scoprire che la duchessa stessa avesse nascosto o
addirittura distrutto la tela. Ma, a parte l’episodio del ritratto,
Isabella provava enorme ammirazione per il pittore dei Gonzaga. E
questa considerazione era ricambiata da Mantegna che ascoltava e
seguiva i suoi progetti, le sue idee veramente affascinanti sulla
filosofia, la pittura e il teatro.
62
Isabella aveva letteralmente affascinato la corte di Mantova dove
vivevano uomini illustri di gran gusto e sapienza.
Tra i più famosi eruditi che sempre l’accompagnavano ricordiamo
Raffaele da Volterra e Lorenzo Valla, studioso quest’ultimo di
lingue antiche del Medio Oriente e grecista di fama. Il linguista
scopre che il famoso “lascito” di Costantino del iv secolo d.C.
redatto in lingua greca, con il quale l’imperatore avrebbe concesso
alla Chiesa beni, territori e diritto all’usufrutto di possedimenti
pubblici, era da ritenersi un falso smaccato e per di più inventato in
tempi recenti. Una truffa spudorata, con la quale vescovi, cardinali
e papi da secoli si godevano vantaggi e interessi, nonché titoli
esorbitanti! Ma come è arrivato Lorenzo Valla a scoprire
l’inghippo? Semplice: analizzando da vero scienziato del lessico
greco ogni riga e parola del documento. Così scopre che in quella
donazione
imperiale
sono
impiegate
espressioni
greche
anacronistiche, sconosciute al tempo di Costantino, nonché
svarioni sintattici e lessicali che ne denunciano palesemente la
falsità. Esplose uno scandalo che gettò la Chiesa tutta in gran crisi.
Sacerdoti e dottori nelle loro cattedrali e monasteri, “una spelonca
di ladri” e falsari.
L’autore della scoperta, come di consueto, fu letteralmente
aggredito dai sapienti della Chiesa cattolica apostolica romana, con
la solita accusa di infame eretico. Il comportamento di Isabella fu
63
esemplare: accolse e difese lo studioso proteggendolo con gran
decisione, dimostrando di essere una persona di indiscutibile lealtà
e senso di giustizia.
Il progetto di studi nel quale Isabella si impegnava in modo a dir
poco maniacale era la numerologia. L’analisi dei numeri e dei
valori sacri e cabalistici fu una disciplina alla quale si dedicarono
molti intellettuali del tempo che univano a questa ricerca lo studio
dell’astronomia e dell’astrologia.
Oltretutto la duchessa era appassionata di teatro: aveva allestito in
uno dei suoi saloni un palcoscenico sul quale si esibivano gli attori
maschi accompagnati addirittura da donne vere, che sostituivano i
normali travestiti. E questo quasi mezzo secolo prima che nascesse
la commedia dell’arte. Era lei che dirigeva questa sua compagnia.
Oltre
che
sovvenzionarla,
si
curava
anche
dei
testi
e
dell’allestimento, sceglieva musici e danzatori, maschi e femmine.
Il Cantelmo, altro erudito della corte dei Gonzaga, ci racconta di
uno spettacolo allestito in Mantova da Isabella su una piattaforma
scenica molto vasta. Il fondale era composto dalle tele dei Trionfi
di Cesare, mentre le ali del proscenio erano costituite da altri
dipinti, sempre di Mantegna, che illustravano i Trionfi del Petrarca,
oggi perduti. Insomma, non il solito teatrino di corte per pochi
intimi, ma una messa in scena davvero maestosa!
64
Abbiamo già capito che Isabella era una donna di grande
temperamento, e alta moralità, ma per niente facile nei rapporti con
i pittori e gli architetti. Contrattò con il Giambellino un dipinto di
tema mitologico per addirittura cinque anni (dal 1501 al 1506).
Purtroppo quel suo dirigismo esasperato si rivelò disastroso:
appoggiata dalla sua corte di esegeti Isabella voleva imporre oltre
al tema della storia anche l’andamento e la collocazione dei
personaggi. Alla fine il Giambellino salutò il cognato e se ne tornò
a
Venezia,
portandosi
via
i
bozzetti
che
andarono
immancabilmente perduti.
Anche con Lorenzo Costa la mecenate ebbe rapporti critici. Alla
fine giunsero a un accordo. Il dipinto per lo studiolo eseguito dal
ferrarese è oggi al Louvre.
Con Mantegna il gioco della committenza era ancora più difficile
anche perché a conclusione di ogni diverbio il padovano accettava
le indicazioni di base della “padrona”, ma appresso inseriva
varianti sul tema che capovolgevano in gran parte il contesto etico
dell’opera.
La prima opera importante commissionata a Mantegna da Isabella
per il suo studiolo nel 1497, ma molto probabilmente eseguita
qualche anno dopo fu Il Parnaso.
65
Partendo a leggere il dipinto da sinistra verso destra incontriamo
subito Vulcano, che fa cenni di minaccia verso un ragazzino. Si
tratta di Amore che lo sbeffeggia indicando vicino a lui Venere,
moglie del dio fabbro-fonditore, che se la spassa con Marte, dio
della guerra. Tanto per non aver dubbi, alle spalle di Venere è già
pronto un letto a due piazze... La figura di questo nudo ci ricorda
subito Tiziano e Giorgione. È il caso di sottolineare che questa
Venere rappresenta una delle più belle immagini di donna ignuda
di tutto il Quattrocento italiano.
Tornando al marito di Venere, Vulcano sta urlando furente verso il
ragazzino come se gli promettesse, se riuscirà di acchiapparlo, uno
spennamento totale, a cominciare dalle sue ali: “Ti ridurrò come un
pollo e ti cuocerò dentro il mio forno, bastardo! Così la pianterai di
sculettare intorno e far danni!”.
In primo piano, sempre sulla sinistra, vediamo Apollo che suona la
cetra con gesto ispirato. Nove Muse danzano seguendo il ritmo del
suo canto con un’eleganza straordinaria, caricate di una sensualità
del tutto nuova in Mantegna. Subito ci vengono in mente Botticelli
e Andrea del Castagno. Esattamente nel centro, la sesta musa pare
ci offra il ritratto di Isabella. La sua postura suggerisce una danza
pavana in cui il ventre piuttosto gonfio viene spinto in fuori e le
natiche a retro fanno altrettanto. Di questa pittura conosciamo il
cartone preparatorio.
66
Raccontano i testi greci che al canto delle Muse la terra fremesse
per il piacere e come in un forsennato orgasmo sbottassero getti di
lava dai vulcani e il terreno, montagne comprese, venisse scosso da
sconquassi tellurici di notevole vigore.
Nella scena in alto a sinistra vediamo infatti una montagna franare
in basso.
All’unisono Pegaso, il mitico cavallo alato, batte gli zoccoli sul
pavimento della scena e tutto si calma, ritorna la quiete punteggiata
da sospiri come in un gigantesco coito interruptus.
Qualche attento ricercatore ha voluto leggere nell’urlo canoro della
musa Isabella un lamento disperato per i continui tradimenti di
Francesco che nell’opera verrebbe rappresentato nei panni del dio
della guerra. Venere che gli sta accanto non sarebbe altro che una
splendida amante del duca, la favorita, una prostituta per la quale il
guerriero avrebbe letteralmente perduto la testa.
Tornando a Pegaso, osservate l’espressione dell’ippovolante:
l’insieme fra un cavallo e un buffonesco asino, con occhi quasi
umani e l’aria da impunito che si fa beffa della sceneggiata a base
di tradimenti, tresche e gestualità con canti ricolmi di una carica
erotica davvero spinta.
È inutile sottolineare che alcuni passi di questo racconto sembrano
ispirati alle satire grottesche di Luciano di Samosata.
Arrivati qui
67
Lo stesso discorso si può fare per quest’altra tela, dove la
paradossale ironia del satirico greco emerge ancora più smaccata e
pungente. L’intento di Isabella era quello di produrre un discorso
morale esaltante la castità e in contrappunto una feroce
fustigazione dei torbidi vizi della società. Ma come abbiamo
premesso fra la frusta moraleggiatrice di Isabella e la messa in atto
della storia bisognava far sempre i conti con l’indomabile ironia di
Mantegna.
Nella scena tutta arcate di fogliami intrecciati, Minerva irrompe
armata di tutto punto in mezzo a un raduno di personaggi sbracati
in atteggiamenti quasi osceni: un fauno ubriaco sollevato di peso e
portato fuor di scena dai suoi compagni di bagordi, mostriciattoli
che indugiano seccati, una donna con un viso leonino che tiene fra
le braccia un bimbo. Dall’acqua in proscenio spunta un centauro e
sulla sua schiena sta in equilibrio una fanciulla nuda. Un drappo
trasparente le nasconde a malapena il pube. I due sono personaggi
mitici cantati nelle Metamorfosi di Ovidio. Si tratta del centauro
Nesso, amico e maestro di Ercole e di Deianira, la giovane moglie
dell’eroe figlio di Giove. Ercole, impegnato nelle sue sette fatiche,
ha affidato la sua sposa al fedele centauro e se ne è andato. I due
con grandi sensi di colpa si innamorano. Sembra di assistere a una
festosa commedia di sesso e follia, ma purtroppo tutto finisce in
tragedia.
68
Sempre immerse nell’acqua fuggono due figure di cui una ha le
braccia tronche e più in alto una donna dai piedi caprini si salva
trascinando un bimbo a sua volta con zoccoli da satiro e tenendo
con un braccio uno stuolo di neonati. Fugge anche uno stormo
d’angeli con le ali da libellula. La dea li incalza armata di lancia e
scudo.
Lassù nel cielo, dentro a una nube fatta a ghirlanda, un gruppo di
divinità assiste indifferente e sembra commentare: “Siamo alle
solite! Quella bacchettona di Minerva sta scacciando i gaudenti. È
il giorno del repulisti morale. Guai dare il potere alle vergini
frustrate”.
Dietro, alle spalle della dea della castità e del buon costume,
appare la figura di Dafne. Apollo ha tentato assatanato di sedurla.
Rincorrendo per la foresta quella splendida ninfa, figlia del fiume e
dei boschi, il divino infoiato le è quasi addosso, sta per consumare
il suo stupro quotidiano. Dafne grida “Padre aiuto!”. Il padre
rapidissimo trasforma la figlia in una splendida pianta. Apollo non
fa in tempo a frenare il suo impeto e va ad inzuccarsi con un
grande schianto contro l’albero dalle fattezze di donna.
Satirici e sarcastici del tempo mitico assicurano che Apollo non
riuscì a frenare la propulsione erotica del proprio fallo. Il fallo
fallò, infilzandosi nel tronco della femmina lignea. L’urlo di
69
Apollo risuonò per le valli, le gole e gli anfratti creando un’eco
infinita seguita da vento e tempesta.
L’immagine della fanciulla scolpita nel legno è struggente e
disperata. Dafne urla ancora, le braccia spalancate ormai tradotte in
rami e fronde. I suoi seni davvero turgidi mostrano capezzoli dai
quali sono spuntati getti di rami fioriti. Altri getti di tenere foglie
stanno nascendo a ornare il corpo della vergine salvata. Sì, salvata
dalla violenza di un dio, ma prigioniera in eterno dentro
un’armatura di alloro.
Un lungo nastro avvolge il corpo ligneo della figlia dei fiumi e dei
boschi. Il suo grido non è più di paura per l’amplesso scansato. È
di attonita disperazione per quella metamorfosi inaccettabile.
Per chiudere, come un sipario sta calando sulla sinistra dall’alto
una rupe che il sole sta arrossando nel tramonto.
Più di uno studioso si dice convinto che queste due tele, soprattutto
il Parnaso, siano state dipinte nei primi del 1500, cioè negli ultimi
anni in cui la duchessa Isabella si trovò a soffrire di una situazione
tragica. Scoprì che suo marito il condottiero, frequentando
prostitute al seguito degli eserciti, si era ammalato di un morbo
comunemente detto mal francese o spagnolo.
70
Sembra di vivere la situazione di una commedia tardo
elisabettiana, il Trionfo del cavaliere dal pestello fiammeggiante,
che racconta appunto di una situazione tragicomica del genere.
Fatto sta che Isabella, lei donna tutta propensa a coltivare castità e
lotta contro la turpitudine, si ritrova un appestato sifilitico nel
talamo nuziale. I due da quel momento vivono forzatamente
separati, comunicano scrivendosi lettere. Inoltre Ferdinando, il
figlio che fra poco prenderà il comando del ducato, s’è innamorato
di una fanciulla deliziosa, moglie di un caro amico della madre,
nobile per giunta, che si chiama come lei. Ne nasce una tragedia.
Isabella ordina al figlio di cessare la tresca. Il figlio risponde che
preferisce lasciare il regno piuttosto che la ragazza. Quasi a vista
per il dolore Isabella comincia ad ingrassare. Dopo nemmeno un
mese le è impossibile montare le scale che la portano alle sue
stanze. Ci prova, rotola dal secondo piano al pian terreno: per
fortuna si è fatta così tonda e fornita di amortizzatori che non
lamenta nemmeno un bozzo ma è costretta a traslocare dal castello
turrito al piano terreno del vecchio palazzo Gonzaga, dove vivrà
fino alla fine dei suoi giorni senza gradini e senza scalinate.
I ritratti
71
A proposito dei ritratti eseguiti da Mantegna, fin dal suo distacco
dallo Squarcione egli godette di grandi elogi da parte dei
committenti. Un umanista ungherese, Giano Pannonio, gli dedicò
un’ode per l’abilità e la possanza che il pittore aveva saputo
esprimere nel ritrarlo insieme all’amico Galeotto da Narni.
Mantegna nella sua lunga carriera dipinse, disegnò, scolpì e
perfino modellò in cotto e in metalli preziosi un gran numero di
ritratti. Fra tanti volti ne abbiamo scelti cinque di una potenza
notevole. Il segno è pulito e deciso, essenziale. La positura e
l’espressione di ogni personaggio denunciano subito il carattere del
modello.
Nella
faccia
barbuta
del
duca
Francesco
II
scorgiamo
immediatamente l’atteggiamento del famoso condottiero che vuol
porre chiaro a chi lo osserva un’immagine di forza e
determinazione. Ne sortisce una figura d’uomo pago di sè,
piuttosto pomposo.
Per seconda figura abbiamo scelto il ritratto di un uomo
dall’aspetto nobile che molti ricercatori pensano sia opera del
cognato di Mantegna, il Giambellino. Spesso i due maestri
copiavano uno dall’altro scambiandosi idee e pure i soggetti. Ad
ogni modo anche qui ci troviamo davanti a un ritratto disegnato
con gran maestria. Non ci sono effetti d’ombre proprie e proiettate
o sguardi a collo torto per comunicare un movimento risoluto, alla
72
Michelangelo. E nemmeno qui Mantegna si vale del suo botto
sempre vincente: lo scorcio. Il volto è visto di quarto, in
atteggiamento del tutto naturale. Nessuno si è messo in posa,
eppure quelle teste esprimono alti valori e un gran senso di
profonda dignità.
La terza immagine che vi proponiamo è uno stupendo ritratto,
pulito, dal segno ancora deciso e senza ripensamenti. Lo sguardo
del modello è intenso e limpido come di chi è abituato a guardare
orizzonti aperti. Potrebbe essere il ritratto di un uomo di mare.
Vento salato e sole sulla faccia, sbruffi di mareggiata e schiaffi di
sale sul viso l’hanno segnato. I capelli sono ancora folti e arricciati.
La testa poggia su un collo ritto e possente. Più lo osservo e più mi
convinco: l’uomo potrebbe essere stato un capitano di mare.
Caboto per esempio o lo stesso scopritore delle Americhe.
A seguire vediamo il Ritratto di uomo con berretto nero. È un
anziano signore dall’aria stanca, assente, senza vigore, con gli
occhi appesantiti da grandi borse. Il disegno è meno perentorio del
precedente, ma straordinariamente intenso, quasi il tratto volesse
seguire il malinconico atteggiamento del vecchio. Potremmo
definirlo un mercante di buona cultura.
Mi fa pensare a uno dei due personaggi della Venesiana,
commedia dei primi anni del Cinquecento, dove due uomini
d’affari, entrambi ormai in là con l’età, si dicono incapaci
73
d’accettare che le rispettive figlie si congiungano durante il
carnevale con due giovani gaglioffi, uno studente e un
sottoufficiale. Alla fine, pur di evitare che la più preziosa proprietà
di famiglia, appunto la verginità delle due figliole, venga goduta
gratis da gente indegna, oltretutto senza produrre vantaggio alcuno,
decidono di sostituirsi ai due intrusi, travestendosi con i loro
costumi, e di scambiarsi le figlie per godersele di persona. È quasi
un incesto, ma importante è che la “robba” resti nella casa.
Per finire abbiamo scelto forse il più bel ritratto fra i cinque
proposti. È chiamato genericamente Ritratto d’uomo, ma del
personaggio possediamo anche un dipinto che molto gli assomiglia
e che è indicato come Ritratto di senatore veneziano firmato da
Francesco Bonsignori, coetaneo o quasi di Mantegna. Se
confrontiamo le due opere notiamo subito una gran differenza di
forza e stile, a tutto vantaggio del disegno. Il dipinto è opera di un
dignitoso pittore che riproduce il viso del modello con buon
mestiere. L’esecutore del disegno, con tutta probabilità Mantegna,
è un artista a dir poco eccelso. Si nota subito che questo secondo
maestro concepisce il ritratto nella sua totalità, non per particolari.
Ma quando giunge ad analizzare occhi, orecchie, naso va in
profondo. Nello stesso tempo sottolinea con leggerezza ogni
passaggio. Si ha l’impressione che la figura disegnata respiri,
74
l’altra, il ritratto su tela, sembra un’immagine incollata su un fondo
nero.
I monocromi
Sulla monografia edita da Rizzoli e dedicata ad Andrea Mantegna
ho trovato una curiosa notizia che riguarda un cartone del pittore
padovano. Il disegno è dedicato a Giuditta e Oloferne
(Washington, National Gallery) e nel catalogo del proprietario,
nientemeno che Carlo I d’Inghilterra, veniva attribuito a Raffaello.
Solo molto più tardi, nel Novecento, Berenson e altri scoprirono
che si trattava di un’opera di Mantegna.
A mia volta devo ammettere che osservando un disegno dedicato a
tre divinità del mondo ellenico, Marte in bella posa fra Venere e
Diana, ho pensato subito si trattasse di un bozzetto del maestro di
Urbino. L’agilità con cui è eseguito quel tratto a penna è davvero
sconvolgente. Le immagini, quella maschile e le due femminili, si
ergono uscendo dal bruno di fondo grazie alla proiezione della luce
che segna i volumi. Marte è seduto nel centro e si appoggia con un
braccio a una gamba ripiegata mentre l’altra si allunga in avanti in
contrappunto al braccio sollevato. È il dio della guerra che
75
trasmette il ritmo del movimento alle altre due figure, Venere e
Diana, come in una sequenza musicale che si trasforma in danza.
Se pensiamo che queste straordinarie immagini grafiche sono state
concepite verso il finire del Quattrocento, cioè quando Raffaello
era appena venuto al mondo, ci vien facile riconoscere che
Mantegna è stato veramente uno dei precursori più alti del
Rinascimento.
Un altro disegno, datato 1491, sempre su fondo scuro, illuminato
di taglio, che ci fa pensare ai grandi pittori del Cinquecento pieno,
è quello che vede Giuditta ritratta quasi di schiena (Firenze, Uffizi)
che aiutata dalla sua vecchia nutrice affonda la testa mozza di
Oloferne in un sacco. Non s’è mai vista nessuna donna riuscire con
tanta grazia a staccar teste e infilarle in una sporta con
atteggiamento di normale menage femminile, come si trovasse in
un mercato di frutta e verdure, compiaciuta dal buon acquisto di
un’anguria o un melone maturo. È proprio il caso di commentare:
“Per una donna così delicata si può pur perder la testa!”.
Le fatiche di Ercole
Fra i disegni più famosi di Mantegna, spesso riprodotti dai suoi
allievi e stampati in gran numero, ci sono Le fatiche di Ercole,
76
episodio che ripropone un antico parallelismo in uso nel mondo
cristiano per indicare allegoricamente la potenza di Cristo. In
particolare lo smascellare le fauci del leone allude al gesto del
Salvatore che sceso all’Inferno spalanca la bocca della discarica
infuocata, liberando le anime condannate per il peccato originale.
Ancora quest’immagine allude alla Fortezza, una delle virtù
cardinali, rappresentata in tutto il Medioevo. Nel mondo greco
Ercole è il semidio della vita attiva in opposizione a quella
contemplativa.
Qui fra l’altro si allude ad Ercole I d’Este, padre di Isabella, duca
di Ferrara, volitivo e concreto.
Spesso la scelta di rappresentare scene mitologiche era un
escamotage per poter raffigurare uomini e donne finalmente liberi
da indumenti e censure puritane. La stessa scena della lotta con il
leone Nemeo venne affrontata anche da altri artisti del
Rinascimento, Donatello, Pollaiolo, Michelangelo e Giulio
Romano.
Ercole lotta con il gigante Anteo, figlio di Nettuno e della terra.
Come riesce a posare i piedi al suolo la forza di Anteo si moltiplica
a dismisura, perciò Ercole si preoccupa di sollevarlo di peso,
tenendolo lontano dal suolo e avvolgendolo con entrambe le mani
fino a soffocarlo. Ma sempre è necessario cercare in ogni opera di
Mantegna il contrappunto satirico che qui rasenta la voluta
77
scurrilità. In tutte le rappresentazioni di questo tema il gigante
sollevato da Ercole è tratto a sè dal forzuto semidio con l’intento di
umiliarlo sopra ogni misura. Sembra proprio intenzionato a
sodomizzare il suo rivale per cancellarne ogni dignità e segno
virile. Il fallo del figlio di Giove è messo sempre in bell’evidenza
nei pressi delle natiche del contendente. Naturalmente in fase di
palese riposo. Scurrili sì ma c’è sempre un limite. È questione di
stile, un po’ di decenza perdio!
La flagellazione
La flagellazione del maestro padovano ci riporta subito a quella di
Piero della Francesca. Anche in questo disegno preparatorio per un
dipinto, sulla destra vediamo una coppia di soldati che discutono
fra di loro. Sul fondo un porticato senza tettoia, un elemento da
scena teatrale. Ai lati di Cristo legato alla colonna, due energumeni
lo battono con ferocia. Ma mentre in Piero della Francesca i
personaggi in primo piano sembrano disinteressarsi completamente
del supplizio e discutono di problemi del tutto personali, nel suo
bozzetto preparatorio Mantegna ci rappresenta i due militari
partecipi della drammaticità. Salvo per il personaggio che sta
seduto contro la cornice di sinistra, dall’espressione assente, tutti
78
gli altri agiscono frenetici dentro una prospettiva a punto di fuga
centrale piuttosto esasperato. Il declivio scosceso e la copertura del
porticato fortemente rastremato concorrono a imporre l’attenzione
sulla figura di Cristo, collocandola in grande evidenza. In questo
caso è la macchina scenica a determinare la situazione tragica.
Ma anche cancellando per intiero le linee di fuga e di piano,
eliminando i battitori e gli sbirri, un pittore della forza di
Mantegna, servendosi di pochi segni, è in grado di produrre
un’opera d’arte davvero eccelsa. Ce lo dimostra l’abbozzo del
Cristo alla colonna, rappresentato in due posizioni, quasi
conseguenti. Anche nel caso di questo disegno alcuni studiosi
discutono se sia opera di Mantegna o di Giovanni Bellini. Ma
evidentemente fra i due era nata ormai una simbiosi espressiva
straordinaria. Se si pensa poi che al tempo in cui furono eseguiti
questo e altri numerosi schizzi entrambi i pittori avevano circa
trent’anni, c’è davvero di che fare gran meraviglia!
Il Cristo risorto
Leonardo da Vinci diceva in uno dei suoi appunti: “Spesso bisogna
impiegare il minimo per ottenere il massimo. Il minimo dei gesti a
cominciare dall’impianto geometrico ridotto all’essenziale. Non
79
abusare degli effetti d’ombra in modo che la luce abbracci tutta la
scena”.
È proprio il caso di questa Resurrezione di Cristo. Il Salvatore è
appena risorto e sta in piedi appoggiato all’asta che issa una
striminzita bandiera. Con l’altra mano accenna una benedizione. È
ancora stordito dalla luce. Tiene la testa reclina. Le due figure che
lo accompagnano sono personaggi anacronistici: due santi che
nulla hanno in comune con la resurrezione, ma che sostengono ed
equilibrano il sorgere di Cristo dalla sua tomba. Il disegno è fra i
più essenziali che sia dato di vedere: è proprio quella povertà di
segni e di gesti che lo rende magico.
La deposizione nella tomba vista di scorcio
Prima di Mantegna nessun pittore aveva pensato a una simile
positura. Cristo calato nella fossa è visto dal basso e di piedi. Due
seguaci lo reggono, Cristo è avvolto nel telo, entrambi i discepoli
tirano a sè il lenzuolo per rallentarne la discesa. La Madonna sta
nel centro tutta protesa verso il figlio. Non è solo un’originale
inquadratura, ma quel taglio di sguincio produce una potente
suggestione.
80
Quello di cui parliamo è solo uno schizzo. Della Deposizione
finale possediamo disegni diversi, e copie di suoi discepoli, tutte
rappresentazioni molto potenti, ma nessuna si avvicina alla
drammaticità di quel semplice schizzo.
I disegni e le incisioni che ci sono pervenuti sono carichi di effetti:
rocce che s’aprono nel centro del dipinto scoprendo una caverna,
alberi contorti, nubi che solcano minacciose il cielo, la Madonna
svenuta vicino al sepolcro sorretta da altre donne... tutto
suggestivo, di grande teatralità. Ma la sintesi essenziale del primo
schizzo dimostra la verità del consiglio di Leonardo: “Spesso
bisogna impiegare il minimo per ottenere il massimo”.
La Pietà con Cristo trattenuto dalla Madonna
e due discepoli
Il corpo di Cristo è visto di fronte seduto, inerte sul soglio del
sepolcro. Il segno corre veloce, descrivendo i gesti essenziali. Sono
accennate teste, mani e braccia ma non per intiero, i particolari
sono quasi volutamente tralasciati eppure il clima tragico risulta
altissimo.
81
Sempre restando nella serie dei disegni “ex tempore” – abbozzi
estemporanei – presentiamo due lavori che si ritrovano sullo stesso
foglio. L’uno è uno studio di Cristo morto in varie posizioni, di cui
quello centrale rappresenta Gesù visto di scorcio. L’altra immagine
descrive la Madonna, o la Maddalena, in ginocchio, forse protesa
verso il corpo di Gesù, vista tanto di fronte che di schiena.
Entrambe esprimono la magia di una incredibile rapidità del segno.
Il pittore, per riuscire a raggiungere una grazia tanto limpida, deve
aver acquisito nell’esercizio grafico una memoria visiva del corpo
umano e dei suoi gesti veramente straordinaria.
Il grande suonatore di liuto o di violino nel produrre un concerto
non si avvale di partitura e non ha nemmeno bisogno di osservare e
controllare i propri movimenti. Spesso i grandi maestri chiudono
addirittura gli occhi, ogni gesto è pura espressione del pensiero.
Essi suonano per immagini. Lo stesso accade per pittori a livello di
Mantegna, Raffaello e Leonardo: di sicuro potevano disegnare a
occhi chiusi, anzi bendati e nessuno si sarebbe accorto del
prodigio.
La Madonna col Bambino
(Madonna della Vittoria)
82
Della Madonna col Bambino del Louvre esistono un dipinto e
un’incisione a punta secca con carta preparata su fondo azzurro
scuro poi lumeggiata. Questo è il disegno preparatorio del quadro
ed è di una bellezza sconvolgente. Il bambino sta all’impiedi in
equilibrio e appoggia i piedi su una gamba della Vergine. La
Madonna lo trattiene ritto quasi per misurarne la forza. Ancora una
volta la figura disegnata fa pensare a Raffaello e a Leonardo. La
posa quasi prassitelica con cui si atteggia Gesù contrasta
fortemente con l’espressione malinconica del suo viso. È la stessa
situazione che ritroviamo nel Battistero degli Ariani di Ravenna,
dove il Figlio di Dio è rappresentato giovane, all’impiedi,
completamente nudo con le gambe immerse nell’acqua mentre
riceve il battesimo da Giovanni. Identica è la sua malinconia.
L’introduzione del culto di Cibele a Roma
Questo è forse uno degli ultimi dipinti di Mantegna. Infatti viene
collocato come esecuzione da molti studiosi tra il 1504 e il 1505,
circa un anno prima della sua morte.
Il committente dell’opera è indicato con il nome di Francesco
Cornaro, probabilmente della stessa famiglia di Alvise che nella
83
parte iniziale del xvi secolo fu lo scopritore del Ruzzante e suo
mecenate.
Sembra quasi il progetto per un grande bassorilievo, dove si
racconta l’arrivo a Roma di un busto di donna. Si tratta di
un’immagine di Cibele, dea della Terra. Portatori sorreggono con
fatica il baldacchino sul quale vediamo l’effigie della dea, che pare
scivolare sull’acqua come una barca. In ginocchio davanti a lei c’è
una donna e dietro un giovane dall’aria possente, seguito dalla sua
corte. Si tratta di Cornelio Scipione, al quale un oracolo ha
ordinato di rintracciare il busto a Pergamo e portarlo nell’Urbe:
“Solo così riuscirai a battere l’armata cartaginese”. La giovane
inginocchiata è Claudia Quinta, indicata dalla pubblica opinione
come una vanesia peccatrice. Ma a questo punto è il caso di
offrirvi il racconto di Ovidio (Fasti, libro iv) al quale Mantegna si è
ispirato.
“La nave che porta la statua aveva toccato la foce [Ostia] dove il
Tevere si disperde nell’alto mare e scorre in uno spazio più libero:
tutti i cavalieri e i seri senatori mischiati insieme alla plebe le
vanno incontro alla foce del fiume toscano. Procedono accanto le
madri, le figlie e le nuore, e le vergini che tutelano i sacri fuochi.
Gli uomini affaticano le attive braccia con il tiro alla fune: la nave
avanza a stento nella corrente contraria. La terra era secca da
tempo, l’erba era bruciata dalla sete: la nave resiste incagliata nel
84
guado fangoso. Ognuno partecipa allo sforzo, e si affatica quanto
può, e aiuta le mani forti con le grida: la nave sta ferma in mezzo
all’acqua come se fosse un’isola. Sbalorditi di fronte al fenomeno
gli uomini si fermano e si impauriscono. Claudia Quinta
discendeva dalla stirpe dell’antico Clauso (e il suo aspetto non era
da meno in quanto a nobiltà), virtuosa essa passava per non
esserlo: voci ingiuste, accuse infondate, avevano attaccato la sua
reputazione,
il
suo
abbigliamento,
l’eleganza
delle
sue
acconciature le avevano fatto torto e, secondo i vecchi severi, la
sua lingua era troppo pronta.
Consapevole della propria rettitudine se la rise delle menzogne che
si dicevano in giro, e tuttavia noi altri siamo gente facile a credere
nel male. Come quella si avanza dal gruppo delle caste matrone, e
raccoglie con le mani l’acqua pura del fiume, e per tre volte si
bagna il capo, tre volte alza le mani al cielo (tutti quelli che
guardano pensano che sia impazzita), e inginocchiata fissa il volto
nell’immagine della dea, e sciolti i capelli dice queste parole:
“Alma e feconda Madre degli Dei, accogli la preghiera di questa
tua supplice in una condizione sicura. Si nega che io sia casta: se tu
mi condanni, affermerò che l’ho meritato; pagherò con la morte la
colpa, per giudizio divino; se invece la colpa è assente, tu darai con
un gesto la prova della mia purezza, e casta, tu seguirai mani
caste!”. Ciò detto, ella senza grande sforzo tira la corda; dirò una
85
cosa che fa stupire, eppure attestata anche in teatro: la dea si avvia,
segue la donna che la guida e, seguendola, la giustifica. Un
clamore che esprime la gioia sale fino agli astri”. Il disegno
colorato rappresenta con rigore l’episodio: tutti i presenti sono
stupiti e commossi, ma Mantegna non poteva chiudere senza un
contrappunto. Infatti al termine della processione pone un giullare
che batte sul tamburo e soffia sul flauto a giocondo commento.
Cristo “in scurto” (Cristo morto)
Scurto significa “di scorcio”, o meglio, visto di scorcio.
Questa figura di Cristo morto steso sulla pietra funebre è uno dei
capolavori giustamente più conosciuti della pittura di Mantegna.
Insieme alla scenografia e alla cosiddetta “fuga architettonica delle
scene” lo studio dello scorcio fu il maggior impegno dell’excelso
pintor paduano. Questa tecnica viene chiamata anche legger di
sguincio. Ma spesso i dipinti realizzati applicando questa scienza
vengono letti solo per l’artificio che producono, la meraviglia
dell’illusione, il trompe-d’oeil. Mantegna ha eseguito decine di
dipinti con figure in scorcio di fattura perfetta, a cominciare dai tre
apostoli sdraiati sul piano roccioso, addormentati mentre Gesù
prega nell’orto del Getsemani, fino al satiro ubriaco portato in
86
braccio dai suoi compagni di sbronza, gli studi per la Deposizione,
l’uomo giacente su una lastra di pietra, la Madonna sdraiata ai
piedi della tomba.
Ma nel concepire il progetto del Cristo morto, Mantegna come tutti
i grandi pittori del suo tempo, vedi Leonardo, Michelangelo,
Giorgione, non applica con rigore geometrico le regole dello
scorcio. In questo dipinto si percepiscono varianti del tutto
arbitrarie ma di grande effetto. Se osservate con molta attenzione il
dipinto a scorcio, vi renderete conto che i piedi del Cristo non sono
a giusta misura, ma più piccoli di quanto lo sguincio imporrebbe.
Al contrario, la testa appare più grande di quanto sarebbe logico.
È un errore? Personalmente per mezzo del computer ho rimontato
il dipinto inserendo le giuste misure dettate dalle regole
prospettico-convenzionali. Ebbene, all’istante la figura diventa
normale ma la drammaticità dell’immagine, l’angoscia che
comunica quella sequenza paradossale degli arti fuori regola
svanisce. In poche parole, in quel Cristo ucciso l’errore diventa il
catalizzatore essenziale e insostituibile del dramma visuale.
La vecchiaia di Mantegna
87
Gli ultimi anni della vita di Mantegna non furono quelli di una
vecchiaia felice.
La splendida moglie Nicolosia, sorella del Giambellino, era morta
da molti anni. Per quella sua compagna portava un amore tenero e
insostituibile. La ricordava spesso. Quella scomparsa lasciò nel
pittore un vuoto incolmabile.
Mantegna a Mantova s’era fatto costruire una bellissima casa – che
esiste ancora ed è stata da poco restaurata – con molte stanze, un
quadriportico interno e intorno un ampio giardino. Il progetto
l’aveva disegnato di suo pugno. Sul lato sud aveva acquistato un
podere, uno spazio che gli permettesse una larga visuale e nulla
che proiettasse ombre sulle finestre dello studio.
È lì, in quella stanza, che aveva dipinto le opere più importanti,
come il “Cristo di scurcio” che si tenne per sè in quella stessa
“camara” fino alla sua morte insieme al grande disegno con il
busto di Cibele che sbarca a Roma.
Per tutto il palazzo erano sparsi reperti archeologici di grande
valore raccolti in anni e anni. Fra questi il preziosissimo busto
romano di Fausta che Mantegna in grave difficoltà finanziaria fu
costretto a vendere alla duchessa Isabella proprio qualche anno
prima di andarsene. Infatti in quel tempo il pittore se la stava
passando proprio male, anche fisicamente.
88
Ma come poteva esser giunto a tanta difficoltà finanziaria? Fra
l’altro Andrea continuava a produrre opere di grande valore, specie
per il Gonzaga che però evidentemente era, come si dice ancora a
Mantova, di braccio corto riguardo i propri debiti. Fatto sta che da
tempo Mantegna non vedeva un quattrino. Ne fa testimonianza una
lettera di Isabella recapitata d’urgenza al duca suo marito che
testualmente così gli comunicava: “Voglio sollecitare una
attenzione particolare per il nostro Andrea pittore che si truova in
malo stato, campando in ristrettezza. Sarebbe d’uopo che voi gli
andassi in aiuto con qualche elargizione, poiché se non lo facessi
c’è pericolo che più non lo trovassi vivo e la dipintura (allude alle
ultime tele dei Trionfi), che per vostro vanto et piacere bene
sarebbe fuesse a compimento, puotria restare encompiuta con
vostro forte disdoro e danno”.
Insomma, non per correttezza e senso umano bisognerebbe correre
in aiuto al malpagato Mantegna, ma solo per interesse! Un’opera
incompiuta vale molto meno sul mercato di una terminata.
Infatti un secolo appresso (1627) Carlo I Gonzaga-Nevers,
trovandosi completamente rovinato dallo sperperare denari e terre
a volontà, costretto a vendere l’intiera sequenza delle tele
glorificanti Cesare e il suo trionfo a Carlo I d’Inghilterra, chiese
una cifra a dir poco mastodontica e la ottenne quasi per intiero. Nel
portarsi via il “bottino” il suddito inglese incaricato al trasporto,
89
preoccupato che il Gonzaga ci potesse ripensare e buttasse all’aria
il contratto, pur di fare in fretta staccò di netto le pitture dai telai,
tagliando lunghe strisce dei dipinti specie nella parte bassa, così
che d’ogni sequenza segò i piedi ai personaggi, ai cavalli e perfino
agli elefanti.
C’è di che essere certi: il pittore nella sua tomba alla vista di quello
scempio avrà eseguito senz’altro un vero e proprio salto mortale
con tanto di bestemmia apocalittica.
A proposito di tomba, Mantegna sborsò parecchi scudi d’oro per
comprarsi lo spazio in cattedrale dove allestire un sepolcro per sè e
per la sua famiglia: addirittura una cappella, privilegio che si
potevano permettere solo mercanti facoltosi e nobili in ottime
condizioni finanziarie. Quel volersi collocare fra i maggiori della
città non era certo dettato dall’ansia di glorificare la memoria di sè,
quanto piuttosto di dare a figli e nipoti una discendenza degna: una
tomba pomposa è meglio di un sontuoso palazzo.
Mantegna non era stato molto fortunato con i suoi eredi. Tanto per
cominciare fra figlie e figli in pochi anni ne perse più della metà.
Inoltre soprattutto i due maschi non facevano che creargli
dispiaceri. Il maggiore in particolare, Ludovico, era rissoso, pieno
di sè, pettegolo e maldicente, specie con i cortigiani dei Gonzaga.
La misura straripò quando tentò di infangare la credibilità del
marchese stesso, del quale era cameriere, insinuando che se la
90
facesse con una setta di eretici. Francesco Gonzaga lo cacciò su
due piedi. Il padre Andrea si umiliò, buttandosi in ginocchio ai
piedi di Isabella e piangendo disperato. La marchesa si commosse
e intercedette presso il marito perché perdonasse lo scellerato. Non
ci fu niente da fare, nonostante Isabella avesse messo in campo
tutta la sua autorità e passione: “Attento Francesco, Andrea è in
mala salute. Un colpo così lo può uccidere”, insistette. “Vada in
malora lui e tutta la sua famiglia”, fu più o meno la risposta del
marito.
Mantegna, pur al limite delle forze, continuava a dipingere. Nel
suo studio si susseguivano visitatori illustri. Era l’unico suo
conforto. In quel tempo aveva iniziato a preparare i cartoni per gli
affreschi della sua tomba. Con sè aveva un figlio, discreto pittore, e
alcuni allievi fra i quali molto probabilmente un giovane di nome
Antonio Allegri, detto il Correggio.
C’è di che chiedersi: era buon maestro Mantegna? Potrebbe qui
rispondere di sua voce Leonardo: “Non necessita tener concione
agli allievi e agli aiuti che ti sono appresso. Basta mostrar loro il
tuo mestiere, le cose che ti vengono facili e l’altre dove ti scopri
affaticato e in difficoltà. Chi di loro ha occhio curioso e doti
acconce impara, l’altri restano allocchi come pria”.
91
Abbiamo già visto che fin da quando, ancora ragazzino, Mantegna
viveva nella bottega dello Squarcione, i suoi maestri e la sua
ossessione furono gli antichi. Li copiava, li riproduceva anche in
cotto e in pietra, ma si salvò dal divenirne schiavo proprio facendo
diventare quei bassorilievi e i dipinti oggetti della quotidianità. In
poche parole, non li ritenne sacri, non ne rispettò i moduli nè tanto
meno gli “ordini”. Se ne serviva ma con distacco, facendone il
pretesto per un gioco.
È lo stesso atteggiamento che avevano gli autori e i comici del
nuovo teatro italiano del Rinascimento, il Calmo, Machiavelli, il
Bibbiena, Della Porta e primo fra tutti Angelo Beolco, detto il
Ruzzante. Costoro si servivano dei classici, da Aristofane a Plauto
e Terenzio, ma ne trasportavano le varie situazioni ai giorni nostri,
li rivestivano di una straordinaria attualità. Il linguaggio usato era
il volgare della strada; del tempo reale erano anche i costumi, gli
oggetti e gli eventi storici, nonché i personaggi con il ruolo di
protagonisti, maschi e femmine. I signori e le signore coinvolte ne
erano lusingati ma il più delle volte indispettiti, se non addirittura
indignati. Non era di certo piacevole scoprirsi ritratti nel ruolo di
truffatore o ruffiano, e per quanto riguarda le signore vedersi
trasformate in femmine di ambigua moralità.
In ogni commedia, dell’Aretino o di Giordano Bruno, così come
nelle tele di Mantegna, Leonardo e Michelangelo, si alludeva a un
92
nuovo modo di pensare, di leggere il creato, a cominciare dalla
sistemazione degli astri nella volta celeste. Si rasentava spesso
l’eresia, si mettevano alla berlina principi e papi, inquisitori e
imbonitori da strapazzo, sia della politica che della fede.
Arricchirsi di scienza e conoscenza era allora un dovere e una
necessità. Non si poteva rimanere indietro nella cavalcata frenetica
del sapere, occorreva scoprire, sperimentare, produrre. Il presente
era già passato. Perfino il futuro in ogni attimo stava già passando.
Per ragioni difficili da stabilire, in quel cerchio che raccoglie
Padova e Venezia, Verona e Mantova con Ferrara si era creato una
specie di crogiolo dell’Umanesimo. Redigere il numero e le qualità
dei maestri che vi dimorarono o vi transitarono è un’operazione
impossibile. Nell’Università di Ferrara vennero a studiare
scienziati del livello di Keplero, si fermò in cerca di rifugio, in
quanto perseguitato, Rabelais, che di certo visitò anche Mantova.
Mantegna, da ragazzino analfabeta qual era al suo esordio a
Padova, come una spugna assorbì tutto il sapere possibile che gli
galleggiava intorno, come stesse dentro un acquario: a bocca
spalancata e occhi stupiti ingoiava immagini, espressioni, dottrine,
follie con una avidità da eterno affamato.
Pur così incostante e neghittoso non si lasciava sfuggire chiunque
gli potesse comunicare qualsiasi nuovo concetto o sapere.
93
Il suo grande maestro, che con Donatello gli squarciò il mondo
dello spazio iscritto nella geometria strutturale, fu senz’altro Leon
Battista Alberti, architetto, letterato e filosofo. Fu lui a leggergli
per primo le Metamorfosi di Ovidio e i dialoghi di Luciano di
Samosata, dai quali abbiamo visto Mantegna trasse grande
ispirazione. E soprattutto il doppio segno della dialettica, cioè la
coscienza che nulla è definitivo e assoluto. Ogni regola ha il suo
contrario, sotto il tragico sta sempre nascosto il grottesco: è la
violenza del dubbio che lo fa emergere. Perciò vedrete spesso nei
dipinti di Mantegna, di fianco alla malinconia o nel piano più
profondo del dolore, spuntare una coppia di conigli che si
rincorrono e appresso un piccolo cane sperduto, laggiù tagliatori di
pietra che battono con la mazza sulla roccia, un impiccato appeso a
un pergolato, due innamorati che si baciano tra le fronde, nel cielo
una nuvola trasformata in un volto, una donna affacciata alla
finestra, un ragazzino appoggiato al muro, un corvo in equilibrio su
un lungo palo, un pavone che si sporge dall’oculo della volta e
bimbi che spuntano da ogni dove.
Attenti, non sono appunti decorativi: sono il mondo.
94