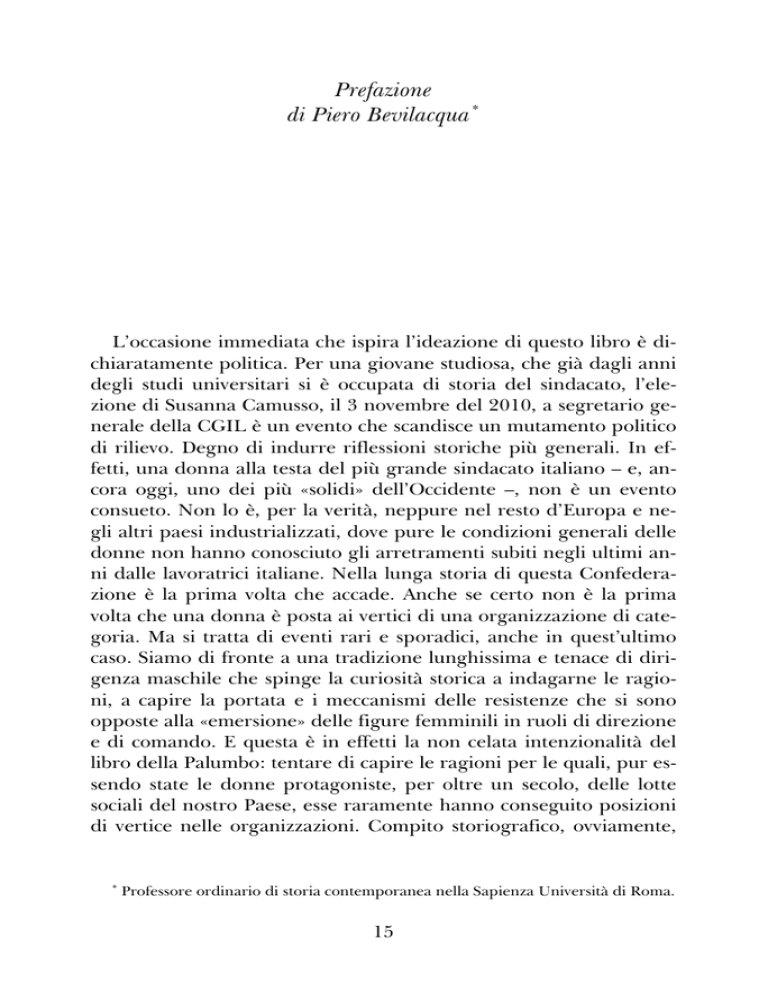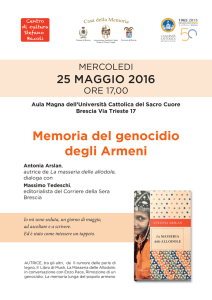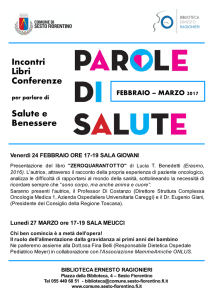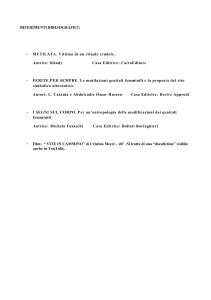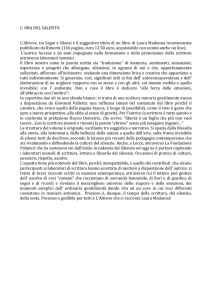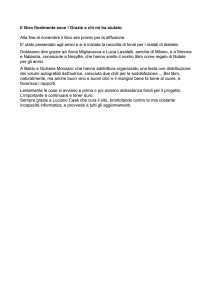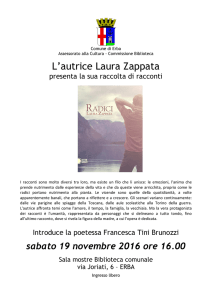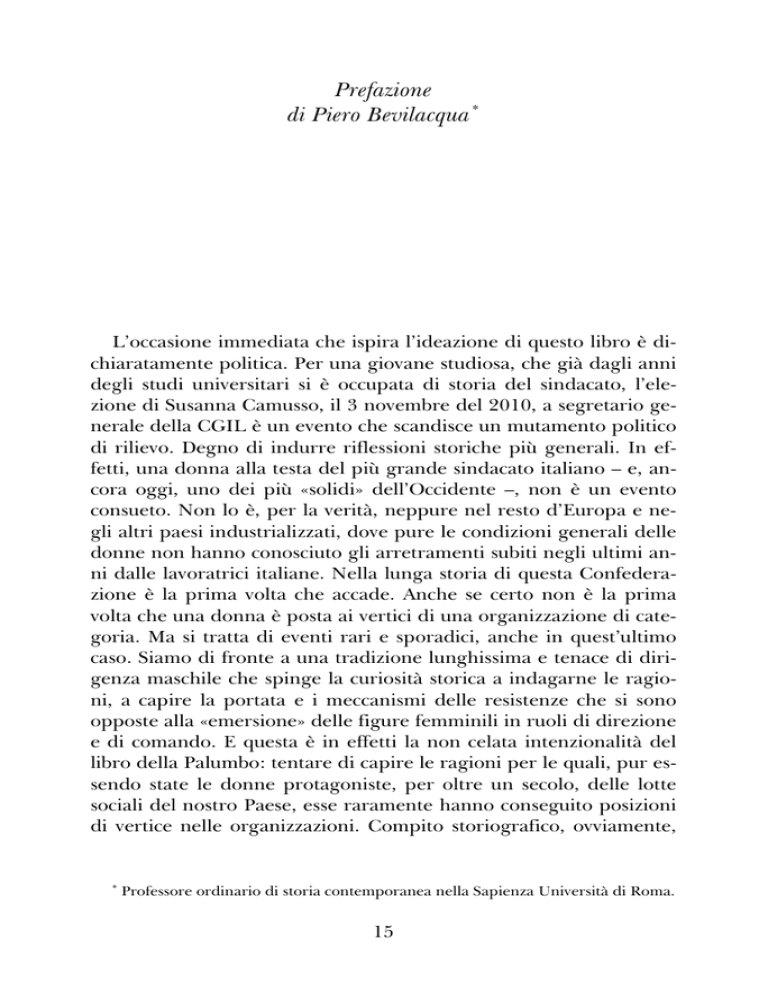
Prefazione
di Piero Bevilacqua *
L’occasione immediata che ispira l’ideazione di questo libro è dichiaratamente politica. Per una giovane studiosa, che già dagli anni
degli studi universitari si è occupata di storia del sindacato, l’elezione di Susanna Camusso, il 3 novembre del 2010, a segretario generale della CGIL è un evento che scandisce un mutamento politico
di rilievo. Degno di indurre riflessioni storiche più generali. In effetti, una donna alla testa del più grande sindacato italiano – e, ancora oggi, uno dei più «solidi» dell’Occidente –, non è un evento
consueto. Non lo è, per la verità, neppure nel resto d’Europa e negli altri paesi industrializzati, dove pure le condizioni generali delle
donne non hanno conosciuto gli arretramenti subiti negli ultimi anni dalle lavoratrici italiane. Nella lunga storia di questa Confederazione è la prima volta che accade. Anche se certo non è la prima
volta che una donna è posta ai vertici di una organizzazione di categoria. Ma si tratta di eventi rari e sporadici, anche in quest’ultimo
caso. Siamo di fronte a una tradizione lunghissima e tenace di dirigenza maschile che spinge la curiosità storica a indagarne le ragioni, a capire la portata e i meccanismi delle resistenze che si sono
opposte alla «emersione» delle figure femminili in ruoli di direzione
e di comando. E questa è in effetti la non celata intenzionalità del
libro della Palumbo: tentare di capire le ragioni per le quali, pur essendo state le donne protagoniste, per oltre un secolo, delle lotte
sociali del nostro Paese, esse raramente hanno conseguito posizioni
di vertice nelle organizzazioni. Compito storiografico, ovviamente,
*
Professore ordinario di storia contemporanea nella Sapienza Università di Roma.
15
assai arduo: come voler cercare di spiegare, in un semplice saggio,
le ragioni storiche dell’asservimento secolare delle donne al potere
maschile. Benché la Palumbo non manchi di individuare alcuni importanti ostacoli giuridici e culturali che hanno sbarrato la strada
all’emancipazione femminile in tale ambito: dalle norme del Codice
civile del 1865, che contrastavano la partecipazione delle donne alle
Società di mutuo soccorso, ai pregiudizi maschili attivi anche dentro
lo stesso movimento sindacale e socialista. D’altra parte, un contributo di conoscenza, pur limitato e circostanziato, può venire dalla ricostruzione delle vicende e dei processi che hanno portato, in alcuni
felici casi, all’ascesa delle figure femminili in ruoli di dirigenza nazionale. Una impostazione di ricerca che equivale al rovesciamento
di una tradizione vittimistica e celebrativa a lungo presente, se non
dominante, nella storia delle donne lavoratrici. «Il topos storicamente rilevante – ricorda con una punta di giustificata polemica la Palumbo – circa la presenza femminile nel movimento dei lavoratori è
quello della vittima». Le donne diventano visibili e storicamente rilevanti quando vengono uccise. Per la verità tale atteggiamento è stato in gran parte corretto dalla recente ricerca storica, mentre in effetti poco studiati sono ancora i processi che portano non alla sconfitta, ma al successo delle donne e alla loro ascesa ai posti di comando.
Ed è quanto si è proposta di realizzare l’autrice, selezionando con
buon senso e realismo storiografico la vicenda di quattro figure di
donne dirigenti del sindacalismo italiano, in quattro fasi storiche ben
distinte. Fasi che scandiscono un secolo di lotte sociali e di storia del
nostro Paese. Mentre le quattro figure corrispondono a personalità
di rilievo che hanno lasciato un segno non uguale né uniforme nell’immaginario politico nazionale, ma che hanno segnato comunque
pagine non comuni di impegno e di realizzazioni: Argentina Altobelli, Regina Terruzzi, Mina Biagini e Donatella Turtura.
Il lettore troverà nel testo abbondanza di documentazione per
scoprire o riscoprire il profilo di queste donne d’eccezione. Tanto
più che esse non sono mai separate – nella ricostruzione della Palumbo – dalle vicende davvero epiche delle lotte sociali del Novecento di cui l’Italia è stata protagonista, non poche volte in forme
drammatiche. L’autrice, infatti, che ha ricostruito le vicende delle
sue eroine nel contesto della propria epoca, ha potuto utilizzare una
storiografia ormai vastissima sulle condizioni delle campagne italiane in età contemporanea. Terreno in cui la ricerca storica italiana
16
può oggi vantare una ricchezza e maturità di risultati che la pongono ai primi posti nel mondo in questo ambito scientifico e culturale.
Non è possibile qui accennare ai tanti aspetti delle vicende narrate
in questo libro per introdurre il lettore al mondo esplorato dall’autrice. Anche se si è tentati dal desiderio di mostrare immediatamente, soprattutto ai lettori giovani, che hanno poche informazioni sulle
condizioni sociali e di lavoro nelle nostre campagne, quali fossero le
forme di sfruttamento praticate poco più di un secolo fa. Non può
che fare impressione, ad esempio, scoprire quanto lunga fosse la
giornata di lavoro delle donne braccianti. Si pensi alle informazioni
indirette che fornivano due grandi dirigenti socialisti, Ivanoe Bonomi e Carlo Vezzani, su la «Critica sociale» del 1901: «I socialisti si occuparono di queste donne e le unirono in Lega; così hanno ottenuto
un orario molto più breve di quello di prima, che era dalla levata del
sole al tramonto. Ora è dalle 6 ant.(elucane) alle 5 pom.(eri-diane)».
Vale a dire una conquista sindacale che portava la giornata lavorativa
delle donne a 11 ore, mentre prima si aggirava intorno alle 13-14!
Un orario che a lungo è stato la norma in tutte le campagne italiane.
Ancora nel secondo dopoguerra, le braccianti del Sud dicevano di lavorare «dalle stelle del mattino alle stelle della sera».
Ma certo non posso non soffermarmi sulla figura di Argentina Altobelli, a cui l’autrice ha dedicato una ricerca appassionata, utilizzando un’ampia gamma di fonti e che certo non è oggi la figura
popolare che meriterebbe di essere nella memoria nazionale. Argentina Altobelli diventa segretaria della Federterra il 2 aprile del
1904 «in un momento – ricorda l’autrice – particolarmente difficile
della vita della Federterra, in cui i dati degli iscritti e l’esigua diffusione territoriale incisero notevolmente nella crisi del Partito socialista italiano». Ma quell’organizzazione che l’Altobelli diresse sino al
1922 sarebbe diventata ben presto una delle maggiori organizzazioni sindacali d’Europa, capace di organizzare scioperi memorabili
per numero di partecipanti e ampiezza delle aree coinvolte. Pur
non volendo enfatizzare il ruolo individuale dei capi, bisogna riconoscere che l’Altobelli fu una personalità d’eccezione nella storia del
sindacato italiano. Un leader che stava alla pari, per prestigio e autorevolezza, con i grandi dirigenti internazionali del movimento
operaio dell’epoca. C’era in lei una capacità e lucidità di analisi e
insieme una forza comunicativa che ne faceva un dirigente, per così
17
dire, naturale. Il suo modo di rappresentare la realtà, la sua capacità di intrecciare l’analisi sociale con la condizione e i sentimenti
umani, senza mai indulgere nei toni melodrammatici, fanno ricordare molto da vicino l’oratoria di Giuseppe Di Vittorio, forse il nostro più grande leader sindacale. Di Vittorio veniva dal mondo contadino della sua Puglia, l’Altobelli, nata a Imola, aveva un’estrazione
borghese ed aveva intrapreso gli studi universitari prima di entrare
nel sindacato. Perciò tanto più stupisce la prosa di questa donna che
doveva parlare a masse di contadini analfabeti e riusciva a descrivere la condizione delle lavoratrici con una forza comunicativa incomparabile:
Le statistiche – scriveva in un articolo del 1912 citato dalla Palumbo – ci
rivelano, colla certa eloquenza delle cifre, che le donne lavoratrici sono
parecchi milioni, che aumentano ogni giorno, che partecipano ad ogni
lavoro, ad ogni attività sociale; ma non ci narrano tutti i dolori, i patimenti, le sofferenze economiche e morali che le donne debbono affrontare e subire nel lavoro e nella vita. E come se non bastassero le ingiustizie e lo sfruttamento capitalistico, anche nella famiglia la donna compie
un quotidiano, ingrato, umile e pesante lavoro, profondendovi tesori di
abnegazione e di affetto, essa non gode quella considerazione di cui
avrebbe ben diritto in ricompensa delle sue cure domestiche. L’uomo è
così abituato ad essere circondato dalle premure diligenti della massaia,
che egli finisce per considerarla ed apprezzarla soltanto in misura ed alla
stregua della comodità che soddisfa le sue esigenze di benessere. Che
importa poi se la donna massaia, quella che gli uomini chiamano «la regina della casa» è isolata dal mondo, piccola e meschina fuori dal suo regno, ignara della vita, delle esigenze sociali, inaccessibile con la sua anima all’anima e allo spirito dell’umanità.
La ricostruzione del profilo di questa dirigente consente anche di
mostrare come, nel vivo delle lotte di quell’epoca di tumultuose trasformazioni, i socialisti apprendessero lezioni politiche straordinarie
che avrebbero orientato la condotta del movimento operaio organizzato nei decenni avvenire. Lezioni che ancora oggi, nel disfacimento della politica come strumento di trasformazione radicale
della società, appaiono del tutte dimenticate. Scriveva l’Altobelli, in
un passaggio ricordato dalla Palumbo: «l’esperienza ha dimostrato
come si renda necessario ogni giorno integrare la resistenza con istituti complementari, senza dei quali la sua azione resterebbe paralizzata o sensibilmente diminuita nella sua efficacia. A che varrebbe
18
scioperare e conquistare un aumento di tariffa quando manchi un
Istituto di controllo sull’onesta applicazione della conquista stessa?
L’accaparramento della mano d’opera abbandonata alla libera scelta del conduttore di terre renderebbe nulli la conquista e lo sforzo
della resistenza». Tanti istituti, come l’Ufficio di collocamento e le
varie leggi di protezione del lavoro, sono nate da tale intuizione, che
ancora oggi fatica a farsi strada nelle forme nuove che andrebbero
create o fatte rinascere. O addirittura viene fatta indietreggiare
nelle sue conquiste storiche – come il contratto nazionale di lavoro –
sotto l’urto delle politiche neoliberiste dei recenti governi.
La ricostruzione del profilo e dell’impegno sindacale di Regina
Terruzzi consente all’autrice di ricostruire il movimento delle donne
rurali durante il ventennio fascista. Un processo che vide il passaggio dall’Unione delle massaie di campagna, nata nel 1918 in Lombardia e legata alle Cattedre ambulanti di agricoltura – una «piccola
organizzazione interclassista formata da donne aristocratiche, della
media borghesia e da contadine» ricorda l’autrice – alla Federazione
delle massaie rurali creata dal fascismo. Si tratta di un capitolo recentemente esplorato dalla storiografia italiana e internazionale,
che ha mostrato l’ambivalenza delle forme di controllo delle lavoratrici da parte del fascismo. Il regime, infatti, mentre irreggimentava
le donne nelle sue strutture autoritarie e ideologicamente opprimenti, le staccava inevitabilmente dall’ambito puramente domestico
proiettandole sullo scenario sociale. Le masse femminili irrompevano così sul terreno organizzato del movimento sindacale, ma irreggimentate dentro le strutture di uno Stato che mirava a un controllo
ravvicinato e a una marcata plasmazione ideologica delle masse popolari. La vicenda della Terruzzi viene esaminata in maniera particolareggiata, quale protagonista di una strategia «innovativa» da
parte del fascismo, che spostava in avanti, per così dire, le forme di
controllo delle donne lavoratrici e mutava i linguaggi dell’egemonia
borghese. Uno «degli aspetti innovativi della nuova ondata di mobilitazione fascista – ricorda l’autrice – fu proprio il fatto che includeva le donne. Ciò introduceva una chiara rottura con gli anni venti, quando persino il piccolo gruppo di donne borghesi che cercò di
avere un ruolo politico attivo attraverso i Fasci femminili incontrò
costante ostilità e indifferenza da parte di gran parte della struttura
gerarchica del PNF».
19
La Palumbo mostra senza reticenza l’ambiguità politica di questa
figura, mazziniana e socialista, che in effetti operò instancabilmente
per organizzare le donne, ma che ebbe una relazione, per così dire
organica, con il regime e anche un lungo rapporto personale con
Mussolini, sin da quando questi era socialista e soldato al fronte, per
continuare fino ai primi anni trenta. Tant’è che, come ricorda la
Palumbo, ella «parteciperà alla fondazione dei fasci di combattimento e, addirittura, è rintracciabile una sua adesione, probabilmente solo morale, anche alla Marcia su Roma del 1922». Ma non è
solo questo l’elemento di ambiguità. Molti in Italia, per le ragioni
più varie, credettero nelle «buone intenzioni» del fascismo ai suoi
esordi. Anche personalità di gran lunga più eminenti di una dirigente sindacale come Regina Terruzzi. Benché un potere conseguito con la violenza di piazza e con l’eliminazione fisica degli avversari
avrebbe da subito dovuto consigliare un atteggiamento quanto meno più prudente, anche alle menti più inclini alla conservazione sociale. Ma il fatto è che la Terruzzi ebbe un posto di rilievo nelle organizzazioni femminili del regime sino al 1932. Ella dunque condivise politicamente le sue scelte di politica generale. Vale a dire che
accettò di collaborare con un regime che aveva distrutto le Camere
del lavoro, chiuso i giornali dell’opposizione, messo fuorilegge i
partiti, perseguitato gli antifascisti. La sottolineatura di tale adesione della Terruzzi al fascismo non significa affatto, ovviamente, negare legittimità all’inserimento del suo profilo nella storia del sindacalismo italiano. Al contrario, la sua vicenda ci consente di osservare in maniera più profonda, nelle sue luci e nelle sue ombre, la
capacità di presa e di consenso del fascismo anche su ambiti che
avrebbero dovuto essergli ostili. Attraverso tale figura si comprende
meglio come il regime abbia costruito il suo consenso utilizzando,
talora, anche uomini e donne che provenivano dall’esperienza socialista. Ma, per la verità, a livello di sguardo storico generale su
questo personaggio ci saremmo aspettati dall’autrice una maggiore
severità di giudizio. Non è certo sufficiente affermare, come fa la
Palumbo: «Regina, pur appoggiando a livello personale le scelte di
Mussolini, tuttavia ne condannerà gli atteggiamenti più violenti».
Era difficile in verità, sul piano politico e morale, separare le scelte
di Mussolini tra quelle «pacifiche» e quelle «violente». Quando la
Terruzzi continuava a dare al regime il suo appoggio e la propria
opera, i capi socialisti e dell’antifascismo erano in esilio o in clande20
stinità, Matteotti era stato ucciso, Gramsci languiva nel fondo di un
carcere. Quella della Terruzzi non era un’ambivalenza da poco. Nel
1925, ricorda la stessa Palumbo, ad Argentina Altobelli Mussolini
offrì la possibilità di organizzare le masse contadine femminili. Ma
Argentina rifiutò.
Un nuovo scenario succede alla storia della Terruzzi, quello che
le libertà civili conquistate con la caduta del fascismo e la Resistenza
avrebbero offerto al protagonismo politico e sindacale delle donne
italiane. In tale ambito si muove, infatti, Mina Biagini, la terza delle
dirigenti sindacali di cui l’autrice ricostruisce le vicende biografiche
e i percorsi della militanza politica e sindacale. La Biagini segna
una rottura, sia di classe che politica, rispetto alle due precedenti
protagoniste. Viene dal mondo contadino, è figlia infatti di mezzadri e nasce a San Gimignano, provincia di Siena, nel 1922. E anche
sotto il profilo geografico si tratta di una novità. Il quadro delle lotte è ora quello delle colline subappenniniche, mentre quello precedente è quasi esclusivamente padano. Il Mezzogiorno, purtroppo,
rimane escluso dalla ricostruzione dei profili biografici (ma non dalla
ricostruzione storica generale). Un’assenza che ovviamente non possiamo rimproverare all’autrice, ma che comunque segnala un evidente ritardo della ricerca sulle vicende delle donne meridionali.
La Biagini, inoltre, è comunista – si iscrive giovanissima nelle file
di quel partito quando è ancora clandestino – e partecipa attivamente come staffetta alla Resistenza e alla Liberazione. Per la verità,
nell’economia del libro, la personalità della Biagini – che rivestirà
incarichi regionali e nazionali nel PCI postbellico, diventando poi
responsabile della Commissione femminile nazionale dei mezzadri
– non assume il rilievo delle altre figure qui protagoniste. Certamente anche per problemi di fonti documentarie. E tuttavia la sua
vicenda consente all’autrice di mostrare un sindacato e un movimento femminile, non più circoscritto alle aree delle campagne padane, vale a dire alle zone d’origine del movimento socialista italiano, ma ormai attivamente proiettato sull’intero territorio nazionale,
e soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, che nella prima parte del
libro vengono comprensibilmente trascurate. Che la Biagini scompaia
un po’ nella folla dei protagonisti che si muovono sulla scena delle
lotte del dopoguerra è d’altra parte abbastanza inevitabile, vista la
statura e si potrebbe dire la folla dei dirigenti attivi in quell’epoca,
21
la molteplicità e vastità dei movimenti di lotta che occupano quasi
un paio di decenni. Si tratta, peraltro, di una fase storica su cui esiste una storiografia ormai sterminata, di cui l’autrice ha cercato di
tener conto con diligenza, registrando i successi e le sconfitte che il
sindacato conseguì e subì tra la fine degli anni quaranta e i primi
anni sessanta.
Conclude il volume, con scelta felice e direi obbligata, la figura di
Donatella Turtura, una delle grandi dirigenti politiche e sindacali
che hanno occupato la scena per buona parte della seconda metà
del Novecento. Nata a Bologna nel 1933, comunista, essa partecipa
alle lotte della sua regione e alla vita politica di un Partito che in
quella città è indubbiamente, a quell’epoca, il più forte dell’intero
Paese. Il suo percorso nel sindacalismo femminile, e specificamente
fra le braccianti agricole italiane, è particolarmente lungo e ricchissimo di fasi nelle quali la sua personalità ha contato nel determinare indirizzi e scelte di grande rilievo. Si pensi, a tal proposito, alla
conquista del contratto nazionale per i braccianti, che consentirà
anche ai lavoratori più deboli di godere di alcune conquiste di base
strappate nelle aree tradizionalmente più avanzate. Questo lungo
percorso – nel quale la Turtura si è distinta per la ricerca intelligente e paziente dell’unità delle donne lavoratrici, al di là delle varie
sigle sindacali che le organizzavano e talora le dividevano – trova il
suo momento di maggiore riconoscimento l’8 maggio del 1977,
quando è nominata segretario generale della Federbraccianti. Sarà
inoltre membro nella segreteria nazionale della CGIL. Un punto di
arrivo che certo non costituisce una conclusione, ma una continuità
d’azione e di indirizzi da una posizione di più elevato potere e responsabilità.
Non è certo compito di chi scrive, né la cosa avrebbe qui gran
senso, riassumere le vicende sindacali attraverso cui si è venuta
svolgendo la militanza di questa donna di grande energia e umanità. Un personaggio che ha lasciato una forte impronta nel sindacato e di cui, peraltro, è ancora viva la memoria tra tanti contemporanei che l’hanno direttamente conosciuta. Il lettore potrà farsene
un’idea leggendo i capitoli finali del libro, che cercano anche di
mostrare l’azione dirigente di questa figura nei processi più generali della «modernizzazione italiana». Una fase della nostra storia
nella quale il quadro delle vicende nazionali delle nostre campagne
22
si lega all’Europa e alle politiche agricole comunitarie. Ma anche
una fase storica nella quale, tuttavia, le masse bracciantili vedono
declinare il loro peso sociale e politico e la trasformazione industriale del Paese cambia ormai irreversibilmente i rapporti storici
tra città e campagna.
23