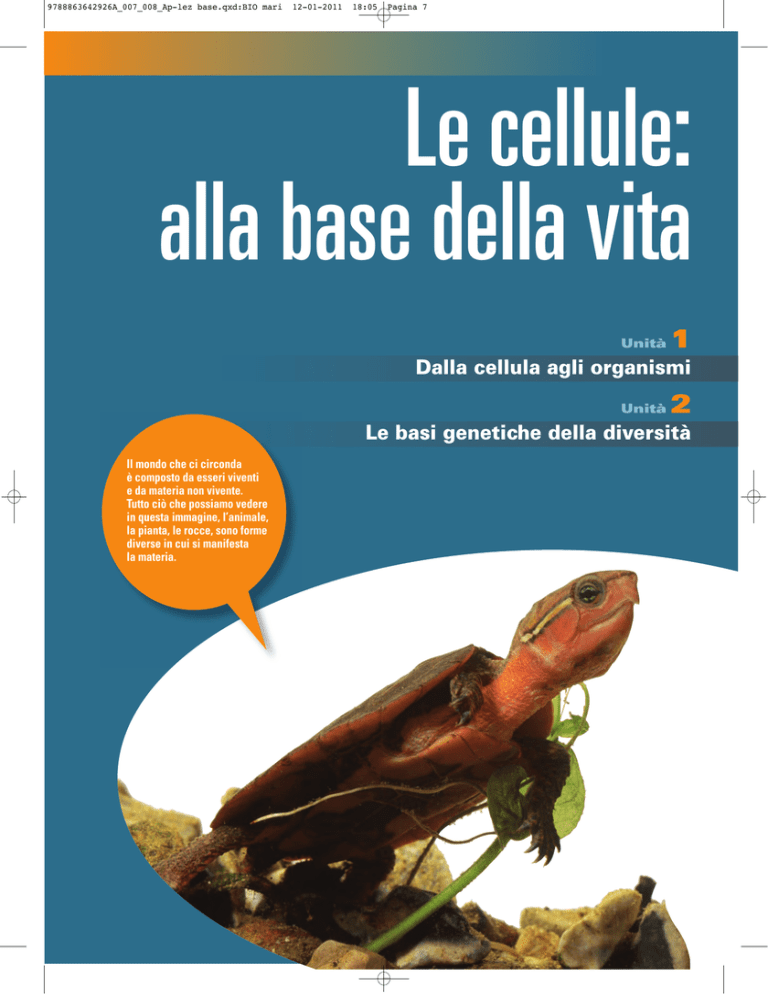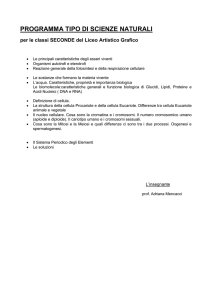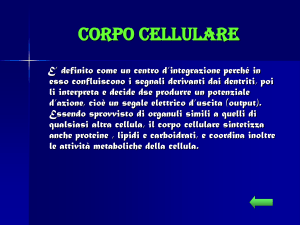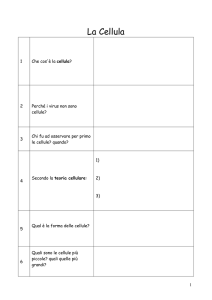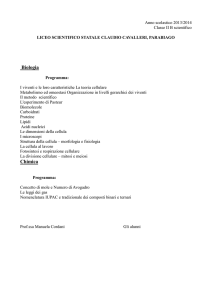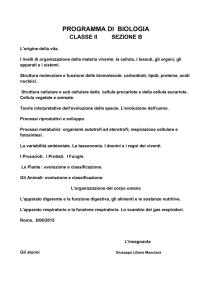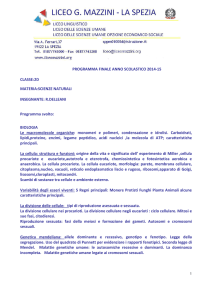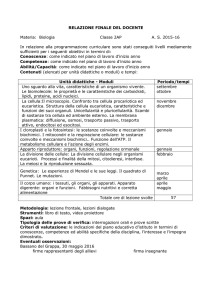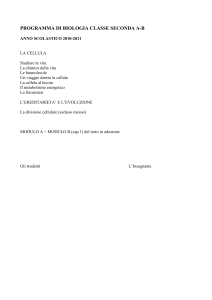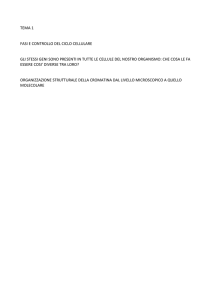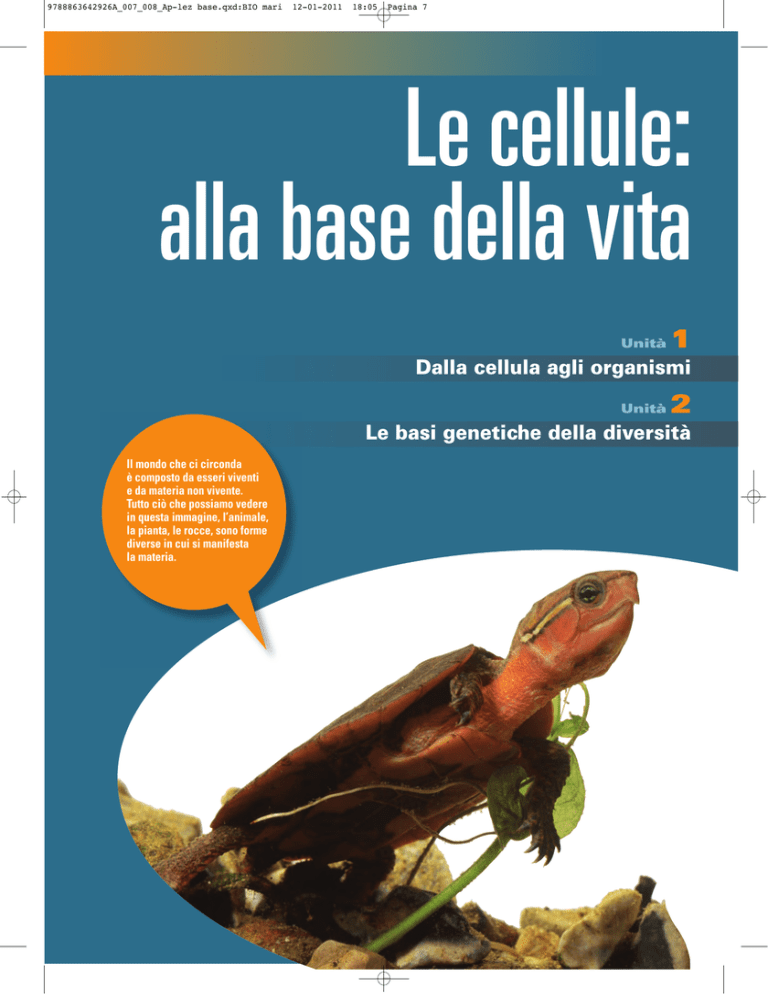
9788863642926A_007_008_Ap-lez base.qxd:BIO mari
12-01-2011
18:05
Pagina 7
Le cellule:
alla base della vita
Unità
1
Dalla cellula agli organismi
Unità
2
Le basi genetiche della diversità
Il mondo che ci circonda
è composto da esseri viventi
e da materia non vivente.
Tutto ciò che possiamo vedere
in questa immagine, l’animale,
la pianta, le rocce, sono forme
diverse in cui si manifesta
la materia.
9788863642926A_007_008_Ap-lez base.qxd:BIO mari
12-01-2011
18:05
Pagina 8
8
Tavola
Di che cosa sono fatte le cellule
Le cellule sono formate in gran parte da acqua (in media, per il 70%), da una piccola percentuale di ioni, e da una grande varietà di
molecole biologiche, o biomolecole, formate da pochi tipi di atomi: il più abbondante
è il carbonio, seguito da idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo.
Il carbonio, grazie alla sua struttura atomica, è in grado di formare lunghe catene molto stabili, a cui si legano gli altri tipi di atomi. Le catene carboniose inoltre, possono
ramificarsi, piegarsi su se stesse e formare
anelli, generando una incredibile varietà di
sostanze.
Molte molecole biologiche sono polimeri,
ossia sono formate dalla ripetizione di singole unità, chiamate monomeri. In base al
tipo di atomi da cui sono formate e alla loro disposizione, le biomolecole possono
essere suddivise in quattro gruppi, ognuno dei quali svolge una funzione diversa
negli organismi viventi (figura 1): i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici.
I carboidrati o zuccheri sono composti formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono la principale fonte di energia
per la cellula ma svolgono anche una funzione strutturale, cioè formano parti delle
cellule e degli organismi.
I carboidrati semplici sono utilizzati come
fonte energetica di utilizzo immediato e possono essere formati da una singola molecola (monosaccaridi) o da due molecole unite tra loro (disaccaridi) (figura 2, in alto).
I carboidrati complessi o polisaccaridi hanno funzione strutturale o di riserva energetica. Sono dei polimeri poiché sono formati dall’unione di un numero elevato di
carboidrati semplici. Nelle cellule vegetali il
principale polisaccaride di riserva è l’amido,
un polimero del glucosio; nelle cellule animali è il glicogeno, anch’esso un polimero
del glucosio, nel quale però le singole unità sono legate tra loro in modo diverso.
Alcuni polisaccaridi hanno anche funzione strutturale: tra questi il più diffuso è
senz’altro la cellulosa, che forma gran parte delle piante. Anche la cellulosa è un polimero del glucosio.
proteine, lipidi
proteine, lipidi,
carboidrati
carboidrati
carboidrati
o Figura 1 Il nostro corpo, e gran parte di ciò che mangiamo, sono formati da biomolecole.
Gli acidi nucleici sono molecole di grandi
dimensioni formate da atomi di carbonio,
idrogeno, ossigeno, azoto e fosforo. Sono
polimeri, costituiti da monomeri chiamati
nucleotidi. Ciascun nucleotide è formato a
sua volta da tre parti: un gruppo fosfato
(cioè un atomo di fosforo legato a quattro
atomi di ossigeno), una base azotata (una
molecola contenente carbonio e azoto) e
uno zucchero semplice a cinque atomi di
carbonio, che può essere il ribosio o il desossiribosio.
Sono due i tipi di acidi nucleici: l’acido ribonucleico o RNA, che contiene lo zucchero
ribosio, e l’acido desossiribonucleico o DNA,
che contiene lo zucchero desossiribosio.
Gli acidi nucleici sono le molecole che contengono l’informazione biologica per la costruzione e il funzionamento di un organismo e consentono di trasmetterla alle cellule
figlie quando una cellula si riproduce.
qua. I lipidi sono importanti componenti
delle membrane cellulari. Alcuni tipi di lipidi, inoltre, funzionano da messaggeri chimici tra le cellule (sono chiamati ormoni).
Le proteine sono polimeri formati dall’unione di monomeri chiamati amminoacidi, contenenti carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Esistono 20 tipi diversi di amminoacidi i
quali, unendosi in vario modo, generano la
grande varietà di proteine presenti nelle cellule. Dall’unione di più di dieci amminoacidi si formano molecole chiamate polipeptidi. Una proteina è formata da uno o più
polipeptidi, assemblati in modo da assumere una specifica struttura tridimensionale.
Le proteine svolgono diverse funzioni: strutturali, di trasporto delle sostanze, di comunicazione e riconoscimento tra cellule. Esistono inoltre proteine chiamate enzimi che
accelerano le reazioni chimiche cellulari e
ne consentono lo svolgimento. Ogni reazione chimica cellulare avviene grazie a uno
specifico enzima.
a ogni vertice del poligono
corrisponde un atomo di carbonio
O
atomo di ossigeno
O
O
O
O
monosaccaridi
O
disaccaride
O
O
O
O
O
O
O
O
O
I lipidi sono formati prevalentemente da
atomi di carbonio e di idrogeno e hanno la
caratteristica di essere insolubili in acqua. Gli
oli vegetali, il burro, la cera d’api sono esempi di lipidi.
La funzione principale dei lipidi negli organismi è di riserva energetica; inoltre servono anche come barriere isolanti, grazie al
fatto che non si possono sciogliere in ac-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
polisaccaride
o Figura 2 In alto, monosaccaridi e disaccaride; in basso, un polisaccaride
è formato dall’unione di un grande numero di monosaccaridi.
O
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 9
Unità
1
Test e mappe interattivi,
file audio mp3, glossario
multimediale su disco
e online
Dalla cellula
agli organismi
I contenuti
Lezione 1 Tutti gli organismi sono fatti
di cellule
Lezione 2 Dentro la cellula eucariote
Lezione 3 La crescita delle cellule
Lezione 4 La divisione cellulare
I risultati attesi
Conoscenze
●
●
●
●
●
spiegare i principi della teoria cellulare
descrivere la struttura e le funzioni
degli organuli cellulari
spiegare quali sono i limiti alla crescita
delle cellule e descrivere la divisione
cellulare
descrivere i principali eventi del ciclo
cellulare
descrivere il processo della mitosi
Abilità
●
Questa fotografia al microscopio
mostra un granulocita neutrofilo,
una cellula contenuta nel midollo
osseo. L’immagine è stata colorata
per evidenziare i diversi organuli.
●
●
●
●
riassumere il percorso che ha portato
gli scienziati dalla scoperta delle prime
cellule alla teoria cellulare
identificare, mediante semplici
osservazioni, le strutture cellulari visibili
al microscopio ottico
classificare le cellule in base alla loro
struttura
riconoscere il ruolo della divisione cellulare
nei diversi tipi di organismi
calcolare il numero di cromosomi e
cromatidi nelle fasi del ciclo cellulare
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 10
10 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
Lezione
1
Tutti gli organismi
sono fatti di cellule
In questa lezione
Le domande guida
Le parole chiave
■
Che cosa afferma la teoria cellulare?
■
Quali sono le differenze tra organismi
procarioti e organismi eucarioti?
■
Quali sono i livelli di organizzazione negli
organismi pluricellulari?
cellula cell
microscopio ottico
light microscope
membrana plasmatica
cell membrane
nucleo nucleus
eucariote eukaryote
procariote prokaryote
organismo unicellulare
unicellular organism
organismo pluricellulare
multicellular organism
Gli organismi viventi, nonostante si presentino sotto forme estremamente diverse, sono tutti costituiti da piccole strutture fondamentali: le cellule. Poiché la maggior parte delle cellule non è visibile a
occhio nudo, la loro scoperta e la comprensione della loro importanza come unità di base di tutti i viventi sono acquisizioni relativamente recenti, avvenute solo in seguito all’invenzione del microscopio.
■ La scoperta della cellula
A partire dalla metà del Seicento gli scienziati cominciarono a utilizzare i microscopi per osservare gli
organismi viventi. Il primo microscopio a essere
costruito fu quello ottico. Nel microscopio ottico i raggi luminosi incidenti vengono deviati attraverso
una serie di lenti generando così un’immagine ingrandita.
tessuto tissue
organo organ
sistema organ system
I primi microscopi Nel 1665 il fisico inglese Robert Hooke (1635-1703) utilizzò un microscopio ottico rudimentale per osservare sottili fettine di sughero. Visto al microscopio, il sughero sembrava
contenere migliaia di minuscole celle rettangolari
vuote, alle quali il fisico diede il nome di cellule. Oggi sappiamo che le cellule non sono vuote, ma contengono molte strutture. Nella figura 1.1 possiamo
osservare una delle illustrazioni di Hooke delle cellule di sughero, accanto a una micrografia di una
cellula vegetale che ne mostra le strutture interne.
In Olanda, all’incirca nello stesso periodo, Anton van
Leeuwenhoek (1632-1723) progettò un microscopio ottico con cui osservò l’acqua prelevata da uno
stagno. Con sua grande sorpresa, scoprì che questi liquidi brulicavano di minuscoli esseri viventi che egli
chiamò “animalculi” (in latino “piccoli animali”).
Un po’ di storia
La storia della cellula
Le osservazioni e le conclusioni di molti scienziati hanno contribuito
allo sviluppo delle nostre attuali conoscenze sulla cellula.
1674 Anton van
Leeuwenhoek osserva
piccoli organismi viventi in
una goccia d’acqua
prelevata da uno stagno,
attraverso un semplice
microscopio che egli stesso
ha costruito.
1665 Robert
Hooke pubblica
il libro Micrographia,
che contiene
le illustrazioni
delle sezioni di
sughero osservate
con uno dei primi
microscopi.
1600
1665
1674
1700
1800
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 11
11
Ø Figura 1.1 Le prime
osservazioni al
microscopio.
A Utilizzando un
B
A
La teoria cellulare Nei due secoli successivi, la costruzione di microscopi più potenti e le numerose
osservazioni effettuate da altri scienziati portarono all’analisi più dettagliata di molti organismi e di
diversi tipi di cellule. Verso la metà dell’Ottocento
tutte queste scoperte furono sintetizzate nella teoria cellulare, un concetto fondamentale della biologia. La teoria cellulare afferma che:
■ tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule;
■ le cellule sono le unità strutturali e funzionali di
base di tutti gli organismi viventi;
■ tutte le cellule si originano dalla divisione di cellule preesistenti.
■ Gli organismi eucarioti e procarioti
Le cellule mostrano una grande varietà nella forma
e nelle dimensioni, sia tra organismi diversi sia in
uno stesso organismo. Mediamente hanno un diametro compreso tra 5 e 50 micrometri (1 micrometro è 1/1000 di millimetro), ma esistono alcune eccezioni. Per esempio, i batteri più piccoli raggiungono
una lunghezza di soli 0,2 micrometri, mentre i prolungamenti delle cellule nervose delle giraffe possono essere lunghi diversi metri.
Nonostante queste differenze, tutte le cellule hanno in comune due caratteristiche:
sono circondate da una barriera chiamata membrana plasmatica;
■ contengono una o più molecole di DNA che trasportano le informazioni genetiche.
Le cellule vengono distinte in due grandi categorie, a
seconda che possiedano o meno un nucleo. Il nucleo
è una grande struttura, circondata da una membrana, al cui interno è contenuto il materiale genetico.
Gli organismi costituiti da cellule provviste di nucleo sono chiamati eucarioti. Negli organismi procarioti, invece, le cellule sono prive di nucleo.
■
I procarioti Nelle cellule procariote il materiale
genetico non è contenuto all’interno di un nucleo. Le
cellule procariote sono generalmente più piccole e
più semplici di quelle eucariote. Nonostante questa
semplicità, i procarioti possono svolgere tutte le attività proprie degli organismi viventi. Essi crescono, si riproducono, reagiscono agli stimoli esterni e
alcuni sono anche in grado di muoversi nei liquidi.
Tutti i procarioti sono organismi unicellulari; essi
comprendono i batteri e gli organismi a loro affini.
Gli eucarioti Le cellule eucariote sono generalmente più grandi e più complesse di quelle procariote,
perché contengono una serie di strutture e di membrane interne, molte delle quali altamente specia-
microscopio rudimentale,
Hooke realizzò questo
disegno delle cellule
di sughero. In questa
illustrazione le cellule
appaiono come cellette
vuote, perché Hooke stava
osservando solo le pareti
di cellule vegetali morte.
B Oggi sappiamo che le
cellule vive, come quelle
della foglia di una pianta,
sono formate da molte
strutture.
Parola per parola
Eucariote e procariote
derivano dai termini greci
káryon che significa “noce,
nucleo”, eu che significa
“bene” e pro che significa
“prima”. Pertanto
procariote significa “prima
del nucleo” ed eucariote
“buon nucleo”.
Scrivila tu!
Utilizzando Internet effettua una ricerca su una nuova
scoperta relativa alla cellula o alle sue strutture. Assicurati di riportare il nome dello scienziato o degli scienziati responsabili della scoperta. Rielabora il materiale
raccolto per preparare un’esposizione orale.
1838 Matthias Schleiden
giunge alla conclusione che tutte
le piante sono fatte di cellule.
1839
Theodor
Schwann
afferma
che tutti gli
animali sono
fatti di cellule.
1838
1839
1855
1970 Lynn Margulis avanza
l’ipotesi che determinati
organuli, piccole strutture
contenute in alcune cellule,
siano stati in origine cellule
libere, dotate di vita
indipendente.
1855 Rudolph
Virchow propone
la tesi secondo cui
tutte le cellule derivano
da cellule preesistenti,
completando la teoria
cellulare.
1900
1970
2000
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 12
12 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
O Figura 1.2 Gli eucarioti
e i procarioti. La cellula
eucariote (A) possiede
un nucleo e molte più
strutture rispetto alla
cellula procariote (B).
Qual è la struttura più
evidente nelle cellule
eucariote della
micrografia?
B
A
lizzate. Come mostra la figura 1.2, le cellule eucariote contengono un nucleo che separa il materiale genetico dal resto della cellula. Gli eucarioti possono essere piccoli organismi unicellulari oppure organismi
di grandi dimensioni formati da miliardi di cellule; essi
comprendono piante, animali, funghi e protisti.
Gli organismi unicellulari Gli organismi formati da una sola cellula sono chiamati organismi unicellulari. Essi svolgono tutte le funzioni proprie degli esseri viventi: crescono, reagiscono agli stimoli
ambientali, trasformano energia e si riproducono.
Gli organismi unicellulari possono essere sia procarioti sia eucarioti.
■ La diversità della vita cellulare
Ma come è possibile che da questi due tipi cellulari
di base possa avere origine l’infinita varietà delle
forme di vita che osserviamo intorno a noi? Le differenze tra gli organismi nascono dalle modalità con
cui le cellule si specializzano per svolgere determinate funzioni e da come esse si associano tra loro per
formare un organismo pluricellulare.
O Figura 1.3 I livelli
di organizzazione
di un organismo
pluricellulare.
Negli organismi
pluricellulari si notano
livelli di complessità
crescente: cellule
con forme e funzioni
diverse danno origine
ai diversi tessuti,
organi e sistemi.
Gli organismi pluricellulari Gli organismi formati da più cellule eucariote sono definiti pluricellulari. Le cellule che li formano si possono sviluppare con diverse modalità per svolgere compiti differenti,
mediante un processo chiamato specializzazione
cellulare.
I livelli di organizzazione Come si può osservare nella figura 1.3, in un organismo pluricellulare si
distinguono quattro livelli di organizzazione: le singole cellule, i tessuti, gli organi e i sistemi. Un tessuto è un gruppo di cellule simili che svolgono una determinata funzione. Esistono quattro tipi principali
di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. Tessuti di tipo diverso possono lavorare insieme per formare un organo. Infine, un gruppo di organi che lavorano in modo coordinato per svolgere una
specifica funzione formano un sistema, come per
esempio il sistema nervoso.
organismo
tarsio
sistema
(nervoso: occhi,
cervello, nervi)
organo
occhio
Sai rispondere?
1. Quali sono le caratteristiche comuni a tutte
le cellule?
2. Tutti gli organismi procarioti sono unicellulari?
3. Tutti gli organismi unicellulari sono procarioti?
tessuto
Provaci tu!
cellula
Osserva e realizza un disegno
Procurati una lente di ingrandimento e osserva la superficie di alcuni semi di girasole, dalla caratteristica buccia
a righe chiare e scure. Realizza un disegno di quello che
riesci a distinguere.
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 13
UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 13
Lezione
2
Dentro la cellula eucariote
In questa lezione
Le domande guida
■
Quali sono i principali
organuli cellulari e le loro
funzioni?
Le parole chiave
citoplasma cytoplasm
organulo organelle
nucleo nucleus
involucro nucleare
nuclear envelope
cromatina chromatin
cromosoma chromosome
nucleolo nucleolus
ribosoma ribosome
reticolo endoplasmatico
endoplasmic reticulum
apparato di Golgi Golgi apparatus
lisosoma lysosome
mitocondrio mitochondrion
nucleo
Una cellula può essere paragonata a una fabbrica. Infatti, come una fabbrica, che necessita di macchinari, operai e uffici per la propria
produzione e per tutte le attività a essa connesse, la cellula utilizza per le sue funzioni vitali strutture diverse, ciascuna con un compito preciso.
All’interno della cellula eucariote si possono
distinguere due parti fondamentali: il nucleo
e il citoplasma. Il citoplasma è la regione della
cellula esterna al nucleo all’interno della quale si trovano strutture specializzate chiamate
organuli. La figura 2.1 mostra gli organuli contenuti nei due tipi principali di cellula eucariote: la cellula vegetale e la cellula animale.
reticolo endoplasmatico
liscio
cloroplasto chloroplast
vacuolo vacuole
citoscheletro cytoskeleton
ciglia cilia
flagelli flagella
nucleolo
involucro
nucleare
reticolo endoplasmatico
ruvido
ribosoma
(libero)
ribosoma
(attaccato)
parete cellulare
apparato
di Golgi
membrana
plasmatica
cloroplasto
mitocondrio
vacuolo
■ Il nucleo
Il nucleo contiene quasi tutto il DNA della cellula e quindi le istruzioni codificate per la produzione di proteine e di altre importanti molecole. Il nucleo può essere considerato il centro di
controllo della cellula.
Il nucleo, come mostra la figura 2.2, è circondato da due membrane che, nell’insieme, formano l’involucro nucleare. Esso presenta migliaia di pori che permettono gli scambi di materiali,
come proteine, RNA e altre molecole, tra l’interno e l’esterno del nucleo.
cellula vegetale
nucleolo
nucleo
involucro
nucleare
ribosoma
(libero)
membrana
plasmatica
reticolo
endoplasmatico
ruvido
ribosoma
(attaccato)
O Figura 2.1 La struttura delle cellule.
Le cellule animali e vegetali contengono molti
organuli. Alcuni di essi sono specifici delle cellule
vegetali o di quelle animali, altri invece, come
i mitocondri, si ritrovano in entrambi i tipi di cellule.
Quali strutture sono presenti solo nelle cellule
vegetali?
reticolo
endoplasmatico
liscio
centrioli
mitocondrio
apparato
di Golgi
cellula animale
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 14
14
■ Il reticolo endoplasmatico
nucleolo
cromatina
o Figura 2.2 Il nucleo.
Il nucleo contiene il DNA
sotto forma di cromatina.
Le informazioni ereditarie
vengono copiate dal DNA
e inviate, attraverso i pori
nucleari, al resto della
cellula. La regione piccola
e densa all’interno del
nucleo è il nucleolo.
Se il nucleo è il centro
di controllo della maggior
parte dei processi cellulari
degli eucarioti, come
fanno i procarioti a vivere
senza nucleo?
involucro
nucleare
pori
nucleari
Le molecole di DNA, unite a proteine, formano un
materiale granuloso chiamato cromatina che, generalmente, si trova distribuito uniformemente nel nucleo.
Quando una cellula si divide, la cromatina si compatta formando grosse strutture chiamate cromosomi, visibili al microscopio ottico. La maggior parte dei nuclei contiene anche una regione piccola e densa
denominata nucleolo, in cui vengono assemblati i ribosomi.
■ I ribosomi
La maggior parte delle cellule contiene un numero
molto elevato di minuscole strutture chiamate ribosomi. I ribosomi sono piccoli organuli cellulari costituiti da RNA e proteine nei quali vengono prodotte e assemblate le proteine in base alle istruzioni
ricevute dal nucleo.
Le cellule eucariote contengono un sistema di membrane interne chiamato reticolo endoplasmatico (in
genere abbreviato con la sigla RE). Il reticolo endoplasmatico viene utilizzato per assemblare le componenti lipidiche della membrana plasmatica, insieme
alle proteine e ad altri materiali che devono essere
trasportati all’esterno della cellula.
La porzione del reticolo endoplasmatico coinvolta
nella sintesi delle proteine è definita reticolo endoplasmatico ruvido, così chiamato per la presenza di
ribosomi sulla sua superficie, come si può osservare
nella figura 2.3. Il reticolo endoplasmatico ruvido è
molto sviluppato nelle cellule che producono grandi quantità di proteine destinate a essere esportate.
Le altre proteine cellulari sono invece sintetizzate
su ribosomi “liberi”, non attaccati a membrane.
Le zone del reticolo endoplasmatico che non presentano ribosomi formano il reticolo endoplasmatico liscio. In molte cellule, il reticolo endoplasmatico liscio contiene diversi enzimi che svolgono
specifiche funzioni, tra cui la sintesi dei lipidi di
membrana e la detossificazione, cioè la demolizione,
di alcune sostanze, come alcol e farmaci.
■ L’apparato di Golgi
Molte delle sostanze prodotte nel reticolo endoplasmatico vengono trasportate, all’interno di vescicole,
verso l’apparato di Golgi. Come illustrato nella figura
2.4, l’apparato di Golgi è formato da una serie di dischi appiattiti, impilati l’uno sull’altro. La funzione
dell’apparato di Golgi è quella di modificare, smistare
e “confezionare” le proteine e altri materiali assemblati nel reticolo endoplasmatico per prepararli a essere immagazzinati nella cellula o espulsi all’esterno. Il
reticolo endoplasmatico e l’apparato di Golgi lavorano
insieme svolgendo una funzione paragonabile a quella di un reparto d’imballaggio e trasporto di una fabbrica: essi, infatti, modificano e aggiungono componenti alle diverse molecole per poi inviarle alle loro
destinazioni finali.
O Figura 2.3 Il reticolo
endoplasmatico ruvido.
Il reticolo endoplasmatico
ruvido è la sede in cui
vengono sintetizzate le
proteine destinate
a essere portate fuori
dalla cellula.
ribosomi
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 15
UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 15
vescicola
■ I lisosomi
Come ogni fabbrica ben organizzata, anche la cellula possiede strutture che servono per “ripulirla”
dalle sostanze che devono essere eliminate. Queste
strutture sono i lisosomi, piccoli organuli ricchi di
enzimi digestivi in grado di demolire in molecole
più piccole qualsiasi sostanza presente all’interno
della cellula. Essi possono anche distruggere gli organuli cellulari invecchiati o danneggiati riducendoli nei loro composti chimici di base, che possono
essere riutilizzati per altri scopi.
■ I mitocondri e i cloroplasti
Così come una fabbrica non può andare avanti senza una fonte di energia, allo stesso modo la cellula,
per produrre le proteine, per muovere le molecole
nel citoplasma o per svolgere qualsiasi altra attività necessaria alla sua sopravvivenza, ha bisogno di
energia.
La cellula può procurarsi l’energia necessaria per le
sue funzioni sia utilizzando un combustibile chimico (come il glucosio o altri zuccheri) sia sfruttando l’energia solare.
membrana
interna
I mitocondri Tutte le cellule, animali e vegetali,
utilizzano l’energia chimica immagazzinata nelle
molecole di glucosio per produrre composti che esse sono in grado di utilizzare direttamente. Queste
trasformazioni avvengono all’interno di particolari
organuli chiamati mitocondri. Come è mostrato nella figura 2.5, un mitocondrio è formato da due membrane, una esterna liscia e una interna ripiegata.
o Figura 2.4 L’apparato
di Golgi. Nell’apparato di
Golgi le molecole vengono
modificate, “confezionate”
e spedite alle loro
destinazioni finali
all’interno di vescicole.
I cloroplasti Per procurarsi l’energia di cui necessitano, gli animali devono alimentarsi. Nelle cellule
vegetali e in quelle di alcune alghe, invece, questa
funzione è svolta dai cloroplasti: i cloroplasti catturano l’energia solare e la convertono in energia chimica in un processo chiamato fotosintesi.
Come possiamo osservare nella figura 2.5, anche i cloroplasti sono formati da una doppia membrana. A
differenza dei mitocondri, però, i cloroplasti presentano al loro interno altri ammassi di membrane
impilate contenenti clorofilla, un pigmento verde. I cloroplasti, per la loro capacità di catturare
l’energia solare e convertirla in energia chimica,
possono essere paragonati ai pannelli solari della
cellula.
Le membrane impilate
all’interno dei cloroplasti
contengono clorofilla.
ø Figura 2.5 Le centrali
energetiche di una cellula
vegetale. I cloroplasti
e i mitocondri sono
entrambi coinvolti nei
processi di conversione
dell’energia che avvengono
all’interno della cellula.
membrana
esterna
membrana
interna
mitocondrio
cloroplasto
membrana
esterna
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:29
Pagina 16
16 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
vacuolo
■ I vacuoli
Così come ogni fabbrica dispone di un magazzino, anche le cellule immagazzinano materiali in strutture a forma di sacco chiamate vacuoli. Nelle cellule
animali i vacuoli possono contenere proteine, grassi o carboidrati.
Nelle cellule vegetali, come quella della figura 2.6,
spesso è presente un grosso vacuolo centrale che
immagazzina acqua e sali minerali. In queste cellule i vacuoli svolgono anche una funzione di supporto: infatti la pressione dell’acqua presente al loro interno consente alla pianta di sostenere strutture
pesanti come foglie e fiori.
o Figura 2.6 I vacuoli. Nelle
cellule vegetali il vacuolo
centrale immagazzina
acqua, sali minerali,
proteine e carboidrati.
In che modo il vacuolo
conferisce sostegno
strutturale alla pianta?
O Figura 2.7
Il citoscheletro.
Una rete di filamenti
proteici fornisce alla cellula
un’intelaiatura che risulta
robusta e flessibile e,
al tempo stesso, è
coinvolta in diverse forme
di movimento cellulare.
Nella fotografia al
microscopio ottico a
fluorescenza sono ben
riconoscibili i microtubuli
(in giallo) e i microfilamenti
(in viola chiaro).
to di materiali da una parte all’altra della cellula e il
cambiamento della forma generale della cellula.
I due tipi principali di filamenti proteici che costituiscono il citoscheletro sono i microtubuli e i microfilamenti, mostrati nella figura 2.7. I microtubuli formano anche l’impalcatura interna di protuberanze
della cellula chiamate ciglia e flagelli. Le cellule possono utilizzare queste strutture per muoversi, come fanno gli spermatozoi grazie alla presenza di un
flagello, oppure per spostare i materiali con cui vengono a contatto. Per esempio, nel caso delle cellule
che rivestono la trachea, le ciglia intrappolano il muco e le impurità per spingerli verso l’esterno, mantenendo così pulite le vie respiratorie.
■ Il citoscheletro
Per finire, come qualsiasi fabbrica, anche la cellula
ha bisogno di strutture interne di supporto per resistere alle forze e alle pressioni cui è sottoposta. Nelle cellule eucariote questa funzione è svolta da una
struttura chiamata citoscheletro. Il citoscheletro è
una rete di filamenti proteici che conferisce rigidità,
forma e organizzazione alla cellula. Oltre a fornire
sostegno meccanico, il citoscheletro è anche coinvolto in molti movimenti cellulari, tra cui il traspor-
reticolo
endoplasmatico
Sai rispondere?
1. Come si chiama la struttura di rivestimento del nucleo?
2. Qual è la principale differenza tra reticolo
endoplasmatico liscio e ruvido?
3. I mitocondri si trovano soltanto nelle cellule animali? E i vacuoli?
4. Da che cosa è costituito il citoscheletro?
membrana
plasmatica
microtubulo
COMPETENZE * AREA COMPETENZE
microfilamento
ribosomi
mitocondrio
Minilab
Come appaiono le cellule di una cipolla osservate al microscopio ottico?
Materiali occorrenti
■ cipolla
■ acqua
■ soluzione iodata (tintura di iodio)
■ microscopio ottico
■ vetrini portaoggetti e vetrini coprioggetti
■ bisturi [attenzione! maneggiare con cautela]
■ contagocce
Il procedimento
1. Prendete la cipolla e, dopo aver tolto gli strati superficiali secchi, asportate delicatamen-
te la pellicina umida e trasparente che si trova tra uno strato e l’altro.
2. Mettete una goccia d’acqua su un vetrino
portaoggetti.
3. Appoggiate la pellicina sulla goccia d’acqua
e ricopritela con il vetrino coprioggetti. Osservate il preparato al massimo ingrandimento possibile, annotando ciò che vedete.
4. Ripetete l’osservazione ai diversi ingrandimenti, aggiungendo lungo il bordo due gocce
di soluzione iodata, così da ottenere un preparato colorato.
Le conclusioni
1. Quale forma hanno le cellule prelevate sotto
la superficie della cipolla? Quali elementi
cellulari si possono distinguere?
2. Che cosa cambia nel vetrino colorato con la
soluzione iodata?
9788863642926A_009_017_Unita1_lez1-2.qxd:BIO mari
11-04-2011
Per approfondire
17:30
Pagina 17
17
TEM
I microscopi
I microscopi ottici
composti
I microscopi più comuni, quelli che si trovano in ogni laboratorio di biologia, sono i microscopi ottici composti, che
permettono di ottenere ingrandimenti
di un oggetto concentrandovi raggi di
luce visibile. I microscopi composti
contengono più di una lente e riescono a fornire immagini ingrandite fino
a 1000 volte (1000⫻). Queste caratteristiche li rendono idonei allo studio e
all’osservazione di molti tipi di cellule e
microrganismi, che in alcuni casi possono
essere studiati quando sono ancora vivi.
L’osservazione al microscopio ottico è facilitata dall’impiego di coloranti chimici che rendono più evidenti le strutture cellulari. Negli
ultimi anni, l’impiego di coloranti fluorescenti è stato associato all’uso di videocamere e
computer per ottenere immagini tridimensionali di processi come il movimento cellulare.
I microscopi elettronici
I microscopi ottici ci consentono di ottenere immagini abbastanza definite soltanto di
oggetti con un diametro maggiore di 0,2 micrometri. Per osservare oggetti più piccoli
occorrono i microscopi elettronici.
Negli anni venti del secolo scorso, alcuni fisici tedeschi scoprirono che utilizzando dei
magneti era possibile concentrare un fascio
di elettroni nello stesso modo in cui una lente di vetro focalizza un raggio di luce. Da questa scoperta sono nati sia i televisori sia i microscopi elettronici.
Un microscopio elettronico può fornire ingrandimenti 1000 volte maggiori di quelli ottenuti con il microscopio ottico, come mostrato nella figura 1 . Ne esistono due tipi
fondamentali:
■
■
LM
Figura 1 Fotografie al microscopio.
Cellule osservate al microscopio ottico (LM),
elettronico a trasmissione (TEM)
ed elettronico a scansione (SEM).
I microscopi elettronici presentano alcuni limiti. Innanzitutto, i campioni devono essere
tenuti sotto vuoto, altrimenti la collisione tra
gli elettroni e le particelle dell’aria produrrebbe immagini poco definite: per questo, i microscopi elettronici permettono di studiare soltanto campioni non viventi. Inoltre, quando si
utilizza il TEM, i campioni devono essere tagliati in fettine sottilissime perché possano essere
attraversati dagli elettroni. Il SEM, infine, fornisce immagini molto realistiche della superficie dei campioni ma non è in grado di evidenziarne la struttura interna.
I microscopi a scansione
a effetto tunnel
Negli anni ottanta del secolo scorso è nato
un nuovo tipo di microscopi che non utilizza lenti di alcun tipo (né di vetro né magnetiche) per ingrandire le immagini. Questi microscopi sono chiamati microscopi a scansione
a effetto tunnel (STM, dall’inglese Scanning
Tunneling Microscope) e utilizzano una punta sottilissima, simile a una sonda, che si sposta lungo la superficie del campione.
I microscopi a scansione a effetto tunnel consentono di ottenere immagini di singoli atomi e molecole e per questo sono diventati
uno degli strumenti principali per l’osservazione e la manipolazione della materia nell’ambito delle nanotecnologie. A differenza dei
TEM e dei SEM, non richiedono che il campione sia sotto vuoto.
Per capire e per riflettere
i microscopi elettronici a trasmissione
(TEM, dall’inglese Transmission Electron
Microscope);
i microscopi elettronici a scansione (SEM,
dall’inglese Scanning Electron Microscope).
Il TEM (figura 2) invia un fascio di elettroni
sul campione: alcuni elettroni vengono deviati o assorbiti, mentre altri attraversano il
campione e vanno a finire su uno schermo
fluorescente o su una lastra fotografica, dove
si forma un’immagine molto ingrandita dell’oggetto. Il SEM, invece, utilizza un sottile
fascio di elettroni che viene fatto scorrere sulla superficie del campione. Nei punti in cui gli
elettroni colpiscono il campione, vengono
emessi altri elettroni che producono un’immagine tridimensionale della superficie dell’oggetto su uno schermo televisivo.
SEM
Figura 2
Microscopio elettronico a trasmissione.
1. Uno strumento che produce immagini
ingrandite di un oggetto utilizzando raggi
di luce visibile è chiamato:
a. microscopio ottico.
b. microscopio elettronico a trasmissione.
c. microscopio elettronico a scansione.
d. TEM.
2. Quale tipo di microscopio utilizzereste per
osservare: (a) i dettagli di un mitocondrio;
(b) un microrganismo presente in una
goccia d’acqua; (c) la struttura della
membrana plasmatica; (d) la struttura
di una superficie metallica, per esempio
di una sottilissima lamina d’oro?
3. Osservate la figura 1; in quale immagine
potete notare i dettagli più fini della
superficie delle cellule? Perché?
4. In che cosa sono simili i microscopi ottici e
quelli elettronici? In che cosa differiscono?
5. In quali altri campi, oltre alla biologia, sono
usati i microscopi?
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 18
18 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
Lezione
3
La crescita delle cellule
In questa lezione
Le domande guida
■
Le parole chiave
Quali sono i limiti alla crescita delle cellule?
rapporto superficie/volume
surface/volume ratio
Che cosa succede alle cellule di un organismo durante il suo accrescimento? In altre parole, un essere vivente diventa più grande perché le sue cellule crescono di dimensioni o perché aumenta il numero delle
cellule che lo costituiscono? Nella maggior parte dei
casi è vera la seconda ipotesi: il corpo di un organismo cresce perché aumenta il numero delle cellule,
mentre le loro dimensioni restano invariate.
■ I limiti alla crescita della cellula
Ci sono due motivi principali per i quali le cellule si
dividono piuttosto che continuare a crescere all’infinito. Quando una cellula diventa più grande, aumentano le richieste nei confronti del suo DNA.
Inoltre, crescendo la cellula deve far fronte a un maggior numero di problemi legati al trasporto di sostanze attraverso la membrana plasmatica.
Il ruolo del DNA Le informazioni che controllano
il funzionamento di una cellula sono immagazzinate nella molecola di DNA. Fin quando una cellula è
piccola, il materiale genetico che ha a disposizione è
sufficiente per far fronte a tutte le sue necessità. Man
mano che le dimensioni della cellula aumentano, in
O Figura 3.1 Il rapporto
tra la superficie e il
volume nelle cellule.
La riduzione del rapporto
superficie/volume rende
più difficili gli scambi di
materiale tra l’interno
e l’esterno della cellula.
Calcolate l’area
superficiale, il volume
e il rapporto
superficie/volume
di una cellula cubica
immaginaria avente
uno spigolo di 4 cm.
divisione cellulare
cell division
genere, non vengono prodotte nuove copie di DNA e
il materiale genetico disponibile è sempre meno in
grado di soddisfare i crescenti bisogni della cellula.
Gli scambi di materiali L’altra ragione per cui le
dimensioni delle cellule sono limitate ha a che fare
con la necessità di scambiare materiali con l’esterno:
in particolare, le sostanze nutritive, l’ossigeno e l’acqua devono entrare nella cellula attraverso la membrana plasmatica, mentre i prodotti di rifiuto devono uscire.
La velocità con cui si verificano questi scambi dipende dall’area superficiale della cellula, che corrisponde
all’area totale della sua membrana plasmatica. Invece, la velocità con cui vengono consumate le sostanze nutritive e l’ossigeno e con cui vengono generati i
prodotti di rifiuto dipende dal volume della cellula. Pertanto, comprendere come varia il rapporto tra l’area
superficiale di una cellula e il suo volume, definito
rapporto superficie/volume, è la chiave per capire perché le cellule debbano dividersi quando crescono.
Il rapporto superficie/volume Consideriamo
un’ipotetica cellula di forma cubica come quella
rappresentata nella figura 3.1. Se lo spigolo della
rapporto superficie/volume nelle cellule
dimensioni
della cellula
1 cm
2 cm
1 cm
3 cm
1 cm
2 cm
2 cm
3 cm
3 cm
superficie (lunghezza altezza numero di facce)
1 cm 1 cm 6
6 cm2
2 cm 2 cm 6 24 cm2
3 cm 3 cm 6 54 cm2
volume (lunghezza larghezza altezza)
1 cm 1 cm 1 cm
1 cm3
2 cm 2 cm 2 cm
8 cm3
3 cm 3 cm 3 cm 27 cm3
rapporto
superficie/volume
6/16:1
24 / 8 3 : 1
54 / 27 2 : 1
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 19
UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 19
cellula è di 1 cm, l’area della sua superficie totale è
di 6 cm2 e il suo volume è di 1 cm3. Questo significa che tutte le sostanze che entrano ed escono da
una cellula con volume pari a 1 cm3 devono attraversare una membrana plasmatica che ha una superficie di 6 cm2. In questo caso, il rapporto superficie/volume è pari a 6.
Come possiamo osservare nella figura 3.1, se raddoppia la lunghezza dello spigolo, il volume della
cellula aumenta di otto volte (diventa 8 cm3), mentre l’area della sua superficie totale aumenta solo
di quattro volte (diventa 24 cm2). Il rapporto tra
l’area superficiale e il volume è quindi uguale a 3.
Questa cellula, otto volte più grande della precedente, avrà bisogno di scambiare con l’esterno una
quantità di materiali otto volte maggiore rispetto
all’altra cellula. In altri termini, una quantità otto
volte maggiore di sostanze deve attraversare una
membrana che è solo quattro volte più ampia rispetto a quella originale.
Questa considerazione viene confermata anche se
triplichiamo la lunghezza del lato della cellula. In questo caso, il rapporto superficie/volume si riduce a 2,
in quanto il volume della cellula è uguale a 27 cm3,
mentre la sua area superficiale è di 54 cm2.
In generale, possiamo notare che il volume aumenta più rapidamente dell’area superficiale, e che, di
conseguenza, quando aumentano le dimensioni della cellula, il rapporto superficie/volume diminuisce.
È proprio questa riduzione la causa dei problemi che
la cellula deve affrontare quando cresce. Infatti, con
l’aumento delle dimensioni, diventa difficile per una
cellula far entrare dalla membrana plasmatica tutte
le sostanze necessarie per la sua sopravvivenza e fare uscire tutte quelle che devono essere eliminate
come materiali di rifiuto.
■ La divisione
di una cellula
Siccome esistono limiti precisi alla crescita cellulare, una cellula si
divide in due cellule “figlie” nel
momento in cui raggiunge le massime dimensioni compatibili con
la sua sopravvivenza. Il processo
attraverso cui una cellula si divide
dando origine a due cellule figlie è
chiamato divisione cellulare. Ogni
cellula figlia avrà un rapporto superficie/volume maggiore rispetto alla cellula originaria con la conseguenza che gli scambi di materiale
con l’ambiente esterno saranno
più efficienti.
Prima che la divisione cellulare abbia inizio, la cellula duplica, cioè copia, tutto il suo DNA; in tal modo
ogni cellula figlia potrà ricevere un corredo completo di informazioni genetiche. La divisione cellulare
è il processo che permette a un organismo di crescere senza che la sue cellule aumentino di dimensioni (figura 3.2).
o Figura 3.2 La crescita
di un individuo. Gli esseri
viventi crescono
producendo nuove cellule.
Sebbene un pinguino
adulto sia più grande
di un cucciolo, le loro
cellule hanno le stesse
dimensioni.
Sai rispondere?
1. Quando aumentano le dimensioni della cellula che
cosa succede al suo rapporto superficie/volume?
2. La quantità di DNA presente in una cellula
aumenta man mano che essa cresce di dimensioni?
3. Man mano che la cellula cresce aumenta la sua
capacità di scambiare materiali con l’esterno?
4. Come fa la cellula ad aumentare il rapporto
superficie/volume?
Minilab
Materiali occorrenti
■ 2 uova sode sgusciate
■ colorante alimentare blu
■ contenitore cilindrico graduato (becher) da 150 ml
■ bisturi da dissezione [attenzione! maneggiare
con cautela]
■ cucchiaio
■ fogli di carta assorbente
■ righello
Il procedimento
1. Indossate un paio di guanti in lattice e un grembiule. Versate 100 ml di acqua nel becher. Aggiungete 10 gocce di colorante alimentare blu e
mescolate con un cucchiaio.
2. Utilizzate il bisturi per tagliare a metà un uovo sodo. Rimuovete il tuorlo. Ritagliate un cubetto di 8
mm dalla parte bianca più spessa.
3. Mettete il cubetto e l’altro uovo sodo intero all’interno del becher con la soluzione colorata.
4. Dopo 10 minuti rimuovete attentamente il cubetto e l’uovo intero dal becher utilizzando un cucchiaio e posizionateli su un foglio di carta assorbente.
5. Tagliate il cubetto d’uovo a metà. Pulite la lama
del bisturi e tagliate a metà anche l’uovo sodo
intero. Con il righello misurate la distanza percorsa dal colorante blu nel cubetto d’uovo e nell’uovo intero.
Le conclusioni
1. Qual è la differenza tra la distanza percorsa dal
colorante nel cubetto e nell’uovo intero?
2. Utilizzate il paragone con l’uovo intero e con il
cubetto per spiegare perché una cellula non
può continuare a crescere all’infinito.
AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * ARE
Quali sono i fattori che impediscono a una cellula di crescere all’infinito?
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 20
20 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
Lezione
4
La divisione cellulare
In questa lezione
Le domande guida
Le parole chiave
■
Quali sono i principali eventi del ciclo
cellulare?
■
Quali sono le fasi della divisione cellulare?
■
Che cosa differenzia le cellule tumorali
dalle altre cellule?
scissione binaria binary fission
mitosi mitosis
citodieresi cytokinesis
cromosoma chromosome
cromatidi fratelli sister chromatids
centromero centromere
ciclo cellulare cell cycle
interfase interphase
La divisione cellulare non consiste in una semplice
scissione della cellula in due parti. È infatti importante che le cellule figlie ricevano tutte le informazioni necessarie per costruire le proprie molecole e gli organuli di cui hanno bisogno per funzionare. Pertanto
ogni cellula, prima di dividersi, deve duplicare il proprio DNA. Questo, infatti, è ciò che permette a ogni
cellula figlia di ricevere una copia completa del materiale genetico, esattamente identica a quella della
cellula “madre”. Ma quali conseguenze ha la divisione cellulare nella vita di un organismo?
■ Il ruolo della divisione cellulare
La divisione cellulare avviene con meccanismi diversi e svolge ruoli differenti nei diversi tipi di organismi.
Nella maggior parte dei procarioti, la divisione cellulare si svolge mediante un processo relativamente semplice, chiamato scissione binaria, che consiste nella separazione del contenuto cellulare in due
O Figura 4.1 La divisione
cellulare nelle cellule
procariote. Fotografia
al microscopio elettronico
a trasmissione di un
batterio in divisione.
È visibile il materiale
genetico duplicato che
si distribuisce tra le due
cellule figlie.
centriolo centriole
profase prophase
fuso mitotico mitotic spindle
metafase metaphase
anafase anaphase
telofase telophase
tumore tumor
parti in seguito alla duplicazione del materiale genetico. Ciascuna delle cellule figlie così prodotte
riceverà una copia del materiale genetico duplicato. Pertanto negli organismi procarioti, come il batterio della figura 4.1, la divisione cellulare dà origine a nuovi individui geneticamente uguali
all’organismo progenitore.
Negli eucarioti, caratterizzati da cellule provviste di
un nucleo che racchiude il materiale genetico, la divisione cellulare avviene con un meccanismo molto più complesso, articolato in due fasi principali:
la prima fase, che consiste nella divisione del nucleo
cellulare, è chiamata mitosi; la seconda fase, detta
citodieresi, porta alla divisione del citoplasma.
Gli organismi eucarioti unicellulari si riproducono
mediante la mitosi e la citodieresi. Si tratta di una forma di riproduzione asessuata, in quanto i nuovi
individui che si formano sono geneticamente identici all’organismo progenitore. Negli organismi pluricellulari, invece, la divisione cellulare consente l’accrescimento progressivo dell’organismo a partire da
una singola cellula e, al tempo stesso, la sostituzione delle cellule morte o danneggiate. Per esempio, è
grazie alla divisione cellulare che le cellule dell’epidermide possono essere rimpiazzate velocemente dopo
una lieve ferita.
■ I cromosomi
Nelle cellule eucariote, le informazioni genetiche
che vengono trasferite da una generazione cellulare
all’altra sono contenute in strutture, formate da
DNA e proteine, chiamate cromosomi. Le cellule degli organismi di ogni specie contengono un numero
caratteristico di cromosomi: per esempio, le cellule
dei moscerini della frutta ne hanno 8, quelle degli
esseri umani 46, e quelle delle carote 18.
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 21
UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 21
Ø Figura 4.2 I cromosomi.
A In ogni cromosoma
i cromatidi fratelli sono
uniti nel centromero.
B Alcuni cromosomi umani
osservati al microscopio
elettronico.
Perché è importante che
i due cromatidi fratelli
siano identici?
cromatidi fratelli
centromero
B
Nella maggior parte delle cellule i cromosomi sono
visibili solo durante la divisione cellulare, quando
le molecole di DNA e proteine, che in genere si trovano distribuite uniformemente nel nucleo sotto
forma di cromatina, si condensano formando strutture compatte osservabili al microscopio ottico.
Dato che prima della divisione cellulare avviene la
duplicazione del materiale genetico, ogni cromosoma è costituito da due filamenti identici di DNA,
chiamati cromatidi fratelli. Come osserviamo nella
figura 4.2, i due cromatidi sono uniti in una zona
detta centromero.
■ Il ciclo cellulare
cellulare la cellula cresce,
duplica il suo DNA, e si
divide in due cellule figlie.
Per ogni singola cellula,
quando ha inizio il ciclo
cellulare? Perché si parla
di ciclo?
osi
i
mit
es
er
di
L’interfase è il periodo più lungo del ciclo cellulare durante il quale si svolgono importanti attività all’interno della cellula.
■ Durante la fase G1 (dall’inglese gap = “spazio, intervallo”) la cellula si accresce e produce nuove
proteine e nuovi organuli cellulari.
■ Nel successivo intervallo di tempo, detto fase S (da
“sintesi”), avviene la duplicazione dei cromoso-
to
■ L’interfase
ø Figura 4.3 Il ciclo
cellulare. Durante il ciclo
fase G1
(crescita della cellula)
ci
Tutto ciò che accade a una cellula dal momento in
cui nasce a quello in cui si divide fa parte di una sequenza ordinata di eventi chiamata ciclo cellulare.
Durante il ciclo cellulare, una cellula cresce, si prepara alla divisione e infine si divide in due cellule figlie, ognuna delle quali darà inizio a un nuovo ciclo.
Il ciclo cellulare è costituito da quattro fasi principali, mostrate nella figura 4.3. La mitosi e la citodieresi si svolgono durante la fase M. Tra una divisione cellulare e quella successiva intercorre un intervallo di
tempo, comprendente le fasi G1, S e G2, che nel suo
complesso viene chiamato interfase.
mi, cioè la cellula raddoppia il proprio contenuto di DNA. In genere, una volta che la cellula entra nella fase S e inizia a duplicare i propri cromosomi, va avanti a completare anche la parte
restante del ciclo cellulare.
■ Nel corso della fase G2 la cellula si prepara alla divisione, producendo le molecole e gli organuli necessari per questo processo.
Durante l’interfase, nelle cellule animali viene avviata anche la duplicazione dei centrioli, due piccole strutture cilindriche costituite da microtubuli e
situate nel citoplasma in prossimità dell’involucro
nucleare.
d
ce ivis
llu io
la ne
re
fas
e
M
A
fase G2
(preparazione
alla mitosi)
fase S
(duplicazione del DNA)
interfase
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 22
22 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
■ La mitosi
Al termine dell’interfase la cellula è pronta per iniziare la divisione cellulare. La mitosi è un processo
continuo, ma i biologi vi distinguono quattro fasi:
profase, metafase, anafase e telofase. A seconda del tipo di cellula, queste quattro fasi possono durare da
pochi minuti a diversi giorni. Possiamo visualizzare ciò
che accade in ogni fase osservando la figura 4.4.
ø Figura 4.4 Gli eventi del
ciclo cellulare. Nelle
cellule eucariote, il ciclo
cellulare comprende
l’interfase, la mitosi
(divisione del nucleo) e la
citodieresi (divisione del
citoplasma). Le quattro fasi
della mitosi sono: profase,
metafase, anafase e
telofase. Gli eventi illustrati
sono caratteristici delle
cellule animali.
Qual è la funzione del fuso
mitotico? Qual è la
differenza tra la cellula che
si forma al termine della
telofase e quella che entra
nella profase?
La profase La profase è la prima fase della mitosi
ed è anche la più lunga, in quanto può occupare fino al 50-60% del tempo totale necessario per completare l’intero processo. Durante la profase i cro-
mosomi diventano visibili. Inoltre, in questa fase,
l’involucro nucleare si dissolve progressivamente fino a scomparire e le due coppie di centrioli migrano
verso le estremità opposte della cellula.
Quando i centrioli hanno raggiunto i poli opposti
della cellula, i microtubuli si organizzano a costituire un fascio, il fuso mitotico, che va da un polo all’altro. Il fuso mitotico si forma sia nelle cellule animali sia in quelle vegetali, sebbene nelle seconde
manchino i centrioli.
Al termine della profase alcuni cromosomi cominciano ad attaccarsi, in corrispondenza del centromero, alle fibre del fuso.
centrioli
involucro
nucleare
cromatina
interfase
La cellula cresce,
duplica il suo DNA
e i centrioli.
telofase
I cromosomi si raggruppano alle estremità
opposte della cellula. Il fuso si spezza
e progressivamente scompare. Attorno
a ciascun gruppo di cromosomi inizia
a riformarsi l’involucro nucleare.
citodieresi
Il citoplasma e il suo contenuto
si distribuiscono nelle due cellule
figlie. Ciascuna di esse possiede
un corredo cromosomico identico
a quello della cellula madre.
L’involucro
nucleare
si riforma.
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 23
UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 23
La metafase Al termine della profase ha inizio la seconda fase della mitosi, chiamata metafase. Questa
fase è la più breve e spesso dura solo pochi minuti.
Durante la metafase i cromosomi finiscono di attaccarsi alle fibre del fuso e si allineano nella zona centrale della cellula: sul piano equatoriale.
L’anafase All’inizio della terza fase della mitosi,
l’anafase, i centromeri si dividono e i due cromatidi
fratelli di ciascun cromosoma si separano per diventare cromosomi indipendenti. Questi cromosomi si
spostano lungo le fibre del fuso verso i poli opposti
della cellula. L’anafase si conclude quando tutti i cro-
mosomi si fermano formando due gruppi alle estremità opposte della cellula.
La telofase Nell’ultima fase della mitosi, la telofase, il fuso scompare gradualmente e i cromosomi,
raggruppati ai due poli della cellula, cominciano a
riprendere la forma di cromatina diffusa. Attorno
a ciascuno dei due gruppi di cromosomi si riforma
l’involucro nucleare. Quando si sono costituiti due
nuclei ben distinti all’interno della cellula, la mitosi si può considerare conclusa. Il processo di divisione cellulare, però, si deve ancora completare con
la citodieresi, cioè la divisione del citoplasma.
formazione del fuso mitotico
profase
La cromatina si condensa
formando i cromosomi.
I centrioli si separano
e inizia a formarsi il fuso
mitotico. L’involucro
nucleare si frammenta
fino a scomparire.
centromero
centriolo
cromosomi
(coppie di cromatidi)
anafase
I cromatidi fratelli si
separano in cromosomi
indipendenti e migrano
verso i poli opposti
della cellula.
cromosomi
indipendenti
fuso mitotico
metafase
I cromosomi
si attaccano al fuso
con il centromero
e si allineano
al centro
della cellula.
centriolo
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 24
24 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
O Figura 4.5 La citodieresi
nelle cellule animali. Nella
zona centrale della cellula
un anello di filamenti
stringe la membrana
plasmatica fino a dividere
il citoplasma in due metà,
ciascuna contenente
un nucleo e parte degli
organuli della cellula
madre.
O Figura 4.6 La citodieresi
nelle cellule vegetali. Nella
piastra cellulare
parete cellulare
zona centrale della cellula,
a metà tra i due nuclei, si
forma una struttura,
chiamata piastra cellulare,
che cresce gradualmente
fino a costituire una nuova
parete cellulare tra le due
cellule figlie.
Qual è la differenza tra
parete cellulare e
membrana cellulare?
Parola per parola
Citodieresi deriva dai
termini greci kýtos,
che significa “cavità”,
e diáiresis che significa
“divisione, separazione”.
Il prefisso cito- si riferisce
alle cellule e, pertanto,
citodieresi significa
“divisione della cellula”.
Quale potrebbe essere
il significato del termine
citotossico?
■ La citodieresi
I due nuclei che si formano al termine della mitosi
contengono un corredo cromosomico completo, ma
sono ancora contenuti nel citoplasma di una singola cellula. La fase M del ciclo cellulare si completa
con la citodieresi, che in genere si svolge contemporaneamente alla telofase.
Nella maggior parte delle cellule animali, la divisione del citoplasma avviene per formazione di una
strozzatura a metà della cellula provocata da un anello di filamenti. Questa strozzatura diventa sempre
più profonda fino a dividere la cellula in due. Ciascuna delle due cellule figlie contiene un nucleo e
circa la metà del citoplasma e degli organuli della
cellula madre. La figura 4.5 illustra il processo di citodieresi in una cellula animale.
Nelle cellule vegetali, invece, la citodieresi avviene per
formazione, a metà della cellula, di una piastra cellulare, che si accresce gradualmente fino a costituire una parete che divide in due la cellula madre, come mostrato nella figura 4.6.
■ Il controllo del ciclo cellulare
Uno degli aspetti più sorprendenti del funzionamento delle cellule in un organismo pluricellulare è
l’attenzione con cui vengono controllate la crescita
e la divisione cellulare. Per esempio, le cellule di alcune parti del corpo umano, come il cervello, il cuo-
re e i muscoli, si dividono raramente o addirittura
non si dividono mai. Al contrario, altri tipi di cellule, come quelle della pelle o dell’apparato digerente,
si dividono frequentemente per sostituire le cellule
danneggiate dalle normali attività quotidiane.
Negli esseri umani la perfetta regolazione del ciclo
di ogni tipo di cellula è fondamentale per la sopravvivenza dell’organismo. Un importante meccanismo
di controllo è rappresentato dal contatto tra le cellule: le cellule smettono di dividersi quando entrano
in contatto con altre cellule, cioè quando non hanno più spazio disponibile. Questo sistema di regolazione non funziona nelle cellule tumorali, che continuano a dividersi ugualmente impilandosi le une
sulle altre anche quando lo spazio adiacente è già
stato occupato. Quindi, i tumori sono formati da cellule “fuori controllo”, che non rispondono ai segnali che regolano il ciclo cellulare.
Sai rispondere?
1. Qual è il ruolo della divisione cellulare negli
organismi unicellulari?
2. Che cosa sono i cromatidi fratelli?
3. Perché il materiale genetico deve essere duplicato
prima che avvenga la divisione cellulare?
4. In quale fase della mitosi si forma il fuso mitotico?
5. Come si conclude la fase M del ciclo cellulare?
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 25
Per approfondire
25
Il cancro
Ogni anno nel mondo diversi milioni di persone muoiono di cancro, o tumore, una grave malattia in cui le cellule dell’organismo si
riproducono in modo incontrollato, distruggendo i tessuti sani. A differenza di altre patologie, causate da agenti estranei, il cancro
dipende proprio dalle nostre cellule: per questo è così difficile da curare.
In generale, lo sviluppo di un tumore (figura
1) comincia quando “si inceppano” i normali meccanismi che controllano i processi di
crescita e di moltiplicazione cellulare. In queste circostanze una cellula o un gruppo di
cellule possono dare origine a una massa anomala. Spesso i tumori sono benigni, vale a dire che non causano problemi perché rimangono confinati alla sede in cui si sono formati,
senza interferire con i tessuti circostanti: va detto comunque che anche un tumore benigno
può essere pericoloso, se si forma in una parte del corpo, come il cervello o il midollo spinale, in cui può creare danni irreparabili solo per la sua presenza.
In altri casi, invece, un tumore può diffondere dal luogo di origine verso altre parti del
corpo, formando nuove masse tumorali chiamate metastasi: si parla in questi casi di tumori maligni (figura 1). Spostandosi, le cellule
maligne assorbono sostanze nutritive destinate ad altre cellule, bloccano le connessioni
nervose e impediscono agli organi che invadono di funzionare correttamente: il delicato equilibrio delle varie funzioni del corpo si
altera e ne risulta una malattia potenzialmente mortale.
Le cause del cancro
Esistono diversi tipi di cancro: tutti, però,
hanno in comune il fatto di essere causati da
alterazioni nei geni, che sono porzioni di cromosomi che trasmettono le informazioni ereditarie. Vi sono geni che controllano la crescita e lo sviluppo delle cellule. Queste alterazioni
possono essere causate da diversi fattori, tra
cui: alcune sostanze chimiche, come il benzene contenuto nel fumo di sigaretta, l’esposizione a radiazioni (anche quelle ultraviolette del Sole, se l’esposizione è eccessiva), alcuni
virus e il danno a geni che, a cascata, ne controllano altri.
Un elevatissimo numero di cellule tumorali
possiede alterazioni in un gene chiamato p53.
Se per qualche motivo i cromosomi non sono integri o il DNA è danneggiato, il gene
p53 impedisce la progressione del ciclo cellulare e la divisione della cellula. Una sua alterazione può facilmente provocare una disfunzione in questo meccanismo di controllo,
B
A
Le cellule tumorali danno origine
a un tumore, la cui presenza interferisce
con la normale disposizione delle cellule
e dei tessuti adiacenti.
Una cellula comincia a dividersi in modo
anomalo.
C
Figura 1 La crescita delle cellule tumorali.
La crescita e la divisione delle cellule sono
sottoposte a un rigido controllo; le cellule
tumorali si sottraggono a questo controllo
e continuano a crescere e a riprodursi fino
a dare origine a un tumore.
Le cellule tumorali possono allontanarsi
dalla sede di origine ed entrare nel circolo
sanguigno o linfatico. In questo modo,
il cancro può diffondersi ad altre parti
del corpo, formando tumori secondari
(metastasi).
con la conseguente insorgenza di forme tumorali.
La cura del cancro
Tanto per cominciare, è buona norma cercare di prevenire il cancro; gli esperti consigliano per esempio di evitare di fumare e di esporsi a radiazioni solari troppo intense. Anche
un regolare esercizio fisico e una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, sono d’aiuto in questo senso.
Se il cancro è già comparso, una diagnosi precoce e una terapia immediata possono aumentare notevolmente le probabilità di guarigione. Purtroppo, però, spesso il cancro è
silente nelle fasi iniziali: quando compaiono
i primi sintomi, la malattia può essere a uno
stadio così avanzato che diventa impossibile
fermarla.
Quando è ancora possibile intervenire, spesso il trattamento chirurgico costituisce la soluzione migliore. Se il cancro è già diffuso o
non può essere rimosso completamente si ricorre invece alla radioterapia, cioè all’uso localizzato di radiazioni per distruggere le cellule tumorali, oppure alla chemioterapia, il
trattamento con una miscela di farmaci che interferiscono con la duplicazione del DNA e
la divisione cellulare. La chemioterapia è molto efficace in certe forme tumorali, quali per
esempio la leucemia infantile, ma ha molti
sgradevoli effetti collaterali – nausea, vomito,
cefalea, perdita di capelli – perché i potenti
farmaci usati interferiscono anche con le cellule sane. Per questo, i ricercatori stanno cercando di mettere a punto farmaci che siano
sempre più efficaci ma che allo stesso tempo
producano il minor numero possibile di effetti collaterali.
Per capire e per riflettere
1. Tutte le forme di cancro:
a. sono ereditarie.
b. sono causate da virus.
c. dipendono da una crescita incontrollata
delle cellule.
d. formano metastasi.
2. Per quale motivo il cancro può essere
definito una malattia genetica?
3. Quali sono i principali agenti responsabili
della formazione di tumori? Per ciascuno
di essi, indicate anche una strategia che
permetta di limitarne l’effetto dannoso.
4. Da che cosa dipendono gli effetti collaterali
della chemioterapia? Da un punto di vista
teorico, come potrebbero essere superati?
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:32
Pagina 26
26 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
Le risposte
alle domande guida
Lezione 3
■
Lezione 1
■
La teoria cellulare afferma che: tutti gli esseri viventi
sono costituiti da cellule; le cellule sono le unità strutturali e funzionali di base di tutti gli organismi viventi; tutte le cellule si originano da cellule preesistenti.
■
Nelle cellule procariote il materiale genetico non è
racchiuso in un nucleo. Le cellule eucariote contengono un nucleo che separa il materiale genetico dal
resto della cellula.
■
In un organismo pluricellulare si distinguono quattro livelli di organizzazione: le singole cellule, i tessuti, gli organi e i sistemi.
Lezione 4
■
Durante il ciclo cellulare una cellula cresce, si prepara alla divisione e infine si divide in due cellule figlie,
ognuna delle quali darà inizio a un nuovo ciclo.
■
La mitosi è il primo stadio della divisione cellulare
nelle cellule eucariote e consiste nella divisione del
nucleo. Essa può essere suddivisa in quattro fasi: profase, metafase, anafase e telofase.
Durante la profase l’involucro nucleare si dissolve fino a scomparire, i cromosomi si condensano e appare il fuso mitotico.
Durante la metafase i cromosomi si allineano al centro della cellula.
Durante l’anafase i centromeri si dividono e i due
cromatidi fratelli si separano per diventare cromosomi indipendenti.
Nella telofase i cromosomi riprendono la forma di
cromatina diffusa, mentre attorno a essi si riforma
l’involucro nucleare.
La citodieresi è il secondo stadio della divisione cellulare e consiste nella divisione del citoplasma.
Lezione 2
■
Il nucleo contiene quasi tutto il DNA della cellula e con
esso le istruzioni codificate per la produzione delle
proteine e di altre importanti molecole.
■
I ribosomi sono piccoli organuli costituiti da RNA e
proteine nei quali, in base alle istruzioni ricevute dal
nucleo, vengono prodotte e assemblate le proteine.
■
Il reticolo endoplasmatico è il luogo in cui vengono
assemblati i componenti lipidici della membrana plasmatica, insieme alle proteine e ad altri materiali che
devono essere trasportati all’esterno della cellula.
■
■
L’apparato di Golgi ha la funzione di modificare, smistare e confezionare le proteine e altri materiali prodotti nel reticolo endoplasmatico per prepararli a essere immagazzinati nella cellula o espulsi all’esterno.
I lisosomi sono piccoli organuli ricchi di enzimi digestivi in grado di demolire in molecole più piccole
qualsiasi sostanza presente all’interno della cellula.
■
I mitocondri trasformano l’energia chimica contenuta nelle molecole di glucosio in composti che le cellule sono in grado di utilizzare direttamente.
■
I cloroplasti catturano l’energia solare e la convertono in energia chimica nella fotosintesi.
■
I vacuoli sono strutture a forma di sacco in cui vengono immagazzinate sostanze di vario tipo.
■
Il citoscheletro è una rete di filamenti proteici che dà
forma alla cellula e partecipa a molti suoi movimenti.
Quando una cellula diventa più grande, aumentano le
richieste nei confronti del suo DNA. Inoltre, crescendo, la cellula deve far fronte a un maggior numero di
problemi legati al trasporto di sostanze attraverso la
membrana plasmatica.
■
■
Le cellule tumorali non rispondono ai segnali che regolano la crescita della maggior parte delle cellule.
Le parole chiave
Puoi rivedere nel Glossario in fondo al volume le definizioni delle parole chiave che hai imparato in questa unità.
anafase • apparato • apparato di Golgi • cellula • centriolo
• centromero •ciclo cellulare • ciglia • citodieresi •
citoplasma • citoscheletro • cloroplasto • cromatidi fratelli
• cromatina • cromosoma • divisione cellulare • eucariote •
flagelli • fuso mitotico • interfase • involucro o membrana
nucleare • lisosoma • membrana plasmatica • metafase •
microscopio ottico • mitocondrio • mitosi • nucleo •
nucleolo • organismo pluricellulare • organismo
unicellulare • organo • organulo • osmosi • procariote •
profase • rapporto superficie/volume • reticolo
endoplasmatico • ribosoma • scissione binaria • telofase •
tessuto • tumore • vacuolo
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:33
Pagina 27
UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 27
Vero o falso?
Mettiti alla prova!
Lezione 1
19 La maggior parte delle cellule ha dimensioni
Per ripassare
dell’ordine dei micrometri.
sia unicellulari sia pluricellulari.
Lezione 1
21 La cellula vegetale contiene i mitocondri.
…………………………… .
V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
22 La divisione cellulare determina
2 Il …………………………… è la regione della cellula esterna al
nucleo.
Lezione 3
una riduzione del rapporto
superficie/volume.
Lezione 4
3 Il processo attraverso cui una cellula si divide in due cel-
lule figlie è chiamato …………………………… …………………………… .
23 Gli organismi pluricellulari si riproducono
mediante la divisione cellulare.
24 Al termine della mitosi, le cellule figlie
Lezione 4
contengono solo la metà dei cromosomi
presenti nella cellula madre.
4 Ogni cromosoma è costituito da due filamenti
identici, chiamati …………………………… .
25 Sia i cromosomi sia i cromatidi sono
5 Si definisce …………………………… …………………………… tutto ciò
formati da DNA.
che accade a una cellula dal momento in cui si forma al momento in cui si divide.
Scegli la soluzione corretta.
Lezione 1
6 La duplicazione del DNA avviene durante la fase
…………………………… .
26 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
Associa ciascuno dei seguenti termini all’immagine appropriata e riporta la lettera corrispondente nello spazio assegnato.
a
Lezione 4
c
………
F
Lezione 3
Lezione 2
8
V
Lezione 2
1 Le cellule prive di nucleo sono chiamate
………
F
20 Gli organismi eucarioti possono essere
Sai utilizzare le parole che hai imparato?
7
V
cromosomi
d
c
centromero
9
………
centriolo
10
………
fuso mitotico
b
Tutte le cellule derivano dalla divisione di altre
cellule.
Le cellule eucariote sono provviste di un nucleo.
I batteri sono organismi procarioti.
Tutti gli organismi unicellulari sono procarioti.
Lezione 2
27 Le informazioni genetiche sono racchiuse in struttu-
b
d
a
re chiamate:
a
ribosomi.
b
cromosomi.
c
d
lisosomi.
vacuoli.
Lezione 3
Completa la mappa inserendo i termini appropriati.
Lezione 4
Il ciclo cellulare
comprende
11 ………………………
12 ………………………
che comprende
che comprende
tre fasi
13 ………………………
16 ………………………
14
15
……………………
……………………
in cui
si divide il
18
17 ………………………
……………………
in cui
si divide il
28 La velocità con cui una cellula scambia materiali con
l’esterno dipende:
a
dal suo volume.
b
dalla sua massa.
c
dalla sua area superficiale.
d
dal suo peso.
29 Quando una cellula raddoppia il proprio diametro,
il suo volume aumenta di:
a
due volte.
b
quattro volte.
c
sei volte.
d
otto volte.
Lezione 4
30 Se una cellula ha 12 cromosomi, quanti cromosomi
citoplasma
avrà ognuna delle sue cellule figlie dopo la mitosi?
a
12
b
24
c
6
d
4
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari
11-04-2011
17:33
Pagina 28
28 LE CELLULE: ALLA BASE DELLA VITA
31 Durante la fase G1 del ciclo cellulare avviene:
a
b
c
d
la duplicazione dei cromosomi.
l’accrescimento cellulare.
la divisione del citoplasma.
la formazione del fuso mitotico.
Rispondi in modo sintetico alle seguenti domande.
Lezione 1
45 Descrivi la teoria cellulare.
46 Elenca le ceratteristiche di procarioti ed eucarioti.
Lezione 2
32 Che cosa differenzia la divisione di una cellula di ra-
na da quella di una cellula di cipolla?
a
I due processi sono identici.
b
Nella cellula di cipolla i cromosomi sono formati da un solo cromatidio.
c
Il fuso mitotico si forma solo nelle cellule della rana.
d
La citodieresi si svolge diversamente.
33 Quale delle seguenti immagini rappresenta l’anafa-
47 Quali sono le funzioni del nucleo e delle diverse strut-
ture che lo compongono?
48 Quali organuli eseguono la “pulizia” della cellula?
49 Quale organulo immagazzina acqua e sali minerali
nella cellula vegetale?
50 Qual è la funzione dei microtubuli e dei microfila-
menti?
Lezione 3
51 In che modo il DNA cellulare può limitare le dimen-
se della mitosi?
a
sioni di una cellula?
c
52 In che modo la crescita potenziale di una cellula è in-
fluenzata dal suo rapporto superficie/volume?
Lezione 4
53 Che cosa succede durante il processo della divisione
cellulare?
d
b
54 Descrivi come cambiano i cromosomi prima della di-
visione cellulare.
55 In che cosa consiste il ciclo cellulare?
56 Spiega la relazione tra i seguenti termini: DNA, cen-
tromero, cromosoma, cromatidio.
34 La divisione cellulare incontrollata avviene:
a
b
c
d
57 Che cosa succede durante l’interfase?
nelle cellule della pelle.
durante la citodieresi.
nelle cellule nervose.
nelle cellule tumorali.
Lezione 2
35 reticolo
endoplasmatico
ruvido
36 reticolo
endoplasmatico
liscio
37 apparato di Golgi
38 mitocondrio
39 cloroplasto
a produce l’energia necessa-
vi che cosa accade durante ognuno di essi: anafase, metafase, telofase e profase.
Per riflettere e applicare le conoscenze
Rispondi alle seguenti domande.
Lezione 2
59 Descrivi le principali funzioni delle diverse parti del-
ria per le attività cellulari
la cellula.
b possiede ribosomi sulla
60 Osserva l’immagine e rispondi alle seguenti doman-
superficie esterna
de.
c è la sede della fotosintesi
E
d modifica le proteine per
ribosoma
(libero)
e sintetizza i lipidi di mem-
F
ribosoma
(attaccato)
A
Lezione 4
41 metafase
involucro nucleare
l’immagazzinamento
o l’espulsione
brana
40 telofase
nucleolo
D
a i cromosomi si allineano al cen-
tro della cellula
42 profase
b la cromatina si condensa
43 anafase
c si forma l’involucro nucleare
44 interfase
d il DNA si duplica
e i cromatidi fratelli si separano
B
C
G
membrana
plasmatica
AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPE-
Collega i termini elencati a sinistra con le affermazioni appropriate della colonna a destra.
58 Elenca nel corretto ordine i seguenti eventi e descri-
11-04-2011
17:33
Pagina 29
E * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE
UNITÀ 1 DALLA CELLULA AGLI ORGANISMI 29
a Questa immagine rappresenta una cellula vege-
65 Scegli due organuli cellulari e descrivi in che modo
tale, animale o procariote? Spiega la tua risposta.
le loro funzioni potrebbero essere ostacolate nel caso in cui la cellula diventasse troppo grande.
b Associa a ogni lettera il nome della struttura cel-
lulare corrispondente.
Lezione 4
c Qual è la relazione tra le strutture D e F?
loro citoplasma. Quale fase del ciclo cellulare non si è
svolta quando si sono formate cellule di questo tipo?
d Qual è la funzione della struttura A?
61 Contiene più mitocondri una cellula della pelle o una
cellula muscolare? Perché?
Lezione 4
Domande 62-63 Le fibre del fuso mitotico di una cellula
in divisione sono state trattate con un colorante fluorescente. All’inizio dell’anafase, è stato utilizzato un raggio laser
per bloccare l’azione del colorante su un lato della cellula,
così da marcare le fibre, come mostrato nella seconda immagine. Il laser non inibisce la normale funzione delle fibre. Osserva l’immagine e rispondi alle domande che seguono.
il raggio laser marca
le fibre del fuso
67 Una normale cellula del corpo umano possiede 46
cromosomi. Indica quanti cromosomi e quanti cromatidi contiene una cellula umana durante la fase G2. Spiega le ragioni della tua risposta.
Sai interpretare i risultati di un esperimento?
inizio
dell’anafase
66 Alcune cellule contengono più nuclei all’interno del
l’anafase
continua
marcatura
Per gli appassionati
Facciamoci un giro!
Negli incroci stradali, i semafori passano successivamente
dal verde, al giallo, al rosso. Affinché questa segnaletica funzioni efficacemente, è necessaria un’accurata regolazione del
ciclo delle diverse luci. In caso contrario, si verificherebbero
ingorghi e presumibilmente incidenti stradali. Attraverso la
seguente attività potrai riflettere su questa domanda: tutti i
cicli devono essere regolati, come accade per i semafori?
a. Considera un qualsiasi fenomeno ciclico che ti è noto
e descrivi gli eventi che si verificano in ogni sua fase.
b. Il ciclo da te descritto ha una sua regolazione? Spiega la
tua risposta.
c. Che cosa potrebbe succedere se il tuo ciclo non fosse
regolato?
d. Che cosa potrebbe succedere se il ciclo cellulare non
avesse una sua regolazione?
In English, please!
62 Questo esperimento ha lo scopo di verificare un’ipo-
tesi riguardante:
a
l’azione dei coloranti fluorescenti sulle cellule.
b
la modalità di migrazione dei cromosomi durante la divisione cellulare.
c
l’effetto dei laser sulle cellule.
d
il motivo per cui le cellule si dividono.
63 Quale delle seguenti conclusioni può essere tratta
da questo esperimento?
a
I centrioli tirano i cromosomi verso i poli opposti della cellula.
b
I cromosomi non migrano in presenza del colorante.
c
I cromosomi migrano solo se trattati con il colorante.
d
I cromosomi migrano lungo le fibre verso i poli opposti della cellula.
The cell cycle
Complete the following diagram of the cell cycle matching the
right sentence with each number.
1 ……………………………
4 ……………………………
The chromatin
condenses into
chromosomes.
The chromosomes
gather at opposite
ends of the cell.
2 ……………………………
3 ……………………………
Rispondi alle seguenti domande.
a The sister chromatids separate into individual chromosomes
and move apart.
Lezione 3
b The chromosomes line up across the middle of the cell.
64 Calcola l’area superficiale, il volume e il rapporto su-
perficie/volume di un’ipotetica cellula cubica con uno
spigolo di 5 mm.
c The cell grows and replicates its DNA and centrioles.
d The cell membrane pinches the cytoplasm in half.
AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE * AREA COMPETENZE *
a
o)
9788863642926A_018_029_Unita1_lez3-4.qxd:BIO mari