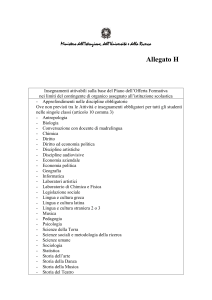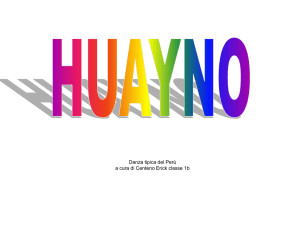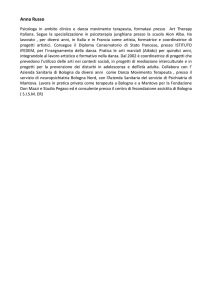Il tarlo e le rose
Conversazione con Alessandro Pintus
di Maria Pia D’Orazi
Un vecchio mobile immerso nel buio al centro della scena. E rumori di una vita che
riprende il suo corso abituale in sottofondo: la sveglia del mattino, la radio, il caffè, i
denti, la doccia fischiettando e i passi scanditi da una porta che si apre e si richiude. È
il mondo, secondo l’esperienza del tarlo che abita il legno. Fuori, un guardiano
armato di paletta tenta instancabilmente di eliminare l’intruso. La danza comincia.
Con il suo ultimo spettacolo, Alessandro Pintus materializza un sogno e una
suggestione. La visione notturna di un uomo uscito fuori da un appendiabiti
improvvisamente animato che sussurra una parola senza senso: bugimirò! E l’idea
che quell’uomo sia la trasfigurazione di un tarlo intrappolato nel suo interno.
Intrecciando immaginazione e memoria personale Bugimirò diventa il suo modo per
raccontare un desiderio di trasformazione che rappresenta la condizione stessa del
danzatore, perennemente in cerca dell’altro da sé per attingere una più autentica
conoscenza di sé e dell’altro. Il tarlo come entità misteriosa che abita il corpo del
performer e lo spinge a muoversi dall’interno: “Un pensiero, una memoria che sta
maturando e si sta facendo carne per passare attraverso la danza in una fase diversa”.
Il tarlo come simbolo della condizione dell’essere umano nella società
dell’immagine, anche lui intrappolato “nelle gallerie che si è scavato da solo, girando
su se stesso e raggirando se stesso”. E nello stesso tempo il tarlo come proiezione di
un eventuale riscatto, perché “il tarlo che si muta in farfalla sta lì a dimostrare che
cambiare è possibile e fa parte dell’ordine naturale delle cose”.
Le scene si susseguono seguendo il ciclo di vita di un animaletto che nasce da un
uovo deposto nell’interstizio di un mobile, si sviluppa nei tunnel che crea nutrendosi
delle fibre di legno, esce in primavera per accoppiarsi dopo aver preso forma di
farfalla e muore, poche ore dopo essersi riprodotto. E ogni quadro trova nella danza
un contrappunto di sensazioni che amplificano la metamorfosi continua “da uovo a
larva a bozzolo a farfalla a niente…”.
Il risultato è un gioco ironico grottesco romantico e un po’ amaro fra il tarlo, il suo
guardiano e due uomini in nero che si aggirano sul palco trasportando cumuli di
segatura che il coleottero lascia dietro di sé: la testimonianza di un’abitudine a
distruggere quello stesso mondo che gli offre un riparo.
Pintus interpreta entrambi i personaggi con lo spirito della coppia “Lupin e
Zenigata”: “Eroe e nemico dell’eroe – spiega – figure mai completamente positive né
negative, come nei cartoni di Miyazaki. Energie opposte che si completano e
motivano l’uno l’esistenza dell’altro”. Due dei suoi allievi (Raffaele Zenobi e
Donato Simone) sono invece i black men – ispirati allo studio del bunraku (ndr: il
teatro di marionette giapponese) – “materializzazioni dello spirito del mobile che
manipolano sia il tarlo che il guardiano, trasformando questi ultimi in marionette,
corpi che si lasciano abitare e che si muovono senza volontà propria”.
Poi l’amore arriva, e il tarlo, che pensa di essere un uomo, tenta di sedurre una donna
con l’unico modo che ha imparato ascoltando i riverberi del mondo dalla sua tana:
una serenata e un mazzo di fiori. Pintus sceglie una canzone dal patrimonio dei suoi
affetti: Rose rosse, nella versione spagnola di Massimo Ranieri, quella tanto amata
dalla nonna. Senza rinunciare al colpo di scena di un cambio di costume istantaneo a
vista che potrebbe far pensare a un analogo espediente del kabuki (il cosiddetto
hikinuki), o più semplicemente, come ha fatto notare Eugenio Barba (nella Canoa di
carta), a uno di quei tanti momenti solenni della liturgia cattolica: quando il drappo
viola cade all’improvviso per svelare la resurrezione del Cristo durante le
celebrazioni pasquali; o quando in corsa su una portantina la Madonna perde i colori
del lutto in un vero e proprio cambio d’abito nella processione della Madonna che
scappa di Sulmona.
Ora il tarlo “è” un mazzo di fiori e indossa una vestaglia con trecento rose rosse
cucite sopra sul modello di un kimono. La sua ultima danza è una danza d’amore.
Subito dopo muore su una lampada elettrica del guardiano che, senza di lui, non ha
più motivo di vivere e, “nella follia totale, danza prendendo le sembianze del tarlo”.
Tutto può ricominciare. Ecco, “la vita è in continua trasformazione” e la danza è la
metamorfosi di un corpo che insegue le sue memorie e si lascia abitare dalla presenza
dell’altro assecondandone le diverse forme e qualità dell’energia. Nessuna
imitazione, piuttosto incorporazione.
Pintus confeziona un lavoro che cerca di consolidare attorno a un percorso narrativo
l’esperienza del butō giapponese e la sua visione del corpo come entità misteriosa e
oscura, ricca di possibilità inesplorate. Un corpo totale e anarchico, che sceglie come
modello la natura e non esaurisce affatto la sua vita nella quotidianità delle abitudini
acquisite.
Un lavoro che è anche l’ultimo atto di una trilogia sull’età, assieme a N (2006), Pane
e Amore e… (2008) e ora Bugimirò. Il primo, dedicato alla nascita, affronta la
vulnerabilità della vita nel suo momento più delicato e fragile, prende le sembianze di
un seme di canna palustre che germoglia in uno stagno e insegue un ricordo di
bambino: un altro tempo e un altro luogo, la Sardegna degli avi. In scena un corpo
nudo, che improvvisa nella più completa e generosa esposizione di sé. Il secondo è
una ribellione che irrompe con tutta l’energia dell’adolescenza. È “l’atto dionisiaco di
smembramento e di sacrificio di sé” identificato nell’offerta rituale di un capro –
vestigia delle feste carnevalesche sarde – e in un momento preciso della nostra storia:
“Il risorgimento italiano mai maturato, il dono fatto da Garibaldi ai Savoia, e la figura
del garibaldino come l’ultimo giapponese: quello che continua a combattere senza
sapere che la guerra è finita”. Con Bugimirò infine siamo all’età adulta e Pintus
chiude idealmente un cerchio personale.
“Il mobile protagonista è un vecchio appendiabiti rimasto per quaranta anni nella
casa della nonna, di quelli con lo specchio e una porta scorrevole” dice. Il suo aveva
un’incisione giapponese: una casa su un’isola, “una premonizione del futuro”. Da
ragazzino Pintus è qui che inventa i suoi giochi nei fine settimana senza giocattoli
della sua infanzia, trasformandolo in astronave, ascensore, mercato, nascondiglio per
sé e i suoi amichetti. In questa stessa casa vive da più di dieci anni e, negli ultimi
tempi, nel mobile ha cominciato a sentire il rumore incessante di un tarlo. Nessun
rimedio riesce a farlo tacere. Poi un giorno non si sente più. È allora che in sogno il
mobile s’illumina, si anima, si aprono le ante e appare una figura animalesca che
sussurra: bugimirò! Curioso del tarlo Pintus scopre che vive nel legno dai tre ai
cinque anni, durante i quali maschio e femmina si parlano attraverso un richiamo
sessuale, poi diventano farfalle escono, si accoppiano e di nuovo depongono le uova.
La fantasia compie il resto e quell’oggetto finisce per diventare il punto d’unione fra
due estremi: l’inizio della vita, il momento irripetibile dell’infanzia e dei giochi; e la
parte finale, quella in cui un ragazzo che accudisce i nonni fa esperienza della morte.
A dispetto di quanti continuano a considerare il butō un genere dalle atmosfere cupe e
inquietanti, questa volta Pintus, spinto da “una nipotina che non riesce mai a portare
a teatro”, ha seguito la vena del travestimento e dell’ironia assecondando un desiderio
di parlare a tutti, compresi nonni e bambini. E per tutti ha confezionato una favola
completa di illusioni. Il mobile lo ha ricostruito da sé modificandolo, in tre mesi di
lavoro. Nella versione scenica c’è uno specchio simpatico con un videoproiettore sul
retro e un doppiofondo (che si apre, con una tendina che diventa uno schermo).
Il mobile è il punto di partenza di un percorso creativo durato circa otto mesi. È cassa
di risonanza che produce suoni e rumori propri. È luogo di visioni.
La premessa della composizione affrontata in stretta collaborazione col musicista
Gabriele Quirici e il video-artista Simone Palma, è l’idea che lo spazio abitato dal
tarlo somigli alla caverna del mito platonico, un luogo in cui la realtà si riduce a
parvenza, ombra proiettata su una parete di roccia. E siccome questo mondo è
inaccessibile “non solo perché minuto, ma anche perché non è visibile né udibile”,
spetta alla tecnologia restituircene un ritratto.
Microfoni a contatto inseriti nel legno, sensori applicati al corpo del danzatore e sulla
scena catturano suoni e rumori provocati dalla scenografia e dal performer, che
finiscono per diventare essi stessi “strumenti sonori”. Il musicista riproduce e
amplifica il suono o lo modifica improvvisando dal vivo.
Anche il corpo del danzatore è un’entità cava, e riproduce in sé un microcosmo
sconosciuto. Per un gioco di proiezioni “il corpo del performer diventa lo stesso
mobile eroso” e produce immagini riprese all’interno (bocca, orecchio, naso) con una
piccola telecamera endoscopica. La stessa che esplora i buchi del legno. Mentre un
gioco di ombre digitali rende visibile la formazione della farfalla e il suo volo.
Secondo Pintus “il corpo quotidiano è una caverna nella quale si proiettano immagini
distorte della realtà effettiva del corpo”. Attraverso la danza si può uscire dalla
caverna – spezzare le abitudini – per diventare coscienti del corpo nella sua totalità, e
conquistare una diversa qualità della presenza e del nostro essere al mondo.
Gli appassionati del genere possono riconoscere citazioni da Min Tanaka (il
guardiano che arriva rigidamente avvolto da un impermeabile), Yoko Ashikawa (la
piccola larva che tenta di distendersi comicamente saltellando da un punto all’altro
della scena), Kazuo Ōno (l’abito di rose) o Sankai Juku (i cumuli di segatura come
sabbia sparsi sulla scena). Alessandro Pintus è un po’ tutti loro e se stesso,
meticolosamente preciso nello svelare tutte le sue immagini e forse per questo ancora
un po’ sfuggente.
Studente di psicologia a Roma negli anni Novanta, Pintus si avvicina al teatro come
attore in una compagnia dell’Università. Poi, mentre si prepara per affrontare il ruolo
di Calibano nella Tempesta, vede il film di Peter Greenaway e resta colpito
dall’interpretazione che ne fa il danzatore scozzese Michael Clark, dalla sua “capacità
di incarnare lo spirito del demone della terra senza dover di dire nemmeno una
parola”. La sua attenzione si sposta sul corpo e comincia a studiare il butō. Seminari
con diversi danzatori presenti in Europa – da Masaki Iwana a Ko Murobushi a Min
Tanaka a Carlotta Ikeda. Poi l’incontro con Pier Paolo Koss, il primo danzatore
italiano che ha lavorato con i giapponesi (Murobushi) e “un ottimo esempio di un
italiano che ricerca un ponte fra due culture”. Perché ciò che è subito chiaro nel butō,
è il confronto fra due diverse culture del corpo. Pintus si rende conto che “i
giapponesi non conoscevano la nostra cultura e noi non potevamo comprendere la
loro nella carne”, avverte una stonatura: “Facevo bene l’esercizio ma sentivo un
conflitto fra comprensione mentale e risultato corporeo”. L’esperienza con Koss è il
primo passo per riflettere su alcuni concetti fondamentali: “Quando noi usiamo delle
immagini di danza – spiega – prendiamo le immagini in maniera letterale e formale.
La danza occidentale parte dalla forma e la comprensione è prima di tutto mentale.
Quando ti trovi di fronte una proposta del tipo ‘viaggiare sull’oceano finché i
polmoni diventano blu’ la vuoi capire con la logica e poi trasferire al corpo. Il
linguaggio del butō elaborato da Tatsumi Hijikata, invece, è di impatto diretto, punta
all’intelligenza del corpo, lo mette in crisi direttamente. La mente arriva dopo.
Hijikata passa attraverso le metafore del corpo, usa un linguaggio onomatopeico ricco
di suoni, senza contare che la stessa lingua giapponese è fisica e corporea: in un
ideogramma c’è anche la simbolizzazione dell’oggetto non solo il significato, c’è un
suono e un profumo. La parola passa attraverso l’esperienza fisica. Il logos è usato
immediatamente al livello della carne. Noi invece dobbiamo fare un salto culturale
per arricchirla o rinnovarla”.
Per Pintus cominciano le domande. “Cosa è l’immagine di danza? A quale parte di
me parla per prima?”.
All’epoca studia con Min Tanaka per dieci giorni nella campagna romana (Tuscania
1999) e riconosce subito una differenza nella percezione di sé: “In natura il corpo è
immediatamente pronto, risvegliato e attento e non c’è bisogno di training
particolari”. Pintus passa attraverso la difficoltà del “non faccio se non capisco” sente
il bisogno di un approfondimento e il passo successivo è un viaggio in Giappone,
“per vedere come vivono il corpo da quelle parti”.
Di nuovo incontra Tanaka (che nel 2000 è a Roma per danzare nei giardini
dell’Accademia di Francia) e raccoglie l’invito a seguirlo nella sua fattoria fuori
Tokyo, ad Hakushu. Nell’inverno del 2001 Pintus è là e Tanaka è il maestro che lo
guida verso un nuovo modo di sentire; da lui più che una tecnica, impara
l’importanza di un linguaggio che maturi attraverso i sensi: “Noi occidentali
vogliamo comprendere il mondo attraverso il linguaggio, non lo conosciamo
attraverso le sensazioni. Se dovessi spiegare le sensazioni dell’oggetto bicchiere non
ho un vocabolario di esperienze così raffinato da poterlo descrivere. Dentro di noi
abbiamo un vocabolario logico ma non abbiamo un vocabolario di sensazioni, o
meglio non siamo abituati ad arricchire e maturare il vocabolario delle sensazioni
così come i concetti. Nozioni intellettuali e sensazioni, sono due vocabolari con
diverso numero di pagine. La ricezione delle impressioni è meno sviluppata
dell’espressione”. L’esperienza della natura nella fattoria di Tanaka diventa uno
stimolo prezioso in una direzione differente dell’attenzione: “Quale fortuna trovarti a
quattro zampe sotto la pianta per vedere se ci sono delle bestie che la infestano e
scoprire in questa posizione una figura di danza. È stato più importante che qualsiasi
altra esperienza fatta in una sala professionale”.
Pintus torna ad Hakushu anche l’estate successiva: “La vita nella fattoria era
estremamente povera ma intensa, perché le estreme condizioni in cui veniva messo il
copro erano già di per sé danza. La giornata era divisa fra lavoro nei campi e danza
vera e propria. A volte le due cose si confondevano: alle cinque del mattino
raccoglievo i cetrioli e mi sorprendevo a danzare. Oppure capitava che, mentre
danzavamo, nello stesso tempo pulivamo il campo dalle erbacce”.
Tra gli eredi di Hijikata ritiene che Tanaka sia quello che ha portato il suo lavoro più
lontano: “Hijikata è morto con un progetto che non ha mai terminato: il Tohoku
kabuki (ndr: il ritorno ai luoghi della sua infanzia nel nord del Giappone). Tanaka,
che ha sempre evitato Hijikata per non essere condizionato dalla sua forza, lo ha
avvicinato soltanto negli anni Ottanta, l’ultimo periodo della sua vita, e con lui è
rimasto circa tre anni. Quanto è bastato per riceverne una summa di insegnamenti,
che Tanaka stesso ha poi sviluppato con il suo progetto di ‘danza e agricoltura’. È
tornato in campagna pur non essendoci nato, seguendo il sogno di Hijikata di tornare
alle proprie radici”.
Nei suoi viaggi in Giappone Pintus conosce Kazuo Ōno e il figlio Yoshito. E nella
lontananza si ricongiunge alle sue radici: “Avevo un nonno sardo al quale piaceva la
vernaccia – racconta – e poco prima che morisse guardammo assieme una
videocassetta di mia madre in cui danzava Kazuo Ōno. Il nonno era un pescatore e
non ha mai studiato, ma quel video è rimasto a guardarlo con me in salone fino alla
fine. Poi mi ha detto: Bravo, lo conosci? Si – gli ho risposto – e prima o poi lo
incontro. Beh! – mi dice – quando lo incontri regalagli una di queste (e prende una
bottiglia della sua vernaccia). Nel 2001 porto la bottiglia con me in viaggio e vado a
casa di Kazuo Ōno. Lui si era appena rotto il bacino e assisteva seduto su una
poltrona alla lezione diretta dal figlio. Prendo parte alla lezione e a un rinfresco che
abitualmente si teneva subito dopo per i saluti. Tiro fuori dal sacco la vernaccia
invecchiata 10 anni e la lascio sul tavolo. Se ne servono tutti e una ragazza mi chiede:
Buono, che cos’è? Racconto la storia che in un attimo arriva a Yoshito e da lui al
padre. Così Kazuo Ōno esprime il desiderio di danzare in onore di quel morto.
Chiede di essere messo a terra e comincia a danzare con la parte superiore del corpo”.
Grato per quel dono che Ōno faceva al nonno, Pintus capisce che “nonostante le sue
gambe non rispondessero lui continuava a danzare, rotolava e si agitava: la sua voglia
di danzare non era un’aspirazione edonistica ma un impeccabile desiderio di stare al
mondo, un’etica della danza precedente qualsiasi stile”.
Nei suoi pellegrinaggi Pintus include pure un altro dei santuari del butō, lo studio,
ormai inesistente, dove Hijikata ha vissuto e composto tutti i suoi spettacoli: il Teatro
Asbestos nel quartiere Meguro di Tokyo. Là, dopo la morte di Hijikata, la moglie
Akiko Motofuji ha continuare a dare lei stessa lezioni e a ospitare altri danzatori.
Pintus la incontra, avvolta da una nuvola di fumo, perché lei fumava sempre “anche
durante la lezione”. Il suo stile è una versione “molto superficiale e formale” del butō
di Hijikata, ma Pintus si lascia suggestionare dal luogo e ne assorbe la memoria,
immagina la storia che là si è svolta fantasticando sulle ammaccature delle tavole e
sul loro odore. Raccoglie impressioni e sensazioni.
Ultima tappa lo studio di Akira Kasai a Kokubunji, periferia di Tokyo. La lezione per
venti persone in una piccolissima stanza, il tè in una cucina dove spicca appesa al
muro la cartina geografica della Sicilia, “perché prima o poi avrebbe voluto andare
là”. Ecco: “I giapponesi i sogni se li appendono al muro e poi li danzano”.
Oggi ai suoi allievi Pintus insegna prima tutto a disarticolare il corpo per spezzare le
abitudini, lavorando contemporaneamente su diversi livelli di attenzione. Conduce
laboratori in sala e nella natura, cercando di sviluppare la percezione del corpo
attraverso il contatto diretto con gli elementi oppure usando contemporaneamente,
come proposte per la danza, immagini poetiche diverse per ogni parte del corpo:
“Sanguisughe sulle braccia, i gomiti perdono l’orientamento, la testa è un aquilone
sotto la pioggia, tra le cosce pietrificate un torrente in piena, una cicatrice al posto del
cuore, due gambe supplementari spuntano ai lati del bacino, polpacci piangono come
neonati, le piante dei piedi sono pergamene preziose e indecifrabili”. Negli ultimi
tempi invita direttamente pittori a lavorare in sala, e usa le loro immagini come
stimolo per ripercorrere un processo creativo oppure come modello da incorporare.
Invita ad affrontare il corpo nella sua imprecisione, a trattarlo “come un bel vassoio
che deve essere lucidato nella parte non esposta oppure a pensarlo come un tappeto
che nasconde una coltre di polvere”.
Dal 2003 nel suo lavoro è entrato anche Gurdjieff. O meglio quella parte del lavoro di
Gurdjeff che secondo Pintus condivide i principi del butō: “La profonda necessità di
trovare un’armonia tra la mente il corpo e le emozioni. L’idea di Hijikata di danzare
le tenebre non è un concetto negativo di autolesionismo ma è il profondo bisogno di
portare alla luce ciò che è inconsapevole all’individuo. Una metafora orientale dice
che l’essere è come una carrozza trainata da cavalli, la carrozza è il corpo i cavalli
sono le emozioni e il conducente è il pensiero. Se non c’è armonia fra questi tre centri
non c’è alcun viaggio possibile. Perché il padrone del viaggio non sono né i
sentimenti né il corpo né la mente, ma è necessaria un’armonia per potersi muovere e
dire ‘io sono’”. Pintus è convinto che la danza sia nello stesso tempo “un processo di
consapevolezza e lo strumento per raggiungere la consapevolezza”: “Il butō è un
mezzo non di realizzazione estetica ma di creazione consapevole del me che deve
ancora nascere. Hijikata spesso parlava della necessità di nascere più volte e per
questo si metteva in condizioni critiche: voleva risvegliare il corpo con la
disperazione. Nelle danze sacre ho ritrovato l’idea che l’essere umano vive per la
maggior parte della sua esistenza un sonno simile alla morte. La danza è necessaria
per mutare questa forma da buia a luminosa. La danza è il processo di tutta una vita.
Ed è il mezzo affinché io possa compiere il mio dovere come essere vivente, ripagare
il debito di gratitudine per essere nato con una scintilla divina di coscienza dentro di
me”. Naturalmente non bisogna confondere le due cose, “Gurjdeff non è fatto per
essere visto in teatro e non ha finalità estetica, perché il suo scopo è l’elevazione
energetica e spirituale, la manifestazione del divino nell’essere per raggiungere
l’armonia. Tuttavia ci sono delle identità nel tipo di tecniche utilizzate per risvegliare
il corpo (il lavoro sulla disarticolazione o quello sul dislocamento dell’attenzione –
per esempio fare calcoli aritmetici a voce alta mentre si danza)”.
Oggi Pintus è convinto che la cosa più importante sia “guidare le persone a
sviluppare un proprio vocabolario di sensazioni e danzare a partire da queste”: “Mi
interessa quanto gli allievi riescono a rimanere disperatamente attaccati alle
sensazioni che nascono in loro. Non svuotarsi mai credo sia la cosa più importante
per un danzatore. Danzare a partire dalle sensazioni vuol dire avere sempre un
contenuto vibrante che muove la danza. Ecco il nocciolo del butō: il corpo che viene
mosso dalle sensazioni e non la mente che guida un movimento per creare una
forma”.