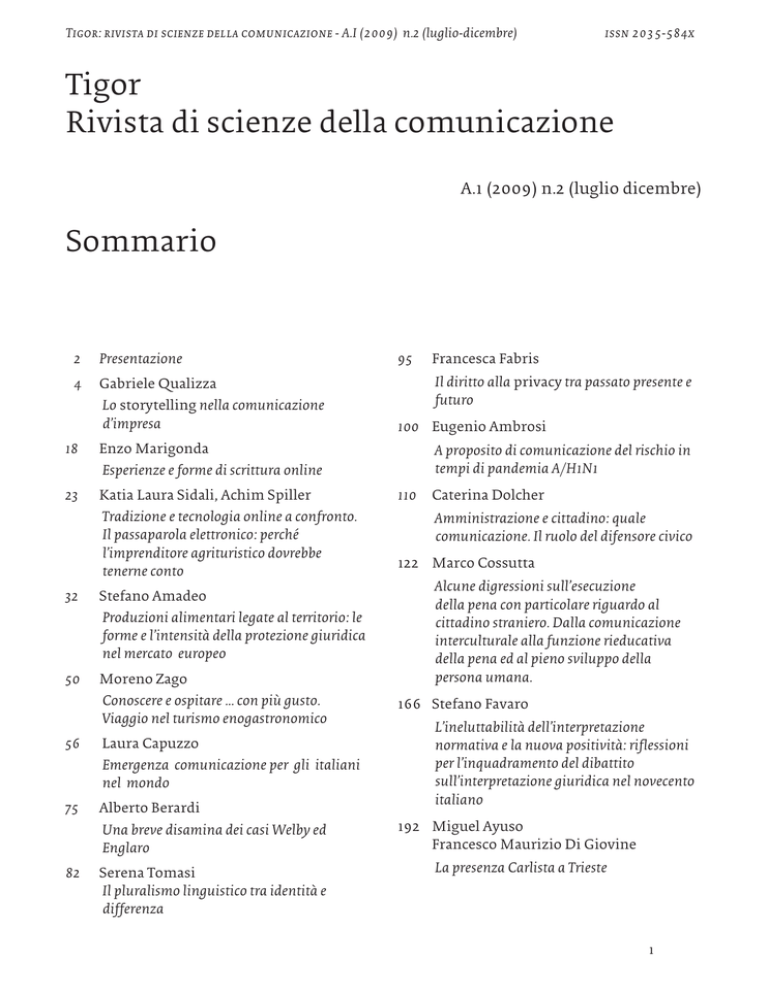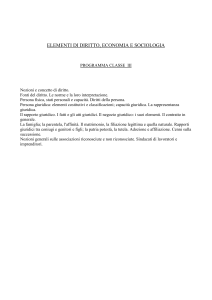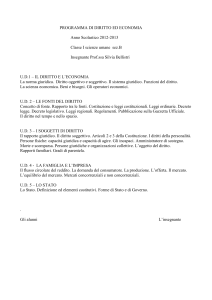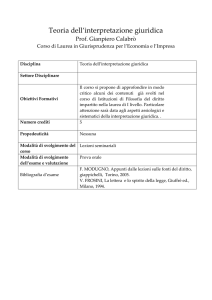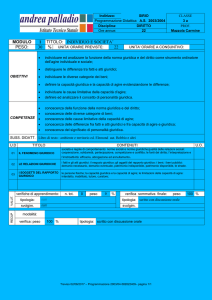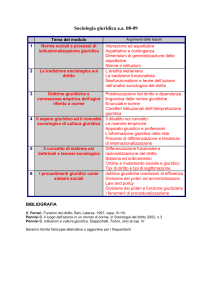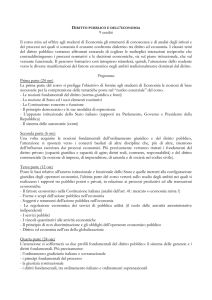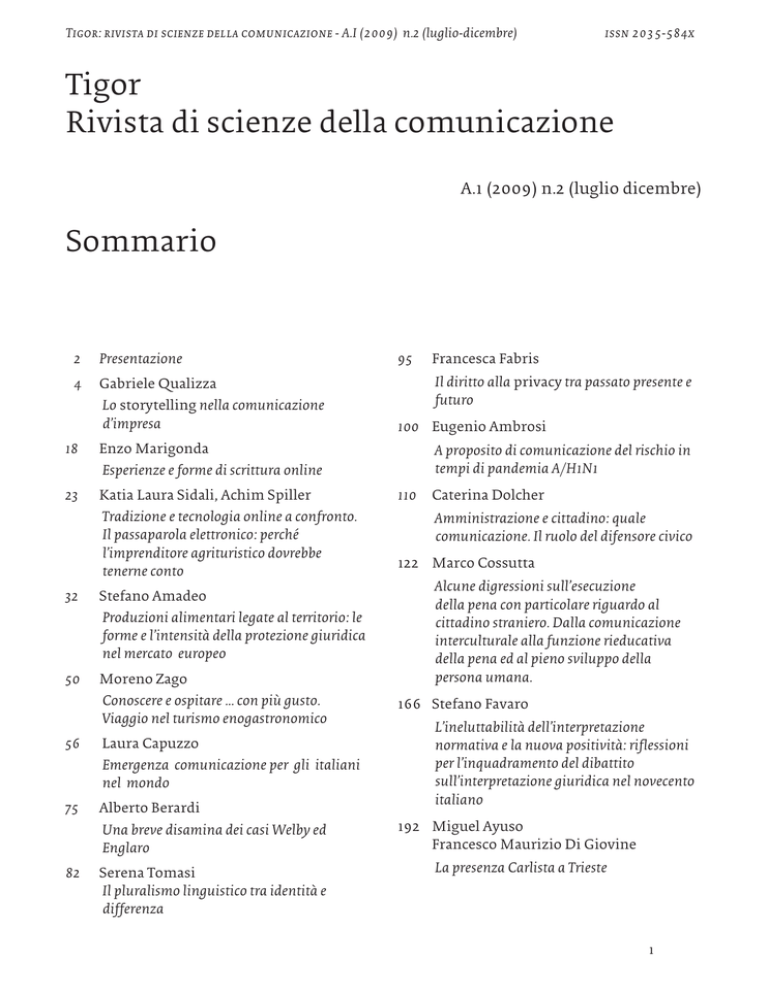
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Tigor
Rivista di scienze della comunicazione
A.1 (2009) n.2 (luglio dicembre)
Sommario
2
Presentazione
4 Gabriele Qualizza
Lo storytelling nella comunicazione
d’impresa
18
Enzo Marigonda
Esperienze e forme di scrittura online
23
Katia Laura Sidali, Achim Spiller
Tradizione e tecnologia online a confronto.
Il passaparola elettronico: perché
l’imprenditore agrituristico dovrebbe
tenerne conto
32
Stefano Amadeo
Produzioni alimentari legate al territorio: le
forme e l’intensità della protezione giuridica
nel mercato europeo
50
Moreno Zago
Conoscere e ospitare ... con più gusto.
Viaggio nel turismo enogastronomico
56
Laura Capuzzo
Emergenza comunicazione per gli italiani
nel mondo
75
Alberto Berardi
Una breve disamina dei casi Welby ed
Englaro
82
Serena Tomasi
Il pluralismo linguistico tra identità e
differenza
95
Francesca Fabris
Il diritto alla privacy tra passato presente e
futuro
100 Eugenio Ambrosi
A proposito di comunicazione del rischio in
tempi di pandemia A/H1N1
110 Caterina Dolcher
Amministrazione e cittadino: quale
comunicazione. Il ruolo del difensore civico
122 Marco Cossutta
Alcune digressioni sull’esecuzione
della pena con particolare riguardo al
cittadino straniero. Dalla comunicazione
interculturale alla funzione rieducativa
della pena ed al pieno sviluppo della
persona umana.
166 Stefano Favaro
L’ineluttabilità dell’interpretazione
normativa e la nuova positività: riflessioni
per l’inquadramento del dibattito
sull’interpretazione giuridica nel novecento
italiano
192 Miguel Ayuso
Francesco Maurizio Di Giovine
La presenza Carlista a Trieste
1
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Presentazione
I
l secondo fascicolo della rivista raccoglie
una serie di contributi, i quali, se appaiono
tra loro distanti per l’oggetto ed il metodo con
cui viene approcciato, sono accomunati dalla
prospettiva di indagine; questa, infatti, volge
ad affrontare in vari modi ed in diversi aspetti
il problema della comunicazione, la cui analisi
caratterizza la presente iniziativa editoriale.
Partendo da una ricognizione sulle nuove
forme di comunicazione di impresa, dallo storytelling, che rappresenta l’oggetto del contributo di Qualizza, al passaparola elettronico,
di cui si occupa, nella dimensione dell’agroalimentare, Sidali, si giunge all’analisi della comunicazione del rischio, trattata da Ambrosi
con particolare riguardo al modo in cui la regione Friuli Venezia Giulia ha affrontato il fenomeno della cosiddetta influenza suina.
Il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione viene altresì analizzato nel contributo di Dolcher, già difensore civico del Friuli
Venezia Giulia, ove si discute sulla qualità della comunicazione pubblica e sul modo in cui i
cittadini percepiscono il linguaggio delle amministrazioni.
Ancora di comunicazione, questa volta declinata sul versante privato, si occupa Marigonda, il quale concentra la propria attenzione
sulle modalità di scrittura on line, con particolare riguardo agli stili di scrittura interattivi
come le chat lines ed i gruppi di discussione
in internet. Su fronte della tutela della privacy
interviene Fabris ripercorrendo le tappe che
hanno portato a riconoscere, nell’ordinamenPresentazione
to giuridico italiano, la tutela dei dati personali evidenziando, nel contempo, la natura poliedrica del concetto di privacy.
Un campo d’indagine molte volte sottovalutato viene affronto dal contributo di Capuzzo,
nel quale si indaga sulla presenza di organi di
stampa e più in generale di strumenti di comunicazione promossi e gestiti dalle comunità italiane residenti all’estero. Gli italiani
all’estero, anche per tramite dei loro mezzi di
comunicazione si palesano sempre più quale
momento di rilancio del “sistema Italia” sui
mercati mondiali.
Il tema del pluralismo linguistico con particolare riguardo al mondo del diritto è oggetto
di riflessione nel contributo di Tomasi, che,
attraverso un approccio critico, analizza lo Statuto della Corte Penale Internazionale. La questione giuridica trova ulteriore specificazione
nell’articolo di Favaro, che affronta il tema della interpretazione normativa proponendo una
breve ma articolata disamina delle principali
teorie interpretative sviluppatesi nella cultura
giuridica italiana del secondo Novecento.
Parimenti di tenore giuridico sono i contributi di Berandi e di Cossutta; il primo, partendo
delle recenti vicende Welby ed Englaro, si incentra sull’attuale dibattito in ambito bioetico,
il secondo, riflettendo sulle recenti normative
in tema di immigrazione, propone una disamina della funzione rieducativa della pena nell’ordinamento giuridico italiano.
Di sapore apparentemente locale appare
l’articolo di Ayuso e Di Giovine, i quali, riper2
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
correndo la vicenda triestina dell’esilio Carlista, offrono nel contempo spunti di riflessione
sul pensiero tradizionalista, di cui i richiamanti
sovrani di Spagna si fanno testimoni.
I contributi di Amadeo e di Zago chiudono
idealmente il presente fascicolo; in questi riportano i loro interventi alla tavola rotonda su
Sapere creare e comunicare i sapori, organizzata
lo scorso settembre nell’ambito del convengo
nazionale di studi … il più vicino possibile ai cittadini …, promosso dall’Associazione di Studi
su «Diritto e società» e dal corso di master in
primo livello in Analisi e gestione della comunicazione.
In questo semestre, la rivista Tigor ha organizzato a cavallo dei mesi di maggio e giugno, di concerto con il predetto master e con
il Centro di Ricerca sulla Metodologia Giuridica, il seminario di studi su Comunicare la comunità, al quale sono intervenuti di professori
Capano, Fileni, Lanzillo e Moro, nonché l’incontro su Quando il linguaggio pubblico veicola
pregiudizio e discriminazione, ove è intervenuta
la professoressa Ravenna. Più di recente, fra
ottobre e dicembre, la rivista si è impegnata
nell’organizzazione della tavola rotonda su Comunicazione e plurilinguismo nel processo di integrazione europea. Il caso del litorale adriatico, con
interventi di Lazzari, Capuzzo, Dorigo, Forza,
Turcinovich Giuricin, Di Leva, Rocco, Rossetti
e Zanini, del seminario di approfondimento
su Davanti alle parti. Regole del contraddittorio e
logica della decisone penale, ove sono intervenuti Marandola, Moro, Rigo, Seibold e Spangher,
della tavola rotonda su Diritto e costruzione narrativa. La connessione fra diritto e letteratura, con
interventi di Cossutta, Heritier, Mittica e Restivo, nonché della tavola rotonda Comunicare
la società multiculturale: esperienze a confronto,
in collaborazione con COSPE – Cooperazione
pr lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, progetto
MediAttori con interventi di Malafronte, Giannoni, De Oliveira, De La Cruz, Soukova, Becce,
Cantarut, Samba, Misso e Gon.
I contributi lì presentati troveranno ospitalità, parimenti a quelli del seminario di
discussione su Didattica forense. Il metodo di
formazione dell’avvocato, tenuto a Pordenone
dalla locale Scuola Forense, in collaborazioPresentazione
issn 2035-584x
ne con il master in Analisi e gestione della
comunicazione, sui prossimi fascicoli della
rivista.
3
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa*
Gabriele Qualizza
Abstract
Parole chiave
Il presente contributo propone una ricerca esplorativa,
focalizzata su aziende italiane, che hanno sviluppato
la formula dello storytelling per la comunicazione con
i propri stakeholder. È una soluzione innovativa, che
implica il superamento degli approcci tradizionali, basati
sulla trasmissione unilaterale del messaggio: invece di
proporre una manifestazione egocentrica della corporate
identity, si tratta di realizzare un modello d’interazione
più evoluto, che dia all’interlocutore un ruolo attivo,
basato non solo su un più intenso coinvolgimento
emozionale, ma anche sulla sua attiva partecipazione
come partner del processo comunicativo.
advergame;
infotainment;
stakeholder;
storytelling;
corporate branding;
comunicazione istituzionale.
D
fondatore della Apple (la storia di un ragazzo
povero, che dopo aver abbandonato l’Università
si trova a frequentare un corso di calligrafia: un
imprinting che orienta il suo interesse verso la
comunicazione visiva), la seconda è una vicenda
di amore e di abbandono (la creazione del primo
Macintosh nel garage dietro casa, l’incontro con
la futura moglie, l’allontanamento dall’azienda
e il successivo rientro), la terza è una storia di
morte e di resurrezione (la diagnosi di una terribile malattia, alla quale sopravvive per miracolo). La conclusione è un invito a credere nel
domani, sempre e comunque.
Steve Jobs parla con voce rotta dall’emozione, in maniera coinvolgente e appassionante.
In realtà, la performance è attentamente preparata a tavolino: nel raccontare la sua storia
di vita, il titolare della Apple si adegua alle norme dello storytelling management. Non parla di
business, di dati, di argomentazioni noiose.
Lascia spento il PowerPoint. Per introdurre i
suoi ascoltatori in un cosmo ricco di miti e di
alla metà degli anni Novanta lo storytelling,
ossia l’arte di raccontare storie, incontra
un sorprendente successo in molteplici ambiti della vita sociale: dalla politica al marketing,
dalla pubblicità alla formazione, dalla progettazione dei parchi a tema ai videogiochi. In questo
contesto, numerose aziende – da Geox a Nike,
da Apple a Microsoft – cominciano a ricorrere
a formule narrative per la costruzione e per la
comunicazione della propria identità istituzionale1, inserendo il corporate theme e la mission
aziendale nella trama di un racconto, in modo
che la fredda logica del business lasci spazio ai
significati, alle intenzioni, alle emozioni.
Un esempio eloquente è il discorso pronunciato il 12 giugno 2005 da Steve Jobs all’Università di Stanford. È un “racconto” articolato in tre
parti: la prima è il romanzo di formazione del
1 B. Czarniawska, Narrating the organization. Dramas of
institutional identity, Chicago, 1997; trad.it. di L. Morra,
Narrare l’organizzazione. La costruzione dell’identità istituzionale, Torino, 2000.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
4
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
simbologie, abitato da eroi e anti-eroi, che sperimentano passioni antiche come il mondo,
universali. Come nelle fiabe e nei romanzi.
Sembra dunque attualizzarsi un’inedita alleanza tra letteratura e impresa. La crisi delle
moderne meta-narrazioni di emancipazione2
apre il varco a una proliferazione di micronarrazioni, riferite ad ogni ambito dell’esperienza umana: in questo senso, anche il mondo dell’impresa sembra investito dall’inatteso
revival del racconto3. In realtà, lo storytelling
promette molto di più: si propone come forma
discorsiva dell’azienda post-moderna4, un’impresa allo stato gassoso, liquida e plurale, in
continuo cambiamento, che declina la propria
comunicazione di corporate secondo i criteri
dell’emotional branding5.
È vero che piccole fiction e slice of life erano
presenti in pubblicità fin dai tempi del Carosello, con l’obiettivo di catturare l’attenzione
dello spettatore, ma l’advertising in quel momento ruotava per intero attorno al prodotto,
alle sue funzionalità e alle sue prestazioni.
Nell’era post-pubblicitaria siamo invece
posti di fronte a un doppio movimento: la prima novità è lo sviluppo narrativo a partire dal
brand. Ciò presuppone che la marca abbia una
personalità, un carattere, un temperamento,
che possono evolvere e cambiare nel corso del
tempo6. La seconda novità è che le narrazioni
vengono sempre più spesso collegate alla comunicazione istituzionale, elaborata secondo
il concetto del corporate branding 7.
2 J.F. Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le
savoir, Paris, 1979; trad.it. di C. Formenti, La condizione
post-moderna, Milano, 1981.
3 Si pensi al romanzo collettivo Le Aziende In-visibili,
scritto da un centinaio di personalità dell’economia e
della cultura, che utilizzano la metafora dell’azienda per
parlare del mondo contemporaneo. Cfr. M. Minghetti
(a cura di), Le aziende in-visibili, Milano, 2008.
4 C. Salmon, Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, 2007; trad.it. di G.
Gasparri, Storytelling. La fabbrica delle storie, Roma, 2008.
5 M. Gobé, Emotional Branding. The new paradigm for connecting brands to people, New York, 2001.
6 M. Lombardi (a cura di), La marca, una come noi, Milano,
2007.
7 Cfr. M.J. Hatch, M. Schultz, Are the strategic stars aligned
for your corporate brand?, in “Harvard Business Review”,
79/2 (2001), pp. 128-134; Id., Bringing the corporation into
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
È su questo tema che intendiamo focalizzare l’attenzione, con particolare riguardo per
quanto si sta muovendo nel nostro Paese.
Gli obiettivi del presente studio si possono
ricondurre a tre principali esigenze: innanzitutto, offrire dati ed elementi di riflessione,
utili a mettere in luce le caratteristiche e a individuare le specificità di questo fenomeno; in
secondo luogo, comprendere le motivazioni
che giustificano l’ampio e crescente ricorso da
parte delle aziende a formule narrative per la
comunicazione istituzionale; infine, valutare
il ruolo acquisito dagli stakeholder di volta in
volta coinvolti nel processo comunicativo.
Per raggiungere tali obiettivi, seguiamo un
percorso di tipo induttivo, mediante la tecnica
dello studio di casi: a partire da concreti esempi di “racconti aziendali” utilizzati a livello
istituzionale, cerchiamo di trarre considerazioni trasversali, utili a “leggere” tale forma di
comunicazione nel suo complesso.
L’analisi dei casi aziendali è preceduta da un
inquadramento teorico e si conclude con l’esame
delle implicazioni manageriali e con l’indicazione di possibili percorsi per la ricerca futura.
1. Riferimenti teorici: due diversi approcci allo storytelling
Il tema dello storytelling è stato finora affrontato a partire da due diversi approcci:
- il primo filone, quello dello storytelling management, prende le mosse da un interesse prevalentemente strumentale8. L’arte di raccontare storie è intesa come tecnica, espediente
utilizzabile per rendere la comunicazione più
coinvolgente e accattivante. A tal fine, diventa
oggetto di interesse tutto ciò che può incorporare al proprio interno un elemento narrativo,
traducibile a sua volta in un artefatto simbolico, capace di “parlare” a pubblici diversi9: in
corporate brand, in “European Journal of Marketing”,
n. 7/8 (2003) pp. 1041-1064; E. Scholes, D. Clutterbuck,
Communication with Stakeholders. An Integrated Approach,
in “Long Range Planning”, 31(2), 1998, pp. 227-238.
8 A titolo di esempio, cfr. S. Denning, Squirrel Inc. A fable of leadership through storytelling, San Francisco, 2004;
trad. it. di N. Gaiarin, Scoiattoli SpA. Storie
������������������������
di noci e leadership, Milano, 2005.
9 A. Fontana, Manuale di Storytelling. Raccontare con ef-
5
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
questa prospettiva, possono diventare “storie”
tutti i discorsi con cui la direzione strategica
cerca di orientare l’opinione pubblica, ma possono essere rielaborati in termini narrativi anche i messaggi diffusi all’interno dell’organizzazione, così come i processi comunicativi tesi
a presidiare i significati che le persone attribuiscono alle proprie esperienze di consumo. Un
meeting, un commercial, un comunicato stampa, il design di un prodotto, una newsletter, un
logo aziendale, un programma di infotainment,
un advergame, le dichiarazioni valoriali contenute nei documenti che definiscono l’identità
d’impresa: tutte queste espressioni possono
trasferire all’interlocutore un elemento narrativo, che può essere anche soltanto accennato,
non necessariamente sviluppato in forma organica e compiuta.
Non mancano, all’interno di questo filone, le
applicazioni originali: basta pensare alle campagne pubblicitarie sviluppate in forma di fiction a puntate (Barilla, Tim, Lavazza), secondo la
logica dell’advertainment10. Tuttavia, il prezzo da
pagare per l’uso sempre più largo e comprensivo del termine è la banalizzazione del concetto
stesso di narrazione, che rischia di trasformarsi
in una marca fonetica priva di significato11;
- il secondo filone, quello dell’organizational
storytelling12, si sviluppa nell’ambito degli studi
organizzativi: il punto di partenza è l’idea che
storie, saghe, miti, riti e cerimoniali possano
essere considerati espressioni del nucleo profondo di una cultura organizzativa13. Da lì, l’attenzione si dilata al vissuto concreto delle per-
sone che operano in azienda, a ciò che rimane
nell’ombra dietro i discorsi e i comportamenti ufficiali. L’analisi delle storie organizzative,
raccolte dalla viva voce dei protagonisti, porta alla luce un complesso e polifonico intreccio di racconti che si parlano, si scambiano, si
contraddicono14. Emergono narrazioni parallele, diverse e alternative rispetto a quelle canoniche: tracce, rumori di fondo, materiali di
scarto, frammenti, nei quali si depositano le
vite personali, con tutto il carico di desideri e
vissuti inconsapevoli, spazi interstiziali in cui
si annida la storia profonda dell’organizzazione15. Si evidenzia come le narrazioni offrano
agli individui e ai gruppi «uno spazio poetico
in cui la fantasia prevale sulla realtà»16, per il
forte contenuto immaginifico ed emozionale
che sono in grado di esprimere.
All’interno di questo filone di ricerche si
sviluppa inoltre una crescente consapevolezza
delle rilevanti implicazioni di carattere teorico, che il tema dello storytelling sottende.
In prima istanza, l’attenzione si focalizza
sulla necessità di un approccio “narrativo” alla
conoscenza, a partire dalla nota distinzione
introdotta da Bruner tra comprensione paradigmatica e comprensione narrativa17. La prima
modalità cognitiva procede in modo lineare,
logico-scientifico, puntando a separare, a individualizzare, a comparare, a calcolare. Essa
ammette solo un’unica rappresentazione della
realtà alla volta, in quanto è orientata alla validazione secondo il criterio del vero e del falso. Il pensiero narrativo consente invece una
ficacia prodotti, marchi e identità d’impresa, Milano, 2009,
p. 26.
10 P. Musso, I nuovi territori della marca. Percorsi di senso,
discorsi, azioni, Milano, 2005.
11 ������������
C. Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, cit., p. 10.
12 ������������������������������������������������������
Per un quadro d’insieme, cfr. C. Rhodes, A.D. Brown,
Narrative, organization and research, in “International
Journal of Management Review”, 7 (3), 2005, pp. 167-188.
13 �����������������������������
I.I. Mitroff, R.H. Kilmann, Stories managers tell: a new
tool for organizational problem solving, in “Management
Review”, 67(7), 1975, pp. 18-28; E. Schein, Coming to
a New Awarness of Organizational Culture, in “Sloan
Management Review”, 25(4), 1984, pp. 3-16; trad.it.
“Verso una nuova consapevolezza della cultura organizzativa”, in P. Gagliardi (a cura di), Le imprese come culture.
Nuove prospettive di analisi organizzativa, Torino, 1995²,
pp. 395-415.
14 ������������
D.M. Boje, The Storytelling Organization: A Study of Story
Performance in an Office-Supply Firm, in “Administrative
Science Quarterly”, n. 36 (1991), pp. 106-126
15 �������������
Y. Gabriel, Organizations and their Discontents: A
Psychoanalytic Contribution to the Study of Corporate Culture,
in “Journal of Applied Behavioural Science”, n.27 (1991),
pp. 38-336.
16 Op.cit., p. 333.
17 J. Bruner, J., The narrative construction of reality, in
“Critical Inquiry”, n. 18 (1991), pp. 1-21; trad.it. “La costruzione narrativa della realtà”, in M. Ammaniti, D.N.
Stern (a cura di), Rappresentazioni e narrazioni, Laterza,
1991. Simile è la distinzione tra paradigma del mondo
razionale e paradigma narrativo proposta da W.R. Fisher.
Cfr. Id., Narration as a human communication paradigm:
the case of public moral argument, in “Communication
Monographs”, n. 51 (1984).
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
6
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
pluralità di rappresentazioni contemporanee
del mondo, dal momento che il suo criterio
di validazione è la plausibilità. Questa modalità cognitiva si nutre dunque di simboli, di
miti, di metafore e di analogie, occupandosi
di ciò che muta un semplice comportamento in un’azione umana, dotata di intenzioni
e di significati18. In particolare, la conoscenza
narrativa consente di stabilire un legame tra
l’eccezionale e l’ordinario: attraverso le narrazioni le persone cercano dunque di elaborare
spiegazioni, interpretazioni e giustificazioni
per quanto di imprevedibile avviene nella vita
quotidiana.
In seconda battuta, «la nozione di sapere
narrativo si accosta alla metafora del mondocome-testo»19. Si assiste dunque ad uno shift:
dallo stoytelling visto in chiave epistemologica allo storytelling come ontologia20, via per
costruire un’identità “narrativa” della stessa
impresa. La crisi del fordismo mette in discussione i significati prescritti e prevedibili:
si tratta allora di ripensare l’organizzazione
come comunità di pratiche e di discorsi, sforzo collettivo di generazione del senso, secondo la prospettiva del sensemaking disegnata da
Weick21, dunque come racconto in costante
cambiamento. All’identità organizzativa, intesa come sostanza, si sostituisce un nuovo modello, nel quale l’identità è vissuta invece come
racconto: non più una struttura monolitica, ma
un filo che continuamente si dipana nel tempo, attraverso le storie dei diversi stakeholder
con cui l’azienda interagisce22.
I due filoni non si escludono a vicenda, la18 Come spiega Barbara Czarniawska, «all’interno del
modo logico scientifico di sapere si ottiene una spiegazione riconoscendo un evento come un caso di una legge generale, o come appartenente a una certa categoria.
All’interno del modo narrativo di sapere, una spiegazione
consiste nel collegare un evento a un progetto umano».
Cfr. B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit. p. 27.
19 B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit. p. 9.
20 C.G. Cortese, L’organizzazione si racconta. Perché occuparsi di cose che effettivamente sono “tutte storie”, Milano,
1999, p. 9.
21 K.E. Weick, Sensemaking in Organizations, Thousand
Oaks, Cal., 1995; trad.it. di L. Formenti, Senso e significato
nell’organizzazione, Milano, 1997.
22 A. Fontana, Manuale di Storytelling, cit., p. 59.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
sciano anzi spazio ad un ampio set di variazioni intermedie: in definitiva, per essere efficace, l’astratto potere del pensiero narrativo deve
comunque tradursi in oggetti fisici, in simboli,
in manifestazioni e artefatti concreti.
1.1 - La fabbrica delle storie
Del resto, come nota Barthes23, «il racconto
comincia con la storia stessa dell’umanità; non
esiste, non è mai esistito in alcun luogo un
popolo senza racconti». Le narrazioni rispondono infatti a una molteplicità di compiti e di
funzioni, che risultano centrali per l’identità
dei singoli e dei gruppi:
- fin dalla notte dei tempi, le storie (orali,
poi scritte, oggi multimediali) si propongono
come dispositivi di organizzazione del pensiero e di conservazione della memoria24;
- per un verso, in quanto schemi cognitivi
(di carattere narrativo), le storie allestiscono
la “cornice di riferimento” entro cui i soggetti possono trovare un senso alla propria esperienza professionale e di vita, partecipando in
prima persona al processo di generazione dei
significati (sense co-makership)25. Le strutture
narrative sono dunque le forme attraverso cui
le persone comprendono la realtà, le proprie
vite, le proprie azioni26: l’inserimento in una
trama, «rende ciascun evento comprensibile
alla luce della totalità in cui esso si colloca e che,
al tempo stesso, contribuisce a generare»27;
- per un altro verso, lo storytelling è in stretto rapporto con la memoria “autobiografica”,
individuale e collettiva: questa agisce infatti
come un “dispositivo narrativo”, chiamato a
restituire il filo della coerenza agli atti unici
della nostra vita, in connessione con quella de23 ��������������������������������������������������������
R, Barthes, R. (1966), “Introduction to the Structural
Analysis of Narratives”, in S. Heath, Image – Music –
Text, Glasgow, 1966, pp. 79-124; trad.it. “Introduzione
all’analisi strutturale dei racconti», in R. Barthes et al.,
L’analisi del racconto, Milano, 1969, pp. 7-46, p. 7.
24 ���������
W. Ong, Orality and literacy. The technologizing of the
word, New York, 1982; trad.it. di A. Calanchi, Oralità e
scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, 1986.
25 A. Fontana, Manuale di Storytelling, cit., p. 29.
26 B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit. p. 19.
27 G.C. Cortese, L’organizzazione si racconta, cit., p. 13.
7
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
gli altri28. Da questo punto di vista, ogni comunità umana è formata e mantenuta in vita da
storie che si diffondono, si ripetono e si cristallizzano nelle tradizioni e nelle realtà sociali29:
l’emergere di un’organizzazione è legato alla
possibilità per i suoi membri di riconoscersi
in schemi interpretativi condivisi, che diventano
la base della cultura collettiva30;
- in questo senso, lo storytelling si propone
come potente dispositivo di allineamento tra i
tanti racconti del business: le costellazioni di
storie proposte dalle persone che vivono in
azienda, l’ “autobiografia” dell’impresa e i molteplici discorsi sviluppati nell’interazione con
i mercati di riferimento31;
- considerando nello specifico la comunicazione diretta agli stakeholder interni dell’impresa, la declinazione in chiave narrativa del
corporate theme32 consente di ottenere ricadute
positive in termini di commitment, tensione
al cambiamento, responsività, integrazione
tra le diverse parti dell’organizzazione, clima,
senso di appartenenza e partecipazione;
- i costrutti narrativi rappresentano infatti un sofisticato mezzo retorico di presidio e
scambio di potere: chi possiede le chiavi d’accesso ai “cancelli del senso”, cioè ai processi di
generazione dei significati, plasma e definisce
la percezione del reale e dunque anche i piani
d’azione che sono possibili in un determinato
contesto33. Assumendo la funzione di gatekee28 A. Fontana, Manuale di Storytelling, cit., pp. 14-16.
29 B. Poggio, Mi racconti una storia? Il metodo narrativo
nelle scienze sociali, Roma, 2004.
30 ����������������������������������������������������
L. Smircich, “Organization as Shared Meanings”, in
L.R. Pondy, P.J. Frost, G. Morgan, T. Dandridge (a cura di),
Organizational Symbolism: Monographs in Organizational
and Industrial Relations, vol. 1, Greenwich, 1983, pp. 55-56.
31 R. Noceti, “Di che storia sei? Lo storytelling nelle attività di head hunting secondo l’esperienza Key2People”, in
A.Fontana, Manuale di Storytelling, cit., pp.159-167, p. 162.
32 U. Collesei, V. Ravà, “La comunicazione integrata”, in
Id. (a cura di), La comunicazione d’azienda, Torino, 2004,
pp. 47-61
33 ���������������
P. Gagliardi, The creation and change of organizational culture. A conceptual framework, in “Organizational studies”, n.
7 (1986), pp. 117-134; trad.it., “Creazione e cambiamento
delle culture organizzative: uno schema concettuale di riferimento”, in Id. (a cura di), Le imprese come culture. Nuove
prospettive di analisi organizzativa, Torino, 1995, pp. 417438.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
per narrativi, imprenditori e manager cercano
dunque di presidiare le “posizioni di confine”
nell’intento di definire l’universo di senso controllato dalle proprie imprese34. D’altro canto,
ogni organizzazione vive di tante storie: quelle
canoniche sostenute dalla coalizione dominante, quelle apocrife proposte da sottogruppi di
minoranza e quelle nascenti, ancora in formazione e alla ricerca di un audience35. Le storie
non danno necessariamente luogo ad un coro
unitario, ma si dispongono più spesso secondo linee alternative e contrastanti36;
- non rientra invece tra i compiti dello storytelling la registrazione fedele di una (supposta) realtà oggettiva, esterna all’osservatore37: la
trama di un racconto non è intrinseca agli eventi, ma imposta dall’autore attraverso la narrazione38. Ogni storia può dunque proporre un
mix di fatti accaduti e di fatti immaginati, ove
l’obiettivo è riconoscere, ricostruire e concettualizzare le esperienze vissute. Insomma, lo
storytelling non è un mezzo per nascondere la
realtà sotto un velo di invenzioni ingannevoli: un racconto non è né vero, né falso, ma può
essere “autentico”, nella misura in cui rende
34 A. Fontana, Manuale di Storytelling, cit., p. 39. Come nota
Azzoni, le visionary companies, imprese di eccellenza caratterizzate da una cult-like culture, tracciano netti confini tra
che è dentro e chi è fuori dall’organizzazione: l’appartenenza all’azienda e la professione del “credo” aziendale diventano dunque tutt’uno. Cfr. G. Azzoni, Le religioni aziendali,
relazione presentata al Convegno di Sociologia del Diritto
su “Diritto/Diritti, Morale/Morali, Religione/Religioni”,
organizzato dall’Associazione di Studi su Diritto e Società,
Cagliari, 19-20 settembre 2003, p. 14 (testo dattiloscritto).
Va per altro notato che fusioni, acquisizioni, reti digitali,
società transnazionali rendono sempre più inconsistente
l’idea di un confine da presidiare (B. Czarniawska, Narrare
l’organizzazione, cit., p. 6). Nei nuovi modelli organizzativi le linee di confine tendono infatti a sciogliersi, trasformandosi in ampi e variegati territori di frontiera: luoghi
fluidi, mobili, dinamici, in continua evoluzione.
35 ������������������������������������������
D. Sims, “Organizational Learning as the
Development of Stories: Canons, Apocrypha and Pious
Myths”, in M. Easterly-Smith, J. Burgosue, L. Arayo
(a cura di), Organizational Learning and the Learning
Organization, London, 1999.
36 ������������
D.M. ������
Boje, Stories of the storytelling organization: a postmodern analiysis of Disney as “Tamara-land”, in “Academy
of Management Journal”, 38(4), 1995, pp. 997-1035.
37 B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit.
38 G.C. Cortese, L’organizzazione si racconta, cit., p. 16.
8
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
conto del mondo organizzativo così come è
esperito, vissuto, dai diversi attori39.
Una delle ipotesi più suggestive, formulate
dagli studiosi, è che tutte le narrazioni ricorrano ad alcuni topoi o schemi narrativi permanenti, che rappresentano altrettanti vettori di
senso, attraverso i quali le culture umane costruiscono le esperienze di vita personale e organizzativa40. In altri termini, gli elementi di
ogni narrazione, variamente combinati, vengono sempre posizionati entro un format di
base, una sorta di meta-copione, che riprende
le caratteristiche dello schema narrativo canonico41: ogni racconto parte da una situazione iniziale di equilibrio, che viene all’improvviso infranto dall’emergere di una mancanza, di una
minaccia, dal prefigurarsi di una realtà potenzialmente ostile. Il quadro, che così si delinea,
pone il protagonista di fronte ad una difficile
sfida, che egli affronta acquisendo innanzitutto le competenze necessarie e successivamente
affrontando vari ostacoli e peripezie, fino allo
scontro decisivo con il principale antagonista.
Con la vittoria ottenuta sul campo il protagonista porta a termine la sfida ed è in grado di ristabilire, su nuove basi, l’equilibrio perduto42.
Non si tratta tuttavia di un ritorno alla status
quo precedente, in quanto la nuova situazione
presuppone un reframing del campo percettivo. Il cerchio non si chiude: anche l’Ulisse che
ritorna ad Itaca è diventato nel frattempo un
altro Ulisse, che ritrova un’altra Penelope43.
39 Op.cit., p. 146.
40 In genere, nelle narrazioni personali e professionali
si ritrovano i seguenti elementi: un eroe alla ricerca di se
stesso; un’impresa da compiere, un insieme di gesta straordinarie; un avversario che ostacola l’eroe; un conflitto,
una battaglia tra i soggetti eroici e i loro antagonisti; un
tesoro da scoprire; un trauma, una violenza gratuita da
cui l’eroe deve riprendersi; uno o più oggetti magici, che
aiutano l’eroe nella realizzazione dell’impresa; alcuni
aiutanti, che sostengono l’eroe nella sua esperienza di
vita; le nozze finali, che rappresentano metaforicamente il coronamento dell’impresa eroica (cfr. Fontana,
Manuale di Storytelling, cit., p. 19).
41 G. Marrone, Il discorso di marca, Roma-Bari, 2007.
42 V. Propp, Morfologija skazki, Sankt Peterburg, 1928;
trad.it. Morfologia della fiaba, Torino, 1966
43 V. Jankélévitch, L’irreversible et la nostalgie, Paris, 1974;
trad.it. (parziale) di A. Serra, “La nostalgia”, in A. Prete (a
cura di), Nostalgia. Storia di un sentimento, Milano, 1992,
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
In maniera analoga a quanto avviene nelle
altre narrazioni, pure lo storytelling aziendale
presuppone l’esistenza di un conflitto, di un
paradosso, di uno scontro tra visioni diverse
della realtà, che la ragione solo calcolante non
è in grado di tenere insieme e di rimarginare.
In altri termini, «si racconta perché i conti non
tornano»44, perché c’è un vuoto che il racconto
è chiamato a riempire. L’esistenza di un conflitto esclude la possibilità di una lettura univoca delle realtà: richiede piuttosto l’attivazione di un processo di interpretazione, orientato
a ridefinire continuamente le cornici di senso
con cui persone e organizzazioni ricostruiscono gli eventi narrati.
Bisogna inoltre sottolineare che, mentre la
logica scientifica si propone di stabilire connessioni rigide, causali, tra i fatti osservati, la
narrazione lascia aperta la natura della connessione: questo significa che «lo stesso insieme di eventi può essere organizzato intorno a
trame differenti»45.
2. Definizione del campo d’indagine
Alla luce di queste considerazioni, la presente indagine focalizza l’attenzione su una
specifica dimensione dello storytelling aziendale, ossia sulla possibilità di ricostruire e comunicare in chiave narrativa, a fini strategici e istituzionali, l’identità e l’immagine dell’impresa,
a prescindere dalla ricerca di immediati ritorni di carattere commerciale. L’ipotesi sottesa è
che la diffusione dello storytelling istituzionale non sia soltanto una moda passeggera, ma
possa essere collegata a nuove modalità di fare
impresa, nelle quali è implicito un più forte
coinvolgimento dei diversi stakeholder.
Siamo dunque nell’ambito della comunicazione istituzionale: un’attività indirizzata a
costruire, diffondere, consolidare – secondo
un orientamento strategico di lungo periodo
– un’immagine forte e attrattiva dell’impresa
con l’obiettivo di generare consensi sociali, il
pp. 119-176.
44 G.P. Quaglino, “Di ciò di cui si narra nelle organizzazioni”, saggio introduttivo a C. Cortese, L’organizzazione
si racconta, Milano, 1999, pp. IX-XVI, p. XIII.
45 B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit. p. 26.
9
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
cui accumularsi possa riverberarsi nuovamente sulla stessa immagine46. È un compito, sviluppato in staff con la direzione generale, che
sviluppa uno specifico elemento del valore: le
relazioni con l’ambiente e con i portatori di
risorse47. I suoi interlocutori sono dunque gli
stakeholder, così come definiti da Freeman:
Any group or individual who can affect or is affected
by the achievement of the organization’s objectives48.
Non semplici “pubblici”, destinatari passivi
del massaggio, ma portatori attivi di interessi
(attuali o potenziali): i clienti, i dipendenti, la
comunità in cui l’impresa è inserita, gli azionisti. Questa relazione non ha necessariamente
carattere formale, ufficiale e contrattuale, né
identifica un qualche potere di condizionamento, esercitato dall’una o dall’altra parte49, ma va
fondamentalmente intesa come base per la legittimazione delle attività dell’impresa50, tenendo presente che tale legittimazione è sempre
“negoziata” attraverso uno scambio comunicativo51. Per usare il modello di Thompson, questo è l’aspetto della comunicazione sviluppato
a livello istituzionale, cioè dal vertice dell’organizzazione, incaricato di definire le strategie e
di controllare le fonti dell’incertezza, operando
secondo criteri di razionalità limitata52.
In questo contesto le attività di corporate sto46 V. Coda, Identità e immagine nella strategia dell’impresa,
Torino, 1991. p. 8.
47 R. Fiocca, Relazioni, valore e comunicazione d’impresa,
Milano, 1993, p. 43.
48 ���������������
R.E. Freeman, Strategic management: a stakeholder
approach, Boston, 1984, p. 46. Notiamo per inciso che
Freeman parla di affect e non di influence: già nella definizione di “stakeholder” si introduce dunque una
componente emozionale, che va oltre il calcolo razionale e il linguaggio formale ispirato al paradigma logicoscientifico.
49 ��������������������������������
R. Mitchell,
����������������������������
B. Agle, D. Wood, Towards a Theory
of Stakeholder Identification and Salience: Defining the
Principle of Who and What Really Counts, in “Academy of
Management Review”, 22(4), 1997, pp. 853-886, p. 862.
50 �����������������������������
T. �������������������������
Donaldson, J.E. Preston, The stakeholder theory of
the corporation: concepts, evidence and implications, in
“Academy of Management Review”, 20(1), 1995, pp. 6591.
51 ��������������������������������
R. Mitchell,
����������������������������
B. Agle, D. Wood, Towards a Theory of
Stakeholder Identification and Salience…, cit., p. 867.
52 ��������������
J. Thompson, Organizations in Action, New York, 1967;
trad.it. L’azione organizzativa, Torino, Isedi, 1988.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
rytelling non sono un semplice espediente retorico, finalizzato ad incrementare l’appeal della
comunicazione, ma assumono una valenza
strategica, incorporando al proprio interno un
modello di razionalità “narrativa” che è affine
a quello utilizzato dal vertice istituzionale per
negoziare con gli stakeholders i valori e i significati che legittimano l’organizzazione: ne consegue che «la reputazione (positiva o negativa) e
il ricordo coinvolgente o irritante delle aziende
derivano da un complesso gioco di interscambio tra le storie interne e le storie esterne»53.
L’implicito sottointeso di questa impostazione è una lettura più ampia del concetto di
accountability, da intendersi non solo come
“responsabilità”, ma anche come capacità di
“offrire un resoconto” di ciò di cui si è autori, situando le azioni in un racconto denso di
significati54. �������������������������������
Come suggerisce lo stesso Freeman, «our task is to take metaphors like the
stakeholder concept and embed it in a story
about how human beings create and exchange
value»55 (corsivo nostro).
In questo senso, l’attività di corporate storytelling non coincide con l’allestimento di fatti e di
sequenze cronologiche, ma prevede la formulazione di racconti che consentano il presidio
e la rielaborazione di vissuti esperienziali e
l’immaginazione di territori ancora inesplorati. Non sono dunque pertinenti cronache e
giornali d’impresa, diari aziendali in forma di
blog, cronologie e bilanci, concorsi letterari
rivolti a stakeholders e dipendenti, books con
elencazione delle tappe della storia aziendale, commemorazioni di eventi, musei allestiti
con esclusivi criteri catalografici.
2.1. Approccio metodologico
Data la novità del tema, ci preme sottolineare il carattere eminentemente esplorativo del
presente contributo. La ricerca è partita da una
fase di desk analysis, che si è focalizzata sulla
letteratura riguardante il tema prescelto (cor53 A. Fontana, Manuale di Storytelling, cit., p. 30.
54 B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit.
55 ���������������
R.E. ���������
Freeman, The politics of stakeholder theory: some future directions, in “Business Ethics Quarterly”, 4 (4), 1994,
pp. 409-421, p. 418.
10
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
porate storytelling e sue implicazioni nell’ambito della stakeholder theory), alla quale ha fatto
seguito una fase di analisi empirica (field work),
basata su studi di caso56, riferiti ad aziende che
utilizzano questa formula innovativa. A tal
fine, abbiamo ritenuto di concentrare l’attenzione sul nostro Paese, considerando gli ultimi cinque anni: un arco di tempo, nel corso
del quale è emerso un crescente interesse per
questo format comunicativo, non sempre sostenuto da un adeguato sforzo di approfondimento e di concettualizzazione.
I materiali raccolti derivano da varie fonti di
informazione, quali stampa specializzata, siti
internet, strumenti audiovisivi, pubblicazioni
aziendali, dialoghi con esperti e professionisti
del settore, visite e sopralluoghi, nell’ambito
dei quali abbiamo fatto ricorso alla metodologia dell’osservazione partecipante. In alcuni
casi siamo stati direttamente coinvolti, per attività di consulenza professionale, nella progettazione di specifici strumenti di comunicazione ispirati a logiche di corporate storytelling.
3. I risultati dell’indagine
Il risultato di questo lavoro è una sorta di
work in progress, che si arricchisce continuamente di nuovi materiali. Tra i numerosi casi
aziendali raccolti, segnaliamo di seguito quelli
più significativi, raccordandoli a sei chiavi di
lettura, che possono spiegare il crescente successo dello storytelling istituzionale:
- l’analogia tra reti narrative e costellazioni
d’imprese e l’emergere della nuova “azienda
cognitiva”;
- il ruolo di collante organizzativo assunto
in tali contesti dal discorso di marca, sempre
più spesso sviluppato in forma di racconto;
- la ricerca di storie contestuali, di esempi di
vita densi di significato, come via per superare
l’impasse decisionale, generata dall’eccesso di informazioni disponibili sul tavolo dei manager;
- il ricorso a “tradizioni inventate” come garanzia e giustificazione degli avvenimenti del
presente;
56 �����������������������
Cfr. K.M. Eisenhardt,
������������ Building Theories From Case
Study Research, in “Academy Of Management Review”,
14(4), 1989, pp. 532-550.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
- la “teatralizzazione” degli ambienti di lavoro, investiti da una pressante richiesta di visibilità e di trasparenza;
- la trasformazione dell’impresa in un “regista di esperienze”, nelle quali coinvolgere – in
veste di co-autori – i diversi stakeholders.
3.1. Reti di racconti e costellazioni di
imprese
C’è un evidente parallelismo tra le “reti narrative” che avvolgono le imprese e le formule
organizzative più evolute57. La crisi del fordismo va infatti di pari passo con l’affermazione di nuovi modelli organizzativi ispirati alla
metafora della “rete”: un insieme di soluzioni
basate non più sull’integrazione verticale del
processo, ma sull’interdipendenza organica tra
imprese diverse, collegate nella supply chain58.
Possiamo parlare a questo proposito di
“reti del valore”59 e di “costellazioni”, generate dal fitto intreccio di relazioni fra «attori
economici diversi - fornitori, partner in affari, alleati, clienti - che operano insieme nella
co-produzione del valore»60. Nelle strutture di
questo tipo i presupposti della comunicazione
e della cooperazione devono essere continuamente ricostruiti attraverso le relazioni tra gli
attori: in altri termini, la comunicazione non
è soltanto un mezzo attraverso cui si veicolano i messaggi, ma è anche un dispositivo di
creazione del senso, un ambito nel quale «si
mettono a punto il linguaggio e i significati in
modo appropriato rispetto agli usi pratici»61.
Sullo sfondo, emerge la nuova prospettiva dell’azienda cognitiva, che non ha più come
principale obiettivo la produzione delle merci,
ma «la condivisione delle conoscenze, la cir57 G.P. Quaglino, “Di ciò di cui si narra nelle organizzazioni”, cit.
58 R. Grandinetti, Reti di marketing. Dal marketing delle
merci al marketing delle relazioni, Milano, 1993.
59 C. Parolini, Rete del valore e strategia aziendale, Milano,
1996.
60 �������������������������
R. Normann, R. Ramirez, From value chain to value
constellation: designing interactive strategy, in “Harvard
Business Review”, luglio-agosto, 1993, pp. 65-77, p. 66.
61 R. Grandinetti, Evoluzione del distretto industriale e delle
sue formule imprenditoriali, in “Economia&Management”,
n. 4 (1998), pp. 79-98, p. 81.
11
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
colazione delle informazioni, la gestione delle
emozioni»62. In questo contesto la narrazione
si propone – insieme – come modalità di conoscenza e come modalità di comunicazione63.
Ci sembrano interessanti, a questo proposito, le esperienze di incentive e di team building
realizzate da alcune aziende (Insiel, Kpmg) con
il supporto di “Log607”, giovane agenzia, nata
da una costola di H-Farm, centro per la ricerca e
l’innovazione con sede vicino a Venezia: si tratta di veri e propri urban games, che integrano in
un sistema cross-mediale una molteplicità di
strumenti, dal catalogo a stampa all’audiovisivo,
dall’instant messaging alla performance dal vivo.
Il filo conduttore è un racconto dato per frammenti, che i giocatori sono invitati a dipanare,
identificando – come in una “caccia al tesoro”
- originali punti di connessione con le persone
e con i luoghi. A questo filone si può ricollegare
anche la convention di rilancio del brand Buitoni, realizzata a gennaio del 2007: tutto ruota attorno al tema dell’inizio, che i partecipanti (oltre
250 dipendenti) vengono sollecitati a vivere in
presa diretta, confrontandosi con il racconto di
avventure esistenziali, sportive ed umane – dal
Cirque du Soleil alla campionessa di ginnastica
Vanessa Ferrari – nelle quali traspaiono i valori
del brand (innovazione, perseveranza, ricerca
dell’eccellenza, spirito di squadra).
Mettendo in scena valori, lo storytelling intende favorire la connessione a livello emotivo fra le persone, prospettando un’interpretazione condivisa e condivisibile del contesto e
dell’identità degli attori coinvolti64.
3.2. Racconti di marca
L’obiettivo di trascendere la frammentazione e di consolidare le relazioni tra i diversi
partner del network conferisce un risalto particolare alle risorse simboliche di cui un’organizzazione dispone65: in tale contesto la marca ac62 C. Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, cit., p. 38.
63 B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit. p. 24.
64 ���������������
P. Gagliardi, The creation and change of organizational
culture. A conceptual framework, cit.
65 �������������
M.J. Hatch, Organization Theory: Modern, Symbolic
and Postmodern Perspectives, Oxford, 1997; trad.it. di A.
Visentin, Teoria dell’organizzazione, Bologna, 1999, p. 192.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
quista il ruolo di collante organizzativo, fino a
diventare un riferimento essenziale per le attività di comunicazione a livello di corporate66.
Il presupposto è uno slittamento dei termini e dei significati, per cui non si parla più di
marchio (semplice “etichetta” applicata ad un
prodotto), ma di marca, intesa come dispositivo che assicura la produzione e la messa in
forma del senso, condensando un insieme di
contenuti complessi in una Gestalt immediatamente riconoscibile e di facile accesso. Ogni
marca presidia dunque un territorio, elabora
un universo simbolico, propone una visione
del mondo, si esprime con una propria estetica
e una propria etica: così, Barilla rappresenta la
casa e gli affetti familiari, Alfa Romeo la sportività, Mulino Bianco il ritorno alla natura, Levissima l’archetipo dell’onestà e della purezza.
D’altro canto, il discorso di marca diventa
efficace nella misura in cui i valori vengono
declinati in racconto, prendendo a prestito e
ricombinando immagini, frammenti di storie
e suggestioni, sedimentati nei vasti territori dell’immaginario collettivo67. Come spiega
Semprini, una marca non enuncia mai direttamente i propri valori, che restano dei principi
astratti e fortemente sintetici, dotati di un’esistenza esclusivamente concettuale, ma li inserisce nel contesto di «narrazioni più o meno
strutturate, all’interno delle quali i valori possono attivarsi e sviluppare tutti i loro sensi»68.
In definitiva, ogni marca «narra delle storie»69.
Cfr. anche G. Azzoni, Le religioni aziendali, cit., p. 6.
66 �������������������������
M.J. Hatch, M. Schultz, Are the strategic stars aligned for
your corporate brand?, cit.; Id., Bringing the corporation into
corporate brand, cit.
67 V. Codeluppi, Verso la marca relazionale, relazione
presentata al convegno “Le tendenze del marketing in
Europa”, Università Ca’ Foscari, Venezia, 24 novembre
2000.
68 A. Semprini, La marca. Dal prodotto al mercato, dal mercato alla società, Milano, 1996, p. 135.
69 Ibidem. Come nota Azzoni, la forze normativa delle
cosiddette “religioni aziendali” non risiede nei principi
astratti a cui fanno riferimento, ma nel fatto che i valori
dichiarati possono “prendere corpo” in una storia, che li attualizza e li rende efficaci (riemerge dunque il concetto di
Wirkungsgeschichte). Esemplare è in questo senso la gestione del caso Tylenol da parte di Johnson&Johnson: in quel
momento «si è creata una storia di cui J&J è la protagonista positiva» e che dà legittimazione pubblica al “credo”
12
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Si potrebbe citare a questo proposito il caso
di Enel: nel 2006 l’azienda realizza una campagna corporate, per raccontare tutto quello che
va oltre il lavoro di produzione e distribuzione
dell’energia, con l’obiettivo di dare un forte segnale della propria responsabilità verso il Paese, presso istituzioni, opinion leaders, cittadini,
azionisti, clienti. L’idea si traduce in tre spot,
che assumono la forma di “favole poetiche”, raccontate dall’attore Giancarlo Giannini. Al centro, i valori chiave dell’azienda: l’impegno verso
un progresso rispettoso e naturale (“Il cervo”),
l’attenzione per la ricerca e il potere delle idee
(“Il cuoco”), la responsabilità verso le comunità
nelle quali opera (“Lo studioso”). Il pay-off unifica in un unico concetto il tema chiave di questa campagna di comunicazione istituzionale:
«L’energia va oltre quello che vediamo».
3.3. L’impatto dei nuovi media
Il tema dell’overload informativo acquista
particolare rilevanza in un contesto caratterizzato dalla proliferazione dei media e dei messaggi. Ogni giorno le scrivanie dei manager
sono “sommerse” da una quantità di dati superiore a quella che essi stessi sono in grado di
elaborare70. La situazione produce effetti paradossali, come il ritardo nelle decisioni cruciali
legato all’eccesso di informazioni disponibili.
Ai dati tradizionali si aggiungono poi le informazioni veicolate attraverso i nuovi media.
Non più asettiche tabelle fornite dalla Nielsen,
non più eleganti rapporti relativi ai focus group,
ma messaggi spontaneamente generati dai
clienti: file audio e filmati, blog ed immagini.
L’analisi delle informazioni veicolate dai diversi media richiede nuove chiavi di lettura, che
sfuggono alla “gabbie” di carattere quantitativo
solitamente utilizzate nel mondo manageriale. In definitiva, solo una ricostruzione di tipo
narrativo è in grado di offrire l’accesso a una
molteplicità di fenomeni e di osservazioni, che
sembrano altrimenti sottrarsi a un filo interaziendale. Cfr. G. Azzoni, Le religioni aziendali, cit., p. 18.
70 A. Boaretto, G. Noci, F.M. Pini, Marketing reloaded.
Leve e strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale,
Milano, 2007, p. 212.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
pretativo unitario71. Come suggerisce Smorti,
il pensiero narrativo usa un tipo di logica mossa
dall’esigenza di arrivare a una rappresentazione il
più verosimile del mondo a partire dal minor numero possibile di esempi di questo mondo. Il pensiero
narrativo si svolge nella vita quotidiana, dove innanzitutto è indispensabile fare delle scelte. E per poter
fare una scelta non si può aspettare di poter ispezionare le complesse concatenazioni logiche di un pensiero deduttivo72.
Quello che può sembrare un elemento di
debolezza (l’inclusione nelle narrazioni del
punto di vista soggettivo), si rivela adesso un
punto di forza, in quanto consente l’accesso a
“storie locali”, cioè a informazioni contestuali,
concrete, lontane dall’astratta generalità delle
leggi e dei principi scientifici73.
A questo approccio fa riferimento anche
Franke Italia. Alla fine del 2006 l’azienda realizza un book, interamente scritto dai dipendenti – con il supporto editoriale di un
consulente esterno – per “raccontare” i primi
quarant’anni di attività. Il cuore di queste pagine è la testimonianza diretta dei protagonisti,
che raccontano i vissuti e le emozioni, i sogni
e i progetti, ma anche i dubbi e le difficoltà,
che hanno fatto da sfondo ai brillanti risultati
conseguiti in questi anni. Il documento non
ha un carattere agiografico e memorialistico:
punta piuttosto a far emergere ed attualizzare
le “tracce di futuro” depositate nel racconto del
passato, assumendo una prospettiva di lungo
periodo, nella quale si fondono creativamente
tradizione e innovazione.
3.4. Tradizioni “inventate”
Muovendosi in ambienti caratterizzati da
elevata turbolenza, le aziende assomigliano
sempre più a entità usa e getta, spazi di aggregazione temporanea per nomadi, pronti ad andare continuamente incontro a nuove sfide74.
71 Op.cit.
72 A. Smorti, Narrazioni. Cultura, memoria, formazione del
sé, Firenze-Milano, 2007, p. 145.
73 Cfr. F. La Cecla, Mente locale, Milano, 1993; B.
Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit., p. 33; G.C.
Cortese, L’organizzazione si racconta, cit., p. 21.
74 �������������������������������
J. Ridderstråle, K. Nordström, Funky Business. Talent
makes capital dance, Stockholm, 1999; trad.it. di R.
13
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
E’ dunque necessario offrire una giustificazione “retorica” delle premesse su cui si regge
l’organizzazione, dal momento che queste non
appaiono più dotate di una validazione empirica75. In altri termini, mentre l’azienda di stampo fordista poteva presentare la propria attività come risposta a bisogni, concretamente
rilevabili, del consumatore (es.: la produzione
di automobili come risposta ad una crescente
domanda di mobilità), in un contesto di mercato maturo tutto appare più incerto e più sfumato, per cui l’azienda è costretta a darsi una
“ragion d’essere”, che faccia appello alle componenti espressive e simboliche della propria
cultura, costruendo un “racconto” del proprio
passato a garanzia e giustificazione degli avvenimenti del presente.
Come ricordano Hobsbawm e Ranger76, nei
momenti di passaggio, segnati dalla frantumazione dei codici e degli ordini sociali, istituzioni politiche e movimenti di massa hanno fatto
ampio ricorso a tradizioni, simboli e rituali
“inventati” di sana pianta, allo scopo di tenere insieme su nuove basi le collettività umane.
Le tradizioni inventate rappresentano dunque
«risposte a situazioni affatto nuove, che assumono la forma di riferimenti a situazioni antiche», o che si costruiscono un passato attraverso la ripetitività quasi obbligatoria del rito77.
È il caso della Geox: tutta la comunicazione
istituzionale ruota attorno al “mito di fondazione” dell’azienda, l’invenzione della calzatura che respira. Durante un viaggio in America,
l’imprenditore Mario Moretti Polegato pratica
dei fori nella suola delle scarpe, trovando una
soluzione efficace per far fuoriuscire il calore in
eccesso: da questo semplice insight ha origine
un’azienda di grande successo, che in pochi anni
raggiunge una posizione di leadership a livello
mondiale nel settore della calzatura da città.
In realtà, Geox nasce dalla ricerca di un’alSpaventa, Funky Business. Il libro culto della net generation,
Roma, 2000.
75 D. Romano, R. Felicioli, Comunicazione interna e processo organizzativo, Milano, 1992.
76 E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), The Invention
of Tradition, Cambridge, 1983; trad.it. di E. Basaglia,
L’invenzione della tradizione, Torino, 1987.
77 Op.cit., p. 4.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
ternativa alla crisi dello sportswear, che attanaglia il distretto di Montebelluna all’inizio degli
anni Novanta: mescolando abilmente realtà
e finzione, il mito di fondazione si propone
come racconto di uno “strappo” rispetto alle
convenzioni e agli schemi consolidati. E’ una
storia romanzata, una tradizione “inventata”
appunto, che tuttavia integra al proprio interno la testimonianza autentica delle emozioni
vissute dai protagonisti del cambiamento.
3.5. Il passaggio dalla fabbrica al teatro
L’evoluzione verso nuove formule organizzative accentua la valenza comunicativa degli
ambienti di lavoro: questi non solo diventano
permeabili all’ambiente esterno, ma vengono
sempre più investiti da una pressante richiesta
di visibilità e di trasparenza, fino a trasformarsi in media building, luoghi in cui lo “spettacolo”
della produzione (merci o servizi) viene offerto allo sguardo e messo in scena78. Assistiamo
dunque al passaggio “dalla fabbrica al teatro”79.
Questo movimento è il risultato di un modello culturale dominato dall’ideologia della
trasparenza assoluta, che oggi emerge in stretta
connessione con le esigenze del nuovo processo produttivo post-fordista, il quale ha bisogno
che l’individuo «renda pubblico il suo consumo
privato, per poter sintonizzare con esso le strategie di produzione»80. In coerenza con queste
78 T. Ito, L’immagine dell’architettura nell’era dell’elettronica,
in “Domus”, n. 800 (1998), p. 28; P. Virilio, Dal media building alla città globale, in “Crossing”, n. 1 (2000), pp. 7-8.
79 F. Carmagnola, M. Ferraresi, Merci di culto. Ipermerce
e società mediale, Roma, 1999. Un eloquente esempio di
questa tendenza alla “teatralizzazione” degli spazi del lavoro è rappresentato dalla sede della L’Oreal ad Aulnay,
alle porte di Parigi: visto dall’alto, il complesso ha la
forma di un’orchidea, con i tetti degli edifici che, come
altrettanti petali, si distendono sopra strutture interamente rivestite di materiali trasparenti. Al centro vi è
uno specchio d’acqua, sopra il quale si eleva – come una
palafitta – il centro direzionale. I camminamenti interni – strutture metalliche sospese a mezz’aria – mettono
in rapporto le diverse aree del centro ricerche e dello
stabilimento di produzione. Tutto è centrato sui valori
della visibilità e della trasparenza comunicativa. In proposito, cfr. M. Augè, L’impossible voyage. Le tourisme et ses
images, Paris, 1997; trad.it. di A. Salsano, Disneyland e altri nonluoghi, Torino, 1999.
80 V. Codeluppi, La vetrinizzazione sociale, Torino, 2007, p.
14
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
premesse, viene meno ogni distinzione tra la
scena e il retroscena: non solo il lavoro viene inserito in un regime di piena visibilità, dal quale vengono tendenzialmente eliminati quelle
zona d’ombra e quei margini d’incertezza, su
cui si esercitava nel passato il potere discrezionale dei soggetti81, ma la fabbrica si trasforma
in un grande dispositivo teatrale, diventando
un’impresa-fiction82, una sorta di “vetrina”,
un’interfaccia comunicante e interattiva.
Un esempio eloquente viene dalla distilleria Nardini, che trasforma gli ambienti di lavoro in un dispositivo narrativo, grazie al grande
“alambicco” di vetro progettato da Massimiliano Fuksas, per ospitare il Research & Multimedia
Center. E’ un insieme formato da due mondi: il
primo è uno spazio “sospeso”, costituito da due
bolle trasparenti che racchiudono i laboratori;
il secondo è uno spazio “sommerso”, un auditorium con cento posti a sedere, scolpito nel
terreno come un canyon. Il complesso, nel suo
insieme, riproduce il percorso di tipo ascensionale disegnato nel mito della caverna platonica, con l’auditorium sotterraneo, dedicato agli
eventi e alle presentazioni multimediali (le
nuove “ombre” in versione tecnologica), avvolto nella semioscurità, debolmente rischiarato
dalla luce solare che proviene dall’alto, ove lo
sguardo incrocia le bolle trasparenti, chiamate
ad ospitare al proprio interno il centro ricerche, allegorica raffigurazione del mondo delle
idee. Utilizzando il linguaggio dell’architettura contemporanea, l’ascesa verso il mondo delle idee suggerisce l’inalterabilità dei valori che
stanno alla base della cultura aziendale. L’impresa si propone dunque come depositaria di
un sapere immutabile, che può essere ri-conosciuto dai suoi interlocutori, ma mai integrato,
confrontato o messo in discussione.
3.6. L’impresa come “regista di esperienze”
Se l’ambiente di lavoro assume sempre più
un impianto scenografico, l’azienda si trasforma a sua volta in un regista di esperienze, chia17.
81 M. Crozier, Le phénoméne bureaucratique, Paris, 1963;
trad.it. Il fenomeno burocratico, Milano, 1969.
82 Cfr. C. Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, cit.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
mato ad offrire ai propri interlocutori non
soltanto beni o servizi, ma anche esperienze
“teatrali”, ricche di sollecitazioni sensoriali83.
Vale la pena segnalare, a questo proposito, la performance recentemente proposta da
Molteni, uno dei maggiori gruppi industriali
nel settore del mobile, presso la propria sede
di Giussano. Lo spettacolo, intitolato “La vita in
un armadio”, ruota attorno a sei carismatiche
donne del Novecento: Frida Kahlo, Marguerite
Yourcenar, Evita Peron, Maria Callas, Elisabetta II d’Inghilterra, Marilyn Monroe. La rappresentazione si sviluppa in sei diversi ambienti,
ciascuno dei quali dominato da un armadio
della collezione Gliss 5th, chiamato a mettere in
mostra i prodotti che hanno caratterizzato la
vita di una delle sei protagoniste: oggetti della
quotidianità, immagini, fotografie. Gli sfarzosi abiti di scena della Callas si alternano così
alle pellicce, ai profumi e alle medicine di Evita
Peron. La performance, composta da sei monologhi – uno per ciascuna protagonista – viene
portata in scena dall’attrice Anna Galiena.
Per raggiungere le diverse installazioni, gli
spettatori sono invitati a muoversi in uno spazio complesso, che richiama gli archetipi del
sentiero e del labirinto, introducendo continui
elementi di novità e di sorpresa84. Chi partecipa alla performance è dunque sollecitato ad
assumere uno sguardo prospettico e multipolare, in costante movimento: l’assenza di rigidi
elementi di separazione tra la scena e lo spazio
circostante favorisce inoltre un più intenso
coinvolgimento emozionale, implicando il superamento della tradizionale distinzione tra
attori e spettatori85. Nel loro insieme, queste
soluzioni sembrano anticipare in forma me83 �������������������������������
Cfr. B. Schmitt, A. Simonson, Marketing aesthetics. The
strategic management of brands. identity, and image, New
York, 1997; J. Pine, J.H. Gilmore, The Experience Economy.
Work Is Theatre & Every Business a Stage, Boston, 1999;
trad.it. di A. Scott-Monkhouse, L’economia delle esperienze, Milano, 2000; M. Ferraresi, B. Schmitt, Marketing
esperienziale, Milano, 2006.
84 Per una più dettagliata analisi di questo caso, rinviamo a P. Musso (a cura di), Internal Branding. Strategie di
marca per la cultura d’impresa, Milano, 2007.
85 Alla preparazione della performance e delle installazioni contribuiscono gli stessi dipendenti dell’azienda,
invitati successivamente a partecipare all’evento.
15
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
taforica un nuovo modello di business, basato
sul coinvolgimento attivo – in veste di co-autori – dei principali stakeholder.
4. Dallo storytelling allo storylistening
In definitiva, dall’analisi dei casi aziendali
emerge l’opposizione tra due diversi modi di
fare storytelling, che può essere inteso, da un
lato, come arte del possibile, rivolta all’immaginazione del domani (cfr. il caso di Molteni)
oppure alla ri-lettura da una differente angolazione del passato (Franke Italia, Geox); da un
altro lato, come strumento di presidio dell’esistente, utile a sollecitare l’adeguamento degli
interlocutori a un quadro di valori e di modelli
già consolidati (Nardini).
In altri termini, alcune aziende interpretano lo storytelling istituzionale come occasione
per “ingessare” in un racconto agiografico l’attività dell’impresa, altre lo ripensano «come
un processo continuo di narrazione» nel quale
sia l’azienda che si racconta, sia i suoi stakeholder, possono in varia misura essere coinvolti
«nel formulare, rivedere, applaudire e rifiutare i vari elementi della narrazione perennemente messa in scena»86.
Il dibattito su questi temi è aperto e offre lo
spunto per ulteriori ricerche, analisi e approfondimenti. Alcuni evidenziano il rischio che
l’impresa-fiction si trasformi in una sorta di
parco a tema, astratto e decontestualizzato spazio del gioco e del divertimento87: un sistema
chiuso, autarchico, purificato da ogni possibile
conflitto, un luogo in cui il confine tra il vero
e il falso si assottiglia sempre più, basato su
«una condizione di equilibrio entropico, che
esclude per principio ogni sbocco sull’altrove»88.
Altri sottolineano come una trama narrativa
non possa mai ridursi a semplice monologo89.
86 B. Czarniawska, Narrare l’organizzazione, cit. p. 70.
87 Cfr. F. Varanini, L’organizzazione come rete di storie e lo
storytelling come furto, in “Sviluppo & Organizzazione”,
n. 220 (2007), pp. 69-74; C. Salmon, Storytelling. La fabbrica delle storie, cit.
88 I. Auricoste, Parchi o utopie mortali? La posta in gioco del
tempo libero, in “Ottagono”, n. 99 (1991), pp. 15-23, p. 23.
89 ������������
D.M. Boje,
������ Stories of the storytelling organization: a
postmodern analiysis of Disney as “Tamara-land”, cit.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
issn 2035-584x
Poiché questa formula espressiva non è assoggettata all’obbligo della coerenza interna, il piacere narrativo prende origine dalla curiosità
di sapere “cosa accadrà dopo” e, nel contempo,
dalla possibilità di tenere sempre aperto uno
iato, che consente al fruitore di attendersi qualunque cosa, anche l’imprevedibile90. Insomma, dare vita a una struttura narrativa significa
creare un intreccio di pieni e di vuoti: varchi
aperti a molteplici passaggi, capaci di stimolare la partecipazione attiva degli interlocutori e
i rapporti con altre aziende e con altri media.
Le implicazioni manageriali connesse a
questa seconda prospettiva ci sembrano di
particolare rilievo: invece di “persuadere” gli
interlocutori, proponendo una manifestazione egocentrica della corporate identity, si tratta
di realizzare un modello d’interazione più evoluto, che dia all’interlocutore un ruolo attivo,
basato non solo su un più intenso coinvolgimento emozionale, ma anche sulla sua attiva
partecipazione come partner del processo comunicativo. Per giungere a questo risultato, lo
storytelling d’impresa non può però prescindere dallo storylistening91.
Sullo sfondo si profilano nuove figure – ownsumer, citizen brand – che anticipano una nuova
prospettiva: quella di una costruttiva alleanza
tra produttori e consumatori responsabili, che
delinea nuovi modelli d’impresa (si pensi a Linux e Wikipedia) e nuovi scenari, nei quali gli
stakeholder si trasformano in co-creatori di
valore92, non solo concorrendo a definire il sistema dell’offerta, ma anche diventando parte
attiva nella programmazione e nella definizione delle scelte strategiche.
* Il presente contributo è la rielaborazione di un lavoro
presentato al Convegno “L’azienda e i suoi stakeholder”,
organizzato da AIDEA Giovani, Accademia Italiana di
Economia Aziendale, presso la sede di Gorizia dell’Università
di Udine (26-27 giugno 2009).
90 �������������
H. Jenkins, Convergence culture: where old and new
media collide, New York, 2006; trad.it. di V. Susca e M.
Papacchioli, Cultura convergente, Milano, 2007.
91 ����������������������������������
Cfr. E. Scholes, D. Clutterbu����
ck, Communication with
Stakeholders. An Integrated Approach, cit.
92 ������������������������������
C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, The future of competition. Co-creating unique value with customers, Boston, 2004;
trad.it. di F. Guaraldo e R. Ricca, Il futuro della competizione. Co-creare valore eccezionale con i clienti, Milano, 2004.
16
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Gabriele Qualizza, assegnista di ricerca presso
il LAREM – Laboratorio di Ricerca Economica
e Manageriale dell’Università di Udine, sede di
Gorizia. Docente a contratto Area marketing e comunicazione d’impresa all’Università di Trieste.
Lo storytelling nella comunicazione d’impresa
17
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Esperienze e forme di scrittura online
Enzo Marigonda
Abstract
Parole chiave
L’esperienza dello scrivere online varia in misura
notevole col variare delle forme e dei contesti di
comunicazione in cui si dà a vedere. Prendendo in esame
quattro ambienti di comunicazione scritta online (non
unidirezionali) – posta elettronica, Twitter, chat, gruppi
di discussione – è possibile far emergere alcuni tratti
distintivi, riguardanti le strategie e gli stili di scrittura.
Un fattore differenziale di cui tenere conto è anche la
relazione tra scrittura e tempo, ovvero le diverse attese in
termini di durata e permanenza del testo scritto.
comunicazione online;
scrittura;
produzione del testo;
relazioni interpersonali;
gruppi online;
ricerche psicosociali.
P
ni, strumenti e possibilità, fino agli attuali fasti
di Twitter, ampiamente utilizzato, per esempio,
dall’opposizione iraniana nel suo sforzo di far
filtrare tra le maglie della censura preziosi frammenti d’informazione sui misfatti repressivi
del regime teocratico. Per non parlare dell’uso di
Twitter nelle attività di comunicazione e soccorso durante il recente terremoto in Abruzzo.
Prima ancora di questi accadimenti, più
d’uno si era stupito del successo di Twitter (d’altronde, i grandi successi spiazzano e stupiscono sempre), non ravvisando nello strumento
nessun particolare elemento di originalità, a
differenza di un altro fenomeno telematico di
grandissima diffusione come Facebook.
In effetti, Twitter si distingue, e si raccomanda, per il suo minimalismo comunicativo: messaggi molto sintetici, in quanto costretti entro
un numero predefinito e limitato di battute
(140). È abbastanza evidente la similarità con
l’usuale messaggistica via cellulare, anch’essa
dominata da finalità di contatto - continuo, costante, reiterato - e di condivisione d’informazioni con interlocutori privilegiati.
er chi non si limita a una frequentazione
passiva del Web, ma lo usa per le proprie
comunicazioni personali, lo scrivere è una
delle pratiche d’uso più comuni, e per certi
aspetti la più articolata. Per marcare le distanze dalle forme tradizionali, per lo più cartacee,
va subito riconosciuto che la scrittura online
si presenta spesso come ibrida, ricca di contaminazioni visive (o audiovisive), più vicina
al linguaggio dello story-board che alla pagina
di diario. E’ quindi arbitrario, in certa misura,
isolare le pratiche di scrittura come oggetto di
osservazione privilegiato.
Tuttavia, pur tenendo conto della forzatura,
può risultare di qualche interesse uno sguardo,
per quanto rapido e parziale, alla pluralità delle forme e delle esperienze di comunicazione
interpersonale online attraverso i testi scritti.
Nel presente articolo, si prendono brevemente in considerazione quattro ambienti di
produzione testuale: la messaggistica di Twitter,
la posta elettronica, la chat, i forum in differita.
Dal tempo delle prime email, la pratica di scrivere in Rete si è ramificata secondo più direzio-
Esperienze e forme di scrittura online
18
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Anche in Twitter abbondano i riferimenti a
ciò che si sta facendo in un dato momento, al luogo in cui ci si trova, etc., ma con una più spiccata
accentuazione pratico-operativa, senza fronzoli.
Il ping-pong informativo di Twitter, quanto più si fa serrato, tanto più sembra favorire
il costituirsi di consuetudini comunicative e
correnti di simpatia tra i corrispondenti che
trovano espressione in giri di frase abituali, parole-chiave, tic verbali, etc. equivalenti a
cenni d’intesa o strizzate d’occhio, senza neppure bisogno di conferme paralinguistiche codificate come gli emoticon.
Tuttavia, al di là delle intese e dei legami
derivanti dall’infittirsi stesso degli scambi, un
aspetto notevole della comunicazione su Twitter è proprio l’esistenza di una norma rigida,
ovvero l’impossibilità di eccedere il numero di
battute previsto.
Si sa che la presenza di vincoli precisi, lungi
dall’ostacolarlo, favorisce e migliora il rendimento estetico di una produzione espressiva;
per contro, l’assenza di regole, e l’apparente libertà creativa totale che ne discende, porta di
solito a risultati insignificanti.
È questo un principio che vale per qualsiasi
forma di scrittura, con o senza ambizioni estetiche, e Twitter non fa eccezione. Per quanto
frammentari e microscopici, i messaggi che circolano su Twitter spesso sanno trarre beneficio
dall’obbligo di asciuttezza, con buoni risultati in
termini di efficacia e piacere della concisione.
La comune corrispondenza via email non
conosce lo stesso tipo di restrizioni, anche se
poi spesso nella pratica si manifesta anche qui
la tendenza a produrre testi brevi, incoraggiata in certa misura da un contesto che di norma
è anche troppo affollato, sovraccarico d’informazioni superflue, se non moleste o addirittura maligne (spamming, phishing, etc.).
La brevità delle comunicazioni trova sostegno
anche nella quantità dei messaggi contenenti allegati: se lo scopo principale della mail è trasmettere un documento (immagini, musiche, testi,
etc.) già esistente, saranno sufficienti poche righe di accompagnamento, niente di più.
Premesso che oggi come oggi la posta elettronica contiene un po’ di tutto, e quindi lascia
spazio a ogni sorta di stili e tipi di scrittura, apEsperienze e forme di scrittura online
issn 2035-584x
pare improprio e riduttivo considerarla come
un semplice sostituto della posta tradizionale,
anche volendo riandare a tempi lontani, precedenti alla diffusione del telefono, in cui la corrispondenza scritta era dominante.
L’erede di questa corrispondenza minuta,
pervasiva, finalizzata al contatto e al controllo, destinata a persone con cui s’intrattiene
un legame particolarmente stretto, affettivo o
operativo, sembra essere piuttosto il cellulare,
con i suoi sms. La posta elettronica, e ancor più
i servizi di messaggi istantanei via Internet, li
completano o li surrogano, dando vita a forme
di scrittura non troppo dissimili: secche, tronche, ricche di acronimi e forme abbreviate, etc.
Nella congerie di messaggi svelti, informali, prossimi all’oralità, di cui le caselle di posta
elettronica sono piene, s’insinua di tanto in
tanto qualche lettera di taglio tradizionale, introdotta da un ‘Cara’ o ‘Caro’ e chiusa con formule di cortesia caratteristiche del supporto
cartaceo. Per un istante, chi legge avverte una
sorta di straniamento, come di fronte a una
palese, inattesa infrazione della regola. Subito
dopo però il senso viene recuperato: in mancanza di un deliberato effetto ironico, o se il
mittente non è un tipo noto per il suo attaccamento alle tradizioni, dovrà trattarsi di una comunicazione formale (un atto burocratico, per
esempio) o comunque di una lettera seria, che
prende a prestito le antiche sembianze epistolari per sottolineare la sua differenza con il disinvolto ciarpame che le fa da contorno.
Tolta di mezzo la corrispondenza indesiderata, la maggior parte delle mail che si ricevono (e che s’inviano) ha come tratto comune
una scrittura facile e sciolta, aliena da ogni eccesso di cerimoniosità e intenzione di ricalco
dei modi epistolari di un tempo. Certamente,
le diffuse esigenze di praticità e le intrinseche
doti di velocità del mezzo sono alla base di un
costume di scrittura quanto mai libero, tollerante, non impegnativo. Ciò deve aver facilitato parecchio il diffondersi della posta elettronica presso persone che prima scrivevano
pochissimo e malvolentieri.
È un’osservazione, talvolta una piacevole
scoperta, che tutti abbiamo fatto, in qualche
momento, leggendo per la prima volta un
19
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
testo (breve, si capisce) scritto da quella tal
persona, frequentata e conosciuta fino ad allora solo attraverso il colloquio diretto. Spesso a quell’interlocutore non si era attribuita
alcuna attitudine allo scrivere, e invece ora
ci sorprende per la vivacità dello stile, la freschezza e l’originalità dei termini con cui dà
corpo alle sue idee.
Per quanto informale e volatile, soggetta a
continue cancellazioni, una email è pur sempre un messaggio scritto, che può essere salvato, riletto, riprodotto, rimeditato, criticato.
Forse è proprio il sentimento latente di una
possibile persistenza che può spiegare quel
quid di originale e di accurato che avviene di
notare nei messaggi di posta elettronica, anche
provenienti da persone in apparenza distanti
da qualsiasi attenzione alla retorica o allo stile. Perfino quando si riducono a poche righe
frettolose, le email trovano spesso il modo di
concedersi un guizzo, un’arguzia, uno scarto
laterale che ci diverte e ci delizia per la sua inventiva. Attraverso queste minute invenzioni
la persona che scrive riesce a lasciare una lieve traccia di sé, si fa ricordare, si distacca dalla
routine comunicativa quotidiana, costellata e
resa noiosa da una quantità di formule, gesti,
parole usa-e-getta.
La scrittura della chat è caratterizzata da
estrema rapidità e da una vicinanza all’oralità
che le deriva direttamente dal modello della
conversazione a più voci.
L’andamento errabondo, se non anarchico,
dello scambio verbale è la regola, più che l’eccezione. È determinato infatti da una condizione
strutturale: gli interventi in contemporanea,
che s’interpongono tra i messaggi appena visionati (a cui si replica), e il proprio atto di scrittura.
In questo senso, una circostanza offline a cui accostare il clima della chat potrebbe essere il classico party baccanoso, con la musica tenuta piuttosto alta e tanta gente che parla tutta insieme.
Su uno sfondo così irrimediabilmente caotico e rumoroso, il singolo intervento testuale rischia sempre la sfasatura, l’irrilevanza, il
fuori tema, qualora la chat abbia preso un’altra strada, in quel breve intervallo di tempo.
Quanto più invece saprà essere tempestivo,
Esperienze e forme di scrittura online
issn 2035-584x
tanto più sarà facile che riesca efficace, ossia
in grado di collocarsi al centro della conversazione, e non alla sua periferia. Ciò significa
riflessi fulminei, battute pronte, alta tensione
costante, specie quando (come accade spesso)
la conversazione diventa pepata, competitiva,
ricca di umori erotici o aggressivi.
In effetti, il gioco al rialzo, l’escalation provocatoria, la disposizione a spararle grosse risultano abbastanza frequenti, temperati però
da una comune volontà di sdrammatizzazione, scherzo, parodia, presa in giro.
Si ha così a volte un andamento ondulatorio
della conversazione: a momenti di massima eccitazione e scambio intenso, senza esclusione
di colpi, seguono fasi di tranquillità e ricarica,
in attesa che i fuochi si riaccendano ancora.
Nei momenti migliori, il divertimento è diffuso, condiviso. I partecipanti più a loro agio
sono senz’altro i battutisti migliori, ma più in
generale coloro che si lasciano andare al libero gioco associativo, producendo una scrittura
irriflessiva, bizzarra, senza censure di ragionevolezza e preoccupazioni di buona forma.
Il protocollo di una chat sufficientemente
animata e veloce si presenta spesso come una
nebulosa verbale di sapore vagamente futurista, ricca di salti, interruzioni, “non sequitur”
(i “cadaveri squisiti” surrealisti, al confronto,
appaiono come modelli di linearità). Oltre al
gusto (generalizzato) per lo spiazzamento e il
paradosso, si rileva di frequente il costituirsi
di sottogruppi o di coppie dialoganti, che danno vita a sequenze più serrate d’interventi, tali
da facilitare la comprensione da parte di un osservatore esterno.
Tutto sommato, però, leggere (o anche rileggere) le verbalizzazioni della chat trattandole
come un’unità di tipo lineare, eventualmente
con l’ambizione di trovarvi un senso latente,
non è molto rilevante né sensato. La ricostruzione dell’esperienza conversazionale e delle
sue dinamiche sarà sempre lacunosa, per chi
non si è trovato “dentro”, immerso nell’immediatezza della produzione testuale, nello spettacolo di fuochi d’artificio delle schermaglie,
del botta-e-risposta, dei colpi a effetto.
Va perciò sottolineato piuttosto il carattere
istantaneo, “cotto e mangiato”, della scrittura
20
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
della (o nella) chat, spesso più vicina alla performance teatrale (o forse cabarettistica) che
all’autobiografismo e alla funzione informativa del messaggio breve.
Sempre rimanendo nell’ambito della comunicazione di gruppo, vale la pena aggiungere
qualche commento su un’ulteriore forma di
scrittura online, apparentemente più vicina
alla tradizione: quella dei newsgroup e dei forum. Le dinamiche di gruppo possono essere
altrettanto intense della chat, ma certo si presentano assai diverse, stante la diluizione degli interventi in un arco di tempo molto ampio
e la relativa lentezza degli scambi.
Più precisamente, l’elemento differenziale decisivo è il funzionamento in differita,
l’assenza di una contemporaneità programmatica. La condizione in cui più membri del
gruppo sono connessi nello stesso momento è
incidentale, non è una regola (anche se di fatto
può produrre effetti rilevanti sull’andamento
della discussione). Il setting dei gruppi in differita mette in conto l’assenza contingente degli altri, e anche una certa distanza psicologica.
Si presuppone cioè una partecipazione relativamente costante, ma limitata a determinati
momenti di vita quotidiana, a discrezione dei
singoli membri del gruppo.
Dal punto di vista della comprensibilità e
dell’orientamento – in una parola, della leggibilità della discussione – gli’interlocutori si
trovano avvantaggiati rispetto alla chat: il testo
complessivo che documenta l’andamento della
discussione del gruppo - anzi, che è la discussione - appare ordinato, chiaro, eventualmente
ripartito su più argomenti, su cui si sviluppano
intrecci d’interventi di alcuni membri, sottogruppi spontanei che si costituiscono in base a
interessi specifici o a spinte del momento. Per
quanto possa essere articolata e abbondante la
mole dei messaggi altrui su cui aggiornarsi per
poter intervenire non a sproposito, la cronologia degl’interventi è indicata con chiarezza, così
come le loro relazioni reciproche (battibecchi,
precisazioni, metacomunicazioni etc.).
Il singolo partecipante ha tutto l’agio necessario per elaborare il suo punto di vista e dargli
espressione in un testo scritto che sarà, a suo
piacere, svelto o meditato, secco o barocco, riEsperienze e forme di scrittura online
issn 2035-584x
volto a tutti o destinato soprattutto a un dato
membro del gruppo. Premuto il tasto d’invio,
il nuovo intervento ottiene a volte una risposta immediata, ma altre volte può passare anche parecchio tempo prima che qualcun altro
lo raccolga e decida di rispondere (per non parlare dei casi, più o meno frustranti, in cui non
viene commentato da nessuno).
Basta una rapida scorsa al testo di qualsiasi
forum o newsgroup sufficientemente vivo e
consolidato per rendersi conto che tra i partecipanti sussistono complesse relazioni di amicizia e di condivisione, con una forte coloritura
di esibizione e competizione, dove la posta in
gioco, spesso non dichiarata, è la conquista o
il mantenimento di una qualche forma di leadership, oppure, più in generale, la ridefinizione incessante delle gerarchie, delle influenze,
delle posizioni all’interno del gruppo.
La misura forse più evidente di tali rapporti di potere è data proprio dalla risonanza, dal
ruolo-guida che il singolo intervento testuale è
in grado di conseguire. Gl’indizi sono di solito
abbastanza eloquenti: l’intensità e il numero
delle repliche, anche polemiche, le citazioni
personali all’interno di altri interventi, i riconoscimenti espliciti del tipo ‘come ha notato
giustamente X’, e altro ancora.
Il silenzio generale è la risposta peggiore,
che fa sentire il singolo partecipante in disparte, ai margini del gruppo, come se le sue parole
fossero irrilevanti, svuotate di senso. Per evitare questo, la scrittura è obbligata a una continua ricerca d’incisività, che si abbia o meno a
disposizione un’argomentazione forte o qualcosa d’importante da dire.
Ciò che si persegue nelle discussioni di
gruppo online, più o meno implicitamente, è
un risultato di rilevanza della propria parola
scritta. Rilevanza da intendere come possibilità di essere considerati con attenzione dagli
altri, e in secondo luogo come influenza, facoltà di agire sugli altri modificandone opinioni,
affetti, atteggiamenti.
La pratica di scrittura si orienta spontaneamente verso tali obiettivi e si caratterizza per
la costante ricerca dell’espressione efficace,
icastica, memorabile, ma anche sciolta, non
artificiosa, non tale cioè da apparire troppo
21
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
studiata e formale, e dunque inadatta al mezzo
online. Analizzati con attenzione, i testi tradiscono l’accuratezza della formulazione, ma al
primo impatto devono suonare spontanei e
immediati. Nella scrittura dei gruppi online
redomina quindi un registro intermedio, tra
il colloquiale e l’aforistico: l’argomentazione
risponde alla necessità di lasciare traccia di sé,
prima ancora di obbedire al desiderio di convincere o sedurre.
Abbiamo visto che anche nella scrittura delle email – di quelle con un valore aggiunto di
comunicazione personale, quanto meno – si
può individuare una fantasia latente di permanenza, di resistenza all’usa-e-getta. Si può
allora sostenere che sia nelle discussioni di
gruppo online sia nelle comunicazioni interpersonali della posta elettronica sopravvive
una suggestione di durata nel tempo, propria
della nozione tradizionale di scrittura.
Viceversa, nelle chat e nei rapidi messaggi
di Twitter la scrittura appare oralizzata al massimo, pressoché priva di elaborazione.
Scrittura del preconscio, nel caso delle chat,
sovente aperte alle bizzarrie, alle associazioni
libere, alla programmatica sospensione del
controllo razionale.
Scrittura secca e pragmatica, quasi militaresca, nel caso dei “cinguettii” della messaggistica breve, volti a isolare e a restituire immediatamente l’essenziale di una circostanza e di
un’esperienza in atto, o appena vissuta.
La produzione del testo scritto, in ambedue
i casi, si organizza intorno a un ideale d’immediatezza e istantaneità, quasi di annullamento
del tempo. I contenuti possono volgersi alla
realtà esterna o alle fantasticherie del mondo
interno, ma sempre nella consapevolezza di
una comunicazione impermanente, volatile,
che vive e si consuma nel presente.
issn 2035-584x
Carlini, F.: Parole di carta e di web, Torino,
2004.
Carrada, L.: Il mestiere di scrivere: le parole al
lavoro, tra carta e web, Milano, 2008.
Castells , M.: Galassia internet, Milano, 2006
Giordano, V. e Parisi, S.: Chattare: scenari della relazione in rete, Roma, 2007.
Hansoon, T. (ed.): Handbook of research on
digital information technologies: innovations,
methods and ethical issues, Hershey, PA, IGI
Global, 2008.
Lughi, G.: Parole on line: dall’ipertesto all’editoria multimediale, Milano, 2000.
O’Reilly, T. e Milstein, S.: The Twitter Book,
Sebastopol, CA, O’Reilly Media, 2009.
Pravettoni, G.: Web psychology, Milano,
2002.
Rondanini, P. e Rech, N.: Internet per la ricerca sociale: dalle indagini via email all’analisi dei
newsgroup, Milano, 2006
Rutledge, P.: Social networking, Milano,
2009.
Spears, R. e Lea,M. e Postmes, T.: Social psychological theories of computer-mediated communication: Social gain or social pain?, In Giles, H.
e Robinson, P. (eds.), New handbook of language
and social psychology, pp. 601-624, New York,
Wiley, 2001.
Enzo Marigonda, psicologo, docente a contratto
all’Università di Trieste (Facoltà di Scienze della
Formazione e Facoltà di Psicologia) e al Master per
l’Editoria dell’Università Statale di Milano, si occupa da anni di ricerche psicosociali di tipo qualitativo applicate all’ambiente online.
Bibliografia
Baldini, M. e Marucci, D. (a cura di): La parola nella galassia elettronica, Roma, 2005.
Bruno, P.: Dolce stil web: le parole al tempo di
internet, Milano, 2009.
Esperienze e forme di scrittura online
22
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Tradizione e tecnologia online a confronto.
Il passaparola elettronico: perché l’imprenditore
agrituristico dovrebbe tenerne conto…
Katia Laura Sidali
Achim Spiller
Abstract
Parole chiave
Il passaparola elettronico può aiutare gli operatori
agrituristici a relazionarsi in maniera più efficace con il
consumatore. Il presente lavoro analizza, attraverso un
esperimento, il grado di fiducia che hanno gli utenti nei
riguardi delle recensioni digitali e offre degli spunti di
riflessione per la commercializzazione dell’agriturismo
in Internet.
passaparola elettronico;
agriturismo;
promozione online;
tecnologie dell’informazione;
recensioni digitali
1. Introduzione1
N
elson Mandela una volta disse che «parlare in una lingua comprensibile permette al messaggio di raggiungere la mente della
persona che sta ascoltando. Per raggiungere
però il suo cuore occorre utilizzare la sua stessa lingua»2.
Nel mercato dei beni turistici una comunicazione che «arrivi direttamente al cuore» del
consumatore è il risultato di un lungo e costo1 Questo articolo presenta nello studio descritto nel
paragrafo 3 la sintesi di due lavori, un articolo e un
capitolo di una tesi di dottorato precedentemente
pubblicati. I riferimenti di entrambi i lavori sono i seguenti: K. L. Sidali, H. Schulze, A. Spiller, The impact of
online reviews on the choice of holyday accomodation, in W.
Höpken, U. Gretzel, R. Law (a cura di), Information and
Communication Technologies in Tourism, Vienna, 2009,
pp. 87-98 e K.L. Sidali, Farm tourism: A cross-country empirical study between Germany and Italy, tesi di dottorato,
Università di Bologna, 2009.
2 Libera trad.it. a cura dell’autore. Il testo originale è il
seguente «If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his
language, that goes to his heart».
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
so processo di studio e sperimentazione, alla
realizzazione del quale partecipano esperti di
diverse discipline. È quindi evidente che non
tutte le imprese possono permettersi simili
investimenti.
Soprattutto in mercati di nicchia, quale
quello dell’agriturismo, le competenze volte
a creare una comunicazione emozionale con i
consumatori sono alquanto limitate. Numerosi studi dimostrano infatti che per molti imprenditori agrituristici è spesso un problema
relazionarsi efficacemente con il consumatore3. In primo luogo mancano molto spesso le
risorse economiche (soprattutto in un contesto di riduzione delle sovvenzioni all’agricoltura) e di tempo (accavallamento dei picchi
turistici durante la stagione agricola). Ma è
soprattutto la limitata conoscenza del mercato
(agri) turistico a determinare le maggiori difficoltà. Infatti oggigiorno il turista, definito da
3 Si vedano cfr. A. M. Hjalager, Agricultural diversification
into tourism, in “Tourism Management”, 17 (1996), n. 2,
p. 109 e R. W. Slee, R. Yells, Some aspects of marketing farm
holiday accommodation, in “Farm Management” 5 (1985),
n. 8, p. 322.
23
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
molti autori come «post-turista»4, è sempre
più esigente e al contempo meno prevedibile
nelle sue decisioni di spesa. Si delineano nuovi
modelli di fruizione della vacanza, all’interno
dei quali gli individui tendono ad attribuire
meno importanza alle caratteristiche estrinseche di prodotti e servizi, per valorizzare maggiormente la natura simbolica del consumo.
Inoltre si viaggia più frequentemente rispetto
al passato ma in maniera più autonoma, privilegiando il contatto diretto con gli operatori
turistici finali e premiando chi offre prodotti
flessibili e innovativi.
In questo contesto, il settore comunemente
definito dell’information technology può aiutare
ad avvicinare gli operatori agrituristici al postturista. Così ad esempio la tecnologia GPS può
aiutare a creare maggiore visibilità soprattutto per gli agriturismi situati in località rurali
difficilmente raggiungibili, sfruttando canali
di distribuzione alternativi o complementari a
quelli tradizionali. Ma è soprattutto l’avvento
di Internet che offre agli imprenditori agrituristici i vantaggi più evidenti, non solo in termini di maggiore visibilità, ma anche dando
agli utenti sia la possibilità di interagire direttamente fra di loro attraverso il cosiddetto passaparola elettronico5, sia quella di comunicare
direttamente con gli operatori del settore (ad
es. con le prenotazioni online, scambiando informazioni via e-mail, ecc.).
Pur trovandosi ancora in una fase di sviluppo iniziale, questa industria dei «neo-beni»6
digitali, basata su tecnologia Internet registra
promettenti prospettive di crescita. Nel presente lavoro si cercherà di analizzare il suo
ruolo per promuovere lo sviluppo del settore
agrituristico e, a tale scopo, si dedicherà par4 Trad. it. a cura dell’autore. Il termine in inglese è
«post-tourist» espressione usata spesso nella letteratura turistica. Si vedano a riguardo D. B. Clarke, M. A.
Doel, K. M. Housiaux (a cura di), The consumption reader,
London, 2003 e L. Roberts, D. Hall (a cura di), Rural tourism and recreation. Principles to practice. Oxford, 2001.
5 Per una definizione del termine «passaparola elettronico» si rimanda al paragrafo 2.1.
6 Cfr. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
(CNEL), Pronunce 54 – Osservazioni e proposte – L’industria
dei contenuti digitali. Gli ostacoli e le condizioni di sviluppo,
Roma, 26 febbraio 2009.
Tradizione e tecnologia online a confronto
issn 2035-584x
ticolare attenzione al passaparola elettronico,
così come è trasmesso attraverso le recensioni
digitali di prodotti e servizi7.
Nel prossimo paragrafo verrà avviata una
riflessione sulle varie forme che può assumere
il passaparola elettronico (2.1). La relazione tra
il settore dell’agriturismo e le nuove tecnologie
sarà presentata nel paragrafo 2.2. Successivamente (3) sulla base dei primi risultati di una
ricerca internazionale mostreremo il primato
della comunicazione online su altre fonti di informazione e riveleremo, attraverso la statistica
descrittiva, quali elementi sono capaci di creare un alto grado di fiducia nel passaparola elettronico attraverso l’esempio della recensione
digitale. Infine (4) verrà offerta una riflessione
sui modi in cui la comunicazione online possa
essere utilizzata per migliorare la relazione tra
gli operatori agrituristici e i consumatori.
2. Quadro teorico
2.1. Il passaparola elettronico
In questo articolo ci riferiamo al termine
«passaparola elettronico»8 come all’insieme
delle comunicazioni fra diversi utenti (Web output) che scorrono sulla rete o World Wide Web.
Dal punto di vista linguistico il passaparola è
una forma di comunicazione tra individui che,
prendendo a prestito il modello «organon» di
Bühler9, può essere rappresentata come un sistema imperniato su un segno (signifiant) che
ricopre la funzione di rappresentare la realtà
esterna. Detto segno è l’oggetto stesso della
comunicazione tra un mittente ed un destinatario, sebbene questi ultimi possano conferirgli diversi significati (signifié del mittente e
signifié del destinatario)10. Sulla base di quanto
7 Per una definizione del termine «recensioni digitali»
si rimanda al paragrafo 2.1
8 Trad. it. a cura dell’autore. Il termine in inglese è
«electronic word of mouth» spesso usato nella forma
abbreviata di «e-WOM».
9 K. Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der
Sprache, Stuttgart/New York, 1992.
10 I termini «signifiant» e «signifié» vengono introdotti nella linguistica da F. de Saussure, considerato il padre dello strutturalismo linguistico, cfr. F. de
Saussure, Cours de linguistique générale. Paris, 1949.
24
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
detto possiamo tracciare una prima classificazione del passaparola elettronico.
La forma (signifiant) più ricorrente che assume il passaparola elettronico (il «segno» nel
modello di Bühler) è sicuramente l’e-mail, la
quale può essere utilizzata sia a scopo ricreativo sia professionale (signifié del mittente e del
destinatario). Un’altra «manifestazione» del
passaparola elettronico è la recensione digitale11 che può essere definita come il giudizio che
il consumatore scrive online sui più svariati
servizi o prodotti, collocandolo su un’apposita
piattaforma digitale12. In questo caso la comunicazione ha prevalentemente natura contingente e divulgativa. Altre forme del passaparola elettronico sono i blogs, i fori di discussione, le
chats e i social networks, nelle quali il significato
del passaparola elettronico è particolarmente
legato alla «mission» del sito ove la stessa è posta (fori medici, blogs istituzionali, ecc.). Newsletter e messaggi tramite tecnologia RSS vengono
invece frequentemente utilizzati dalle aziende
per fidelizzare quei consumatori che sono già
entrati in contatto con l’impresa almeno una
volta e che accettano questo tipo di comunicazione selettiva per difendersi dal cumulo indiscriminato di informazioni elettroniche13.
Da questa breve rassegna è evidente che la
forma del passaparola elettronico spesso coincide con lo stesso canale di trasmissione della comunicazione online, che, a sua volta, influenza
il signifié cioè il significato del messaggio comunicato tramite il passaparola e, di conseguenza,
il suo grado di rappresentazione della realtà.
La questione non è di poco conto soprattutto per beni, come i prodotti turistici, altamente esperienziali, dove cioè non è possibile determinare la qualità del bene da acquistare se non
consumandolo, e, quindi, trasformandolo in
un’esperienza unica e memorabile. La decisio-
ne d’acquisto per questo tipo di beni avviene
pertanto alla fine di un processo oneroso in termini di tempo dedicato alla ricerca di informazione e alla selezione della stessa. Ciò richiede
un’attenta scrematura di molteplici fonti di
informazione, operazione non facile visto che
il consumatore è generalmente svantaggiato
rispetto alla controparte14. In questo contesto
il passaparola, anche di natura elettronica, assume un’importanza fondamentale.
Come già accennato, nel seguito di questo
articolo analizzeremo ulteriormente il passaparola elettronico circoscrivendolo al fenomeno delle recensioni digitali di prodotti e servizi
turistici. In particolare riporteremo i risultati
di uno studio condotto in Germania, attraverso
il quale intendiamo dimostrare l’importanza
del passaparola online per il settore dell’agriturismo in quanto dotato di una forte valenza
emotiva. Sulla base di detti risultati offriremo
degli spunti di riflessione per la commercializzazione di questa particolare nicchia turistica.
11 Libera trad.it. a cura dell’autore. Corrisponde al termine inglese «electronic» o «e-review». 12 Siti nati appositamente per ospitare recensioni digitali sono gli storici www.tripadvisor.com diffuso soprattutto negli Stati Uniti e www.holidaycheck.com
consultato più frequentemente in Europa.
13 Problema, questo, a cui si fa riferimento nella letteratura
con il termine di information overload si veda cfr. R. E. Mayer,
Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning, in
“Educational Psychologist”, 38 (2003), n. 1, pp. 43-52.
14 Nelle scienze economiche ci si riferisce a questo problema impiegando l’espressione «informazione asimmetrica» si veda G. A. Akerlof, The market for «lemons»:
quality uncertainty and the market mechanism, in “Quaterly
Journal of Economics”, 84 (1970), pp. 488-500.
15 Questa definizione è valida solo per l’Italia, l’unico
paese europeo dotato di un corpus giuridico espressamente dedicato all’agriturismo. Per approfondimenti si
rimanda alle leggi n. 96 del 2006 e n. 730 del 1985.
16 Hjalager (1996). Opera cit.
Tradizione e tecnologia online a confronto
2.2. Agriturismo e nuove tecnologie
L’accostamento di «passaparola digitale»
con «agriturismo» potrebbe sembrare a prima
vista improbabile o azzardato. L’agriturismo,
definito come «attività turistica connessa ad
attività agricola»15 è per lo più associato con paesaggi romantici, tradizioni popolari antiche
e, in generale, una vita contadina cadenzata
da ritmi lenti, che evoca nostalgia. In verità le
zone rurali sono già da tempo meccanizzate e
ciò che viene offerto al turista cittadino tramite accurate politiche di commercializzazione
(il corso di cucina tradizionale piuttosto che la
scuola di agricoltura biologica, ecc.) è piuttosto
una «re-invenzione della realtà»16.
La modernizzazione dell’agriturismo è visi-
25
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
bile anche in Internet. Nel mare magnum digitale infatti gli imprenditori agrituristici più
attenti alle cangianti esigenze dei consumatori si sono velocemente provvisti di una pagina
Web (propria o della associazione agrituristica
cui appartengono) per approfittare dell’incredibile chance data dalla «rete» in termini di
visibilità planetaria. Inoltre, in questo modo,
possono anche far fronte all’alto tasso di concorrenza che caratterizza questo settore.
Ma se la maggior parte degli imprenditori
agrituristici non ha perso il treno tecnologico
partito con la diffusione di Internet (provvedendo ad esempio, a fornirsi di una home page)
e denominato Web 1.0; la sfida odierna si identifica con la seconda generazione di tecnologie digitali, riunite nell’espressione Web 2.0.
Questo salto numerico sta ad indicare le nuove
caratteristiche del web utente il quale si è liberato del suo ruolo passivo di osservatore della
vetrina digitale per interagire direttamente
con un’impresa, come nel caso dell’online banking, o con i suoi simili (peers), come accade nei
forum di boicottaggio, nei blogs o sulle piattaforme online ospitanti le recensioni digitali di
beni. È proprio attorno a quest’ultimo tipo di
passaparola elettronico che, come già accennato, ruoterà l’analisi seguente con l’obiettivo di
capire l’influenza della comunicazione online
rispetto ad altri generi di comunicazione, sulle
decisioni di spesa del consumatore ed evincere
quindi quali siano le componenti chiave della
fiducia che il consumatore ripone in questo
genere di comunicazione.
3. Lo studio
Per raggiungere gli obiettivi sopraccitati la sezione di Marketing Agro-Alimentare
dell’Università di Göttingen ha elaborato un
apposito questionario. Quest’ultimo si articola in quattro sezioni principali. Nella prima
sono inserite domande relative al processo decisionale che viene intrapreso dal turista prima di iniziare un viaggio. In particolare viene
chiesto di selezionare le fonti di informazione
considerate più importanti per l’acquisto di un
prodotto turistico.
Nella seconda sezione viene presentato
Tradizione e tecnologia online a confronto
issn 2035-584x
un esperimento in base al quale i rispondenti devono scegliere per quattro volte tra due
strutture turistiche dello stesso genere che
si differenziano unicamente per la fonte di
informazione che recensisce la struttura. In
ognuno dei casi presentati, la recensione digitale fornita da altri consumatori compete con
altre fonti di informazione: una guida turistica molto conosciuta in Germania, il numero
di stelle utilizzate nel settore alberghiero ed i
consigli di un’agenzia di viaggio tedesca molto rinomata a livello nazionale17. Le opzioni
scelte dai partecipanti sono state in seguito
codificate e trasformate in un indice in grado
di misurare il livello di preferenza dell’utente
per il passaparola online trasmesso attraverso
la recensione digitale18.
Nella terza parte del questionario le domande identificano le componenti che rendono la
recensione online degna di fiducia agli occhi
degli utenti. L’ultima sezione riguarda la raccolta di informazioni sui dati anagrafici: stato civile, età, professione e reddito della famiglia, ecc.
Sulla base di tale questionario durante il
mese di maggio 2008 è stato costruito un campione di 216 soggetti scelti casualmente fra i
residenti della città di Goettingen. La popolazione del campione19 risulta così composta:
L’età media dei rispondenti è 39 anni. In
particolare la fascia di età maggiormente rappresentata è tra i 21 e i 30 anni (40,4%), seguita
da quella tra i 31 e i 50 anni (35,2%) ed infine
quella degli ultra cinquantenni (22%). Solo
l’1,6% del campione ha un’età inferiore ai 20
anni. Inoltre, nel campione prevalgono le donne (54% contro il 46% degli uomini).
Per quanto riguarda la fase della preparazione della vacanza il campione dimostra un alto
livello di «impegno» (o involvement come vie17 Non potendo condurre le interviste online è stato
utilizzato in sede di esperimento il logo di famosi siti
ospitanti recensioni digitali in maniera tale da simulare
l’ambiente Internet.
18 Si tratta di un indice costruito con la seguente scala di valori: da 0= non è mai scelta la struttura ricettiva
con la recensione digitale migliore 5= in tutti i casi viene scelta la struttura ricettiva con la recensione digitale
migliore.
19 trattasi di cosiddetto “convenience sample” cioè
campione non rappresentativo.
26
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
ne definito nella terminologia del marketing).
Infatti, ben il 43,5% dei partecipanti afferma
di investire molto, in termini sia di tempo sia
di energia, nell’attività pre-viaggio. Ma il dato
più interessante riguarda proprio l’uso delle
nuove tecnologie in supporto a tale attività: il
63,5% del campione dichiara di far uso della
tecnologia Internet per pianificare le vacanze
e il 56,6% degli intervistati dichiara di aver già
prenotato in passato una vacanza in Internet.
3.1. Fonti di informazione a confronto:
primato della comunicazione online
Attraverso l’utilizzo di domande Likert è stato chiesto ai participanti di selezionare le fonti
di informazione considerate più importanti
per valutare la qualità di un prodotto turistico.
Le fonti di informazione proposte spaziavano
da quelle considerate più oggettive nel veicolare informazioni concernenti la qualità di un
prodotto turistico, come ad esempio il sistema
della classificazione alberghiera basato sulle
stelle, ad altre più soggettive come il passaparola di amici/colleghi, brochures turistiche e,
naturalmente, anche il passaparola elettronico.
Come mostra la tabella 1, le prime quattro fonti di informazione dichiarate più importanti
sono risultate essere le seguenti: il passaparola
di amici/colleghi (cosiddetto passaparola offline), il sistema della classificazione a stelle del
settore alberghiero, il passaparola elettronico
nella forma della recensione digitale e i consigli delle agenzie di viaggio.
Questo primo risultato è importante perché mostra come il passaparola elettronico,
strumento di comunicazione relativamente
nuovo, riesca comunque ad essere percepito
come più importante del tradizionale agente
di viaggio. Tuttavia, per comprendere a fondo
il complesso fenomeno del processo decisionale precedente l’acquisto di un bene turistico,
è necessario analizzare ciò che avviene nella
vita reale in quanto, secondo Hato (et alii) ,20
20 ��������������������������������������������������
E. Hato, M. Taniguchi, Y. Sugie, M. Kuwahara, H.
Morita, Incorporating an information acquisition process into a route choice model with multiple information
sources, in Transportation Research Part C: Emerging
Technologies, 7 (1999), n. 2-3, pp. 109-129.
Tradizione e tecnologia online a confronto
issn 2035-584x
mentre «gli individui nella fase di ricerca acquisiscono le informazioni da molteplici fonti
di informazione, il numero di queste ultime si
riduce sensibilmente al momento di provvedere effettivamente all’acquisto del bene».
I risultati dell’esperimento sembrano supportare tale tesi in quanto i precedenti risultati vengono «ribaltati»: la maggioranza dei rispondenti sceglie, nella simulazione della vita
reale rappresentato dall’esperimento, prioritariamente la struttura ricettiva con la recensione digitale migliore indicando in questo modo
chiaramente un alto livello di preferenza per
questo tipo di passaparola elettronico. A grande distanza seguono le guide turistiche, i consigli delle agenzie di viaggio e, solo per ultimo,
il sistema di classificazione alberghiero.
Come si giustifica il ruolo predominante
dato al passaparola online nella forma delle recensioni digitali? Sicuramente, come sostengono Molina e Esteban 21, diverse fonti di informazione trasmettono diverse aspettative. Così
è plausibile pensare che, se per l’acquisto di un
genere alimentare una fonte di informazione
percepita come molto oggettiva (es. il marchio
di qualità assegnato da un certificatore esterno) possa avere un’influenza molto forte in
quanto agisce sulla sfera cognitiva dell’essere
umano (che vuole sapere cosa mangia), per un
bene tuttavia altamente esperienziale, è plausibile che altre fonti di informazione, più influenti sulla sfera affettiva, esercitino un ruolo
principe, innescando l’insorgere di sogni/speranze (es. la promessa di riposo di una vacanza
in agriturismo) che sarà poi premura dell’imprenditore (agri)turistico rafforzare.
21 ������������������������
A. Molina, A. Esteban, Tourism Brochures - Usefulness
and Image –, in “Annals of Tourism Research”, 33 (2006),
n.4, pp. 1036-1056.
27
issn 2035-584x
Le più importanti fonti di informazione sono…
Le fonti di informazione scelte più frequentemente in sede di esperimento
1
Consigli di amici/colleghi
1
Recensione digitale
2
Classificazione alberghiera
2
Guida turistica
3
Recensione digitale
3
Suggerimento dell’agenzia di viaggio
4
Agenzia di viaggio
4
Sistema alberghiero
Fonte: propria
elaborazione
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Tabella 1. Confronto tra le risposte date dagli intervistati ed i risultati dell’esperimento
3.2. Elementi chiave nella creazione di
fiducia verso le recensioni digitali peerto-peer
Per comprendere il livello di fiducia che i consumatori riversano nei confronti della comunicazione online è stato chiesto agli intervistati di
indicare la propria opinione nei riguardi delle recensioni digitali di prodotti turistici. In generale,
la netta maggioranza del campione (61%) dichiara che le recensioni digitali sono «molto utili»
nella pianificazione della vacanza e addirittura
il 75% degli intervistati dichiara che sarebbe disposto a pagare un prezzo maggiore per un hotel
recensito positivamente da peers in Internet.
La statistica descrittiva ci viene in aiuto anche
al momento di analizzare quali aspetti di questo
tipo di comunicazione sono percepiti come particolarmente importanti per determinare un alto
livello di fiducia nel consumatore (vedi Tabella
2). Il 67% degli intervistati dichiara di affidarsi
soprattutto a recensioni ricche di dettagli (utili al
fine della pianificazione della vacanza) mentre il
64% attribuisce un alto grado di fiducia alle recensioni dalle quali traspare un’alta esperienza di
viaggio dell’autore. Altri elementi atti a creare fiducia verso questo tipo di comunicazione online
sono uno stile amichevole (33%), una (percepita)
empatia (in termini di comunanza di interessi,
visione del mondo, ecc.) tra il lettore e l’autore
della recensione (33%) ed, infine, il numero totale di recensioni scritte dall’autore (30%).
Caratteristica della recensione digitale in grado di Percentuale degli intervistati che si definiaumentarne la fiducia nel lettore1:
scono molto o abbastanza d’accordo2:
Ricchezza di dettagli
67%
Alta esperienza di viaggio dell’autore
64%
Stile amichevole
33%
Empatia con l’autore
33%
Numero di recensioni scritte dall’autore
30%
1 Domanda del tipo Likert con scala di valori da (+2) =assolutamente d’accordo a (-2) =assolutamente in disaccordo
2 Le percentuali si riferiscono alle risposte con valore (+1) e (+2)
Tabella 2. Analisi degli elementi che concorrono a creare fiducia nelle recensioni digitali
Tradizione e tecnologia online a confronto
28
Fonte: propria elaborazione
Il primato della recensione digitale su fonti più oggettive come la classificazione alberghiera può essere quindi spiegato in quanto
la prima agisce sulla sfera affettiva dell’individuo. Come spiegare però il primato della stessa anche su altre fonti di informazioni, quali
gli agenti di viaggio, che utilizzano raffinate
tecniche di comunicazione creativa (story-telling, slogan d’effetto, foto e video accattivanti
sulle brochures, ecc.) al fine di creare un legame emozionale con l’utente? La spiegazione è
data probabilmente dal particolare rapporto di
fiducia che si instaura tra l’utente che legge la
recensione digitale e colui che descrive il bene
basandosi sulla sua precedente esperienza. Nel
paragrafo successivo tale rapporto sarà esaminato ulteriormente.
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Come precedentemente accennato il canale di trasmissione di un messaggio digitale è parte integrante della comunicazione.
Nella fattispecie, le recensioni di strutture
turistiche come quelle proposte in sede di
esperimento possono trovarsi sia su siti istituzionali (ad es. il sito turistico ufficiale della
regione) sia su portali privati (come nel caso
dei portali delle associazioni di operatori agrituristici). Nella Tabella 3 analizziamo, attraCaratteristica della piattaforma in grado di aumentarne la fiducia nel lettore1:
Indipendenza della piattaforma
Disponibilità di informazioni aggiornate
Notorietà della home page che ospita la piattaforma
Customization della piattaforma
Popolarità della piattaforma
Numero di funzioni per raffinare la ricerca
Incentivi economici
Pubblicità esterna
dal 12% degli intervistati) né gli incentivi economici offerti da talune piattaforme digitali
per aumentare il numero di recensioni (15%
del campione) sembrano capaci di innalzare
il grado di fiducia nella piattaforma.
3.4. Considerazioni generali
In generale risulta evidente che la recensione più è percepita come dettagliata più è
considerata affidabile. Non stupisce che, soprattutto in tempi di ristrettezze economiche, il consumatore premi la comunicazione
che meglio di altre permette di ridurre al miPercentuale degli intervistati che si definiscono
molto o abbastanza d’accordo2:
82%
68%
61%
59%
53%
51%
15%
12%
Fonte: propria elaborazione
3.3. Elementi chiave nella creazione di
fiducia verso le piattaforme digitali
ospitanti le recensioni
issn 2035-584x
1 Domanda del tipo Likert con scala di valori da (+2) =assolutamente d’accordo a (-2) =assolutamente in disaccordo
2 Le percentuali si riferiscono alle risposte con valore (+1) e (+2)
Tabella 3. Analisi degli elementi che concorrono a creare fiducia nei siti Internet (piattaforme) che ospitano le recensioni digitali
verso la statistica descrittiva, quali elementi
concorrono a creare un legame di fiducia tra
il fruitore della recensione e la piattaforma
sulla quale tale recensione è posta.
L’indipendenza della piattaforma dal proprietario della struttura ricettiva è l’elemento indicato dalla maggioranza del campione
(82%), seguito dall’aggiornamento delle informazioni presenti sulla piattaforma (68%),
il livello di notorietà della home page (se presente) ospitante la piattaforma (61%) il grado
di adeguamento (customization) della piattaforma alle esigenze degli utenti (59%), il
grado di popolarità della piattaforma stessa
(53%) ed il numero di funzioni offerte per raffinare la ricerca (51%). Al contrario, né la pubblicità esterna (considerata importante solo
Tradizione e tecnologia online a confronto
nimo il rischio di spendere male i soldi destinati all’acquisto di un bene turistico.
Inoltre, come abbiamo visto, la stessa piattaforma dove è posta la recensione, deve essere percepita come credibile. Questo significa
forse che recensioni poste sulla propria home
page debbano essere escluse a priori? Uno
sguardo al settore alberghiero, dove non è raro
trovare questo genere di passaparola elettronico come ulteriore servizio di cortesia per i
potenziali clienti sembrerebbe smentire questa limitazione. Vero è comunque che qualora un imprenditore agrituristico decidesse di
ospitare sul proprio sito Internet recensioni
relative alla propria offerta, le precauzioni da
usare sono molteplici. A tale genere di riflessioni è dedicato il paragrafo seguente.
29
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Implicazioni per gli imprenditori
agrituristici
Abbiamo visto nelle sezioni precedenti
che il passaparola elettronico in generale e le
recensioni digitali in particolare, esercitano
una forte valenza emotiva sul consumatore.
Ciò implica che gli imprenditori agrituristici
non possono più ignorare questo genere di
comunicazione, che sembra, tra l’altro, destinata a diffondersi considerevolmente anche
per la diffusione di informazioni riguardanti
beni diversi da quelli turistici. A questo punto
è plausibile supporre che per gli operatori del
settore agrituristico ci siano due possibilità di
inclusione delle recensioni digitali nella rete
di promozione e commercializzazione della
loro struttura. In primo luogo l’imprenditore potrebbe decidere di ospitare le recensioni
digitali sul suo stesso sito Internet. In questo
caso, e posto che venissero pubblicate sia le recensioni positive sia quelle negative per rendere maggiormente credibile la comunicazione
peer-to-peer, il vantaggio più evidente sarebbe
l’aumento della reputazione dell’agriturismo
in questione, vista la totale trasparenza segnalata dall’imprenditore ai suoi utenti. Un altro
vantaggio derivante da tale decisione è legato
alla miniera di informazioni assolutamente
gratuita, autentica e aggiornata di cui l’operatore agrituristico disporrebbe sui suoi clienti.
Dall’altro lato però, tale disponibilità di dati
si rivelerebbe inutile e addirittura costosa se
l’operatore agrituristico non pianificasse, parallelamente, un continuo e attento lavoro di
controllo redazionale atto a catalogare le informazioni a fini statistici, cancellare dati inopportuni (informazioni obsolete o lesive della
privacy propria o altrui, informazioni false,
ecc.). Inoltre, un’altra conseguenza negativa di
cui l’operatore agrituristico dovrebbe tenere
conto sarebbe la diffusione incontrollabile di
un eventuale passaparola negativo dovuto al
reale problema che nulla di ciò che viene pubblicato in Internet può essere definitivamente
cancellato.
Per cercare di ridurre al minimo tale rischio
l’operatore agrituristico ha a sua disposizione
un’altra possibilità: quella di affidarsi ad un
Tradizione e tecnologia online a confronto
issn 2035-584x
soggetto esterno. I portali promozionali di
agriturismi22, ad esempio, sono specializzati
nella promozione di tali strutture e dispongono delle necessarie risorse, in termini sia
di know-how tecnologico sia di tempo, per
effettuare un controllo redazionale continuo.
Inoltre, ospitando diverse strutture ricettive
queste piattaforme vengono percepite dagli
utenti come indipendenti dal singolo operatore agrituristico aumentando, di conseguenza,
anche il grado di fiducia nelle recensioni ospitate. Dovendosi però affidare ad un soggetto
esterno è però evidente che i costi per l’operatore agrituristico aumentano notevolmente.
Questo è quindi il principale svantaggio riguardante la decisione di affidare un sistema
di comunicazione peer-to-peer ad un soggetto
esterno.
In generale possiamo concludere che, come
ribadito più volte nella letteratura23, alla comunicazione online dovrebbe venire riconosciuta
maggior importanza considerato il suo impatto sulle decisioni di spesa dei consumatori.
Ciò dovrebbe venire spiegato agli operatori turistici soprattutto in quei settori, come
quello del turismo rurale e dell’agriturismo,
in cui l’affinità con gli strumenti dell’information technology è particolarmente carente sia
per motivi infrastrutturali (dividendo digitale
infrastrutturale) sia, soprattutto, per motivi
socio-culturali (dividendo digitale culturale).
Maggiori investimenti per aumentare la ricerca sperimentale in questo campo e un più
effettivo approccio interdisciplinare potrebbero agire da motore propulsivo per ampliare
le conoscenze in questo recente e complesso
campo di studio.
22 Portali italiani di agriturismi sono ad esempio www.
agriturismo.it e www.agriturismoitaliano.it.
23 �������������������������������
T. Hennig-Thurau (a cura di), ‘Word-of-Mouse’: why
consumers listen to each other on the Internet Berlin, n. 3,
2005.
30
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Katia L. Sidali è specializzata in teoria del
consumatore e marketing agro-alimentare e turistico. Attualmente è titolare di una borsa di
post-dottorato presso l’Università di Goettingen,
Dipartimento di Economia Agraria e Sviluppo
Rurale.
Achim Spiller è professore di Marketing agroalimentare presso l’Università di Goettingen,
Dipartimento di Economia Agraria e Sviluppo
Rurale.
Tradizione e tecnologia online a confronto
31
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Produzioni alimentari legate al territorio:
le forme e l’intensità della protezione giuridica nel
mercato europeo
Stefano Amadeo
Abstract
Parole chiave
Nel diritto dell'Unione europea la regolazione delle
indicazioni geografiche risale a tempi recenti. Tuttavia
essa è caratterizzata da un notevole grado di sviluppo
e complessità. Ispirato alla normativa convenzionale,
motore di ulteriori evoluzioni sulla scena internazionale,
il diritto comunitario esprime un sistema uniforme su
base regionale, e un elevato grado di tutela dei segni
distintivi legati al territorio. Il presente contributo
ricostruisce le articolazioni essenziali della disciplina,
valorizzando il contributo della giurisprudenza
nell'individuazione di un “punto di equilibrio”, per certi
versi peculiare o atipico, fra le opposte esigenze della
tutela dei segni e della libera circolazione dei prodotti
nel mercato europeo
prodotti agricoli
prodotti alimentari
indicazioni geografiche
diritti di privativa
registrazione comunitaria
protezione
mercato unico europeo
misure di effetto equivalente
Sommario: 1. La specificità della protezione giuridica delle indicazioni geografiche nel mercato
europeo: “bella addormentata nel bosco” o “gatto con gli stivali”? 2. La coesistenza e le relazioni
tra i vari regimi: normative nazionali e strumenti
internazionali; 3. Le indicazioni geografiche nel
diritto comunitario; 4. I presupposti della tutela
5. Contenuto e limiti della tutela; 6. La protezione
delle indicazioni geografiche in deroga alla libera
circolazione delle merci; 7. Il carattere esauriente
della disciplina comune e la possibile protezione
“complementare” prevista dal diritto nazionale.
nel bosco” della privativa internazionale1. Il
riferimento corre al crescente e progressivo
“risveglio” degli interessi commerciali che
circondano, a livello mondiale e soprattutto
europeo2, i segni distintivi geografici (i segni
che permettono di collegare un prodotto alla
località, al territorio o allo Stato di origine)3.
Dinanzi agli insospettabili “passi” che la disci-
1. La specificità della protezione giuridica delle indicazioni geografiche nel
mercato europeo: “bella addormentata
nel bosco” o “gatto con gli stivali”?
L
e denominazioni d’origine (dette anche indicazioni geografiche, o secondo l’acronimo inglese, GIs) dei prodotti agricoli e alimentari sono state definite la “bella addormentata
Produzioni alimentari legate al territorio
1 Cfr. M. Höpperger, in www.wipo.int/export/sites/
www/wipo_magazine/en/images/banner.git
2 Cfr. B.A. Babcock, R. Clemens, Geographical Indications
and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural
Products, Matric Briefing Paper 04-MBP 7, in www.matric.iastate.edu, spec. p. 16 s.
3 Cfr. M. D’Addezio, La promozione e la regolazione del mercato alimentare nell’Unione europea. Esperienze giuridiche
comunitarie e nazionali, in M. D’Addezio e A. Germanò (a
cura di), La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell’Unione europea, Milano, 2007, p. 3; L. Francario,
La valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano attraverso i segni del territorio, ibidem, p. 55. �������������������
Cfr. anche, in senso critico, K. Rustiala, S.R. Munzer, Global Struggle over
Geographical Indications, in UCLA School of Law, Research
Paper No. 06-32, in http://ssen.com/abstract=925751.
32
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
plina dei segni geografici ha compiuto e si appresta a compiere, a livello regionale europeo,
e dell’impulso ulteriore che ne potrebbe derivare per la disciplina internazionale, a buon
diritto le denominazioni d’origine andrebbero
definite, piuttosto, come il “gatto con gli stivali” della privativa internazionale.
Sebbene l’origine della normativa di settore,
in ambito comunitario, sia alquanto recente, il
sistema di tutela posto in essere risulta articolato. Si tratta di un sistema sui generis, che solo
in parte presenta analogie con gli strumenti di
tutela della privativa commerciale4.
La protezione delle denominazioni d’origine nel diritto dell’Unione europea si colora, in
effetti, di una particolare intensità. Ciò in ragione del preminente interesse che la Comunità nutre per la qualità dei prodotti agricoli5
e per il sostegno del reddito delle popolazioni
rurali; ma altresì per il contributo dato dalle
indicazioni di qualità alla conservazione e alla
promozione del patrimonio culturale del territorio6.
In ogni caso l’intensità delle garanzie che
circondano le indicazioni geografiche è tributaria, in gran misura, dello sforzo interpretativo della Corte di giustizia, che a partire dai
primi anni ‘90 ha non solo formulato le coordinate di sviluppo della legislazione derivata7,
ma ha inoltre impresso alle forme della protezione e agli strumenti di tutela previsti a livello normativo un’ampiezza insospettata8. Ciò è
particolarmente evidente se l’estensione della
tutela conferita alle denominazioni di origine
viene esaminata come un’ipotesi di deroga al
fondamentale principio della libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato interno9. Ma risalta altresì se la protezione delle de4 Infra, n. 2.
5 Cfr. il Libro Verde della Commissione europea del
15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM/2008/0641 def); v. anche C. Cattabriga, E.
Monaguti, P. Ruggeri Laderchi, Art. 37 TCE, in A. Tizzano
(a cura di), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 338 ss., 346.
6 Infra, n. 1.3.
7 Infra, n. 4.
8 Infra, n. 5.
9 Infra, n. 3 e 6.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
nominazione d’origine è posta a raffronto con
le garanzie di cui godono altri segni distintivi
privi di radicamento territoriale: per esempio,
nell’ambito della disciplina dei vini, con le indicazioni di qualità10.
La tutela uniforme delle indicazioni geografiche garantita in tutto il territorio dell’Unione,
a partire da un complesso procedimento di registrazione delle medesime a livello comunitario, non sembra peraltro escludere una protezione complementare prevista, all’occorrenza,
dagli ordinamenti nazionali mediante figure
che tutelino il legame tra prodotto e territorio
d’origine in forma più attenuata11.
1.1. In senso ampio, le indicazioni geografiche hanno tradizionalmente una duplice
funzione. Consentono al consumatore di selezionare prodotti genuini che traggono la
loro reputazione e la loro unicità dal territorio
d’origine, e dall’uso e dall’affinamento delle
tecniche adoperate, nel tempo, dagli operatori
ivi stabiliti. Premiano insomma, attraverso il
riferimento a un contesto territoriale, la qualità dei prodotti, qualità che è all’origine del
carattere rinomato della denominazione e che
è sempre più apprezzata dai consumatori12.
Alla base dell’istituto vi è insomma il legame
specifico tra la terra e l’unicità qualitativa del
prodotto che è espresso dalla nozione francese
di terroir13.
10 Sulla controversia relativa all’uso di indicazioni
omonime, di cui l’una espressiva di un riferimento
geografico (la denominazione di origine ungherese
“Tokai”) l’altra di un’indicazione di qualità (“Tocai”) relativa a un vitigno e a una produzione localizzata nel nord
est d’Italia, v. Corte giust., 12 maggio 2005, C-347/03,
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA, in Racc., p.
I-3785 e soprattutto ordinanza 12 giugno 2008, C-23/07
e C-24/07, Confcooperative Friuli Venezia Giulia e altri, in
Racc., p. I-4277. Sul tema F. Spitaleri, Denominazioni
d’origine e indicazioni omonime: la Corte di giustizia definisce la controversia sul caso Tocai, in Diritto unione europea,
2008, p. 835, ove anche indicazioni di dottrina.
11 Infra, n. 7.
12 Cfr. Corte di giustizia, 16 maggio 2000, C-388/95,
Belgio c. Spagna, in Racc., p. I-3123, cpv. 56; 20 maggio
2003, C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma, in Racc.,
p. I-5121, cpv. 48.
13 Secondo Le Petit Larousse, Paris 1992, la parola terroir
esprime la “terre considérée sous l’angle de la produc-
33
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Sul versante dell’offerta, le indicazioni geografiche garantiscono ai produttori situati
nelle zone rurali una ricompensa per la qualità
conseguita (c.d. premium prize), tanto maggiore
quanto più i prodotti che se ne fregiano sono
riconosciuti e apprezzati dal consumatore; stimolano la diversificazione della produzione e
proteggono contro appropriazioni indebite da
parte dei terzi14. In effetti “nella percezione del
consumatore, il nesso tra la reputazione dei
prodotti e la qualità dei prodotti dipende … dalla sua convinzione che i prodotti venduti con
la denominazione di origine sono autentici”15.
1.2. Sotto quest’ultimo profilo, e benché sul
piano internazionale le opinioni non siano
concordi, le indicazioni geografiche hanno
una base concettuale comune con i diritti di
privativa16. Esse rientrano “nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale. La
normativa [che le prevede] tutela i beneficiari
contro l’uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare
della reputazione da esse acquisita”17. Esse contribuiscono a garantire condizioni leali di contion ou d’une production agricole caractéristique”; cfr.
ad esempio, sulla “sfida” dei crus du terroir, per ciò che
riguarda il Barolo delle Langhe e il Pinot di Borgogna, La
Stampa del 22 novembre 2009, p. 33.
����������������������������������
F. Addor, N. Thumm, A. Grazioli, Geographical
Indications: Important Issues for Industrialized and
Developing Countries, in The IPTS Report, 5/2003, p. 23, 25;
cfr. anche le motivazioni iniziali del reg. CE n. 510/2006
del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari, in Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (GUUE), L 93 del 31 marzo 2006, p. 12
15 Corte giust., 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto
di Parma, cit., cpv. 64.
16 Si tratta di diritti di proprietà (privativa commerciale) alquanto atipici, nella misura in cui non appartengono a un solo titolare: ne possono beneficiare tutti
i produttori che operano in un determinato contesto
geografico, a condizione che rispettino, nell’elaborazione del manufatto, determinate prescrizioni (usi leali e
costanti, indicati nel “disciplinare”). Inoltre tali prescrizioni, in genere a tutela della qualità, sono elaborate da
associazioni private (consorzi o associazioni) e approvate o rese vincolanti da atti della pubblica autorità.
17 Corte giust., 16 maggio 2000, Belgio c. Spagna, cit., cpv.
54; 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma, cit.,
cpv. 48.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
correnza tra produttori di beni simili nonché a
“facilitare il conseguimento, da parte [di questi ultimi], di migliori redditi in contropartita
di uno sforzo qualitativo reale”18. In tale misura le indicazioni geografiche condividono le
finalità generali che caratterizzano il diritto
industriale e dei marchi in particolare19.
1.3. Strumento di garanzia della qualità dei
prodotti legati al territorio, le denominazioni d’origine non esauriscono tuttavia la loro
funzione nella tutela di interessi economici di
carattere privatistico. I titoli di proprietà intellettuale, industriale e commerciale favoriscono lo sforzo creativo, l’innovazione e il progresso tecnologico. Le indicazioni geografiche
costituiscono, altresì, espressione di “identità,
valori e significati culturali”20.
In tale prospettiva i segni distintivi alimentari appaiono portatori di dati storici e geografici obiettivi. Svolgono un ruolo strumentale
alla tutela del patrimonio culturale dei popoli e
delle loro conoscenze tradizionali, in quanto
manifestazione delle vocazioni e delle tradizioni produttive – dunque dell’identità – di un
territorio21. Il legame tra prodotto e territorio
appare, tuttavia, tanto più attenuato quanto
18 Corte giust., 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto
di Parma, cit., cpv. 63, in fine.
19 Corte giust., 17 ottobre 1990, C-10/89, Hag, in Racc.,
p. I-3711, spec. cpv. 13, che ricorda quasi letteralmente
il ragionamento della Corte richiamato nella nota che
precede.
����������������������������
Cfr. tuttavia D. Gervais, Traditional Knowledge &
Intellectual Property: A TRIPS-Compatible Approach, in
Michigan State Law Review, 2005, p. 137 ss.
21 V. in generale B. de Witte, Trade in Culture: International
Legal Regimes and EU Constitutional Values, in Gráinne
de Búrca, J. Scott (eds.), The EU and the WTO – Legal and
Constitutional Issues, Oxford, Portland Oregon, 2001,
p. 237 ss.; G. Coscia, I rapporti fra sistemi internazionali e
comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità, in
B. Ubertazzi, E. Muňiz Espada (a cura di), Le indicazioni
di qualità degli alimenti - Diritto internazionale ed europeo,
Giuffrè, 2009, p. 43 ss., in fine. Per un’approfondita e
critica analisi di tale approccio, cfr. T. Broude, Taking
“Trade and Culture” Seriously: Geographical Indications and
Cultural Protection in WTO Law, in http://papers.ssrn.
com., p. 1-43, che valuta la tutela della cultura attraverso
le indicazioni d’origine come un’ipotesi più prossima
al “protezionismo culturale” che alla “protezione della
cultura”, ibidem, p. 42.
34
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
più indeterminate o “delocalizzate” sono le caratteristiche che il prodotto deve presentare per
il conferimento dell’indicazione d’origine22.
L’estesa e articolata protezione riconosciuta alle indicazioni d’origine nell’ordinamento
comunitario23 sembra potersi rappresentare
come uno strumento di protezione della diversità culturale nazionale e regionale (o territoriale) attraverso la privativa commerciale, in
armonia con quanto stabilito dall’art. 151 TCE.
Il principio di protezione “trasversale” della
cultura che tale norma incorpora24 risulta internazionalmente rafforzato per effetto della
Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
firmata a Parigi il 20 ottobre 2005 ed entrata
in vigore, con la partecipazione della Comunità e dei suoi Stati membri, il 18 marzo 2007.
L’art. 20 di tale strumento vincola in effetti i
contraenti a “tener conto” della Convenzione
nell’interpretazione e nell’applicazione degli
altri trattati internazionali di cui sono parti25.
2. La coesistenza e le relazioni tra i vari
regimi: normative nazionali e strumenti internazionali.
Le indicazioni geografiche fruiscono di forme di protezione differenziate negli ordinamenti nazionali, in funzione delle discipline
sostanziali e processuali che le prevedono. Così
le indicazioni geografiche possono trovare variabile garanzia nelle norme sulla concorrenza
sleale, nelle norme a tutela del consumatore, o
in specifiche previsioni di diritto industriale,
22 Cfr. D. Sarti, Segni e garanzie di qualità, in B. Ubertazzi,
E. Muňiz Espada (a cura di), Le indicazioni di qualità, p. 112
ss., e infra, n. 4.1. e 4.2.
23 Cfr. infra, n. 3.
24 Cfr. l’art. 151, par. 4, TCE: “La Comunità tiene conto
degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di
altre disposizioni del presente trattato, in particolare
ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue
culture”; e l’analogo disposto dell’art. 167 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione, dopo le novelle di Lisbona.
25 La Convenzione è stata adottata sotto gli auspici
dell’UNESCO: vedila tra gli strumenti giuridici pubblicati nel sito ufficiale dell’Organizzazione, www.unesco.
org. Sulla bozza di Convenzione, cfr. T. Broude, Taking
“Trade and Culture” Seriously, cit.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
come avviene nell’ordinamento italiano26, o
nel diritto dei marchi, come avviene negli Stati
Uniti27. Possono altresì trovare tutela (indiretta) nelle norme che proibiscono la pubblicità
ingannevole28.
2.1. L’efficacia degli strumenti predisposti
dagli ordinamenti nazionali è tuttavia relativa. Tali strumenti hanno un ambito d’applicazione limitato dalle frontiere nazionali, secondo il principio di territorialità. I fenomeni di
imitazione o appropriazione parassitaria delle
indicazioni geografiche da parte dei terzi, al
contrario, si verificano prevalentemente al di
là delle frontiere del paese di origine del prodotto (interessato alla sua tutela)29. E’ alla luce
delle considerazioni che precedono – l’esigenza di garantire un minimo standard di protezione delle indicazioni geografiche attraverso
le frontiere nazionali – che sono da intendersi le numerose convenzioni internazionali
multilaterali (o bilaterali) adottate in materia,
nonché le pertinenti disposizioni dell’Accordo
sugli aspetti della proprietà intellettuale collegati al commercio30.
26 Cfr. in Italia gli art. 29 e 30 del codice della proprietà
industriale (decreto lgs. n. 30 del 2005).
27 ������������������
Cfr. T. Josling, What’s in a Name? The economics, law
and politics of Geographical Indications for foods and beverages, IIIS Discussion Paper, 2006, p. 11 s., in http://eulaw.typepad.com.
28 Cfr. per esempio gli art. 3 e 4 del decreto lgs. n. 145
del 2007 (attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/
CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole), in GURI n. 207 del 6 settembre 2007.
29 ��������
Cfr. l’Handbook commissionato dalla Commisssione
europea allo studio O’Connor & Company – European
Lawyers, Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later...
A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO
Members, p. 1, reperibile in trade.ec.europa.eu/doclib/
html/135088.htm.
30 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (c.d. TRIPs), allegato al Trattato istitutivo
dell’Organizzazione mondiale del commercio (1994),
art. 22-24: lo si veda al sito ufficiale dell’Organizzazione
(www.wto.org), comprensivo di una versione integrata
con le pronunce dell’Organo di soluzione delle controversie. La disciplina dei diritti di privativa nell’ambito
delle norme sul commercio internazionale sono giustificate, come ricorda il preambolo dell’Accordo, dall’esigenza di promuovere una protezione “effettiva e adeguata” di tali diritti, evitando al contempo che l’eserci-
35
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
2.2. Gli strumenti multilaterali non importano in genere armonizzazione né uniformazione delle discipline nazionali in materia di
indicazioni geografiche. Più modestamente,
essi affermano obblighi, applicabili a tutti gli
Stati membri, in materia di trattamento nazionale dei cittadini degli altri Stati contraenti, titolari di diritti di privativa, anche sotto il
profilo dell’accesso ai procedimenti giurisdizionali31. Prevedono disposizioni “autonome”
sulla definizione delle indicazioni geografiche
e dispongono, soprattutto, che gli Stati medesimi debbano vietare – e predisporre rimedi avverso – comportamenti privati idonei a
pregiudicare l’affidabilità delle indicazioni
geografiche. Fra questi l’impiego di “false indicazioni di origine”32, di “indicazioni false
o ingannevoli”33, ovvero “l’uso di ogni mezzo
nella designazione o presentazione di un bene
che indichi o suggerisca un’origine geografica
diversa da quella effettiva in una maniera idonea a ingannare il pubblico sulla provenienza
del bene”34; nonché le prassi industriali o commerciali “sleali” o disoneste, fra le quali l’uso
di indicazioni idonee a confondere il pubblico
circa la natura il processo produttivo o le caratteristiche dei beni35.
Talora una protezione aggiuntiva è prevista rispetto ai titoli di privativa “antagonisti”,
quali i marchi, che consistano di, o rechino,
indicazioni idonee a ingannare il pubblico
zio dei medesimi costituisca un ostacolo al “legittimo
commercio”. Cfr. A. Lupone, Il dibattito sulle indicazioni
geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha
Round dell’Organizzazione Mondiale del Commercio alla
protezione Trip plus, in B. Ubertazzi, E. Muňiz Espada (a
cura di), Le indicazioni di qualità, cit., p. 36, 39.
31 Cfr. per esempio l’art. 2 della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, fatta a Parigi il 20
marzo 1883 e più volte emendata, nonché l’art 1, par. 3,
del TRIPs.
32 V. art. 10 della Convenzione per la protezione della
proprietà intellettuale, cit.
33 V. l’art. 1 e l’art. 3 bis dell’Accordo relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci dei
prodotti, fatto a Madrid il 14 aprile 1891.
34 Art. 22, par. 2, lett. a, e par. 4 del TRIPs.
35 Art. 10bis della Convenzione per la protezione della
proprietà intellettuale, richiamato dall’art. 22, par. 2, lett.
b del TRIPs.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
circa la “vera” origine del prodotto36.
Gli Stati parte conservano autonomia circa la scelta dei mezzi per adeguare il proprio
ordinamento a tali divieti37; e possono predisporre una tutela maggiore rispetto a quanto
previsto dagli strumenti qui sommariamente
richiamati, nel rispetto di eventuali clausole di
compatibilità38.
2.3. Un’autonoma menzione merita l’Accordo relativo alla protezione delle denominazioni d’origine e alla loro registrazione internazionale, fatto a Lisbona il 31 ottobre 1958 e più
volte modificato.
Esso si distingue dai precedenti in quanto
prevede, come recita il titolo, un procedimento di registrazione internazionale delle denominazioni d’origine dei vari Stati membri, che
può essere attivato a richiesta dagli stessi e “a
nome delle persone fisiche o giuridiche ... titolari del diritto di utilizzo delle denominazioni
secondo la loro legislazione nazionale”39. Le
denominazioni registrate godono, negli Stati
membri, della protezione prevista in modo autonomo dall’Accordo40, che configura uno standard ampio e cumulativo rispetto alle garanzie
già previste da altri strumenti internazionali.
Ciascuno Stato membro si impegna ad assi36 Art. 22, par. 3 del TRIPs. Sulla struttura della disciplina prevista dal TRIPs per le indicazioni geografiche, con
particolare riguardo alla tutela accresciuta predisposta
a favore delle indicazioni d’origine dei vini e dei prodotti alcolici (art. 23) e sulla clausola “evolutiva” di cui
all’art. 24, v. G. Contaldi, Il conflitto tra Stati Uniti e Unione
europea sulla protezione delle indicazioni geografiche, in B.
Ubertazzi, E. Muňiz Espada (a cura di), Le indicazioni di
qualità, cit., p. 27, dove ulteriori (spec. p. 53) riferimenti
di dottrina e cenni alla prassi recente.
37 Art. 1 del TRIPs. Si vedano anche le numerose disposizioni della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, che rinviano agli ordinamenti nazionali per le modalità concrete della protezione, talora
graduando gli obblighi pattizi secondo alternative che
tengano conto dello specifico modo di essere dei primi
(ad esempio l’art. 9, spec. paragrafo 6). Sulle modalità attraverso le quali l’ordinamento della Comunità europea
si conforma agli obblighi derivanti dal TRIPs nel settore delle indicazioni geografiche, cfr. G. Coscia, op. cit., p.
44-49.
38 Cfr. l’art. 1, par. 1, dell’Accordo.
39 Cfr. l’art. 5 dell’Accordo di Lisbona.
40 Art. 1 dell’Accordo di Lisbona.
36
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
curare, alle denominazioni d’origine protette dagli altri Stati membri e registrate, tutela
“contro ogni usurpazione o imitazione, anche
se la vera origine del prodotto è indicata o se
la denominazione è impiegata in traduzione
o s’accompagna a espressioni come “genere”,
“tipo”, “maniera”, “imitazione”, et similia”41
2.4. A parte l’Accordo sugli aspetti della
proprietà intellettuale legati al commercio, di
cui la Comunità è parte a fianco dei suoi Stati
membri42, tutti gli altri accordi annoverano la
partecipazione (limitata) dei soli Stati membri43. Per ciò che concerne il TRIPs, che annovera, rispetto agli accordi citati, un’ampia partecipazione44, esso condiziona il modo di essere
del diritto dell’Unione europea solo attraverso l’attività normativa delle istituzioni; la sua
autonoma rilevanza in sede giurisdizionale è
invece, come noto, del tutto recessiva45. E’ dunque per il tramite del diritto derivato che gli
obblighi internazionali della Comunità, e degli Stati membri assieme, trovano espressione
nel mercato unico europeo. L’elevato grado di
protezione che tale diritto predispone contribuisce, peraltro, ad evitare la frammentazione
“soggettiva” del regime comune che conseguirebbe all’applicazione della “deroga” prevista
dall’art. 307 TCE a favore degli obblighi internazionali previgenti degli Stati membri.
2.5. Un progresso ulteriore nella disciplina
internazionale delle indicazioni geografiche
è stato realizzato sovente su base bilaterale,
41 Art. 3 e 4 dell’Accordo di Lisbona.
42 La Comunità è membro del WTO e dei suoi accordi
plurilaterali a partire dal 1° gennaio 1995. La partecipazione della Comunità o dei suoi Stati membri si articola
in base a criterio della competenza nelle materie oggetto dell’accordo.
43 Così 26 Stati membri partecipano alla Convenzione
di Parigi (che annovera 173 Parti contraenti); 14 all’Accordo di Madrid (35 Parti contraenti); 10 all’Accordo di
Lisbona (26 Parti contraenti).
44 L’Organizzazione mondiale del Commercio annovera 153 Parti contraenti.
45 Cfr. Corte giust., 9 settembre 2008, C-120/06 e
C-121/06, FIAMM c. Consiglio e Commissione, in Racc., p.
I-6513; sul problema D. Boni, Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale, Milano, 2008, spec. p. 262
ss., 330 ss., 372 ss.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
grazie a una rete di accordi attraverso i quali
gli Stati europei maggiormente coinvolti – in
particolare del centro e sud Europa – hanno
tentato, sin dai primi decenni del secolo scorso, di “esportare”, su base di reciprocità, le indicazioni geografiche, e il livello di protezione
previsto nel proprio ordinamento, nello Stato
di importazione (o di smercio) del medesimo. Tale risultato è conseguito attraverso l’applicazione del principio del paese di origine
dell’indicazione geografica, in sostituzione del
principio del paese di importazione cui generalmente si ispirano le convenzioni multilaterali citate. Il riferimento alla disciplina del
paese di origine consente di conciliare tollerabili difformità nelle normative nazionali con
lo standard di tutela – verosimilmente elevato
– previsto dallo Stato che ha il maggiore interesse nella tutela dell’indicazione geografica;
e permette di evitare le flessioni nella protezione derivanti, sotto il profilo fattuale, dalla
diversa valutazione che i consumatori esteri
possono avere dell’identità e della reputazione
del prodotto46.
La giurisprudenza comunitaria offre vari
esempi di tali convenzioni, che a fronte del livello elevato di protezione, e dei conseguenti
ostacoli alla circolazione delle merci che comportano, nei rapporti fra Stati membri possono essere applicate solo in quanto compatibili
con i principi del mercato interno e con la normativa derivata.
Le convenzioni bilaterali degli Stati membri
possono “interferire” con le regole del mercato interno in vario modo: in passato, potevano
precostituire il titolo in base al quale un’indicazione geografica, originaria di uno Stato membro, viene tutelata in un altro Stato membro47;
attualmente possono determinare il contesto
giuridico e fattuale nell’ambito del quale si inserisce il diritto comunitario, e l’applicabilità
46 Corte giust., 10 novembre 1992, C-3/91, Exportur,
in Racc., p. I-5529, cpv. 12. Per un esempio di protezione delle indicazioni secondo il principio del paese
di origine, v. la Convenzione italo-francese firmata a Roma il 28 aprile 1964 ed evocata nella sentenza Corte giust., 20 maggio 2003, C-469/00, Ravil, in
Racc., p. I-5053, cpv. 3 ss.
47 Corte giust., 10 novembre 1992, Exportur, cit.;
37
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
degli istituti da questo previsti è valutata48. In
tempi recenti la rilevanza di tali convenzioni è
stata esaminata con riguardo al problema del
se la regolamentazione comunitaria che disciplina le indicazioni geografiche abbia, o meno,
carattere esaustivo49.
3. Le indicazioni geografiche nel diritto comunitario.
La tutela delle indicazioni geografiche dei
prodotti alimentari coinvolge vari settori del
diritto dell’Unione europea.
In primo luogo tale protezione è l’oggetto di
un ampio corpus normativo adottato nell’ambito della politica agricola comune, in origine
con riferimento alle denominazioni dei vini,
e a partire dagli anni novanta con riferimento
altresì alle produzioni alimentari. Tale regolamentazione s’ispira agli accordi multilaterali di cui gli Stati membri o la Comunità sono
parte, e per vari profili è migliorativa di tali
discipline.
In secondo luogo le indicazioni geografiche
sono oggetto di norme nazionali, autonome
o adottate in esecuzione di obblighi pattizi o
comunitari; esse sono applicabili, come è noto,
nella misura in cui non contrastino con le regole del Trattato sulla libera circolazione delle
merci. In tal caso il diritto comunitario s’occupa della protezione ma indirettamente, in
senso permissivo. La giurisprudenza esamina
dunque se la portata del “privilegio territoriale” di cui godono le indicazioni geografiche sia
coperta dalla deroga concernente la tutela della
proprietà industriale o commerciale e, in caso
positivo, se le modalità della protezione esprimano un adeguato “bilanciamento” con il principio della libera circolazione delle merci50.
Infine la tutela delle indicazioni geografiche trova spazio e regolamentazione nell’ambito dei rapporti commerciali internazionali
dell’Unione. Per un verso attraverso l’attività
delle Commissione nell’ambito dell’Organiz48 Per esempio Corte giust., 4 marzo 1999, C-87/97,
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, in Racc., p.
I-1301, spec. cpv. 35.
49 Infra, n. 7.
50 V. infra, n. 6.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
zazione mondiale del Commercio, intesa – in
essenza – a tradurre nella disciplina del TRIPs
il sistema di registrazione internazionale, e relative garanzie, vigente nell’ordinamento comunitario. Per altro verso, a livello di rapporti
bilaterali, l’azione dell’Unione si esprime nella
stipula di accordi sul mutuo riconoscimento
delle indicazioni d’origine (ma non degli standard di protezione) delle Parti contraenti51, in
applicazione dunque del principio dello Stato
di origine; ovvero nella stipulazione di accordi commerciali complessi che dettano, in aggiunta, norme specifiche per il coordinamento
della protezione garantita da ciascuna Parte52.
Numerosi accordi comportano una disciplina delle indicazioni geografiche più efficace
di quella predisposta, a livello multilaterale,
nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del
Commercio.
4. I presupposti della tutela.
La protezione giuridica prevista dal diritto dell’Unione si fonda attualmente su due
regolamenti della Comunità relativi, rispettivamente, alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei
51 Si vedano l’Accordo tra la Comunità europa e l’Australia sul commercio dei vini, firmato a Bruxelles e a
Camberra il 25 e il 31 gennaio 1994, art. 6 (le modalità
della protezione delle indicazioni geografiche ricadono
nella competenza dello Stato o della Parte di importazione del prodotto, v. art. 3, 6 e 13); l’Accordo tra il Canada
e la Comunità europea sul commercio dei vini firmato
a Niagara-On-The-Lake il 16 settembre 2003; e l’Accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa
sul commercio dei vini, firmato a Paarl SA il 28 gennaio
2002 (ispirato alla medesima disciplina dell’Accordo tra
la Comunità europea e l’Australia).
52 Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti
sul commercio del vino, firmato a Londra il 10 marzo
2006: oltre al mutuo riconoscimento delle pratiche
enologiche rispettive, l’accordo prevede che gli Stati
Uniti riservino talune denominazioni “semi-generiche” (quali Champagne, Chianti, Sauterne, Madeira,
Marsala, Retsina, Sherry, Tokai, ecc.) ai vini originari
della Comunità europea sul mercato statunitense, e
che la Comunità europea consenta l’impiego, da parte
dei vini originari degli Stati Uniti, di talune espressioni precedentemente proibite quali chateau, clos, fine,
vintage, ecc.; inoltre le Parti contraenti si impegnano a
riconoscere nel rispettivo mercato interno talune denominazioni d’origine della controparte.
38
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
prodotti agricoli e alimentari53, nonché alle
specialità tradizionali garantite dei prodotti
agricoli e alimentari54. Una disciplina analoga
nei contenuti e nella struttura è oggi prevista
nel regolamento relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, per quanto
riguarda, appunto, i vini55.
Il regolamento n. 510 del 2006, al quale si
limita il presente esame, comprende una normativa articolata su vari profili, relativi alla
definizione e ai presupposti positivi e negativi
delle denominazioni protette; al procedimento comunitario di registrazione delle medesime e alle autorità competenti per i controlli; ai
contenuti della protezione a queste conferita,
anche in rapporto con altri titoli di privativa.
4.1. Per quanto concerne l’identificazione
delle indicazioni geografiche, il reg. 510 del
2006 si pone ampiamente in linea di continuità con la disciplina precedente56. Questa
53 Reg. (CE) n. 510/2006, cit.
54 Reg. (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei
prodotti agricoli e alimentari, in GUUE L 93 del 31 marzo
2006, p. 1. Le cosiddette STG riguardano un prodotto che
“si distingue nettamente”, in ragione delle sue caratteristiche, da altri prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria, in uso nel mercato comunitario da almeno
25 anni (art. 2). La disciplina del regolamento è sostanzialmente ispirata a quella del reg. 510/2006, salvo per
ciò che concerne i contenuti della protezione delle STG,
che appaiono notevolmente attenuati e vengono affidati alla normativa adottata dagli Stati membri (art. 17).
55 Cfr. reg. (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
GUUE L 148 del 6 giugno 2008, p. 1, art. 34 ss. (per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche) e
54 ss. (per le menzioni tradizionali). Il considerando n.
27 ricorda espressamente che la disciplina della qualità
nel settore dei vini è “in linea con l’impostazione seguita nell’ambito della normativa trasversale della qualità applicata [...] ai prodotti alimentari diversi dal vino
e dalle bevande spiritose” dal reg. (CE) n. 510 del 2006.
Cfr. C. Dordi, La regolamentazione internazionale del vino:
profili rilevanti degli accordi dell’Organizzazione mondiale
del Commercio, in F. Albisinni (a cura di), Le regole del vino.
Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale, Milano,
2008, p. 137; R. Mildon, The Reform of the Common Market
Organisation for Wine, ibidem, p. 255.
56 ��������������������
L. Gonzales Vaqué, Indications géographiques et appellations d’origine: interprétation et mise en œuvre du nouveau
règlement n. 510/2006, in Revue droit de l’Union eur., 2006,
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
era stata adottata all’inizio degli anni ‘9057, in
coincidenza con due sentenze (i casi Delhaize58
e Exportur59) in cui la Corte di giustizia, alla luce
di un esame comparato degli ordinamenti nazionali, aveva introdotto una prima distinzione fra denominazioni e indicazioni di origine.
Mentre le denominazioni di origine intendono garantire che il prodotto “provenga da una
zona geografica determinata e possieda alcune
caratteristiche particolari”, derivanti dal territorio di cui è originario e stabilite con atto della pubblica autorità60, le indicazioni di origine
(o di provenienza) hanno, più modestamente,
la funzione di attestare l’origine geografica del
prodotto, senza stabilire un legame necessario
(bensì solo eventuale) tra le sue caratteristiche
qualitative e l’origine territoriale.
La regolamentazione attuale preserva e precisa la sostanza di tali aspetti definitori. Agli
articoli 2 e 3 il reg. n. 510 delinea i presupposti
costitutivi delle denominazioni e delle indicazioni che devono essere soddisfatti ai fini della
registrazione. Le “denominazioni d’origine”
consistono dunque nel “nome di una regione,
di un luogo determinato o, in casi eccezionali,
di un paese” attribuito a un prodotto che, cumulativamente, è originario di tale territorio,
le cui qualità o caratteristiche “sono dovute
essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori
naturali e umani” e la cui “produzione, trasforp. 795 ss. ������������������������������������������
Il motivo del “rinnovamento” normativo intervenuto nel 2006 deve individuarsi nell’esigenza di
“sanare”taluni profili di contrasto emersi, ed accertati
da un panel il 15 marzo 2005, tra la disciplina comunitaria previgente e le norme, su ricordate, dell’OMC, in
particolare per ciò che concerne pretese “discriminazioni” (sul piano sostanziale e procedimentale) a carico
dei cittadini originari di Stati membri dell’OMC: v. G.
Contaldi, Il conflitto fra Stati Uniti e Unione europea, cit.;
e ampiamente J. Hughes, Champagne, Feta, and Bourbon:
The Spirited Debate About Geographical Indications, in
Hastings Law Journal, 2006, p. 299, 323 ss.
57 Regolamento (CEE) del Consiglio del 14 luglio 1992,
n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari, in GUCE L 208, p. 1.
58 Corte giust., 9 giugno 1992, C-47/90, Delhaize, in
Racc., p. I-3669.
59 Corte giust., 10 novembre 1992, Exportur, cit.
60 Corte giust., 9 giugno 1992, Delhaize, cit., cpv. 17.
39
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
mazione e elaborazione” avvengono nella zona
geografica delimitata.
Le “indicazioni geografiche” si differenziano dalle prime in quanto, salva l’attestazione
dell’origine cui il nome geografico si riferisce,
le qualità, reputazione o altre caratteristiche
del prodotto “possono essere attribuite a tale
origine geografica” mentre, alternativamente
o cumulativamente, la produzione, la trasformazione o l’elaborazione del medesimo avvengono nella zona geografica delimitata.
Gli elementi indicati devono essere comprovati da un disciplinare, ossia un protocollo
contenente gli elementi descrittivi del prodotto, della sua origine e del legame fra le sue caratteristiche qualitative e il territorio61.
A fianco di tali presupposti il regolamento
delinea varie condizioni negative od ostative
alla registrazione, fra le quali il carattere generico acquisito dalla denominazione; i casi del
conflitto e dell’omonimia, anche parziale, con
una precedente denominazione registrata, ovvero con un marchio già utilizzato rispetto al
quale la denominazione possa indurre in errore il consumatore62.
4.3. Per avere valore giuridico in tutto il territorio dell’Unione la denominazione dev’essere registrata. Il procedimento, sebbene unitario, consta di due fasi e autonome, a livello
nazionale e comunitario.
i) La prima fase si esaurisce nell’ordinamento dello Stato membro ove è localizzata la zona
61 Art. 4 del reg. n. 510 del 2006.
62 Art. 3 del reg. n. 510 del 2006. Per ciò che concerne
la volgarizzazione delle denominazioni, l’art. 3, par. 1,
dispone che “le denominazioni divenute generiche non
possono essere registrate”, precisando che tale situazione ricorre quando il nome di un prodotto, pur collegato
al territorio in cui è stato inizialmente prodotto o posto commercializzato, è divenuto “il nome comune” di
un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità. La
norma va posta sistematicamente in rapporto con l’art.
13, par. 2, secondo cui per converso “le denominazioni
protette non possono diventare generiche”. Cfr. in argomento ...(azione internazionale per “bloccare” la volgarizzazione di indicazioni geografiche europee). Per i
rapporti tra marchi e denominazioni geografiche, regolate dal principio del preuso, cfr. oltre all’art. 3, par. 4 (a
tutela del marchio preesistente), l’art. 14, par. 1 (a tutela
della denominazione preesistente).
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
d’origine cui si riferisce la denominazione. Il
procedimento prende avvio con la domanda
dell’associazione o (per le denominazioni relative a zone transfrontaliere) alle associazioni interessate. Lo Stato membro verifica se le
condizioni stabilite dal regolamento sono soddisfatte63. Qualora la valutazione sia positiva,
e non vi siano opposizioni “ricevibili” (che
dimostrano, cioè, la sussistenza di una condizione ostativa), lo Stato membro adotta una
decisione favorevole. Possono introdurre una
domanda, o presentare opposizione solo i soggetti che risiedano o siano stabiliti nello Stato
membro64 (con modulazione di tale regola nel
caso di denominazioni relative a zone d’origine situate a cavallo di due o più Stati membri o
Stati terzi65).
La decisione nazionale favorevole, una volta trasmessa alla Commissione, abilita lo Stato
interessato ad accordare alla denominazione
una “protezione transitoria”, entro i confini
nazionali e sotto la responsabilità esclusiva
del medesimo qualora l’esito del procedimento comunitario sia negativo.
ii) Con la trasmissione della decisione favorevole alla Commissione a cura dello Stato
membro prende avvio la seconda fase. Nel caso
in cui la domanda di registrazione riguardi
una zona di origine situata in un paese terzo,
gli interessati possono trasmetterla alla Commissione direttamente ovvero (come nella disciplina previgente) attraverso le autorità del
paese terzo riguardato.
Il procedimento di valutazione della Commissione presenta una “dimensione comunitaria” e talune specificità rispetto a quello che si
svolge a livello nazionale. Possono infatti presentare opposizione gli (altri) Stati membri o i
63 Cfr. art. 7, par. 3, del reg. n. 510 del 2006, che alle
condizioni già previste dagli art. 2 e 3 del reg., aggiunge
l’ipotesi del pregiudizio all’esistenza di prodotti che si
trovano già legalmente sul mercato in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine della denominazione
(lett. c).
64 Art. 5 del reg. n. 510 del 2006.
65 V. art. 16, lett.. d, del reg. n. 510 del 2006 e art. 12 del
reg. (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.
510/2006, in GUUE L 369 del 23 dicembre 2006, p. 1.
40
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
paesi terzi ovvero ogni persona interessata che
sia stabilita o risieda in uno Stato membro o in
un paese terzo66. Se l’opposizione è ricevibile,
la Commissione invita le parti che si contrappongono ad avviare consultazioni allo scopo
di pervenire a un accordo; e in caso negativo
adotta una decisione secondo una procedura
aggravata67. Qualora l’esame della domanda
dia risultato favorevole e non vi siano opposizioni ricevibili, la Commissione registra la denominazione; questa è conservata a cura della
Commissione in un registro “aggiornato delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”68.
iii) La giurisprudenza ha precisato il contenuto di ciascuna fase del procedimento in
una spirito di sussidiarietà. E’ stato così riconosciuto che gli accertamenti di fatto e le
qualificazioni giuridiche necessarie ai fini
della registrazione devono essere svolte dallo
Stato membro territoriale, cui spetta altresì
promuovere la fase “comunitaria” del procedimento: “tale sistema di ripartizione delle
competenze si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la
verifica che un certo numero di requisiti sono
soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari
dello Stato membro interessato, elementi che
possono essere meglio verificati dalle autorità
competenti di tale Stato”69. Per converso alla
66 Art. 7, par. 1 e 2 del reg. n. 510 del 2006. Cfr. per esempi di opposizioni sollevate dagli Stati membri nel procedimento di registrazione della denominazione di origine greca “Feta”, in considerazione del preteso carattere
generico acquisito dal termine in taluni Stati membri,
v. Corte giust., 16 marzo 1999, C-289/96, C-293/96 e
C-299/96, Danimarca e altri c. Commissione, in Racc., p.
I-1541; 25 ottobre 2005, C-465/02 e C-466/02, Germania
e Danimarca c. Commissione, in Racc., p. I-9115; o con riferimento al procedimento di registrazione dell’indicazione geografica “Bayerisches Bier” (birra bavarese), in
considerazione dell’esistenza di marchi contenenti il
termine “Bayerisches”, che avrebbe peraltro asssunto un
carattere generico, Corte giust., 2 luglio 2009, C-343/07,
Bavaria, non ancora pubblicata in Racc.
67 Art. 15, par. 2, del reg. n. 510 del 2006, che prevede
l’intervento di un procedimento intergovernativo.
68 Art. 7, par. 6, del reg. n. 510 del 2006.
69 Corte giust., 6 dicembre 2001, C-269/99, Kühne, in
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
Commissione compete “soltanto un semplice
esame formale per verificare se i requisiti posti dal regolamento sono soddisfatti”70.
La natura comunitaria del procedimento,
nel quale è integrata la fase nazionale71, implica peraltro che – in ossequio al principio
della tutela giurisdizionale effettiva – gli interessati debbano poter disporre, dinanzi ai
giudici nazionali, di adeguati mezzi di ricorso
avverso gli atti dell’autorità nazionale che possano “incidere sui diritti che derivano ai terzi
dal diritto comunitario”. A fronte del margine di valutazione “limitato o inesistente” di
cui dispongono le istituzioni comunitarie, e
dell’ampia competenza di cui dispongono, per
contro, le autorità dello Stato membro negli
accertamenti relativi alla domanda di registrazione, l’onere del controllo giurisdizionale
è dislocato essenzialmente nelle mani delle
giurisdizioni nazionali. Pertanto è “compito
dei giudici nazionali statuire sulla legittimità
di una domanda di registrazione di una denominazione [...], conformemente alle modalità
di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo [...] e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo
scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere”72.
iv) La primazia dello Stato di origine del
nome geografico riverbera peraltro, al di là dei
Racc., p. I-9517, cpv. 53, con riferimento ad una domanda
pregiudiziale relativa alla validità del regolamento mediante il quale la Commissione aveva registrato come
indicazione geografica protetta (“Spreewälder Gurken”)
le conserve di cetriolini coltivati nel terreno alluvionale
della valle dello Sprea, regione situata a sud di Berlino.
Tale questione era stata sollevata dal giudice di Amburgo,
su richiesta della società Jütro, sita all’esterno dell’area
geografica dell’IGP e convenuta in un procedimento
inibitorio promosso dalla Kühne avverso l’impiego, da
parte della prima, dell’indicazione «Spreewälder Art»
(cetrioli alla maniera dello Spreewald).
70 Corte giust., 6 dicembre 2001, Kühne, cit., cpv. 52.
71 Corte giust., 8 settembre 2009, C-478/07, Budĕjovický
Budvar, non ancora pubblicata in Racc., cpv. 117: “Le procedure nazionali di registrazione sono [...] integrate nella procedura nazionale comunitaria”.
72 Corte giust., 6 dicembre 2001, Kühne, cit., cpv. 57 e
58; 2 luglio 2009, C-343/07, Bavaria, non ancora pubblicata in Racc., cpv. 56 e 57.
41
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
profili procedurali legati alla registrazione, sul
piano del riparto delle competenze “orizzontali” fra Stati membri per ciò che concerne la
tutela dell’indicazione geografica.
Secondo la Corte – che rigetta sul punto
un ricorso per inadempimento portato dalla
Commissione contro la Germania – anche la
responsabilità dei controlli “pubblicistici”, o
di polizia amministrativa, relativi alla protezione giuridica dell’indicazione compete, in
via di principio, allo Stato di origine di questa. Non invece allo Stato di importazione e di
smercio, come sostenuto dalla Commissione,
il quale deve però approntare nel proprio ordinamento strumenti di tutela effettiva dei
diritti che i singoli traggono dal regolamento
comunitario73. La Corte ha fondato tale conclusione, conforme ai principi generali del
mercato interno, sull’interpretazione letterale e sistematica del regolamento previgente e
sulla constatazione che la Commissione non
aveva dimostrato che gli strumenti di garanzia
predisposti dalla Germania – norme sulla concorrenza sleale, norme sulla tutela dei marchi
e altri segni distintivi, con riconoscimento di
un’ampia legittimazione ad agire dei singoli
interessati, produttori, concorrenti, associazioni dei consumatori – non siano idonee a
tutelare la denominazione di un altro Stato
membro74.
5. Contenuto e limiti della tutela.
Per effetto della registrazione solo gli operatori che commercializzano prodotti conformi
al disciplinare possono utilizzare la denominazione corrispondente75.
Il regolamento assicura alla denominazione registrata una tutela intensa e quasi assoluta nell’intero territorio dell’Unione, per taluni
aspetti “esaurendo” l’ambito di discrezionalità
del legislatore tracciato dalla Corte nella sua
73 Corte giust., 26 febbraio 2008, C-132/05, Commissione
c. Germania, in Racc., p. I-957, cpv. 73 ss.
74 Corte giust., 26 febbraio 2008, Commissione c.
Germania, cit., cpv. 80. Sulla scelta della Corte, cfr. M.
Cian, Le indicazioni di qualità, cit., p. 199 s., anche per analogie con la situazione italiana.
75 Art. 8 del reg. n. 510 del 2006.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
giurisprudenza fondativa76. I titolari possono
infatti impedire ai terzi impieghi commerciali
che abbiano lo scopo di sfruttare indebitamente o usurpare la reputazione del prodotto, o che
si avvalgano di indicazioni false o ingannevoli,
o che abbiano comunque l’effetto di indurre in
errore il consumatore77. Gli strumenti di tutela
concretamente utilizzabili (azione inibitoria,
azione di nullità, azione di risarcimento, ad
esempio) devono essere rintracciati nell’ordinamento nazionale, salvi i principi del diritto
comunitario.
La giurisprudenza conferma, in sede applicativa, il carattere ampio della tutela, che
risponde sul piano interpretativo al principio
di effettività. La Corte ha ritenuto, in una controversia sorta in Austria concernente l’uso
del marchio “Cambozola”, riferito a un formaggio a pasta molle di origine tedesca, che
76 Corte giust., 10 novembre 1992, Exportur, cit., cpv. 14,
in cui la Corte si pronuncia peraltro con riferimento alla
disciplina (assai) protettiva di indicazioni geografiche
posta da una convezione bilaterale franco-spagnola, ritenuta compatibile con il sistema del Trattato.
77 L’art. 13 par. 1 tutela le denominazioni registrate contro a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto
di una denominazione registrata per prodotti che non
sono oggetto di registrazione, in quanto comparabili ai
prodotti registrati ovvero in quanto sfruttino la reputazione della denominazione registrata; b) qualsiasi usurpazione imitazione o evocazione, anche se l’origine vera
del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta
è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera” e simili; c)
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa
alla provenienza all’origine ecc. usata nella confezione,
nell’imballaggio, nel condizionamento o nella pubblicità; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore. Sulle implicazioni internazionali di
tale rigorosa disciplina, cfr. Irene Calboli, Expanding the
Protection of Geographical Indications of Origin Under TRIPS:
Old Debate or New Opportunity?, in Marquette University
Law School Legal Studies, Research Paper Series, Research
Paper No. 06-19, 2006, p. 181-203, p. 200 ss. Per evitare
che la registrazione di una denominazione finisca per
“ingessare” le attività produttive e per impedire lo sviluppo di altre iniziative economiche, M. Cian (Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela, in
B. Ubertazzi, E. Muňiz Espada (a cura di), Le indicazioni di
qualità, cit., p. 191, 197 s.) ha proposto una lettura non
estensiva della norma, e della nozione di “sfruttamento” della reputazione, in quanto riferita a prodotti non
comparabili originari della zona di produzione.
42
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
potesse sussistere il rischio di evocazione della
denominazione di origine italiana “Gorgonzola” registrata ai sensi del regolamento, pur in
mancanza di qualsiasi rischio di confusione e
sebbene nessuna tutela comunitaria si applichi ai singoli elementi della denominazione di
riferimento78.
Tale approccio è stato ribadito, e ulteriormente rafforzato, in una controversia che opponeva la denominazione “parmesan” alla denominazione di origine protetta “Parmigiano
Reggiano”. La Corte, pur senza affermare esplicitamente che la tutela della denominazione
registrata si estende – in quanto tale – ai singoli elementi di cui si compone, e senza chiarire se la tutela riguardi altresì la traduzione del
termine contenuto nella denominazione, ha
ammesso che l’uso dell’espressione (tedesca)
parmesan costituisse un’evocazione (vietata)
della denominazione Parmigiano Reggiano.
Tale conclusione è stata raggiunta, ancora una
volta, con riguardo alle circostanze fattuali in
cui si era posta la questione, ossia alla sussistenza di una similarità nell’aspetto esterno
dei prodotti, associata ad analogie “fonetiche e
ottiche” fra le due denominazioni, e ad una “somiglianza concettuale” tra i due termini, “pur
di due lingue diverse”. Invero “tale somiglianza, come già le somiglianze fonetiche e ottiche,
è idonea a indurre il consumatore a prendere
come immagine di riferimento il formaggio
recante la DOP “Parmigiano Reggiano” quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta
duro, grattuggiato o da grattuggiare, recante la
denominazione “parmesan””79.
5.1. Per effetto della registrazione la denominazione è posta al riparo da eventuali fenomeni di volgarizzazione80.
Inoltre la denominazione registrata preclude la successiva domanda di registrazione di un marchio, concernente lo stesso
tipo di prodotto, che possa ledere le garanzie di cui è circondata la stessa, e determina
la nullità dei marchi registrati nonostante
tale preclusione81.
Tale disposizione equipara la natura della
protezione assicurata alle denominazioni o
indicazioni geografiche a quella dei marchi; e
sembra giustificare l’opinione di quanti valutano la tutela delle indicazioni geografiche addirittura superiore a quella dei marchi, tenuto
conto dei presupposti che si accompagnano
alla titolarità di tale ultimo tipo di diritti di
privativa82.
Peraltro, e a temperamento del carattere assoluto della protezione delle denominazioni,
talune tutele sono assicurate ai diritti dei terzi in
buona fede, tutele che implicano delicati bilanciamenti di natura fattuale e giuridica.
In primo luogo i terzi possono utilizzare il
nome contenuto in una denominazione registrata se questo “è considerato generico”, nonostante la corrispondenza dei prodotti agricoli o alimentari riguardati, senza che i titolari
della denominazione registrata possano invocare le prerogative conferite dal regolamento83. Da questa disposizione la Commissione
desume, a contrario, che la protezione si estende anche ai singoli termini che compongono
la denominazione – salvo che, appunto, siano
78 Corte giust., 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela
del formaggio Gorgonzola, cit., cpv. 26. Secondo la Corte
“trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato
il cui aspetto esterno presenta analogie con quelle del
formaggio “Gorgonzola”, sembra legittimo ritenere che
vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due
medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una
similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini”.
La Corte ha dato anche risalto al fatto che, a partire da un
documento pubblicitario dell’impresa titolare del marchio, “l’analogia fonetica fra le due denominazioni non
[pareva] frutto di circostanze fortuite” (cpv. 27 e 28).
79 Corte giust., 26 febbraio 2008, Commissione c.
Germania, cit., cpv. 46-48.
80 Secondo l’art. 13, par. 2, “Le denominazioni protette
non possono diventare generiche”.
81 Art. 14, par. 1, del reg. n. 510 del 2006.
82 Cfr. nella dottrina italiana, M. Cian, Le indicazioni di
qualità, cit., p. 195; D. Sarti, Segni e garanzie di qualità, cit.,
p. 124; nella dottrina straniera, D. Gangjee, Quibbling
Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical
Indications, in Chicago-Kent Law Review, 2007, passim e
in http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1000467, secondo cui “Despite their apparent functional similarity to trademarks, Gis are ontologically
distinct beasts (...). These considerations results in a sui
generis GI protection framework which has relatively
stronger levels of producer protection when compared
to trademark law”.
83 Art. 13, par. 1, co. 2 del reg. n. 510 del 2006.
Produzioni alimentari legate al territorio
43
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
divenuti generici84. In secondo luogo le denominazioni non registrate e preesistenti, che
siano fondate su usi leali, costanti e soddisfino
talune condizioni cumulative, possono essere
autorizzate dalla Commissione su domanda
e con procedura aggravata, per un periodo di
quindici anni, anche se siano identiche alla
denominazione registrata85. Infine, e ancora
in conformità con il principio del preuso (first
in time, first in right), l’utilizzo di un marchio
depositato, registrato o acquisito con l’uso
in buona fede sul territorio comunitario può
proseguire, anche dopo la registrazione della
denominazione o dell’indicazione geografica,
a condizione che il marchio esista anteriormente alla data di protezione della denominazione o dell’indicazione geografica nel paese di
origine, e che il marchio stesso non incorra in
nullità o decadenza per i motivi previsti dagli
strumenti comunitari pertinenti86.
5.2. Nel contenzioso comunitario il problema del carattere “generico” della denominazioni d’origine o dell’indicazione geografica
è immancabilmente invocato, come mezzo
difensivo o offensivo, avverso il privilegio che
alle prime si accompagna.
Tale carattere è conseguenza del successo e
della diffusione di un segno indicativo dell’origine del prodotto87: attraverso l’impiego diffuso, esso “perde il suo significato geografico e
acquisisce un diverso significato, basato sulle
qualità non geografiche del prodotto, come
accade quando i parigini vanno al ristorante
cinese negli Champs-Elysées, o a distanza di
nove fusi orari, quando i californiani ordinano
le French fries con un hamburger”88. Come si è vi84 Cfr. Corte giust., 26 febbraio 2008, Commissione c.
Germania, cit., cpv. 21.
85 ������������������������������������������
Art. 13, par. 4 del reg. n. 510 del 2006.
86 ������������������������������������������
Art. 14, par. 2 del reg. n. 510 del 2006.
87 Sull’attuale approccio dell’Unione europea rivolto
al “recupero” di denominazioni considerate generiche
negli Stati Uniti, cfr. da ultimo D. Snyder, Enhanced
Protections for Geographical Indications Under TRIPs:
Potential Conflict Under the U.S. Constitutional and Statutory
Regimes, in Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 2008, p.
1297 ss. (e in http://ssm.com/abstract=1275543)
88 ������������
J. Hughes, Champagne, Feta, and Bourbon, cit., p. 304.
Secondo la Corte “per quanto concerne un’IGP, una de-
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
sto il carattere generico di una denominazione
ne preclude la registrazione, mentre la volgarizzazione di un termine fra quelli registrati
che compongono la denominazione comporta la facoltà di impiego del termine stesso per
prodotti agricoli o alimentari corrispondenti.
Come si ricorderà, già nel seminale caso Exportur la Corte aveva ammesso che una convenzione franco-spagnola potesse estendere,
su base bilaterale, la tutela delle indicazioni
geografiche prevista da una Parte contraente all’altra Parte, purché tali indicazioni “non
[avessero] acquistato, al momento dell’entrata
in vigore della convenzione o in un momento
successivo, natura generica nello Stato d’origine”, e che tale estensione “condizionata” era
giustificabile alla luce del principio della libera
circolazione delle merci89.
Il regolamento n. 510 precisa che si ha volgarizzazione quando una denominazione, già
collegata col nome del territorio di cui il prodotto è originario, è divenuta successivamente “il nome comune di un prodotto agricolo o
alimentare nella Comunità”. Profilo cruciale
nell’accertamento del carattere generico di
una denominazione è l’individuazione dei
“mezzi di prova” a tal scopo utilizzabili; l’art.
3, par. 1, del regolamento fornisce al riguardo
sommarie indicazioni, prescrivendo che nello
svolgimento dell’esame “si tiene conto di tutti
i fattori, in particolare [..] della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo [e] delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie”.
5.3. La giurisprudenza valuta conseguentemente in maniera estensiva le categorie di
dati rilevanti per accertare la genericità di una
denominazione90, e ha talora annullato le reginominazione diventa generica solo se il nesso diretto
tra, da un lato, l’origine geografica del prodotto e, dall’altro, una qualità determinata dello stesso, la sua reputazione o un’altra caratteristica del medesimo, attribuibile a detta origine, sia scomparsa e la sua denominazione
descriva ormai soltanto un genere o un tipo di prodotti”:
sentenza 2 luglio 2009, Bavaria, cit., cpv. 103.
89 Corte giust., 10 novembre 1992, Exportur, cit., cpv. 3538.
90 Trib. primo grado, 12 settembre 2007, T-291/03,
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. Ufficio
44
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
strazioni conseguite senza che l’autorità competenza avesse tenuto conto dei fattori essenziali indicati dal regolamento91 eventualmente
integrati in via interpretativa92.
Benché “il divieto di registrare denominazioni generiche o divenute tali [sia] generale
e incondizionato”93, la prassi rivela come la
dimostrazione del carattere generico della denominazione, proprio in considerazione della
quantità e della complessità degli elementi di
fatto rilevanti, costituisce uno “scoglio” probatorio notevole, quando non insormontabile, per gli Stati membri e i terzi interessati94.
Ad esempio nel caso Germania e Danimarca c.
Commissione, che conclude la più complessa
controversia sul preteso carattere generico di
una denominazione, la Corte ha escluso che il
nome “Feta”, registrato a livello comunitario
per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), in Racc., p.
II-3081, cpv. 65-67, che fornisce una sintesi dei dati ritenuti pertinenti nella prassi giurisprudenziale; ciò in occasione di un ricorso, promosso dal Consorzio nominato, contro la sentenza che, nell’ambito del contenzioso
sulla validità del marchio “Grana Biraghi” per contrasto
con le denominazioni d’origine e i marchi precedenti
Grana e Grana Padano, aveva ritenuto che il termine
“grana” era generico, nonché descrittivo di una qualità
dei formaggi in oggetto. Nella sentenza del 26 febbraio
2008, Commissione c. Germania, cit., la Corte ha ricordato,
più concisamente, che “nel valutare la genericità di una
denominazione occorre prendere in considerazione
[...] i luoghi di produzione del prodotto considerato sia
all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto,
il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all’interno
e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una
normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto,
nonché il modo in cui la detta denominazione è stata
utilizzata nella legislazione comunitaria” (cpv. 53).
91 Corte giust., 16 marzo 1999, C-289/96, C-293/96,
C-299/96, Danimarca e Germania c. Commissione, in Racc.,
p. I-1541.
92 Trib. primo grado, 12 settembre 2007, Consorzio per la
tutela del formaggio Grana Padano c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), cit., il quale annulla
la sentenza della commissione di ricorso in materia di
marchi per non aver l’organo giurisdizionale preso in
considerazione i criteri “espressi dalla giurisprudenza
comunitaria” (cpv. 69).
93 Corte giust., 16 marzo 1999, Danimarca e Germania c.
Commissione, cit., cpv. 52.
94 Corte giust., 28 febbraio 2008, Commissione c.
Germania, cit., cpv. 57;
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
come denominazione di origine di una parte
del territorio greco, avesse carattere generico,
sebbene il nome del formaggio in questione derivasse dall’italiano “fetta”, il formaggio
stesso presentasse un’ampia e precedente diffusione nei Balcani sotto altra denominazione
e fosse da molto tempo regolarmente prodotto
e commercializzato in vari Stati membri (Germania, Francia e Danimarca) con la stessa denominazione95. Per raggiungere tale soluzione
essa si è basata su vari elementi, quali la preponderanza del consumo comunitario di tale
formaggio in territorio greco, la percezione
dei consumatori greci secondo cui il nome feta
avrebbe connotazione geografica e non generica, il fatto che negli altri Stati membri il feta
sarebbe commercializzato con etichette che richiamano le tradizioni culturali e la civiltà greche, e infine, sotto il profilo normativo, il fatto
che in Danimarca la produzione e il commercio di “feta danese” suggerissero che “la denominazione feta senza ulteriore qualificazione
ha mantenuto la sua connotazione greca”96.
6. La protezione delle indicazioni geografiche in deroga alla libera circolazione delle merci.
La protezione dei segni geografici da parte
del diritto nazionale può pacificamente comportare un pregiudizio alla libera circolazione
delle merci nel mercato unico europeo, ai sensi
degli articoli 28 e 29 del Trattato97, nella misura
in cui ostacola il commercio dei prodotti non
riconducibili all’area di origine della denominazione (anche a prescindere, come detto, da
un rischio di confusione del consumatore). La
struttura del sistema di protezione su base territoriale può determinare altresì effetti discriminatori. Tale trattamento deteriore concerne (normalmente) i prodotti degli altri Stati
membri, nella misura in cui solo i prodotti nazionali originari della zona delimitata posso95 Corte giust., 25 ottobre 2005, C-465/02 e C-466/02,
Germania e Danimarca c. Commissione, in Racc., p. I-9115.
96 Corte giust., 25 ottobre 2005, Germania e Danimarca c.
Commissione, cit., cpv. 75-99.
97 Cfr. L. Daniele, Diritto del mercato unico europeo,
Milano, 2006, p. 59 ss. spec. 78.
45
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
no beneficiare del segno distintivo98. Ma può
concernere anche i prodotti nazionali, configurando un ostacolo all’esportazione di questi,
quando implichi un regime asimmetrico di
circolazione “interna” ovvero “internazionale”
in relazione ai medesimi prodotti99.
In ragione dei descritti effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, la tutela delle indicazioni geografiche può essere ammessa solo se giustificata da motivi di tutela della
proprietà industriale o commerciale (art. 30
del Trattato). E’ richiesto allora che la tutela sia
idonea alla “salvaguardia dei diritti che costituiscono l’oggetto specifico di detta proprietà”100,
ossia, nel linguaggio della Corte, tenuto conto
della peculiarità dei segni geografici in esame,
sia necessaria (e proporzionata) rispetto allo
scopo di garanzia dell’origine e della qualità
del prodotto.
6.1. Una prima linea giurisprudenziale si è
occupata della protezione accordata dagli Stati
membri ai segni distintivi che non comportano uno “specifico” riferimento all’origine del
prodotto, bensì un generico riferimento geografico. Secondo la Corte tali segni (c.d. segni
di qualità) non rientrano nella deroga relativa
alla proprietà industriale e commerciale, poiché mirano semplicemente a garantire la qualità dei prodotti agli occhi del consumatore, o a
promuovere il consumo di specialità tradizionali. Si è così ritenuto, ad esempio, che la disciplina francese che subordina il commercio dei
prodotti francesi provenienti da zone montane
al conferimento amministrativo dell’appellativo “montagna”, senza esigere che tali prodotti
siano riconducibili a zone montane determinate, contrasta con l’art. 28 del Trattato e non
è coperto dalla deroga di cui all’art. 30 in quan98 V. per un’illustrazione più articolata, Corte giust., 10
novembre 1992, Exportur, cit., cpv. 18-20.
99 Corte giust., 9 giugno 1992, Delhaize, cit., cpv. 12-14;
16 maggio 2000, Belgio c. Spagna, cit., cpv. 38-41, in relazione all’obbligo, posta dall’ordinamento spagnolo,
dell’imbottigliamento all’interno della zona di produzione “Rioja” del vino che voglia fregiarsi dell’appellativo “denominación de origen calificada Rioja”, ma con
possibilità di circolazione del vino sfuso solo all’interno
della zona delimitata dell’origine.
100 Corte giust., 10 novembre 1992, Exportur, cpv. 23-25.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
to tale segno “non può essere qualificat[o] alla
stregua di un’indicazione di provenienza”101.
Ne risulta che affinché le indicazioni geografiche possano avvalersi della deroga ex art. 30 è
imprescindibile il collegamento del segno con
una specifica realtà territoriale.
6.2. Tanto severa è la Corte nei confronti
delle normative nazionali che non esprimono
segni legati al territorio, quanto permissiva
nei confronti degli ostacoli alla circolazione
dei prodotti posti in essere dalla disciplina
nazionale che tutela – sotto la “copertura” del
diritto derivato – denominazioni di origine o
indicazioni di provenienza in senso proprio.
Il problema che si è posto recentemente alla
giurisprudenza è relativo a quali operazioni,
inerenti ai prodotti tutelati, possano essere
riservate alle imprese stabilite nella zona di
origine del prodotto, e quali invece debbano essere consentite ai terzi che esportano e
commercializzano il prodotto originale. Il problema, insomma, di individuare un adeguato
“punto di equilibrio” fra la tutela della privativa e le esigenze della libera circolazione delle
merci.
In tale settore la Corte non sembra dare rilievo a distinzioni relative alla categoria (produzione, condizionamento, modalità di vendita o
di impiego del prodotto) in cui l’operazione si
colloca102, come invece nell’ambito applicativo
101 Corte giust., 7 maggio 1997, C-321/94, C-322/94,
C-323/94, C-324/94, Pistre, in Racc., p. I-2343, cpv. 53; 5
dicembre 2000, C-448/98, Guimont, in Racc., p. I-10663
(divieto francese di produzione e messa in commercio
di un formaggio privo di crosta con la denominazione
Emmenthal); 5 novembre 2002, C-325/00, Commissione
c. Germania, in Racc., p. I-9977 (il marchio di qualità Markenqualitat aus deutschen Landen” - conferito ai prodotti tedeschi che presentino determinati requisiti qualitativi, siano prodotti in Germania con materie prime
sia tedesche che importate, “non può in alcun caso essere considerat[o] come un’indicazione geografica che
possa essere giustificata in base all’art. [30] del Trattato,
cpv. 27).
102 Corte giust., 16 maggio 2000, Belgio c. Spagna, cit.,
cpv. 49: “Ai fini della soluzione della presente controversia occorre non tanto stabilire se si debba considerare come una fase del procedimento d’elaborazione di
un vino che può fruire di una «denominación de origen calificada» il suo imbottigliamento nella regione di
produzione, quanto piuttosto valutare i motivi per cui,
46
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
generale dell’art. 28 del Trattato103 e del diritto
derivato104. Coerentemente con la teoria dell’oggetto specifico della privativa, la Corte utilizza
piuttosto un criterio di tipo finalistico.
Possono restare nella potestà esclusiva delle
imprese titolari della denominazione (o indicazione) d’origine, senza dar adito a dubbi di
“protezionismo alimentare”, tutte le operazioni che sono suscettibili di incidere in modo
peggiorativo sulla qualità, e dunque sulla reputazione, del prodotto qualora lasciate all’intervento dei terzi.
In punto di proporzionalità, peraltro, la
Corte non s’accontenta di valutare se esistano
strumenti alternativi ed efficaci di tutela, però
meno ostativi alla circolazione delle merci.
Richiede, invece, che i mezzi alternativi siano idonei a garantire o a preservare la migliore
qualità del prodotto, enfatizzando in tale prospettiva le indicazioni “legislative” risultanti
dai regolamenti comunitari105. È soprattutto in
punto di qualificazione degli elementi fattuali
che la giurisprudenza esprime un atteggiamento permissivo106, ispirato a una particolare sen-
sibilità per le esigenze di qualità dei prodotti, a
dispetto della torsione che tale approccio arreca a uno dei fondamenti del mercato comune.
In concreto i requisiti che devono cumulativamente sussistere affinché le operazioni di
intervento sul prodotto possano restare in via
esclusiva nella responsabilità delle imprese
della zona d’origine, ad esclusione di tutte le
altre imprese europee, e possano essere opposte a queste ultime, sono molteplici. In punto
di forma, le operazioni di cui si tratta devono
essere previste dal disciplinare, e questo deve
risultare adeguatamente accessibile alle imprese degli altri Stati membri107; in punto di
sostanza, le operazioni devono contribuire
sensibilmente a preservare, attraverso la specificità tecnica dei controlli cui il prodotto è
assoggettato, la qualità del medesimo.
Per converso la Corte ha dato – sinora – rilevanza non decisiva alla possibilità di “decentrare”, in modo altrettanto efficace, i controlli specialistici al di fuori della zona di
produzione (considerando tale delocalizzazio-
secondo il governo spagnolo, tale operazione dev’essere
effettuata nella regione di produzione. Infatti, la condizione controversa può essere considerata conforme al
Trattato malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci solo ove detti motivi siano di per
sé idonei a giustificarla”.
103 ��������������������
Cfr. L.W. Gormley, The Definition of Measures Having
Equivalent Effect, in A. Arnull, P. Eeckhout & T. Tridimas
(eds.), Continuity and Change in EU Law, Essays in Honour
of Sir Francis Jacobs, Oxford, 2008, p. 189 ss.
104 Cfr. reg. n. 1898 del 2006, cit., art. 8, che prescrive
un obbligo di specifica motivazione della restrizione
alla libera circolazione delle merci e dei servizi qualora
l’associazione richiedente stabilisca nel disciplinare che
il “condizionamento del prodotto agricolo o alimentare”
debba avvenire nella zona geografica delimitata.
105 Corte giust., 16 maggio 2000, Belgio c. Spagna, cit.,
cpv. 53.
106 V., con riguardo al se l’obbligo di imbottigliamento del vino nella regione di produzione costituisca un
requisito indispensabile a garantire la qualità del prodotto tutelato, Corte giust., 9 giugno 1992, Delhaize, cit.
(che conclude in senso negativo, poiché non era stato
provato che l’ubicazione delle attività di imbottigliamento sia di per sé atta a incidere sulla qualità del vino,
cpv. 23); 16 maggio 2000, Belgio c. Spagna, cit. (che conclude in senso positivo, dopo una dettagliata analisi delle caratteristiche della disciplina del vino di qualità in
esame: “Pertanto, occorre riconoscere che la condizione
controversa, la quale è diretta a preservare la notevole
reputazione del vino Rioja potenziando il controllo
delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità,
è giustificata come misura di tutela della «denominación de origen calificada» di cui gode la collettività dei
produttori interessati e che per essi riveste un’importanza decisiva”, cpv. 75); con riguardo al se l’obbligo di
effettuare la grattuggiatura e il confezionamento del
formaggio Grana Padano nella zona di produzione contribuisca in modo decisivo a preservare la qualità del
medesimo, Corte giust., 20 maggio 2003, Ravil, cit. (che
conclude in modo positivo, cpv. 48 ss., spec. 52 ss.); con
riguardo al se l’obbligo di affettamento e confezionamento del Prosciutto di Parma nella zona di produzione sia giustificata a preservazione della qualità e della
reputazione del prodotto, Corte giust., 20 maggio 2003,
Consorzio del Prosciutto di Parma, cit. (che conclude in senso positivo: cpv. 65 ss., spec. 78: “Pertanto, la condizione
di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, la quale è diretta a preservare la reputazione
del prosciutto di Parma potenziando il controllo delle
sue caratteristiche particolari e della sua qualità, può
essere considerata giustificata come misura di tutela
della DOP di cui beneficia la collettività degli operatori
interessati e che riveste per questi ultimi un’importanza decisiva”).
107 Corte giust., 20 maggio 2003, Ravil, cit., cpv. 100102; Corte giust., 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto
di Parma, cit., cpv. 82-98.
Produzioni alimentari legate al territorio
47
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
ne “difficilmente concepibile”108); né ha ritenuto dirimente, a dimostrazione del carattere
non necessario della restrizione, il fatto che almeno in talune ipotesi il trattamento del prodotto non viene necessariamente effettuato
(come nel caso del consumo al dettaglio o nei
luoghi di ristorazione) nella zona di produzione. In modo alquanto contraddittorio la Corte
ha ritenuto che, in tali ipotesi, l’accertamento
dell’origine del prodotto permanga nel controllo (eventuale) del consumatore109.
Infine, distanziandosi dall’approccio adottato con riguardo alle generiche produzioni
tradizionali (quali la “birra tedesca”) non coperte da garanzie comunitarie, la Corte ha ritenuto che un mezzo altrettanto efficiente (e
meno restrittivo) non potesse essere ravvisato
in un obbligo di “adeguata etichettatura” che
permetta al consumatore di essere informato
del fatto che il trattamento o alcune fasi del
trattamento del prodotto sono svolti fuori dalla zona di produzione110.
7. Il carattere esauriente della disciplina comune e la possibile protezione
“complementare” prevista dal diritto
nazionale.
Un ultimo e cruciale problema di cui si è
occupata la giurisprudenza, con esiti non lineari e ancora in evoluzione, è relativo al se la
disciplina delle denominazioni che discende
dal regolamento abbia carattere esaustivo, ovvero lasci spazio alla protezione “nazionale” (o
nazionale e convenzionale assieme) di segni
indicativi in cui il legame fra segno e territorio
appare attenuato o meno caratterizzato rispetto a quanto previsto dalla disciplina comune.
Nel vigore del precedente regolamento la
Corte aveva più volte affermato che la disciplina delle indicazioni geografiche da questo po108 Ad esempio, Corte giust., 20 maggio 2003, Consorzio
del Prosciutto di Parma, cit., cpv. 75.
109 Così, ancora, Corte giust., 20 maggio 2003, Consorzio
del Prosciutto di Parma, cit., cpv. 77. Cfr. in argomento le
insuperate critiche dell’Avvocato generale S. Alber nelle
conclusioni in causa C-108/01, spec. cpv. 112.
110 Corte giust., 20 maggio 2003, Consorzio del Prosciutto
di Parma, cit., cpv. 80.
Produzioni alimentari legate al territorio
issn 2035-584x
sta non impedisse – salve le regole sulla libera
circolazione delle merci – agli ordinamenti
nazionali di predisporre ulteriori ipotesi o
forme di tutela, per esempio in relazione alle
cosiddette “indicazioni di origine geografica
semplici”, intendendosi con tale espressione
i segni geografici che “non implicano nessun
rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la
sua origine geografica”111, in particolare, nessun rapporto di tipo qualitativo112.
Da ultimo nella sentenza Budejovický Budvar
la Corte ha confermato che la normativa comunitaria non si oppone al riconoscimento
da parte di uno Stato membro (l’Austria), per
effetto di una convenzione bilaterale, di una
indicazione di origine geografica (della Repubblica ceca) che “non fa parte delle designazioni che rientrano nella sfera d’applicazione
del regolamento n. 2081/92”, il quale limita la
sua disciplina “alle designazioni relative ad un
prodotto per il quale esiste un nesso particolare tra le sue caratteristiche e la sua origine
geografica”113. Secondo la Corte la denominazione in esame, qualificabile come indicazione
di origine semplice e indiretta, “non è di per sé
una denominazione geografica, ma almeno è
idonea ad informare il consumatore del fatto
che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da un regione o da un paese determinati”.
Rimane oscuro, nel ragionamento della Corte,
111 Corte giust., 7 novembre 2000, C-312/98, Warsteiner,
in Racc., p. I-9187, cpv. 47. Confronta, a contrario, per
l’ipotesi in cui la disciplina nazionale interferisca con
la normativa comunitaria, Corte giust., 6 marzo 2003,
C-6/02, Commissione c. Francia (marchi regionali), in Racc.,
p. I-2389, cpv. 13 (per la tesi della Commissione, apparentemente accolta dalla Corte).
112 Cfr. D. Sarti, La tutela delle indicazioni geografiche nel
sistema comunitario, in B. Ubertazzi, E. Muňiz Espada
(a cura di), Le indicazioni di qualità degli alimenti, cit., p.
324 ss., spec. 345 ss., per un’interpretazione ampia di
tale nozione, che potrebbe estendersi, ad esempio, alle
indicazioni in cui il nesso fra “provenienza territoriale e caratteristiche del prodotto non è stato accertato
nell’ambito di un procedimento comunitario [...] ancorché possa eventualmente sussistere”; così come alle
“denominazioni che in alcuni paesi conservano carattere distintivo di una tradizione produttiva locale, ma
che nella maggior parte del territorio comunitario sono
considerate generiche”.
113 Corte giust., 18 novembre 2003, C-216/01, Budejovický
Budvar, in Racc., p. I-13617, cpv. 73-78.
48
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
quale possa essere la tutela conferita a tali indicazioni semplici. Deve ritenersi che essa si collochi
all’estremo “esterno” della protezione consentita
dall’art. 30; in conseguenza gli strumenti nazionali di garanzia dovrebbero risultare proporzionati al limitato significato che tali indicazioni
rivestono tra i segni geografici. In tale ordine di
idee, nella sentenza in esame, la Corte ha escluso che la disciplina controversa potesse “essere
giustificata in forza della tutela della proprietà
industriale e intellettuale”114, a causa precisamente della protezione assoluta – che prescinde
da qualsiasi rischio di inganno del consumatore
– prevista dal diritto nazionale.
Tale approccio parrebbe destinato a sopravvivere anche nel vigore del reg. n. 510 del 2006.
Nella sentenza Budejovický Budvar (II), in effetti,
la Corte ha bensì riconosciuto che il regolamento mira a “prevedere un sistema di tutela
uniforme ed esauriente”, tanto sotto il profilo
sostanziale che sotto il profilo procedurale, delle “indicazioni geografiche qualificate”115; ma
ha preso le mosse dal presupposto, evidenziato dal giudice del rinvio, che la denominazione
in oggetto fosse tutelata dall’ordinamento ceco
(e austriaco) in quanto denominazione d’origine e non come indicazione di provenienza
geografica semplice116. In altri termini, il regolamento comunitario osterebbe alla disciplina
nazionale delle indicazioni geografiche solo in
caso di coincidenza negli istituti (nelle “figure”) tutelati da parte del diritto interno e del
diritto comunitario, anche nel caso in cui questi rivelino non incompatibilità, ma semplice
differenziazione.
Stefano Amadeo, professore associato di Diritto
internazionale e di Diritto dell’Unione europea
nell’Università di Trieste, Facoltà di Giurisprudenza.
114 Corte giust., 18 novembre 2003, Budejovický Budvar,
cit., cpv. 54, 107-111.
115 Corte giust., 8 settembre 2009, Budejovický Budvar,
cit., cpv. 114 e 117.
116 Corte giust., 8 settembre 2009, Budejovický Budvar,
cit., cpv. 96.
Produzioni alimentari legate al territorio
49
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Conoscere e ospitare ... con più gusto. Viaggio nel
turismo enogastronomico
Moreno Zago
Abstract
Parole chiave
L’approccio al viaggio del what to do today fa sì che gli
interessi turistici si focalizzino sempre più su vacanze
brevi ma che privilegiano interessi particolari. Il turismo
enogastronomico è espressione di questa modalità di
scoperta e di conoscenza dei territori, alla ricerca di
sapori e di tradizioni autentiche.
Cibo e identità;
Turismo del gusto;
Specialità tradizionali;
Sviluppo locale;
Ospitalità.
1. Autenticità vs. creolizzazione del
prodotto locale
S
ociologi e antropologi1 hanno ampiamente evidenziato come l’atto del mangiare sia
uno degli ambiti privilegiati di espressione
dell’identità sia a livello individuale che in ambito sociale. Il cibo, quale frontiera culturale
simbolica, è il medium attraverso il quale l’individuo esprime se stesso e, allo stesso tempo, si
differenzia dagli altri. Da un lato, quindi, il cibo
crea appartenenza ad una comunità, membri
di un’unica cultura e, dall’altro lato, sottolinea
una differenza con chi non condivide le medesime abitudini alimentari, rimarcando un
“noi” da un “loro”.
In particolare, gli studi sulla nostalgia come
costruzione simbolica collettiva hanno dimostrato come, sia nella migrazione interna italiana dei meridionali al Nord del Novecento,
1 Cfr. R. Sassatelli, L’alimentazione: gusti, pratiche e politiche, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, (2004), n. 4,
pp. 1-18; A. Guigoni, Antropologia del mangiare e del bere,
Lungavilla, 2009; E. Battaglini (a cura di), Il gusto riflessivo. Verso una sociologia della produzione e del consumo alimentare, Roma, 2007.
Conoscere e ospitare... con più gusto
sia in quella oltreoceano così come in quella
straniera odierna in Italia, la cucina costituisca il nucleo attorno cui costruire la resistenza
individuale e familiare ad un ambiente visto
come estraneo e ostile. Attraverso il cibo si
attua un’operazione di resistenza all’assimilazione in grado di rimuovere le frustrazioni
causate dallo status di minoranza2.
Inoltre, l’adesione ad una cultura culinaria
delle proprie radici rappresenta una forma di
resistenza alla globalizzazione del gusto, la c.d.
McDonaldizzazione, e all’inserimento nelle tradizioni culinarie locali di ingredienti gastronomici provenienti da altre culture. È la riscoperta di una storia e di una tradizione locale che ha
indotto alcuni sindaci ad imporre veti alla presenza di ristoranti etnici all’interno dei centri
storici, visti come elementi estranei al tessuto
culturale urbano. Parlando di cibo, quindi, si
gioca con le nozioni di inclusione/esclusione
ed il disprezzo delle abitudini alimentari altrui
2 D.R. Gabaccia, We are what we eat: ethnic food and the
making of Americans, Cambridge, 1998.
50
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
così come l’accento sui tratti diversificanti dei
saperi culinari sono spesso presenti nei discorsi d’intolleranza culturale e di xenofobia3.
Contro questa politica eccessivamente localista si è costituita l’associazione Cous Cous
Clan la cui food-losophy dei suoi membri si
fonda sulla convinzione che: a) ogni cultura
gastronomica è frutto di incontri e scambi avvenuti con le altre culture gastronomiche (art.
1 dello statuto) e che, pertanto, è destinata a
cambiare e ad evolversi nel corso del tempo
(art. 2); b) che gli xenofobi che urlano nei loro
comizi “Polenta Si - Couscous No” dimenticano che il mais non è un prodotto tipico della
Padania, ma del centro America (art. 8); c) che
l’amore per le cucine, i prodotti ed i cibi esotici, può tranquillamente convivere con l’amore
per i piatti, i prodotti ed i cibi della terra nativa
(art. 7); d) che il protezionismo economico, il
fanatismo, l’orgoglio nazionalista e i precetti
alimentari delle religioni, sviluppano solo ideologie, barriere culturali e pregiudizio (art. 4).
Il movimento mette in risalto un aspetto
importante: gli alimenti che definiscono il
senso di identità di una nazione hanno spesso
storie complesse, fatte di scambi commerciali e culturali cosicché le cucine nazionali sono
sempre sottoposte ad un processo di creolizzazione attraverso cui il passato si sedimenta nel
presente. Anderson4 sostiene che, così come la
nazione e la lingua nazionale, anche la dieta nazionale altro non sia che una rassegna di piatti
e tradizioni immaginate. A titolo di esempio,
Hall5 ricorda che, nonostante non vi sia una
singola piantagione di tè in tutto il Regno
Unito, questo sia diventato la simbolizzazione
dell’identità inglese, così come è trascurabile
per l’identità italiana ricordare che la pasta sia
stata portata dalla Cina da Marco Polo6.
I popoli, come ha presente Douglas7, neces3 C. Fischler, L’onnivoro. Il piacere di mangiare nella storia
e nella scienza, Milano, 1992.
4 B. Anderson, Comunità immaginate, Origine e diffusione
dei nazionalismi, Roma, 1996.
5 S. Hall, Old and new identities, old and new ethnicities, in
M. Featherstone, Global Culture, cit., p. 39.
6 F. La Cecla, La pasta e la pizza, Bologna, 1998.
7 M. Douglas, Antropologia e simbolismo. Religione, cibo e
denaro nella vita sociale, Bologna, 1985, pp. 193-229.
Conoscere e ospitare... con più gusto
issn 2035-584x
sitano di una cucina tipica come strumento di
affermazione della propria identità e, nel mosaico incongruente dei consumi postmoderni,
è in costante crescita la richiesta di autenticità
da parte delle persone e dei turisti, in particolare. Il turismo enogastronomico è espressione
di questa ricerca della tipicità locale che lega il
cibo all’identità del territorio.
2. Dimensione e localizzazione del
fenomeno
L’Italia è un paese ricco di tradizioni gastronomiche e di prodotti tipici che gli italiani hanno saputo mantenere vive. Il nostro paese è il
primo produttore mondiale di vino con 316 vini
a Denominazione di origine controllata, 41 a
Denominazione di origine controllata e garantita e 120 a Indicazione geografica tipica. A ciò
si devono aggiungere l’individuazione e la valorizzazione di ben 118 prodotti a Denominazione di origine protetta e a Indicazione geografica
protetta, 4.396 specialità tradizionali regionali,
18mila agriturismi, 4mila ristoranti, 61mila tra
frantoi, cantine, malghe e cascine8.
Il turismo enogastronomico contribuisce
a valorizzare questo patrimonio, da un lato,
richiamando un numero sempre crescente di
appassionati alla ricerca di sapori e tradizioni
autentiche e, dall’altro lato, facendo del cibo un
vettore di culture e valori saldamente legati al
territorio e alle proprie radici9.
Secondo i risultati di una ricerca del BitLab,
l’Osservatorio sull’Immagine del Turismo Italiano all’estero10, su questa tipologia di viaggi,
l’Italia è il paese più citato nelle riviste internazionali. Lo studio che ha preso in esame 3.492
articoli di circa 100 testate giornalistiche con
sede in 20 differenti nazioni, ha anche evidenziato le mete valutate come interessanti dai
turisti del gusto: i parchi dell’Aspromonte in
8 BITEG, Enogastronomia, motore per il turismo in
Italia e in Piemonte, www.biteg.it/Public/News/
Enogastronomia%20motore%20del%20Turismo.pdf;
Sito consultato il 13/09/2009.
9 A. Antonioli Corigliano, G. Viganò, Turisti per gusto:
Enogastronomia, territorio, sostenibilità, Novara, 2004.
10 BitLab, Bit/4, Italia meta preferita per l’enogastronomia,
www.travelnostop.com/news.aspx?id=60404; Sito consultato il 13/09/2009.
51
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Calabria, le colline dell’Umbria, le campagne
del Lazio, i boschi e i vigneti del Piemonte.
Il turismo enogastronomico in Italia produce un volume d’affari annuo di 2,5miliardi
di euro e conta circa 5milioni di appassionati,
pari al 60% di visitatori provenienti dall’Europa e al 32% dell’Italia che, abbandonando le
motivazioni di viaggio più classiche, come il
mare e le città d’arte, organizzano vacanze brevi all’insegna del wine&food11.
L’importanza assunta dal settore è testimoniata dal BITEG - la Borsa Internazionale del
Turismo Enogastronomico -, l’unico evento
italiano per l’incontro tra domanda e offerta,
tra i più qualificati a livello internazionale e
dall’istituzione, presso il Ministero del Turismo, della Commissione per la promozione ed il sostegno del turismo enogastronomico le cui finalità
sono da rintracciarsi a) nella presa di coscienza
collettiva della quantità e della qualità del nostro tesoro agroalimentare, unico al mondo
anche per la sua varietà in rapporto all’estensione territoriale e b) nel coordinamento a
tutti i livelli, indispensabile per razionalizzare
la varietà dell’offerta e consentire la creazione
di iniziative e network enogastronomici capaci di attirare turismo anche destagionalizzato.
Quest’ultimo punto è rilevante perché la ricchezza legata alla cultura della buona tavola
ha la potenzialità di attrarre turisti anche nei
periodi di bassa stagione, coniugando con naturalezza il consumo di specialità locali con gli
altri segmenti turistici quali: terme, attività
sportive, escursionismo, visite alle città, shopping, ecc. In quest’ottica, attraverso il turismo
enogastronomico, passa anche il rilancio del
brand Italia e del Made in Italy.
Secondo un sondaggio della Coldiretti12, il
cibo e la buona cucina sono, per quasi due italiani su tre - e uno straniero su due - il simbolo
proprio del Made in Italy superando la cultura
e l’arte ferme al 24%, la moda all’8%, la tecnologia al 3% e lo sport al 2%. A conferma dell’importanza assunta dalle specialità locali, uno
11 Eurispes, XXI Rapporto Italia, Roma, 2009.
12 Coldiretti, In vacanza spopola il souvenir enogastronomico,
www.newsfood.com/q/53456/coldiretti-in-vacanza-spopola-il-souvenir-enogastronomico; Sito consultato il 13/09/2009.
Conoscere e ospitare... con più gusto
issn 2035-584x
studio dell’Istituto Piepoli-Leonardo-Ice ha
evidenziato come i turisti italiani e stranieri
che trascorrono le ferie estive in Italia preferiscano come souvenir il prodotto enogastronomico tipico del luogo di vacanza. Per sei turisti
su dieci, il prodotto alimentare caratteristico
del territorio, come vino, formaggio, olio di
oliva, salumi o conserve, è stato il souvenir
più apprezzato rispetto ai prodotti artigianali
locali (25%) e ai ricordi più commerciali come
cartoline, gadget e magliette (5%)13. Specificatamente per i turisti stranieri, particolarmente attratti dalle specialità italiane sono gli
svedesi (70%) e gli americani (58%), mentre
il gradimento più basso lo registrano i cinesi
(31%) e i russi (28%) che preferiscono i prodotti
della moda. L’acquisto di questi ricordi appetitosi rappresenta un modo per rendere meno
traumatico il rientro a casa e nella routine della
quotidianità e per prolungare quello stato di
grazia che attenua manifestazioni di cattivo
umore, insonnia e mal di testa.
Lo sviluppo del turismo enogastronomico è
andato di pari passo con la crescente diffusione di una cultura dell’alimentazione di qualità
e la riscoperta del terroir. Movimenti culturali
come Slow food e il Gambero rosso hanno contribuito, a partire dagli anni ottanta, a diffondere
un approccio conoscitivo del cibo più attento
attraverso pubblicazioni di critica gastronomica, corsi di degustazione ed eventi di grande impatto mediatico e le aziende hanno compreso
l’importanza di aprire le loro porte ad un pubblico desideroso di entrare nel vivo del processo
produttivo. In questi ultimi anni, inoltre, si è visto in molte città e località turistiche l’apertura
dei mercati degli agricoltori organizzati dalla
Coldiretti dove è possibile acquistare prodotti
genuini direttamente dal campo.
Una menzione speciale va sicuramente al
Movimento del turismo del vino che, nel 1993,
convince alcune decine di aziende vitivinicole dapprima solo toscane e poi, nel corso degli
anni, centinaia di imprese di tutta la penisola, a
restare aperte al pubblico l’ultima domenica di
maggio. Quale grande produttore di vino, l’Ita13 Coldiretti, Vacanze: coldiretti, 6 su 10 rientrano con
cibo e vini come souvenir, www.coldiretti.it/docindex/cncd/
informazioni/643_09.htm; Sito consultato il 13/09/2009.
52
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
lia ha saputo valorizzare le località e i prodotti
vinicoli delle principali regioni produttrici con
itinerari e percorsi segnalati da cartelli informativi che indirizzano nelle principali cantine
e aziende vitivinicole del territorio. Oggi, sono
circa 140 le Strade del Vino e dei Sapori e 1.300
sono i comuni attraversati da questa rete capillare che comprende quasi 400 denominazioni
territoriali di vini, oltre 4mila ristoranti, quasi 33mila prodotti vitivinicoli e più di 3,3mila
cantine che spesso accolgono turisti e curiosi
per una degustazione dei loro vini.
Il 62% dei produttori delle aziende oggetto
del sondaggio dell’Osservatorio delle Città del Vino-Censis14 ha visto aumentare mediamente del
19% il numero di visitatori nel 2008, sempre
più attratti dalle degustazioni (94%), dalle visite delle cantine (86%) e dalla vendita diretta
dei vini (57%). La crescita del numero di turisti
appassionati di vino è in linea con la tendenza
vacanziera affidata ad una cultura del what to
do today, basata su vacanze brevi, più frequenti
e meglio organizzate.
Un ulteriore elemento che ha contribuito
allo sviluppo del turismo enogastronomico è
stata la crescita delle vacanze nel verde e degli
agriturismi. L’Italia può contare su 772 parchi
e aree protette (il 10% del territorio nazionale)
e sulla leadership europea nella produzione
biologica che contribuiscono al successo dei
week end nel verde. La vacanza a contatto con
la natura in campagna, nei parchi o nelle oasi
naturalistiche ha fatto registrare nell’estate del
2009 un aumento di quasi l’80% rispetto all’anno precedente, coinvolgendo circa 5milioni di
turisti15. Nella sola Regione del Friuli Venezia
Giulia, in dieci anni, le aziende agrituristiche
sono pressoché raddoppiate, passando dalle
233 del 1998 alle 453 del 2007 per un totale di
arrivi pari a 34mila e di presenze pari a 105mila. Rispetto all’anno precedente, l’incremento
delle presenze è stato di ben 27 punti percen-
tuali16. A spingere i turisti nel verde c’è, da un
lato, la volontà di trascorrere il tempo libero
all’aria aperta, lontano dal caos delle città e,
dall’altro lato, la voglia di riscoprire le tradizioni alimentari realizzate con ricette uniche ed
ingredienti sani. Infine, ad attirare turisti in
queste strutture è l’offerta di programmi ricreativi come l’osservazione naturalistica, l’equitazione, il trekking, il wellness, le visite guidate
ai luoghi archeologici o ai borghi d’arte, ecc.
Ma qual è l’identikit del turista enogastronomico? Rispetto al passato, il turista in veste
di consumatore è sicuramente più preparato,
esigente e selettivo. Ha imparato a riconoscere
la qualità dei prodotti agroalimentari, anche
attraverso la lettura delle etichette. Inoltre, i
suoi comportamenti sono orientati all’individualismo e al contingente; non è un caso che
Bauman17 utilizzi il turista come metafora
della vita postmoderna basata sulla ricerca di
diversità, di nuove esperienze e sul rifiuto a legarsi ad identità stabili. Pertanto, non è possibile delineare con precisione il profilo del turista enogastronomico e il mercato si articola in
un’infinità di possibili consumatori ciascuno
dei quali è portare di una specifica e personale
identità, cultura e aspettativa.
Una nota classificazione suddivide i turisti
del sapore in due categorie: i gastronauti e i foodtrotter18. I primi vedono nel giacimento enogastronomico l’esclusivo motivo del viaggio e
riservano al territorio circostante un ruolo secondario. I secondi, viceversa, pur permanendo la centralità della risorsa enogastronomica,
sono interessati anche alle altre risorse del
territorio. La lunghezza del viaggio (vacanze
brevi o week end per i primi e vacanze più lunghe per i secondi) e il grado di cultura alimentare del fruitore (già esperti i primi, assetati di
conoscenze i secondi) costituiscono ulteriori
elementi discriminanti sul modo di accostarsi alla visita del territorio, all’azienda di pro-
14 Osservatorio sul Turismo del Vino delle Città del Vino,
Rapporto annuale, n. 7, Castelnuovo Berardenga, 2009.
15 Coldiretti, Questa estate è boom per le vacanze verdi,
www.newsfood.com/q/a5556ae8/turismo-coldirettiquesta-estate-e-boom-per-le-vacanze-verdi-80;
Sito
consultato il 13/09/2009.
16 G. Dominutti, I. Plet, L’agriturismo in Friuli Venezia
Giulia al 31.12.2007, Servizio statistica-Regione Fvg,
Trieste, 2008.
17 ������������
Z. Bauman, Modernity and ambivalence, Cambridge,
1991.
18 D. Paolini, I luoghi del gusto. Cibo e territorio come risorsa di marketing, Milano, 2000.
Conoscere e ospitare... con più gusto
53
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
duzione e alla degustazione. Le due tipologie
rappresentano gli estremi di un continuum
all’interno del quale si collocano diverse figure
di fruitori dei sapori occasionali quali i gitanti
della domenica, i visitatori delle fattorie didattiche, i consumatori attenti, i vip, ecc.
Croce e Perri19 ben sintetizzano questo turista come un soggetto con un livello culturale
elevato, abituato ad organizzare autonomamente le proprie vacanze perché scettico sulle competenze specifiche dei tour operator,
esigente nei confronti dei territori visitati in
cui cerca bellezza, qualità, professionalità, accoglienza e un flavour caratteristico e inequivocabile, desideroso di trascorrere momenti
di esperienza educativa, curioso di entrare in
contatto diretto con la filiera produttiva del
cibo gustato a tavola e predisposto a considerare questo come un mezzo per comprendere
un’identità culturale, al pari di un’opera d’arte.
3. La cultura dell’ospitalità
Il turismo enogastronomico quando è ben
progettato rappresenta un’importante risorsa per la valorizzazione ambientale, economica, sociale delle zone interessate dai flussi
turistici. E una buona progettazione implica
necessariamente un’adeguata comunicazione
del territorio e dei prodotti, un’accoglienza di
qualità, un’attenzione alle modalità di mobilità, il confezionamento di un prodotto turistico
tematico inconfondibile.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha puntato
molto sulla valorizzazione del patrimonio enogastronomico. Friuli Doc, Cantine aperte, BioFattorie aperte, Aria di festa a San Daniele sono
solo alcuni dei grandi eventi in grado di far
conoscere i prodotti locali e capaci di attrarre
decine di migliaia di visitatori. All’interno del
Parco agro-alimentare di San Daniele, le aziende aderenti al Consorzio di tutela del prosciutto di San Daniele marchiano oltre 2,6milioni
di cosce l’anno. Nel 2008 è nata la card Via
dei Sapori grazie alla quale si può disporre
dell’esperienza e dell’alta professionalità dei
19 E. Croce, G. Perri, Il turismo enogastronomico, Progettare,
gestire, vivere l’integrazione tra cibo, viaggio, territorio,
Milano, 2008, p. 54.
Conoscere e ospitare... con più gusto
issn 2035-584x
ristoranti top della regione che propongono
quanto di meglio offre questa terra. Inoltre, la
Regione, attraverso l’Agenzia TurismoFvg, ha
basato la propria strategia promozionale sullo
slogan: “Ospiti di gente unica” affiancato, per
quanto riguarda il prodotto enogastronomico,
dai claim “Gusti e profumi autentici” e “Sapori
di gente unica”.
Oggi, con lo slogan “Ospiti di gente unica”,
l’esperienza turistica vuole essere diversa non
per i luoghi ma grazie alle persone e al contesto culturale e sociale in cui si approfondisce
l’esperienza turistica. Il fattore umano è l’elemento su cui si è voluta differenziare la regione: un diverso modo di ospitare il turista, fondato sull’autenticità e sulla qualità che sono
alla base della costruzione di un rapporto di
fedeltà con il cliente20.
Nella primavera del 2007, lo scrivente ha
condotto una ricerca su “Le competenze emergenti nel sistema dell’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia”21. Ad un campione regionale
stratificato di 400 residenti è stato chiesto di
valutare complessivamente l’operato di quanti
lavorano nel turismo in regione e di esprimere
un’opinione sul claim “Ospiti di gente unica”
e, in particolare, in cosa la gente di questa regione fosse unica. Nell’insieme, gli operatori
sono stati valutati positivamente. Emerge lo
stereotipo della laboriosità del popolo friulano
ma anche l’affidabilità, l’ospitalità e l’onestà. In
misura minore, gli operatori sono considerati
socievoli, dinamici e cooperativi.
Alla domanda successiva sul significato di
“gente unica”, ha risposto il 74% degli intervistati. I 294 significati attribuiti all’aggettivo
“unica” sono stati raggruppati in sei categorie.
Il 21,4% degli intervistati pensa che la gente
della regione sia troppo legata alla propria terra, alle tradizioni locali e alla lingua. Un’eccessiva attenzione alle tradizioni, agli usi e ai costumi locali, inclusa la lingua friulana, rischia
di far rimanere indietro rispetto ad una realtà,
come quella turistica, sempre più a valenza
20 J. Ejarque et al., Piano di sviluppo turistico del Friuli
Venezia Giulia, Torino, 2005.
21 M. Zago, L’offerta turistica di una regione di frontiera:
movimenti, strategie, professionalità, Dipartimento di
Scienze dell’Uomo, Trieste (in preparazione), 2009.
54
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
internazionale. Gli intervistati, inoltre, sottolineano il carattere introverso e riservato del
friulano e lo descrivono come una persona isolata, rigida, a tratti scontrosa, incapace di dare
confidenza e poco propensa al sorriso.
Il 19% del campione fa emergere la qualità
delle risorse naturali e culturali della regione.
La posizione geografica di frontiera che ne ha
fatto una terra di transito e la varietà morfologica evidenziano i punti di forza del patrimonio ambientale a cui si devono collegare gli
aspetti specificatamente storici che emergono
con forza da ogni angolo umanizzato e quelli
gastronomici. Non secondari sono gli elementi della multiculturalità che arricchiscono il
Friuli Venezia Giulia.
Il 17,3% evidenzia l’operosità e lo spirito imprenditoriale della gente. I numerosi eventi
organizzati in regione - dalle sagre alle mostre
internazionali - confermano di essere in presenza di persone dinamiche e lavoratrici.
Il 17% delle risposte attiene ad aspetti caratteriali positivi di questa “gente unica”. Le persone
vengono identificate come semplici, genuine e
schiette. Persone su cui poter contare per la loro
onestà, serietà e coerenza. Sanno essere socievoli, di compagnia e capaci di godersi la vita.
Il 17% degli intervistati evidenzia l’aspetto
strettamente utilitaristico dello slogan il cui
scopo è esclusivamente di incuriosire e attrarre i turisti. L’aspetto ingannevole viene riscontrato anche nella gestione troppo individualistica e competitiva dei servizi turistici e con
una visione eccessivamente localista.
L’8,2%, infine, non vede aspetti di esclusività né positiva né negativa, ritenendo la gente
della regione “unica” tanto quanto quella di altre regioni italiane.
I promotori istituzionali considerano il
claim efficace. Esso evidenzia una caratteristica importante di questa terra: la capacità di
ospitare il cliente. In questo senso, il claim ha
la duplice valenza di trasmettere un’immagine positiva al di fuori della regione, nei confronti del mercato turistico internazionale, e
di rafforzare un tratto dell’identità. Inoltre, lo
slogan è forte dal punto di vista comunicativo
perché s’imprime facilmente nella memoria.
È evidente che lo stesso crei nel turista delle
Conoscere e ospitare... con più gusto
issn 2035-584x
aspettative che devono trovare adeguate risposte. Attorno a questo slogan si deve così costruire un prodotto migliore e diffondere la cultura
dell’ospitalità attraverso un’attività di formazione che coinvolga, non solo gli operatori, ma
soprattutto la popolazione. Chi è formato nel
settore del turismo comprende chiaramente
l’importanza della cortesia e di un sorriso, ma
il turista si muove in uno spazio in cui vivono persone che non necessariamente lavorano
nel settore. La qualità dell’ospitalità è fatta anche dal residente che deve percepire il turista
come una risorsa. Anche se non c’è una partecipazione diretta nel settore turistico, diverse
possono essere le attività (uffici pubblici, banche, ecc.) e le professionalità (tassisti, benzinai,
negozianti, ecc.) che ne beneficiano. Inoltre, la
creazione dell’ambiente di accoglienza è realizzata dal residente attraverso la cura e l’attenzione che egli manifesta per gli spazi (pulizia
dei cortili e delle piazze, potatura delle piante,
abbellimenti delle abitazioni, ecc.).
In conclusione, come scrive Savelli22, l’unicità di un luogo - e, aggiungerei, della gente dipende «dalle strategie innovative poste in
essere contemporaneamente da residenti, operatori locali, operatori esterni e consumatori
elaborate sulla base di un sistema efficiente
e il più possibile aperto (non esclusivo) di informazione e di comunicazione tra le diverse
tipologie di soggetti». In questo senso, l’unicità diventa qualcosa di costruito assieme e non
qualcosa che viene sbandierata come una caratteristica intima e peculiare della popolazione
regionale che rischia di non trovare effettivo
riscontro nella realtà e di mandare in frantumi
un sogno, quello del viaggio.
Moreno Zago è ricercatore presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Trieste dov’è
titolare dei corsi di Sociologia del Turismo e di
Sociologia del Confine
[email protected]
22 A. Savelli, Mutamenti di significato dei luoghi e degli
sguardi turistici, in R. Bonadei, U. Volli (a cura di), Lo sguardo del turista e il racconto dei luoghi, Milano, 2003, p. 145.
55
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Emergenza comunicazione per gli italiani nel
mondo
Laura Capuzzo
Abstract
Sono varie centinaia le testate italiane all’estero. Sparse
in tutti i continenti. Perlopiù si tratta di giornali,
sorti per rispondere al bisogno degli emigranti di
mantener vivo un legame con il Paese d’origine. Ma
non mancano le radio, le tv e, più recentemente, forme
nuove di comunicazione realizzate attraverso Internet.
I cambiamenti sociali ed economici intervenuti negli
ultimi decenni e l’affermarsi, per quanto lento, di
una nuova visione della presenza italiana nel mondo,
considerata non più come un problema, ma come
una risorsa per il “sistema Italia”, impongono nuovi
compiti ai media italiani all’estero. In particolare, se
vogliono sperimentare il futuro, essi devono riuscire a
farsi interpreti di un’alternativa culturale e porsi come
strumento di rilancio economico. Ne deriva, in questo
momento, un’emergenza comunicazione per gli italiani
nel mondo, che implica da un lato una rivisitazione della
stampa di settore e un potenziamento delle radio e tv
“etniche” e, dall’altro, una loro collaborazione per favorire
Stampa, radio, tv e testate on-line
C
omunicare. Informarsi. Tra gli italiani che
a partire dalla seconda metà dell’800 lasciarono l’Italia per cercar fortuna altrove1, il
bisogno di mantenere vivo un legame con il
Paese d’origine si fece sentire presto e fu motivo della nascita di una miriade di fogli, disseminati nei cinque continenti.
1 A partire dall’unificazione del 1861, l’Italia ha conosciuto un espatrio di poco meno di 30 milioni di persone e conta attualmente, sparsi nei cinque continenti, più di tre milioni di cittadini e più di 60 milioni di
oriundi, a tener conto delle stime che circolano. Cfr. F.
Pittau (a cura di), I flussi migratori degli italiani con l’estero, in Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel mondo
2006, Idos Centro studi e ricerche, Roma, 2006, p. 16.
la conoscenza, in Italia, dell’attività dei connazionali
nel mondo.. A supporto di questa nuova strategia della
comunicazione, servono interventi mirati, che puntino,
ad esempio, ad un forte impiego della tecnologia,
all’avvio di flussi informativi “di ritorno”, in particolare
a livello regionale, allo sviluppo dell’informazione di
carattere economico e soprattutto al coinvolgimento
delle nuove generazioni. Occorre formare i giovani
operatori della comunicazione nell’ottica di un nuovo
rapporto dell’Italia con i suoi connazionali all’estero
e, per fare questo, grande responsabilità spetta alle
Università e alle Scuole di giornalismo.
Parole chiave
comunicazione; informazione;
emigrazione; italiani all’estero;
giornalisti; università; editoria;
media; giovani.
Grandi e piccole, finora trascurate dalla
ricerca accademica, se non per l’aspetto storiografico2, le testate italiane che ancora oggi
escono in giro per il mondo, sono tante. Sup2 Una sintesi degli sviluppi, dalle origini alla crisi del
secondo dopoguerra, della stampa italiana all’estero è
quella di B. Deschamps, Echi d’Italia. La stampa dell’emigrazione, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a
cura di), Storia dell’emigrazione italiana, II, Arrivi, Roma,
2002, pp. 313-334, cui ha fatto seguito più di recente
E. Franzina (a cura di), La stampa italiana nel secondo
dopoguerra, Archivio storico dell’emigrazione italiana 001, Sette Città, 2005, http://www.asei.eu/index.
php?option=com_content&task=view&id=72&Item
id=262; sito consultato il 6/9/2009. In precedenza, un
punto di riferimento per questi studi è stato V. Briani,
La stampa italiana all’estero dalle origini ai nostri giorni,
Poligrafico dello Stato, Roma, 1977.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
56
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
portate (di rado) da una struttura redazionale
oppure (la maggior parte) affidate allo spirito
di intraprendenza del singolo, che è insieme
editore, direttore, redattore e responsabile
amministrativo, hanno soddisfatto, durante il
periodo di inserimento delle collettività italiane nelle società di accoglienza, la loro esigenza
di partecipazione alle vicende italiane e vivono oggi una delicata fase di trasformazione,
determinata sia dai cambiamenti sociali ed
economici intervenuti negli ultimi decenni,
sia dall’avvento delle nuove generazioni3.
Sul loro numero, i dati a disposizione non
sono precisi.
In un’indagine realizzata nei primi anni
Novanta del secolo scorso da Assocamerestero
per conto del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri4, si parla di 392 testate, con prevalenza della carta stampata (213 giornali e
riviste a periodicità variabile, che tirano ogni
anno più di 100 milioni di copie, 150 radio e
29 programmi tv), e di 2.370 dipendenti, di cui
1.318 a tempo pieno.
Una decina d’anni più tardi, nel 2004, la Federazione unitaria della stampa italiana all’estero (FUSIE), in un altro studio condotto per conto del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, riporta a sua volta il dato di quasi 400
testate della stampa italiana edite all’estero, ma
precisa che “altrettanto numerose sono le radio
e le televisioni in lingua italiana che operano
nei Paesi di emigrazione. Circa 50 - aggiunge sono i giornali per l’emigrazione editi in Italia”5
3 Per la stesura di queste pagine ampi stralci e spunti
ho tratto da un’ottima tesi di laurea di cui sono stata
correlatrice (L. Cechet, L’informazione italiana nel mondo
tra stereotipi e innovazione. Analisi di due casi vicini al confine, Istria e Svizzera, tesi di laurea inedita, Università di
Trieste, a.a. 2004-2005, relatore Gianfranco Battisti, correlatrice Laura Capuzzo) e dai materiali (documenti, articoli, relazioni, interventi perlopiù inediti a convegni
di settore ecc.) che in quella circostanza avevo messo a
disposizione della laureanda.
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria, I media della diaspora.
Giornali, radio e televisioni dell’Italia fuori d’Italia, fuori
commercio, [1994?].
5 Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, La comunicazione interculturale. Indagine e riflessioni sulla stampa di immigrazione in Italia e sulla stampa italiana all’estero,
issn 2035-584x
da enti, associazioni, sindacati, patronati.
Nello stesso anno escono i risultati di un
censimento curato da Mediapress srl sui mass
media ed i comunicatori italici6 nel mondo. I
dati rilevati sono stati inseriti in due Annuari7:
— l’Annuario dei mass media italici nel mondo è una mappatura del sistema di comunicazione italico; in esso sono infatti contenute tanto
le testate in lingua italiana o bilingue all’estero
rivolte al pubblico italico, quanto le pubblicazioni edite in Italia ma rivolte comunque alle
comunità italiane che si trovano fuori dei confini nazionali. In 61 nazioni sono stati individuati circa 700 mass media, tra pubblicazioni
cartacee (369), testate on-line (28), newsletter
(70), emittenti radiofoniche (186), stazioni televisive (24). Di essi 128 sono nel Nord America,
214 nell’America Latina, 267 in Europa, 34 in
Oceania, 20 in Asia, 16 in Africa;
— l’Annuario dei comunicatori italici nel mondo, nato come pubblicazione complementare
all’Annuario dei mass media italici nel mondo,
riguarda giornalisti, editori, comunicatori pubblici e pubblicitari di origine italiana che vivono e
lavorano all’estero. La directory dalla quale origina l’Annuario, riunisce i nominativi di circa 1.440
comunicatori provenienti da 50 diversi Paesi.
I due Annuari hanno fornito il materiale di
base di due banche dati presenti dal 2007 nel
sito del Ministero degli Affari esteri8, in base
ad un protocollo d’intesa stipulato con l’Ordine nazionale dei giornalisti:
Roma 25 marzo 2004, fuori commercio, parte seconda,
p. 5. In Italia ha sede anche quella manciata di agenzie di
stampa (una decina, più o meno) specializzate nel campo dell’emigrazione, che garantiscono con regolarità a
giornali, radio e tv i materiali informativi di base.
6 Il termine “italico” fa riferimento alla definizione introdotta da Piero Bassetti, presidente dell’Associazione
“Globus et Locus”, per indicare non solo la comunità di
italiani d’origine e di oriundi, ma anche gli italofoni, gli
italofili e tutti coloro che, anche senza sangue italiano
nelle vene, hanno abbracciato valori, stili di vita e modelli dell’Italian way of life. V. http://www.globusetlocus.org/it/italici ; sito consultato il 20/9/2009.
7 Esiste una versione cartacea degli Annuari, uscita nel
2004, ed una versione on-line diffusa attraverso il portale Media & Comunicatori Italici (www.mediaecomunicatoriitalici.net ).
8 www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/
Pubblicazioni/ ; sito consultato l’11/9/2009.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
57
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
— nel link “L’Italia dell’informazione nel
mondo” sono presenti oggi 814 media in lingua italiana diffusi nel mondo (stampa 494,
radio 274, tv 46);
— nel link “Comunicatori italiani nel mondo”
quasi mille operatori della comunicazione italiani e di origine italiana operanti all’estero.
Ridotto è il numero dei quotidiani. “America
Oggi”, il tabloid fondato da Andrea Mantineo
per gli italiani della East Coast statunitense,
esce a New York. Ad esso si aggiungono “La Voce
issn 2035-584x
del Popolo” a Fiume, il “Corriere canadese” a
Toronto, “Il Globo” a Melbourne e “La Fiamma”
a Sydney. E’ diventata quotidiano dal 2002 anche “La Voce d’Italia” di Caracas, fondata come
settimanale da Gaetano Bafile. Nel 1999 è nato
“Gente d’Italia” diretto da Mimmo Porpiglia,
che dopo un’iniziale diffusione a New York e
Miami, è ‘sbarcato’ anche a Montevideo.
Più dell’80% dei giornali italiani all’estero
appartiene a proprietari-editori privati. Poi ci
sono i giornali cattolici, soprattutto quelli sca-
(Fonte: MediaPress srl; questo grafico non tiene conto dell’editoria per gli italici prodotta in Italia e in San Marino e distribuita nel mondo)
(Fonte: MediaPress srl)
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
58
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
(Fonte: MediaPress srl)
(Fonte: MediaPress srl)
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
59
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
(Fonte: MediaPress srl)
(Fonte: MediaPress srl)
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
60
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
(Fonte: MediaPress srl)
(Fonte: MediaPress srl)
(Fonte: MediaPress srl)
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
61
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
(Fonte: MediaPress srl)
(Fonte: MediaPress srl)
labriniani; una piccola fetta è riservata infine
alle Camere di Commercio italiane all’estero.
Nonostante la lontananza geografica che separa i vari luoghi di edizione, questi periodici
presentano caratteristiche comuni facilmente
enucleabili: il formato più diffuso è il tabloid;
quanto alla scelta delle notizie, poi, si tratta di
prodotti del tutto differenti rispetto ai giornali nazionali. Le vicende politiche italiane interessano quando ci sono notizie “di sostanza”:
la riforma del sistema previdenziale o le novità dell’ultima legge finanziaria sì, i battibecchi,
le polemiche a distanza, il gossip parlamentare no. Bandita la cronaca nera, a meno che non
si tratti di fatti davvero eclatanti: terremoti, alluvioni, rapimenti ed attentati eccellenti fanno notizia anche oltreoceano, l’uxoricidio o il
colpo in banca no. Una attenzione particolare
è dedicata all’informazione regionale: spesso
l’italiano all’estero ha mantenuto un legame
fortissimo con la sua città o paese, ed è interessato a ricordarne le tradizioni, gli avvenimenti
culturali, le bellezze naturali ed artistiche. In
generale destano un grande interesse tutte le
notizie sull’ “italian way of life” e sul “made in
Italy”: design e arte, cucina e moda italiani sono
diventati fenomeni di tendenza ed esercitano
una potente attrattiva nei confronti delle gio-
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
62
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
vani generazioni di oriundi. Vi sono poi tutte
le informazioni specifiche del settore: dalle
novità sul voto all’estero alle leggi regionali
per l’emigrazione, dai convegni alle mostre sul
tema, un fronte di notizie molto più vasto di
quanto non si possa sospettare sfogliando un
qualsiasi giornale italiano “d’Italia”.
Importantissimo, infine, il capitolo dello
sport: sono molto richieste le notizie ed i commenti sul campionato di serie A, ma anche su
quelli minori, per non parlare delle imprese sportive della Ferrari. In linea di massima
questo schema è valido anche per i pochissimi quotidiani italiani all’estero, considerando
però le differenze dovute alla periodicità della
pubblicazione9.
Società e informazione: cambiamenti e
nuove esigenze
«L’italiano non era lettore di carta stampata in patria, ma lo è diventato attraversando il
mare», scrisse monsignor Alberto Giovannetti, osservatore permanente della Santa Sede
all’Onu dal 1964, autore del saggio su “L’America degli italiani”10.
I giornali italiani all’estero hanno innanzi
tutto soddisfatto il bisogno degli emigrati di
mantener vivo il senso di appartenenza all’Italia, a quel Paese lasciato spesso per necessità,
ma mai abbandonato completamente. Senza
questi giornali, senza informazione, le comunità all’estero non avrebbero avuto una voce,
una identità11.
9 Editoria italiana nel mondo: il ruolo delle agenzie di stampa specializzate, intervento letto da Roberto Secci (Grtv) a
nome delle agenzie di emigrazione al quarto Congresso
mondiale della Fusie, Catania 25-28 aprile 2005, in “Italia
Estera” 3/5/2005, http://www.italiaestera.net/modules.
php?name=News&file=print&sid=2061; sito consultato
il 20/9/2009.
10 Ibidem.
11 La nostra identità si intitolava l’editoriale di Mario
Basti, uscito nel 1977 sul primo numero di “Tribuna
Italiana”, settimanale di Buenos Aires. Trent’anni dopo,
il figlio del fondatore, Marco Basti, ha riproposto lo stesso titolo per l’editoriale con cui ha celebrato l’anniversario. L’articolo è presente nella rivista on line ”Visioni
Latino Americane” del Centro Studi America Latina
dell’Università di Trieste http://www2.units.it/~csal/
home/?file=contributo_basti.htm; cfr. anche F. Lazzari,
issn 2035-584x
«Nel corso della storia - ricorda Bénédicte Deschamps - i periodici in lingua italiana
pubblicati fuori della penisola assunsero molteplici ruoli. Paladina del mantenimento della
lingua madre, guardiana del legame affettivo
che unisce ogni emigrante alle proprie radici,
cemento della comunità, portavoce delle rivendicazioni degli italiani e specchio dei loro
problemi, spazio di ricostruzione dell’identità
etnica, intermediaria tra le autorità italiane e
il governo dei Paesi di adozione, promotrice
dell’economia comunitaria, tribuna di libera
espressione in tempi di oppressione, interprete della realtà locale, educatrice politica, organizzatrice sindacale, traghettatrice tra due
sponde culturali, la stampa italiana all’estero
svolse, malgrado i suoi limiti e le sue contraddizioni, ognuna di queste funzioni, anche se
non necessariamente allo stesso tempo»12.
Nell’ultimo dopoguerra, però, vennero rapidamente meno alcune condizioni di fondo
che avevano consentito la grande espansione
fra Otto e Novecento di un tipo di comunicazione e di collegamento congeniale ai bisogni
della maggior parte degli “antichi” emigrati13.
Dopo il 1945 si assiste ad un declino quantitativo e qualitativo del fenomeno, nonostante
la ripresa delle correnti di espatrio, interrotte
per oltre vent’anni dalla chiusura degli sbocchi
emigratori e dal divampare del secondo conflitto mondiale. Sulla scena, inoltre, compaiono radio e televisioni e il computer apre alla
comunicazione orizzonti insperati.
L’Italia d’oggi non è più quella di un tempo.
Ed anche la presenza italiana all’estero è cambiata. Quella che è stata una sorta di vergogna
nazionale su cui per molto tempo è calato il silenzio, un “ottuso e indecente silenzio” lo definisce Gian Antonio Stella14, o di cui si parlava
L’attore sociale tra appartenenza e mobilità. Analisi comparate e proposte socio-educative, Cedam, Padova, 2000.
12 ��������������
B. Deschamps, Op. cit., pp. 333-334.
13 E. Franzina, La stampa italiana nel secondo dopoguerra, Asei 001, 2005. http://www.asei.eu/index.
php?option=com_content&task=view&id=72&Itemi
d=262 ; sito consultato il 6/9/2009.
14 G. A. Stella, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi,
2002, Rizzoli, p. 9. «La feccia del pianeta, questo eravamo.
Meglio: così eravamo visti», ricorda Stella. «Non potevamo mandare i figli - racconta - alle scuole dei bianchi
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
63
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
malvolentieri, nel giro di tre o quattro generazioni è stata vista in una maniera nuova e positiva. I discendenti di quegli emigrati si sono
trasformati pressoché in ogni parte del mondo in cui hanno messo radici, in protagonisti
e vengono additati come modelli di integrazione riuscita. Oggi il numero di italiani che
lasciano il proprio Paese per trasferirsi all’estero, si è fortemente ridotto, anche se non si è
completamente esaurito. Ciò che è mutato, è la
qualifica professionale degli emigranti.
Negli ultimi quindici/venti anni l’emigrazione italiana ha cambiato aspetto, tanto da
rendere non più appropriato il termine “emigrato” per indicare l’italiano che ha scelto (e
non è stato costretto) di cercare fortuna fuori
dai confini nazionali. Si tratta di persone che
hanno sostituito la vecchia valigia di cartone
con la ventiquattrore, spinte non dalla necessità di trovare un’occupazione, ma dalle opportunità offerte da un mondo globalizzato.
Sono tecnici, ingegneri, medici, artisti, scienziati che guardano al mercato. E che il mercato
mondiale cerca anche per l’immagine positiva
che i loro predecessori più sfortunati hanno saputo costruire in decenni di lavoro all’estero15 .
Tantissimi sono anche i giovani che passano
fuori dall’Italia periodi mediamente lunghi
per studiare e specializzarsi, maturando così
un’esperienza a contatto con due sistemi e
due stili di vita diversi.
L’emigrazione italiana ha cominciato a non
porsi quindi più come un problema. «Fino
a poco tempo fa – sottolinea padre Graziano
in Louisiana. Ci era vietato l’accesso alle sale d’aspetto
di terza classe alla stazione di Basilea. Venivamo martellati da campagne di stampa indecenti contro “questa
maledetta razza di assassini”. Cercavamo casa schiacciati
dalla fama d’essere “sporchi come maiali”. Dovevamo tenere nascosti i bambini come Anna Frank perché non ci
era permesso portarceli dietro. Eravamo emarginati dai
preti dei Paesi d’adozione come cattolici primitivi e un po’
pagani. Ci appendevano alle forche nei pubblici linciaggi
perché facevamo i crumiri o semplicemente perché eravamo “tutti siciliani”. “Bel paese, brutta gente”. Ce lo siamo tirati dietro per un pezzo, questo modo di dire diffuso in tutta l’Europa e scelto dallo scrittore Claus Gatterer
come titolo di un romanzo in cui racconta la diffidenza e
l’ostilità dei sud-tirolesi verso gli italiani» (p. 7).
15 R. Romoli Venturi, Italia Nazione Globale. Riflessioni in
libertà sull’essere italiani nel XXI secolo, Roma, 2003, p. 58.
issn 2035-584x
Tassello – esisteva un certo pudore da parte
dell’emigrato a pubblicizzare la sua storia ed i
suoi mutamenti. La comunicazione di notizie
si esauriva all’interno di un preciso sistema
parentale, unico legame che sembrava durare
nel tempo. Di recente, tuttavia, si registrano
segnali di un mutamento di atteggiamento.
Persone, considerate portatrici di “problemi”
e che costituivano un “problema” per l’Italia e
per le autorità consolari e nei cui confronti venivano proposti dei sussidi, sono state improvvisamente valutate come una grande risorsa
economica e politica a disposizione dell’Italia,
una media potenza che intende giocare, anche
attraverso i suoi “figli all’estero”, un ruolo più
aggressivo in campo internazionale»16.
Di fronte ai mutamenti che hanno attraversato l’Italia e il mondo dell’emigrazione
italiana, diventa inevitabile anche per i media
italiani all’estero un cambiamento di ruolo.
È convinzione diffusa che essi potranno continuare a essere importanti strumenti della
comunicazione a condizione che sappiano
rinnovarsi. A condizione che sappiano farsi interpreti, in un mondo come quello attuale che
tende sempre più all’omogeneizzazione, di
un’alternativa culturale e sappiano porsi come
strumento di sviluppo economico.
Questo nuovo ruolo, però, va costruito. Partendo da alcuni dati di fatto, purtroppo di per
sé negativi: innanzi tutto, la scarsa conoscenza
in Italia del fenomeno, che porta molto spesso a liquidare l’informazione italiana all’estero come un prodotto destinato ad una cerchia
talmente ristretta di utenti da non meritare attenzione; in secondo luogo, la scarsa consapevolezza da parte dei giornalisti italiani all’estero di poter ricoprire quel ruolo, dal momento
che manca molto spesso un’adeguata qualificazione e men che meno una qualche forma di
riconoscimento professionale17.
16 G. G. Tassello, Il diritto ad essere conosciuti, il dovere di
conoscere, in L. Capuzzo (a cura di), La diaspora negata.
Italiani all’estero e informazione nel Friuli-Venezia Giulia,
Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, 2000,
fuori commercio, p. 102.
17 L. Capuzzo, Introduzione al convegno “Italia-Brasile.
Informazione in viaggio - Primo congresso dei giornalisti italiani, italo-brasiliani e brasiliani”, San Paolo, 1718 giugno 2003.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
64
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Già nel 1996, nel corso della Conferenza mondiale per una politica dell’informazione italiana
all’estero, l’allora presidente del CNEL, Giuseppe De Rita, invitava a «ragionare in termini di
offerta di un tipo di informazione che non sia
soltanto delegata a coloro i quali confermano
la dimensione etnica regionale o patriotticonazionale. Altrimenti l’informazione italiana
all’estero – avvertiva – sarebbe destinata al residuo, a morire poco a poco, con la derubricazione
del suo messaggio all’italianità stereotipata»18.
Le premesse per un’inversione di tendenza, in altre parole, stanno maturando, legate
in primo luogo al cambiamento di ottica con
cui si guarda, o, meglio, si dovrebbe guardare
agli italiani nel mondo: non più un fenomeno
patetico, segno dell’inadeguatezza di una società a rispondere ai bisogni dei suoi cittadini,
ma una risorsa, «il nostro maggior strumento
di internazionalizzazione ed il nostro maggior fattore di potenza internazionale», come
scriveva lo stesso De Rita in un memorabile
articolo apparso sul “Corriere della Sera”19. Di
conseguenza, al compito unanimamente riconosciuto ai media italiani all’estero, di mantenere informata l’”altra Italia” su quanto accade
nella Penisola, se ne aggiungono altri.
Per esempio, dopo l’approvazione da parte
del Parlamento italiano della legge n. 459 del 27
dicembre 2001 che riconosce il diritto di voto ai
cittadini italiani residenti all’estero, il problema
dell’informazione in occasione di consultazioni
elettorali è divenuto di grande attualità.
«L’elezione di 18 rappresentanti diretti
delle nostre collettività nel Parlamento italiano - rilevava Bruno Zoratto, che fino al 2004,
anno della sua prematura scomparsa, è stato
presidente della Commissione Informazione
del Consiglio generale degli italiani all’estero
- oltre a porre fine ad una assurda discriminazione, inserisce a pieno titolo nel “sistema Italia” milioni di cittadini italiani che risiedono
all’estero, finora abbandonati e misconosciuti.
Questo fatto destabilizzante, oltre a squinternare le logiche antiche e perverse, permette18 Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, La comunicazione interculturale cit., parte seconda, p. 9.
19 G. De Rita, La grande carta degli emigranti, in “Il
Corriere della Sera”, 10 novembre 1993.
issn 2035-584x
rà obbligatoriamente un approccio nuovo al
problema della informazione e della comunicazione degli italiani nel mondo. Se prima era
un optional, ora vi è un obbligo istituzionale di
informare adeguatamente le nostre collettività. La legge ordinaria sull’esercizio del voto
all’estero, tra l’altro, contempla non a caso dei
riferimenti obbligatori alla informazione e alla
comunicazione delle nostre comunità20».
Per gli italiani nel mondo c’è dunque in questo momento un’emergenza comunicazione,
che implica da un lato una rivisitazione della
stampa di settore e un potenziamento delle
radio e tv “etniche” e, dall’altro, una loro collaborazione per favorire la conoscenza, in Italia,
della presenza italiana nel mondo.
Per raggiungere lo scopo, servono interventi mirati, a cominciare da un progetto politico
organico in questo senso21 e da una revisione
della normativa statale riguardante l’assegnazione dei contributi22.
20 B. Zoratto, Relazione alla Conferenza Stato-RegioniProvince autonome-Cgie, Roma, 11-12 febbraio 2002,
http://www.italiamiga.com.br/noticias/artigos/relazione_di_bruno_zoratto_alla_.htm; sito consultato il
14/9/2009.
21 «L’Italia non dimentichi l’”altra Italia”», invoca padre Luciano Segafreddo, direttore del “Messaggero di
Sant’Antonio”, nel suo editoriale sul numero di ottobre 2009, anticipato dalle agenzie (http://www.mclink.
it/com/inform/art/09n17220.htm; sito consultato il
22/9/2009). Secondo Segafreddo, «si attende un progetto politico in grado di assicurare risorse e porre nuovi obiettivi al ruolo delle sedi consolari, degli istituti di
cultura e di altre realtà come i patronati, le associazioni
e gli organi di informazione. Realtà che possono concorrere al recupero del senso di “cittadinanza attiva” dei nostri connazionali e del senso di appartenenza affettiva e
culturale degli oriundi e di tanti italofili. Un progetto
politico che darebbe credibilità alle istituzioni governative e parlamentari italiane e una risposta alle attese dei
nostri connazionali e dei loro discendenti».
22 L’argomento è stato affrontato dal presidente della
FUSIE, Domenico De Sossi, nell’audizione dell’1 luglio
2009 davanti al Comitato per le questioni degli italiani
all’estero del Senato. Dopo aver ribadito l’importanza di
una «uniformità di trattamento normativo tra stampa
nazionale e quella edita all’estero», De Sossi ha sostenuto che «oggi più che mai serve un intervento normativo
di riassetto della disciplina della stampa italiana all’estero, poiché essa attualmente riguarda solamente la carta
stampata e non i nuovi media, assegna fondi di entità
insufficiente [circa 2 milioni di euro l’anno, N.d.A.] e presenta lacune che ne rendono talvolta incerti i margini ap-
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
65
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Nel corso del convegno sull’informazione
svoltosi a Roma nel dicembre 2000, nell’am
bito della Prima Conferenza degli italiani nel
mondo, si erano studiati i modi per dar luogo
a nuove forme di comunicazione con i connazionali d’oltreconfine, visti come una risorsa
per l’informazione. Nella relazione introduttiva che io stessa avevo presentato, invitavo
a riflettere sulla «necessità di chi opera nel
campo dell’informazione italiana, di sprovincializzarsi, di aprirsi al confronto con culture e
stili professionali diversi, di inserirsi nei processi di globalizzazione. Per contro, si consideri - continuavo - la “fame” di notizie sull’Italia
che caratterizza non solo le nostre comunità
all’estero, ma anche, per determinati settori, il
più vasto pubblico straniero. Riuscire ad avviare iniziative attraverso le quali far entrare nei
giornali italiani la realtà dei nostri connazionali all’estero e arricchire le testate straniere di
informazioni sull’Italia - concludevo - significa
proiettare il discorso in una dimensione mondiale, con positive ricadute sul sistema Italia
nel suo complesso, e allargare le prospettive
professionali sia per i giornalisti italiani che
per quelli italiani all’estero»23.
Da queste considerazioni deriva l’urgenza
di mettere in atto una strategia informativa
che poggi su quattro linee di forza, l’una intimamente connessa con l’altra. Tali linee consistono nel ricorso ad un forte impiego della
tecnologia, nell’avvio di flussi informativi
“di ritorno”, soprattutto a livello regionale, nella grande attenzione da riservare per
l’informazione di carattere economico e nel
contributo delle giovani generazioni.
L’uso della tecnologia
Un prodotto dei tempi moderni in fulmiplicativi». V. http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/
frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id e http://
www.italiachiamaitalia.net/print.php?a=16399;
siti
consultati il 22/9/2009. I finanziamenti alla stampa italiana all’estero sono regolati sulla base della legge 416 del
1981 sull’editoria e successive modificazioni.
23 Ministero degli Affari Esteri, Prima Conferenza
degli italiani nel mondo, Atti del Convegno Italiani nel
mondo: una risorsa per l’informazione, Roma 13 dicembre
2000, intervento di L. Capuzzo, Roma, 2001, p. 32.
issn 2035-584x
nea evoluzione, di cui, senz’altro, va incentivato l’uso, è la tecnologia.
Da quando, nel 1993, Internet è esploso24, il
mondo della Rete è diventato a tutti gli effetti
parte integrante della comunicazione, un importantissimo vettore di diffusione di notizie,
destinato ad avere un impatto eguale o superiore a quelli del telegrafo e del telefono. Per
gli italiani all’estero, in particolare, la presenza
e le potenzialità di questo nuovo strumento
hanno significato un balzo in avanti considerevole e inaspettato sia dei rapporti tra le comunità dei diversi Paesi che delle loro relazioni con l’Italia.
Annullando le dimensioni di tempo e spazio, le nuove tecnologie hanno introdotto una
grande novità rispetto al passato, rendendo
più facile il dialogo, lo scambio di informazioni a distanza. Per gli italiani nel mondo, di
colpo sono cadute quelle barriere spazio-temporali e quei condizionamenti che per decenni
avevano ostacolato la comunicazione, e si sono
dischiuse opportunità insperate.
24 La prima pubblicazione in cui si teorizza una rete di
computer mondiale ad accesso pubblico è On-line man
computer communication dell’agosto 1962, pubblicazione scientifica degli statunitensi Joseph C.R. Licklider e
Welden E. Clark. Nella pubblicazione Licklider e Clark,
ricercatori del Massachusetts Institute of Technology,
danno anche un nome alla rete da loro teorizzata:
“Intergalactic Computer Network”. Ma prima che tutto
ciò diventi una realtà è necessario attendere fino al 1991
quando il governo degli Stati Uniti d’America emana la
High performance computing act, la legge con cui per la
prima volta viene prevista la possibilità di ampliare, ad
opera dell’iniziativa privata e con finalità di sfruttamento commerciale, una Internet fino a quel momento rete
di computer mondiale di proprietà statale e destinata al
mondo scientifico. Sfruttamento commerciale che subito viene messo in atto anche dagli altri Paesi. Nel 1993 il
CERN, l’istituzione europea dove nasce il World Wide
Web, decide di rendere pubblica la tecnologia alla base
del World Wide Web in modo che sia liberamente implementabile da chiunque. A questa decisione fa seguito un immediato e ampio successo del World Wide Web
in ragione delle funzionalità offerte, della sua efficienza
e, non ultima, della sua facilità di utilizzo. Da tale successo ha inizio la crescita esponenziale di Internet che
in pochissimi anni porterà la rete delle reti a cambiare
per sempre la società umana rivoluzionando il modo di
relazionarsi delle persone come quello di lavorare tanto
che nel 1998 si arriverà a parlare di “nuova economia”.
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Internet; sito consultato il 20/9/2009.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
66
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Vari e per tanti versi ancora inesplorati
sono i modi in cui Internet e, più in generale,
l’Information and communication technology
(Ict) sta modificando la comunicazione e gli
stili di vita, di chi sta in Italia o in qualsiasi altra
parte del mondo, indifferentemente. E’ in corso quella che Giovanni Giovannini ha definito
la “Grande Mutazione”25, paragonabile a pochi
altri eventi nella storia dell’umanità: alla nascita della scrittura (per rimanere nel campo della comunicazione) cinquemila anni addietro,
o all’invenzione gutenberghiana della stampa
a caratteri mobili della metà del Quattrocento.
Il travolgente, continuo incalzare dell’innovazione nell’information technology permette
sempre di più ad ogni essere umano di essere
vicino nei tempi e nei modi ad un altro essere
umano, a dispetto della lontananza fisica che
li separa, facendo sempre più diventare tutti
cittadini nel villaggio globale: Weltburger, cittadini del mondo.
Non è di poco conto che oggi, grazie alle
nuove tecnologie, una persona che si trasferisce all’estero, non subisca più un black out
forzato di notizie in tempo reale dalla sua comunità d’origine. In questi ultimi anni, infatti, i giornali raggiungibili su Internet hanno
un rapporto diretto con gli italiani residenti
all’estero, che partecipano in pieno alla Grande Mutazione e possono addirittura leggere
un quotidiano prima dei compatrioti, se si calcolano le differenze di fuso orario fra un continente e l’altro. E’ un settore, questo delle news
on line, che in Italia è in forte sviluppo e vede
impegnati tutti i grandi gruppi editoriali.
Con il passar del tempo, sono sorte molte
webzine, pubblicazioni solo on line dedicate
specificatamente al mondo dell’emigrazione e quindi spesso consultabili sia in italiano
che nella lingua del Paese in cui vengono create. Anche la televisione, la radio, le agenzie di
stampa si sono trasferite sul Web, coltivando
nuove nicchie di mercato e contribuendo a sviluppare una nuova architettura di rapporti fra
le diverse comunità sparse per il mondo, ma
legate da radici e cultura simili. Sono così nate
web-radio, web-tv, newsletter, portali, blog,
25 G. Giovannini, La “mutazione” tecnologica, in L.
Capuzzo (a cura di), La diaspora negata cit., pp. 72-75.
issn 2035-584x
tutti prodotti in costante crescita, anche se, al
di là delle visioni più ottimistiche, rimane comunque opinione comune il fatto che i portali
ed i canali d’informazione italiani che guardano all’Italia al di fuori dei confini nazionali,
abbiano ancora molta strada da fare prima di
riuscir a promuovere, con costanza ed impegno, il nuovo volto dell’emigrazione italiana
all’estero.
A ciò vanno aggiunte le modalità di comunicazione informatizzata utilizzate dalle istituzioni italiane, come il Ministero degli Esteri,
che ha creato “In rete con l’Italia”, una newsletter rivolta agli italiani all’estero, il Ministero
dell’Interno, che riporta i dati delle Anagrafi
degli italiani residenti all’estero (Aire), la Rete
internazionale della pubblica amministrazione, promossa dal Ministero per l’Innovazione
e le tecnologie e dal Ministero degli Esteri per
estendere agli uffici esteri il Sistema pubblico
di connettività, la Rete delle Camere di commercio italiane all’estero.
I cambiamenti innescati dallo sviluppo
dell’Ict, però, sembra non coinvolgano solo
l’area della produzione, ma stiano toccando in
maniera profonda - come osserva Maddalena
Tirabassi26 - sia l’agenda degli studi sull’emigrazione italiana, sia gli esiti del fenomeno
migratorio. A proposito della ricerca, il Web
fornisce un facile accesso alle fonti mondiali,
dalle più tradizionali a quelle più innovative,
elemento essenziale per una storia interdisciplinare e intrinsecamente transnazionale
come quella dell’emigrazione. Favorisce e accelera il dialogo tra gli studiosi, consentendo
un aggiornamento continuo sui progressi della ricerca nel settore su scala mondiale.
Il Web è anche riuscito a dare visibilità agli
italiani che attraverso i secoli si sono dispersi nel mondo. Sul Web gli italiani emigrati si
contano, si vedono attraverso le fotografie, i
percorsi museali, i film, si ascoltano nei siti di
dibattito e attraverso la musica.
Ma al di là di tutti questi aspetti abbastanza
26 Nel saggio Gli italiani sul Web, in P. Bevilacqua, A. De
Clementi, E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione
italiana, Arrivi, cit., pp. 717-738, M. Tirabassi presenta i
primi risultati di una interessante ricerca avviata nel
1996 dalla Fondazione Giovanni Agnelli sui siti utili per
lo studio dell’emigrazione italiana.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
67
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
ovvii, ciò che colpisce è l’influenza che le nuove
opportunità create dall’Ict esercitano sulla presa
di coscienza etnica. In un’epoca di identità deterritorializzate, sempre meno legate a luoghi fisici,
l’identità della diaspora italiana muta e si rafforza
attraverso le nuove opportunità, offerte dal Web,
di stabilire contatti rapidi e diretti e con il Paese
d’origine e con gli altri membri della diaspora. In
altre parole, Internet non è semplicemente una
forma di accesso a informazioni su un soggetto
dato, ma è una forza che concorre a ridefinire in
profondità il soggetto stesso.
Come conferma Robin Cohen, uno dei principali studiosi dei fenomeni delle diaspore,
«in epoca di globalizzazione i moderni mezzi
di trasporto, comunicazione e di trasmissione culturale fanno sì che il mantenimento di
lingua […] legami familiari e di rapporti commerciali e politici tra comunità sparse in Paesi
diversi sia facile come non è mai stato»27.
Ancorché l’affermazione di Cohen sia riferita alle diaspore in generale, essa si adatta
particolarmente bene all’esperienza degli italiani nel mondo. Gli italiani che non avevano
mai completamente interrotto i legami con le
comunità d’origine, oggi sembrano avvalersi appieno delle nuove risorse. Hanno inoltre
colto l’opportunità di estendere quei legami
attraverso nuove reti: i forum di discussione
che consentono il dialogo con i membri della
diaspora italiana nel mondo, bypassando anche il Paese d’origine, mentre è ancora tutta
da verificare la loro presenza sulle piattaforme
di social network28, recentissima ma probabilmente non ultima innovazione tecnologica
dove si intrecciano sentimenti di appartenenza e scambi di dati, suscitando nuovi tipi di
emozioni, nuovi generi di rapporti.
Dimensione regionale e informazione
“di ritorno”
Un secondo elemento da tener presente, è
��������������
R. Cohen, Rethinking «Babylon»: Iconoclastic Conceptions
of the Diasporic Experience, in «New Community», XXI,
1995, 1, pp. 5-18.
28 Un’approfondita disamina sul fenomeno dei social
network in senso generale, è presente nel numero
speciale Social network, cultura come valore della rivista
“Media Duemila”, n. 268, settembre 2009.
issn 2035-584x
il valore della dimensione regionale dell’informazione, non certo intesa in un’accezione
folcloristica e nostalgica, ma come condizione
per accrescere i flussi informativi verso l’estero, e soprattutto per introdurre nei giornali
locali italiani un’informazione regolare, costante, non episodica, circa i corregionali che
stanno fuori Italia.
L’obiettivo da perseguire è un salto di qualità dell’informazione verso quello che è stato
definito, con brutta parola, il glocal, in cui tutto
è globale e anche, allo stesso tempo, locale. Un
salto di qualità non facile che, nel rispetto delle diversità regionali, porti a reinterpretarle,
agganciandole a un contesto più ampio, universale, anziché a ridurle a espressione di un
localismo fine a se stesso.
La regionalità, in altre parole, è un patrimonio ad alto valore aggiunto, una risorsa
culturale decisiva che, attraverso i corregionali all’estero, vive nel mondo e che, collegata
all’attualità, deve essere messa in rete con la
realtà che sta all’interno dei confini nazionali. In questo quadro si inserisce un’altra constatazione: l’orgogliosa difesa di un’identità
regionale di origine, che caratterizza il mondo italiano all’estero e che ben si sposa con la
tendenza, emergente in questi ultimi anni in
Italia, a valorizzare le peculiarità del territorio,
in un’ottica di agire sul locale, ma ragionando
sul globale.
Qui il discorso si intreccia inevitabilmente con la richiesta, emersa in più occasioni
negli ambienti degli italiani all’estero, della
cosiddetta “informazione di ritorno”, con
ciò intendendo un’informazione sulla vita
politica, sociale, culturale ed economica delle collettività italiane all’estero, avente lo
scopo, tra gli altri, di far uscire dai luoghi comuni l’immagine che degli italiani all’estero
si ha in Italia.
Nei vari convegni ed incontri sui temi
dell’emigrazione si è parlato spesso di un’informazione di ritorno integrata nella normale
programmazione della stampa quotidiana e
periodica e della testate radiofoniche e televisive, ritenuta molto utile perché tratta tematiche alle quali l’Italia, Paese di recente immigrazione, si sta affacciando solo ora.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
68
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Finora, però, l’informazione di ritorno è rimasta confinata in Italia a oggetto di dibattito,
«vissuta - diceva Niccolò D’Aquino29 - come
qualcosa a metà tra l’oggetto misterioso e, nel
migliore dei casi, l’oggetto dei desideri»: sui
quotidiani ci sono pochissimi articoli dedicati
agli italiani nel mondo, in radio ed in tv si sente raramente parlare di loro30.
Al momento attuale gli italiani all’estero che
sembrano interessare i connazionali in patria
o, quantomeno, i media italiani, sono soltanto
quelli che hanno avuto successo. L’unica e rara
informazione di ritorno, che qualche volta
compare sui mezzi di informazione italiani, è
quella che racconta le vicende, di solito travagliate, di connazionali che ad un certo punto,
in virtù dei loro sacrifici e delle loro capacità,
sono riusciti ad affermarsi e di ciò vanno giustamente orgogliosi. Ma c’è anche un’altra presenza italiana all’estero, molto più articolata
e complessa, che dovrebbe venir conosciuta
ed invece non trova spazio nei circuiti dell’informazione italiana, perché molto spesso ci si
trincera dietro la considerazione che gli italiani all’estero non fanno notizia, a meno che
non si rendano protagonisti di episodi di cronaca nera, ed allora non vale neanche la pena
di perdere tempo su tale tematica.31.
29 N. D’Aquino, Informazione di ritorno tra business e regionalità, intervento al convegno “Informazione e business, strumenti per valorizzare l’identità di origine nella nuova Europa: il caso Italia-Germania”, Francoforte
sul Meno, 6 giugno 2002.
30 Un caso a sé è stato quello del sen. Luigi Pallaro, eletto in Sud America come indipendente nella tornata elettorale del 9 e 10 aprile 2006 e diventato l’ago della bilancia al Senato per garantire al centrosinistra di Romano
Prodi la possibilità di governare. L’episodio che ha visto
protagonista il senatore italo-argentino, per quanto inserito in un evento storico come la prima votazione per
corrispondenza degli italiani all’estero, è stato trattato
dalla stampa italiana esclusivamente per la sua valenza
politica, non sembra aver avuto un effetto di trascinamento, non sembra cioè aver determinato nel mondo
dell’informazione italiana un’apertura di interesse
verso tematiche sempre trascurate, come gli italiani
all’estero e l’America Latina. Una volta conclusa quella
vicenda, tutto è rientrato nei soliti binari.
31 L. Capuzzo, Linee guida per un’efficace informazione da
e per i corregionali nel mondo, intervento nell’ambito di
“Friuli-Venezia Giulia nel mondo”, Trieste, 24 novembre
2003.
issn 2035-584x
Il Consiglio generale degli italiani all’estero
e la FUSIE hanno più volte posto l’accento su
questa situazione, sollecitando le istituzioni,
il Parlamento, il Governo, le Regioni a porsi
realisticamente di fronte al problema della
informazione e della comunicazione in modo
moderno ed adeguato, «superando il concetto
unidirezionale dell’informazione tendente a
favorire esclusivamente chi si informa di quello che succede in Italia, puntando anche ad una
informazione di carattere bidirezionale, se
non addirittura, come qualche addetto ai lavori ha dichiarato, grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie, circolare»32.
E’ assolutamente necessario rendere appetibile al mondo dei media italiani il “sistema
emigrazione”, non guardando al passato ma
seguendo l’evoluzione in corso, non cavalcando la nostalgia ma aprendo gli occhi sul nuovo
che avanza e che molte volte, in questo campo,
può offrire spunti anche per capire altri fenomeni contemporanei, come quello dell’immigrazione, e costringendo così la società italiana ad un esercizio complesso, ma civilmente
utile, qual è quello dell’educazione alla multiculturalità, al rispetto delle singole identità
culturali e linguistiche.
Un tentativo per comprendere meglio i contorni del fenomeno, ivi compresa l’eventuale
spendibilità di un’informazione di ritorno, è
stato fatto nel 1997 dall’Ordine dei giornalisti
del Friuli Venezia Giulia, che ha commissionato alla SWG un sondaggio su un campione
di 58 giornalisti pubblicisti e professionisti e
500 residenti in Regione33. Lo studio ha messo in rilievo come lo spazio attuale nell’informazione regionale occupato dal tema “italiani
all’estero” sia piuttosto modesto. Inoltre non
sembra che le comunità di emigrati del Friuli
Venezia Giulia suscitino particolare interesse
tra i residenti in Regione.
I mezzi di comunicazione regionale - secon32 B. Zoratto, Relazione alla Conferenza Stato-RegioniProvince autonome-Cgie, Roma, 11 e 12 febbraio 2002,
http://www.italiamiga.com.br/noticias/artigos/relazione_di_bruno_zoratto_alla_.htm; sito consultato il 14/9/2009.
33 I risultati del sondaggio sono stati pubblicati in L.
Capuzzo (a cura di), La diaspora negata cit., pp. 19-44.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
69
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
do gli esiti del sondaggio - danno largo spazio
a notizie riguardanti gli incontri con delegazioni regionali o all’attività delle associazioni
degli emigrati. Poca attenzione viene dedicata
alle persone e alle informazioni di carattere
economico. In particolare i laureati mostrano di gradire l’informazione economica, i più
giovani e le donne articoli sulle persone, i più
vecchi ed i soggetti caratterizzati da un basso
profilo scolare, le notizie che descrivono incontri pubblici-istituzionali.
«Molte cose quindi allontanano – osservano i responsabili del sondaggio – le due sponde del mare. Ma ci sono anche degli elementi
che possono unire: gli spostamenti rapidi, le
maggiori disponibilità economiche, la progressiva mondializzazione dell’economia, la
tecnologia delle comunicazioni. Ovviamente
tra gli intervistati questo tipo di consapevolezza è ben presente, forse però non rappresenta
ancora una spinta per poter agire sul percorso
che dal “ricordo/nostalgia” porti verso una dimensione nuova del fenomeno, la dimensione
delle potenzialità (economiche e culturali) che
il mondo della “vecchia” emigrazione può recare con sé. Certamente questo passaggio non
è semplice, non è semplice perché richiede –
in qualche misura – un contenimento delle
emozioni ed un incremento della razionalità.
E’ certamente un possibile incontro diverso,
forse con una diversa profondità, ma probabilmente è un incontro che guarda verso il futuro
del passato fenomeno migratorio».
Promozione del “sistema Italia”
Un terzo aspetto va analizzato se si vuole
immaginare un nuovo modello di sviluppo
dell’informazione italiana all’estero. Ed è quello dell’interesse da rivolgere alla comunicazione di carattere economico e alla promozione
della lingua e della cultura italiana nel mondo.
È presumibile che «la conoscenza delle imprese, delle attività produttive in un numero
svariatissimo di campi, delle aziende, delle
risorse culturali che sono controllate dai nostri connazionali, e reciprocamente, la conoscenza da parte degli stessi della potenzialità
produttiva delle Regioni - sottolineava Gui-
issn 2035-584x
do Barbina, docente dell’Università di Udine
- possono diventare un motivo di ulteriore
progresso economico e creare flussi di scambio del tutto nuovi e impensati»34.
La promozione dell’immagine italiana nel
mondo, a livello sia culturale che economico,
è un elemento da tenere in forte considerazione quando si parla di potenziamento della rete
comunicativa con le comunità di italiani che
vivono all’estero.
L’italian style, dalla moda alla cucina, dall’arte al design, oggi fa tendenza; l’italian style,
però, «non è solo un’espressione di italianità
o un fenomeno commerciale, è un modello di
vita» 35 e come tale va valorizzato, attraverso un
miglioramento del sistema informativo a tutti i livelli. Le comunità italiane all’estero sono
una risorsa essenziale per diffondere il made in
Italy, amato ed apprezzato in tutto il mondo.
È arrivato il momento, come sostengono
anche Giovanna Chiarilli e Antonella Pontuti36, di esprimere la presenza internazionale
dell’Italia in maniera più attiva, rendendo partecipi nel processo di affermazione anche le
comunità all’estero. E il mondo dell’informazione, in questo senso, ha un preciso ruolo per
uscire dall’immobilismo. Una comunicazioneinformazione per l’estero e all’estero, significa
anche promozione della lingua, della cultura,
del prodotto turistico, gastronomico: le grandi
potenzialità del Paese, a cominciare dall’arte, la
moda, il successo delle piccole e medie imprese, rendono molto fertile questa “missione”.
Attualmente in Italia, quando si parla del
made in Italy, la maggior parte delle persone fa riferimento ad Armani, Gucci e Prada,
alla Fiat, alla Ferrari, ecc. In realtà, al di là dei
grandi marchi a tutti noti, esistono tantissimi
italiani ed oriundi che con grande volontà e
capacità, nel corso dei decenni, hanno saputo
imporre lo stile italiano, dal cuoco all’imprenditore, dal dirigente aziendale all’operatore
34 G. Barbina, Gli scambi informativi come premessa alla
penetrazione economica, in L. Capuzzo (a cura di), La diaspora negata cit., p. 99.
35 R. Romoli Venturi, Italia Nazione Globale cit., p. 49.
36 G. Chiarilli e A. Pontuti, intervento al convegno
“Comunicazione ed emigrazione”, Padova, 11 novembre
2000, in Grtv del 17/1/2001.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
70
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
dell’industria turistica.
In un mondo globalizzato è necessario definire una politica che abbia l’obiettivo della
piena valorizzazione del patrimonio economico rappresentato dagli italiani nel mondo
e che parallelamente possa offrire alle nostre
comunità ed in particolare ai giovani, come
ha affermato il presidente del CNEL, Pietro
Larizza37, «un riferimento solido, organizzato
e duraturo nel tempo, sulla cultura, sull’informazione, sull’assistenza e, quando necessario,
sulla formazione, per progredire negli stessi
Paesi di accoglienza».
L’informazione italiana all’estero, quindi,
se adeguatamente coinvolta, potrebbe garantire un ottimo ritorno di immagine, e perché no,
economico se si parla di turismo, senza trascurare il prodotto gastronomico, il patrimonio
culturale e quant’altro l’Italia è in grado di offrire, sia alle comunità italiane, sia autoctone.
Basti solo pensare che la lingua italiana è al
diciannovesimo posto tra le lingue più parlate al mondo, ma nonostante ciò, si colloca
al quinto posto per il numero di studenti che
aspirano ad apprenderla. La domanda di apprendimento è inoltre in costante crescita
in ragione di vari fattori: da quelli, più tradizionali, collegati allo studio delle discipline
artistiche o musicali, a quelli, più recenti, derivanti dallo sviluppo dei rapporti economici
con i Paesi esteri, dall’incremento dei flussi
turistici e dei servizi ad essi collegati, sino
alle opportunità di lavoro in Italia o con l’Italia. Da “lingua della memoria e della cultura”
l’italiano si sta diffondendo, in talune aree,
anche come “lingua degli affari e del lavoro”.
Giovani protagonisti del futuro
Quarto elemento cui rivolgere attenzione, sono le tendenze, le scelte delle giovani
generazioni che guardano all’Italia con occhi
diversi dai padri o dai nonni, più disincantati
e tendenti a porre a confronto le novità e le risorse che hanno a disposizione nella Nazione
di accoglienza con l’immagine ormai superata
dell’Italia perpetuata dal microuniverso fami37 P. Larizza, intervento alla Prima Conferenza degli
italiani nel mondo, cd-rom ADN-Kronos Libri.
issn 2035-584x
liare. Sono giovani nati e cresciuti spesso in
società multiculturali, che si interrogano sulle
proprie origini e parlano il linguaggio di Internet e della nuova economia.
I giovani italiani nel mondo38 sono una risorsa importantissima alla quale l’Italia può
legare la proiezione della sua immagine nel
mondo; sono una nuova potenzialità di valori
culturali, sociali ed economici. «Vi è una necessità (…) di guardare al futuro e di costruire ponti con le nuove generazioni - avvertono Franco
Narducci e Graziano Tassello nella Prefazione
ad un’indagine sui giovani svolta dall’Iref per
conto del Ministero degli Affari esteri39 - per
preservare il patrimonio secolare di valori solidali e culturali costruito faticosamente dai
nostri connazionali in oltre un secolo di emigrazione di massa. Non basta riscoprire la memoria e codificarla per salvaguardare il legame
che attraverso i decenni ha unito la diaspora
con l’Italia, bisogna osare il futuro. (…) Soltanto rinvigorendo la loro identità, i giovani
potranno confrontarsi in modo corretto con i
valori dell’italianità, evitando il pericolo della
massificazione e della invisibilità».
Si fa un gran parlare di italianità e di italiani all’estero come risorsa. Spesso però gli
studiosi - continuano Narducci e Tassello40
- riservano questi dibattiti alle prime generazioni. Le seconde e successive generazioni
sembrano un corpo estraneo, quando invece
ogni autentica strategia deve coinvolgere i
38 Tra gli italiani all’estero, i giovani, compresi in una
fascia d’età dai 18 ai 35 anni, sono 929.249, pari al 24%
della collettività, con preponderanza in Europa e Nord
Africa (53,9%), poi in America Latina (33,1%) e nei Paesi
anglofoni (10,1%). V. http://www.esteri.it/MAE/IT/App
rofondimenti/2008/11/20081128_ConferenzaGiovani;
sito consultato il 29/11/2008.
39 F. Narducci e G. G. Tassello, Prefazione, in C. Caltabiano
e G. Gianturco (a cura di), Giovani oltre confine. I discendenti e gli epigoni dell’emigrazione italiana nel mondo, Carocci
editore, 2005, p. 12. Narducci e Tassello firmano la
Prefazione in qualità rispettivamente di segretario del
Consiglio generale degli italiani all’estero e di presidente del Comitato scientifico.
40 Ibidem, p. 13. Di giovani “protagonisti del rilancio
delle politiche migratorie” parla anche la coordinatrice organizzativa della Uim nazionale, Laura Garavini,
nel numero di settembre 2007 del “Messaggero di
Sant’Antonio” (v. NIP 25/7/2007).
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
71
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
giovani come protagonisti nella ricerca di piste nuove. Non si tratta più di un ricordo nostalgico, ma di recepire l’evoluzione in atto e
scoprire i protagonisti del futuro.
Protagonisti del futuro che chiedono di comunicare tramite i mass-media, «per esempio
i giornali - suggerisce Francesco Robles - che
devono essere di alta qualità e devono raggiungere tutti i giovani e tutti quanti siano interessati alla cultura italiana. Inoltre, stazioni
radiofoniche e trasmissioni televisive, quali
potrebbero essere quelle di Rai International - aggiunge - devono permettere l’accesso
all’informazione, alla formazione, alla lingua e
alla cultura della moderna Italia, ormai tanto
dissimile da quella dei nostri genitori o nonni (…). I giovani hanno bisogno di essere informati sulla possibilità di eventuali viaggi in
Italia, ovunque in Italia, non solo Regione per
Regione (…). C’è infine bisogno di aumentare
gli scambi culturali e programmi di studio soprattutto a livello di scuola secondaria, a livello
universitario e post-universitario»41.
Analoghe istanze emergono dal Documento approvato dalla Conferenza mondiale dei
giovani italiani nel mondo, svoltasi dal 10 al
12 dicembre 2008 a Roma. L’Informazione è
il primo dei temi di interesse prioritario proposti dai giovani italiani nel mondo alle assise42. Nel testo si evidenzia una forte richiesta
di informazione «a tutti i livelli ed in tutti gli
ambiti perché senza informazione non vi è
possibilità di un recupero della memoria, della sedimentazione della memoria e del rafforzamento dell’identità italiana in un contesto
globale in cui l’interculturalità sussiste come
dato di fatto imprescindibile e di cui occor41 F. Robles, Atti del convegno “Le nuove generazioni: tendenze, aspettative, richiami, opportunità”, Campobasso,
9-10 dicembre 2000, cd-rom ADN-Kronos Libri.
42 Gli altri sono Identità, Interculturalità, Interscambio,
Formazione professionale e mondo del lavoro. I cinque
punti di discussione si ritrovano nella totalità dei documenti risultati dalle riunioni, incontri e consulte che
alcune Regioni hanno sperimentato per i propri giovani nel mondo e nei documenti scaturiti dai giovani
partecipanti alle riunioni continentali che hanno preceduto la Conferenza. Cfr. Consiglio generale degli italiani all’estero – Ministero degli Affari Esteri, Documento
propositivo in vista della Conferenza mondiale dei giovani
italiani nel mondo, Roma 10-12 dicembre 2008, p. 2.
issn 2035-584x
re tenere il massimo conto. Di qui l’esigenza
- secondo i giovani italiani di tutto il mondo
che hanno partecipato alle riunioni preparatorie dell’evento - di un interscambio fra le
comunità e l’Italia, dal quale non può essere
disgiunto il momento formativo. In particolare, la formazione professionale è uno dei punti
salienti – recita il Documento – che emergono
dal dibattito dei nostri giovani all’estero, come
momento di arricchimento per una migliore
affermazione nel mondo del lavoro».
Nel Documento si chiede il riconoscimento
dei titoli di studio fra i vari Paesi «come condizione necessaria per l’agevolazione alla mobilità
professionale e scolastica oramai indispensabile
nella nostra società globalizzata» e di «facilitare
la formazione professionale e post laurea con
possibilità di stage e workshop ai vari livelli»43.
Se si trasferisce il discorso della formazione
professionale al campo della comunicazione,
si aprono prospettive interessanti al fine di
delineare un nuovo ruolo per l’informazione
italiana nel mondo.
È evidente che il processo di rinnovamento
di una prassi consolidata parte nel momento in
cui si ha coscienza del problema e se ne intravvedono le soluzioni. Ecco, una delle soluzioni - e
forse quella più determinante, a mio parere, per
gli sviluppi futuri - è la formazione di una nuova
generazione di operatori della comunicazione,
sia in Italia che all’estero, più consapevoli, da un
lato, del potenziale rappresentato dagli italiani
nel mondo, e più preparati professionalmente,
dall’altro, a reggere le sfide del futuro.
Nella società contemporanea, la nuova generazione di giornalisti italiani ha una forte
necessità di entrare in contatto con le diverse
realtà straniere e di capire cosa rappresenta
la presenza italiana nel mondo, allargando le
proprie conoscenze ed i propri orizzonti professionali. Viceversa i giornalisti italiani che
vivono all’estero, necessitano di avvicinarsi
maggiormente alla realtà italiana e, così facendo, possono anche capire quali sono le notizie
da produrre in loco per suscitare un vivo interesse non solo nella comunità italiana del Paese in cui risiedono, ma anche nell’Italia stessa.
Un’adeguata formazione professionale dei
43 Ibidem, p. 5.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
72
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
giornalisti italiani e dei loro colleghi che vivono all’estero, gioca insomma un ruolo importantissimo nel miglioramento dell’attuale
informazione sia “di andata” che “di ritorno”.
Formare gli operatori dell’informazione
nell’ottica di un nuovo rapporto con gli italiani
nel mondo significa creare consapevolezza, negli italiani d’Italia e negli italiani all’estero, dei
nuovi scenari e disporre di professionisti da un
lato (quelli in Italia) sensibili alle tematiche internazionali ed in grado di valorizzare la presenza italiana nel mondo, e dall’altro (quelli all’estero) capaci di trasformarsi in canali di accesso
privilegiato alla realtà dei Paesi d’accoglienza.
«Perché il consenso intorno all’esigenza di
diffondere l’informazione sul fenomeno migratorio non sia scontato, o velleitario, o di adesione
superficiale - osserva Ulderico Bernardi - la prima necessità è quella di formare gli opinion-maker da destinare a questo specifico servizio»44.
Non sfugge, in questo contesto, la responsabilità delle Università e delle Scuole di giornalismo nel saper cogliere questi segnali e favorire una partecipazione attiva dei giovani ai
processi comunicativi che intercorrono tra gli
italiani che vivono in Italia e la comunità dei
connazionali all’estero.
Nell’ambito della formazione giornalistica,
i giovani studenti di Scienze della Comunicazione e delle Scuole di giornalismo diventano
così un’importante risorsa da tenere in considerazione per l’organizzazione di corsi, Master, Summer school, stage, tirocini formativi,
interscambi, che prevedano l’inserimento di
giovani aspiranti comunicatori italiani in alcune testate italiane all’estero e, viceversa, di giovani aspiranti giornalisti italiani all’estero nelle strutture italiane, dove potrebbero trovare
anche occasioni di approfondimento della lingua del luogo e di migliore conoscenza del territorio. Per fare ciò occorrono borse di studio,
agevolazioni ed accordi bilaterali, che aiutino i
giovani ad introdursi nelle realtà straniere45.
44 U. Bernardi, La condizione migrante e l’educazione alla
interculturalità, in L. Capuzzo (a cura di), La diaspora negata cit., pp. 111-113.
45 Un esperimento pilota di successo in questo senso
venne condotto in due edizioni successive, nel 1998 e
nel 1999, dall’Ordine regionale dei giornalisti del Friuli
issn 2035-584x
Le università del Nord-Est ed in particolare
l’Università di Trieste, per la storia della città, la
sua posizione geografica, il passato di emigrazione vissuto, comprensivo anche delle tragedie dell’esodo istriano46, per la sua vocazione
naturale all’internazionalizzazione delle conoscenze, derivata anche dalla presenza di una folta comunità di scienziati e ricercatori stranieri,
si configura come luogo ideale per interventi
di questo tipo. Interventi che non sono certo
facili, ma indispensabili nella realtà odierna e
che rivestono un carattere fortemente innovativo proprio perché, toccando il mondo della
comunicazione e, nello stesso tempo, i rapporti
dell’Italia con i Paesi che sono stati segnati dalla
Venezia Giulia, attraverso alcune Borse di studio sponsorizzate dallo SMAU, che avevano consentito l’interscambio di giovani giornalisti tra la Regione e il Canada e la
realizzazione di stage presso testate del Paese ospite.
46 V. C. Donato, P. Nodari, Emigrazione giuliana nel
mondo: note introduttive, Trieste, 1996; G. Cresciani,
Storia e caratteristiche dell’emigrazione giuliana, istriana
e dalmata in Australia, in “Qualestoria”, n. 2, dicembre
1996; A. Kalc, L’emigrazione slovena e croata dalla Venezia
Giulia fra le due guerre, in Friuli e Venezia Giulia. Storia del
‘900, Gorizia, 1997; S. Bon, Trieste La Porta di Sion. Storia
dell’emigrazione ebraica verso la Terra d’Israele 1921-1940,
Firenze, 1998; P. Purini, L’emigrazione da Trieste nel dopoguerra, in “Annales. Annali di studi istriani e mediterranei” Koper, n. 10, 1997; F. Cecotti, Guerra, miseria, emigrazione. Motivazioni e caratteristiche di una emigrazione insolita. Venezia Giulia 1945-1960, in P. Pedron, N. Pontati (a
cura di), Il novecento tra storia e memoria, Trento, Museo
storico in Trento (Quaderni di didattica della storia, 6)
1999; F. Fait, L’emigrazione giuliana in Australia 1954-1961,
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Udine 1999;
P. Purini, L’emigrazione non italiana dalla Venezia Giulia
dopo la prima guerra mondiale, in “Qualestoria”, n. 1, a.
XXVIII, giugno 2000; F. Cecotti, Emigranti e marinai. I
cittadini del Litorale trattenuti all’estero 1914-1919, in «un
esilio che non ha pari». 1914-1918 profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell’Isontino e dell’Istria, a cura di F. Cecotti,
Gorizia, 2001; D. Krmac, L’emigrazione istriana nel passaggio dall’impero asburgico al regno d’Italia (1918-1924),
in S. Allievi (a cura di), Islam in Europa, Islam d’Europa,
Centro studi emigrazione, Roma, 2002; M. Cattaruzza,
M. Dogo, R. Pupo (a cura di), Esodi. Trasferimenti forzati di
popolazione nel Novecento europeo, Napoli, 2000; R. Pupo,
Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Milano,
2005; C. Colummi, L. Ferrari, G. Nassisi, G. Trani, Storia
di un esodo, Istria 1945-1956, Istituto Regionale di Storia
del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia,
Trieste, 1980; F. Rocchi, L’esodo dei 350.000 giuliani, fiumani e dalmati, Difesa adriatica, Roma, 1970.
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
73
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
sua emigrazione, aprono l’Italia al mondo e fanno entrare direttamente il mondo in Italia.
Laura Capuzzo, triestina, lavora dal 1979 come
giornalista presso l’Agenzia Ansa, alla quale ha dedicato la tesi di laurea, premiata nel ’77 con il Saint
Vincent di giornalismo e pubblicata nel ’90 con il
titolo Notizie in viaggio. Dalle agenzie ai quotidiani: il processo di riscrittura giornalistica,
da Franco Angeli, Milano. E’ stata co-curatrice di
Contarsi. Raccontarsi. Contare. La donna come
protagonista dei media (Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia, 1994) ed ha curato nel 2000
la realizzazione di La diaspora negata. Italiani
all’estero e informazione nel Friuli–Venezia
Giulia per conto dell’Ordine regionale dei giornalisti. Ha ricoperto vari incarichi negli organismi di
categoria a livello nazionale e regionale ed organizzato manifestazioni, in Italia e all’estero, su tematiche attinenti all’attività giornalistica. Dal 1997 si
occupa di comunicazione italiana nel mondo.
[email protected]
Emergenza comunicazione per gli italiani nel mondo
74
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Una breve disamina dei casi
Welby ed Englaro*
Alberto Berardi
Abstract
Le vicende Welby ed Englaro vengono osservate
muovendo dall’esame di due decisioni giudiziarie, la
sentenza pronunziata dal G.u.p. di Roma nel caso Welby
e la sentenza della Cassazione che ha aperto la strada
all’epilogo del procedimento Englaro. Tali sentenze
fanno interamente propria l’idea, condivisa, che non
sussista alcun criterio razionale di demarcazione del
trattamento terapeutico dal sostegno vitale, oltre che
l’idea, contestata, che l’art. 32 Cost. consacri il dogma
dell’autodeterminazione volontaristica in materia
di trattamento terapeutico, che si esprime nel diritto
soggettivo perfetto del paziente a pretendere dal
medico la prestazione sanitaria invocata o rifiutata, cui
corrisponde il dovere giuridico del medico di consentirne
l’attuazione. Su tale terreno di ricostruzione, peraltro,
viene denunziato il limite giuridico ed epistemologico
della sentenza della Cassazione civile sulla vicenda
Englaro, la quale ha inteso colmare la fisiologica assenza di
una manifestazione di volontà attuale e giuridicamente
rilevante nel senso del rifiuto del trattamento di sostegno
alimentare e idrico in capo alla paziente, che versava
in stato vegetativo persistente, con una inaccettabile
ricostruzione induttiva di una supposta volontà
presunta, a partire da una valorizzazione generale dei
precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato. Tale
chiarissima forzatura giuridica appare suggestiva del
bisogno di una legislazione sul testamento biologico,
sulla cui efficacia risolutiva delle vicende controverse,
peraltro, si nutre più di qualche dubbio.
V
che attiene al sostegno di funzioni vitali»2.
Nell’uno e nell’altro di tali passaggi motivazionali convivono, uno accanto all’altro, inscindibilmente, in un rapporto di compenetrazione
reciproca, l’idea del sostegno, del soffio vitale,
assieme a quella del presidio terapeutico.
A ben vedere, tali annotazioni motivazionali,
a mio sommesso giudizio, colgono interamente nel segno; esse rendono ragione di un dato di
fatto, incontestabile, in forza del quale, la pervasività della penetrazione della tecnica, da intendersi quale passaggio applicativo dell’invasione
orrò dar corso al mio approfondimento
prendendo le mosse da due riferimenti
testuali, estratti da due note sentenze che occupano la materia del mio intervento; il primo
è della Corte Suprema di Cassazione, secondo
la quale «non v’è dubbio che l’alimentazione e
l’idratazione artificiali costituiscono un trattamento sanitario, […] un presidio proporzionato al mantenimento del soffio vitale»1, mentre
il secondo è del Tribunale di Roma, per il quale
«non può escludersi la natura di terapia di ciò
1 Cass. Civ., Sez. I, 16.10.2007, n. 21784, in Foro It., 2008,
I, p. 3042.
Una breve disamina dei casi Welby ed Englaro
Parole chiave
Welby, Piergiorgio;
Englaro, Eluana;
testamento biologico;
art. 32 Costituzione;
trattamento terapeutico;
sostegno vitale.
2 G.u.p. Roma, 23.07.2007, in Foro It., 2008, II, p. 105.
75
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
della scienza, nello scandire ogni istante della
vita dell’uomo, sia oramai talmente profonda e
per l’appunto penetrante, da rendere oggi non
più predicabile qualsivoglia criterio razionale
di distinzione tra ciò che è naturalmente vitale
e ciò che è tecnicamente terapeutico.
Mi si perdoni la banalità, che vuol essere solo
metaforica, ma quando rifletto sul più banale
dei “sostegni” alla vita piegata dalla senescenza,
il bastone della vecchiaia, mi avvedo che esso
reca con sé tale e tanta scienza – medica, ortopedica, bio-ingegneristica, ergonomica et similia
– che nemmeno rispetto ad esso mi sento di poter escludere la medesima natura ambivalente.
Le ragioni di questa premessa sono presto
spiegate: la tesi della quale intendo farmi latore è che l’atteggiamento intellettuale di chi
voglia difendere il bene della vita, affermandone l’indisponibilità giuridica – si badi l’indisponibilità giuridica, non sociologica, non
di fatto –, in quanto bene relazionale oltre che
individuale, sostenendo la pretesa di sottrarre dal dogma della libertà di autodeterminazione individuale i presidi di sostegno vitale,
versus il riconoscimento acritico della totale
disponibilità volontarista dei trattamenti sanitari, si fa latore di una difesa dell’indisponibilità del diritto alla vita, al contempo molto
debole, destinata a soccombere, e prim’ancora di retroguardia.
Che si tratti di una difesa debole, mi sembra
tragicamente confermato dalla modestia intellettuale del dibattito sul punto, soprattutto
politico e ai suoi epifenomeni parlamentari,
ad ogni livello; dibattito che quotidianamente
ci rammostra un dialogo tra sordi, che non appare minimamente in grado di far accrescere
di alcunché lo spessore della conoscenza, su di
un tema, come quello che ci occupa, invero di
conoscenza assetato.
Ma come ho poc’anzi riferito, oltre che
debole e destinato alla soccombenza, a mio
giudizio tale atteggiamento è anzitutto di retroguardia, posto che accetta in modo affatto
supino l’idea, assolutamente dominante nel
diritto vivente, che, mercé il presidio costituzionale del comma II dell’art. 32 della Carta
fondamentale, quello del rifiuto alle cure sia
incontestabilmente un diritto soggettivo perUna breve disamina dei casi Welby ed Englaro
issn 2035-584x
fetto, e quindi azionabile, in relazione al quale
sussiste il correlato dovere giuridico di consentirne l’esercizio effettivo; e pertanto, che,
affermato il dominio incontrastato della volontà individuale, anche distruttiva e di morte,
in termini di diritto soggettivo, ogniqualvolta
questa si esprima attraverso il rifiuto alle cure,
a tale rifiuto deve corrispondere un autentico
dovere giuridico.
La citata sentenza del G.u.p. di Roma, sul punto, è assolutamente paradigmatica, per chiarezza
espositiva, e diffusamente condivisa; «quando si
riconosce l’esistenza di un diritto di rango costituzionale – ricorda il Giudice capitolino –, quale quello all’autodeterminazione individuale e
consapevole in materia di trattamento sanitario,
non è, poi, consentito lascarlo senza tutela, rilevandone, in assenza di una normativa secondaria
di specifico riconoscimento, la sua concreta inattuabilità sulla scorta dell’esistenza di disposizioni
normative di fonte gerarchica inferiore […] se si
accogliesse una tale conclusione, potremmo incorrere in una palese violazione dei principî che
presiedono alla disciplina della gerarchia delle
fonti, in quanto non è consentito disattendere una
norma costituzionale sulla scorta dell’esistenza di
norme contrastanti di valore formale inferiore
[…] il giudice tra interpretazioni diverse avrebbe
dovuto privilegiare quella conforme alla norma
costituzionale immediatamente applicabile, potendo autonomamente disattendere interpretazioni di segno diverso […] certamente non si può
lasciare inattuato un principio costituzionale e
senza tutela giuridica il diritto soggettivo che da
esso discende».
A fronte di tale indicazione assertoria e
aproblematica, intendo invece problematizzare l’argomento e sollecitare proprio il ragionamento critico, articolando un quesito, che
mutuo dall’intelligenza argomentativa degli
amici e colleghi Giovanni Caruso e Fabio Pinelli, che, recentemente, in occasione di un
consesso medico, di questi argomenti si sono
occupati con altissima originalità scientifica e
metodologica3.
3 Il riferimento è alla relazione dal titolo I casi Welby ed
Englaro pronunziata il 19 dicembre 2008 da Fabio Pinelli
in occasione di un convegno medico di anestesisti e rianimatori, in Firenze, inedita.
76
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Esiste una qualche ragione giuridica per
la quale, colui che con la forza bruta impedisce l’altrui suicidio, non risponde, al cospetto
dell’ordinamento penale, del delitto di violenza privata? Se la volontà di morire integrasse
un diritto soggettivo perfetto, espressione della massima estensione della libertà di autodeterminazione, il dovere sarebbe di assecondarla, ed illegittima dovrebbe essere pensata ogni
manovra interdittiva al perseguimento dello
scopo prefisso.
Se così non fosse, come non è, questo mi
sembra già un buon indizio falsificante dell’impostazione dominante: se la manovra interdittiva è legittima, ciò significa che il bene della
vita prevale, e non cede al cospetto della libertà
di autodeterminazione.
Posso immaginare la replica a tale esemplificazione: l’impedimento del suicidio è condotta
giuridicamente infungibile, rispetto a quella
del medico, invero obbligato ad assecondare la
volontà anticonservativa del paziente.
Ma la replica non basta, a mio giudizio, essendo sufficiente riconnotare l’esemplificazione in termini un po’ più articolati.
Si pensi all’aspirante suicida che non riesce
nell’intento, ma all’esito del gesto si procuri
solo delle lesioni gravissime, che, se non curate,
lo porterebbero certamente a breve termine ad
assecondare il tragico intento iniziale; e si pensi, al contempo al medico, magari anestesista rianimatore, che assiste al compimento del gesto,
dopo aver dialogato con il malcapitato ed aver
dunque appreso la di lui irreversibile ed informata volontà di morte. Forse che quel medico
si asterrebbe dal prestargli le prime cure salvavita, titubante di fronte al rischio di subire una
condanna per violenza privata – o fin’anche per
lesioni volontarie se si determinasse a praticare
una tracheotomia – avendo egli impedito l’esercizio di un diritto soggettivo perfetto?
Mi arresto qui con l’esasperazione delle
esemplificazioni, perché esse mi sembrano
sufficienti a mettere in evidenza il florilegio
di aporie, alle quali conduce la pretesa aproblematica di esasperare il principio volontarista
nel rapporto tra medico e paziente.
Donde la necessità conoscitiva di determinarsi a mettere in discussione il dogma di
Una breve disamina dei casi Welby ed Englaro
issn 2035-584x
riferimento: a mio giudizio esistono ragioni
fortissime, d’esegesi storica e di consistenza
giuridica e deontologica, per potersi determinare a tale esercizio intellettuale.
Anzitutto e con grande brevità, non è rinvenibile traccia nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, di una sacralizzazione
assolutista di un principio volontaristico
come incarnato dall’art. 32 comma II Cost., che
a ben vedere non ha inteso in alcun modo innovare rispetto al principio giuridico dell’indisponibiltà della vita umana; la natura e la
funzione della norma, nell’intento dei padri
costituenti, erano molto meno spregiudicate, e al contempo particolarmente dignitose;
rendere illegittime e vietate con assolutezza –
qui sì con assolutezza esasperata – tutte quelle pratiche sanitarie coattive e non consentite, dalla sterilizzazione alla sperimentazione
umana, che avevano tragicamente contraddistinto la storia europea dell’immediato pre
conflitto mondiale4.
Ma è soprattutto sul piano del significato
giuridico e deontologico, del rapporto tra medico e paziente, che il dominio dell’autodeterminazione volontarista del malato produce
i suoi effetti più nefasti, posto che sottrae il
medico al dovere dell’alleanza terapeutica, e
quindi al dovere di condividere con il malato,
nella direzione deontologica del principio di
beneficità, la fissazione dei presidi curativi, da
praticare e/o da omettere, nella direzione del
maggior bene per il paziente, ricostruito dialetticamente attraverso l’incrocio della scienza
medica con i bisogni, fin’anche con i semplici
desiderata, del malato.
Orbene, riconosco che dietro l’esasperazione
del volontarismo terapeutico individualista può
militare una comprensibile reazione al modello paternalistico del rapporto medico-paziente,
4 C. Mortati, La tutela della salute nella costituzione italiana, ora in Id., Raccolta degli scritti, III, Milano, 1979,
pp. 433-446; D. Morana, La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Milano, 2002, p. 201; M. Ronco,
L’indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio
autonomistico e svuotamento della tutela penale della vita,
in Cristianità, maggio-agosto 2007, n. 341-342, pp. 11 ss.;
L. Eusebi, Note sui disegni di legge concernenti il consenso
informato e le dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, in Criminalia, 2006, pp. 252 ss.
77
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
in forza del quale il malato, ed il suo tragico portato di sofferenza, dovrebbero essere strumenti silenti della somministrazione unilaterale e
benefica di una scienza medica, così signora di
sé, da non potersi permettere di dialogare con
il proprio oggetto d’applicazione. Ma è altrettanto incontestabile l’irrazionalità ideologica
del voler ribaltare questo eccesso atomistico
con il suo opposto, altrettanto tale, che determinerebbe il medico a divenire il mero esecutore
delle volontà individuali del paziente, in una
relazione che, da terapeutica, finisce per essere
puramente negoziale, con il medico obbligato
a eseguire la prestazione dedotta nel rapporto
sinallagmatico, senza interferenza alcuna delle
ragioni etiche e benefiche di una medicina, al
contrario, così poco signora di sé. E della quale,
a bene vedere, non vi sarebbe alcun bisogno,
essendo sufficiente un tecnico sedatore e somministratore di sostanze venefiche, vieppiù
all’altezza del proprio compito di adempiere al
dovere impostogli dal diritto del paziente.
Ed allora deve il diritto denunziare il negativo giuridico di una relazione medico-paziente
nella quale il secondo scompare, mercé il dominio della primo; al contempo tuttavia è ben
paradossale che l’ordinamento possa ergersi a
sostenitore del diritto del paziente ad ottenere
dal medico ciò che vuole, nei termini giuridici
di un dovere, ed a prescindere da un apprezzamento valoriale del significato concreto particolarissimo, in termini di beneficità medica o
meno, di quel desiderio.
Mi si consenta, epistemologicamente non
è una forzatura, il confronto con l’esperienza
giuridica; verrebbe a mente a taluno di considerare dovere del difensore penale l’introduzione consapevole di un falso testimone nel
processo, nel contesto del rapporto negoziale
di patrocinio ed in adempimento del volere individuale assolutizzato dell’assistito? Si badi,
un volere magari assolutamente orientato al
bene, individualmente ricostruito da costui,
alla sacrosanta conservazione della propria libertà individuale! È noto, non è un dovere per
il difensore, e nemmeno una facoltà, bensì è il
prodromo di una gravissima responsabilità.
E perché mai l’ordinamento dovrebbe, in
misura affatto contraria, accordare al bene inUna breve disamina dei casi Welby ed Englaro
issn 2035-584x
dividualmente ricostruito dell’insostenibilità
dell’esistenza, la caratura fin’anche del diritto
soggettivo, che impone conseguentemente al
medico un dovere giuridico?
Le ragioni ontologiche della medicina e del
diritto non possono consentirlo; l’alleanza terapeutica con il paziente e il principio di beneficità lo impediscono.
Come in parte già accennato, ciò non determina affatto che il medico possa prevaricare
autoritativamente le libertà di autodeterminazione dell’individuo, possa permettersi, mercé
l’autosufficienza della scienza, di non considerarle nella costruzione dialogica del perimetro
del miglior bene del paziente, in ogni singolo
caso concreto, hic et nunc. Solo che tale libertà
di autodeterminazione non può mai assurgere
a diritto, non può correlativamente fondare alcun obbligo del medico.
Quelle aspirazioni e quei desideri sono e restano delle mere facoltà di fatto, che il medico
prima e l’ordinamento poi, potranno, di fatto,
riconoscere come invincibili nel loro essere
necessarie nella direzione del bene del paziente in relazione alla singola vicenda concreta,
ma mai in termini generali ed astratti di diritto, e quindi mai in termini giuridicamente
azionabili come pretesa nei confronti di terzi.
L’incapacità di fatto di sostenere la fatica
della vita, vieppiù allorquando piagata dalla
sofferenza, esiste certamente nell’orizzonte
della natura e nelle ragioni della libertà; e di
fronte ad esso l’ordinamento può, fors’anche
deve arretrare ed astenersi dal giudicare e
dal qualificare; sia in negativo, che in positivo, tuttavia.
Il percorso ricostruttivo così suggerito apre
certamente alla fisiologia della discriminazione tra singole vicende concrete e dell’incertezza dell’apprezzamento dello specifico significato giuridico di ciascuna vicenda concreta.
Il rischio della discriminazione è certamente alle porte; discriminazione tra chi, come
Piergiorgio Welby si è trovato nella condizione soggettiva di poter gridare al mondo intero
tutta la propria indignazione razionale al cospetto della propria vita piagata; e di poter far
apprezzare conseguentemente il significato
giuridico dell’omissione medica dalla prose78
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
cuzione delle cure; e chi, come Eluana Englaro
questa condizione non l’ha mai sperimentata.
Le discriminazioni tuttavia sono della natura e l’uomo ha il dovere generale di riconoscerle, ed accettarle; si badi, ciò non significa che
non sia apprezzabile l’impegno etico alla loro
riduzione, ma tale impegno presuppone il loro
riconoscimento. Ed allora, dev’essere tacciata
di razionalismo prescrittivo la pretesa dell’uomo, che non reca con sé alcunché di razionale,
di poterle cancellare, assurgendo a dominatore della natura.
Il rischio dell’incertezza nella comprensione dell’insostenibilità di fatto o meno di una
condizione di vita piagata dalla malattia, è evidentemente conseguente, e va rispettato. E la
pretesa del positivismo razionalista di cancellare le incertezze della mondanità terrena, a
ben vedere, non ha più alcuna dignità scientifica; ce lo ha insegnato tragicamente la storia.
Io sono dell’idea, rectius faccio dolosamente
e retoricamente mia l’idea – per certi versi pericolosa, perché abdicativa delle battaglie sui
principi – della politica relativa di riduzione
del danno: essa, non il dogma, mi impone, al
cospetto dell’incertezza, di astenermi dal qualificare – dall’autorizzare nella vicenda Englaro –,
in nome di un elementare criterio di prudenza.
Ed invece, in senso contrario, la vicenda Englaro mi sembra emblematica proprio della
pretesa razionalista di voler superare l’ostacolo dell’incertezza invalicabile, nell’aver voluto
costruire la determinazione volontaria individuale di costei, in costanza di una patologia
come lo stato vegetativo persistente, che la
rendeva per converso non conoscibile.
Ed è proprio questa pretesa, che – a mio
sommesso e nondimeno determinato giudizio – ha portato alla costruzione di quel monstrum giuridico che è la citata sentenza n.
21748 della I Sez. Civ. della Corte di Cassazione,
che nell’annullare la penultima decisione della
Corte d’Appello di Milano, ha aperto la strada
all’epilogo della vicenda di questa primavera,
a tutti noto.
Un monstrum giuridico, ma prim’ancora
epistemologico. Solo in tal guisa riesco a definire l’asserto del Supremo Collegio in forza
del quale può essere «ricostruita la presunta
Una breve disamina dei casi Welby ed Englaro
issn 2035-584x
volontà della persona in stato d’incoscienza
alla stregua di chiari univoci e convincenti
elementi di prova, dei precedenti desideri e
dichiarazioni dell’interessato, ma anche sulla
base dello stile e del carattere della sua vita, del
suo senso dell’integrità e dei suoi interessi critici e di esperienza» e che «il tutore ha il compito di completare questa identità complessiva
della vita del paziente, ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse
stato capace».
Mi sembra sufficiente ricordare la chiarezza
dell’argomentazione di David Hume, vergata
sin dalla prima metà del XVIII sec. nel suo Trattato sulla Natura Umana a proposito dell’insostenibilità razionale di qualsiasi pretesa di
giustificazione logica dell’argomentazione induttiva, per allargare le braccia allo sconforto
a fronte di un’argomentazione siffatta. Come
ricorda Karl Popper rammentando le osservazioni del filosofo scozzese, «non può esservi
alcun argomento logico valido che ci consenta
di stabilire che quei casi dei quali non abbiamo
avuto nessuna esperienza somigliano a quelli dei quali l’abbiamo avuta»; di conseguenza,
«anche dopo aver osservato il frequente e costante congiungimento degli oggetti, noi non
abbiamo nessuna ragione di trarne un’inferenza riguardante un oggetto che è al di là di quelli
di cui abbiamo esperienza»5. Alla luce di questo
insegnamento magistrale, che ha segnato i percorsi della miglior filosofa della scienza contemporanea6, non esiste alcuna ragione logica
che possa consentire di costruire un’inferenza
determinatrice della volontà attuale del malato
in stato vegetativo persistente, a partire dai precedenti desideri manifestati nel passato; l’argomentazione, in termini logici, non ha pregio.
E ancora, quando la Corte Suprema ci riferisce di una decisione ipotetica di volontà a
ricostruirsi, manifesta bensì la consapevolez5 D. Hume, A Treatise of Human Nature, trad. it., Bari,
1967, pp. 139, 195; Id., An Enquiry Concerning Human
Understanding, trad. it., Bari, 1996, pp. 89 ss.; K. R. Popper,
Conjectures and Refutations, trad. it., Bologna, 1972, p. 76.
6 «Le teorie non possono mai essere inferite da asserzioni osservative, o venire giustificate razionalmente
mediante esse»; K. R. Popper, Conjectures and Refutations,
cit., p. 77; sul tema, in particolare, Id., The Logic of Scientific
Discovery, trad. it., Torino, 1970, pp. 5 ss.
79
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
za di tale natura del prodotto conoscitivo, ma
ha piena consapevolezza che la struttura della
conoscenza scientifica attribuisce ad ogni asserto ipotetico natura puramente congetturale7, anche allorquando, come nel caso di specie,
questo è costruito a partire dall’osservazione
selettiva della realtà pregressa? E che pertanto esso necessita, per poter essere predicato,
di rigoroso controllo corroborante sul piano
dell’esperienza?8 E che il terreno di tale controllo non può mai essere, pena lo scadere in un’argomentazione paralogica, lo stesso contesto di
esperienza che ha determinato induttivamente
la formulazione dell’asserto ipotetico? E quale
altro terreno di corroborazione sperimentale è
stato percorso? E potremmo continuare...
Ma ritorniamo e concludiamo nei porti della riflessione giuridica, lanciando due ultime,
e assolutamente rapsodiche, provocazioni intellettuali, o meglio sarebbe ammettere, provocazioni retoriche.
La prima riguarda il tema della volontà, che,
ci viene indicato, dev’essere ricostruita in capo
alla persona in stato d’incoscienza; rammento che questa specifica persona, a far data dal
1996, risultava interdetta. Riconoscendo tutta
la mia ignoranza in subiecta materia mi chiedo, l’interdetto può farsi portavoce di una volontà giuridicamente rilevante? A rileggere le
norme di riferimento del codice civile mi determino alla risposta negativa.
La seconda riguarda il tema delle forme di
manifestazione di una volontà negoziale giuridicamente rilevante e produttrice di effetti
giuridici e mi sovviene – qui l’argomento, con
franchezza, mi avvedo essere puramente retorico – la prescrizione dell’art. 1341 c.c. sull’approvazione separata per iscritto delle clausole
vessatorie di un contratto, ispirata, a leggere
il commentario di Alberto Trabucchi, all’intenzione di «proteggere dal rischio di subire
condizioni particolarmente gravose, consentendo una ponderata riflessione sui punti del
regolamento negoziale più svantaggiosi»9. Ad
una così puntuale attenzione dell’ordinamen7 K. R. Popper, Conjectures and Refutations, cit., pp. 83 ss.
8 K. R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, cit., pp. 275 ss.
9 A. Trabucchi, G. Cian (a cura di), Commentario breve al
Codice Civile, Padova, 20078, p. 1341.
Una breve disamina dei casi Welby ed Englaro
issn 2035-584x
to per i possibili svantaggi patrimoniali di un
impegno contrattuale di un soggetto debole,
che esige, per produrre effetti, di approvazione per iscritto specifica e separata, la volontà
individuale di un soggetto debole di porre fine
alla propria vita viene dall’ordinamento ricostruita induttivamente – e quindi in modo
logicamente insostenibile –, a partire da vaghi
presupposti indiziari, in capo ad un soggetto
che non è nemmeno nelle condizioni giuridiche d’esprimere una volontà...
Non c’è dubbio, che a fronte di tale panorama
desolante, il riconoscimento dell’irresistibilità
della tentazione umana, di voler compensare
con le certezze generali ed astratte del diritto,
le incertezze peculiari e concrete della natura,
determina, in nome della già citata politica di
riduzione del danno, la necessità ed il bisogno
di una legislazione sul testamento biologico.
Ma non dimentichi l’uomo che la varietà
della natura è sempre più testarda dei suoi
sogni razionalisti di semplificazione; e i problemi non si risolveranno, e le questioni d’interpretazione delle dichiarazioni anticipate
di trattamento apriranno fisiologicamente al
contenzioso ed alla necessità della soluzione
giudiziaria del medesimo.
E saremo daccapo.
E dunque all’autorità giudiziaria sarà attribuita la funzione – che non ho mai invidiato
– non solo e non più di decidere della libertà e
del patrimonio, che è emanazione della libertà, delle persone, ma anche della loro vita e della loro morte.
E tutto ciò mi genera nel profondo angoscia
e terrore.
* Testo della relazione pronunziata al Convegno
Bioetica Oggi dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani,
Sezione di Padova, Centro Universitario, il 18 giugno
2009.
Alberto Berardi, ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede
di Padova, dell’Università degli Studi di Padova,
avvocato, iscritto alla Camera Penale “Francesco
de Castello” di Padova, già membro del Consiglio
Direttivo dell’A.N.F. (associazione nazionale forense) di Padova, dottore di ricerca in Filosofia nel
80
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Diritto. Docente delle Scuole Forensi di primo livello
dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Padova
e Vicenza e della “Scuola di formazione dell’Avvocato penalista. Corso di deontologia e tecnica della
difesa penale”, dell’Unione delle Camere penali del
Veneto. Responsabile didattico dell’area di diritto
penale del Corso di preparazione alle prove scritte
degli esami di stato per l’abilitazione alla professione di avvocato della Fondazione Gentile Onlus
di Venezia.
Una breve disamina dei casi Welby ed Englaro
81
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Il pluralismo linguistico tra identità
e differenza
Serena Tomasi
Abstract
Lo Statuto della Corte Penale Internazionale fissa normativamente (artt. 50 e 128) la scelta della Comunità
Internazionale di utilizzare un regime plurilinguistico.
La dichiarazione di equipollenza dei testi redatti nelle
lingue riconosciute ufficiali non elimina, tuttavia, il problema della potenziale divergenza di senso tra gli stessi.
La scelta per il plurilinguismo giuridico costituisce, dal
punto di vista teoretico, espressione di un pensiero di tipo
identitario, proprio della modernità, poiché assume le entità linguistiche in relazione di uguaglianza, astraendo
dalle differenze e rescindendo, per ciascuna, i rapporti tra
lingua e ordinamento giuridico di provenienza. La traduzione del linguaggio giuridico è operazione complessa
per ragioni di natura semantica, sintattica e per la specificità sistemica della lingua. La metodologia che con-
sentirebbe di comporre eventuali contrasti determinati
da divergenze di significato tra testi aventi, per convenzione, pari valore ma in opposizione tra loro, è la retorica
forense: l’argomentazione del Tribunale nella decisione
del caso Akayesu, giudicato per il crimine di genocidio,
costituisce un esempio noto in giurisprudenza di applicazione (ancorché non tematizzata né perfettamente
consaputa) di questa forma della logica giuridica.
Parole chiave
multilinguismo; traduzione;
processo; logica giuridica;
argomentazione dialettica;
retorica; topica.
Premessa
L
a presente trattazione prende spunto dal testo dell’accordo istitutivo della Corte Penale
Internazionale, quale strumento per la prevenzione e la repressione dei crimini di rilevanza
internazionale. In particolare, oggetto di interesse sono gli articoli 50 e 128 dello Statuto i
quali esprimono la scelta degli Stati che parteciparono alla Conferenza Diplomatica di Roma
nel luglio del 1998 di redigere il testo dello Statuto in sei lingue aventi tutte autentico valore1.
La decisione della Comunità Internazionale
di instaurare un regime multilingue stimola
riflessioni di natura giusfilosofica oltre che
teorico-normativa.
Giova sin da subito chiarire i limiti di questo
saggio, che tralascerà ogni indagine sul carattere proprio del diritto internazionale, sulle problematiche di giustizia penale internazionale e
sulle questioni di protezione dei diritti umani,
soffermandosi sulla concezione del rapporto
lingua-diritto implicata nel testo dello Statuto. In particolare, l’analisi del caso Akayesu (un
noto precedente di divergenza delle versioni
statutarie nelle lingue ufficiali, tale da generare
incertezza sul contenuto della previsione normativa punitiva) costituirà l’occasione per mostrare la validità della procedura topico-retorico-dialettica per la composizione del contrasto.
1 Cfr. E.P. Reale (a cura di), Lo Statuto della Corte Penale
Internazionale, Padova, 1999.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
82
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
La Corte Penale Internazionale: cenni
storici
Per un migliore inquadramento del problema, appare opportuno premettere alcune
informazioni di carattere generale sulla Corte
Penale Internazionale (d’ora in poi, CPI)2.
Nel 1989 (risoluzione 44/39 del 4 dicembre
1989) l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
diede mandato alla Commissione per il Diritto
Internazionale di esaminare le questioni relative alla creazione di una Corte con competenza sui crimini internazionali. Gli avvenimenti, europei e mondiali, successivi al secondo
conflitto bellico ed, in particolare, la fine della
guerra fredda, segnarono una definitiva accelerazione verso la creazione di un nuovo organo, indipendente ed imparziale, chiamato a
giudicare i crimini più efferati commessi dagli
individui ed a garantire il rispetto delle nome
fondamentali di convivenza internazionale.
Nove anni dopo quella risoluzione, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocava a Roma dal 15 giugno al 17 luglio una
Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari
per l’istituzione della Corte Penale Internazionale, chiamata alla negoziazione del progetto
di Statuto così come elaborato dal Comitato
Preparatorio, già incaricato di redigere un testo che potesse essere largamente condivisibile. Il progetto di Statuto predisposto dal Comitato preparatorio costituì la base dei lavori
della Conferenza Diplomatica: lo svolgimento
dei lavori prevedeva l’esame da parte del Comitato Plenario del Progetto di Statuto e quindi il deferimento al Comitato di Redazione del
testo delle disposizioni sulle quali fosse stato
raggiunto il necessario consenso. Compito del
Comitato di Redazione sarebbe stato quello di
tradurre il testo negoziato in forma giuridica
e nelle sei lingue ufficiali della Conferenza.
2 Cfr. B. Pastore, Il diritto internazionale in un mondo
in trasformazione: verso un diritto giurisprudenziale?, in
AA. VV., Vol 6: Giustizia internazionale e interpretazione,
Padova, 2001, pp. 157-193. L’Autore riconosce un ruolo
centrale all’istituzione giudiziaria rispetto alle attuali
dinamiche della società internazionale ed assume il
processo istitutivo della CPI quale testimonianza della
fiducia nel contesto internazionale verso meccanismi
di tipo giudiziario.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
Nella notte tra il 17 ed il 18 luglio 1998 fu
adottato lo Statuto della CPI, istituzione permanente dotata del potere di giudicare le persone fisiche per i più gravi crimini di portata
internazionale, complementare alle giurisdizioni nazionali.
Si osservi che il problema della lingua di redazione dell’atto diplomatico viene trattato in
due articoli dello Statuto: l’articolo 50, rubricato «Lingue ufficiali e di lavoro» riconosce
che «Le lingue ufficiali della Corte sono Arabo,
Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo. Le
sentenze della Corte, nonché le altre decisioni
che regolano questioni fondamentali sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza, avuto riguardo dei criteri
fissati nel Regolamento di Procedura e Prova,
determina quali decisioni possono essere considerate regolanti questioni fondamentali agli
effetti del presente comma. Le lingue di lavoro
della Corte sono Inglese e Francese. Il Regolamento di Procedura e Prova determina i casi
nei quali possono essere usate lingue diverse
da quelle ufficiali come lingue di lavoro. Su richiesta di una parte processuale o di uno Stato autorizzato ad intervenire nel processo, la
Corte autorizza gli stessi all’uso di una lingua
diversa dall’Inglese e dal Francese, se riconosce adeguatamente giustificata la richiesta».
Nel novero delle norme finali, l’articolo 128,
precisa che «L’originale del presente Statuto
del quale i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno fede in pari misura è depositato presso l’Ufficio del segretario
Generale delle Nazioni Unite che ne trasmette
copia autentica a ciascuno Stato»3.
Queste due previsioni normative esauriscono la disciplina giuridica volta a determinare le
lingue che possono essere utilizzate nello svolgimento delle attività giuridiche e diplomatiche.
È intuitivo che in tutte le occasioni in cui si
stabiliscono rapporti tra appartenenti a gruppi
linguistici diversi e, massimamente, in ambito
internazionale, si avverte la necessità della re3 La carta è consultabile on line al sito <http://www.
difesa.it/giustiziamilitare/rassegnagm/corte-penaleinternazionale/statuto-cpi.htm> (sito consultato il
4/9/2009).
83
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
golamentazione del mezzo linguistico4. L’ordinamento internazionale non prevede norme di
carattere generale sull’uso della lingua nei rapporti diplomatici, né si è formata una costante
prassi in materia: l’analisi della storia dei rapporti diplomatici tra Stati in ambito internazionale consente di individuare l’impiego nella
maggioranza dei documenti fino alla prima
metà del XVIII secolo del Latino, poi del Francese, ed oggi della lingua inglese. Dopo la seconda
guerra mondiale, si registra un incremento di
trattati multilingui, espressione di un crescente multilateralismo nelle relazioni internazionali. In tal senso, si consideri paradigmatico il
sistema delle Nazioni Unite: la Conferenza di
San Francisco del 1945 scelse come lingue ufficiali l’Inglese, il Cinese, lo Spagnolo, il Francese
ed il Russo. La Comunità Europea è l’unica organizzazione internazionale (art. 290 CE) che
instaura un regime multilingue integrale per
cui ogni Stato aderente ha diritto a che sia rispettato il proprio regime linguistico.
Premesse queste considerazioni introduttive, occorre tornare alla questione del plurilinguismo nello Statuto della CPI, riflettendo sulla
possibilità di un conflitto che può discendere
dalla redazione del testo in più versioni linguistiche e sulle modalità di soluzione dello stesso.
La redazione del testo in tutte le lingue ufficiali implica la produzione di tante versioni
quante sono le lingue prescelte. Tutte le versioni linguistiche fanno ugualmente fede o,
detto altrimenti, un unico precetto normativo
è formulato in diverse lingue. L’assenza di un
testo unico di riferimento viene infatti sopperita dalla dichiarazione di equipollenza tra i
vari testi redatti in più lingue. Ma la relazione
di identità tra le traduzioni giuridiche è una
finzione5: a fronte dell’equipollenza, il proble4 Cfr. G. Cansacchi, vc. Lingua (Diritto Internazionale), in
Novissimo Digesto Italiano, IX, Torino, 1965, p. 934; nonché A. Pizzorusso, vc. Lingua (uso della), in Novissimo
Digesto Italiano, IX, Torino, 1965, p. 935ss.
5 Cfr. F. Megale, Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e “translation studies”, Napoli, 2008, p.
52. Segnala la necessità di un cauto utilizzo del termine «traduzione» in presenza di dichiarazioni di equipollenza tra testi redatti in più lingue, esponendo che
«Nella realtà del plurilinguismo legislativo le diverse
versioni linguistiche sono considerate per legge dei
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
ma è quello della divergenza di senso tra testi
di pari valore e della necessità di determinare
il risultato linguistico prevalente.
Il problema, posto in questi termini, induce ad un approfondimento teoretico circa la
natura della pluralità linguistica in rapporto
al dichiarato principio di uguaglianza tra le
versioni linguistiche, nonché, sul piano metodologico, circa la modalità di soluzione del
contrasto linguistico.
Lingua e linguaggio giuridico: significato
dei termini, sintassi, usi linguistici
Prima di discutere le problematiche inerenti ad un regime linguistico multilingue esaminando il presupposto teoretico di siffatta concezione e le questioni giuridiche correlate, si
rende necessario rivolgere preliminarmente
l’attenzione alla specificità del linguaggio giuridico e, segnatamente, della lingua giuridica.
Il linguaggio giuridico ha una natura ibrida
in quanto si fonda sul linguaggio ordinario integrato da elementi di carattere tecnico propri
dell’oggetto trattato6. Nel suo studio in merito
ai problemi posti dal linguaggio giuridico, Marco Cossutta evidenzia che le potenzialità comunicative del linguaggio giuridico, come accade
per il linguaggio ordinario da cui deriva, sono
minate da due ordini di problemi che possono
rendere il messaggio non immediatamente ed
inequivocabilmente comprensibile7.
“testi autentici”, anche quando nella pratica una di esse
ha costituito l’originale di tutte le altre e queste ultime
sono pertanto delle semplici traduzioni. Tuttavia in
questo caso i giuristi preferiscono non usare la parola
traduzione poiché considerano tali versioni dei testi autentici al pari dell’originale».
6 Cfr. M. Jori, A. Pintore, Manuale di teoria generale del
diritto, Torino, 1995, p. 339. «Il diritto moderno è caso
paradigmatico della categoria pragmatica generale
dei linguaggi amministrati, distinta sia dai linguaggi
strumentali-artificiali sia dalle lingue naturali e ad essi
intermedia, una categoria di cui il discorso del diritto è
senz’altro il più importante».
7 Cfr. M. Cossutta, Questioni sull’informatica giuridica,
Torino, 2003, pp. 87-96; per il discorso sul carattere del
linguaggio giuridico mi sono avvalsa di questo contributo di Marco Cossutta; per ulteriori approfondimenti, veggasi su tutti: R. Guastini, Dalle fonti alle norme,
Torino, 1990; Id., Le fonti del diritto e l’interpretazione,
84
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Più precisamente, si ravvisano problemi di
natura semantica8, che ineriscono il rapporto
tra il termine (significante) e ciò che questo
designa (significato). L’analisi semantica del
termine è necessaria a fronte delle difficoltà
interpretative generate dalla presenza di termini indeterminati, che mancano cioè di precisione nel significato, «vaghi»9, la cui portata
informativa non è cioè determinata. Le principali questioni semantiche legate all’ambiguità
riguardano l’omonimia, ovvero la presenza nel
linguaggio di termini con la medesima forma
(significante) ma dotati di diverso significato,
e la sinonimia, ovvero il manifestarsi all’interno del linguaggio di termini diversi nella forma (significante) ma con identico significato.
Ricorrono inoltre questioni di natura sintattica, circa le regole proprie al combinarsi
delle parole nella composizione della frase ed
il modo in cui si organizzano le singole parole per produrre una frase significativa. Genera, infatti, discussioni sintattiche l’impiego di
determinate regole per la costruzione di proposizioni grammaticalmente corrette ma con
significato ambiguo.
Vi è poi un terzo livello di analisi linguistica
che interessa il processo di comprensione ed
uso del linguaggio, cioè quello della pragmatica, che si occupa delle relazioni tipiche dei
segni con i loro utenti e delle regole che li riguardano10. Molte questioni terminologiche
sorgono dal fatto che ogni Stato ha la propria
terminologia giuridica, pur usando come linMilano, 1993; P. Comanducci, R. Guastini (a cura di),
Analisi e diritto, Torino, 1998.
8 Per un’analisi del problema linguistico dal punto di vista semantico e sintattico, cfr. J.R. Searle, L’unità della proposizione, (trad. it. di M. V. Bramè), in AA. VV., Traduzione
e diritto, Padova, 2000, pp. 37-55. Sul problema dell’ambiguità sintattica, v. T. De Mauro, Linguistica elementare,
Bari, 1998; sul problema della vaghezza degli enunciati
normativi, veggasi C. Luzzati, La vaghezza delle norme:
un’analisi del linguaggio giuridico, Milano, 1990.
9 Cfr. R. Guastini, Le fonti del diritto, cit., p. 357. Per
Guastini, nel linguaggio giuridico non vanno confuse
polisemia e vaghezza: mentre la prima richiede una
scelta interpretativa tra diversi significati possibili, la
seconda richiede una decisione interpretativa circa i
confini del significato.
10 M. Jori, A. Pintore, Manuale di teoria generale, cit., p.
313.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
gua giuridica quella di un altro Stato. Gli studi di semiotica spiegano questa diversità, riscontrabile nella prassi linguistica degli Stati,
a mezzo del cd. triangolo segnico11. L’immagine del triangolo segnico, ai cui vertici stanno
segno, significato e referente, è utile a comprendere la dinamica contestuale propria del
linguaggio: più precisamente, assume rilievo
non l’aspetto esteriore del segno ma il suo posto nel sistema segnico nel quale si inserisce.
Ciascun segno ha infatti un significato come
parte di un sistema di segni che si distinguono tra loro12.
Questa peculiarità è ben conosciuta da tutti
i giuristi, in particolare dagli studiosi di diritto
comparato i quali, occupandosi di traduzione
giuridica, sanno che il linguaggio si differenzia in base ai sistemi giuridici esistenti e territorialmente delimitati. Su tutti, Rodolfo Sacco
osserva che «La parola esprime una nozione.
Se un biologo, per parlare di gangli linfatici,
utilizza quattro lingue differenti, trova in ciascuna di esse una parola che corrisponde esattamente al concetto che egli deve esprimere.
La stessa cosa non si produce sempre per il diritto. I concetti creati, elaborati, definiti dal legislatore o dal giurista di un certo sistema non
corrispondono necessariamente ai concetti
elaborati per un altro sistema»13. Il fatto che
la terminologia giuridica esprima i concetti di
un certo sistema nazionale implica che14, ai fini
11 Ibid., p. 306ss.
�������������
Cfr. anche D. Patterson, Law & Truth, New York,
1996. Si segnala che è in fase avanzata di pubblicazione
la traduzione italiana di Law and Truth [Diritto e verità], a
cura di M. Manzin, che sarà edita da Giuffrè, Milano,
2009. Patterson, basandosi sugli scritti del secondo
Wittgenstein, indaga la struttura del discorso giuridico
e spiega perché essa sia fondamentale per comprendere
la dimensione normativa della pratica giuridica.
13 R. Sacco, Traduzione giuridica, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento I, Torino,
2004, p. 725.
14 Cfr. F. Megale, Teorie della traduzione giuridica, cit., p.
79. L’Autore puntualizza la sussistenza di un rapporto di
dipendenza del linguaggio dal sistema giuridico rispetto al quale la delimitazione nazionale, statale e territoriale svolge un ruolo rilevante di individuazione, qualificazione e diversificazione dei concetti. Nell’illustrare
la centralità di questa osservazione, egli si richiama
ad un’espressione in uso tra i common lawyers: «Law is
85
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
della traduzione del linguaggio giuridico in un
altro linguaggio giuridico, si debba studiare il
significato che i termini da tradurre hanno
nel sistema giuridico della lingua di partenza
e, successivamente, ricercare un termine che
possieda il medesimo contenuto nel sistema
giuridico della lingua d’arrivo15. Ecco che il traduttore deve trovare un termine equivalente: in
ragione della specificità sistemica dei termini
giuridici, in via di principio, vi sarà piena equivalenza solo quando le due lingue si rapportano
al medesimo sistema giuridico. Laddove invece
la lingua di partenza e quella di arrivo si rapportano a differenti sistemi giuridici, l’equivalenza
tra termini è rara. De Groot, in relazione al procedimento traduttivo consistente nella ricerca
di termini equivalenti, osserva che può darsi
equivalenza completa o quasi completa quando
vi è «Una parziale unificazione delle aree giuridiche rilevanti per la traduzione, dei sistemi
giuridici relativi alla lingua di partenza ed a
quella di arrivo» nonché nel caso in cui «Un
concetto proprio di un sistema giuridico è stato
mutuato da un altro sistema e continua a funzionare in quel sistema nel medesimo modo,
senza venire influenzato dal resto del sistema
giuridico» 16. In particolare, secondo de Groot,
«Di fondamentale importanza sono il contesto
e la finalità della traduzione: questi sono i fattori che determinano se le differenze tra il termine della lingua di partenza ed il termine della
lingua d’arrivo sono così rilevanti che il possibile termine della lingua d’arrivo non può essere
usato come traduzione del termine della lingua
di partenza. […] L’accettabilità dell’equivalenza
dipende dai fattori sopra menzionati. È perciò
una decisione che il traduttore deve prendere di
volta in volta»17.
Se non si riesce ad individuare nessun termine equivalente nel sistema giuridico della
lingua d’arrivo, si devono cercare soluzioni
supplementari: una di queste può essere il
mantenimento del termine nella lingua di
system-bound».
15 Cfr. G.-R. De Groot, La traduzione di informazioni giuridiche, (trad. it. di E. Pariotti), in AA. VV., Traduzione e
diritto, Padova, 2000, pp. 135-154.
16 Ibid., pp. 137-138.
17 Ibid., pp. 139-140.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
partenza, spiegandolo mediante apposita nota
o informazione riportata in parentesi. Oppure, un altro modo per rendere accessibile al
giurista un concetto giuridico estraneo è quello di utilizzare una parafrasi per descrivere il
termine della lingua di partenza. La terza soluzione consiste nella creazione di un neologismo: quando il traduttore osservi che ciò giova
alla comprensione, opererà in modo creativo,
introducendo un neologismo, necessario a
rendere il termine presente nella lingua d’origine, o utilizzando una parola o espressione
già esistente per tradurre termini privi di corrispondente.
La ricognizione svolta, sia pur in rapida sintesi, intende mostrare che il rapporto tra testi
autentici non può essere piano e lineare: le osservazioni precedenti indicano la complessità
dei problemi legati alla traduzione giuridica
che combina i temi della linguistica in generale
con le questioni specifiche del linguaggio giuridico18. In particolare, la specificità di ciascuna versione linguistica è legata ai tratti del diritto e della terminologia giuridica impiegata,
la quale è propria di un sistema: questo rende
rara un’equivalenza accettabile tra termini ed
impone forme di adattamento linguistico19.
Ora, la difficoltà soggiacente ad ogni traduzione del linguaggio giuridico comporta inevitabilmente alcune implicazioni: con riguardo al multilinguismo, alla stregua del quale
un’unica regola giuridica è formulata in lingue
diverse, occorre assumere coscienza che, in via
di principio, le versioni linguistiche sono equi18 Cfr. D. Terpin, La comunità linguistica slovena in Italia e
la sua percezione dell’ordinamento giuridico italiano, in Tigor,
1, 2009, p. 47ss., <http://www.rivistatigor.scfor.units.
it/> (sito consultato il 4/9/2009). Egli affronta la questione del rapporto, in campo giuridico, tra lingua maggioritaria italiana e lingua minoritaria slovena individuando
un alto livello di assimilazione, da parte della minoranza
slovena, del complesso normativo espresso in lingua italiana. Egli adduce alcuni casi pratici, tratti dalla sua esperienza professionale di avvocato appartenente alla minoranza slovena, mostrando il limite cui si è pervenuti in
ragione di questa assimilazione, cioè l’incapacità di svolgere una comunicazione giuridica nella lingua madre.
19 Sull’analogia traduzione-interpretazione, richiamo
il saggio di T. Mazzarese, Interpretazione giuridica come
traduzione, in AA. VV., Traduzione e diritto, Padova, 2000,
pp. 165-194.
86
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
valenti, ma nella prassi non vi è un’unica regola giuridica vigente bensì tante regole quante
sono le lingue in cui essa è tradotta.
Giova quindi ritornare agli enunciati normativi espressi negli artt. 50 e 128 dello Statuto della CPI, i quali individuano sei lingue ufficiali, facenti fede in pari misura20.
Orbene, l’adozione di un regime plurilingue
non è prassi inconsueta: i trattati internazionali con più versioni autentiche costituiscono ormai la maggioranza21; parimenti, le parti di un
contratto internazionale possono liberamente
concordare il regime linguistico, prevedendo
l’uso di una sola lingua o l’uso di una lingua autentica e di un’altra non autentica, ovvero, allo
scopo di eliminare le diffidenze reciproche, ricorrendo ad un clausola in base alla quale tutte
le versioni linguistiche siano dichiarate autentiche22.
Numerosi sono anche gli esempi di legislazione plurilingue, cioè di redazione degli atti
legislativi in tutte le lingue ufficiali poste su un
piano di parità giuridica23: il caso più interes20 La locuzione utilizzata nel dettato dell’art. 128 dello
Statuto in Spagnolo, Francese ed Inglese è la seguente:
«Son igualmente àuténticos», «Font également foi»,
«Are equally authentic».
21 Per esempio, in seno alle Nazioni Unite, i trattati
sono adottati dall’Assemblea Generale o da apposite
Conferenze: il numero di versioni autentiche di ogni
trattato varia da caso a caso (una, alcune o tutte le lingue ufficiali). Cfr. F. Megale, Teorie della traduzione giuridica, cit., p. 69.
22 C. Cicala, Lingua straniera e testo contrattuale, Milano,
2003, pp. 173-175. A titolo esemplificativo di clausola del
secondo tipo, nota anche come controlling language clause, l’Autore propone una formula, tratta da un contratto di joint venture, che stabilisce: «This contract shall be
written both in Chinese and English. Authentic text, in
case of controversies, shall be the English text».
�������������������������������������������������������
Si pensi ad esempio al bilinguismo in Canada, ove le
leggi ed i regolamenti federali sono adottati e pubblicati
in Inglese e Francese: l’uguale autenticità delle leggi federali è riconosciuta a livello costituzionale nell’art. 18 del
Constitution Act, che statuisce «The statutes, records and
journals of Parliament shall be printed and published in
English and French and both language versions are equally authoritative», nonché a livello legislativo nell’Official
Language Act del 1985 che, ex art. 2, ha lo scopo di assicurare «respect for English and French as the official languages of Canada and ensure equality of status and equal
rights and privileges as to their use in all federal institutions». Oppure, si consideri il Belgio, ove le versioni
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
sante è senza dubbio quello offerto dall’Unione Europea, ove i regolamenti e gli altri testi
di portata generale sono redatti e pubblicati
nelle ventitré lingue ufficiali24. Le differenti
versioni linguistiche, tutte ugualmente autentiche, rappresentano l’espressione linguistica
plurima di una medesima norma destinata
ad operare in tutti gli Stati membri. Il regime
linguistico dell’organizzazione comunitaria è
fondato sul principio di uguaglianza tra le versioni linguistiche, a garanzia del quale nel regolamento n. 1 del 1958, deliberatamente, non
si parla mai di traduzione bensì di redazione,
con rifermento precipuo alla prassi di predisposizione degli atti giuridici comunitari mediante la tecnica di co-redazione25.
Il principio di equipollenza tra versioni
linguistiche diverse come conseguenza
del “pensiero identitario”
legislative ufficiali in Francese ed in Neerlandese sono
autentiche: l’art. 1 della Legge sull’impiego delle lingue
un materia legislativa del 31 maggio 1961 statuisce che
«Les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et
publiées en langue française et en langue néelandaise».
Parimenti, in Svizzera la pubblicazione di leggi è fatta contemporaneamente nelle tre lingue ufficiali, cioè
Tedesco, Francese ed Italiano. In Finlandia, le lingue ufficiali sono il Finnico e lo Svedese: in entrambe devono
essere pubblicate tutte le leggi del Paese.
24 Bulgaro, Ceco, Danese, Estone, Finlandese, Greco,
Inglese, Irlandese, Italiano, Lettone, Lituano, Maltese,
Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco,
Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tedesco e Ungherese.
25 Cfr. T. Gallas, Coredazione e traduzione giuridica nella
legislazione multilingue, in particolare quella comunitaria”
in La traduzione. Saggi e documenti IV. Quaderni di Libri e
Riviste d’Italia, 43, Roma, 1999, p. 137. L’Autore, che fu
giurista-linguista nel Consiglio dell’Unione Europea,
definisce la co-redazione per differenza dalla traduzione, precisando quanto segue: «Per traduzione consideriamo la produzione di un testo in una data lingua L2
a partire da un testo originale in un’altra lingua L1; la
conversione potrà essere più o meno libera, caratterizzante è che il testo L1 non viene influenzato da L2. Sarà
definito co-redazione il caso in cui nella stesura del testo L2 è possibile una retroazione su L1 in maniera che
questo possa essere modificato, corretto, o perfezionato
nel corso della trasposizione in L2». Sul tema del multilinguismo in ambito comunitario, vedi anche E. Ioriatti,
Lingua e diritto in Europa: multilinguismo, pluralismo linguistico e terminologia giuridica uniforme nel diritto europeo
dei contratti, in Diritto pubblico comparato ed Europeo, IV,
Torino, 2005, pp. 1549-1567.
87
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Nella realtà del plurilinguismo, come si è
detto, le diverse versioni linguistiche sono
considerate per legge tutti testi autentici.
Ebbene, occorre non confondere la scelta per
il plurilinguismo giuridico in una scelta di
tutela della differenza, espressa in particolare come differenza etnico-linguistica dei
soggetti coinvolti, essendo piuttosto ravvisabile nella dichiarazione di equipollenza
delle versioni linguistiche un esplicito portato del pensiero identitario, proprio della
modernità.
«Il pensiero della modernità è stato segnato sin dal suo inizio da una tensione verso la
semplificazione egualitaria»26. E ancora: «Nella storia del pensiero, testimonianze molteplici possono essere ricondotte entro gli ambiti
di due filoni principali: quello indicato come
“classico”, per il quale la differenza è costitutiva dell’essere-pensiero, e quello detto “moderno”, teso all’affermazione esclusiva di un ordine, identico per tutti i campi dell’esperienza. I
due termini, “classico” e “moderno”, sono dunque da intendersi piuttosto in senso categoriale che cronologico»27. Il pensiero moderno è
identitario o egualitario in quanto cerca l’essere come ciò che è uniformemente identico
in tutto, indifferenziato: «Per questo motivo
il pensiero identitario finisce per ammettere
come unico criterio logico atto a controllare la
validità delle inferenze, e a fondare conoscenze rigorose, il principio di identità»28. Al pensiero dell’identità si oppone il pensiero della
differenza, teso a valorizzare ciò che distingue,
26 M. Manzin, Ordo iuris, Milano, 2008, p. 22. L’Autore
puntualizza, sul processo di semplificazione, quanto segue: «La semplificazione, in tutte le sue molte e diverse
declinazioni, si sostiene su due concetti apparentemente
distinti tra loro, quello di unità e quello di molteplicità.
La molteplicità si mostra fenomenologicamente come
il prius dell’operazione razionale, l’unità ne costituisce
il modello e il costante riferimento. […] Vi è dunque un
prima rappresentato dall’oggetto ancora indeterminato,
dai molti possibili significati e un dopo che è l’unico significato al quale esso sarà collegato e che ne segnerà i
confini semantici» (p. 18).
��Ibid., nt. 9, p. 90.
�� Ibid., p. 19. ������������������������������������������
Il principio di identità si esprime secondo il principio A=A, in forza del quale un ente è uno in
quanto uguale a se stesso. All’identità si associano i concetti di unità, uniformità, eguaglianza.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
ponendo l’enfasi sulla differenza, intesa come
qualità di ciascun ente per la quale esso è se
stesso e non è altro da sé29.
Ebbene, il pensiero moderno ha gradualmente preso le distanze dalla concezione
classica, privilegiando la potenza calcolante e
quantificatrice della tecnica ed eliminando le
relazioni: «La rescissione progressiva di tutti
i vincoli con ciò che è altro rispetto ad un ente
[…] corrisponde alla sua restituzione al puro
principio di identità (A=A), ad una solitaria
condizione di unici-identici non comunicanti
tra loro, che meglio si prestano ad essere maneggiati da una ragione calcolatrice e quantificante. Astratto dalla pluralità delle relazioni,
l’identico subirà la rottura per essere conosciuto nelle sue parti costitutive, che […] si riveleranno a loro volta degli identici»30.
Quanto sopra evidenziato, conduce a precisare cosa si intende per pluralità e come questa
si esplichi all’interno del pensiero egualitario.
L’adozione di un regime plurilingue e l’attribuzione di pari valore a tutte le versioni
linguistiche conseguenti risponde espressamente all’esigenza di evitare l’egemonia linguistica (e quindi politica e giuridica) di una
versione sulle altre e di garantire il principio
di uguaglianza tra le versioni linguistiche.
Segnatamente, per quanto attiene allo Statuto della CPI, trattandosi di una giurisdizione a vocazione universale a tutela dei diritti
universali per eccellenza, cioè i diritti umani,
l’esigenza egualitaria sopraddetta emerge in
forma marcata: la funzione della comunità
internazionale consiste proprio nel garantire
l’esercizio delle libere volizioni31. L’egualitari29 Ibid., p. 18. La differenza è la qualità che implica (almeno) una presenza altra dall’uno. E dunque una molteplicità di enti diversi fra loro. Alla differenza si associano concetti come pluralità, diversità, molteplicità.
30 Ibid., p. 22.
31 Sulla concezione dei diritti umani, che dopo la seconda guerra mondiale si presentano nella forma di diritti
internazionalizzati e costituzionalizzati, segnalo l’articolo di M. Manzin, La barba di Solzenicyn e la frammentazione dei diritti umani, in Persona e Derecho, 58, 2008, pp.
456-572. Intendo appuntare, ai fini della lettura della
presente trattazione, una riflessione dell’Autore di centrale rilevanza, nella misura in cui svela il presupposto
teoretico che si cela dietro la parabola dei diritti umani:
«La concezione dei diritti umani che si fa strada dopo
88
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
smo come ideale, giuridico e politico, da cui discende la necessità di rimuovere le differenze,
si esprime anche nella scelta, normativamente
espressa negli artt. 50 e 128 dello Statuto della
CPI, per il pluralismo linguistico nella misura
in cui l’art. 50 contempla l’esistenza di molteplici entità linguistiche le quali, ex art. 128,
sono da intendersi perfettamente uguali tra
loro. Questo modo di concepire il concetto di
pluralità è proprio della modernità che eredita dal neoplatonismo la nozione di Principio
come assoluta identità32. Ipotizzare che tutte
le versioni linguistiche siano equally authentic,
eliminando le differenze tra le stesse e, per ciascuna, rescindendo i rapporti tra lingua e sistema giuridico, equivale ad una finzione. Si badi,
«Lo stesso concetto di unico è una finzione,
poiché la differenza è sempre implicata, ed in
primo luogo è implicata nella distinzione tra
soggetto (che finge l’unità) ed oggetto (l’unità
pensata), cioè dall’attività stessa del pensare e
del rappresentare. In secondo luogo, essa è implicata dalle pluralità pensate, poiché 2 = (1+1)
è diverso da 3 = (1+1+1), benché, secondo il pensiero dell’identità, solo quantitativamente»33.
Le lingue non sono entità identiche, ma diverse: come suggestivamente fissato nel mito
biblico di Babele34, le lingue sono plurime,
il Sessantotto segna il passaggio dalla modernità alla
post-modernità (o tardo-modernità), alla possibilità di
accettare – anzi, invocare – la debolezza che affligge il
pensiero quando deve trovare un fondamento durevole
per i sistemi e le ideologie (per le visioni del mondo), nel
nome di un’uguaglianza che non ha più bisogno di modelli o di teorie, poiché – neoplatonicamente – si consuma tutta nell’enade individuale» (p. 459). «La parabola
dei diritti umani è efficacemente rappresentata sul piano linguistico dalla trasformazione dell’aggettivo qualificativo: da diritti dell’uomo e del cittadino essi diventano diritti civili; poi, nel corso del XIX secolo, diritti sociali
e politici; si opacizzano nel corso del Novecento, afflitto
dai totalitarismi, per ricomparire dopo il Sessantotto
come una sorta di energia che trasforma qualsiasi desiderio dell’uomo in diritto (Kundera)» (p. 463).
32 Manzin in Ordo Iuris, cit., argomenta la tesi secondo
la quale fu il pensiero neoplatonico a fornire i presupposti per una progressiva riduzione dell’ordine dinamico
del logos, come inteso in senso classico, ad ordine sistematico, di tipo razionalistico, proprio della modernità.
33 M. Manzin, loc. ul. cit., p. 20.
34 Gen., 11, 1-9, ed. CEI, consultabile alla pagina web
<http://www.vatican.va/archive> (sito consultato il
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
differenti e costituiscono un insieme solo apparentemente caotico. Durante la costruzione
della Torre, infatti, tutta la terra aveva una sola
lingua: la differenziazione linguistica, dunque, sorge da, e si collega ad, un unico linguaggio originario. Nella lingua greca,come è noto,
l’attività del linguaggio quale è esercitata dagli
uomini si esprime con il termine logos, che ha
«Un significato anteriore, più originario, di
quello che si congiunge immediatamente al
dire. Esso designerebbe la capacità di tutti gli
elementi di un mondo di connettersi tra loro
senza perdere - anzi, così mostrando - la loro
rispettiva individualità. Logos esprimerebbe
allora l’unione in atto, e quindi la connettibilità, tra cose diverse: da ciò Logos varrebbe anche ad indicare tanto la potenza per la quale la
connessione si manifesta quanto la presenza
in atto di quest’ultima»35. Il fatto è che, secondo Francesco Cavalla, cui si deve uno studio
approfondito sull’argomento, il Logos, nel suo
significato originario, non designa solo attività linguistiche, ma «Ci parla di una realtà
che trascende il discorrere (rivelando peraltro,
con lo stesso, una indissolubile intimità)»36.
«Sicché, si potrebbe dire, il Logos anticipa il
mondo destinandolo a comparire in un linguaggio articolato. Perciò il Logos non assomiglia semplicemente al linguaggio, né lo forma
come una realtà particolare tra altre; costituisce, piuttosto, quel Principio che si manifesta
4/9/2009): [1] «Tutta la terra aveva una sola lingua e
le stesse parole. [2] Emigrando dall’oriente gli uomini
capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si
stabilirono. [3] Si dissero l’un l’altro: “Venite, facciamoci
mattoni e cuociamoli al fuoco”. Il mattone servì loro da
pietra e il bitume da cemento.[4] Poi dissero: “Venite,
costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il
cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta
la terra”. [5] Ma il Signore scese a vedere la città e la torre
che gli uomini stavano costruendo. [6] Il Signore disse:
“Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora quanto
avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile.
[7] Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua,
perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro”.
[8] Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. [9] Per questo la si chiamò
Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la
terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra».
35 F. Cavalla, La verità dimenticata, Padova, 1996, p. 132.
36 Ibid., p. 133.
89
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
– per quanto si manifesta – là dove accade il
linguaggio»37.
In questa prospettiva, che è anche quella del
celebre prologo giovanneo38, ciò che è anteriore in assoluto è la differenza, che anticipa ogni
cosa: unità e pluralità si implicano indissolubilmente a vicenda.
Questa prospettiva viene «dimenticata» nella modernità, che assume il Principio come assoluta identità ed interpreta la differenza in modo
meramente quantitativo: questo è il presupposto teoretico che si cela dietro il regime linguistico plurilingue adottato nello Statuto dell’Organizzazione Internazionale. È significativo che
la Carta Statutaria si limiti ad elencare le lingue
ufficiali della Corte, individuandole quantitativamente nel numero di sei e giustapponendole
come entità linguistiche equipollenti.
Ciò che occorre recuperare è la consapevolezza che le versioni linguistiche sono diverse,
e quindi suscettibili di entrare in contrasto tra
loro, ma che c’è un principio che consente di
dirle e pensarle unitariamente.
Il metodo topico-retorico per la soluzione del contrasto tra versioni linguistiche
Resta da approfondire quanto dichiarato
in chiusa al precedente paragrafo: si tratta ora
di sviluppare le precedenti considerazioni dirigendole ad un fine specifico, quello di comprendere cosa accade quando manchi l’unità
di senso tra le differenti versioni linguistiche
(im)posta dall’art. 128 dello Statuto CPI39. Lo
Statuto suppone la perfetta concordanza tra
le varie versioni linguistiche ed assume che
i testi abbiano lo stesso significato e la stessa
valenza in tutte le lingue40. È pacifico però che
37 Ibid., p. 132.
38 Gv. 1,1: a Francesco Cavalla si deve uno studio approfondito sul proemio evangelico (vedi F. Cavalla, loc. ul.
cit., pp. 167-182).
39 Il tema dell’interpretazione dei testi giuridici plurilingui, con precipuo riferimento allo Statuto della CPI,
è trattato da E. Fronza, Les sources du droit international
penal. L’expérience des tribunaux pénaux internationaux et le
statut de la cour pénale internationale, Paris, 2004, pp.157210.
40 A titolo esemplificativo, intendo riportare la citazio-
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
nella prassi possono verificarsi ipotesi di divergenza di senso tra i testi di pari valore.
Nello specifico, lo Statuto della CPI non
offre, normativamente, alcun criterio ermeneutico di cui avvalersi per determinare la
versione prevalente41. L’assenza di una regola
risolutiva generale e astratta non sarebbe, per
sé, il punto più rilevante, perché ciò di cui abbisogna il giurista non è semplicemente un
quadro sistematico-normativo per risolvere
le questioni che si presentano42, ma una logica
ne di Rodolfo Sacco, il quale evidenzia che «Il vocabolo
giuridico non ha necessariamente un solo significato. La
parola contract in quanto vocabolo di diritto positivo inglese o americano, si rapporta all’accordo (agreement) fondato su una consideration. A fianco del contract, il contratto
francese ed il Vertrag tedesco che non comportano necessariamente un vantaggio per il promittente o uno svantaggio per colui che stipula. La nozione giuridica ha una
sua bivalenza, per cui da un canto è una nozione di diritto
positivo, e da un altro canto è una nozione (normalmente
dotata di contenuto più generale) appartenente alla teoria generale del diritto» (R. Sacco, Lingua e diritto, in AA.
VV., Traduzione e diritto, Padova, 2000, p. 128).
41 Per quanto attiene alle questioni del plurilinguismo
nei trattati, frequente è il riferimento all’art. 33 della
Convenzione di Vienna del 1969 che recita: «1. Quando
un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo
testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il
trattato non disponga o che le parti non convengano che
in caso di divergenza prevalga un testo determinato. 2.
Una versione del trattato in una lingua diversa da una
di quelle in cui il testo è stato autenticato sarà considerato come testo autentico solo se il trattato lo prevede o
se le parti si sono accordate in tal senso. 3. Si presume
che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato
nei diversi testi autentici. 4. Salvo il caso in cui un testo
determinato sia destinato a prevalere ai sensi del paragrafo 1, quando il raffronto dei testi autentici fa apparire
una differenza di senso che l’applicazione degli articoli
31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il senso
che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato,
permette di meglio conciliare i testi in questione».
42 Per un’alternativa critica alla prospettiva normativista,
si vedano, tra i molti possibili, S. Cotta, Giustificazione e
obbligatorietà delle norme, Milano, 1998. Cotta ha rappresentato nella sua forma più autorevole una posizione alternativa al normativismo nell’ambito della filosofia del
diritto italiana nel secondo dopoguerra. La posizione
antinormativista conosce anche una corrente di studi
ispirata al pensiero della classicità, di cui è esponente
di rilievo Francesco Cavalla [in prop. vedi F. Cavalla,
La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di
Enrico Opocher, Padova, 1991, e più recentemente Id. (a
cura di), Retorica, processo, verità, Milano, 2007; nonché
M. Manzin (a cura di), Interpretazione giuridica e retorica
90
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
«Che gli consenta di tener conto delle possibili alternative d’impostazione del discorso che
gli si prospettano dinanzi al caso di specie, e di
prescegliere, ai fini dello sviluppo del medesimo, quella concretamente più promettente»43.
Più correttamente, il problema non è rappresentato dal fatto che lo Statuto non dia atto
della diversità delle versioni linguistiche (con
irrisolta conflittualità), con ciò alimentando il
mito dell’equivalenza egualitaria dei testi autentici. Ma, giova ripeterlo, la soluzione del
contrasto paventato e delle difficoltà applicative del diritto non può ricercarsi in una griglia
generale e astratta44.
La prassi giuridica e politica della modernità
ha assegnato alla regola il carattere di principio
costitutivo del diritto: secondo questa visione teoretica, la norma si rivolge ad una classe
indeterminata di soggetti, garantisce l’uguaglianza di trattamento dei destinatari della sua
applicazione e viene emanata al fine di prevenire la controversia. Ma non si può pretendere
di eliminare la controversia, in tanto in quanto
è ineliminabile la differenza che è a fondamento della realtà45.
Alla luce di ciò, si rende necessario acquisire
coscienza della centralità di una logica che organizzi l’esperienza giuridica non in un sistema statico, di marca razionalistica e cartesiana,
ma in un ordine dinamico, in linea con la concezione classica. Infatti, «La conoscenza di una
forense: il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale, Milano, 2006; P. Moro, La via
della giustizia, Pordenone, 2001].
43 D. Velo Dalbrenta, Brocardica, Milano, 2007, p. 102.
L’Autore, ponendosi alla ricerca del principio costitutivo dei brocardi, riscopre la centralità della topica, della
dialettica e della retorica nell’esperienza processuale. La
funzione del brocardo, in particolare, non è quella di orpello esornativo del discorso, bensì quella di rappresentare con chiarezza il punto di vista di chi parla, affinché
si possa identificare con la stessa chiarezza il punto di
vista opposto e procedere al confronto dialettico.
44 Per una prospettiva antinormativista interna al positivismo giuridico, vedi utilmente D. Patterson, Law
and Truth, cit., e talune recenti aperture nell’ambito del
cd. costruttivismo, il cui rappresentante più autorevole
in Italia è Vittorio Villa (V. Villa, Il positivismo giuridico:
metodi, teorie e giudizi di valore. Lezioni di filosofia del diritto, Torino, 2004).
45 Su questo tema si veda M. Manzin, Ordo Iuris, cit.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
forma astratta non toglie il problema di vedere
quali siano le caratteristiche proprie del caso
in discussione e quali lo rendano comprensibile: quali siano cioè quelle che si associano in
modo ricorrente in una serie di fenomeni già
nota in un dato contesto»46.
In questa prospettiva, l’unica logica e metodologia di cui il giurista non può fare a meno è
la topica giuridica47. L’attività topica si sviluppa
quando si scontrano opposte tesi che non possono venire organizzate da un principio unico
accolto da tutti gli interlocutori. Segnatamente, Aristotele individuava il genere dei discorsi
propri della topica in quello delle discussioni
amicali, dei dibattiti politici e dei discorsi giudiziari48. Ecco che la topica è intrinsecamente
destinata ad esercitare la sua funzione insostituibile anche per la composizione della controversia che sorga dal contrasto tra versioni
linguistiche, facenti fede in pari misura.
A riprova di quanto affermato, si consideri
l’argomentazione della Trial Chamber nella
decisione del caso Akayesu49: essa corrisponde
a quella peculiare logica per la quale i mezzi
retorici possono produrre una premessa da
cui derivare una conclusione stringente in
quel determinato contesto. Si riconoscerà in
essa un esempio di generalizzazione in senso
retorico-giuridico, che consente ad una regola
di farsi premessa di ragionamento, entro quel
determinato contesto argomentativo50.
Jean Paul Akayesu, sindaco della città ruandese di Taba, fu processato dal Tribunale Internazionale per il Ruanda (d’ora in poi TPIR) e
condannato nel 1998 all’ergastolo per il massacro di duemila Tutsi rifugiati nel municipio
di Taba, lo stupro collettivo delle donne Tutsi
46 Cfr. F. Cavalla (a cura di), Retorica, processo, verità, cit.,
p. 65.
47 Cfr. F. Cavalla, vc. Topica giuridica, in Enciclopedia
del diritto, Milano, 1992; Id., vc. Logica giuridica, in
Enciclopedia Filosofica, Milano, 2006; Id., Retorica, processo, verità, cit.
48 Aristotile, Retorica e Poetica, M. Zanatta (a cura di),
Torino, 2004, III, 17.
��������
TPIR, Prosecutor c. Akayesu, Trial Chamber, 02 October
1998.
50 Sul concetto di generalizzazione, veggasi F. Cavalla,
Retorica, processo, verità, cit., p. 59ss.
91
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
e la partecipazione diretta a diversi omicidi51.
La decisione del TPIR sul caso Akayesu ha una
funzione paradigmatica nella misura in cui
fornisce una serie di elementi interpretativi in
relazione al crimine di genocidio, elencando e
descrivendo la condotta penalmente rilevante
ai fini del reato.
Rispetto al tema conduttore di questo lavoro, di interesse è il ragionamento della Corte
nella parte in cui risolve una questione definitoria generata dal contrasto tra due versioni
linguistiche, quella inglese e quella francese,
del testo dello Statuto del Tribunale Speciale.
L’art. 2 dello Statuto enuncia, infatti, che
per genocidio si intende «Uno qualsiasi dei
seguenti atti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso in quanto tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) attentato grave all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
51 TPIR Sentenza 02 ottobre 1998. Il capo di imputazione nei confronti di Akayesu era per il seguenti fatti: «1.
Akayesu is individually, criminally responsible for the
killing of and causing serious bodily or mental harm
to members of the Tutsi group. 2. Akayesu aided and
abetted acts of sexual violence by allowing them to take
place on or near the premises of the bureau communal
while he was present on the premises and by facilitating the commission of these acts through his words of
encouragement. In other acts of sexual violence which
by virtue of his authority sent a clear signal of official
tolerance for sexual violence without which these acts
of sexual violence would not have taken place. 3. On 19
April 1994, Akayesu addressed a meeting at Gisheshe
and called on the population fight against accomplices
of the Inkotanye knowing that his utterances would
be understood by the people present to mean, kill the
Tutsi, and as a result thereof widespread killing of Tutsi
had commenced in Taba. 4. At this meeting in Gisheshe,
Akayesu mentioned the name of Euphraim Karangwa.
Later on, that same day, groups of people acting on
the orders of Akayesu and in his presence, destroyed
Karangwa’s house and Karangwa’s mother’s house and
killed Karangwa’s three brothers. 5. Akayesu is individually, criminally responsible for the death of the eight
refugees from Ruanda who were killed in his presence
by the Interahamwe acting on his orders. 6. Akayesu is
individually, criminally responsible for the killing of
the five teachers who were killed by the Interahamwe
and local population acting on his orders. Lastly, point,
7, Akayesu is individually, criminally responsible for
the torture of Victims».
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
c) inflizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita preordinate a condurre alla sua
distruzione fisica, totale o parziale;
d) imposizione di misure tese ad impedire
nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciullo del
gruppo in un altro gruppo».
Dalla lettura della norma si comprende che
il crimine di genocidio non implica la sterminazione del gruppo nella sua interezza ma,
ai fini dell’integrazione, è sufficiente che sia
commessa una delle azioni menzionate nel
succitato articolo con la specifica intenzione
di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo
nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Il genocidio richiede cioè il dolus specialis, cioè la sussistenza di uno special intent
che consiste appunto in «specific intention to
destroy, in whole or in part, a national, etnical,
racial or religious group».
Con riferimento alla condotta incriminata ex art. 2 co. 2 lett. a) dello Statuto, in ossequio alla quale è genocidio «killing members
of the group», la Corte nota che la versione
francese utilizza il termine «meurtre», quella
inglese «killing». Le espressioni linguistiche
in discussione non sono equivalenti: il termine «killing» utilizzato nella versione inglese
appare alla Corte troppo generico in quanto
comprende sia l’omicidio doloso (intentional
homicide) sia l’omicidio colposo (unintentional
homicide). Il termine utilizzato nella versione
francese, «meurtre», è più preciso e pregnante. La Trial Chamber giustifica pertanto la preferenza per questa concezione rispetto all’altra,
offrendo argomenti volti a mostrare la sua idoneità a normare il caso di specie in ragione della sua conformità a ciò che è ritenuto il sapere
giuridico in quel contesto territoriale. Più precisamente, la versione francese risulterebbe
maggiormente compatibile con la concezione
di uccisione espressa all’art. 311 del Codice Penale Ruandese il quale sancisce che «Homicide committed with intent to cause death shall
be treated as murder». Inoltre, in ossequio alla
presunzione di innocenza dell’imputato e ai
principi generali della legge penale, la Corte
ritiene che nella versione francese possa essere individuata la versione più favorevole al reo
92
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
e concordante con la definizione di «murder»
fornita dall’art. 311 del Codice Penale del Ruanda in quanto contempla solo l’ipotesi di omicidio commesso con l’intento di causare la morte ed esclude l’ipotesi di omicidio colposo52.
In tutta evidenza, l’attività dell’argomentare della Corte, chiamata, nel giudizio penale,
ad individuare i confini del concetto di genocidio inteso come uccisione di membri di
un gruppo, a fronte di due versioni opposte,
si svolge a partire da una premessa che viene
precisandosi per accumulo. «Definire implica sempre, anche, riportare in un campo più
ampio: nel campo, quindi, dove le proprietà
del fenomeno si ripetono associate formando
una serie»53. Quindi, il retore non dice ciò che
è implicito nella premessa, ma aggiunge alla
stessa una serie di note caratteristiche idonee a
fornire, in quel determinato contesto e tempo,
indicazioni univoche sui fatti dedotti in giudizio. Questo procedimento produce una pro52 Per completezza riporto l’argomentazione della Trial
Chamber sul punto, parr. �����������������������������
500-501, TPIR ���������������
sentenza 02 ottobre 1998: «500. With regard to Article 2(2)(a) of the
Statute, like in the Genocide Convention, the Chamber
notes that the said paragraph states “meurtre” in the
French version while the English version states “killing”. The Trial Chamber is of the opinion that the term
“killing” used in the English version is too general, since
it could very well include both intentional and unintentional homicides, whereas the term “meurtre”, used in
the French version, is more precise. It is accepted that
there is murder when death has been caused with the
intention to do so, as provided for, incidentally, in the
Penal Code of Rwanda which stipulates in its Article 311
that “Homicide committed with intent to cause death
shall be treated as murder”. 501. Given the presumption
of innocence of the accused, and pursuant to the general
principles of criminal law, the Chamber holds that the
version more favourable to the accused should be upheld and finds that Article 2(2)(a) of the Statute must be
interpreted in accordance with the definition of murder given in the Penal Code of Rwanda, according to
which “meurtre” (killing) is homicide committed with
the intent to cause death. The Chamber notes in this
regard that the travaux préparatoires of the Genocide
Convention, show that the proposal by certain delegations that premeditation be made a necessary condition
for there to be genocide, was rejected, because some delegates deemed it unnecessary for premeditation to be
made a requirement; in their opinion, by its constitutive physical elements, the very crime of genocide, necessarily entails premeditation».
53 F. Cavalla, Retorica, processo, verità, cit., p. 61.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
issn 2035-584x
posizione fondamentale (la premessa) ed una
serie di proposizioni da essa dipendenti che
hanno la funzione di precisarne il significato.
In ciò consiste l’operazione di precisazione del
significato del dato normativo controverso
avvicinandolo al caso particolare. «Tale procedura raggiunge il suo scopo quando sono state
nominate tante proprietà che si associano in
modo ricorrente nell’esperienza, tanto che la
loro frequenza sia riconoscibile e riconosciuta
da chi ascolta»54. In altre parole, la Corte, nel
continuo trascorrere dal particolare e concreto
del caso al generale e astratto della regola, ricava la premessa veramente adeguata al caso,
perché dipendente da un sapere irrinunciabile
in quel contesto, da cui poter poi derivare una
conclusione necessaria.
Conclusioni
In chiusura di questo lavoro, sembra opportuno ripresentare, in sintesi, la complessità
del problema implicato dalla scelta di un regime plurilingue, riproponendo le acquisizioni
fatte proprie nelle linee di approfondimento
tematico percorse.
L’indagine ha preso le mosse dalla lettura
dello Statuto di un’istituzione giudiziaria internazionale, la Corte Penale Internazionale,
quale organo deputato ad introdurre garanzie
giurisdizionali contro le violazioni della pace e
dei diritti dell’uomo. In particolare, l’attenzione è stata riposta su un dato, espresso normativamente negli enunciati degli artt. 50 e 128,
vale a dire la scelta di Arabo, Cinese, Inglese,
Francese e Russo quali lingue ufficiali, facenti
fede in pari misura. Per il vero, come si è detto,
le questioni del plurilinguismo possono essere studiate con riferimento alla legislazione, ai
trattati o ai contratti nella misura in cui è prassi diffusa, espressione di un crescente multilateralismo nelle relazioni internazionali, la redazione dell’atto in più versioni autentiche: le
differenti versioni linguistiche, equally authentic, rappresentano l’enunciazione linguistica
plurima di una medesima norma destinata ad
operare in tutti gli Stati membri.
L’intento del saggio era quello di mostrare
54 Ibid.
93
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
come la suddetta dichiarazione di equipollenza possa considerarsi un portato del pensiero
identitario, proprio della modernità, contrassegnato da una tensione egualitaria che si traduce in un ideale giuridico e politico volto ad
eliminare le differenze ed a valorizzare l’identità. Così le lingue ufficiali dell’Organizzazione Internazionale sono individuate numericamente e giustapposte quali entità linguistiche
equivalenti, con la conseguente rescissione di
ogni rapporto tra lingua e sistema.
Si è notato infatti che la traduzione del linguaggio giuridico si scontra con problemi di
natura semantica e sintattica nonché con la
specificità sistemica della lingua.
Quindi, a fronte della finzione di equivalenza tra le versioni linguistiche, si pone il problema della divergenza di senso tra testi di pari
valore e della necessità di determinare il risultato linguistico prevalente. La soluzione del
contrasto non risiede in una griglia generale
e astratta, in quanto è necessario tener conto
delle possibili alternative d’impostazione del
discorso che si prospettano dinanzi al caso di
specie e prescegliere, ai fini dello sviluppo del
medesimo, quella concretamente più promettente. In questa prospettiva, la logica di cui il
giurista non può fare a meno è quella della topica giuridica. A riprova della necessità e della
bontà di questa indicazione metodologica, è
stata proposta l’argomentazione del TPIR nella
decisione del caso di Akayesu, giudicato per il
crimine di genocidio, riconoscendo in essa un
esempio di generalizzazione in senso retoricogiuridico: la versione francese dell’art. 2 co. 2
lett.a) dello Statuto diventa la premessa del ragionamento giudiziale entro quel determinato contesto argomentativo.
Topica, dialettica, retorica ci riportano al quadro di quella logica giuridica di origine classica
che è stata offuscata nella modernità, e che occorrerebbe invece assumere consapevolmente
nel ragionamento giudiziale per renderlo aderente al contesto linguistico controversiale e
semanticamente vago in cui esso si svolge55.
Serena Tomasi si è laureata nel 2008 presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Attualmente è
iscritta al secondo anno della Scuola di Dottorato
in Studi Giuridici Comparati ed Europei dell’Università di Trento e collabora alle attività della cattedra di Filosofia del diritto (prof. M. Manzin) e del
CERMEG.
55 Per un approccio ai profili di applicazione forense
di topica, dialettica e retorica, cfr. F. Cavalla (a cura
di), Retorica, processo, verità, cit., nonché M. Manzin,
Ricordando Perelman, in G.A. Ferrari, M. Manzin (a cura
di), La retorica tra scienza e professione legale, Milano,
2004, p. 17ss., P. Moro (a cura di) Metodologia della scrittura forense. Manuale di redazione del parere motivato e
dell’atto giudiziale, Trento, 2006.
Il pluralismo linguistico tra identità e differenza
94
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Il diritto alla privacy tra passato,
presente e futuro
Francesca Fabris
Abstract
Nonostante si tratti di un concetto diffuso, non esiste
una uniforme definizione di diritto della privacy. La natura poliedrica del concetto di privacy risulta ancor più
evidente ripercorrendone l’evoluzione storica dalle origini sino agli ultimi interventi legislativi. Da tale analisi
emerge come, alla luce del passato e del presente, molti
non potranno che essere in futuro gli ulteriori interventi
necessari in materia, quantomeno fintanto che non si
diffonderà una vera a e propria cultura della privacy.
Sommario
Parole chiave
1. L’evoluzione del concetto di privacy;
2. Il diritto alla privacy nell’ordinamento
italiano; 3. La tutela della privacy
privacy; riservatezza;
dati personali;
amministratore di sistema
1 - L’evoluzione del concetto di privacy
È
comune ritenere che il concetto di privacy
sia il recente parto della mente di qualche
giurista, causa forse il termine anglosassone
utilizzato.
In realtà la nozione di privacy ha antiche e
nobili origini, come magnificamente esposto
da Sergio Niger nella sua opera Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla
protezione dei dati personali1. Questo autore ripercorre l’evoluzione storica vissuta dal diritto
alla privacy, dai tempi dell’Antica Grecia sino ad
oggi evidenziando come «la nozione di privacy
non è una nozione unificante. Non è cioè un
concetto che esprime esigenze uniformemente e coerentemente diffuse nella storia e nella
collettività»2.
Gli antichi greci ritenevano fondamentale,
quasi un dovere, per i propri cittadini maschi,
1 S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla
riservatezza alla protezione dei dati personali, Padova 2006.
2 S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla
riservatezza alla protezione dei dati personali, cit., p.XI
Il diritto alla privacy tra passato presente e futuro
la partecipazione alla vita pubblica3; essi riconoscevano anche la necessità per ognuno di
avere una sfera privata, ma si trattava dell’ambito strettamente limitato all’espletamento dei
propri bisogni e delle proprie necessità, vicino
alla fondamentale bios politikos4.
La polis riteneva e tutelava come sacri i confini della proprietà ma a fondamento di ciò non
vi era il rispetto della proprietà privata, come
saremmo portati a credere, bensì il fatto che
«senza una casa un uomo non poteva partecipare agli affari della città, perchè in essa non
3 «un uomo che vivesse solo una vita privata e che, come
lo schiavo, non potesse accedere alla sfera pubblica o
che, come il barbaro, avesse scelto di non istituire un
tale dominio, non era pienamente umano», H. Arendt,
Vita activa. La condizione umana, trad. it. di A. Dal Lago,
Milano, 2001, p.19.
4 «Di tutte le attività necessarie e presenti nelle comunità umane, solo due erano stimate politiche e costitutive di quello che Aristotele chiamò il bios politikos, cioè
l’azione (praxis) e il discorso (lexis), da cui trae origine il
dominio degli affari umani […], dal quale ogni cosa meramente necessaria o utile è rigorosamente esclusa»,
ibidem
95
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.1 (luglio-dicembre)
aveva un luogo che fosse propriamente suo»5.
La privacy fine a se stessa, come vita spesa
fuori dal mondo comune, acquisiva una connotazione quasi antisociale, tanto che «lo stesso Platone riteneva che in una società ideale
non vi fosse alcun bisogno di una sfera privata
in cui l’individuo potesse rifugiarsi. Questo bisogno veniva visto come un pretesto per sottrarsi agli obblighi etici e sociali»6.
Proseguendo nella propria evoluzione, il
termine privato divenne, in età medievale, sinonimo di familiare. In quell’epoca, infatti, la
vita privata era basata sulla fiducia reciproca
che univa i membri del gruppo7 , dando luogo,
quindi, ad una vita familiare intesa in senso
conviviale, ove non vi era spazio per l’individualità.
Con la feudalizzazione il potere pubblico
si frammentava in uno «sbriciolamento che
finisce col disseminare i diritti del potere pubblico, di casa in casa, col trasformarsi di ogni
grande casa in un piccolo stato sovrano dove si
esercita un potere che pur essendo contenuto
in una cornice ristretta, pur essendosi infiltrato in seno alla dimora, conserva nondimeno il suo carattere originale che è pubblico»8.
La società feudale era, pertanto, caratterizzata
dalla fitta serie di relazioni che collegavano gli
individui che ne facevano parte, finché si svi5 S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla
riservatezza alla protezione dei dati personali, cit., p.2.
6 Ibidem.
7 «Attorno ai termini che esprimono a quest’epoca la nozione di privacy c’è in effetti una costellazione di altri termini che arricchiscono questa nozione. Soffermiamoci
su uno di questi, commendatio, parola chiave, in verità
poiché definisce l’entrare in quella relazione su cui si
costruiva la concordia nell’interno dei gruppi privati.
Come tradurre? Con quest’atto un individuo si affida ,
affida la sua persona, si lega al capo di un gruppo e attraverso di lui, a tutti coloro che formano il gruppo, con
un legame affettivo molto potente che la lingua volgare
e la lingua dotta chiamano amicizia e che costituisce il
cemento di tutti gli ordinamenti interni: da tali rapporti
è strutturata un’entità sociale riparata da una chiusura
protettiva contro la legge, la cui tendenza è ad espandersi, a insinuarsi; quando il potere esteriore riesce a farlo,
manifesta la sua potenza mediante un simbolismo di
penetrazione», G. Duby, Potere privato, potere pubblico, in
Aries P., Duby G (a cura di), La vita privata, vol. II, RomaBari, 2001, p.10.
8 Ibidem.
Il diritto alla privacy tra passato presente e futuro
issn 2035-584x
luppò, come chiaramente esposto da Mumford nel suo libro La cultura delle città, il senso
di intimità9. «Questo infatti significava la possibilità di appartarsi a volontà dalla vita e dalle
occupazioni in comune con i propri associati.
Intimità durante il sonno; intimità durante i
pasti; intimità nel rituale religioso e sociale; finalmente, intimità nel pensiero.. questo fatto
segna la fine delle reciproche relazioni sociali
fra i ranghi superiori e quelli inferiori del regime feudale: relazioni che avevano mitigato la
sua oppressione. Il desiderio di intimità segnò
l’inizio di quel nuovo schieramento di classi
che era destinato a finire nella lotta di classe
senza quartiere e nelle rivendicazioni individualistiche di un periodo posteriore»10.
Fu così che, con il disgregarsi della società
feudale, si affermò la privacy nella connotazione a noi più vicina.
Secondo Ariès tra gli elementi che contribuirono all’evoluzione di tale concetto vi furono indubbiamente la progressiva costruzione
dello stato moderno e lo sviluppo dell’alfabetizzazione11.
«I secoli XVIII e XIX rappresenterebbero secondo autorevoli storici, l’età aurea del privato,
in cui si precisano parole e cose e le nozioni si
affinano»12.
Appare doveroso rammentare che a tale
periodo risale proprio il right to privacy, ovvero la privacy in ambito giuridico, di Warren e
Brandeis, i quali evidenziarono l’esigenza di
protezione giuridica della personalità di ogni
individuo. Essi indicarono thoughts, sentiments
and emotions, come i beni da tutelare giuridicamente in capo ad ogni individuo.
Così la giurisprudenza anglosassone, equiparando la violazione della privacy a quella del
domicilio o dei luoghi privati, estese a tutela
della sfera privata le stesse regole che erano
9 «il primo mutamento radicale […] destinato ad infrangere la forma della casa abitazione medievale fu lo
sviluppo del senso di intimità», L. Mumford, La cultura
delle città, trad. it. Di E. e M. Labò, Milano 1967, p.53.
10 Ibidem.
11 P. Ariès, Per una storia della vita privata, in Ariès p., Duby
G. (a cura di), La vita privata, vol. III, cit., p.VI.
12 S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto
alla riservatezza alla protezione dei dati personali, cit., p.25.
96
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.1 (luglio-dicembre)
state poste a garanzia del pacifico godimento
delle proprietà13.
L’evoluzione del concetto di privacy non si
arresta grazie soprattutto all’interpretazione
giurisprudenziale, «trovando esplicazione in
situazioni profondamente differenti che vanno dal diritto del singolo ad impedire comportamenti intrusivi nella propria vita privata ad opera dei media, al diritto di aborto, alla
libertà sessuale»14 e così manifestando tutta la
propria natura poliedrica. Si giunge, pertanto,
a parlare di informational privacy e di decisional
pivacy. Entrambe hanno «come fulcro il riconoscimento e la garanzia del potere di autocontrollo in capo al singolo, che nel primo caso
si manifesta in una sorta di signoria sulle informazioni inerenti la propria persona, traducendosi in un limite non solo alla diffusione di
indiscrezioni sulla vita privata, ma anche, più
in generale, alla raccolta ed all’impiego arbitrario dei dati personali; mentre nella seconda
declinazione la privacy diviene la libertà di autodeterminarsi rispetto alle scelte personali,
siano esse pertinenti al procreazione, la libertà sessuale o la libertà di organizzazione»15. Il
concetto di right to privacy finisce per diventare
un “contenitore concettuale”, come lo chiama
Mantelero16, all’interno del quale confluiscono
tutte le modalità di tutela della libertà personale garantite al singolo dallo Stato.
2. Il diritto alla privacy
nell’ordinamento italiano
Da quanto sin qui richiamato emerge chiaramente la difficoltà di fornire una definizione
di privacy. Si tratta di un diritto che proprio per
la sua intrinseca complessità non ha trovato
immediatamente riconoscimento in Italia.
Vista l’assenza, nel nostro ordinamento, di
una norma generale e astratta a definizione e
tutela di tale diritto, il problema principale è
stato quello di trovare un “appiglio” normativo
13 La tutela di tale diritto veniva azionata mediante il
trespass.
14 A. Mantelero, Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, Milano, 2007, p.1.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
Il diritto alla privacy tra passato presente e futuro
issn 2035-584x
dal quale far derivare la tutela generale dell’interesse alla riservatezza.
Ecco che il fondamento della tutela alla privacy è stato rinvenuto negli articoli 13 e 3 della Costituzione, il primo parla di inviolabilità
della persona, il secondo di diritto alla dignità.
La riservatezza viene quindi individuata
come quello «interesse che in base ad una certa valutazione legislativa e sociale risulta fondamentale per l’individuo. Questi ha bisogno
per poter condurre la propria vita di vedersi
riconosciuto un certo ambito privato dal quale poter escludere l’altrui ingerenza; è la stessa natura umana che rifiuta l’indiscriminata
pubblicizzazione di ciò che riguarda nell’intimo. Il rifiuto di tale riconoscimento finirebbe
col menomare gravemente l’individuo e col
pregiudicare lo stesso valore della persona,
quindi la sua dignità; di qui la tutela implicita, anche sotto questo aspetto, del diritto alla
riservatezza»17. Definendo la riservatezza un
valore essenziale della persona, il diritto alla
privacy viene fatto rientrare tra i diritti inviolabili della persona e, quindi, tutelato dall’art.
2 della Costituzione. «In questa prospettiva
l’art. 2 Cost. non è più una formula riassuntiva
dei diversi diritti della persona costituzionalmente riconosciuti, ma una clausola generale
attraverso la quale operare il continuo adeguamento delle garanzie giuridiche alle sempre
nuove esigenze di tutela della persona»18.
È superfluo evidenziare come dette esigenze siano mutevoli nel tempo e come, soprattutto, il loro incremento sia direttamente proporzionale alla diffusione dei computer. Con la
“distribuzione” dell’informatica, il computer
non rappresenta più solamente uno strumento finalizzato allo svolgimento di un’attività
lavorativa ma diviene un home computer; tutti
possono così servirsene per giocare, studiare,
disegnare, scrivere e addirittura creare banche
di dati personali.
Se da un lato la diffusione dei computer
rappresenta una indubbia conquista del progresso, non si può sottacere il rischio che tale
17 T.A. Auletta, Riservatezza e tutela della personalità,
Milano, 1978, p. 36.
18 S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto
alla riservatezza alla protezione dei dati personali, cit., p. 43.
97
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.1 (luglio-dicembre)
diffusione accompagna: il consolidamento di
quello che taluno definisce un “potere occulto”. «Man mano che si amplia il numero dei
possessori di computer si allarga conseguentemente quello dei detentori del nuovo potere
informatico, consistente nel controllo sui singoli, reso possibile dall’acquisizione e dall’elaborazione di informazioni, spesso anche apparentemente neutre. Un potere spesso occulto,
sia per le modalità di esercizio, essendo possibile un archivio di dati a completa insaputa dei
soggetti interessati in assenza di alcuna regolamentazione, sia in ragione dell’ignoranza da
parte delle persone a cui le informazioni si riferiscono di quelli che sono le modalità tecniche ed i meccanismi di gestione delle stesse»19.
Tale potere occulto, all’inizio solo appannaggio
della pubblica amministrazione, si è poi diffuso a macchia d’olio anche alle imprese private, basti pensare al fatto che nel 1981 in Italia
le banche dati erano già 61.71720 e da allora si
sono moltiplicate esponenzialmente.
Accedendo ad una o più banche di dati o, addirittura, collegando i dati nelle stesse contenuti, diviene possibile conoscere aspetti della
vita di ciascuno, dalle abitudini di consumo
ai propri rapporti sociali, dal proprio stato di
buono o cattivo pagatore (si pensi alla Centrale rischi della banche) ai siti internet visionati
più di frequente e perfino ai propri dati sanitari. Lungo è l’elenco di informazioni che vengono fornite, più o meno inconsapevolmente, e
quotidianamente trattate.
Si è resa, quindi, subito manifesta la necessità di regolamentare tale attività. Quasi tutti
gli stati europei hanno così adottato apposite
legislazioni per la tenuta e l’utilizzo delle banche dati. Per quanto concerne l’Italia bisogna
però aspettare sino al 199621 perchè il nostro
19 A. Mantelero, Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, cit., p. 14.
20 Tale dato risulta dalla Relazione al Parlamento sulla rilevazione delle banche dati privati ai sensi dell’art. 8, legge 1
aprile 1981, n. 121, elaborata dal Ministero dell’interno e
relativa ai dati aggiornati al 31 dicembre 1981, riportata
in V. Zeno-Zencovich (a cura di), Le banche dati in Italia,
Realtà normativa e progetti di regolamentazione, Napoli,
1985, p. 217 e ss.
21 Il 31 dicembre 1996 entra in vigore la legge n. 675. Per
uno studio comparatistico sul rapporto tra la l. 675/96
Il diritto alla privacy tra passato presente e futuro
issn 2035-584x
stato, in notevole ritardo rispetto agli altri stati europei, si doti di una normativa per il trattamento dei dati personali22. Successivamente
vari altri testi normativi sono stati emanati in
tale materia, testi che hanno trovato ordine
nel noto Codice in materia di protezione dei
dati personali adottato con il d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196. Il legislatore, che ha riconosciuto
sin dai primi articoli del Codice il “diritto alla
tutela dei dati personali”, non si è limitato ad
ordinare la materia ma ha dettagliatamente regolamentato il trattamento dei dati.
È, infatti, «nella fase dinamica che affiora
l’esigenza di affiancare una serie di tutele all’affermato diritto sui dati, in maniera da rendere
effettivamente garantita e non meramente
enunciata tale signoria riconosciuta a ciascuno dall’ordinamento. In tal senso il “diritto alla
protezione dei dati personali” viene assicurato
attraverso l’introduzione di precise regole di
condotta a cui l’autore del trattamento deve
attenersi, nonché mediante una procedimentalizzazione del trattamento medesimo al fine
di assicurare in via preventiva, con evidenti finalità deterrenti, la conformità della gestione
dei dati al dettato normativo»23.
Dall’esame del Codice sopracitato emerge
con chiarezza il ruolo centrale assunto dal consenso del titolare del dati24, ma non è l’unico
elemento. Il legislatore infatti non vuole abbandonare la materia alle regole del mercato e,
pertanto, riconosce comunque un nucleo minimo di protezione al singolo proprio con la
regolamentazione di carattere procedimentale
del trattamento. Egli mira a fissare delle regole comportamentali nonché tecniche al fine di
prevenire un uso scorretto delle informazioni
e la direttiva comunitaria 95/46/CE si veda quello di
Zeno- Zencovich, Una lettura comparatistica della l. n.
675/96 sul trattamento dei dati personali, in Riv. Trim. Dir.
Proc. Civ., 1998, p.734 e ss.
22 Oltre all’Italia l’unico altro stato appartenente
all’Unione Europea e sprovvisto di una propria disciplina del trattamento dei dati personali era la Grecia.
23 A. Mantelero, Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, cit., p. 73-74.
24 e ciò a prescindere dalla sua qualificazione giuridica. Secondo alcuni infatti l consenso è un atto unilaterale secondo altri appartiene alla categoria dei negozi
giuridici.
98
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.1 (luglio-dicembre)
assunte pur in presenza del consenso.
3 - La tutela della privacy
Purtroppo vi è un dato di fatto che lo stesso legislatore non ha potuto fare a meno di
constare: l’elevato numero delle violazioni nel
trattamento dei dati personali.
Nella speranza di scoraggiare e limitare tali
violazioni il legislatore ha nel corso degli anni
previsto un inasprimento delle sanzioni, da
ultimo con la conversione in legge del decreto
legislativo n. 207 del 30/12/200825.
Per comprendere la portata economica di
tali mutamenti appare opportuno fare alcuni esempi. Oggi, chi omette di svolgere l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice della
Privacy, o pone in essere un’ informativa inidonea, è soggetto ad una sanzione che va dai
6.000,00 euro ai 36.000,00 euro; chi poi cede
dati violando la normativa stessa è soggetto
ad una sanzione che va dai 10.000,00 euro ai
60.000,00 euro26.
L’intervento del legislatore non si è fermato qui; con la l.n. 14/2009 sono state, inoltre,
introdotte nuove fattispecie di illeciti amministrativi.
L’art. 162 del Codice della Privacy è stato
appunto modificato ed allo stesso sono stati
aggiunti due rilevanti commi: il comma 2 bis
ed il comma 2 ter. Il comma 2 bis dell’art. 162
prende in considerazione l’ipotesi in cui il titolare del trattamento non adotti le misure
minime di sicurezza, previste dall’art 33 del
Codice, volte ad assicurare almeno un livello minimo di protezione dei dati personali, o
violi la normativa vigente in tema di corretto
trattamento dei dati27. Tale ipotesi oggi costituisce un illecito amministrativo sanzionato
con il pagamento di una somma che varia da
20.000,00 a 120.000,00 euro. Il comma 2 ter
introduce, invece, un’altra tipologia di illecito amministrativo che si configura quando il
titolare del trattamento non osserva le misure
necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti e prescritte dallo
stesso Garante, ovvero pone in essere un trattamento dei dati vietato dal Garante. In que25 Il 27 febbraio 2009 il decreto legislativo n. 207 del
30/12/2008 è stato convertito nella legge 14/2009.
26 Con la legge 14/2009 le sanzioni amministrative
sono state praticamente raddoppiate (prima le sanzioni erano infatti di 3.000,00 e 18.000,00 euro nel primo
caso e di 5.000,00 a 30.000,00 euro nel secondo).
27 Si veda l’art. 167 del Codice.
Il diritto alla privacy tra passato presente e futuro
issn 2035-584x
sto caso la sanzione oscilla tra i 30.000,00 ed i
180.000,00 euro.
Recentemente è stato inoltre imposto ai titolari del trattamento dei dati l’onere di nominare l’amministratore di sistema, colui che si
dovrà occupare della gestione e manutenzione
degli impianti di elaborazione con cui vengono effettuati i trattamenti dei dati.
È indubbio il tentativo di tutelare, almeno
formalmente, il corretto trattamento e la custodia dei dati personali, tuttavia tutte queste
innovazioni, una particolareggiata disciplina
normativa, persino la previsione di sanzioni
sempre più gravose non sono e non saranno
sufficienti per recepire nuovi valori nel contesto economico e sociale. Non si può quindi
che concordare con Mantelero, «occorre che
si radichi una cultura della “privacy”, fondata
sulla consapevolezza dell’importanza dei dati
personali e, più in generale, su un maggior
rispetto per l’individuo. È questo un processo
lungo, in quanto incidente su aspetti valoriali,
che può tuttavia essere agevolato da una chiara e coerente applicazione della legge da parte
degli organi deputati a vigilare sull’attuazione
della stessa e, soprattutto, da una divulgazione più lata possibile dei principi che ne sono a
fondamento»28.
Francesca Fabris è dottoranda di ricerca presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, inoltre esercita come avvocato occupandosi prevalentemente di questioni in materia
civilistica.
28 A. Mantelero, Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, cit., pp. 84-85.
99
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
A proposito di comunicazione del rischio in tempi
di pandemia A/H1N1
Eugenio Ambrosi
Abstract
Per essere in grado di gestire la comunicazione durante
una situazione di rischio ci si deve essere lungamente
preparati a farlo: il modo in cui la Regione Friuli Venezia
Giulia ha affrontato la pandemia A/H1N1 nel corso del
2009 ne è puntale conferma.
I diversi soggetti a vario titolo coinvolti (dalle istituzioni
alle organizzazioni ai media) devono aver preparato per
tempo, in periodi “normali” le politiche di comunicazione
da adottare in situazione di crisi: le esperienze maturate
negli anni dalla Regione attraverso specifici progetti
comunitari ne sono state utili punti di riferimento.
Occorrono interventi formativi/informativi integrati e
costanti nel tempo per creare tra la popolazione una vera
e propria cultura della crisi, un mix di codici, linguaggi e
informazioni in grado non solo di favorire l’adattarsi dei
comportamenti dei singoli alla situazione di emergenza
in corso ma, ancor prima, di fare raggiungere la quantità
di fiducia e credibilità indispensabili per permettere al
messaggio di penetrare nella quotidianità del rapporto
istituzioni / cittadini e, quindi, di essere efficace.
Parole chiave
comunicazione istituzionale;
comunicazione del rischio;
comunicazione di emergenza;
pandemia;
influenza.
1. Premessa
A
metà giugno la situazione pandemica della nuova influenza A/H1N1, vulgo influenza suina, è stata certificata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità: l’espansione del virus,
favorita dall’impossibilità di bloccare le frontiere tanto più in epoca di vacanze e voli low
cost, è globale, fortunatamente sin qui sterilizzata dal fatto che il vaccino funziona.
Quando l’articolo verrà pubblicato, anche nella nostra regione sarà stata avviata la vaccinazione, in primis quella delle persone a rischio; ed in
molti, anche autorevoli professionisti, si interrogano ora apertamente sulla sua necessità.
Quando invece l’articolo era stato concepito, la pandemia era sulla bocca di tutti: il 25 luglio, per fare un esempio, il Corriere della Sera
vi dedicava due pagine, la Frankfurter Allgemeine Zeitung una e così il Times; e, ovviamente,
l’elenco potrebbe continuare all’infinito.
Nel dibattito dunque, ora ed allora, in corso
sulla pandemia il concetto di “rischio” è ricorrente: nei media, anche chi non l’ha inserito nei
titoli, ne cita poi ripetutamente il concetto.
Possiamo allora pensare che tale concetto (il
rischio, non la pandemia) sia chiaro a tutti?
Forse si, forse no. Ad esempio, un professore di antropologia dell’ateneo triestino mi ha
fatto notare tempo addietro che il termine ha
una derivazione araba, significa “ipoteca”.
Per evitare allora il rischio che non lo sia,
brevi considerazioni sulla materia si impongono. Diciamo una manciata di pillole.
Emanuele Kant1 era stato chiamato alla corte del
1 Le citazioni in Premessa sono tratte da: V. Ambrosi,
Divulgazione scientifica: istruzioni per il futuro. Il Parque de
las ciencias di Granada come modello per il Parco del mare
di Trieste, Università degli studi di Trieste, Facoltà di
Scienze della formazione, tesi di laurea in Scienze della
comunicazione, a.a. 2006/07.
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
100
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
re di Prussia anche per studiare come prevenire le
conseguenze dei terremoti nella società civile.
Per Max Weber il rischio può essere considerato un genere di realtà virtuale.
Per Jost van Loon solo se si pensa al rischio
in termini di realtà in fieri se ne può comprendere la materializzazione sociale.
Il concetto di rischio, però, se considerato da
un punto di vista scientifico (rischio = incidente x probabilità)2 assume la forma di un calcolo
di probabilità che non potrà mai escludere il
peggiore dei casi. Le assicurazioni funzionano
così, in fin dei conti, secondo V. Prior3.
Niklas Luhmann distingue tra rischio e pericolo, facendo riferimento all’accettazione delle
decisioni del rischio, evidenziando la differenza esistente tra chi decide il rischio (decisore) e
chi è costretto ad affrontarne le conseguenze.
Per Francois Ewald4 il calcolo del rischio
sviluppa forme e metodi che rendono prevedibile l’imprevedibile.
Mentre dischiudendo sfere d’azione sempre più numerose, la scienza crea anche nuovi
tipi di rischio5.
Quanto minore è il numero di rischi pubblicamente riconosciuti, tanto maggiore è quello
di rischi prodotti.
Rischi che, nella società del rischio, vedono
l’autotrasformazione del rischio tecnico in rischio economico, politico, di mercato, per la
salute e via così.
Rischi che, secondo Robertson6, sono contemporaneamente locali e globali: sono glocali.
E la società moderna è la società globale del
rischio7, con alcune contraddizioni palesi: i
tecnici delle industrie chimiche sostengono
che non vi è alcun rischio nella loro attività, gli
assicuratori rifiutano l’assicurazione perché i
rischi sono eccessivi.
Società globale del rischio perché i pericoli
globali configurano azioni transnazionali e favoriscono la nascita di strategie, organismi ed
istituzioni e accordi internazionali.
Si possono individuare due strategie per affrontare le incertezze prodotte: solo determinate conoscenze possono indurci ad agire, per
cui la negazione dei rischi determina una crescita incontrollabile delle incertezze; oppure si
opta per la strategia contraria e si fonda l’azione contro i rischi sulla presunta mancanza di
conoscenza, per cui tutto diventa rischioso.
Il rischio dà indizi su cosa va evitato, non su
cosa è più o meno opportuno.
Il rischio oggettivo è che, nella miriade caleidoscopica di interventi previsti nei vari contesti, non si capisca il senso del loro fluire, che
si perda inutilmente il bandolo della matassa.
Ambiente, natura, tecnologia, uomo, scienza,
rischio, comunicazione e quant’altro: fermiamoci un attimo, giusto per ricapitolare le idee.
Me ne assumo il compito volentieri, portatore di un insolito mix professionale: dirigente pubblico, tecnico, docente universitario,
ricercatore, comunicatore, cittadino; e del conseguente carico e portato di esperienze dirette
di interazione con esperti e profani in materia
di scienza e società, di percezione e comunicazione del rischio, di policy e di governance.
2 L’approccio probabilistico definisce il rischio (R) come
il prodotto del danno (D) associato ad un evento che ha
una certa probabilità di verificarsi in un intervallo di
tempo (Pi/T): da cui la formula R=D*Pi/T. Al riguardo
Cfr. M. Lombardi (a cura di), La comunicazione dei rischi
naturali, Milano, 2005, pag. 159.
3 Cfr. U. Beck, La società globale del rischio, Trieste, 2001,
pag. 155, il quale ritiene che si debba anche tener conto
della distinzione, socialmente rilevante, tra decisori del
rischio e soggetti costretti ad affrontare le conseguenze
delle decisioni di altri.
4 Ibidem, pag. 159.
5 Ibidem, pag.188.
6 Ibidem, pag. 160.
7 Ibidem, pag. 29.
Nel tempo ho avuto modo tra docenze, ricerche, tesi e tesine di sviluppare un’articolata
esperienza didattica e di ricerca che nel corso
dell’ultimo decennio nel mio ruolo di direttore
del Servizio Rapporti Comunitari ed Integrazione Europea della Regione FVG ho avuto modo
di riportare a concretezza ideando e sviluppando alcuni progetti che si rifacevano in maniera
sempre più puntuale alla risk theory, nella sua
articolazione strutturale classica di risk analysis,
risk management, risk comunication.
È in questa chiave che abbiamo vissuto
l’avvento dell’euro nel 2001, con un progetto
2. Dal Progetto EURO a ClimChange
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
101
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
articolato di informazione istituzionale e comunicazione pubblica che non solo ha destato
l’apprezzamento dell’opinione pubblica locale
ma è stato portato ad esempio dagli organismi
comunitari e inserito, quale best practice italiana, in una specifica pubblicazione del Comitato delle Regioni8.
Un paio d’anni dopo abbiamo vissuto l’ingresso nella UE di Slovenia, Ungheria ed altri
Paesi con il progetto “Extra-Large / XL”, che ci
ha permesso, partendo dall’esperienza EURO,
di portare all’approvazione della Commissione europea un progetto di analisi, gestione
e comunicazione del rischio – allargamento
2004 come vissuto sul confine italo/sloveno
nella prospettiva di fungere da laboratorio per
l’allargamento 2007 sul confine greco-bulgaro
e per quello in fieri sul confine italo/sloveno/
croato9.
Oggi, più banalmente ma comunque seguendo quelle tracce scientifiche, ci si ripropone di affrontare per tempo il rischio della mancata comprensione del cittadino dell’avvento
alla televisione digitale nell’autunno 2010, per
affrontare il quale come Corecom FVG stiamo
lavorando per tempo e da tempo10.
L’ampliamento dell’esperienza ha permesso di dare forma e sostanza all’idea originaria:
si è così sviluppata l’analisi del rischio socio8 In occasione dell’arrivo della moneta unica europea il
Comitato delle Regioni ha lanciato un bando per costruire un Manuale di buone strategie e misure preparatorie all’introduzione dell’euro, individuando così vere e
proprie best practices realizzate da enti regionali e locali, raccolte nella pubblicazione “The Introduction og the
Euro and its Impact on Local and Regional Authorities”
(Bruxelles, 2001). Tra gli otto progetti regionali è stato selezionato anche “L’Euro tra noi”, realizzato dal
Servizio per la Promozione dell’integrazione europea
della RAFVG.
9 Il Progetto “ExtraLarge-XL”, finanziato dal PHARE CBC
della DG Allargamento, è stato coordinato dal Servizio
per la Promozione dell’integrazione europea della
RAFVG nel biennio 2002/03 ed è servito per studiare
l’impatto dell’ingresso della Slovenia nell’UE sul confine
italiano, nella prospettiva di individuare problematiche
e metodologie di intervento da sperimentare in loco in
occasione dei successivi allargamenti sul confine grecobulgaro e su quello italo/sloveno/croato.
10 Il “Progetto Digito” è attualmente all’attenzione del
Corecom FVG in vista della discussione in Consiglio
Regionale del bilancio 2010.
issn 2035-584x
economico per il FVG come pure delle aspettative dell’opinione pubblica regionale alle porte
dell’ingresso di economie e popoli sino a non
molto tempo prima separate da confini geografici, politici, economici ma anche culturali
ed umani, contribuendo alla definizione del
quadro di riferimento per una legge regionale
di gestione del rischio con l’assistenza ad alcune categorie professionali maggiormente a
rischio ed intervenendo poi con una manovra
a cascata di comunicazione del rischio verso
stakeholder privilegiati: giornalisti, operatori
delle telecomunicazioni (tlc), docenti, amministratori locali, ministri di culto; e, attraverso
questi, verso categorie target: opinione pubblica, studenti, cittadini, fedeli, etc.
Negli ultimi anni della programmazione
UE 2000-2006, il progetto “Interreg IIIC Risk
& Innovation”, concluso nell’anno successivo
con la pubblicazione di un Vademecum sul
rischio legato all’innovazione nelle zone di
confine europee, ci ha permesso di allargare il
nostro cammino dalla dimensione socio-economica a quella tecnologico-ambientale11.
E siamo stati ancora impegnati sino alla primavera 2008 nella dimensione del progetto
Interreg 3B Spazio Alpino “Climate Change” a
ragionare sul cambiamento climatico e le sue
ripercussioni sul nostro territorio montano12 e
su come comunicarlo ai cittadini.
Nella scorsa estate con una tesi di laurea specialistica ci siamo spinti ad analizzare i problemi del rischio pandemico legato alle epidemie
di influenza aviaria, prima, e suina, poi13.
11 Il Progetto è stato approvato dallo Steering
Committee interregionale il 16 giugno 2006 e si è concluso nel giugno 2007, capofila la Camera di Commercio
di Siviglia (Spagna) e ulteriori partecipanti due partner
greci (Chamber of Commerce of Drama e Prefectural
Local Authority Rodopi/Evros) ed il il Servizio Rapporti
Comunitari e Integrazione europea della la Regione FVG
per il tramite della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Trieste.
12 Si tratta di una ricerca sul campo nell’area FVG del
“Progetto ClimChAlp”, collocato nell’Interreg III B transnazionale dedicato allo Spazio Alpino. Il Progetto, sviluppatosi nel 2006/2008 ha visto partner il Servizio
Rapporti comunitari e integrazione europea, della
Regione FVG e il Master in Analisi e gestione della comunicazione dell’Università degli Studi di Trieste.
13 T. Bojanovic, Dalla prevenzione del rischio all’esplosione
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
102
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Con i fondi a disposizione: comunitari, nazionali e regionali abbiamo così cercato di sviluppare e promuovere all’interno dell’Amministrazione Regionale e dell’Università di Trieste
una nuova sensibilità sulla dimensione specifica del rischio, della sua percezione e della sua
comunicazione, lasciando agli altri esperti dei
vari settori le competenze di indagine ed intervento in materia di analisi del rischio ambientale, tecnologico, umano e di gestione degli interventi volti a ridurre, minimizzare, eliminare
il rischio e le sue potenziali minacce come pure
le sue concrete e violente manifestazioni.
C’è stata la capacità e la lungimiranza, in
particolare, di proporre la dimensione della
comunicazione del rischio per primi nella dimensione della cooperazione territoriale nei
nostri bacini di eleggibilità, dai Balcani alla
Scandinavia, quindi, ed abbiamo inserito, sin
dall’avvio della nuova programmazione, come
ambito strategico di intervento, la dimensione del rischio tout court e della sua comunicazione in particolare.
Oggi siamo quindi pronti a confrontarci, con
questo bagaglio di esperienza, con quanti sono
interessati ad affrontare il problema in maniera
concreta ed organica, ad esempio (ma non solo)
nell’ambito della programmazione 2007/2013.
3. Perché ragionare di comunicazione
del rischio?
Il progetto “Big Manhattan” e lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki,
nel 1945 hanno messo in discussione all’interno della nazione americana, e da lì nel mondo
intero, la “pacificità” del dialogo sul rapporto
tra politica e ricerca, tra scienza e società14.
Il Rapporto che l’ing. Vannevar Bush, consigliere del presidente Roosvelt prima e Truman
poi, presentò al termine dell’incarico affidatogli per ricucire quel dialogo fu ampiamente ridella crisi: la comunicazione di emergenza, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della formazione,
Corso di laurea specialistica in pubblicità e comunicazione d’impresa, a.a. 2008/09.
14 Al riguardo, cfr. G. Brunelli, Le politiche di diffusione
della scienza. Consenso, conflitto e partecipazione, in Rivista
italiana di comunicazione pubblica, n.25, Milano, 2005,
pag. 119.
issn 2035-584x
preso nei successivi programmi USA di scientific literacy, individuando nella conoscenza
scientifica la leva dello sviluppo della nazione.
La politica americana si trovava a dover gestire contemporaneamente l’incremento della
democrazia e quello della tecnologia all’interno
della società, evitando che esse entrassero in
conflitto. Cosa non facile, se si pensa agli anni
della guerra fredda, della corsa agli armamenti,
della corsa allo spazio, ed il termine di scientific
literacy, che compare nei rapporti ministeriali
sull’alfabetizzazione scientifica per le scuole
americane, testimonia lo sforzo in tale direzione; il cosiddetto deficit model è così la base
ideologica del flusso monodirezionale d’informazioni tra scienza e pubblico nei programmi
di diffusione ed alfabetizzazione scientifica di
una società che, dal punto di vista della presa
d’atto dell’emergere del rischio scientifico e
tecnologico, si rivelava sempre più complessa.
Le delusioni della guerra nel Vietnam, la crisi petrolifera, gli scandali politici, la sfida economica del Giappone prima e della Cina poi, il
declino della leadership economica nel mondo
globalizzato, le paure della sfida portata in casa
e nel mondo dal terrorismo: nell’altalena degli
alti e bassi che investono la società si è consolidata nel tempo la convinzione dell’utilità di
un programma di consenso ed alfabetizzazione scientifica, premessa indispensabile per
l’affermarsi di una vera e propria scuola della
comunicazione scientifica e della comunicazione del rischio.
Anche in Gran Bretagna, sebbene alcuni
decenni più tardi, si è sviluppata analoga riflessione sul rapporto tra scienza, tecnologia
e società quale premessa per la messa in discussione del rischio e l’adozione di una vera
e propria risk theory. Il programma “Public
Understanding of Science – PUS” nato all’inizio degli anni Ottanta su iniziativa della Royal
Society aveva proprio l’obiettivo di comprendere il livello di alfabetizzazione scientifica del cittadino inglese e di partire da lì per
impiantare un nuovo discorso metodologico,
similmente a quanto sviluppatosi negli USA:
misurazione delle competenze scientifiche
dei cittadini, studio dei meccanismi per colmare in via generalizzata le lacune emerse; e
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
103
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
quindi proposta di una serie di attività comunicative su ampia scala, volte ad avvicinare
alla società i modi ed i contenuti della scienza
e a creare i presupposti per il superamento
dei fattori di insicurezza e paura.
E’ del 1985 il primo documento elaborato
dal PUS: il “Rapporto Bodmer”, dal nome del
responsabile di una commissione multidisciplinare (scienziati, politici, sociologi, giornalisti), contiene le ragioni che spingono alla
promozione ed alla diffusione della cultura
scientifica. E’ la migliore comprensione delle
ragioni della scienza e della tecnologia che può
portare la collettività a sostenere la crescita
della nazione, garantendo il singolo dall’esclusione sociale e rendendolo consapevole nel
prendere decisioni che lo riguardano come
singolo e come membro della società.
I due modelli, quello americano e quello inglese, si ripropongono dunque di operare attraverso l’alfabetizzazione scientifica; sono figure
di esperti (scienziati in primis, ma anche giornalisti, amministratori, politici) a sviluppare la
riflessione teorica e l’attuazione pratica di proposte operative; il target è individuato sostanzialmente in un pubblico inesperto, omogeneo:
studenti ed adulti; le attività di comunicazione
non vanno quindi tarate su specifici pubblici,
ma devono indirizzarsi verso una gamma generalizzata e generalista di tanti pubblici diversi.
Ed in Italia? Nel nostro Paese le vicende
legate al terremoto nel Friuli (1976), all’incidente di Seveso (1976, liberazione di diossina
nell’ambiente), all’esplosione del reattore 4
della centrale nucleare di Cernobyl (1986), alla
diffusione del virus Hiv/Aids, all’epidemia di
BSE in Gran Bretagna ed Europa; le discussioni
sugli OGM; i vari casi di dismissione di scorie
radioattive e la conseguente sindrome “NIMBY – Not in my back yard”; le minacce provenienti dal bioterrorismo (metropolitana di
Tokio, 2002); lo tsunami nell’oceano indiano
(2004), la ricerca sulle cellule embrionali e la
fecondazione assistita (2005); l’influenza aviaria (2006), lo scioglimento dei ghiacci perenni (2007), la corsa al nucleare iraniano (2008),
l’influenza suina (2009) hanno indubbiamente influito nel mettere in discussione il rapporto di fiducia tra scienza e società, come di
issn 2035-584x
volta in volta confermato dalla conta degli italiani su temi sottoposti a referendum, dal nucleare alla ricerca sugli embrioni. Se in passato
anche in Italia ci si interrogava, e si dibatteva,
sui temi di scienza e sociologia e tecnologia, in
chiave di rischio per la crescita economica ed
il progresso sociale, oggi l’opinione pubblica
si interroga più in generale sul rapporto tra
costi e benefici legati all’impatto tecnologico e
pone al centro della riflessione un nuovo fattore, quello del rischio: “il rischio e la responsabilità sono intimamente correlati, così come
il rischio e la fiducia, il rischio e la sicurezza …
A chi può essere assegnata la responsabilità (e
dunque i costi)?”15. Fattore, questo, rispetto al
quale la comunicazione e la governance della
scienza devono necessariamente intervenire.
Proprio il contributo di Beck alle scienze
sociali del rischio si pone come fondamentale
per comprendere il senso del nostro ragionare
odierno: sostenendo che lo sviluppo ed il progresso sono stati perseguiti a spese della natura, portando alla rottura del rapporto tra sistema sociale e natura medesima. Per cui nella
società del rischio il rischio è sempre ecologico, il processo di sviluppo è sfuggito al controllo ed attraverso l’acquisizione del consenso si
sostiene di poter controllare i rischi esistenti
ed emergenti16. E’ da qui, da questa pessimistica visione che si è poi sviluppata la discussione sulla vulnerabilità del sistema sociale e la
conseguente necessità di elaborare strumenti
per conoscere, prevenire, controllare e gestire
i rischi. E, ovviamente, comunicarli.
Si giunge così a promuovere una sorta di
consapevolezza sociale del rischio e non la sua
rimozione, consapevolezza che implica nuove
strategie di azione per farvi fronte.
Anche perché è la stessa opinione pubblica
che pone le questioni ambientali a confronto se
non in alternativa a quelle dello sviluppo: economia ed occupazione da un lato, tutela delle
risorse naturali e quindi dell’uomo dall’altro.
Che si tratti di un impianto di produzione
industriale, di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti, di un corridoio logistico e tra15 ���������������
Cfr. U. Beck, op. cit., pag. 16.
16 Cfr. M. Lombardi (a cura di), La comunicazione dei rischi naturali, Milano, 2005, pag. 160.
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
104
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
sportistico, di un rigassificatore o quant’altro,
la comunicazione intorno a queste scelte è una
variante ineludibile e dominante: da una parte
la captazione del consenso come strategia fondamentale; dall’altra la partecipazione informata come stile di comportamento.
La ricerca sociologica ha nel tempo individuato cinque aspetti ricorrenti nel fenomeno17:
innanzitutto tre domande:
1 - la domanda di informazioni sulle ricadute ambientali
2 - la domanda di partecipazione dei cittadini alle scelte
3 - la domanda di una più equa ripartizione
di rischi e benefici
dopodiché due considerazioni:
a - l’accettazione delle scelte di politica ambientale e tecnologica discende dalla credibilità delle istituzioni che garantiscono l’affidabilità delle soluzioni tecnologiche e gestionali;
b - i media tendono ad enfatizzare le notizie
relative allo stato ambientale, con una comunicazione più sensazionalistica ed allarmistica
che informativa.
È dall’intersecazione di tali fattori, dalla miscela che ne deriva che alla fine il singolo decide
se accettare o meno di convivere con un rischio.
4. Ma allora, che cos’è il rischio?
Nella sua dimensione più semplice la materializzazione di un rischio latente viene definita
come una rottura dell’equilibrio pre-esistente,
che comporta il venir meno del quadro di riferimento esistente sino ad un attimo prima e presuppone la capacità di reazione organizzativa
in grado di riportare la situazione ad una nuova
condizione di equilibrio accettabile.
Di per sè
- il rischio può essere naturale o sociale
- il rischio naturale può essere passivo o attivo
- il rischio sociale può essere volontario o
involontario
- il rischio può essere reale o percepito.
La rischiosità è legata alle proprietà percepite del rischio:
- controllato \ non controllato
- familiare \ sconosciuto
17 Ibidem, pag. 161.
issn 2035-584x
- temibile \ poco temibile
- immediato \ differito nel tempo
- latente \ presente
- specifico \ a-specifico
- recuperabile \ irreversibile.
È sulla base di tali classificazioni che il singolo elabora un proprio grado di esposizione al
rischio e le conseguenti strategie di reazioni.
È sulla base di tali studi e dello scostamento
esistente tra rischio reale e rischio percepito
che le assicurazioni lavorano, misurando i rischi e quantificando i costi.
Quando abbiamo studiato preventivamente l’impatto dell’euro sulla popolazione
del FVG, ad esempio, abbiamo così riscontrato una carenza di informazione di fondo alla
quale abbiamo cercato di dare risposta con una
campagna informativa -con i limitati mezzi a
disposizione- nei confronti dei cittadini più
esposti e bisognosi.
L’ingresso della Slovenia e di altri paesi ex
Patto di Varsavia nell’UE, ancora, ha determinato incertezze per alcune categorie economiche, per cui si è contribuito al quadro conoscitivo per una legge regionale di intervento a
loro favore; timori nelle famiglie per l’arrivo
di lavoratori dai nuovi paesi a portare via il lavoro ai loro figli; amarezza per l’accoglimento
nella casa europea di coloro che avevano cacciato i nostri genitori dalla casa natia istriana:
dimensioni, queste, alle quali si è cercato di
porre rimedio con campagne di comunicazione ed informazione autogestite come pure attraverso stakeholders previamente individuati
e coinvolti: giornalisti e mass media, enti locali ed amministratori, ministri di culto delle
varie confessioni, docenti e studenti18.
18 Nella programmazione 1997/2000 il Servizio
Promozione dell’Integrazione europea della Regione
FVG aveva guidato la partecipazione italiana al Progetto
CADSES II Preparity, volto a predeterminare i possibili
scenari dell’allargamento comunitario ad est sulle fasce
di confine interessate, dalla Grecia alla Germania. Con
fondi propri aveva poi sviluppato, in collaborazione
con l’ISDEE di Trieste e le quattro CCIAA regionali, un
progetto volto a riportare gli scenari comunitari nella
dimensione regionale del Friuli Venezia Giulia per fare
conoscere i risultati ddi Preparity, per determinare i
possibili impatti dell’allargamento ad Est dell’UE sul
tessuto economico e sociale del Friuli Venezia Giulia e
ipotizzare prime dinamiche d’intervento. Da qui era poi
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
105
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Con “Risk & Innovation” abbiamo studiato nel concreto i rischi che l’antropizzazione
del territorio e lo sviluppo industriale e tecnologico possono comportare all’ambiente ed
all’individuo, ci siamo confrontati con amministratori, scienziati, esperti per individuare
le migliori modalità di comunicazione all’opinione pubblica come al singolo cittadino delle
implicazioni che discendono da tali rischi.
Così come abbiamo fatto sul versante alpino con lo studio del cambiamento climatico e
le conseguenze ambientali, economiche e sociologiche sulle comunità che vi vivono.
5. La comunicazione del rischio, tra
teoria e pratica
La dimensione soggettiva del rischio e la
sua percezione in una situazione preventiva si
qualificano come un processo di attribuzione
di senso razionale; in situazione di crisi, però,
l’individuo è naturalmente portato a “manipolare” le informazioni relativa alla nuova realtà
vissuta, cerca di riportare ad un modello interpretativo consolidato il nuovo ed imprevisto,
la razionalità non è più sufficiente. L’emergenza fa esplodere il rischio e la sua complessità
e la crisis comunication diventa momento originale e strategico gestionale.
L’individuo si pone due domande immediate: Che cosà è successo? Che cosa devo fare?
Questa domanda di informazione è stata analizzata e portata a descrizione con le curve della domanda e della risposta, la cui distanza individua il cosiddetto vuoto informativo.
Quattro sono i fattori da tenere in evidenza
quando parliamo di rischi naturali e/o tecnologici:
a - l’adeguatezza della vigente normativa di
prevenzione,
b - l’efficacia dell’organizzazione dell’intervento,
c - l’attenzione dedicata dalle istituzioni,
d - la capacità dei media di fornire informazioni oggettive.
Guardiamo agli attori della comunicazione
sotto tre aspetti correlati della loro immagine:
1 - la loro chiarezza, innanzitutto, cioè la
capacità di comunicare ma anche la misura in
cui l’interlocutore li percepisce vicini ai propri
nato il progetto ExtraLarge-XL.
issn 2035-584x
codici e schemi cognitivi;
2 - la loro credibilità che chiama immediatamente in causa la sfera delle intenzioni attribuite al comunicatore;
3 - la competenza che i nostri interlocutori
attribuiscono agli attori della comunicazione,
e ci accorgiamo che è proprio la comprensibilità che può costituire la principale pecca.
I giornalisti sono più chiari che credibili;
sindaco, forze dell’ordine, insegnanti e parroco
risultano più chiari che competenti; vigili del
fuoco e protezione civile, ovvero gli operatori
dell’emergenza, paiono prevalere, anche se più
per chiarezza che per credibilità e competenza, mentre gli esperti paiono più competenti
e credibili che comprensibili, caratterizzati da
un linguaggio difficile.
In dieci anni, tanti ne sono passati tra due
ricerche in materia svolta in Lombardia (ma da
un contesto di rischio tecnologico si è passati
ad uno ambientale), ambientalisti ed esperti
hanno ceduto posizioni nella graduatoria del
gradimento, mentre ne hanno guadagnate
forze dell’ordine e vigili del fuoco; i giornalisti
ieri come oggi ponevano il problema della loro
credibilità, del rapporto fiduciario con il loro
pubblico, mentre la frattura esistente tra politici nazionali e locali ed i loro cittadini emergeva chiara dieci anni fa e persiste tuttora.
Anche nell’ambito della nuova programmazione comunitaria, all’interno della quale si è
riusciti in qualche misura a fare prevalere la
necessità di idonei assi operativi in materia di
rischio nell’accezione qui utilizzata, si potrebbe quindi proporre, aggiornato e verificato
quello precedentemente usato, un modello comunicativo a due livelli (two-step flow communication).
Il modello di comunicazione che qui si
propone è a valanga: un primo step per amministratori locali, membri di associazioni o
gruppi, di volontariato, forze dell’emergenza
e del soccorso, operatori della comunicazione,
specie locali. A loro volta questi vengono investiti del compito di formare la popolazione attraverso modalità consone al loro ruolo ed alle
loro competenze, attraverso:
- seminari di formazione per i mediatori
- incontri assembleari con la popolazione
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
106
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
- mostra con pannelli, cd-rom
- video
- gioco di ruolo
- spazio interattivo di informazione e formazione.
Riprendendo in qualche modo ed ampliando lo schema classico delle “5 W” giornalistiche, si può riportare lo sviluppo dell’attività
del modello di comunicazione del rischio così
definito ad una serie di domande/risposte/
principi:
Why: perchè la comunicazione?
Who: chi ne è la fonte?
When: quando avviene la comunicazione?
Where: in quale contesto?
What: che cosa si comunica?
Whom: a chi si comunica?
Poste le domande ed acquisite per tempo
le risposte, è così possibile contribuire fattivamente all’acquisizione delle necessarie
competenze e quindi alla costruzione di un
messaggio strutturato, puntuale, efficace in
materia di rischi naturali, tecnologici, etc per
lo specifico territoriale di riferimento.
L’esperienza sviluppata dalla Direzione
centrale sanità della RAFVG nell’ambito della
situazione pandemica A/H1N1 nella primavera/estate 2009, da questo punto di vista, costituisce un interessante esempio di come la P.A.
riesce concretamente ad operare in una situazione di rischio prima e di emergenza poi19.
Dalla fine del 2003, quando in Estremo
Oriente i focolai di influenza aviaria da virus A/
H5N1 sono divenuti endemici nei volatili ed il
virus ha causato infezioni gravi anche nell’uomo, il rischio di una pandemia influenzale è
considerato concreto. Al punto che l’OMS ha
raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto
un Piano pandemico e di aggiornarlo costantemente secondo linee guida concordate. La rapida espansione di casi di infezione nell’uomo dovuti al nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1
mai rilevato prima, rende questo rischio ancora
più concreto e ormai prossimo nel tempo.
L’influenza è un’infezione comune in Italia, specialmente durante i mesi invernali. La
malattia, causata dal virus dell’influenza, può
essere mite o severa e, in alcuni casi, può con-
issn 2035-584x
durre alla morte. Generalmente alcuni gruppi
di persone sono più suscettibili all’influenza
di altri, specialmente gli anziani, i bambini
piccoli e le persone con particolari condizioni
di salute. Questo è il motivo per cui la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a questi gruppi di persone ogni anno. L’influenza
pandemica è diversa dall’influenza stagionale perché si sviluppa quando un nuovo virus
influenzale emerge nella popolazione umana
e si diffonde da persona a persona in tutto il
mondo fino a colpire tutti i paesi. Siccome è
un nuovo virus, l’intera popolazione sarà suscettibile perché nessuno avrà un’immunità
specifica per esso. Quindi, adulti sani come
anziani, bambini piccoli e persone con patologie preesistenti saranno contagiati. La mancanza di immunità nella popolazione italiana
farà sì che il virus abbia la potenzialità di diffondersi molto velocemente tra la gente. Ciò
porterà a una forma di malattia più grave con
un maggior numero di decessi. Oggi esistono
le circostanze per lo sviluppo e la diffusione
mondiale di un nuovo virus influenzale.
La diffusione di una pandemia influenzale
potrebbe provocare una crisi del sistema sanitario a tutti i livelli e una situazione di emergenza in tutti i settori sociali. Per fronteggiare
questo evento in modo coordinato e efficace la
Direzione centrale Sanità ha elaborato le “Strategie e misure di preparazione e risposta a una
pandemia influenzale nella regione Friuli VeneziaGiulia”, tenendo conto del Piano di preparazione a una possibile pandemia influenzale
pubblicato dall’Organizzazione mondiale della
sanità nel 2005 ed il suo recente aggiornamento (Pandemic influenza preparedness and response:
a WHO guidance document, 2009), del “Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale”, dei Piani pandemici allestiti da altri Paesi e delle conoscenze disponibili.
Il documento fornisce le linee guida regionali
in caso di situazione pandemica, rappresenta il
documento di riferimento per la preparazione
dei piani operativi delle singole aziende sanitarie ed ha come obiettivo l’individuare e strutturare gli interventi di sanità pubblica e di tutela
della popolazione da attuarsi nel Friuli Venezia
19 cfr. T. Bojanovic, op. cit.
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
107
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Giulia secondo sette azioni chiave:
1. Sorveglianza
2. Prevenzione e controllo infezione
3. Trattamento e assistenza
4. Servizi essenziali
5. Comunicazione
6. Formazione
7. Valutazione.
La comunicazione viene riconosciuta come
fondamentale strumento per la riuscita del
Piano, così come la formazione, l’una e l’altra
con rilevanza interna ed esterna, verso gli operatori e verso i cittadini, mentre l’inserimento
di meccanismi di valutazione garantisce la verifica dei risultati e il periodico aggiornamento del documento.
6. Conclusioni
Se si porta la questione del rischio oltre la
sua definizione culturale e se ne esplorano i
dettagli relativi alla gestione del rischio nelle
istituzioni, risulta chiaro che la nostra società
oggi riflette e si concentra sulle conseguenze
indesiderate del proprio essere, sui propri rischi e sulle conseguenti implicazioni per il
proprio sviluppo.
La comunicazione del rischio deve tener
conto della situazione in cui si attua, e quindi del momento preventivo oppure di quello
gestionale, e dei relativi obiettivi che si pone,
cognitivi oppure operativi: dall’incrocio emergono quattro modalità di intervento che orientano gli obiettivi della comunicazione del
rischio e, conseguentemente, le strategie da
mettere in atto pur nella persistenza del triangolo classico della struttura della comunicazione pubblica: istituzioni – media – pubblico,
le relazioni tra i quali evidenziano alcuni nodi
di volta in volta problematici20:
- il tempo
- la fonte
- la responsabilità
- la conoscenza
- le priorità
- la cedibilità
- la fiducia
- i dati
issn 2035-584x
- la comprensione
- l’attenzione
- la verità
- le funzioni.
I percorsi specifici individuati per la specifica progettualità portano all’acquisizione di
un linguaggio comprensibile, all’acquisizione
di nuove capacità di relazioni con il pubblico,
alla stabilità organizzativa e acquisizione delle
professionalità, alla routinizzazione del processo comunicativo.
Per essere in grado di gestire la comunicazione durante una situazione di rischio ci si deve
essere lungamente preparati a farlo: i diversi
soggetti a vario titolo coinvolti (dalle istituzioni
alle organizzazioni ai media) devono aver preparato per tempo, in periodi “normali” le politiche di comunicazione da adottare in situazione
di crisi. Occorrono interventi formativi/informativi integrati e costanti nel tempo per creare tra la popolazione una vera e propria cultura
della crisi, un mix di codici, linguaggi e informazioni in grado non solo di favorire l’adattarsi
dei comportamenti dei singoli alla situazione
di emergenza in corso ma, ancor prima, di fare
raggiungere la quantità di fiducia indispensabile per garantire quel grado di credibilità sufficiente a permettere al messaggio di penetrare
nella quotidianità del rapporto istituzioni / cittadini e, quindi, di essere efficace.
Bibliografia:
E. Ambrosi (2001), Examples of best practices:
the case of Timavo/Reka river, The role of Euroregions
in promoting good-neighbourly “relations, Sofia,
29-30.6.2000, Council of Europe, Strasbourg”.
E. Ambrosi (2001), The introduction of the Euro
and its Impact on local and regional Authorities: The
study-case of Friuli-Venezia Giulia Region, “Committee of the Regions Studies-E-3/2001, Brussels”.
20 Cfr. al riguardo M. Lombardi (a cura di), op. cit., pag. 170.
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
108
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
E. Ambrosi (2002), “EXplaining TRAnsition to
enLARGEment”: la Slovenia nell’’UE: un progetto
regionale di comunicazione del “rischio-allargamento” per il Friuli-Venezia Giulia”, COM.PA., Bologna, 19.9.2002, RAFVG, s.i.p.
E. Ambrosi (2003), Dalla risk analisys alla
comunicazione del rischio istituzionale, RAFVG,
s.i.p., Trieste, 14.11.2003.
V. Ambrosi, Divulgazione scientifica: istruzioni per il futuro. Il Parque de las ciencias di Granada
come modello per il Parco del mare di Trieste, Università degli studi di Trieste, Facoltà di Scienze
della formazione, tesi di laurea in Scienze della
comunicazione, a.a. 2006/07.
U. Beck, La società globale del rischio, Trieste, 2001.
P. Bevitori (a cura di), La comunicazione dei
rischi ambientali e per la salute, Milano, 2004.
T. Bojanovi, Dalla prevenzione del rischio
all’esplosione della crisi:la comunicazione di emergenza, Università degli Studi di Trieste, Facoltà
di Scienze della formazione, Corso di laurea
specialistica in pubblicità e comunicazione
d’impresa, a.a. 2008/09.
G. Brunelli, Le politiche di diffusione della
scienza. Consenso, conflitto e partecipazione, in
Rivista italiana di comunicazione pubblica, n.25,
Milano, 2005.
M. Lombardi, Rischio ambientale e comunicazione, Milano, 1997.
M. Lombardi (a cura di), La comunicazione
dei rischi naturali, Milano, 2005.
F. Martinelli (a cura di), I sociologi e l’ambiente, Roma, 1989.
M. Padula, Crisis communication. Come comunicare le emergenze, Cantalupa (TO), 2005.
D. Piegai, Comunicare il rischio. Strategie e
strumenti, Roma, 2008.
E. Serrano (a cura di), Handbook on crossborder globalisation and innovation risks: EU views
and experiences, CCamara Sevilla, 2007.
Eugenio Ambrosi, docente di Comunicazione pubblica al Corso di perfezionamento in analisi e gestione della comunicazione pubblica e d’impresa e
docente a contratto di Comunicazione pubblica degli enti territoriali presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Trieste.
A proposito di comunicazione del rischio in tempi di pandemia A/H1N1
109
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione.
Il ruolo del difensore civico
Caterina Dolcher
Abstract
Parole chiave
Lo scritto intende presentare la figura del difensore
civico come uno strumento di “relazioni pacifiche” e di
comunicazione comprensibile, corretta, di ascolto ed
empatia tra il cittadino e la P.A., affinché una corretta
percezione del “giuridico” ristabilisca in lui un'affezione
al sistema democratico onde possa condividere l'interesse
per il bene comune, partecipando anche attivamente
alla “ricerca delle comuni ragioni dell'agire”.
Difensore civico;
diritti;
individualismo;
responsabilità;
relazione;
pacificazione;
trasparenza;
partecipazione.
1. Il problema
C
i sono alcune domande che è opportuno
porsi per cercare di individuare quale ruolo, nell’ambito della comunicazione istituzionale tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, spetti al difensore civico. Ne indico le
seguenti: se le persone comuni sono in grado
da sole di capire il diritto (o meglio il “giuridico”); se sono o non sono messe in grado di farlo dagli attori istituzionali; se è necessario che
questo avvenga e perché; e, qualora sia bene
che sia, come deve avvenire la comunicazione
della Pubblica Amministrazione.
Un tempo questo problema non era ritenuto
importante: l’illustre Giuseppe Capograssi poteva affermare che «il processo è qualche cosa
che tocca tutte le persone e tutti gli interessi:
se pure è un problema tecnico, al di sotto c’è un
problema di vita, [...] perciò deve essere lecito
ad un semplice passante di esprimere non le
proprie opinioni che non è in grado di avere,
ma qualche cosa che sta al di qua delle opinioni,
si potrebbe dire i propri desideri.»1. Possiamo
1 G. Capograssi, Giudizio processo scienza verità, in Rivista
perciò convenire che per il quidam di un tempo era sufficiente l’obbedienza al diritto e l’ossequio alle istituzioni che dovevano occuparsi
di proteggere la sua vita e le sue cose. Questo
poteva avvenire anche grazie alla deontologia
di una classe forense ristretta, riservata nell’accesso ai rampolli delle classi colte, conscia della
propria superiorità sociale, ma conscia anche
della qualità di “servizio” della propria professione. Una tipica dimensione verticale.
2. La situazione attuale: come i cittadini
conoscono e vivono il “giuridico”
Oggi non è più così: da una parte vi è una
pletorica massa di professionisti2, tra i quali
purtroppo ve n’è chi, per mantenere un reddidi Diritto processuale, 1950, I, pp. 1-22.
2 Per i dati relativi al numero dei professionisti iscritti agli Ordini forensi in Italia si veda l’ultima Relazione
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2008 svolta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in
apertura dell’anno giudiziario 2009, pp. 39-41 http://
www.cortedicassazione.it/DocumentiPrimaPag/
InaugurazioneAG/InaugurazioneAG.asp; sito consultato il 15.9.2009.
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
110
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
to dignitoso, non sa più quali cause inventarsi;
dall’altra, quel “passante” non è più uno che non
sia in grado di avere opinioni. Il cittadino comune, anzitutto, è ben convinto di avere dei diritti
da far valere, (il ché è un bene; non sempre però
egli è anche disposto a riconoscere che vi sono i
diritti altrui). Le sue opinioni, però egli se le forma, purtroppo, solo dai media, attraverso notizie o informazioni formulate spesso in modo
suggestivo: infuse in menti digiune di diritto
(e spesso anche di cultura generale), producono forti storture. Con questo bagaglio confuso
di informazioni “giuridiche” e con le proprie
convinte opinioni circa i propri diritti, queste
stesse persone si trovano poi a dover ammettere, davanti ad una sentenza o anche soltanto davanti ad una citazione in giudizio, di non essere
in grado di capire nulla e non solo per un fatto
linguistico. Mancano ai più persino le nozioni
di base relativamente alla principali ripartizioni e funzioni del diritto (penale-civile-amministrativo-tributario ecc.) e relativi organi ed essi
vanno nel panico se “quel” mondo li tocca personalmente negli interessi più importanti. Le
informazioni che ricevono, però, sono spesso
sommarie, sbrigative, e anche quelle formulate
in linguaggio “iniziatico”3.
È interessante considerare questo modo
di “percepire” la realtà del giuridico da parte
del comune cittadino raffrontandolo al degrado civile cui assistiamo in questa società
di massa, complessivamente benestante, ma
irriguardosa del diritto inteso come «regola
socialmente garantita»4; una società cioè per
larga parte incapace di uniformare le proprie
azioni secondo le regole date nel contesto sociale italiano. Il fenomeno ciclico dei condoni,
3 S. Ondelli, La lingua del diritto, Roma, 2007, p. 5 denuncia che: «i giuristi non possono esimersi dal compiere
operazioni semantiche (determinare significati), poiché
la loro attività si fonda sul linguaggio e in esso trova il
suo strumento. Non potendo conoscere il diritto senza
sapere che cosa sia il discorso, tale attività richiederebbe una consapevolezza linguistica che spesso non viene
perseguita dagli addetti ai lavori, i quali non ampliano
le proprie attività oltre a prospettive piuttosto ristrette,
limitate alla cultura giuridica, e il linguaggio si delinea
come un mero strumento [...]»
4 Questa definizione di “diritto” trovasi in C.M. Bianca,
Diritto civile. Norma giuridica, i soggetti, Milano, 1984, p. 5.
issn 2035-584x
per esempio, che così spesso e a lungo sono
stati e sono posti in essere in vari campi del diritto amministrativo, tributario e penale, consolida l’opinione che il rispetto delle leggi non
è necessario e, anzi, non “conviene”. Prevale in
vaste zone d’Italia un’illegalità diffusa in ogni
strato della popolazione e l’arte di arrangiarsi.
In alcune attività umane particolarmente pericolose, come la guida dei mezzi di trasporto,
il rispetto delle norme è trascurato addirittura
dalla maggioranza dei cittadini.
D’altra parte assistiamo, più che nel resto
del mondo, ad una enorme difficoltà degli organi giurisdizionali nel “rendere giustizia”.
Affaticamento che dipende da molti fattori, in
particolare, dall’altissimo numero delle questioni sottoposte ai giudici. L’Italia ha un non
invidiabile primato in Europa quanto a litigiosità e durata dei processi5.
Vi è un nesso tra la mancata o distorta comprensione del giuridico da parte del comune
cittadino, il fenomeno di “denegata giustizia”
da parte del sistema giurisdizionale italiano e
il degrado nel rispetto delle “regole”?
Secondo quella che viene definita prospettiva
processuale del diritto, è il processo, da un punto di vista logico ed ontologico, l’evento primo,
originario dell’esperienza giuridica. Il diritto
esercita la sua funzione attraverso la sentenza
che è l’atto che risolve la crisi, cioè dirime i conflitti intersoggettivi. Solo con la sentenza il diritto risponde a quel desiderio – o bisogno - del
nostro famoso passante il quale lo accetta se e in
quanto è in grado di risolvere le sue particolari
crisi, di tutelare i suoi diritti alle cose che gli servono, che servono alla sua vita di ogni giorno. E’
una prospettiva che «relativamente ai rapporti
tra diritto e processo, non considera il processo
in funzione del diritto, come se avesse il compito di ristabilire un ipotetico ordine giuridico
compromesso dall’insorgere della controversia,
ma il diritto in funzione del processo, nel senso
che tutta l’esperienza giuridica è condizionata
5 Per queste affermazioni si rinvia ancora alla Relazione
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2008 svolta
dal Primo Presidente della Corte di Cassazione in apertura dell’anno giudiziario 2009 http://www.cortedicassazione.it/DocumentiPrimaPag/InaugurazioneAG/
InaugurazioneAG.asp cit., p. 30.
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
111
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
dall’esigenza di risolvere le controversie».6
Questa prospettiva mi pare che faciliti la
lettura del fenomeno di degrado civile sopra
denunciato: in un sistema statuale dove il processo non funziona, il “diritto” inteso, come si
è detto, come «regola socialmente garantita»
tende a scomparire. Restano: un’enorme congerie di norme, talvolta severissime, talvolta
incongruenti tra loro7; un apparato repressivo
che fa del proprio meglio per funzionare – e
che solo grazie alla professionalità, abnegazione e buon senso delle persone che vi lavorano ottiene grandi successi in lotte difficili e
sanguinose, come contro terrorismo e mafie
-; carceri strapiene di persone delle quali però
la metà sono in attesa di giudizio; “resiste” un
apparato giudiziario scalcinato dove persone
volonterose cercano di fare del proprio meglio
in condizioni spesso impossibili, talora con
grande frustrazione per la consapevolezza di
manovrare un sistema lentissimo ed inefficace. Viene a mancare il diritto8. La gente non
6 F. Cavalla, La prospettiva processuale del diritto - Saggio
sul pensiero di Enrico Opocher, Padova, 1991, p. 9.
7 Se l’attuale legislazione italiana la si giudichi nella prospettiva non formalista, nel senso indicato da M. Cossutta,
Questioni sulle fonti del diritto, Torino, 2005 p. 4: «la fonte
formale di produzione del diritto oggettivo renderebbe
palese, istituzionalizzandolo, un fenomeno giuridico
di per sé pre-esistente [...] tanto che il diritto oggettivo,
all’interno della prospettiva non formalista, non potrebbe sussistere se separato dalla sotterranea presenza della
regolarità, di cui è espressione. La fonte formale non sarebbe il luogo di creazione del diritto oggettivo, piuttosto
[...] un mezzo di ricognizione» - le attuale “fonti del diritto” mi pare denuncino efficacemente l’attuale schizofrenia della società contemporanea. Circa i danni che una
legislazione contraddittoria, incongruente o troppo mutevole produce nell’ordinamento si veda anche L. L. Fuller,
La moralità del diritto, Milano, 1986, p. 56 ss.
8 Sono ipotizzabili certamente molte spiegazioni a questo fenomeno contemporaneo. In particolare mi sembra
molto interessante quella che traggo dall’ipotesi formulata da G. Cosi in L. Lombardi Vallauri (a cura di), Logos
dell’essere logos della norma. Studi per una ricerca, Milano,
1969, p. 843, il quale riconduce l’esperienza originaria
e primordiale del diritto alle due condizioni «onto-esistenziali di base, comuni ad ogni essere umano in quanto tale: 1) limitatezza temporale: la sua “finitezza”; 2)
carenza materiale: la sua “indigenza”. Condizioni delle
quali l’uomo, unico tra i viventi, possiede la piena consapevolezza.» Situazione che invece l’uomo contemporaneo forse non percepisce oggi per il fatto «di vivere
issn 2035-584x
recepisce più che una qualche “giustizia” è
amministrata nel nome del popolo italiano e
non pensa più che le norme vadano rispettate.
Si aspetta ancora risposte dalla giustizia, ma il
più delle volte è costretta a constatare che non
ne riceve o che quelle che riceve non le capisce.
La gente ne deduce che il sistema è “ingiusto”
e lo ripaga di conseguenza.
Alla domanda, perciò, se è necessario che il
cittadino capisca, mi pare che si debba rispondere di sì: se il cittadino non è messo in grado
di capire il sistema, quali diritti spettano a lui e
agli altri e quali sono i suoi doveri, o meglio le
sue responsabilità9; se le risposte dell’ordinamento gli appaiono incomprensibili ed incongrue, - peggiori addirittura di quanto lo sono
in un ambiente relativamente ma diffusamente sicuro»
che lo porta a rimuovere il dato ontologico e, quindi,
l’idea stessa del diritto.
9 Il termine “dovere”, oltre che desueto nel linguaggio comune, è oggetto di analisi critica in filosofia.
Sicuramente può ancora essere pensato hofeldianamente come concetto correlato a “diritto” in una delle relazioni diadiche fondamentali. Attualmente, forse è meglio fare ricorso al termine responsabilità. La proposta
di un’etica della responsabilità che presenti argomenti
rilevanti anche per il diritto viene ripresa da A. Foddai in
L. Lombardi Vallauri (a cura di), Logos dell’essere logos della norma. Studi per una ricerca, cit., p. 1119, la quale, a partire dalla crisi dei principi dell’agire nel panorama culturale postmoderno, illustra l’etica della responsabilità di
K.O. Apel e H. Jonas, i principali teorici che sostengono
la necessità di fondare razionalmente i principi dell’agire responsabile «considerata la crisi teorica e pratica
dei principi dell’agire nel panorama postmoderno» e
considerata l’«impossibilità di fondare razionalmente i
valori che guidano le scelte individuali e collettive, assumendo nel discorso quell’idea di razionalità avalutativa
ricavabile dagli esiti dell’epistemiologia moderna che
ha costruito una ragione neutrale rispetto al valore». H.
Jonas ritiene che la capacità di essere responsabili faccia
parte del corredo ontologico degli uomini e che per costruire il principio responsabilità la sua esplicazione sia
affidata ad un dovere di conoscenza che incombe su ciascuno, relativo sia al valore dell’oggetto o soggetto verso
cui si dirige la sua azione, sia sugli effetti che è ormai
capace di produrre. Come ci illustra la Foddai, secondo
Jonas la ragione per cui la responsabilità non è mai stata al centro delle teorie etiche tradizionali risiede nel
fatto che in queste l’aspetto cognitivo è stato svalutato
a vantaggio di quello prescrittivo. Mi sembra che nel
presente discorso sulla comunicazione tra istituzioni e
cittadino questo pensiero risulti molto utile nel distinguere il paradigma verticale (prescrizione-obbedienza)
da quello orizzontale (cognizione-responsabilità).
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
112
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
realmente a causa delle disfunzioni giudiziarie
e della cattiva comunicazione sopra descritte la sua affezione all’ordinamento democratico
si allenta10. Il cittadino, che dovrebbe essere
al centro dell’ordinamento democratico, se ne
distanzia sfiduciato, facilmente delegando il
potere ad un “padrone” che sia capace di risolvere i suoi problemi quotidiani.
Cosa avviene nei contatti quotidiani del nostro cittadino con la pubblica amministrazione? Mi sembra che le cose non vadano meglio
di quanto vanno nel sistema-giustizia: neppure quando non si hanno motivi per lamentare
ritardi o disfunzioni, il rapporto con la PA non
è facile perché si fa fatica a capire, il linguaggio
è spesso tecnico, il dialogo non è cordiale, la relazione si trasforma spesso in uno scontro11.
10 O forse è proprio la tenuta dell’ordinamento democratico che si allenta. I due fenomeni, degrado del sistema e disaffezione, probabilmente, si autoalimentano.
«L’identità della democrazia richiede un’elevata misura
di responsabilità nei confronti della dimensione collettiva dell’esistenza». Invece «Le forze cooperative sono
in difetto nella politica; spadroneggiano i più forti; il
denaro, da misura di valori materiali, è diventato valore per se stesso ed oscura ogni altro; la prevaricazione
prevale spesso sul rispetto; la legalità è insidiata non
solo dall’illegalità, ma addirittura dalla legalizzazione
dell’arbitrio; il potere legale è intrecciato a quello illegale e criminale; gli egoismi prevalgono spesso sulla solidarietà; dilagano la solitudine, il senso di vuoto, di inadeguatezza e di colpa rispetto ad una società ultracompetitiva» La diagnosi è di G. Zagrebelsky, Contro l’etica
della verità, Bari, 2008, p. 7. Purtroppo all’acuta diagnosi
pare alla sottoscritta che non segua, da parte dell’illustre
Autore, un’altrettanto valida ipotesi terapeutica nel senso che egli dichiara di abbracciare proprio quelle categorie “formali”(testualmente si veda ibidem p. 3) che, per
esempio per F. Gentile, Intelligenza politica e ragion di stato, Milano, 1984 (l’idea permea tutta l’opera dell’Autore)
fanno parte della visione individualistica del diritto.
11 S. Rolando, La comunicazione di pubblica utilità, Milano,
2004, p. 316: «C’è un vecchio stereotipo della relazione
tra burocrazia e cittadini che fatica a morire. E’ fondato
su tre fattori radicati: l’alterità, la diffidenza, la depersonalizzazione. Lo stereotipo è quello di darsi del voi. “Voi”
dice la gente di quelli che fanno un lavoro “pubblico”
[...] “Voi” dice la burocrazia quando si riferisce ai cittadini in coda [...], a soggetti di adempimenti, a destinatari
di messaggi dovuti [...] L’alterità è evidente. Entrambi
gli schieramenti denunciano una soggettività “diversa”
[...] Entrambi gli schieramenti sentono poca simpatia
reciproca: la burocrazia [...]sente il cittadino come una
perturbazione; il cittadino sente la burocrazia come parassitaria. La depersonalizzazione sta tutta in quel “voi”
issn 2035-584x
Per non parlare di quando, addirittura, la
comunicazione manca del tutto: centralini che
non rispondono o costringono a defatiganti
attese, uffici muti che non rispondono al telefono e neppure alle mail o ai fax. Personale
“intasato” dalle troppe richieste (succede!) o
assenteista? Il giudizio del cittadino, rinforzato dai molti luoghi comuni, è generalmente
quello più negativo.
3. Quale comunicazione?
Nell’era delle comunicazioni la comunicazione è diventata difficile, non solo quella con
la pubblica amministrazione. Per comunicare
bisogna riconoscere l’altro da sé, volergli parlare perché capisca e, prima ancora, bisogna
saperlo ascoltare. Il comunicare è un’azione
fondamentale della persona e ne coinvolge intelligenza, volontà e amore per il prossimo12
proprio perché è relazione13: l’uomo è persona
nella relazione con l’altro14. Il riconoscimento
dove sparisce il familiare “tu”, il più rispettoso “lei”, il
riconoscimento dell’identità dell’interlocutore.»
12 Mi rendo conto che usare questo termine oggi è rischioso. Nel mondo moderno dobbiamo ammettere che
la secolarizzazione ha portato all’«eclissi-e-secolarizzazione della carità»: così L. Lombardi Vallauri, Amicizia,
carità e diritto, Milano, 1969, p. 10.
13 Benedetto XVI, nell’enciclica Caritas in veritate propone, affinché il mondo globalizzato ritrovi il senso più
profondo e giusto dell’agire umano, un nuovo “modo
di pensare” centrato sulla relazionalità come categoria
centrale per leggere la condizione umana e le vie da percorrere per un autentico sviluppo integrale della persona e dell’umanità. Questo aspetto dell’Enciclica viene
messo in risalto nel commento redatto da P. Donati, La
novità della “Caritas in Veritate”, Zenit, 21.7.2009, <http://
www.zenit.org/article-19045?l=italian>; sito consultato il 22.7.2009.
14 Francesco Carnelutti – intervenendo nel Convegno
annuale dell’UGCI Persona, Società intermedie e Stato,
Quaderni di Iustitia, 10, Roma 1958, p. 35 - ricordava
che non siamo tutti d’accordo intorno al significato del
termine “persona”. Ancora oggi, cinquant’anni dopo, i
termini persona e individuo continuano ad essere usati promiscuamente, quasi fossero sinonimi. Secondo
l’eminente giurista, l’essere persona è la meta del cammino, del quale l’individuo è il principio: se il termine
“persona” viene da per-sonare perché si chiamava persona
la maschera che si adoperava una volta per dar forza alla
voce degli attori nei teatri all’aperto, «la parola allude
ad un’espansione dell’individuo». Mi pare, allora, che
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
113
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
vicendevole tra l’uomo e l’altro costruisce rapporti pacifici ed etici perchè «la relazione dialogica tende a distruggere il rancore e il risentimento provocati dalla lite.[...] Nell’ordine del
dialogo e dell’incontro, l’orizzonte particolaristico di ognuno si apre [...] e la prospettiva di
ciascuno si completa nella diversa prospettiva
dell’altro. Attraverso la comprensione reciproca deriva l’arricchimento di ciascuno e sorgono le condizioni per la ricerca e lo svelamento
della verità. [...] La vera pace è in qualche modo
necessariamente anche una pace cognitiva,
una pace nella verità»15 Verità parziale e provvisoria che cerca la verità dell’altro con il presupposto psicologico della «benevolenza degli
uni verso gli altri, un atteggiamento spirituale
di reciprocità»16. Una verità che si “costruisce”
mediante il confrontare e il mettere in comune le verità parziali dei singoli.
L’esperienza giuridica è un’esperienza di rapporto. Su questo anche il cd. positivismo formalista è d’accordo17 ed è quindi possibile «approfondire l’esperienza giuridica [...] come uno dei
modi dell’incontro con l’altro, dell’esse ad, dell’essere-in-relazione, dell’essere-con (Mitsein).»18
questa “espansione” stia nella capacità di relazione con
l’”altro”, capacità che ciascuno acquista per una propria
strada, sua particolare, singolare. C. Mazzucato in L.
Lombardi Vallauri (a cura di), Logos dell’essere logos della norma. Studi per una ricerca, cit., p.1248 efficacemente
scrive: «E’ questo il rapporto pacifico ed etico: la presenza dell’Altro non fa violenza, anzi, l’epifania del volto fa
appello alla responsabilità verso il proprio simile e fonda la libertà di ciascuno.»
15 C. Mazzucato, ibidem, p. 1249.
16 G. Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, cit, p. 6.
L’Autore propone l’etica del dubbio come ri-affermazione della verità perché «il dubbio, al contario del radicale
scetticismo, presuppone l’afferrabilità delle cose umane,
ma, insieme, l’insicurezza di averle afferrate veramente,
cioè la consapevolezza del carattere necessariamente
fallace o mai completamente perfetto della conoscenza
umana, cioè ancora la coscienza che la profondità delle
cose, pur se sondabile, è però inesauribile» ibidem, p. VII.
Con questo atteggiamento di ricerca, perché la mia verità è imperfetta e cerco quella dell’altro, avviene l’incontro
che rende “vero” il dialogo ed efficace la comunicazione.
17 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, 1966, p.
44 riferendosi all’ordinamento giuridico afferma «E’
il comportamento reciproco degli uomini l’oggetto di
questa regolamentazione».
18 L. Lombardi Vallauri, Amicizia, carità e diritto, cit., p. 5.
issn 2035-584x
Il rapporto tra privati e pubblica amministrazione – e quello tra la giustizia e il cittadino comune – che sono certamente rapporti
giuridici, possono costituire una relazione nel
senso proprio e pieno del termine? La risposta
non è scontata.
In primo luogo, l’esperienza giuridica non è
ritenuta, tradizionalmente, come un’esperienza di autentica relazione: L. Lombardi Vallauri,
nel mentre include il diritto tra le esperienze
di rapporti, esclude che quello giuridico sia un
rapporto che si instaura al livello “personale”
poiché «l’instaurarsi di un rapporto di diritto
obbedisce ad un’ispirazione ambivalente: - fiducia e diffidenza, affidamento ed autogaranzia, intesa con l’altro e difesa dall’altro, alleanza
e competizione – [...]» Secondo questo Autore,
nel diritto mancano sia il momento oblativo
che quello unitivo: non vi è dedizione né dono
e non vi è «- sia pure nel mantenimento, spesso indispensabile, delle “distanze” - fusione,
comunione, ma coordinazione, delimitazione.
Ciò significa essere uniti da una linea divisoria, accumunati da un con-fine. [...] Complementari e necessari a vicenda nell’atto stesso
di escludersi. Posso perché tu devi; se posso
io, non puoi tu; se questo è mio, non è tuo»19
e via dicendo. Questa «imperfezione dei momenti oblativo e (soprattutto) unitivo» sarebbe connessa, secondo l’Autore, al carattere non
personale del rapporto giuridico nel senso che
«esso si istituisce tra soggetti pensati astraendo dall’io inconfondibile di ciascuno; tra soggetti tipici e dunque settoriali; tra ruoli.»20
In secondo luogo, nei rapporti con le istituzioni ci troviamo di fronte ad un rapporto
tradizionalmente asimmetrico: da una parte
un’istituzione, come tale “impersonale” che
persegue fini pubblici, dall’altra il singolo che
si pone in termini “personali” - di diritti, interessi, aspettative, semplici attese o bisogni -.
Non è dubitabile che il rapporto di diritto
amministrativo sia, per la tradizionale scienza
giuridica, un rapporto asimmetrico né è dubitabile che il rapporto che si instaura nel diritto
sia inferiore a quello dell’amicizia e d’amore –
nel senso di carità -. Eppure non penso che il
19 ibidem, p. 124
20 ibidem
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
114
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
rapporto giuridico escluda di per sé un rapporto interpersonale di comunicazione improntata a simpatia, gentilezza e cordialità. Penso
cioè che inserire questi umanissimi valori,
che fanno parte del comune comportamento
umano, nel rapporto giuridico che, di per sé,
non li richiede, renda possibile una più salda
“tenuta” dell’ordinamento democratico; ordinamento che, invece, nell’odierno pluralismo
dei valori, plurali fino ad un’estrema frammentazione21, sta pericolosamente mostrando
di stare per cedere.
Ritengo cioè che una comunicazione empatica nell’ambito giuridico-istituzionale possa
facilitare i cittadini nell’assumere una consapevolezza dell’effetto sociale dei loro atti giuridici
e possa aiutarli sia a far valere i propri diritti/
interessi sia a sentire la loro responsabilità nei
confronti dell’Altro, che si tratti del singolo con
il quale la relazione si è guastata o che si tratti
di quell’altro rappresentato dalla pubblica amministrazione (dalla quale spesso si pretende
molto di più di quanto sia possibile ottenere).
Quale strumento utilizzare? Quale strumento amministrativo può fare in modo che
la comunicazione istituzionale contribuisca a
far vivere il diritto «nel senso del suo farsi (comune) esperienza»22 (giuridica), così da superare l’asimmetria del rapporto cittadini-P.A.,
trasformandolo da “verticale” ad “orizzontale”
e da giuridico-formale a rapporto anche umano non necessariamente conflittuale?
4 Il cittadino: i suoi diritti, la sua
responsabilità
Col termine diritto, com’è noto, indichiamo diverse realtà giuridiche sia dal punto di
vista dell’ordinamento, come insieme delle
leggi poste (diritto positivo – il latino lex), sia
dal punto di vista dei soggetti, come situazioni
21 Il sociologo Giuseppe De Rita in Una società a coriandoli, intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo in “Corriere
della Sera”, 26.8.2007, ha così definito la nostra società,
“a coriandoli”, «disintegrata, frantumata in una miriade
di interessi particolari.» Mi pare che questa diagnosi sia
rivelatrice di una società che sembra avere perso del tutto il senso del bene comune.
22 F. Cavalla, La prospettiva processuale del diritto – Saggio
sul pensiero di Enrico Opocher, Padova, 1991, p. 45.
issn 2035-584x
favorevoli semplici o complesse (il latino ius).
Dal punto di vista soggettivo, il termine diritto
è usato sia nel senso di situazione favorevole
tutelata da un’azione corrispondente che consente di esigerlo – diritto soggettivo – sia in
un senso generico come situazione valutativa
o argomentativa, ossia con riferimento a valori che giustificano situazioni favorevoli più o
meno tutelate23.
Comunque si intenda, si è visto sopra come
sia il diritto-ordinamento che il diritto-situazione favorevole chiedono di essere visti in
una prospettiva di rapporto. È nel rapporto –
il processo tradizionalmente inteso e il procedimento amministrativo quanto al diritto
ordinamento – che l’ordinamento si realizza
come sistema di relazioni ordinate al bene24.
È nel rapporto, eventuale o necessario – cui si
potrebbe annettere la tradizionale distinzione
tra diritti assoluti e relativi25 – che il diritto-si23 Per una recente classificazione si veda Mauro Barberis,
Etica per giuristi, Bari, 2006 – pp. 3 e ss. N. Bobbio, L’età dei
Diritti, Einaudi, Torino, 1997, p. XIX ci avverte che: «Il
linguaggio dei diritti resta molto ambiguo, poco rigoroso e spesso usato retoricamente. Nulla vieta che si usi
lo stesso termine per indicare i diritti solo proclamati
e quelli effettivamente protetti», ma – e non possiamo
che convenire con N. Bobbio - «tra gli uni e gli altri c’è
una bella differenza!».
24 J. Maritain, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Milano,
1991, p. 11 afferma che «è il bene comune il fondamento dell’autorità». Più di recente F. Gentile, Ordinamento
giuridico tra virtualità e realtà, Padova, 2001 p. 87 definisce il bene comune come il «Bene cioè che accomuna
una molteplicità di soggetti diversi facendone, appunto,
una comunità».
25 La tradizionale distinzione tra diritti assoluti e relativi evidenzia come nella posizione soggettiva garantita dai diritti “assoluti” per eccellenza, i cd. diritti reali,
campeggia in primo piano «la relazione dell’uomo e la
cosa che si attua senza bisogno della cooperazione altrui» (per tutti cfr. A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale
di diritto privato, Milano, 1978, p. 65). In realtà, è esperienza quotidiana che anche per i diritti assoluti (reali
e della personalità) la relazione, anche se eventuale, è
un’ipotesi tutt’altro che astratta. Questa constatazione
pratica è suffragata dalla seconda tesi di Hohfeld (che
ognuno degli otto concetti giuridici fondamentali è
sempre associato ad un altro concetto giuridico fondamentale) dalla quale deriva «che un diritto reale non è
un diritto nei confronti di una cosa, né nei confronti di
una collettività indifferenziata, ma fa parte di un gran
numero di diritti fondamentalmente simili, riconducibili ad una persona; ad ognuno di tali diritti è correlativo
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
115
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
tuazione favorevole particolare si sperimenta
e trova tutela in quanto parte di quel sistema
di relazioni ordinate.
Finché i diritti restano concepiti in termini
individualistici e solipsistici26 la contrapposizione sia dei cittadini tra loro sia con la pubblica amministrazione resta inevitabile proprio
per l’impostazione intrinseca a questa visione:
il diritto-ordinamento inteso come tecnica
che consiste nell’ottenere dagli uomini la condotta sociale desiderata mediante la minaccia
di una misura coercitiva27, dove ciò che lo caratterizza, rispetto ad altri ordinamenti sociali, è l’elemento coattivo, “crea”, per così dire, fa
sorgere diritti-situazione favorevoli concepiti
e vissuti in termini conflittuali. Non c’è spazio per la comunicazione che è vera, invece,
nella misura in cui cerca la “comprensione”
«atto con cui si prende coscienza della realtà intesa come l’insieme di componenti fattuali,
un dovere (uno e uno solo) riconducibili singolarmente a molte persone diverse.» «Per Hohfeld il supposto
unico diritto reale, correlato con un “dovere” di tutte le
persone, comporta in realtà tanti separati e distinti rapporti “diritto-dovere” quante sono le persone soggette a
un dovere». «Con questa sua seconda tesi Hohfeld conduce alle estreme conseguenze la tesi della necessaria
relazionalità di ogni posizione giuridica estendendola
anche ai diritti reali, così come dalla seconda tesi deriva
che non può esistere un soggetto di diritto isolato, ma
che un soggetto di diritto si dà sempre insieme ad un
secondo soggetto di diritto (così come in M. Buber o in
E. Mounier l’“Io” è costitutivamente definito dal “Tu”)».
Così G.M Azzoni in L. Lombardi Vallauri (a cura di),
Logos dell’essere logos della norma. Studi per una ricerca, cit.,
pp. 991-995.
26 G. Zagrebelsky ricorda che se la democrazia basata sulla libertà «alimenta la pura libertà egoistica, realizzando integralmente il resort individualistico, sprigionerà
la medesima forza autodistruttiva che è proprio di altri
regimi che realizzano integralmente il proprio principio essenziale» in Contro l’etica della verità, cit, p. 14 e, in
un’altra meno recente opera, Il diritto mite, Torino, 1992,
p. 129 parla di «potenziale aggressivo, disgregatore e distruttivo dei diritti, in particolare, dei diritti in funzione della volontà». P. B. Sorge, Charitas in veritate: una bussola per il XXI secolo in Aggiornamenti Sociali 9-10/2009
p. 568, a proposito del paragrafo n. 43 dell’Enciclica di
Benedetto XVI, avverte come la rivendicazione dei diritti individuali, se svincolati da una visione complessiva
di diritti e doveri, diviene l’occasione per mantenere i
privilegi di pochi.
27 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, cit. p. 45.
issn 2035-584x
emotive, psicologiche e affettive che costituiscono il “bagaglio” di ciascun contendente. [...]
Comprendersi, misurandosi con la realtà crea
inoltre una comunanza di prospettiva.[...] Per
poter capire occorre, infatti, aprire il proprio
angolo visuale, imparare ad ascoltare, fare domande, piuttosto di avere risposte.» Solo un
«atteggiamento di apertura e “curiosità” non
ostili verso la comprensione della realtà rende
possibile la comunicazione: non parlando per
imporre e nemmeno per convincere, ma con
l’intento di farsi capire [...] si induce una certa
disponibilità all’ascolto reciproco, a non rifiutare in modo precostituito ogni suggerimento
o proposta di provenienza unilaterale»28.
Spetta anche alla Pubblica Amministrazione, nelle articolazioni necessariamente “personali” dei suoi organi, di sperimentare questa dimensione della relazionalità? La risposta
non può che essere affermativa: vista in termini di relazione personale, la comunicazione è
sempre un evento che arricchisce; vista in termini istituzionali, l’arricchimento porta alla
corretta conoscenza delle diverse posizioni
coinvolte cosicché il potere di scelta (discrezionale) sarà in condizione di essere esercitato in
modo ottimale29.
La comunicazione (istituzionale) trasformandosi da giuridico-formale a rapporto sostanziale di comune ricerca delle ragioni per
l’agire si rivela idonea a superare la tradizionale asimmetria del rapporto cittadini-P.A
inducendo nella democrazia una forza propulsiva che, da sistema formalistico di stampo liberale, la trasformi in quella democrazia di sostanza secondo i connotati impliciti
nella nostra Costituzione, di cui sono tipici
esempi sia la norma dell’art. 3, II comma sia
la nuova formulazione dell’art. 118 u.c. laddove prevede che, sulla base del principio di
sussidiarietà, sia favorita la partecipazione
dei cittadini, singoli e associati, allo svolgi28 C. Mazzucato in L. Lombardi Vallauri (a cura di),
Logos dell’essere logos della norma. Studi per una ricerca, cit.,
p. 1260.
29 Cfr. G. Gardini, Le regole dell’informazione, Zibido San
Giacomo (MI), 2009, p. 267.
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
116
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
mento di attività di interesse generale30.
5. Uno strumento: il difensore civico
La figura del difensore civico, detto ombudsman in altri ordinamenti dov’è nato, e introdotto nell’ordinamento italiano da singole regioni, prima, e poi solo a livello di enti locali
dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è
una figura che la teoria del diritto italiana tarda ad assimilare. Si tratta infatti di un ibrido:
appartiene all’amministrazione, ma gli è connaturata l’indipendenza; è eletto dal potere politico, - la maggioranza, preferibilmente qualificata, del consiglio, regionale, provinciale o
comunale, - ma deve essere estraneo al gioco
politico di chi lo ha eletto; è privo di un qualsiasi “potere” circa decisioni vincolanti; cerca
la mediazione, ma essendo chiamato “difensore” civico fa pensare più ad un organo a favore
del cittadino che un organo “mediano”, imparziale tra il cittadino medesimo e la PA che pure
lo ha nominato.
Questo ibrido in una prospettiva
“geometrica”31 del diritto non può che stentare
ad essere capita – e di conseguenza “utilizzata” - proprio perché non si inserisce nell’ottica formale e gius-positivista del diritto come
norma/coazione - scontro. Essa può inserirsi
solo se ci si apre ad un diversa prospettiva del
giuridico: il comportamento giuridico, per
la prospettiva opocheriana, «è un comportamento valutato all’interno dell’ordinamento
come regolare, non perché prevedibile, bensì
in quanto volto al riconoscimento dell’altro.
L’ordine giuridico è perciò la risultante di un
processo di valutazione delle azioni e si pone
come garante dell’affermazione dell’altro.»32
Mentre nella prospettiva kelseniana, dove il
diritto è uno strumento di coazione, l’agire
30 Sul punto si veda in particolare M. Cossutta, Questioni
sulle fonti del diritto, cit., p. 85.
31 L’espressione, com’è noto, è di Francesco Gentile.
Si veda ad esempio Intelligenza politica e ragion di stato,
Milano, 1984 pp. 180 e ss.
32 Testualmente M. Cossutta, Questioni sulle fonti del diritto, cit., p. 3
issn 2035-584x
umano è sottoposto solo a regolamentazione
eteronoma, statuale, nella prospettiva “relazionale” sono invece possibili altri “eventi
giuridici” che consentono alla persona umana
di cercare, se necessario con la mediazione di
un terzo, un’autonoma “fonte” di regolazione
giuridica del proprio comportamento nel confronto con l’altro. Non un giudice, che applica
la norma statuale, per imporre una propria decisione (eteronoma, quindi), ma un soggetto
che non ha nessun’altra forza che quella di “far
parlare” tra loro i contentendi nell’ordine mite
del dialogo e dell’incontro.
Gli strumenti di cui si avvale il difensore civico, infatti, essenzialmente promozione, suggerimento e mediazione – che nella pratica si
rivelano efficacissimi – possono essere intesi
solo in una prospettiva di ricerca della “pacificazione” intesa come quel procedimento «che
porta all’instaurazione di un ordine dialogico
e collaborativo tra i litiganti fondato sul reciproco riconoscimento»33. Questa prospettiva è agli antipodi di una logica di scontro – il
diritto visto come strumento di coazione -: lo
scopo della pacificazione è la ricostruzione, la
ritessitura della relazione lacerata dal conflitto. Secondo Mazzuccato «L’ordine imposto
attraverso l’applicazione del diritto non è un
ordine armonioso, non è kosmos.»34 La norma
eteronoma, che nasce per controllare la violenza, per sottrarre i litiganti alla vendetta e alle
giustizia private e arbitrarie «instaura una
tranquillità basata sulla “separazione” [...] tra
un soggetto e l’altro, sulla definizione del diritto e del torto, del giusto e dell’ingiusto, sulla
separazione -appunto- anche fisica, dei colpevoli dagli innocenti, dei vincitori dai vinti.»35
«La pace assicurata dal diritto inteso come
sistema di norme statuali, eteronome si dimostra oggettivamente insufficiente anche
sul piano dell’effettiva risoluzione dei conflitti: essa infatti, lo si è visto, non produce
33 Così testualmente C. Mazzucato in L. Lombardi
Vallauri (a cura di), Logos dell’essere logos della norma.
Studi per una ricerca, cit., p. 1245.
34 C. Mazzucato, ibidem, p. 1246
35 Ibidem.
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
117
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
una vera riconciliazione fra i litiganti»36
Le difficoltà a comprendere la figura dell’ombudsman che ho sopra evidenziato, hanno fatto sì che da poco sia iniziata una sistematica
riflessione sulle sue funzioni e che finora lo si
sia studiato più in ambito comparatistico che
all’interno del sistema amministrativo italiano. Insomma, ha ancora bisogno di ricevere,
dalla cultura anzitutto, una definizione convincente. Solo una riflessione e una “presa di
coscienza” scientifica del significato e del ruolo
del difensore civico potrà portare ad una legge
statuale che, pur in un sistema articolato su
base regionale e locale, ne preveda la necessità
e ne disegni alcuni principi comuni imprescindibili.37
Tra queste caratteristiche dovrà esserci quella della prossimità al cittadino per “stare dalla
sua parte”: questo, specie dal punto di vista della
comunicazione, non dovrà significare però parzialità in una logica di scontro, ma dovrà essere
36 Ibidem, p. 1247. In un mio precedente scritto, Il difensore civico – Una diversa cultura del diritto, in “Etica per
le professioni”, 2008, 3, pp. 64-71 scrivevo, sulla base
dell’esperienza personale di difensore civico regionale del Friuli Venezia Giulia maturata dal 2003 al 2008
che il processo, luogo dove tradizionalmente si esplica
la funzione di risolvere la lite - che è lacerazione della
relazione - non è, in realtà, il luogo dove la relazione è
ricomposta. La sentenza che definisce il processo non
ha, per sua natura, questa funzione. Nel concreto spesso
lascia i rapporti più esacerbati: per il soccombente, nella
misura in cui, sconfitto, sente tutta la frustrazione per la
battaglia persa e un senso di ingiustizia quando non gli
è dato di comprendere le ragioni della sentenza perché il
tecnicismo terminologico la rende non intellegibile; per
la parte vittoriosa nella misura in cui si ritrova con quella che gli appare una “vittoria di Pirro” quando il tempo
impiegato, le spese sostenute e le difficoltà nel mettere
in esecuzione la sentenza lasciano l’amaro in bocca.
37 Potrebbe avvenire altrimenti in altri casi quanto successo al Difensore civico regionale del Friuli Venezia
Giulia nell’agosto del 2008: che, dopo essere stato a
lungo “tollerato” come fosse solo un dispendioso (sic!)
“seccatore” istituzionalizzato, bistrattato nella sua imprescindibile indipendenza facendone oggetto di lobbistico mercimonio, dopo venticinque anni di onorata
attività ne è stata abrogata la legge istitutiva con un solo
comma di una legge di aggiustamento di bilancio. Il
Difensore Civico era stato istituito nella Regione Friuli
Venezia Giulia con legge regionale n. 20/1981 ed è stato
soppresso dall’art. 12 comma 33 della L.R. 14.8.2008 n. 9.
issn 2035-584x
una “presa in carico”38 dei suoi problemi affinché siano risolti, se possibile, e, qualora questo
non possa avvenire, sia recuperato il rapporto
con la P.A. mediante un’attività di mediazione
nella quale potrà trovarsi una composizione
oppure potranno attivarsi quelle energie positive di “cittadinanza” per cui il cittadino sia
disponibile ad accettare l’impossibilità legibus
sic stantibus della soluzione sperata.39 Queste
energie potranno incalanarsi, eventualmente,
nella creazione di comitati e associazioni che
puntino ad una modifica delle norme.
Per ottenere un risultato positivo in termini di mediazione l’interlocuzione con gli uffici
operativi della P.A. non dev’essere partigiana ed
aggressiva, perpetuando quello stereotipo ben
descritto da S. Rolando40 e sopra riferito, bensì
dovrà utilizzare gli strumenti della sollecitazione e della persuasione sulla base delle leggi
vigenti alla luce dei principi costituzionali e dei
trattati internazionali. La sua interlocuzione
con il cittadino non potrà blandirne i desideri,
a pena di cocenti delusioni quando si scopra
una realtà diversa, ma essere semplice, chiara e
onesta, nel senso di dirgli le cose come stanno.
Questo però non è un problema di poco conto,
oggi: dire le cose come stanno suppone un’idea
di “verità”. Se l’idea stessa di verità è andata così
in crisi nell’epoca moderna e , lentamente, la
38 S. Rolando, La comunicazione di pubblica utilità, cit., p.
321 mette in evidenza come lo svolgersi di una cultura
attiva può far emergere una rispettiva «valorizzazione
del rispetto e della fiducia. [...] Il perimetro dei diritti
della persona è infatti – oltre al tema delle inviolabilità e
delle sensibilità – (tutela della privacy) anche un terreno
in cui conta il “farsi carico”. Apparentemente il campo
opposto, ovvero quello dell’intrusione. Ma è un’intrusione modellata dalla cultura del servizio e non da quella del controllo».
39 Funzione diversa svolgono gli Uffici di Relazione col
Pubblico: il compito prezioso di informazione all’utenza,
che si è sempre più diffuso nella P.A. è altra cosa, per lo
più è compito di informazione. Il Difensore civico deve
invece fare parte dei processi di comunicazione, nel senso completo del termine, come ascolto, presa in carico
e risposta personale. Quello è un servizio offerto per la
fisiologia del sistema di relazioni tra P.A. ed utenza, il difensore civico invece è un servizio offerto per la patologia della relazione, quando qualcosa non ha funzionato e
il compito è quello di aggiustare, ricucire il rapporto.
40 S. Rolando, La comunicazione di pubblica utilità, cit,
p. 316.
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
118
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
crisi di questo concetto è giunto nella vita comune e ha contaminato la “spontaneità” della
vita diretta delle persone comuni41, il compito
è assai arduo. Merita però di essere percorso. E’
una semina silenziosa e non appariscente; ha
bisogno di tempo, proprio come la semina, i risultati non si vedono nell’immediato. E’ un’iniezione silenziosa di “semi di pace”, quella «pace
cognitiva, e della verità [...] pace severa, senza
sentimentalismi»42 che la persona quando viene riconosciuta nei suoi bisogni e nelle sue ragioni il più delle volte è disposta a perseguire43.
A che punto è la legislazione italiana circa
questo istituto? A parte la lodevole autonoma
iniziativa delle regioni, è sicuramente significativo che la prima apparizione del difensore
civico nel diritto statuale italiano sia avvenuta
nella legge sulla trasparenza amministrativa44
ed è significativo alla luce del discorso sulla
comunicazione che, come si è visto, è assolutamente necessaria per un’amministrazione
democratica: «la democrazia deve essere il
regime della verità, nel senso della piena possibilità della conoscenza dei fatti da parte di
tutti. Perché solo così i cittadini sono messi
in condizione di controllare e giudicare i loro
rappresentanti, e di partecipare al governo della cosa pubblica.»45
41 Come dice G. Capograssi, Giudizio processo scienza verità, in Rivista di Diritto processuale, 1950, I, p. 54 «all’ultimo stadio della crisi, è apertamente negato che la verità
obbiettiva delle cose, [...] che quello che è valga, debba
essere riconosciuto» ed, invece, il fine che una forza
storica vuole imporre, diventa se si vuole la verità: «è
“vero” tutto ciò che favorisce questo fine, “falso” tutto
quello che l’ostacola. In ultima analisi la forza, solo la
forza, diventa la “verità”»
42 C. Mazzucato in L. Lombardi Vallauri (a cura di),
Logos dell’essere logos della norma. Studi per una ricerca, cit.,
p. 1249.
43 ibidem
44 Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dalla L.
24/11/2000, n. 340, art. 15. Una comparsa parrebbe timida, in realtà “rivoluzionaria” perché, il ricorso al difensore civico previsto dall’art. 25 della L. 241/90 è e resta
l’unico caso in cui l’intervento dei difensori civici da
una parte è procedimentalizzato e dall’altra sospende, o
meglio non fa decorrere il breve termine per il ricorso
davanti al TAR.
45 S. Rodotà, La menzogna. Quando i potenti manipolano
la realtà, La Repubblica 27.3.2004, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/03/27/
issn 2035-584x
6 Democrazia e partecipazione: la
trasparenza degli atti e del linguaggio
Il principio della trasparenza amministrativa è stato atttuato in Italia, com’è noto, con
la L. 7 agosto 1990 n. 241 che, sia con le norme
inerenti la partecipazione procedimentale – a
partire dalla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7) -, sia con quelle relative all’accesso agli atti del procedimento, ha indubbiamente fatto fare alla pubblica amministrazione
italiana un grande passo avanti, innescando
«un rapporto biunivoco tra amministrazione
e privati,[...] un rapporto interattivo tra soggetti.[...] Attraverso la partecipazione procedimentale il cittadino è messo in grado non
solo di conoscere l’azione che l’amministrazione pone in essere, ma anche di modificarne lo sviluppo e l’esito. La partecipazione, e il
giusto procedimento che si realizza mediante
essa, risulta quindi funzionale al cittadino, ma
anche alla stessa amministrazione per poter
assumere la propria decisione con una migliore rappresentazione dei fatti e degli interessi
coinvolti»46 Il potere di scelta dell’amministrazione (discrezionalità) sarà, cioè, esercitato in
modo ottimale solo quando sia supportato da
una corretta conoscenza delle posizioni coinvolte47. Quanto al diritto all’accesso, il suo riconoscimento tende a modificare il tradizionale
modo di rapportarsi dell’amministrazione con
il cittadino, andando verso la trasformazione
dell’amministrazione pubblica in una “casa di
vetro” in cui il cittadino abbia la possibilità di
osservare e controllare costantemente l’attività dell’amministrazione stessa48.
Ma non bastano i documenti. Il problema
della comunicazione è connesso al problema
del linguaggio: per comunicare è necessario
essere comprensibili. In linguistica, nell’affrontare il problema del linguaggio giuridila-menzogna-quando-potenti-manipolano-la-realta.
html; sito consultato il 23.9.2009. Il termine democrazia accolto da Rodotà e da G. Zagrebelsky (di cui alle
note 17 e 24) si rifà, evidentemente, ad un concetto di
democrazia sostanziale.
46 G. Gardini, Le regole dell’informazione, cit, p. 266
47 G. Gardini, Le regole dell’informazione, cit, p. 267 .
48 P. Costanzo, L’informazione, Bari, 2004, p. 74
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
119
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
co, si riconosce da una parte che «Il principio
del controllo democratico del contenuto delle
leggi e delle modalità della loro applicazione
è sempre presente nelle riflessioni condotte
dai giuristi»49 dall’altra che questa esigenza
va contemperata con quella di raggiungere la
massima precisione per la quale il linguaggio
comune si rivela inadatto50. Tuttavia, questo
stile «caratterizzato da prolissità e cavillosità
che vanno ben oltre le giustificate esigenze di
precisione e di chiarezza [...] viene stigmatizzato dai cittadini in qualità di utenti, i quali
si ribellano a ciò che percepiscono come un
sopruso da parte di una casta professionale
che difende il proprio potere dai non adepti anche attraverso una marcata e deliberata
complicazione linguistica»51 Mi pare sensata
la distinzione tra il “linguaggio della legislazione” ed il “linguaggio dei giuristi” per dare
conto «dei due compiti principali assegnati
allo strumento linguistico dal diritto: da una
parte la formulazione di norme che descrivono e regolano la realtà sociale e che sono dirette a tutti i cittadini [...] e dall’altra la riflessione
metagiuridica delle norme stesse, riservata
agli esperti.»52 A questi due ne aggiungerei un
altro: il linguaggio degli operatori del diritto,
siano essi avvocati, magistrati o funzionari
della PA quando si rivolgono al cittadino: qui
il linguaggio dovrebbe essere quello comune,
operando una vera e propria “traduzione” dei
termini tecnici. Infatti, il comunicare con il
cittadino con un linguaggio tecnico si rivela
un modo di tenere nascosto il proprio pensiero, un arroccamento nel potere. Da tempo
sono stati lanciati, dai ministri alla funzione
pubblica che si sono succeduti, programmi
di azioni positive per la comunicazione delle
pubbliche amministrazioni, nella consapevolezza «che non è lanciando una parola d’ordine che si raddrizzano le gambe a cani abituati
49 Cfr. S. Ondelli, La lingua del diritto, cit., p. 8. All’autore
pare ingenuo però l’auspicio di leggi trasparenti espresse in un linguaggio comune e indispensabile nel diritto un linguaggio tecnico per raggiungere la necessaria
precisione.
50 Ibidem.
51 Ibidem, p. 18
52 Ibidem, p. 19
issn 2035-584x
da secoli alla deformazione ossea [...]53 Il difensore civico, che incontra quotidianamente
molti cittadini che vivono una relazione non
buona con la pubblica amministrazione; che
vede in corpore vili i danni prodotti dalla comunicazione mancata, deficitaria o sbagliata; che
ha come sua mission la ricucitura del rapporto
mediante il rimedio al ritardo, alla disfunzione o mediante la mediazione, impossibilitato
com’è a prendere provvedimenti vincolanti;
con l’esperienza che accumula e la sensibilità
che affina, è in grado di fornire validi indicazioni e suggerimenti sul modo migliore per
comunicare tra P.A. e cittadino.
Rendere comprensibile il proprio linguaggio, pertanto, significa parlare e scrivere in una
espressione linguistica corretta e comprensibile al cittadino con un livello medio di scolarità, tenendo conto che la maggioranza dei
programmi scolastici non prevedono lo studio
del diritto; la comunicazione poi deve essere
completa, deve cioè rendere compiutamente il
pensiero che origina l’azione amministrativa,
gli obiettivi perseguiti, le leggi applicate, gli
interessi che sono stati comparati per giungere ad una certa decisione; infine deve essere
concisa e non ridondante: dire quanto serve in
modo semplice, ordinato, completo, senza informazioni inutili54.
53 S. Rolando, La comunicazione di pubblica utilità, cit.,
p. 317. L’Autore avverte che «La motivazione a lavorare
sulla semplificazione dei linguaggi deve avere un contesto di riferimento in cui l’azione individuale – e dunque l’esperienza – ha la sua centralità. Schemi astratti di
semplificazione si declinano in schemi astratti di comportamento. I primi lasciano intatto il “burocratese”, i
secondi lasciano intatta la diffidenza sociale e i sentimenti di depersonalizzazione.»
54 I sistemi di videoscrittura al computer rendono oggi
possibile personalizzare la comunicazione scritta anche
quando si tratti di atti ripetitivi. Non ha senso avere a
disposizione questi moderni sistemi di redazione degli atti ed usarli per confezionare e stampare moduli:
la comunicazione va personalizzata dando al cittadino
le informazioni che servono nel suo caso particolare.
Eventualmente si potrà depennare da un modulo quanto non interessa, ma il costume di fornire una massa
di informazioni inutili all’interno delle quali il singolo debba cercare quanto concerne il proprio caso è un
modo di comunicare sciatto, spesso fonte di errori e che
mette le persone in difficoltà.
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
120
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Sembrano offensivi e controproducenti i
messaggi incoerenti e lacunosi o anche solo
approssimativi, quasi, appunto, vi fosse qualcosa da tenere nascosto. In un’epoca, come dicevamo, in cui i cittadini sanno dei loro diritti,
anche se spesso non ne conoscono esattamente la portata e i contorni, quanto resta oscuro
è percepito come offesa e diventa occasione di
protesta e di lite. Una comunicazione corretta,
invece, oltre ad essere più efficace, è anche educativa nel senso che il singolo può essere aiutato a comprendere che le decisioni si basano su
una serie di norme da coordinare, su una comparazione di interessi, su una serie di motivi
che non sono volti contro di lui, ma debbono
tener conto dell’interesse del singolo e di quello
degli altri, così come di una serie di circostanze
che possono non essere a lui favorevoli.
issn 2035-584x
sia informato e che sia messo in grado di capire la vita delle amministrazioni pubbliche.
Un cittadino, non solo un “consumatore”,
consapevole.
Perché questo accada è necessario un organo
amministrativo indipendente che aiuti i cittadini a risolvere i loro problemi con la pubblica
amministrazione – la diffusione dell’ombudsman in tutti i paesi del mondo e specialmente
in quelli di più antica tradizione democratica
rivela che non vi sono amministrazioni perfette dove non sorgano problemi tra i cittadini e
la pubblica amministrazione - non nell’ordine
del conflitto, ma nell’ordine mite del confronto
e della mediazione affinché la soluzione possa
anche essere trovata insieme. Una soluzione
rispettosa sia delle sue aspettative o bisogni
sia del “bene pubblico” al quale così ogni cittadino deve poter concorrere.
Conclusioni
Alle domande poste inizialmente circa l’esigenza di una comunicazione chiara e completa
nei confronti dei cittadini da parte della Pubblica Amministrazione ho inteso fornire una
risposta positiva cercando nelle “radici” del sistema democratico: di fronte ad un’usura evidente di un concetto “comunitario” dello stato
di diritto e del valore stesso della democrazia
ho cercato di spiegare la necessità che il cittadino sia coinvolto nella vita delle istituzioni
con un linguaggio che sia alla sua portata, che
gli sia comprensibile, un linguaggio idoneo
affinché possa essere partecipe della ricerca
di una “comune azione giuridica” (secondo
l’etimo del termine comunicazione). Comune
proprio perché appartenente sia al popolo che
alla burocrazia che è al suo servizio, al servizio
del bene che accomuna le persone che appartengono alla comunità territoriale sulla quale
incide una determinata attività amministrativa. Questo coinvolgimento può trasformare
il rapporto da verticale – autorità/suddito – ad
orizzontale, dove la ricerca del bene comune è,
appunto, un fatto che appartiene a tutti e tutti
vi possono concorrere. Per fare del cittadino,
di ogni cittadino, un possibile partecipante a
questa ricerca è necessario che, appunto, egli
Caterina Dolcher, avvocato, ha svolto attività
legale presso enti pubblici ed è stata membro del
Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia
Giulia. Dal 2003 al 2008 è stata Difensore Civico
regionale nel FVG. Si è occupata di rapporti fra il
cittadino e la PA, pubblicando alcuni saggi in materia. Ha tenuto, come professore a contratto, presso
l’Università degli Studi di Trieste, l’insegnamento di
Diritto di famiglia.
Amministrazione e cittadino: quale comunicazione
121
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Digressioni sull’esecuzione della pena con particolare riguardo al cittadino straniero.
Dalla comunicazione interculturale alla funzione
rieducativa della pena ed al pieno sviluppo della
persona umana
Marco Cossutta
Abstract
Parole chiave
L’autore, nel presentare raccolti alcuni studi elaborati dal 2004 sul problema del deviante e dell’esecuzione penale, pone l’accento sulla funzione rieducativa della pena, così come si è venuta ad affermare
nell’ordinamento giuridico attraverso una rilettura
del dettato costituzionale. Si rileva però che in talune situazioni, con particolare riguardo al cittadino
straniero, la pena assume vistosi connotati prevenzionistici, tanto da lasciare supporre una sorta di
dualismo fra il trattamento del cittadino italiano
e quello dello straniero. In proposito si esamina la
natura ed il diverso utilizzo della misura di sicurezza personale a fronte di cittadini italiani e stranieri.
L’autore ravvisa, anche alla luce di recenti interventi
legislativi (vedi la legge 94/2009), una sorta di riconsiderazione in chiave critica del profondo processo di riforma dell’ordinamento italiano avviatosi
negli anni Settanta dello scorso secolo, che, accanto
al nuovo diritto di famiglia, ha proposto la riforma
dell’Ordinamento penitenziario del 1975 e la legge
manicomiale del 1978.
Articolo 3 Costituzione;
Articolo 27 Costituzione;
Clandestino;
Comunicazione interculturale;
Devianza;
Diritti umani;
Esecuzione della pena;
Espulsione cittadino straniero;
Funzione rieducativa della pena;
Lavoro carcerario;
Legge 180/1978;
Mediazione culturale;
Misure di sicurezza personali;
Ordinamento penitenziario;
Pena come prevenzione.
Dans les premiers jours du mois d’octobre 1815,
une heure environ avant le coucher du soleil,
un homme qui voyageait à pied entrait dans la
petit ville de Digne.
(Victor Hugo)
Premessa
I
testi qui di seguito presentati sono stati elaborati dalla primavera del 2004 alla
primavera del 2009, nell’arco di un quinquennio, durante il quale l’autore più volte
è stato sollecitato ad intervenire in tema di
esecuzione della pena. Gli scritti in questione danno conto delle relazioni presentate ai
vari conventi ed incontri di studio ove venne
invitato ad esporre la sua opinione in merito
ai temi lì trattati.
Digressioni sull’esecuzione della pena
Si trattava di incursioni in un ambito della riflessione giuridica che non gli era né gli è
tutt’ora proprio, né per formazione, né per vocazione di studi; pertanto possono essere considerati episodi isolati, il più delle volte determinati
da un improprio coinvolgimento, da parte degli
organizzatori, fra ben più qualificati relatori.
Ciò non di meno si auspica che il materiale in
quelle occasioni raccolto ed elaborato e fin’ora
inedito, possa essere di qualche utilità; in primis
122
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
per colui che lo ha scritto, di modo che possa
offrirsi costante e concreta testimonianza della
sua incosciente sfrontatezza nell’addentrarsi
in campi a lui pressoché sconosciuti e, secondariamente, perché si ritiene che, sia pure con
esiti che definire dilettantistici appare poco,
nei testi qui presentati si possa pur tuttavia cogliere la tensione a porre la persona umana e la
sua sfera relazionale al centro della riflessione
sull’esecuzione della pena e sulle sue finalità rieducative, centralità della persona umana che
pare nel concretarsi di alcune recenti politiche
penali alquanto depotenzializzata.
Soprattutto la finalità rieducativa, ben istituita fra i valori fondamentali della Repubblica dal legislatore costituzionale sembra,
all’interno delle elaborazioni normative proposte dal legislatore ordinario in questi ultimi anni, non ritrovare più, non solo pratica
attuazione, ma nemmeno teorico richiamo,
tanto da far trasparire, in alcuni specifici settori del diritto penale, ove si richiamano figure riconducibili al cosiddetto extracomunitario, una concezione della pena attratta da fini
prevenzionistici più che rieducativi.
Si rammenta in pronostico come l’articolo
61 del Codice penale, recentemente novellato,
al comma 11 bis introduca fra le circostanze
aggravanti comuni la qualifica di clandestino;
infatti, ai sensi del predetto comma, “l’avere
il colpevole commesso il fatto mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale” costituisce una delle circostanti aggravanti parimenti
a quanto disposto dal comma primo dell’articolo 61, ovvero “l’aver agito per motivi abietti o
futili”. Sicché, stante a questa impostazione, la
condizione di clandestinità, la quale, come oramai appare conclamato, si manifesta a seguito
di gravi squilibri socio-economici presenti nel
paese d’origine (da cui di fatto l’agente fugge),
che si fondono con l’impossibilità, nel paese di
rifugio, di raggiungere un’integrazione, tanto
da collocare nuovamente il soggetto clandestino
qui rifugiatosi in una situazione di totale marginalità e minorità socio-economica nonché
giuridica, tale condizione, per quanto si suppone non certamente soggettivamente ricercata, rende oggettivamente il reo meritevole di
un aggravio di pena. Il comma 11 bis introduce
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
nell’ordinamento una ulteriore circostante aggravante soggettiva, legata cioè alla condizione
del reo, la quale ritrova però la propria causa
non, ad esempio, nell’intensità del dolo e nemmeno nella personalità del delinquente, che
per l’appunto sono manifestazioni ed elementi di soggettività, bensì nella sua intrinseca ed
ineliminabile povertà oggettiva, povertà che ne
fa un soggetto oggettivamente pericoloso.
Rebus sic stantibus, l’inasprimento della sanzione risulta difficilmente comprensibile al
reo, se non sotto la vesta di una ennesima vessazione, che il mondo dei ricchi offre a quello
dei poveri, tanto da far apparire l’esecuzione
della pena non pienamente collocabile in quel
processo rieducativo che per venire attuato,
stante l’ordinamento vigente, non può che interamente fondarsi sulla colpevolezza: “vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice
della scala dei valori la persona umana (che non
può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche che
lo stesso sistema, allo scopo d’attuare compiutamente la funzione di garanzia assolta del principio di legalità, ritiene indispensabile fondare
la responsabilità penale su «congrui» elementi subiettivi”, così la Corte costituzionale nella
lontana sentenza n. 364 del marzo del 1988.
Il richiamo fra le circostanze aggravanti della semplice condizione di trovarsi “illegalmente sul territorio nazionale” fa sì che si imputi
al reo una responsabilità il più delle volte non
a questi soggettivamente ascrivibile, ma che,
ciò non di meno, lo trasforma, prescindendo
dal reato commesso e dalle modalità in cui il
comportamento delittuoso si è estrinsecato, in
elemento socialmente ostile.
Questa impostazione pare ribadita e rafforzata da recentissime disposizioni legislative, quale la legge n. 94 del 15 luglio 2009, che,
all’articolo primo, comma sedicesimo, introduce nell’ordinamento (segnatamente nel Testo
unico delle disposizione concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, all’articolo 10 bis) il reato di Ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
Tale nuova fattispecie criminosa, configurabile quale contravvenzione, non sostituendo
quanto previsto, all’articolo 10 del Testo unico,
123
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
in materia di respingimento da parte dell’autorità di pubblica sicurezza degli stranieri “che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera sono fermati all’ingresso o subito dopo”, così al comma secondo
dell’articolo 10, pare sovrapporti sostanzialmente a quanto già prescritto dall’articolo 13
del Testo unico in materia di espulsione amministrativa, trasformando quella che sostanzialmente appariva situazione meritevole di misura di sicurezza in un reato.
Ma questa trasformazione si palesa soltanto apparente; infatti, pur prevedendo la
disposizione dell’articolo 10 bis, il reato e la
conseguente sanzione di natura pecuniaria, infatti viene comminata un’ammenda da 5.000 a
10.000 euro, l’unica conseguenza che pare riscontrasi, salvo caso di recidiva, è l’espulsione
dello straniero denunciato e non, come potrebbe aspettarsi, dello straniero condannato, di cui
fra l’altro si fa menzione nel novellato articolo
16 del Testo unico, ove il giudice ha facoltà di sostituire la pena erogata, anche ex articolo 10 bis,
“con la misura dell’espulsione per un periodo
non inferiore ad anni cinque”.
Nella nuova disposizione legislativa possiamo, infatti, riscontrare espressioni quali
“esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato” per ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato; che di mero denunciato si
tratti e non di reo ce lo fa supporre un ulteriore
passo del predetto articolo, ai sensi del quale, a
fronte della fattispecie di cui sopra, “il giudice,
acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione […] pronuncia sentenza di non luogo a
procedere”; soltanto nel caso in cui lo straniero rientrasse illegalmente nel territorio nazionale, ovvero ricadesse nella stessa fattispecie
criminosa, da cui la recidiva, si procederà con
l’azione penale, dalla quale potrà scaturire una
condanna con conseguente erogazione di pena
sostituibile con l’espulsione.
Pertanto, di fronte alla prima commissione
del reato, la sanzione pecuniaria dell’ammenda
comminata dal legislatore nei fatti si trasforma
nell’immediata espulsione nel soggetto denunciato, il quale, data la pronuncia di non luogo a
procedere, non può essere considerato reo di
alcunché; ciò non di meno gli è soggetto ad un
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
provvedimento, non di natura giurisdizionale,
di pura di prevenzione sociale. Che il provvedimento non abbia natura giurisdizionale è ben
evidenziato dal fatto che, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione non è previsto il nulla osta
rilasciato dall’autorità giudiziaria, che l’articolo 13, comma terzo del sopra richiamato Testo
unico ritiene necessario al fine di procedere
all’espulsione dal territorio nazionale di uno
straniero sottoposto a procedimento penale.
Ben strano reato è stato inserito nell’ordinamento soprattutto se letto alla luce della “garanzia assoluta del principio di legalità”, a cui faceva riferimento la Corte costituzionale nel 1988:
il denunciato o indagato, che di si voglia, non
viene sottoposto ad alcun procedimento penale,
non sarà mai imputato, pertanto non potrà mai
venire condannato per il reato in questione, né
gli potrà venire erogata una pena (rammentiamo che, ai sensi del comma secondo dell’articolo 27 del dettato costituzionale, “l’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva”), non solo, egli mai comparirà, mancando un formale rinvio a giudizio, di fronte
all’autorità giudiziaria, la quale acquisirà notizia dell’esecuzione dell’espulsione dal questore
e pronuncerà il non luogo a procedere.
Alla pena, mai erogata, è sostituita la misura dell’espulsione eseguita dall’autorità
di pubblica sicurezza e lo stato, per tramite
di un espediente da leguleio, abdica, fra gli
altri, al suo diritto e dovere alla rieducazione di un soggetto che viene, de facto, considerato colpevole di reato senza però che
nessun organo lo abbia mai dichiarato tale
(vedi la sentenza di non luogo a procedere
emessa dall’autorità giudiziaria competente
ad accertare il reato, che viene emessa dalla
stessa dopo che il questore le ha comunicato
l’espulsione del clandestino).
Va altresì posto il problema del ricorso avverso all’esecuzione di espulsione ex articolo
10 bis, il quale, a fronte di un provvedimento
di espulsione amministrativa è ammesso dal
comma ottavo dell’articolo 13 del Testo unico.
Dalla lettura della disposizione, salvo il caso di
azione penale riproposta, ai termini dell’articolo 345 del Codice di procedura penale, per il
soggetto che rientrasse illegalmente nel terri124
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
torio dello stato, non pare trasparire opportunità di ricorso contro l’esecuzione dell’espulsione da parte del questore. Tutto ciò in grave
lesione dell’articolo 111, comma settimo del
dettato costituzionale.
In proposito sovvengono le parole della
Corte costituzionale che, più di vent’anni fa,
ribadiva la non legittimità di una pena scevra
da percorsi rieducativi e protesa verso una
funzione deterrente nei confronti del reo: “ciò
è sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data al grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana”, così
leggiamo nella già richiamata sentenza n. 364
del marzo del 1988.
Si assiste all’introduzione nell’ordinamento
di un reato sì consumabile, ma nei fatti volutamente non giustiziabile; in situazioni di clandestinità viene agitato lo spettro del crimine,
operando una sorta di criminalizzazione mediatica di una situazione di estrema marginalità sociale, a fronte della quale l’ordinamento,
in deroga ai suoi principi generali, agirà per
mezzo dell’autorità di pubblica sicurezza, negando nei fatti all’indagato ogni forma di garanzia, incrinando con ciò il principio di legalità su cui si fonda l’ordinamento stesso.
Pare in definitiva che in taluni ambiti, in
vero quantitativamente ristretti (vedi il richiamo sopra effettuato al clandestino), ma
non per questo qualitativamente irrilevanti per il sistema giuridico e per i valori che lo
stesso veicola(va), si assista ad una rotta della
pena verso lidi prevenzionistici più che rieducativi, ponendo in essere con ciò una sorte
di dualismo finalistico della pena, che rimane
pur sempre ancorata a teorie rieducative per
la maggior parte dei soggetti al diritto penale,
ma che assume sembianze prevenzionistiche
per una minoranza degli stessi.
Una minoranza, che per le condizione oggettive di minorità in cui versa, ben esemplificate dal termine clandestino, più di altri dovrebbe
usufruire, ove ciò fosse praticamente possibile, di quell’opera di rimozione degli ostacoli
che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana, a cui il legislatore costituzionale
fa cenno al comma secondo dell’articolo tre del
dettato costituzione, la cui luce permette alla
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
Corte costituzionale, nella sentenza qui citata,
di ritenere indispensabile “garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere
penalmente solo per azioni da lui controllabili
e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente
vietate”, ovvero di por fine all’errare ramingo
del Jean Valjean dei nostri giorni.
I quattro contributi qui raccolti son presentati in maniera disgiunta, in modo che ognuno
possa mantenere, qualora sia presente, il proprio apparato di note, al quale non è stato apportato alcun aggiornamento bibliografico dal
tempo della loro stesura.
Il primo inerisce alla collocazione dell’istituzione carceraria all’interno di una dimensione
europea, con particolare riguardo alla funzione
rieducativa della pena. In proposito si ritiene
che, ove la pena potesse risultare, in via teorica,
connessa ad un processo di rieducazione del reo,
tale itinerario, nel caso dello straniero, pare il
più delle volte depotenzializzato dalla mancanza di una mediazione culturale nell’esecuzione
della pena, ovvero dall’assenza di un processo
di comunicazione fra istituzione e reo tale da
favorire l’elaborazione di una cultura giuridica comune. Pare in definitiva, come si cerca di
argomentare nello scritto qui presentato1, di riscontrare un forte deficit di educazione ad una
comune giuridicità, che coinvolga fattivamente istituzioni rieducative e rei.
Parimenti deficitario appare, come accennato nel secondo contributo presentato2, il
coinvolgimento del detenuto straniero in processi di reinserimento sociale tramite il lavoro
carcerario, con particolare riguardo a quello
extramurario. All’interno di questa problematica, viene fatto cenno alla questione della comunicazione dell’etica del lavoro fra la società
1 Si tratta dell’intervento al Seminario internazionale di
studi su «Carcere ed Unione europea», organizzato il 16
aprile 2004 a Trieste dal Centro Studi Criminologici e
dal Sindacato Direttori Penitenziari.
2 Il testo è stato presentato al convengo «Per una nuova idea di carcere fabbrica del reinserimento sociale»
organizzato a Trieste il 25 maggio 2007 dall’Istituto
Internazionale di Studi sui Diritti dell’Uomo.
125
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
libera ed il mondo dei ristretti.
Il tema della centralità della persona umana e
dell’incisivo processo di riforme sociali e giuridiche che hanno caratterizzato gli anni Settanta
del cosiddetto secolo breve, fra le quali vanno annoverate le Norme sull’ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà, contenute nella legge n. 354 del 26
luglio 1975, e le norme sugli Accertamenti sanitari volontari e obbligatori, proposte dalla legge n.
180 del 13 maggio 1978, è argomento del terzo
contributo presentato3, ove si tratteggia il percorso posto in essere dal legislatore ordinario
per rendere effettivo il comma secondo del già
richiamato articolo tre del dettato costituzionale, percorso che pare possa considerarsi in parte
invertito dal legislatore attuale.
L’ultimo testo proposto4 riguarda specificatamente la questione delle misure di sicurezza e del loro rapporto con l’ordinamento
costituzionale vigente.
3 Il contributo, titolato La legge n. 180 del 13 maggio 1978
ed «il pieno sviluppo della persona umana», è stato presentato come relazione al Convengo su «Prevenzione, giovani e stigma della malattia mentale», organizzato dalla
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste il 4 dicembre 2008.
4 Il testo raccoglie le osservazioni conclusive proposte
al Convegno su «Le misure di sicurezza personali» promosso dalla Camera Penale «prof. Sergio Kostoris» di
Trieste e tenutosi il 21 marzo 2009.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
Su la pena e la sua finalità rieducativa
in un contesto pluriculturale
1. Analisi sociale e politica penale; 2. Valori culturali e politica penale; 3. Parità
versus omologazione; 4. La centralità della
mediazione culturale nel processo rieducativo; 5. Esecuzione della pena ed espulsione;
6. Il diritto-dovere alla rieducazione.
1. Analisi sociale e politica penale
I
n un recente studio di criminologia possiamo leggere: “se la politica è l’arte del possibile, la politica del diritto penale è l’arte del diritto penale possibile”1.
Rifacendoci a tale assunto, riconosciamo
come una prospettiva, che non inquadra l’indagine sulla politica penale sul mero dato
normativo2, permette di rendere permeabili
i confini posti dal tecnicismo giuridico3, non
già per discuterne i postulati, riproponen1 Così in S. Vinciguerra, Principi di criminologia, Padova,
2004, p. 129. L’accostamento fra arte e mondo del diritto non è ovviamente esclusiva del curatore della prestigiosa collana “Casi, fonti e studi per il diritto penale” se
già Francesco Carnelutti ebbe modo di redigere per il
Nuovissimo Digesto la voce Arte del diritto. Come sottolinea
l’Autore dei Principi, il termine arte non va intesto quale
sinonimo di fantasia; va in ogni caso accennato che, sia
pur all’interno di una “attività di ricerca e di proposta
condotta secondo canoni di razionalità”, richiamarlo
di per sé implica l’evocare una tradizione di esperienza
giuridica più legata a forme di dialettica aristotelica che
a rigidi schemi deduttivi e, quindi, il palesare la politica del diritto penale non tanto come attività di ricerca
pedissequamente legata ad un certo modo di intendere
il dato normativo riconducibile alla premessa maggiore
di un ragionamento deduttivo, quanto quale momento di indagine, la quale, pur non prescindendo dal dato
normativo, si rapporta a questo in modo problematico.
2 Con autorevolezza viene rammentato che “nel campo
del diritto penale vero e proprio la politica criminale investe tre settori fondamentali: quello della individuazione dei fatti meritevoli di punizione, quello dei principi
generali della responsabilità penale, quello delle funzioni e delle finalità delle pene”, G. Vassalli, Politica criminale e sistema penale, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato
di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense,
Milano, 1987, p. 1013.
3 Cfr. in proposito ancora S. Vinciguerra, Principi di criminologia, cit., p. 120 e segg.
126
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
do un dibattito relativo al diritto sostanziale,
quanto per affrontare in modo non formalistico i problemi giuridici relativi ad una realtà
sociale in e di integrazione.
Il richiamo all’arte del possibile apre, quindi, proprio nell’ambito specifico dell’esperienza penalistica, opportunità per una ricerca giuridica che rifletta problematicamente
sulle conseguenze dell’incontro fra le regole
dell’ordinamento giuridico e la regolarità dei
comportamenti dei consociati all’interno di
un contesto sociale che sempre più si qualifica (in negazione) attraverso la perdita di una
precisa identità culturale. La politica penale,
intesa come ricerca del diritto penale possibile, non può non tenere conto di questo fatto;
il racchiudersi in una sorta di autoreferenzialità normativa, la quale ritenga estranea dal
proprio campo di ricerca una riflessione sul
dispiegarsi concreto dell’esperienza giuridica
e, quindi, neghi quale premessa metodologica
un’indagine sull’ambito sociale in cui la norma
si colloca4, renderebbe la politica penale ed il
diritto penale da questa derivato, del tutto inadeguati a rispondere sia alle finalità che l’ordinamento stesso istituzionalmente pone, che
ai bisogni di ordine promananti dalla società.
Gli stessi dati che rappresentano la realtà quotidiana dell’esecuzione penale in Italia
sono di per sé esemplificativi di tale esigenza.
issn 2035-584x
Due appaiono le questioni alle quali qui far
brevemente cenno al fine di prendere le mosse.
La prima, di carattere più generale, è inerente
alla valutazione giuridica di un fatto, ovvero
alla sua qualificazione come reato. La seconda,
conseguente alla prima, è relativa alla pena da
erogare e, ancor più specificatamente, all’esecuzione della pena stessa.
A ben vedere non si tratta di problemi fra
loro separabili se l’esecuzione della pena è
il punto finale di un percorso che riconosce
il proprio avvio in un fatto posto in essere
dall’agente. Non appare perciò né concretamente possibile, né concettualmente corretto
non riconoscere una unitarietà nell’esperienza penalistica anche se la riflessione sulla stessa si tripartisce tradizionalmente negli ambiti
del diritto penale sostanziale, del diritto penale procedurale, del diritto dell’esecuzione penale. Il momento che unifica tale esperienza è
offerto, come emergerà nello sviluppo del contributo, dalla riflessione sull’antigiuridicità;
questa costituisce il cardine su cui ruota ogni
elemento della tripartizione ed è quindi il fulcro su cui si dispiega l’intera politica penale.
Le due questioni, nonché la riflessione a
queste connessa, vanno collocate, meglio, vanno indagate avuto riguardo ad un contesto di
diversità di cultura giuridica5. Un discorso di
politica penale che non tenga conto di una esperienza culturale sempre più policromatica, che
si riversa specularmente nel microcosmo della
cultura giuridica, corre un duplice rischio. Per
un verso, di non cogliere la realtà, per lo meno
nel senso di ritenere che la diversità culturale
non possa costituire né oggetto proprio al discorso giuridico intorno al reato ed alla pena,
né influire indirettamente sullo stesso. Per altro, cosa ancor più problematica, non riconoscere come la stessa esperienza giuridica, che
non può che prendere le mosse dal dato normativo, è di per se stessa portatrice di indagine sulle motivazioni culturali che indirizzano
il soggetto a compiere una data azione. Ciò a
maggior ragione nell’ambito di una riflessione
4 Ciò che qui si critica è il rappresentasi della politica
penale sotto forma di una branca della scienza giuridica
kelsenianamente intesa; per l’autore qui richiamato, “la
dottrina pura del diritto, come specifica scienza giuridica, rivolge la sua attenzione a norme giuridiche […] non a
fatti concreti, cioè a quello che le norme vogliono o si rappresentano, bensì a norme giuridiche intese come contenuti ideali voluti o rappresentati”, così ne La dottrina
pura del diritto, trad. it. Torino, 1960, p. 124. Per una più generale critica della prospettiva kelseniana cfr. F. Gentile,
Intelligenza politica e ragion di stato, Milano, 1983.
5 In proposito richiamiamo la oramai classica distinzione proposta da L. M. Friedman nel suo Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, trad. it. Bologna,
1978. Per l’Autore “possiamo distinguere, con riferimento alla cultura, la cultura giuridica esterna dalla
cultura giuridica interna. La cultura giuridica esterna
è la cultura propria di tutta la popolazione e comune a
tutta la popolazione; la cultura giuridica interna è la cultura giuridica propria di quei membri della società che
compiono attività giuridiche specializzate”, così a p. 371
della trad. it. citata. Sull’argomento cfr. anche O. Höffe,
Globalizzazione e diritto penale, trad. it. Torino, 2001.
2. Valori culturali e politica penale
Digressioni sull’esecuzione della pena
127
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
sulla politica penale che, come richiamato dal
pensiero di Vassalli, non può prescindere dalla
individuazione dei fatti meritevoli di punizione; questo giudizio è strettamente correlato,
come tutta una tradizione di studi penalistici
ha posto in evidenza6, sia alle motivazioni (culturali) del soggetto, che al più generale contesto
sociale e culturale in qui queste di collocano7.
All’intero di questo contesto, il rapporto fra
la qualificazione del fatto8, l’erogazione della
pena e l’esecuzione della stessa non può costituirsi sulla falsariga del ragionamento ipotetico-deduttivo. Una riflessione che investa i tre
settori intorno ai quali si dispiega l’esperienza
penalistica partendo proprio dagli elementi
costituivi del reato, come il magistero di Bettiol ha evidenziato, pone in essere una critica
della prospettiva sillogistica e, nel contempo,
si affaccia ad una prospettiva interculturale9.
Ciò risulta palese proprio avuto riguardo al
ripensamento del portato del principio di inescusabilità dei precetti della legge penale, che
prende l’avvio con la nota sentenza della Corte
Costituzionale sull’articolo 5 del Codice Penale.
La sentenza n. 364 del marzo del 1988 permette di aprire all’interno dei confini dell’ordinamento giuridico una controversia sul disvalore
6 Basti in proposito richiamare il pensiero di Giuseppe
Bettiol; per un primo approccio al pensiero del penalista
patavino cfr. Scritti giuridici, Padova, 1966 e Diritto penale,
Padova, 1979. Su Bettiol cfr. per tutti G. Marini, Giuseppe
Bettiol. Diritto penale come filosofia, Napoli, 1985.
7 Si veda ad esempio la questione dell’abrogazione per
desuetudine di disposizioni penali quali l’omicidio e le
lesioni personale a causa d’onore, previste nell’articolo
587 che non vedeva applicazione in molte parti del territorio nazionale ben prima della sua formale abrogazione avvenuta con legge n. 442 del 5 agosto 1981.
8 Più precisamente, tra fatto materiale qualificabile
come reato attraverso la sussunzione della fattispecie
concreta nella fattispecie astratta ed il giudizio sullo
stesso che lo qualifica effettivamente come reato.
9 La prospettiva interculturale, come da più parti rilevato, non appare riconducibile ad una tendenza giustificazionista, al contrario, si costituisce sulla necessità
del giudizio sulla relazione intersoggettiva. In tale prospettiva è intrinseca la valutazione del comportamento
rispetto a parametri di bilateralità dello stesso. Questa
si innesta a pieno titolo all’interno di una riflessione
sull’esperienza giuridica impregnata sul valore, come
evidenzia il magistero di Enrico Opocher; si vedano in
proposito le Lezioni di filosofia del diritto, Padova, 1983.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
che l’azione può assumere rispetto alla cultura giuridica dell’agente. Va solo rammentato
come sia la valutazione del disvalore di una
azione che informa, per un verso, la condotta
dell’agente e, per altro, il giudizio dell’autorità
competente nel qualificare il fatto e nell’erogare la pena, ma anche, e soprattutto in questo
contesto, il percorso di rieducazione che l’esecuzione della pena necessariamente implica.
La sentenza della Corte Costituzionale riconosce la necessità di ponderare elementi
non formalmente definiti all’intero dell’opera di valutazione di un fatto; la natura di questi elementi è tale da non consentire la rappresentazione del processo di valutazione per
mezzo della sussunzione.
Quindi, a fronte del fatto materiale e della qualificazione dello stesso come reato,
primeggia la valutazione della buona fede
dell’agente, dell’antigiuridicità di cui esso si
fa portatore; la valutazione dell’antigiuridicità si ripresenta nel momento dell’erogazione
della pena, nonché durante l’esecuzione della
pena, che si caratterizza con un percorso rieducativo, il quale per essere efficace non può
prescindere dalla base culturale di ognuno,
ovvero dal suo essere persona umana; ciò al
fine di rendere effettiva l’equità e l’eguaglianza di trattamento fra detenuti.
In definitiva si tratta pur sempre di riportare nell’ambito di un discorso di politica penale
non più racchiuso entro gli impermeabili confini di una statualità, che sottenda all’omogeneità ma che è invece sempre più intrisa di valori culturali diversi, il problema della vigenza
di beni costituzionalmente protetti, beni che
ritrovano altresì tutela all’interno dell’ordinamento internazionale, a cui la stessa carta costituzionale non soltanto non può sottrarsi,
ma al quale appare sempre più soggetta10.
3. Parità versus omologazione
Fra i molti, sono due i problemi che merita qui brevemente accennare; sono problemi
relativi, per riprendere una espressione forse
10 Si veda, in merito alla gerarchia delle fonti, il problema del rapporto fra ordinamento interno e quello
Unione europea.
128
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
abusata, ma che ben evidenzia la natura debole
dei soggetti a cui si rivolge, alle pari opportunità
nelle modalità di esecuzione della pena fra detenuti italiani e stranieri11.
Il primo è inerente alla figura ed al ruolo
del mediatore culturale, ex articolo 35 del DPR
n. 230 del 30 giugno 2000 (Regolamento recante
norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà); il secondo si riconnette alla vexata questio relativa all’articolo 15
della legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo).
I due problemi vanno indagati in un’ottica
che ritrovi il proprio fuoco in una parità di trattamento fra i soggetti sottoposti all’esecuzione della pena, un’eguaglianza che abbia come
punto di riferimento la funzione rieducativa
della pena così come tratteggiata nell’articolo
27, comma terzo, del Dettato costituzionale12;
ovvero una parità di trattamento che non deve
tradursi, proprio per far emergere la finalità
sancita dal legislatore costituzionale, in omologazione del trattamento soprattutto a fronte di
detenuti portatori di cultura diversa da quella in
11 Risulterebbe forse più appropriato il richiamo alla cultura di origine più che alla cittadinanza del detenuto, sia
questo italiano o straniero. In proposito va rilevato che
l’ordinamento riconosce come straniero, in linea generale, il cittadino di uno stato diverso da quello italiano
e l’apolide (vedi ad esempio l’art. 10 della Costituzione
e l’art. 143 CPP), in senso più ristretto (ex art. 1 del Testo
Unico n. 286/1998 - norme sull’immigrazione) i cittadini
di stati non membri dell’Unione europea e gli apolidi.
12 Tale funzione viene più volte rimarcata alla Corte
Costituzionale e rappresenta il fulcro introno a cui si dispiega la sentenza n. 364 del marzo 1988, ma è implicita
allo stesso articolo 3, comma secondo del Dettato, nel
momento i cui pone come compito qualificante della
Repubblica la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana. Fra questi
indubbiamente trovano collocazione quelle deficienze,
la cui origine può individuarsi anche in fattori economico-sociali oppure psicologico-culturale, che inducono al
crimine. In proposito giova rimarcare come, ai sensi
della sentenza della Corte Costituzionale n. 163, del giugno del 1983, per un verso “l’articolo 3 della Costituzione
attribuisce a ogni cittadino il diritto fondamentale di
realizzare lo sviluppo della propria personalità” ma, per
altro, “contribuire a che la vita di ogni persona rifletta
ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale
della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può
abdicare in nessun caso”, così la sentenza della stessa
Consulta n. 217 del febbraio 1988.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
cui si radica l’ordinamento giuridico italiano.
Che l’esecuzione della pena sia improntata
su una parità di trattamento e su una individuazione di un percorso personale di rieducazione del reo appare in maniera inequivocabile già all’articolo 1, comma sesto, della legge n.
354 del 26 luglio 1975 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Detto comma
recita: “nei confronti dei condannati e degli
internati deve essere attuato un trattamento
rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento
sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individuazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.
A ciò fanno eco il comma primo e secondo
dell’articolo 1 del DPR n. 230 del 2000: “il trattamento degli imputati sottoposti a misura
privative della libertà consiste nell’offerta di
interventi diretti a sostenere i loro interessi
umani, culturali e professionali. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati
è diretto, inoltre, a promuovere un processo
di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni
familiari e sociali che sono di ostacolo a una
costruttiva partecipazione sociale”.
Ai sensi dell’articolo 3, comma secondo del
predetto DPR: “il direttore dell’istituto e quello
del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle
attività dell’istituto e del servizio; decidono le
iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento
dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all’esterno; impartiscono direttive agli
operatori penitenziari anche non appartenenti all’amministrazione, i quali svolgono i compiti loro affidati con l’autonomia professionale
di competenza”. La sinergia fra direzione degli
istituti e centri di servizio sociale per adulti
ritrova la propria ratio nel disposto dell’articolo 72 della legge n. 354 del 1975; ai sensi del
comma quinto, “i centri prestano […] opera di
consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario”.
Il trattamento, è bene ribadirlo, “deve rispondere ai particolari bisogni della persona129
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
lità di ciascun soggetto”, così al comma primo
dell’articolo 13 della L. 357/1975; il comma secondo tratteggia le funzioni della “osservazione scientifica della personalità”, le cui finalità
sono rimarcate al comma terzo: “per ciascun
condannato e internato, in base ai risultati
dell’osservazione, sono formulate indicazioni
di merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che
è integrato o modificato secondo le esigenze
che si prospettano nel corso dell’esecuzione”.
Ciò ritrova puntuale riconferma nel DPR 230
del 2000 agli articoli 27 (Osservazione della personalità), 28 (Espletamento dell’osservazione della
personalità) e 29 (Programma individualizzato di
trattamento), su questi ritorneremo in seguito.
Giova per il momento soltanto rammentare
che, ai sensi dell’articolo 1, comma primo, della
legge n. 357 del 1975, “il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi
principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e
sportive e agevolando opportuni contatti con il
mondo esterno ed i rapporti con la famiglia”.
La politica penale, come prassi dispiegata dalle pubbliche autorità, deve assolvere ai
compiti assegnati dall’ordinamento giuridico, in primis dai valori recepiti nel (ed istituiti
dal) dettato costituzionale. Alla politica penale spetta altresì il compito, spesso arduo, di
ricercare un equilibrio oggettivo, ma sempre
instabile, fra esigenze soggettivamente opposte: dignità della persona umana e rigore nella
esecuzione della pena; esigenze di ordine sociale e ripristino dello stesso per mezzo della
punizione, che potrebbero far emergere delle
tendenze prevenzionistiche, e tutela del diritti umani e rieducazione del reo13. Il tutto il più
delle volte dovendo confliggere con il demos di
aristotelica memoria.
In questa suo operare, la pubblica autorità,
referente unico per l’esecuzione delle misure
di diritto penale previste dalla legge, può avvalersi di figure esterne alla pubblica amministrazione in senso stretto, ad esempio consulenti, ex articolo 80 della legge 354 del 1975, e
volontari, ex articolo 78 della predetta legge.
13 Cfr. per tutti il già richiamato testo di Sergio
Vinciguerra.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
Attraverso un itinerario di ricerca, di esperienza, finalizzato ad individuare dialetticamente il giusto mezzo fra l’eccesso ed il difetto,
la politica penale incontra difficoltà culturali e
sostanziali, che, con arte, tende ad attraversare.
All’intero di questo contesto, brevemente sunteggiato, volto a rendere effettivo ed
efficace il valore costituzionale tratteggiato
nel Dettato all’articolo 27, si colloca la figura
dell’operatore di mediatore culturale, introdotto nell’ordinamento giuridico con l’articolo
35 del DPR 230 del 200014.
4. La centralità della mediazione culturale nel processo rieducativo
All’interno di una riflessione che tende ad
inquadrare la politica penale in una cornice
interculturale, va rilevata la centralità della
figura dell’operatore di mediazione culturale, prevista, come noto, all’articolo 35 del DPR
230 del 2000. Il Regolamento, nel ribadire, più
che l’eguaglianza di trattamento, il principio
di pari opportunità di rieducazione offerto
dalle istituzioni a tutti i detenuti, stabilisce, al
comma primo del citato articolo: “nell’esecuzione delle misure privative della libertà nei
confronti di cittadini stranieri, si deve tenere
conto delle loro difficoltà linguistiche e delle
differenze culturali”. Non solo, quindi, traduzione in una lingua comprensibile al detenuto, auspicabilmente la sua lingua madre, da
cui la figura dell’interprete, ma soprattutto un
intervento che, al di là delle difficoltà linguistiche, avvenga, avuto riguardo alle differenze
14 Va solo accennato che il mediatore culturale qui richiamato non può appiattirsi sulla figura dell’interprete,
così come questa viene prevista nel codice di procedura
penale, ex art. 143 e, in primis, dall’art. 111, comma terzo,
della Costituzione. Infatti, la prima è propria alla fase di
esecuzione della pena, la seconda, invece, alla fase di accertamento. Un accostamento ma non certamente una
confusione fra le due figure potrebbe tutt’al più rilevarsi avuto riguardo “all’obbligo del direttore dell’istituto
penitenziario di accertare, se del caso con l’ausilio di un
interprete, che l’interessato abbia precisa conoscenza
del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti”, Cass. I, n. 3759,
23 maggio 2000. Sull’argomento cfr. A. Caputo, Il diritto
all’assistenza linguistica dell’imputato straniero, in “Diritto,
immigrazione e cittadinanza”, 2002, n. 2, pp. 47 e segg.
130
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
culturali. Ai sensi del comma secondo del predetto articolo il Regolamento ritiene che “deve
essere, inoltre, favorito l’intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso
convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato”.
Come già sottolineato, l’esecuzione, al fine di
non caratterizzarsi quale momento meramente afflittivo, si riconnette ad un programma di
trattamento rieducativo, di cui agli articoli 1 e 13
della legge 354 del 1975, un programma rieducativo che, per “rispondere ai particolari bisogni
della personalità di ciascun soggetto” (così al già
richiamato comma primo dell’articolo 13 della L.
354/1975), viene redatto da un gruppo di osservazione e trattamento, il quale dà vita, per l’appunto, ad un programma individualizzato.
Giova richiamare la specifica norma dal DPR
230 del 2000; all’articolo 29, comma secondo,
si stabilisce: “la compilazione del programma
è effettuata da un gruppo di osservazione e
trattamento presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli esperti
che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell’articolo 28”.
La questione, rispetto a condannati o internati stranieri, è relativa alla partecipazione al
gruppo di lavoro dell’operatore di mediazione
culturale; ovvero, nel caso di detenuti stranieri,
l’operatore, di cui all’articolo 35 del DPR, partecipa costitutivamente al gruppo di osservazione e
trattamento presieduto dal direttore dell’istituto, oppure la sua presenza è opzionale?
Va rilevato in proposito che l’osservazione,
ai sensi del comma primo dell’articolo 27 del
DPR 230 del 2000 ha come oggetto anche “una
riflessione sulle condotte antigiuridiche poste
in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione
delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”.
Si potrebbe, quindi, presumere che “l’osservazione scientifica della personalità [,la quale]
è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze
fisico-psichiche, affettive, educative e sociali,
che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione”, ancora il
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
comma primo del richiamato articolo 27, non
possa prescindere da una indagine che ponga
nella giusta evidenza la cultura giuridica del
soggetto, più precisamente la cultura giuridica esterna che permea il soggetto e che determina, all’interno di un dato contesto culturale,
una idea di antigiuridicità sì imprecisa o vaga
e non sempre corrispondente all’ordinamento
giuridico, ma certamente radicata in un sistema di valori propri al contesto sociale, quindi
culturale, dal quale il soggetto proviene.
Al fine di esperire i bisogni di ciascun soggetto e, quindi, di dare vigenza alle finalità rieducative della pena in un contesto così tratteggiato, appare, dunque, centrale la figura del
mediatore culturale, figura sì nominata dalla
normativa vigente ma non per questo esplicitamente collocata all’intero del programma di
trattamento, né, più in generale, nel processo
rieducativo. Infatti, l’articolo 35 del DPR indica
soltanto che, nel caso di cittadini stranieri, deve
essere favorito l’intervento del mediatore culturale, non che tale intervento debba costituire
parte integrante del processo di individuazione del percorso rieducativo del cittadino straniero. Qui pare che la possibilità di operare di
tale figura sia lasciata alla discrezionalità delle
autorità penitenziarie, prime fra tutte il direttore dell’istituto.
Fermo restando, per un verso, che l’operatore di mediazione culturale, in quanto tale,
difficilmente può appartenere all’Amministrazione penitenziaria, mancando chiarezza
normativa su tale figura (in merito richiamiamo il comma 3 dell’articolo 28 del DPR
354/2000, per il quale “l’osservazione [di cui
al precedente articolo 27] è condotta da personale dipendente dall’Amministrazione”),
per altro, non è nemmeno espressamente richiamato, né poteva essere altrimenti, fra i
“professionisti indicati nel secondo e quarto
comma dell’articolo 80 della legge” 354/1975,
dei quali, “secondo le occorrenze”, l’Amministrazione, sempre ai sensi dell’articolo 28 del
DPR, può avvalersi al fine di espletare l’osservazione scientifica.
Infatti, ai sensi della legge istitutiva l’Ordinamento penitenziario, articolo 80, comma
quarto, “per lo svolgimento delle attività di
131
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale,
pedagogia e criminologia clinica”; il mediatore
culturale, in senso lato, potrebbe essere un professionista esperto in una delle quattro materie indicate dal legislatore. Pare, altresì, forzato
equiparare il mediatore culturale all’educatore,
di cui all’articolo 82 della L. 354/1975.
Riprendendo la lettera della legge, il mediatore culturale potrebbe rientrare genericamente fra il “personale incaricato giornaliero”,
cui fa menzione il comma secondo dell’articolo 80 della richiamata legge, dimenticando,
però, che questo va letto in combinato disposto con il comma quarto, di cui sopra; in ogni
caso l’utilizzo di personale esterno è limitato
dalla disponibilità di risorse finanziarie.
Il mediatore culturale può rientrare a pieno
titolo fra gli assistenti volontari, di cui all’articolo 78 della legge del 1957 ripreso dall’articolo 120 del DPR del 2000. La qual cosa è lasciata
più che supporre dallo stesso comma secondo
dell’articolo 35 del DPR; l’intervento è, infatti,
favorito “anche attraverso convenzioni con gli
enti locali o con organizzazioni di volontariato”, quelle stesse organizzazioni di volontariato che, ai sensi del comma primo dell’articolo
120 del DPR, “assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri
di servizio sociale, continuità di presenza in
determinati settori di attività”.
Qualora l’operatore di mediazione culturale rientri nella fattispecie prevista dall’articolo
78 della legge 354 del 1975 e richiamata nell’articolo 120 del DPR 230 del 2000 non potrebbe
partecipare direttamente alla compilazione
del programma individualizzato di trattamento ex articolo 29 del DPR, in quanto non assimilabile al personale incaricato ex articolo 80
della legge del 1975. Rammentiamo, infatti,
che, ai sensi del comma secondo dell’articolo
29, la compilazione del programma è effettuata dal gruppo di osservazione presieduto dal
direttore dell’istituto e composto dal personale dell’amministrazione nonché dagli esperti
che hanno svolto l’osservazione; gli esperti
sono inequivocabilmente, ai sensi del comma
terzo dell’articolo 28 del DPR, i professionisti
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
richiamati all’articolo 80 della legge del 1975.
In definitiva, l’assenza di questa figura nei
lavori del gruppo di osservazione, o, meglio, il
suo non esserne parte costitutiva (la sua presenza e, infatti, frutto di un’opzione effettuata
dai vertici dell’amministrazione) depotenzia
non poco la funzione rieducativa della pena
erogata ad uno straniero. Manca, infatti, la mediazione fra la cultura giuridica del reo e la cultura giuridica del paese ove la pena ha trovato
erogazione ed esecuzione.
5. Esecuzione della pena ed espulsione
In materia di esecuzione penale, che veda
soggetti cittadini di paesi non aderenti all’Unione Europea, attenzione merita la disposizione
dell’articolo 15 della L. 189 del 30 luglio 2002
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo). Detto articolo, rubricato con Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione, regolamenta, come noto, l’espulsione del cittadino straniero, ovvero extracomunitario, che, versando nelle condizioni previste dall’articolo 13, comma secondo del Testo
Unico del 1998, sia un cosiddetto clandestino. Ai
sensi del comma primo “il giudice nel pronunciare sentenza di condanna […] può sostituire la
medesima pena con la misura dell’espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni”,
sempre che la pena detentiva non sia superiore
a due anni. L’espulsione è “eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile”.
Parimenti, ai sensi del comma quinto, sesto e settimo, del sopra richiamato articolo, il
magistrato di sorveglianza, con decreto motivato, può disporre l’espulsione dello straniero,
identificato, detenuto e clandestino “che deve
scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni”. Il detenuto “può
proporre entro dieci giorni opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza”.
Dal che si evince: il giudice di merito, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa
vigente ha facoltà di sostituire la pena (“quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni”) con la misura
dell’espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni; il magistrato di sorveglianza
132
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
può disporre l’espulsione, ovvero commutare la
pena detentiva con la misura dell’espulsione.
In quest’ultimo caso, ai sensi del comma ottavo, “la pena è estinta alla scadenza del termine
di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione
[…] sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l’esecuzione della pena”.
Va, per inciso, constatato come il legislatore nell’utilizzare, al comma quinto della predetta legge, il sostantivo detenuto senza altra
specificazione lasci intendere che il decreto
di espulsione del magistrato di sorveglianza
possa riguardare sia uno straniero sottoposto
ad esecuzione intramuraria, ossia detenuto in
carcere, che uno straniero detenuto il luogo
diverso dal carcere, un esempio, per quanto
remoto, potrebbe riguardare la detenzione domiciliare; il decreto potrebbe trovare soggetto
anche in uno straniero in esecuzione di pena
detentiva in forma alternativa o sostitutiva al
carcere, fra le misure alternative vanno richiamate l’affidamento in prova e la semi-libertà.
Tutto ciò a significare che se la ratio di tale
disposizione fosse meramente operativa, ovvero fosse da riconnettersi ad una necessità di
sfollamento delle carceri, la stessa si applicherebbe soltanto ai cittadini stranieri extracomunitari clandestini ristretti nelle carceri stesse.
È ben vero che proprio nei confronti dei detenuti stranieri, che versano nelle condizioni
previste dalla normativa qui richiamata, si riscontrano le maggiori difficoltà oggettive per
la concessione delle misure alternative (mancanza di tessuto socio-famigliare, mancanza di
lavoro, assenza di domicilio e via discorrendo),
per cui il loro numero appare talmente esiguo
da non necessitare uno specifico richiamo nella disposizione. In tal modo però anche questi
ricadono, cosa del resto puntualmente verificatasi15, sotto la previsione del comma quinto
15 Esemplificativa della questione risulta il dubbio di
legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, il 18 dicembre 2003, in merito al
richiamato articolo. Il Tribunale osserva in fatto che il
soggetto del provvedimento di espulsione “si trovava in
detenzione domiciliare presso la madre”; non solo, il detenuto in questione ha abbandonato con tutta la famiglia il paese d’origine all’età di cinque anni, non ne parla
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
che non lascia al magistrato di sorveglianza
poteri discrezionali (“nei confronti dello straniero […] è disposta l’espulsione”). La disposizione ritrova dunque vigenza nei confronti
dell’intera classe dei detenuti stranieri richiamati all’articolo 1516.
la lingua, non possiede in questo alcun legame parentale né, tanto meno, sociale. Per il Tribunale di sorveglianza sassarese “il forzato rientro del detenuto nel paese di
origine lo costringerebbe ad una vita di emarginazione,
povertà, incomprensione dei valori e della cultura locale e difficoltà nei rapporti sociali”, ponendo il soggetto
in una situazione analoga a quella prevista dall’articolo
19 del Testo Unico, che “ha voluto evitare una siffatta
situazione ed altre anche più gravi se causata da persecuzione. Sarebbe del tutto irragionevole un sistema giuridico che, invece, consentisse la medesima situazione
non determinata da persecuzione ma da altra causa. Il
collegio reputa che nel caso in esame si realizza tale irragionevolezza della norma richiamata e, nel contempo,
una violazione del principio di eguaglianza, perché il
Legislatore non contempla tra i divieti di espulsione e
di respingimento il caso di stranieri che, pur non in regola con le norme di soggiorno, abbiano tutti i famigliari regolarmente soggiornati in Italia e non abbiano più
alcun legame famigliare, sociale, linguistico e culturale
con il loro paese d’origine”.
Va in proposito rilevato che il Collegio pur non ritenendo manifestatamente infondato il dubbio di legittimità
costituzionale della norma in oggetto non richiama le
finalità rieducative della pena irrogata al detenuto al
fine di argomentarne l’incostituzionalità. L’esecuzione
della stessa avviene nella forma della detenzione domiciliare, ex articolo 47 ter della legge 354 del 1975, presso
un famigliare. Giova rilevare che la Corte Costituzionale
ha stabilito che la detenzione domiciliare “è volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti famigliari ed intersoggettivi, senza incidere negativamente sulle eventuali opportunità di lavoro”, così
nella sentenza n. 422 del 27 ottobre 1999. Tale forma di
misura alternative si inserisce perfettamente all’interno di una più complessa opera di rieducazione del reo.
Venendo meno la stessa a fronte dell’espulsione del detenuto tale opera si interrompe con come conseguenza
la lesione di un diritto fondamentale del detenuto. Nel
caso in specie, il tribunale di sorveglianza di Sassari ritiene più appropriato richiamare gli articoli 29 e 30 della Costituzione (unità famigliare).
Post scriptum: la Corte costituzionale, con ordinanza n.
260 del 20 giugno 2005, ritenendo, fra l’altro, che “la
questione postula una pronuncia additiva concernente
situazioni indeterminate e comportante quindi l’esercizio di valutazioni discrezionali estranee alle funzioni
di questa Corte”, dichiara la manifesta inammissibilità
della questione stessa.
16 Diversa è l’interpretazione del tribunale di sorve-
133
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Al di là delle considerazioni di cui sopra,
non pare potersi prendere in considerazione l’ipotesi che il legislatore attraverso questa disposizione voglia abdicare tout cour alla
pubblica autorità all’esecuzione penale17; che
l’espulsione sia una della modalità di esecuzione della pena lo si evince chiaramente dalle disposizioni contente al comma quarto: infatti,
nel caso di espulsione erogata dal giudice “se
lo straniero espulso […] rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine
previsto […] la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente”; al comma ottavo:
nel caso di espulsione disposta dal magistrato
di sorveglianza “la pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espulsione”, se lo straniero espulso dal
decreto del magistrato di sorveglianza rientra
illegalmente nel territorio dello Stato “lo stato
di detenzione è ripristinato”.
Va notato che il periodo contenuto nel
comma ottavo viene concluso dal legislatore
con l’espressione “riprende l’esecuzione della
pena” (“lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l’esecuzione della pena”); dal che si
può intendere che l’espulsione possa trattarsi
di una forma di sospensione della esecuzione della pena che rimane pur sempre detentiva. Ciò però appare in contrasto con quanto
lo stesso legislatore dispone in altra parte del
comma ottavo in merito dell’estinzione della
pena alla scadenza del termine, estinzione che
glianza di Sassari, che con ordinanza del 27 marzo 2003
rileva come “l’ammissione del condannato alla detenzione domiciliare faccia venire meno uno dei presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione dell’espulsione” in quanto “la sanzione alternativa di cui all’art. 16
è prevista solo per i detenuti e in mancanza di espressa
previsione legislativa non appare corretto estendere la
norma anche ai detenuti domiciliari”. Se ciò avvenisse
“la sanzione finirebbe, infatti, per colpire soggetti la cui
assenza di pericolosità così come la possibilità di un loro
effettivo e idoneo inserimento nel territorio nazionale
dello Stato, sono state già positivamente valutate in sede
di concessione della detenzione domiciliare e avrebbe
l’effetto di porre nel nulla la funzione rieducatrice svolta
dalla pena durante la carcerazione, fino ad ora sofferta”.
17 Se ciò fosse, bisognerebbe in qualche modo riconnettere tale istituto a una interpretazione fin troppo estensiva ed elastica della liberazione anticipata, ex articolo
54 della legge n. 354 del 1975, quale strumento principe
di svuotamento di istituti fin troppo sovraffollati.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
avviene automaticamente senza necessitare di
altra formalità che il trascorrere del tempo.
Nel quadro tratteggiato dall’articolo 16 del
D. leg n. 286 del 25 luglio 1998 così come modificato dall’articolo 15 della legge n. 189 del
2002, l’ipotesi relativa ad una espulsione come
sospensione della pena è quindi da scartarsi;
l’espulsione sostituisce non sospende la pena.
Qualora, infatti, non ci sia rientro clandestino
dello straniero soggetto del provvedimento,
l’espulsione produce di per sé l’effetto di estinguere la pena; questa, nella forma di detenzione, viene ripristinata come momento afflittivo (la privazione di un bene quale la libertà).
Ma la stessa sostituzione della pena detentiva
con l’espulsione viene meno con il rientro del
reo nel territorio nazionale e appare del tutto
naturale che, per così dire, rifiutando egli nei
fatti l’esecuzione della pena attraverso l’espulsione venga sottoposto alla detenzione.
Dal che si evince come sia la sentenza che
sostituisce la pena detentiva con la misura
dell’espulsione, che il decreto che tramuta la
detenzione residuale in espulsione, si mantengano all’intero dei confini dell’esecuzione
della pena. L’espulsione è un provvedimento
di esecuzione della pena; è, a tutti gli effetti,
una misura alternativa alla detenzione.
Ciò premesso vanno effettuate alcune considerazioni d’ordine generale.
6. Il diritto-dovere alla rieducazione
All’interno di un discorso che mira ad indagare la salvaguardia della dignità umana anche, e
soprattutto, nel momento dell’esecuzione penale
va posta una distinzione preliminare che possa
apportare chiarezza nell’affrontare l’argomento.
Infatti, ad un ambito può essere ascritta la
questione relativa alla salvaguardia dei diritti
individuali del condannato. Questi ritrovano
indubbiamente il loro fondamento nella Carta costituzionale e la loro attuazione nell’Ordinamento e nel Regolamento penitenziario e
rappresentano, per un verso, le normali regole
di trattamento (rapporti con l’esterno, attività
ricreativo-culturali, sanità, pratiche religiose e
così via per finire ai regimi di sorveglianza) e,
per altro, ineriscono alla possibilità di usufrui134
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
re di regimi alternativi alla detenzione. Queste
statuizioni si riconducono al principio secondo il quale “le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità”, così
come stabilito dalla prima parte del comma
terzo dell’articolo 27 del dettato. Quindi, l’esecuzione della pena, al fine di potersi collocare
nei confini tracciati dall’ordinamento giuridico, non può discostarsi dal senso di umanità. Vengono posti dei limiti superati i quali la
pena perde la propria giuridicità.
Altro, invece, è l’ambito dove va ricondotto
il diritto-dovere del condannato alla rieducazione, che avviene per mezzo dell’esecuzione
della pena, come evidenziato dalla seconda
parte del comma terzo del richiamato articolo.
La violazione dei diritti riconducibili al primo ambito comporta l’infrangersi di un insieme di tutele pur sempre ricollegabili ai diritti
individuali e sociali, che, pur compatibilmente
con regime di restrizione della libertà, non si
annullano, ma vedono sempre il condannato
ed il detenuto come soggetto.
Le violazioni dei diritti appartenenti a questo gruppo ritrovano strumenti di riequilibrio
sia nel diritto interno, che nel diritto internazionale e, più specificatamente in quello comunitario. In questo contesto si colloca la tutela
della diversità culturale, tutela che, come chiaramente si evince dalla lettera del Regolamento
del 2000, oltrepassa i muri del carcere.
In altro contesto si colloca però il dirittodovere alla rieducazione. Infatti, il non porre
in essere, da parte della pubblica autorità, un
processo rieducativo non cozza direttamente
contro quei diritti individuali e sociale del detenuto sopra richiamati.
Le finalità rieducative della pena, al di là
della loro statuizione all’articolo 27, ritrovano sia la fonte, che il raccordo con l’intero ordinamento, nell’articolo 3 della Costituzione.
Attraverso questo ancoraggio è possibile individuare sia un diritto del condannato alla
rieducazione, che un obbligo alla rieducazione
che vede il destinatario nella pubblica autorità
Nel momento in cui viene erogata una
pena a fronte della commissione di un fatto
antigiuridico, si costituisce il diritto-dovere
alla rieducazione, che vede, per l’appunto,
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
due destinatari: l’ente pubblico ed il reo.
Se il venire meno del dovere da parte del
condannato è, in qualche modo ricompreso e
ricompensato nella e dalla pena detentiva, la
privazione della libertà che assume, infatti,
anche connotati afflittivi e non solo rieducativi, il venir meno del suo diritto, ovvero il non
adempimento da parte dell’autorità pubblica al
compito (al dovere) rieducativo ad essa ascritto
dall’ordinamento stesso, ha due conseguenze.
Per un verso, provoca un danno al condannato in quanto persona umana parte di un
consesso societario; l’inattività della pubblica
autorità non lo pone nelle condizione di superare le soggettive situazioni di antigiuridicità
che lo hanno determinato alla commissione
del reato (si vedano, a titolo esemplificativo,
gli articoli 13 e 15 dell’Ordinamento penitenziario). Venendo meno alla funzione di rimozione
degli ostacoli, che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana, fra i quali va annoverata la propensione all’antigiuridicità del
reo, si produce una sorta di negazione da parte
dell’ente pubblico stesso del suo carattere costitutivo, segnato, come ampiamente dimostrato dalla dottrina e dalla giurisprundenza,
dall’articolo 3 del Dettato.
Appare quindi palese come la pena privata
delle sue finalità rieducative risulti estranea
all’ordinamento giuridico vigente.
Allora una questione può essere posta: se
e come l’esecuzione della pena per mezzo
dell’espulsione dal territorio dello stato del
condannato detenuto possa ricondursi ad una
funzione rieducativa della stessa.
Oltre i propri confini lo stato, come evidenziava già Grozio, non esercita alcuna potestà,
men che meno può dispiegare un trattamento rieducativo. La pena, in questa fattispecie,
consiste esclusivamente nella messa al bando
del condannato, su questo non è operato alcun
intervento, la Repubblica non esercita il suo
principale e caratterizzante compito privando
il condannato dell’azione rieducativa di cui ha
diritto anche nel caso in cui alla estinzione della pena detentiva venga espulso.
In proposito appare indicativa una pronuncia di Cassazione. Già nel febbraio 1982 la
Cassazione ha evidenziato come l’espulsione a
135
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
pena espiata non contrasti affatto con le finalità rieducative della stessa né, più in particolare
con il graduale reinserimento del reo nella società. “Poiché la risocializzazione deve intendersi in senso sovranazionale” non rileva l’ambito statuale nel quale avverrà il trattamento
di reinserimento sociale del soggetto; ciò che
importa è l’idoneità del trattamento rieducativo a favorire il “recupero sociale nel contesto
del consorzio civile, quale elemento dell’intera
comunità internazionale”.
La Cassazione ribadisce la parità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini stranieri, che ritrova la propria ratio nella parità
di diritti propria all’essere umano, così come
si evince dalla disposizione dell’articolo 2 del
dettato costituzionale.
Operare una discriminazione nel campo
dell’esecuzione della pena in base alla cittadinanza del reo fa venire meno l’effettività dei diritti inalienabili dell’uomo riconosciuti dall’ordinamento; ciò pone l’ordinamento stesso,
disancorato sia dall’articolo 3, che dall’articolo
2 del dettato, in balia di correnti che possono
trascinarlo verso i vortici del diritto inteso
come una tecnica di controllo sociale.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
Sul carcere quale “fabbrica del
reinserimento sociale”
1. Il rapporto fra reinserimento sociale e
lavoro nel quadro valoriale tratteggiato dalla Carta costituzionale; 2. L’intervento del
legislatore ordinario nell’affermare i valori
costituzionali; 3. Imprese e carcere fra norme
promozionali e “marchio etico”; 4. L’evoluzione del lavoro nella società contemporanea e le
sue possibili ripercussioni nel processo rieducativo del reo; 5. Sul ristretto e l’etica del lavoro; 6. Su possibili implicazioni fra il lavoro
carcerario e la decarcerizzazione; 7. Il percorso
della rieducazione: da lavorante a lavoratore.
1. Il rapporto fra reinserimento sociale
e lavoro nel quadro valoriale tratteggiato dalla Carta costituzionale.
L
e tematiche proposte nell’ambito di una
riflessione su una realtà carceraria tesa a
divenire una “fabbrica del reinserimento sociale” inducono a riconoscere come, sia pure
all’interno d’una quotidianità resa precipua
dal regime di limitazione della libertà, si assista all’intrecciarsi di diritti fondamentali della
persona umana, ai quali corrisponde l’affermarsi di precisi doveri che investono, ovviamente da prospettive diverse, sia coloro i quali
scontano una pena, che le istituzioni sociali, le
quali tale esecuzione hanno previsto.
In un quadro illuminato dalle disposizioni
contenute nell’articolo 3, comma secondo della
Costituzione del 1948, il quale, come noto, nel
riconoscere l’obbligo rimozionale della Repubblica di quegli ostacoli che limitando la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini ne impediscono il
pieno sviluppo come persone umane, afferma
il principio partecipativo di tutti i lavoratori
alla vita politica, economica e sociale del paese, si colloca il comma terzo dell’articolo 27 del
dettato e, quindi, la necessaria interazione fra
il diritto del condannato alla rieducazione ed il
dovere delle istituzioni a predisporre un trattamento penitenziario conforme al finalismo
rieducativo lì sancito. La tensione alla riedu136
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
cazione del condannato non può che ritrovare
nel lavoro il proprio punto di riferimento e ciò
a maggior ragione in un contesto istituzionale, come quello tratteggiato dall’articolo 1 della
Carta costituzionale, che si riconosce, sia pure
senza alcuna pretesa di esclusività, fondato
anche sul principio lavorista. Il lavoro è, dunque, uno dei pilastri su cui si regge il contesto
socio-politico del paese ed è, nel contempo,
strumento per partecipare attivamente a tale
contesto, come evidenzia il comma secondo
dell’articolo 3, poco innanzi richiamato.
Di fatti, al riconoscimento ed alla promozione del diritto al lavoro, che dà vita ad un
interesse costituzionalmente garantito, si affianca, come evidenziato dal comma secondo
dell’articolo 4 della carta costituzionale, il dovere, sia pur, come rilevato1, non coercibile, e,
per tanto, di natura più morale che giuridica,
ad “un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società”.
Appare, quindi, chiaro, e ora va soltanto brevemente accennato, come l’articolo 41 del dettato sottolinei che il lavoro, combinato al capitale ed alla conoscenza tecnologica, non possa
“svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”.
La finalità rieducativa della pena non può,
all’interno di questo quadro normativo e valoriale, che ritrovare esplicazione anche in una
prassi di educazione al lavoro, sicché al dovere del condannato corrisponde il diritto della
società di esigere che la rieducazione del reo
avvenga anche per mezzo del lavoro, nel momento in cui questo pare rappresentare uno
dei nuclei intorno ai quali si fonda e si dispiega la vita societaria.
Va soltanto accennato come l’articolo 35 della Costituzione, al comma secondo, dopo avere, al comma primo, tutelato “il lavoro in tutte
1 Cfr. per tutti V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, p. 150. Proprio in tema
di condanna penale va in ogni caso rilevato come, ai
sensi dell’articolo 133, comma secondo, punto quarto
del Codice penale, il giudice, nell’esercitare il poter discrezionale nell’applicare la pena, possa, nel tener conto
“della vita individuale, familiare e sociale del reo”, prendere in considerazione il suo rapporto con il lavoro. Va
altresì sottolineato che tali considerazioni posso pesare
notevolmente sulla dichiarazione di delinquente o contravventore abituale ai sensi degli articoli 103 e 104 del
Codice penale.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
le sue forme ed applicazioni”, quindi, anche il
lavoro dei carcerati, faccia cura alla Repubblica
della formazione e della elevazione professionale del lavoratore, in modo tale da potersi ravvisare un diritto del cittadino incarcerato alla
formazione professionale, diritto rinforzato da
una interpretazione estensiva del comma terzo
dell’articolo 38 del dettato, del resto legittimata
dalla modifica delle norme in materia di cooperative sociali (legge n. 381 del 8 novembre 1991),
che già all’origine ricomprendevano nella categoria delle “persone svantaggiate”, oltre ai soggetti esplicitamente menzionati dal legislatore
costituzionale nel sopra richiamato articolo, i
detenuti negli istituti penitenziari.
All’interno di tale contesto, lo stesso istituto
familiare risulterebbe monco se separato dal
lavoro; non appare, infatti, casuale che la carta
costituzionale riconosca, all’articolo 36, comma primo, il diritto del lavoratore ad una “retribuzione […] sufficiente ad assicurare a sé ed
alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
La stessa libertà, quindi, in una “Repubblica
democratica, fondata sul lavoro” non appare disgiungibile da quest’ultimo; è di fatti il lavoro
che promuove sostanzialmente nella vita concreta la libertà, la quale ritrova, per l’appunto,
nel lavoro, quale mezzo istituzionale per una
esistenza almeno dignitosa, più che in vuoti
enunciati, il proprio supporto e ciò a maggior
ragione per chi, come il detenuto, si vede limitato nell’uso di questo bene, la cui piena riacquisizione passa attraverso un processo rieducativo nel quale l’essere lavoratore appare centrale.
Solo per inciso va rilevato come la forte tutela dei diritti dei lavoratori, l’imprescindibilità
della funzione sociale del lavoro, l’impossibilità,
quindi, di esplicarlo a nocumento della sicurezza e della dignità umana, nonché il riconoscimento del lavoro quale fondamento della vita
democratica stessa, rendono impossibile sul
piano della ricostruzione dei valori costituzionali tragici accostamenti fra i sostantivi lavoro
e libertà, che forse verrebbero alla mente avuto
riguardo ad una certa rappresentazione del lavoro penitenziario storicamente verificabile.
137
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
2. L’intervento del legislatore ordinario
nell’affermare i valori costituzionali.
Il legislatore ordinario ha più volte ribadito
la centralità del lavoro nel trattamento rieducativo del condannato. Nello stesso Ordinamento
penitenziario, radicalmente riformato con la
legge n. 354 del 26 luglio 1975, che abbandona definitivamente l’idea di pena come ritorsione istituzionalizzata a fronte di un reato,
emerge, all’articolo 15, fra i principali elementi
di trattamento del condannato, il lavoro. Tale
tema ritrova, come noto, sua specificazione in
primis all’articolo 20, il quale tratteggia, per i
detenuti, la distinzione fra lavoro interno (intramurario) e lavoro esterno (extramurario),
ma soprattutto stabilisce, al comma quinto
che “l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro
nella società libera al fine di far acquisire ai
soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per
agevolarne il reinserimento sociale”. In tal
senso appare centrale sottolineare come, nonostante il lavoro penitenziario tragga origine
più da un obbligo legale che da un rapporto
contrattuale, nello stesso ritrovi applicabilità
nella sua interezza la legislazione a tutela del
lavoro (dalla sicurezza al riposo festivo, dalla
tutela assicurativa e previdenziale alla erogazione degli assegni famigliari).
Va solo rammentato che dall’entrata in vigore della richiamata legge del 1975 la normativa sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà ha subito una notevole
modificazione; centrale in tal senso appare la
legge n. 663 del 10 ottobre 1986 (cosiddetta
legge Gozzini), che dà impulso ad una politica
di decarcerizzazione per mezzo delle cosiddette misure alternative alla detenzione, le quali
ritrovano un importante intervento normativo nella legge n. 165 del 28 maggio 1998 (cosiddetta legge Simeone).
Come si ha agio d’osservare, le misure alternative appaiono fondamentali ed imprescindibili al fine di ipotizzare il lavoro extramurario,
il quale ritrova ulteriore rilancio per mezzo
della legge n. 193 del 22 giugno 2000 (cosiddetta legge Smuraglia), contenente norme per
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
favorire l’attività lavorativa dei detenuti attraverso la concessione di agevolazioni per aziende (cooperative sociali ed imprese pubbliche
e privata) che impieghino lavoranti detenuti.
Fondamentale, non soltanto per il lavoro intramurario, appare il precedente intervento
normativo avvenuto con legge n. 293 del 12
agosto 1993, il quale favorisce lo sviluppo delle attività lavorative all’interno delle strutture
penitenziali ed avvia il processo di formazione
professionale dei detenuti.
La prospettiva solcata dal legislatore con la
riforma dell’Ordinamento penitenziario del 1975
non è nel corso di questo trentennio mai stata
posta in discussione ed anzi gli ulteriori interventi normativi succedutisi nel tempo la hanno maggiormente rinforzata, tratteggiando,
con particolare riguardo all’idea del rapporto
fra lavoro e trattamento rieducativo, un’ipotesi per la quale il lavoro del detenuto, lungi dal
apparire soltanto un espediente per togliere
il ristretto da una situazione di ozio foriero di
ulteriore sregolatezza (il lavoro, infatti, all’interno di questa rappresentazione, che ritrova
il proprio punto di riferimento nel Regolamento penitenziario del 1931, di poco successivo alla
promulgazione del codice penale tutt’ora in
vigore, “sostituendo all’inerzia il movimento,
dona all’individuo, se non il gusto, per lo meno
la nozione della regolarità e dell’ordine”), viene
proposto come diritto costituzionale e dovere
sociale, elemento indispensabile alla rieducazione ed al reinserimento sociale del reo.
Qui è possibile soltanto accennare (e la questione meriterebbe un’analisi particolareggiata), come con la riforma del 1975 venga istituito il Centro di Servizio Sociale per Adulti (si
veda l’articolo 72), al quale vengono attribuite,
fra le altre, importanti funzioni nell’ambito
della organizzazione del lavoro penitenziario
(si veda in proposito gli articoli 47 e seguenti
del regolamento esecutivo della legge n. 364
de 1975 posto con DPR n. 230 del 2000), nonché, con particolare riguardo al fine di favorire
il reinserimento del reo nella società, il Consiglio di aiuto sociale (vedi articolo 74)2.
2 Su tali questioni ci permettiamo di rimandare al lavoro di tesi di laurea in Scienze del Servizio Sociale di
Luciana Bertoia, Il servizio sociale penitenziario: le misure
138
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
3. Imprese e carcere fra norme promozionali e marchio etico
Da quanto sopra brevemente accennato
è possibile in ogni caso cogliere una precisa
linea di tendenza, che partendo dalla tensione all’equiparazione del lavoro penitenziario,
sia nella forma intramuraria che in quella extramuraria, al lavoro svolto nella società libera, giunge da ultimo a riconosce, per tramite
di norme promozionali, degli incentivi alle
imprese che impiegano lavoranti detenuti e
lavoratori ex detenuti; questa prospettiva si
colloca all’interno di una cornice istituita dai
supremi valori costituzionali, la quale racchiude un’idea di rieducazione del reo, in cui
la vigenza del diritto/dovere al lavoro appare
assolutamente imprescindibile.
Ripensando agli incentivi a favore delle
imprese impegnate a conciliare le esigenze
di mercato con un netto e marcato intervento a favore della persona umana, di cui la legge Smuraglia del 2000 rappresenta un chiaro
esempio, nel momento in cui estende alle imprese agevolazioni prima usufruite soltanto
dalle cooperative sociali (ex articolo 4, legge
381/1991), e, nel contempo, radicalizza l’intervento a favore dell’assunzione di lavoranti
detenuti e lavoratori ex detenuti, sovviene il
dibattito sviluppatosi anche in Italia in merito
al cosiddetto marchio etico.
Giova in proposito rammentare come, anche sulla scorta di iniziative comunitarie (vedi
il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e successivamente il libro verde della
Commissione Promuovere un quadro europeo per
la responsabilità sociale delle imprese del luglio
del 2001), il legislatore nazionale sia stato più
volte sollecitato ad intervenire, per tramite di
norme promozionali, sul riconoscimento di
un marchio etico per le imprese socialmente responsabili. Estrapolando dalla relazione ad un
disegno di legge presentato nel corso della XIV
legislatura, “il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa che esse decidono, di
propria iniziativa, di contribuire a migliorare
la società, cioè di investire maggiormente nel
alternative alla detenzione, anno accademico 2002-2003,
Università degli Studi di Trieste.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate, al fine di conciliare
le ragioni della competitività con quelle dello
sviluppo sociale”. Si tratta, per tanto, di incentivare le imprese a “sviluppare le prassi socialmente responsabili” già istituzionalizzate da
organismi internazionali; in proposito uno
dei principali punti di riferimento è offerto dal
Social Accountability International, estensore
della norma SA 8000, a cui anche la proposta
di legge sopra richiamata faceva riferimento.
Ebbene, senza dilungarci sull’argomento, spiace in questo contesto constatare che
l’utilizzo del lavoro penitenziario sia preso in
considerazione solamente nella sua accezione
negativa o patologica, di lavoro obbligatorio
(meglio forzato), si veda in proposito in punto 2 della SA 8000, mentre nessuna menzione viene fatta in merito alla promozione del
reinserimento dei detenuti ed ex detenuti nel
contesto societario per mezzo dell’offerta sia
di formazione professionale, che di opportunità di impiego. Infatti, all’intero della cornice
che il legislatore nazionale riterrà di porre e in
quella già predisposte dai legislatori regionali3, il lavoro penitenziario, nella sua accezione
fisiologica ricavabile dai principi costituzionali, di cui prima si è fatto cenno, non appare valorizzato quale requisito per accedere al marchio etico, mentre, come osservato, questo è un
veicolo primario al fine di porre l’impresa al
servizio della persona umana e più in generale
per valorizzare la sua funzione sociale. La quotidiana promozione della persona, anche della
persona ristretta nelle maglie della istituzione
penitenziaria, rappresenta, infatti, la strada regia per l’affermazione dei diritti dell’uomo.
In questo senso, meriterebbe attenzione
e ulteriore valorizzazione lo sforzo compiuto
dal mondo delle imprese al fine di agevolare,
per tramite della formazione professionale e
dell’offerta lavorativa, il pieno reinserimento
dei detenuti ed è pertanto auspicabile un coordinamento delle iniziative volte a promuovere
la funzione sociale dell’imprese e con questa,
3 In materia è già intervenuta la Regione Abruzzo, con legge
n. 12 del 14 febbraio 2000 e, dopo la riforma del Titolo quinto, sono presenti proposte di legge presso i competenti organi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Piemonte.
139
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
come appare ovvio da quanto siamo andati dicendo, promuovere la vigenza dei diritti inalienabili della persona umana.
In proposito un attento osservatore della questione ha avuto modo di suggerirci che
“non ci può essere vera tutela di un diritto solo
attraverso la repressione come reato della condotta che lo viola […] tutelare un diritto significa garantire il soddisfacimento di un bisogno
fondamentale”4 quale è, nel nostro contesto, il
bisogno di reinserimento del reo nella società.
issn 2035-584x
Da queste brevi considerazioni non si può
che constatare come ogni richiamo, ogni tentativo di far entrare il lavoro nel carcere, di favorire il reinserimento sociale del detenuto anche
per tramite della sua partecipazione alla realtà
lavorativa, si colloca a pieno titolo nell’alveo
valoriale tracciato dai principi costituzionali
ed anzi diviene una delle principali vie per rendere effettivi, anche nel mondo del carcere, nel
piccolo e povero vissuto quotidiano, i grandi valori racchiusi nelle enunciazioni di principio.
È necessario, quindi, verificare nella realtà quotidiana l’estrinsecarsi sia dei principi,
che degli interventi volti a realizzarli. In proposito ci giunge come stimolo la riflessione
per la quale “la giuridificazione [dei diritti
umani] è una conquista della civiltà giuridica e politica; è, con i suoi strumenti applicativi, necessaria, ma non sufficiente per il
soddisfacimento dei bisogni”5.
Nel discutere di lavoro e carcere e nel distinguere quest’ultimo dalla galera, alcune questioni non possono venire sottaciute. Di queste daremo soltanto brevi cenni. Ci permettiamo di
porre due questioni di carattere generale per poi
dar conto di alcuni punti di criticità presenti, a
nostro avviso, nel rapporto fra lavoro e carcere,
così come tratteggiato dalla vigente normativa.
La prima questione è relativa al fatto che
la società a noi contemporanea ha avviato un
processo di radicale modificazione della realtà
lavorativa. Il lavoro, inteso nella sua accezione di posto di lavoro, sta perdendo sempre di
più quella caratteristica di fissità che lo aveva
caratterizzato negli scorsi decenni a tutto vantaggio di forme lavorative protese verso la flessibilità, la segmentazione, la mobilità, di cui
autorevole esempio appare la legge n. 30 del 14
febbraio 2003, con particolare riferimento agli
articoli 3 e 4. Come ci viene sottolineato6, ogni
modificazione regolamentativa del lavoro produce immediatamente i suoi effetti nell’ambito
del lavoro penitenziario, nel momento in cui,
come stabilisce la normativa vigente, questo si
adegua a quello della società libera. Pertanto, la
realtà lavorativa verso la quale i detenuti vanno
incontro all’interno d’un processo di trattamento rieducativo è ben diversa da quella presente
fino agli anni Novanta dello scorso secolo, in
cui l’asse del rapporto fra flessibilità e sicurezza era sbilanciato a vantaggio di quest’ultima;
sull’orizzonte che ricomprende il reinserimento sociale del reo anziché palesarsi il posto di lavoro si staglia la potenziale incombenza della
parzialità e temporaneità dello stesso. Il lavoro
si concretizza nell’immaginario collettivo sempre meno con le sembianze del posto fisso, intorno al quale costruire o, nel caso del reo, ricostruire la propria vita sociale; infatti, se, per un
verso diamo per non mutato l’ambito valoriale
nel quale si colloca il lavoro, per altro è sicuramente mutata la realtà concreta nella quale il
rapporto di lavoro si esplica, sicché in questo
il tempo ritrova sempre più precise determinazioni, che non possono che influire sull’interazione, di natura psicologica, fra il reo e l’idea
di lavoro da questo percepita e produrre effetti
ben più esiziali alla prova dei fatti.
Va da sé che l’effetto pratico di questo processo conduce inevitabilmente e, per certi versi
istituzionalmente, ad una sorta di precarietà,
anzitutto psicologica non potendo l’immaginario il più delle volte ancorarsi a quella idea di
stabilità lavorativa, che la legge delega del 2003
4 A. Papisca, Infrastrutture e diritti umani per il sistema democratico, in L. Strumendo (a cura di), Costituzione diritti
umani garanzie, Padova, 1998.
5 Ibidem.
6 Cfr. l’intervento del magistrato Monica Vitale, autrice del
volume Il lavoro penitenziario, Milano, 2001, alla giornata di
studi su “Carcere: lavorare in stanca”, Padova, 9 maggio
2003 reperibile sul sito www.ristretti.it/convegni/lavoro.
4. L’evoluzione del lavoro nella società
contemporanea e le sue possibili ripercussioni nel processo rieducativo del reo
Digressioni sull’esecuzione della pena
140
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
tende a superare. Si può presumere che tale flessibilità nella acquisizione del reddito investirà
sempre più prepotentemente l’immaginario
dei soggetti deboli, fra i quali si annoverano i
detenuti e gli ex detenuti e ciò con conseguenze
facilmente intuibili per quanto concerne il fenomeno della recidiva (ma su questo oltre).
Altro fattore non secondario da tenere presente nel momento in cui viene affrontato il
nostro tema è il fenomeno della delocalizzazione dei processi produttivi, ovvero lo sradicamento degli stessi dalle tradizionali aree
geo-economiche per mezzo dello spostamento sempre più massiccio di fasi e settori della
produzione verso aree ove il costo del lavoro
(inteso in senso lato e comprensivo anche di
sicurezza, di politiche ambientali nonché di
politiche sindacali-rivendicative) sia più favorevole. Tale processo non può che investire
il lavoro penitenziario, lavoro, al di là di tutti
i meritevoli sforzi, reso da manodopera non
qualificata e perciò facilmente fungibile, nonché, anche per motivi strutturali, rivolto verso
fasi di lavorazione non altamente specializzate e, quindi, facilmente delocalizzabili.
Bisogna, quindi, interrogarsi sulla reale
portata degli incentivi offerti alle imprese
dalle norme promozionali del lavoro del detenuto e dell’ex detenuto (vedi legge Smuraglia)
a fronte della possibilità di usufruire, da parte
delle imprese, di altra forza e forme di lavoro
a basso costo. La delocalizzazione delle attività produttive è indubbiamente una di queste
possibilità, per tacer ovviamente del ricorso al
cosiddetto lavoro nero od al lavoro in condizioni di totale illegalità avuto riguardo ai parametri normativi di sicurezza7.
Non appare perciò casuale che le percentuali di occupati nel mondo della reclusione
siano non elevate; in proposito i dati riconoscono una percentuale annua di circa il 20% di
occupati nella popolazione penitenziaria, ma
tale dato8, stando a stime calibrate, ad esem7 Mi piace soltanto rammentare, in proposito del lavoro sommerso, il lavoro redatto negli anni Settanta da A.
Bagnasco, Le tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, 1977.
8 Il Ministero della Giustizia offre al 30 giugno 2006
una percentuale di detenuti lavoranti pari al 25,3% dei
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
pio dalla constatazione della temporaneità e
brevità del rapporto lavorativo, va dimezzato,
giungendo alla stima del 10% di occupati nella popolazione carceraria9. A tale proposito va
aggiunto che, per quanto concerne il lavoro
intramurario, ovvero l’attività produttiva che
si svolge all’interno degli istituti penitenziari,
il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro, quindi l’adeguamento dei locali del carcere adibiti a laboratori ai parametri
normativi, è posta a carico dell’impresa. Ciò
porta ovviamente ad un notevole incremento dei costi di produzione e disincentiva non
poco l’utilizzo di reclusi soprattutto da parte di
imprese private.
Va altresì rilevato che, al momento della sua
attuazione, la legge Smuraglia offriva copertura per circa 750 posti di lavoro in tutto il territorio nazionale e per l’intera popolazione carceraria (il cui ammontare superava le 60.000
unità), come noto soltanto la metà dei fondi
stanziati a copertura ebbe modo di venire utilizzato, poco più di 300 unità lavorative usufruirono realmente dei benefici posti in essere
dal legislatore10. Questo dato induce ad interrogarsi se effettivamente un intervento, come
quello previsto dalla attuale normativa, che
tende ad incentivare l’assunzione di detenuti
solo attraverso la riduzione del costo del lavoro, si collochi, per così dire, in armonia con le
attuali dinamiche del mercato del lavoro.
Un’ultima questione merita qui richiamo
detenuti presenti (15.501 detentuti lavoranti, di questi
936 donne, su una popolazione carceraria di 61.264 unità, di cui 2.923 donne). Di questi, lo 81,2% (12.591 unità)
sono alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, il restante 18,8% (2.908 unità) non è alle dipendenze
dell’amministrazione, ma di datori di lavoro esterni. Va
rilevato, in merito ai detenuti stranieri, come sia stimata, sempre dalla stessa fonte, una percentuale del 23% di
lavoranti, dato che appare in sintonia con quello generale. Una stima del 2005 curata dall’Associazione Antigone
e reperibile sul sito della stessa (www.associazioneantigone.it) rileva la presenza di 19.836 detenuti stranieri
su una popolazione complessiva di 59.523 unità.
9 Cfr. la relazione di A. Margara, ex direttore del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
alla già richiamata giornata di studi su “Carcere: il lavoro non stanca”, reperibile sul sito www.ristretti.it/
congegni/lavoro.
10 Ibidem.
141
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
ed è offerta dalla più volte evidenziata11 sfasatura fra la formazione professionale offerta
ai detenuti negli istituti carcerari e le esigenze
lavorative esterne, in modo tale da determinare una situazione di non competitività del
lavorante recluso rispetto all’aggiornamento
professionale del lavoratore libero. Tutto ciò si
riflette pesantemente sulla possibilità dell’ex
detenuto di ottenere, una volta eseguita la pena,
una occupazione lavorativa dignitosa, che gli
permetta di acquisire un reddito sufficiente;
come evidenziato negli studi in materia12, gli ex
reclusi trovano impiego in lavori a basso profilo professionale, per lo più nel settore dell’edilizia o in quello della ristorazione nonché in
cooperative di pulizia o facchinaggio13.
All’interno di questo quadro, non certamente idilliaco, non appare trascurabile l’ipotesi,
più volte sollevata14, di riservare legislativamente una quota di posti di lavoro a detenuti
ed ad ex detenuti, così come già avviene per altre categorie socialmente svantaggiate.
L’incentivo alla attività lavorativa della popolazione carcerata può apparire di non secondaria importanza, al di là del centrale richiamo nel
trattamento rieducativo, per quanto concerne
l’esecuzione delle pene pecuniarie, il più delle
volte convertite in regime di libertà controllata. In questo senso, la possibilità di usufruire
di lavoro intramurario o di misure alternative
11 Nel primo semestre del 2006, stante ai dati del
Ministero della Giustizia, sono stati attivati 316 corsi
di formazione professionale con 3.569 iscritti; ne sono
stati portati a compimento 231, a cui hanno partecipato
2.847 detenuti. Fra le tipologie di corsi più seguite spiccano quelle di informatica (18%), di arte e cultura (13%),
cucina e ristorazione (12%).
12 Cfr. L. Baccaro – G. Mosconi, Il girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva, in “Dei delitti e delle pene”,
2003, n. 3. Il lavoro ha per oggetto una ricerca su un
campione di detenuti nella Casa di Reclusione e nella
Casa Circondariale di Padova.
13 Non appare fuori luogo riproporre dati del Ministro
della Giustizia in merito alla scolarità della popolazione
detenuta e riferiti al 31dicembre 2006: analfabeti 1,5%;
senza titolo 3,8%; scuola elementare 19,4%; media inferiore 35,2%; scuola professionale 1,6%; media superiore
4,6%; laurea 1,1%.
14 Cfr. le conclusioni, tratteggiate da Giuseppe Mosconi,
alla giornata di studi su “Carcere: lavorare non stanca”
consultabile sul sito www.ristretti.it/convegni/lavoro.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
alla detenzione permetterebbe al condannato
di eseguire la pena pecuniaria e, nel contempo,
alle istituzioni di rendere non soltanto letterale
tale forma di pena. A maggior ragione lo stesso
ragionamento si applica per quanto concerne il
risarcimento del danno. Tale discorso implica
che le pene accessorie erogate debbano essere
tali da non inficiare la capacità lavorativa del
reo e, pertanto, debbano essere calibrate con il
suo inserimento nel mondo del lavoro.
In questa direzione si volge il dibattito15 che
ravvisa opportuno che la misura alternativa
sia applicata già nella sentenza, dal giudice di
merito e non successivamente nella fase esecutiva della condanna dal tribunale di sorveglianza. A detta dei fautori di quest’ipotesi,
la cui realizzazione non appare certo priva di
problematiche se non altro per la constatazione che la misura alternativa attualmente si colloca all’interno del trattamento rieducativo ed
è concessa a seguito di approfondite indagine
sul percorso rieducativo stesso, porterebbe a
snellire i tempi della concessione della misura
stessa, ponendo immediatamente il condannato nelle condizioni di accedere ad occupazioni lavorative esterne al carcere e, più in generale, farebbe prevalere già nella sentenza la
fase della rieducazione e della risocializzazione del reo su quella della sua dichiarazione di
colpevolezza collocando chiaramente la pena,
già nella sua fase dichiarativa, verso le finalità
rieducative e non afflittive.
5. Sul ristretto e l’etica del lavoro.
La seconda e forse più radicale questione
inerisce alla constatazione che, abitualmente,
discutendo di lavoro carcerario si assume in
modo aproblematico un preciso quadro valoriale, all’interno del quale si inserisce il lavoro. Il quadro valoriale riconducibile a quanto
descritto nella prima parte del presente intervento, può ritrovare indistintamente punti
di riferimento sia nel pensiero di Sieyès, che
in quello di Marx ed Engels (le loro due opere più note, rispettivamente Che cosa è il terzo
stato?, apparso nel gennaio 1789 ed il Manifesto
del partito comunista, pubblicato nel marzo del
15 Cfr. ibidem.
142
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
1848, se divergono profondamente da un punto di vista operativo, si riconnettono sull’orizzonte teoretico proprio in considerazione
dell’identico valore offerto dagli autori al lavoro; entrambe i testi fondano e si fondano su
una precisa etica del lavoro, borghese la prima,
proletaria la seconda).
Il problema è interrogarsi, a maggior ragione discutendo di carcere e lavoro, su quale sia
il grado di interiorizzazione dell’etica del lavoro nella popolazione carcerata.
Infatti, prendendo a prestito una nota teoria sociologica16, il lavoro rappresenta uno dei
principali mezzi istituzionali per raggiungere
delle mete socialmente condivise (ad esempio,
il benessere materiale, ma anche, in una prospettiva consumistica ed edonistica, l’esibizione per tramite di simboli di status sociale); in
questo senso, si perdoni la banalità, chi lavora
per conquistare tali mete ha un comportamento socialmente conforme; chi, invece, pur condividendo i valori sociali incarnati in quelle
mete, rifiuta i mezzi istituzionali per raggiungerle, ponendo in atto altri percorsi non socialmente (e giuridicamente) legittimi assume un
comportamento deviante (per Merton si tratta
di una sorta di devianza riformista giacché non
pone in discussione l’intero assetto sociale, condividendone, infatti, le mete di fondo, ma attua
una prassi volta al loro raggiungimento non
ortodossa). La maggior parte dei reati contro
il patrimonio (per inciso va rammentato che il
30% della popolazione carceraria ha commesso
reati contro il patrimonio) si colloca su questo
sfondo teorico, che vede fra le proprie basi il
rifiuto del lavoro quale principale mezzo istituzionale per realizzare le mete sociali. Sicché,
se esaminati sotto lo spettro della teoria del sociologo funzionalista, in coloro che delinquono contro il patrimonio si riscontra un radicale
rifiuto del mezzo istituzionale pur a fronte di
una accettazione dei valori sociali dominanti,
in modo tale che l’attività lavorativa conforme
ai dettami sociale viene considerata inadeguata al raggiungimento di tali scopi (più proficui
appaiono le modalità descritte, ad esempio,
negli articoli 624 e seguenti del codice penale;
16 Si fa riferimento a R. K. Merton, Teoria e struttura sociale, trad. it. Bologna, 1971.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
lo stesso discorso può applicarsi ovviamente ai
delitti contro la persona, quali quelli descritti
dall’articoli 600 e seguenti del codice penale)17.
In tale contesto un trattamento penitenziario che concentra la sua attenzione sul lavoro
quale fulcro dell’intero processo di risocializzazione potrebbe palesare il lavoro anziché quale
mezzo di rieducazione quale momento di angheria, di lavoro forzato, imposto coattivamente
su soggetti totalmente refrattari, che tutt’al più
lo accettano al fine di usufruire delle agevolazioni connesse alla misure alternative. In tale
quadro, dal punto di vista del soggetto refrattario trattato, il lavoro penitenziario, lungi dal
manifestarsi quale possibilità di reinserimento
sociale, si concretizza quale ulteriore affiliazione da aggiungere alla privazione della libertà18.
17 Dati della Associazione Antigone relativi al 2005
evidenziano che al 30,3% della popolazione detenuta è
ascritto reati contro il patrimonio; al 14,6% reati connessi alle sostanze stupefacenti; al 16% reati connessi alle armi; 2,5% reati di stampo mafioso; 0,6% reati
connessi al mondo della prostituzione. Fra l’altro, dati
forniti dall’Associazione Antigone e riferentisi al 2005
indicano che, su una popolazione detenuta di 59.125
unità, 23.012 risultano, ai sensi del articolo 73 del Testo
Unico n. 309 del 1990, tossicodipendenti o alcolisti. Tali
percentuali collimano sostanzialmente con i dati rilevati dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2006, che
riscontrano il 28% dei detenuti con ascritto reati contro
il patrimonio; il 14% con reati contro la legge della droga; il 16,6% contro le legge sulle armi; il 3,4% reati di tipo
mafioso; lo 0,6% reati connessi alla prostituzione.
18 Senza voler in nessun caso disconoscere il ruolo centrale svolto da autori come Hugo e Sue nella formazione
di un movimento di riforma delle politiche penali, che
ritrovi nella valorizzazione della persona umana e non
nella sua repressione i fulcro del trattamento penitenziario, è indubbio che, proprio avuto riguardo all’etica
del lavoro e con particolare riguardo a certe categorie
di condannati, difficilmente potremmo ritrovarci di
fronte al Jean Valjean de I miserabili, né, sul piano apposto all’espropriatore anarchico Jacob. Ovvero o a soggetti
che, pur desiderandolo, non hanno avuto, dalla società
del loro tempo, l’opportunità di usufruire di quei mezzi
istituzionali per raggiungere delle mete sociali da loro
condivise, prima fra tutte un’esistenza dignitosa, oppure, all’opposto, che, in quanto refrattari ai tutti i valori
sociali hanno coscientemente e scientemente rifiutato
mezzi e mete istituzionali. In proposito, oltre a rimandare alla rilettura delle opere di Victor Hugo e di Eugène
Sue, segnaliamo, sulla vicenda dei lavoratori della notte, di cui Jacob fu indiscusso ispiratore, il volume di B.
Thomas, Jacob, trad. it. Catania, 1989. Pare che il Maestro,
descritto ne I misteri di Parigi, sia pure depurato da tutta
143
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Che, sia pure entro certi limiti, il lavoro non
rappresenti il principale problema del carcerato lo si può con chiarezza evincere da una recente ricerca su i recidivi19, dalla quale emerge
che soltanto il 15,3% degli intervistati ritiene
che la maggiore difficoltà incontrata nel periodo di scarcerazione sia connessa al lavoro, alla
mancanza o insufficienza dello stesso; la stessa
indagine rileva che solo il 7,1% degli intervistati riconosce quale causa della recidiva l’assenza
di lavoro (ciò in un campione in cui, prima della seconda detenzione, il 5,9% si dichiara disoccupato, il 65,1% con un impiego precario e
solo il 28,6% con un contratto di lavoro fisso e
regolare; fra gli occupati solo il 9,4% si dichiara
soddisfatto dell’attività lavorativa, il 45% chiaramente insoddisfatto della stessa).
In questo contesto, il combinarsi di una oggettiva scarsa propensione al lavoro (meglio,
a riconoscersi in quell’etica del lavoro sopra
richiamata e che è posta a fondamento dell’intreccio fra carcere e lavoro) con l’altrettanto
oggettiva difficoltà del ex detenuto ad entrare
nel mondo del lavoro e, qualora questo ingresso avvenga quasi sempre è per una porta di
servizio, rischiano di depotenziare non poco
gli sforzi che mirano al reinserimento del reo
attraverso tali percorsi.
Sicché, avuto riguardo alle obbiezioni sopra
poste, si corre il rischio di veder naufragare
il progetto di trattamento penitenziario fra
gli scogli di una carità pelosa, da una parte, e
dell’angheria, dall’altra; pericolo, questo, reso
ancor più pressante dalla constatazione che la
navigazione in oggetto non avviene in un mare
aperto, libero, ma entro zone rigidamente delimitate dal regime penitenziario e dall’intervento della magistratura di sorveglianza.
6. Su possibili implicazioni fra il lavoro
carcerario e la decarcerizzazione
L’idea di carcere quale fabbrica del reinserimento sociale, qui indagata, prevede anche
l’ipotesi, come evidenziato dai promotori della
la crudeltà ascrittagli da Sue, sia un ragionevole paradigma del detenuto medio.
19 Cfr. il già citato saggio di L. Baccaro - G. Mosconi, Il
girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
prospettiva, “di project financing, affinché chi
si accolla l’onere della loro realizzazione possa poi rientrare nei costi e guadagnare, garantendo l’erogazione dei servizi necessari per la
gestione del carcere stesso. Costruire, quindi,
un carcere [… e affidarlo poi] nella gestione dei
servizi ai privati, con esclusione di quelli della sorveglianza, del trattamento rieducativo e
dell’assistenza sanitaria”20.
Questa prospettiva, invero innovativa per
la panoramica italiana, non è però scevra da
problemi di fondo.
Infatti, per il proverbiale non addetto ai lavori una delle constatazioni più sorprendenti,
nel confrontare il numero dei detenuti con il
numero dei condannati, è offerta dall’osservare come, a fronte della sostanziale costanza
del secondo si assiste a notevoli variazioni del
primo21. Questa macroscopica sfasatura ritrova spiegazione nel fatto che il numero dei
detenuti dipende da scelte di politica penale e
non direttamente dalla propensione a delinquere di una data popolazione rapportata alla
capacità delle autorità di erogare sanzioni. In
questo senso, assumiamo che la percentuale
di popolazione detenuta è anche il frutto di
scelte di politica penale22.
Va riconosciuto che in Italia, per lo meno dalla
cosiddetta “legge Gozzini” del 1986, si è assistito ad una netta politica di decarcerizzazione, sia
per tramite dell’applicazione delle misure alternative alla pena detentiva, che per mezzo di altri
interventi da parte delle autorità competenti.
20 La citazione è tratta della Presentazione del Convegno
«Per una nuova idea di carcere fabbrica del reinserimento sociale», organizzato a Trieste il 25 maggio
2007 dall’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti
dell’Uomo.
21 Tale rapporto è agevolmente coglibile, ad esempio,
nello studio di Nils Christie, Il business penitenziario. La
via occidentale al gulag, trad.it. Milano, 1996. Più in generale sulla cosiddetta costante tendenza al crimine cfr. S.
Vinciguerra, Principi di criminologia, Padova, 2004.
22 Stante i dati del Ministero della Giustizia, la popolazione carceraria in Italia il 30 giugno 2006 ammontava
a 61.264 unità, la stessa popolazione carceraria al 31 dicembre 2006 ammontava a 39.002 unità. Appare evidente come una precisa scelta di politica penale, l’entrata in
vigore della legge n. 241 del 31 luglio 2006, Concessione di
indulto, abbia quasi dimezzato la popolazione presente
nelle carceri italiane.
144
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Il moto di decarcerizzazione è però contraddistinto da una ratio contraddittoria; infatti, a
ben vedere, il punto di avvio di tale processo
è offerto soprattutto dalla constatazione del
sovraffollamento delle carceri italiane23. Senza addentrarsi in una specifica analisi di tale
fenomeno, va in ogni caso riconosciuto come
una situazione di sovraffollamento endemico
è largamente nociva per qual si voglia tentativo di trattamento rieducativo. In proposito,
sociologi ed etologi da sempre evidenziano
nelle loro ricerche un aumento degli atteggiamenti violenti all’interno di spazi comunitari
sovrappopolati. Nella realtà carceraria una situazione di sovrappopolamento si oppone in
linea di principio alla funzione rieducativa
della pena per esaltarne nei fatti il suo essere
affittiva; la lesione della dignità umana rende
precari, all’interno di quel determinato spazio,
la fruizione dei diritti umani.
Pertanto, lo svuotamento delle carceri oggettivamente riduce notevolmente il palesarsi
di queste problematiche, rendendo all’interno
degli istituti più vivibile la permanenza dei
reclusi e, quindi, offrendo parametri di qualità della vita più consoni alla vigenza dei diritti umani24. Se ciò è indubbio, non va sottaciuto il fatto, più volte rimarcato in dottrina,
per il quale lo Stato, avviando un processo di
decarcerizzazione, ispirato soltanto da ragioni operative, viene meno al suo dovere di rieducazione del reo per tramite della pena ed il
23 Nella voce Ordinamento penitenziario redatta da M. G.
Coppetta per il IV aggiornamento della Enciclopedia del
diritto edito nel 2000, possiamo leggere: “l’esigenza di
contenimento della popolazione detenuta entro limiti
ragionevoli ha caratterizzato tutti i recenti interventi
del legislatore penitenziario, il quale, a tal fine, ha operato nel senso di agevolare l’accesso ai «benefici» ai condannati considerati portatori di una minore pericolosità sociale. In definitiva, si è assistito ad una crescente
strumentalizzazione delle misure de quibus ad obiettivi
di deflazione carceraria”, p. 897.
24 A titolo esemplificativo, la Casa Circondariale di
Trieste, con capienza regolamentare dichiarata dal
Ministero della Giustizia di 155 unità, nel 2005, stante dati della Associazione Antigone, ospitava circa 250
detenuti; al 31 dicembre 2006, dati del Ministero della
Giustizia, ospitava 106 detenuti. Il che significa, confrontando i due dati, che sono calate le presenza di ben
150 unità.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
reo stesso perde contemporaneamente il suo
diritto al trattamento rieducativo implicante il
reinserimento sociale25.
Pare di poter cogliere come la politica di
decarcerizzazione, al di là di enunciazioni di
principio, sia direttamente indirizzata più da
constatazioni di ordine operativo (riduzione
dei costi del controllo sociale: edilizia e infrastrutture, servizi anche rieducativi ai detenuti, personale), che da considerazioni sulla
funzione della pena. Ove l’esecuzione della
pena diviene troppo onerosa lo Stato abdica il
suo diritto-dovere alla rieducazione, ma se ciò
corrisponde alla realtà allora l’esercizio della
funzione rieducativa è subordinato, in linea di
principio, da ragioni di ordine economico. Se
però, per qualche espediente, il dato economico relativo alla carcerazione potesse rilevarsi
in pareggio se non addirittura in attivo, allora
le tendenze alla decarcerazione potrebbero invertirsi. Il condannato detenuto da una fonte
di passività potrebbe trasformarsi in una fonte
di attività, di guadagno.
È ben chiaro che tale problema non investe
tanto quella percentuale di condannati per reati gravi, che hanno di fronte a loro ancora una
lunga condanna detentiva da eseguire, la cui
permanenza nel regime detentivo appare difficilmente eliminabile26, piuttosto quella percentuale di condannati a pene detentive la cui
presenza nel carcere è subordinata alla modificazione delle politiche di esecuzione penale.
Proposte volte a rinsaldare i legami fra carcere e mondo produttivo, anche per mezzo della
privatizzazione di parte del sistema penitenziario, investono direttamente questo proble25 In tal senso si esprime, ad esempio, già M. P. Giuffrida,
I Centri di servizio sociale dell’Amministrazione penitenziaria, Roma, 1999, che rileva come la legge n. 165 del 1998,
in materia di estensione dell’istituto della detenzione
domiciliare, abbia effetti deflativi sul sovraffollamento
delle carceri e, quindi, palesi una rinuncia dello Stato ad
esercitare il suo diritto/dovere di trattamento per quei
soggetti i quali, non potendo uscire dal circuito penitenziario per mezzo di altre misure alternative, come
l’affidamento, misure che implicano un forte impegno
personale del soggetto rispetto al percorso rieducativo,
usufruiscono della detenzione domiciliare.
26 Si veda in proposito, al comma secondo dell’articolo
1 della legge n. 241 del 2006, l’elencazione dei delitti per
i quali non si applica la concessione di indulto.
145
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
ma e possono determinare notevoli contraccolpi sulle politiche penali, particolarmente su
quelle relative alla decarcerizzazione.
Ove, infatti, la detenzione risultasse produttiva in termini economici si potrebbe verificare una tendenza alla ricarcerizzazione, tale da
vedere aumentare (sia pure a fronte della sostanziale costanza del numero dei condannati) la percentuale della popolazione detenuta e
questo non tanto per una riscoperta del valore
della detenzione nel trattamento rieducativo
quanto per la scoperta del valore economico della detenzione, sì da fare ripensare quel
rapporto fra i sostantivi lavoro e libertà, a cui
avevamo fatto cenno all’inizio, sostantivi che
certamente non verranno più declinati né nella lingua de La mia battaglia, né in quella in cui
vennero scritti Memorie dalla case dei morti e
Una giornata di Ivan Denisovič, ma che pur tuttavia anche in realtà di democrazia consolidata
rendono non esenti da problematiche le relazioni fra carcere e lavoro.
Alcuni criminologi, sia pur in un contesto
critico forse esasperato, tanto da assumere a
loro emblema uno studio titolato Il business penitenziario. La via occidentale al Gulag, ci fanno in
ogni caso rilevare come a seguito dell’ingresso
del mondo della produzione nel sistema carcerario statunitense la percentuale di popolazione ivi detenuta sia bruscamente aumentata (sia
pure con notevoli differenze fra gli Stati federati, dal 1970 si riscontra un aumento della popolazione carceraria del 65%)27. È ben vero che
altre cause hanno influito su tale incremento28,
ma è altrettanto vero che il dato quanto meno
dovrebbe essere foriero per una riflessione.
Questa constatazione, che non vuole assolutamente essere utilizzata quale freno ad
un processo di indubbio valore sociale, come
quello che vede l’accostarsi al carcere del mondo imprenditoriale, va in ogni caso presa in
27 Di contro è curioso il dato riguardante il crepuscolo
dell’URSS: nel 1986 assistiamo a 458.729 condanne a
pene detentive, 1990 soltanto a 292.992 condanne a pene
detentive. Cfr. N. Christie, Il business penitenziario, cit.
28 Cfr. il volume di A. De Giorni, Zero tolleranza. Strategie
e pratiche della società di controllo, Roma, 2000. Sulla tematica vedi anche il volume di Lucia Re, Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa,
Roma-Bari, 2006.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
considerazione a maggior ragione inserendo
il rapporto fra carcere e lavoro in un contesto
che si qualifica per l’attenzione alla vigenza
dei diritti umani, in modo tale che il lavoro del
recluso ritrovi la propria ragione esclusiva in
un quadro di vigenza dei diritti della umana
persona e venga, perciò, eliminato ogni equivoco avuto riguardo ad una sua possibile rappresentazione nei termini di sfruttamento del
lavoro della persona detenuta.
7. Il percorso della rieducazione: da
lavorante a lavoratore
Al di là delle constatazioni sopra espresse
preme effettuare, in fase conclusiva, ancora alcuni rilievi. Risulta palese come l’Ordinamento
penitenziario contenuto originariamente nella
legge 354 del 1975 sancisca che il lavoro dei
condannati debba riflettere le modalità del lavoro libero, ma come evidente, la disposizione,
nel richiamare il riposo festivo, la tutela assicurativa e previdenziale, così al comma diciassettesimo dell’articolo 20 della sopra richiamata
legge, non fa esplicita menzione di altri diritti
riconosciuti ai lavoratori, ad esempio il diritto
alle ferie annuali retribuite. La formulazione
della disposizione ha permesso che, per mezzo di una interpretazione letterale della stessa,
si traessero delle norme tali da creare una situazione di disparità di trattamento fra lavoranti detenuti e lavoratori liberi, nonché fra
detenuti ammessi al lavoro interno e detenuti
ammessi al lavoro esterno, in palese violazione dell’articolo 3 del dettato costituzionale.
Una giurisprudenza costituzionale protesa
a rendere vigenti le enunciazioni di principio
che caratterizzano, sino dalla riforma del 1975,
la normativa in materia di esecuzione penale
ha reso effettivi anche per il lavorante detenuto i diritti riconosciuti ai lavoratori. Va qui richiamata la sentenza n. 158 del maggio 2001,
la quale riconosce, intervenendo sull’articolo
20, comma 16, dell’Ordinamento penitenziario,
al lavorante detenuto il diritto al riposo annuale retribuito, dato che “ove ne sussistano
le caratteristiche, alla soggezione derivante
dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro
146
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra
cui quelli previsti dall’art. 2199 c. c.) e di obblighi”. Di fatti, nel contesto penitenziario, “né
tale specificità, né la circostanza che il datore
di lavoro possa coincidere con il soggetto che
sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere
ogni rapporto di lavoro subordinato”.
Come sottolineato in dottrina29, la pronuncia della Corte sembra confermare “la qualificazione del lavoro carcerario come una species del
lavoro subordinato”, tanto da poter riconosce
una “progressiva osmosi dei due rapporti di lavoro”. Ciò, fra l’altro, porrebbe fine al dibattito
non solo dottrinario sulla natura del lavoro penitenziario facendo primeggiare l’opinione30
per la quale nello stesso sono presenti tutti gli
elementi che caratterizzano il lavoro subordinato e per tanto la distinzione, ancora presente,
fra lavoranti detenuti e lavoratori liberi avrebbe
rilevanza soltanto lessicale e non giuridica31.
Tale ipotesi viene, altresì, confermata da una
precedente pronuncia della stessa Corte, la sentenza n. 26 del febbraio 1999, in materia di omessa previsione di tutela giurisdizionale contro
violazioni di diritti di detenuti e di internati32.
D’altro canto, prima di abbandonare definitivamente l’ipotesi per la quale il lavoro
carcerario potrebbe palesarsi, non tanto come
privo di ogni riferibilità agli schemi del lavoro
subordinato perché nascente da un obbligo legale e come tale riconducibile ad un rapporto
di diritto pubblico33, prospettiva in vero ora rigettata dalla Corte con la richiamata sentenza
del 2001, quanto come un rapporto di lavoro
29 Cfr. A. Morrone, Il diritto alle ferie ai detenuti, in
“Giustizia Costituzionale”, 2001, pp. 1227 e segg.
30 Già coeva alla riforma del 1975, cfr. Di GennaroBonomo- Breda, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano, 1976.
31 Per un primo succinto ma puntuale approccio al dibattito in materia si veda G. Galli, «Mercede» e «remunerazione» del lavoro del detenuto, in ”Giustizia Costituzionale”,
1988, pp. 5299 e segg.
32 Cfr., in commento alla stessa, i contributi di S.
Bartole, E. Fazzioli, M. Ruotolo e C. Santoriello in
“Giurisprudenza Costituzionale”, 1999, pp. 190 e segg.
33 Si veda in proposito C. Erra, sub voce Lavoro penitenziario, in Enciclopedia del diritto.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
atipico, ovvero collocato all’interno d’un contesto anche normativo dotato di autonomia e
connotato per la presenza di elementi pubblicistici tali da renderlo peculiare rispetto al rapporto di lavoro subordinato, ma non per questo avulso da tutte le disposizioni, compatibili
con il regime penitenziario, che lo tutelano34,
è ben riproporre la spinosa questione relativa
all’articolo 22, comma primo dell’Ordinamento
penitenziario in materia di mercedi.
Il lavoro carcerario è ricompensato, ma tale
trattamento economico più che ricondursi alla
disposizione dell’articolo 36 della Costituzione, ai sensi della quale “il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro”, pare venire attratto
ancora verso l’articolo 145 del codice penale,
secondo il quale “ai condannati è corrisposta
una remunerazione per il lavoro prestato”. La
possibilità di rendere, anche qui, soltanto lessicale la distinzione fra retribuzione, diritto del
lavoratore, e la remunerazione, corrisposta al
detenuto lavorante, non appare così scontata.
Infatti, a ben vedere, tale ipotesi cozza contro la disposizione dell’articolo 22 dell’Ordinamento penitenziario; ai sensi del suo primo
comma, come noto, “le mercedi per ciascuna
categoria di lavoratori sono equitativamente
stabilite in relazione alla quantità e qualità del
lavoro effettivamente prestato”; in tal modo il
legislatore ordinario fa proprie le indicazione
della Costituzione, ma specificando che le mercedi del detenuto sono fissate “in misura non
inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”. Quindi, la remunerazione del detenuto
lavorante può risultare inferiore di un terzo
rispetto a quella del lavoratore libero, sì da far
supporre che l’articolo 36, ma ancor prima l’articolo 3, della Costituzione trovi solo una parziale applicazione in ambito carcerario.
Tutto ciò ci viene confermato dalla stessa Corte Costituzionale in una nota pronuncia. Ci riferiamo alla sentenza n. 1087 del dicembre 1988,
che ci permettiamo, per meglio evidenziarla, di
collocarla, non solo cronologicamente ma an34 Tesi, quest’ultima, sostenuta ad esempio da R.
Kostoris, sub voce Lavoro penitenziario, in Nuovissimo
Digesto Italiano, Appendice IV.
147
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
che idealmente, a metà strada fra la sentenza n.
264 del novembre 1974, a ridosso della riforma
penitenziaria del luglio dell’anno successivo, e
la già richiamata sentenza n. 158 del 2001.
Infatti, la pronuncia del 1988, pur riconoscendo, sulla scorta del nuovo Ordinamento penitenziario, “che il lavoro prestato dai detenuti
è uno strumento per la loro redenzione ed il
loro riadattamento alla vita sociale: non è un
elemento di espiazione della pena ma è un metodo di trattamento”, ribadisce che il rapporto
di lavoro del detenuto con l’amministrazione
penitenziaria “trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto; ha una propria
particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti […]. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla
vita sociale; l’acquisto o lo sviluppo dell’abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento
nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti”. Sicché in questo quadro il
detenuto impegnato in attività lavorative non
sarebbe a pieno titolo un lavoratore, piuttosto
un lavorante, ovverosia una persona il cui lavoro ha finalità, prima ancora che produttive,
rieducative; difatti il lavoro “è un metodo di
trattamento”. In tal senso, solo indirettamente
il lavoro carcerario va ricondotto al comma secondo dell’articolo 4 della Costituzione. Infatti,
prosegue la Corte nella sua argomentazione,
“l’amministrazione non si prefigge né utili né
guadagni; si avvale di una mano d’opera disorganizzata, a volte non qualificata, disomogenea,
variabile per le punizioni ed i trasferimenti da
stabilimento a stabilimento; i prodotti non
sono sempre curati e sempre rifiniti; essi, il più
delle volte, si vendono sottocosto”. Ed al fine di
eliminare ogni equivoco su ipotetiche sinonimie, la Corte rileva che “il compenso previsto
per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede”.
Attraverso queste argomentazioni la Corte
Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 22
della legge n. 354 del 1975 che, con riferimento
agli articoli 3 e 36 della Costituzione, era stata
sollevata, senza per questo non ritenere che,
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
ove si palesassero le condizioni, al detenuto
lavorante, a titolo di mercede, possa venire
corrisposta l’intero ammontare della retribuzione spettante al lavoratore libero. Infatti,
“vero è che stabilito un trattamento minimo
non inferiore ai due terzi del salario previsto
[dai contratti collettivi di lavoro], ma trattasi
solo di una determinazione nel minimo, mentre non può escludersi l’osservanza del criterio
della relazione con la qualità e la quantità del
lavoro prestato e nemmeno possono trascurarsi, secondo il precetto costituzionale, i bisogni della famiglia di chi lavora”.
La sentenza del 1988 qui richiamata porta
in nuce il principio di lì a poco esplicitato dalla
sentenza n. 49 del 1992, ai sensi della quale sussiste violazione del articolo 3 della Costituzione
ogni qual volta si ponga “una irrazionale ingiustificata discriminazione tra i detenuti e gli altri
cittadini”; su questo principio si fonderanno le
successive pronunce della Corte in materia.
Si assiste, per tanto, ad una netta inversione
di tendenza rispetto alla posizione assunta dalla Corte nel 1974, anno in cui la stessa riteneva, per un verso, che la “funzione (e fine) della
pena non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile”, per altro, che “il lavoro, ben lungi dall’essere
in contrasto con la morale esigenza di tutela e
rispetto della persona, è gloria umana, precetto
religioso per molti, dovere e diritto sociale per
tutti e reca sollievo ai condannati che lavorando, anche all’aperto […] godono migliore salute
fisica e psichica, conseguono un compenso e si
sentono meno estraniati dal contesto sociale”.
È ben vero che la sentenza n. 158 del 2001 supera ampliamente le previsioni del giudice costituzionale del 1988, ponendo le basi per il definitivo e pieno scioglimento della dicotomia tra
detenuto lavorante e lavoratore libero e, infatti,
avendo come riferimento la sentenza n. 26 del
1999, la Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 16 dell’Ordinamento
penitenziario nella parte in cui non riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite al detenuto che
presta la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria. Sicché la
Corte conferma la qualificazione del lavoro penitenziario come specie del lavoro subordinato ma,
148
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
come rilevato, apre solo le porte per la definitiva
caduta di “ogni residuo fattore di disomogeneità
che la legislazione e parte degli interpreti ancora
configurano nel caso del lavoratore dipendente
dell’amministrazione penitenziaria”35.
In proposito va rilevato che la stessa Corte,
con sentenza n. 341 del ottobre 2006, riconosce
che “il lavoro dei detenuti, sia che venga svolto in favore dell’amministrazione penitenziaria, sia che venga effettuato – come avviene
sempre più di frequente – alle dipendenze di
terzi, implica una serie di diritti e obblighi
delle parti, modulati sulla base contrattuale
dei singoli rapporti instaurati”; in tal modo si
rinforza sempre di più la prospettiva che vede
nel contratto e non nell’obbligo legale la fonte
del lavoro penitenziario.
Ciò non di meno non si può che rilevare
come l’abbandono della dicotomia fra lavorante e lavoratore, sia pur ora molto attenuata
attraverso le pronunce della Corte, ma ancora
sostanzialmente presente nella prassi e nella
normazione, e, quindi, l’affermarsi del principio per il quale il lavoro penitenziario vada in
tutto assimilato al lavoro libero, passa attraverso una reinterpretazione del disposto dell’articolo 22 della legge 354 del 1975, che ponga anche in evidenza il problema del trattamento di
fine rapporto.
Infine, in materia di diritti dei lavoratori,
così come statuiti dalla legge 300 del 1970, non
va sottaciuta la questione relativa al diritto allo
sciopero, invero sancito dalla carta costituzionale all’articolo 40, e da ipotizzarsi, nel più
genuino rispetto del dettato costituzione, nei
limiti compatibili con l’ordine carcerario (in
proposito va rammentato come la sopra richiamata sentenza n. 341 del 2006 ritenga che “i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole
bilanciamento nel diritto della collettività alla
corretta esecuzione delle sanzioni penali”) e,
ancor prima, avuto riguardo anche alle richieste
dei lavoranti detenuti; i quali palesano l’ipotesi
di elezione diretta dei rappresentanti sindacali,
rappresentanti, quindi, non sorteggiati come
quelli previsti dall’Ordinamento del 1975 agli articoli 12 (biblioteca) e 27 (attività culturali).
A detta dei promotori di quest’ultima inizia-
issn 2035-584x
tiva, una rappresentanza sindacale elettiva non
contravverrebbe alla disposizione dell’articolo
3 dell’Ordinamento, che fa divieto all’istituzionalizzarsi di posizioni di preminenza fra detenuti,
piuttosto valorizzerebbe la partecipazione dei
detenuti lavoranti, “si realizzerebbe, insomma,
un effettivo riavvicinamento tra le modalità di
vita all’interno del carcere e quelle all’esterno:
risultato di indubbio valore – come sottolinea
la redazione della rivista “Ristretti orizzonti”- ,
in prospettiva del reinserimento sociale”.
35 A. Morrone, Il diritto alle ferie ai detenuti, cit., p. 1278.
Digressioni sull’esecuzione della pena
149
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
La legge n. 180 del 13 maggio 1978 ed
“il pieno sviluppo della persona umana”
1. I valori sociali vigenti e la scoperta di nuovi
valori giuridici; 2. L’incisività dei valori sociali sull’ordinamento giuridico; 3. I reietti e lo
sviluppo della persona umana; 4. La devianza
quale condizione per l’esclusione dalla polis;
5. Sulla genericità della terminologia usata
nella legislazione in materia; 6. La legge 180 e
la rottura con le istituzioni totali; 7. Oltre il
recinto della istituzione.
1. I valori sociali vigenti e la scoperta di
nuovi valori giuridici
N
egli anni Settanta dello scorso secolo, indubbiamente a seguito di istanze sociali
prodotte dal radicale modificarsi dei costumi
e della morale pubblica iniziata il decennio
precedente, sono, anche da un punto d’osservazione giuridico, caratterizzati da profonde
innovazioni. Queste hanno in parte modificato l’asse di rotazione dell’ordinamento giuridico; il fenomeno è particolarmente evidente se
confrontato con il precedente trentennio repubblicano informato, ovviamente, anch’esso
dal dettato costituzionale del 1948.
Il diritto del lavoro ed il diritto di famiglia
sono protagonisti di radicali riforme, le quali
offrono vigenza e giustiziabilità a istanze politiche e culturali quali l’eguaglianza fra uomo e
donna (ex articolo secondo della Costituzione;
ai sensi del quale, è bene ricordarlo, “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alle legge, senza distinzioni di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”), e
la reale e diretta partecipazione dei lavoratori
alla gestione della vita economica (va anche qui
rammentato che il dettato costituzionale prevede nella parte dedicata ai Principi fondamentali, “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale
del paese”, così all’articolo 3, comma secondo).
La nuova rappresentazione giuridica della
condizione femminile e di quella dei lavoratori ritrova legittimità all’interno di una diversa
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
lettura dei valori costituzionali che allora andava affermandosi. Solo per inciso va accennato
che il testo della carta costituzionale è rimasto
(per ciò che concerne i Principi fondamentali e
la Parte prima, Diritti e doveri dei cittadini) inalterato; le nuove rappresentazioni giuridiche a
cui sopra si è fatto cenno, che taluni potrebbero anche definire come più consone agli allora valori sociali radicati in una cospicua parte
della società italiana (si pensi all’esito del cosiddetto referendum sul divorzio avvenuto nel
1972; fu quella la prima volta in cui lo strumento referendario usci con prepotenza dalla mera
lettera della Costituzione dove giaceva inerte
da ventiquattro anni), hanno potuto sostituirsi alle precedenti a seguito di un diversa interpretazione del dettato costituzionale e, più in
generale, del corpus normativo vigente, tanto
da far palesare, proprio negli anni Settanta, un
nuovo e diverso ordinamento giuridico.
All’interno di un contesto socio-culturale allora dominante e fortemente proiettato verso
radicali innovazioni, la centralità della persona umana, da grazioso orpello contenuto nel
testo costituzionale, diviene momento costitutivo dell’ordinamento giuridico.
Va ancora richiamato che l’articolo 3, comma secondo della Costituzione recita nella sua
interezza: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.
La Repubblica pertanto si caratterizzerebbe,
secondo una certa lettura della Carta, essenzialmente per il compito rimozionale che essa
solennemente si assume, per essere la stessa il
volano, il momento propulsivo di un processo
di coinvolgimento sempre più complessivo di
tutti i cittadini nella vita economica e sociale
del paese. La partecipazione dei cittadini deve
essere stimolata dalle articolazioni di cui la
Repubblica si compone attraverso la progressiva, ma inarrestabile rimozione di qualsiasi
ostacolo si frapponga al pieno sviluppo dell’essere umano, considerato singolarmente, oppure, come ben evidenziato all’articolo 2 del
150
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
testo, “nelle formazioni sociali”. Il venir meno
a questo compito, che porterebbe a palesare la
persona umana non più come fine in sé, bensì
quale strumento funzionale al perseguimento di scopi che la travalicano, determinerebbe
una grave crisi di legittimità; la Repubblica
cessando di essere il fulcro su cui si fonda la
promozione della persona umana, rimarrebbe
contenitore formale di istituzioni il cui operato sarebbe privo di ogni riferimento al supremo valore repubblicano.
In questo senso può essere letta la disposizione contenuta nell’articolo 139 del dettato:
“la forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale”. Giova rammentare come la Corte costituzionale abbia riconosciuto che “la Costituzione italiana contiene
alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto
essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali
sono tanto i principi che la stessa Costituzione
esplicitamente prevede come limiti assoluti
al potere di revisione costituzionale, quale la
forma repubblicana, quanto i principi che, pur
non essendo espressamente menzionati fra
quelli non assoggettabili al procedimento di
revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la
Costituzione italiana”, così la sentenza n. 1146
del 15 dicembre del 1988.
2. L’incisività dei valori sociali sull’ordinamento giuridico
Il lento modificarsi dottrinale e giurisprudenziale della materia lavorista (il diritto del
lavoro ed il diritto sindacale) nell’arco del decennio che ha preceduto lo Statuto del 1970
(legge n. 300 del 20 maggio 1970, Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), ed il profondo
rinnovamento dell’istituto familiare investito,
sempre nel 1970 (legge n. 898 del 1° dicembre
1970, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), da una provvedimento legislativo che
lo libera delle ultime vestigia sacrali, testimoniano come istanze sociali rappresentative di
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
valori sociali emergenti abbiano potuto incidere sull’ordinamento giuridico.
Anche una differente lettura del testo del
comma secondo dell’articolo 3 della Costituzione permette, sia nel campo legislativo che
in quello giurisprudenziale (inteso nella sua
duplice accezione di giurisdizione ordinaria e
di giurisdizione costituzionale), di avviare un
riposizionamento della qualificazione giuridica di status soggettivi e di quotidiani comportamenti posti in essere dai soggetti giuridici.
Il diritto di famiglia ritroverà nuova regolamentazione di lì a poco con al legge n. 151 del 19
maggio 1975, Riforma del diritto di famiglia; tale
legge, nel modulare diarchiamente la gestione
di questa società naturale, attraverso il riconoscimento della parità fra i coniugi (riconoscimento che giungerà a definita completezza con
la legge n. 218 del 31 maggio 1995, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), dà
effettivo vigore e giustiziabilità, sottraendolo
all’eterea validità formale, al principio di eguaglianza fra i sessi, contenuto sin dal 1948 nel
dettato costituzionale all’articolo 3, comma primo. Con tale, ancor oggi discussa, disposizione
legislativa, la Repubblica rimuove un ostacolo
(la primazia in famiglia del coniuge maschio
titolare dalla patria potestà) al pieno sviluppo
della persona umana, in questo caso il coniuge femmina che viene tolto, nell’ordinamento
giuridico, da una condizione di minorità.
Oltre alle già richiamate riforme in ambito
lavoristico e familiare, pare utile qui ricordare,
al fine di rimarcare il processo di riposizionamento dell’ordinamento giuridico avuto riguardo ai valori sociali (riposizionamento determinato da un fatto indubitabile: dalle stesse
disposizioni costituzionali sono state tratte
delle norme di contenuto diverso da quelle che
hanno sovrainteso la vita giuridica dei primi
cinque lustri di vita della Repubblica), alcuni
interventi epocali sull’insieme legislativo italiano. In questa sede non possono che essere
richiamati sotto forma di semplice elencazione.
Nel 1969 la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 3 dicembre porta all’abrogazione integrale, in quanto non conformi
con i principi della Costituzione, degli articoli
151
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
559 (Adulterio) e 560 (Concubinato) del Codice
penale (l’articolo 559 era già stato oggetto di
sindacato costituzionale l’anno precedente
quanto la Corte ne aveva abrogato i primi due
commi, in quanto non conformi al principio
di eguaglianza fra i sessi); la legge n. 194 del
22 maggio 1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della
gravidanza) abroga l’articolo 553 (Incitamento a
pratiche contro la procreazione). Bisogna attendere il 1981 perché la legge n. 442 del 5 agosto di quell’anno abroghi nel Codice penale il
tristemente famoso articolo 587 (Omicidio e lesione personale a causa d’onore) ed il forse meno
noto, ma sicuramente altrettanto infamante
per la società italiana, articolo 544, ai sensi
del quale alcuni reati contenuti nel Titolo del
Codice penale riguardante i delitti contro la
moralità pubblica ed il buon costume, fra i quali
quelli di cui agli articoli 519 (Violenza carnale),
521 (Atti di libidine violenti), 522 (Ratto a fine di
matrimonio), 523 (Ratto a fine di libidine), 524
(Ratto di persona minore degli anni quattordici o
inferma, a fine di libidine o di matrimonio) e 530
(Corruzione di minori, ma in realtà, stando alla
descrizione della fattispecie, “atti di libidine
su persona o in presenza di persona minore
degli anni sedici”), si estinguono con il così
detto matrimonio riparatore; citiamo testualmente: “il matrimonio, che l’autore del reato
contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi
nel reato medesimo”.
Un’ultima annotazione; è del 1996 (legge n.
66 del 15 febbraio) la disposizione legislativa
che transita la violenza sessuale nel Titolo XII
Dei delitti contro la persona, sottraendola alla
precedente collocazione nel Titolo IX Dei delitti
contro la moralità pubblica e il buon costume.
3. I reietti e lo sviluppo della persona
umana
In un contesto contrassegnato da profondi
cambiamenti sociali e culturali si collocano anche gli interventi legislativi che vedono protagonisti i reietti della società: i matti e i delinquenti.
All’interno di una prospettiva che si muove
lungo l’asse del “pieno sviluppo della persona
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
umana” non appare corretto disgiungere la
riforma manicomiale da quella che ha investito l’istituzione carceraria. Non tanto perché,
come in quegli anni lo stesso Basaglia, sulla
scorta di Goffman, ci rammentava che entrambe sono istituzioni totali, oppure perché la
prima, la riforma dell’ordinamento penitenziario, precede di poco la seconda, l’intervento
in ambito manicomiale, quanto per la constatazione che l’intervento legislativo, il quale si
incunea in questi luoghi di sofferenza e privazione modificandone l’aspetto e la finalità, è
in entrambi i casi guidato da quella riscoperta
del assoluto valore della persona umana, a cui
fa esplicito riferimento il richiamato articolo
3 della Costituzione.
Intento del legislatore è di far entrare la
persona umana nell’ambito del trattamento
psichiatrico e nel campo dell’esecuzione della
pena; si palesa cioè la possibilità di sradicare
quei cancelli che separavano totalmente gli
ospiti dei manicomi e delle carceri dalla società dei “normali” impedendo ogni contatto
fra i relegati nell’istituzione totale e la società
esterna e determinando con ciò la creazione di
due mondi incomunicabili: il modo della normalità e quello della devianza.
Normalità e devianza costituivano i due
esclusivi poli di aggregazione della popolazione; strutturandosi concettualmente in un aut
aut priva di soluzione di continuità la coppia
dicotomica normale/deviante erigeva fra i due
punti una barriera invalicabile che assumeva la
veste di un confine fra il sano complesso sociale
e la massa disaggregata degli individui malati.
Si può con una certa sicurezza affermare che
sia nel carcere, che nei manicomi, prima degli
interventi legislativi del 26 luglio 1975, legge n.
354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà, e del 13 maggio 1978, legge n. 180 Accertamenti sanitari volontari e obbligatori, la persona
umana fosse considerata un estraneo, una presenza indesiderata. Il suo sviluppo, da attuarsi
attraverso la rimozione di quegli ostacoli, che
nel limitare la sua partecipazione alla vita sociale ne hanno determinato l’internamento,
non pareva essere compito né delle istituzioni
carcerarie né di quelle manicomiali, entrambe
152
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
rette da disposizioni legislative radicate in un
ambito valoriale incentrato sulla pericolosità
sociale dei reclusi (per quanto concerne l’ambito manicomiale il punto di riferimento era
ancora la legge n. 36 del 14 febbraio 1904 Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e
cura degli alienati, a cui segue la legge n. 431 del
18 marzo 1968 in materia di Accertamenti sanitari volontari e obbligatori; il sistema carcerario
ritrovava la propria regolamentazione nel Codice di procedura penale del 1933).
Si è detto che il trattamento carcerario e
manicomiale si sviluppava avuto riguardo
ad una particolare rappresentazione dell’essere umano; questa era tratteggiata sulla sua
pericolosità sociale, sul suo essere oggettivo
elemento di disturbo per una normale vita sociale, quella, per l’appunto, che si sviluppava
fuori della istituzioni totali.
Il potenziale di pericolosità rappresentato dal
deviante (matto o delinquente che fosse) era la
chiave di volta di ogni intervento sullo stesso.
In proposito, l’articolo primo della legge manicomiale del 1904 stabilisce al comma
primo: “debbono essere custodite e curate nei
manicomi le persone affette per qualunque
causa da alienazione mentale, quando siano
pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere
convenientemente custodite e curate fuorché
nei manicomi”. Che il punto di riferimento sia
principalmente la sicurezza sociale e non la
cura dell’infermo è bene evidenziato dal comma primo dell’articolo 2 della predetta legge, ai
sensi del quale “l’ammissione degli alienati nei
manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, è può esserlo da chiunque altro
nell’interesse degli infermi e della società”. La
presenza dell’alienato si configura, all’interno
di questo quadro, principalmente come una
questione di ordine pubblico, più che di sofferenza personale; ciò è comprovato dal fatto che,
ai sensi del comma terzo del su citato articolo, “l’autorità locale di pubblica sicurezza può,
in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via
provvisoria, in base a certificato medico”. Ciò
che qui preme rilevare non è tanto la possibile arbitrarietà di un ricovero in una struttura
manicomiale, quanto la sua valenza di provveDigressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
dimento relativo al mantenimento dell’ordine
pubblico.
In questa prospettiva, la sicurezza dei normali si fonda principalmente sulla esclusionesegregazione di chi normale non è e di colui il
quale, sulla scorta di una classificazione antropometrica di sapore attuariale, è oggettivamente una fonte di rischio sociale. In questo senso,
sono le istituzioni totali e non le politiche sociali gli strumenti con cui la sana società affronta,
isola e sconfigge coloro che le sono ostili.
4. La devianza quale condizione per
l’esclusione dalla polis
Da un punto di vista prettamente giuridico
appare interessante notare come la certificazione della malattia mentale, nella prospettiva
sopra tratteggiata, sia semplicemente considerata dall’ordinamento il presupposto per la
incapacità di agire, per la sospensione o soppressione dello status di persona socialmente
ed economicamente attiva; l’incapace non partecipa, infatti, alla vita della polis. L’incapacità
giuridica istituzionalizza una condizione di
assoluta minorità, di totale dipendenza dagli
altri; vale la pena di ribadire che colui il quale
dagli altri dipende non è più il soggetto delle
sue azione, ma l’oggetto delle azioni altrui; è
rappresentato, quindi, come una cosa.
Parimenti al matto, anche il delinquente, a
fronte di determinati reati ritenuti dal legislatore particolarmente pericolosi per la società,
è reso incapace di interagire giuridicamente
con la società; è da questa, per così dire, annientato come persona umana, ridotto a mero
organismo biologico che vegeta sotto lo stretto
controllo della istituzione carceraria (oppure,
sul versante del malato di mente, relegato dietro le sbarre del manicomio).
Malato e delinquente vengono spersonalizzati e desoggettivati; così rappresentati vengono relegati in case chiuse, chiuse dall’interno
in modo che il recluso non possa uscire e contaminare con la sua presenza i sani, chiuse
dall’esterno perché nessuna persona normale e sana vi possa entrare. La casa chiusa deve
suscitare reazioni claustrofobiche e quindi di
repulsione, soprattutto all’elemento sano del153
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
la società, la reazione dell’internato poco conta all’interno di questa prospettiva, in quanto
incapace è un dovere sociale rinchiuderlo e
renderlo innocuo.
In proposito va richiamata la stesura originaria dell’articolo 414 del Codice civile. Va sottolineato che tale articolo, nonché la stessa rubricazione del Titolo XII in cui è inserito, venne
modificato dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo alla istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414,
417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni, nonché relative
norme di attuazione, di coordinamento e finali.
L’articolo sopra richiamato disponeva che
coloro “i quali si trovano in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi, devono essere
interdetti”; la parte in corsivo è stata sostituita
dal legislatore del 2004 e attualmente si legge
“sono interdetti quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione”. Va rilevato che l’istituto dell’interdizione, dopo la
novella del 2004, non si pone più come finalità la tutela della società dall’infermo di mente,
piuttosto la tutela dell’infermo; non sono più
gli altri (i sani) ad essere protetti dall’infermo,
ma l’infermo dagli altri cosiddetti sani. Qui è
centrale la protezione dell’infermo, l’assicuragli nelle forme più consone la adeguata protezione di cui necessita a causa del suo stato di
non stabilità mentale. Egli riacquista dignità
giuridica, ridiventa soggetto giuridico anche
se sottoposto a restrizioni, ma queste sono
funzionali al suo completo reinserimento nella società non al suo totale isolamento dalla
stessa (si pensi all’abrogato, dalla legge 180 del
1978, articolo 420 del Codice civile Internamento definitivo in manicomio, ai sensi del quale “la
nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva
la custodia di una persona inferma di mente
in un manicomio o in un altro istituto di cura
o in una casa privata. In tal caso, se la istanza
di interdizione non è stata proposta dalle altre
persone indicate nell’articolo 417, è proposta
dal pubblico ministero”).
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
5. Sulla genericità della terminologia
usata nella legislazione in materia
Dopo questa digressione, che ci proietta in
una dimensione rappresentativa del matto
del tutto diversa da quella dominante l’ordinamento giuridico dopo della cosiddetta riforma
Basaglia, è bene soffermare l’attenzione su un
fatto di non secondaria importanza, di cui si è
fatto cenno nel paragrafo precedente. Le disposizioni legislative in materia, segnatamente
quelle racchiuse nel Titolo XII del Libro primo
del Codice civile, sono redatte, da un punto di
vista medico-psichiatrico, con un linguaggio
non tecnico. A tale proposito va riconosciuto
come il legislatore del 1942 abbia voluto ricomprendere sotto le generiche dizioni di “infermità mentale” e di “incapacità di intendere e
volere”, ricorrenti nelle disposizioni contenute
dal Titolo in oggetto, sia le patologie psichiche
comportanti alterazioni del senso di identità
(quali la mancanza di coerenza, della propria
identità, dell’autostima) e del recepimento della realtà esterna (quali deliri, allucinazioni),
che di cosiddetti disturbi della personalità, i
quali non necessariamente sconfinano in psicosi, nonché, ciò segnatamente all’articolo 415,
l’abuso di bevande alcoliche e di stupefacenti.
Le generiche dizioni in oggetto vengono nel
linguaggio del legislatore solo apparentemente graduate e, quindi, ricondotte ai diversi stati
di patologia psichica o di disturbo della personalità o ancora di etilismo oppure di tossicodipendenza, e si accompagnano ad altre altrettanto generiche espressioni quali, ad esempio,
il richiamo, nel primo comma dell’articolo 415,
a “lo stato [di infermità mentale] non talmente
grave da far luogo all’interdizione”.
Il legislatore, utilizzando anche in questo
contesto clausole generali o concetti giuridici
indeterminati, che di si voglia, offre all’interprete discrezionalità nella scelta dei provvedimenti da adottare a fronte del caso concreto.
Tale discrezionalità non essendo vincolata da
precise delimitazioni offerte dalla scienza medica, che del resto paiono avulse dalla ratio che
ha accompagnato la riforma Basaglia, non può
che basarsi, al fine di non apparire arbitraria, su
più generali valori sociali che informano l’ordi154
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
namento giuridico; primo fra questi la rappresentazione della persona umana e la sua collocazione all’interno di una tassonomia valoriale.
Se, come più volte richiamato, in un passato anche recente, tali espressioni erano funzionali esclusivamente alla dichiarazione di interdizione o di inabilità dell’infermo di mente,
tanto da poter escludere un ruolo attivo dell’ordinamento nel recupero sociale del matto, ora
tale passività è rigettata e l’ordinamento deve
farsi carico di ricercare per ogni singolo caso la
soluzione più adatta al fine di favorire in ognuno il pieno sviluppo della propria personalità.
La sopra richiamata legga n. 6 del 2004 non
a caso individua la figura dell’amministratore
di sostegno quale supporto, meno traumatico
ed invasivo della tutela e della curatela, per la
persona in difficoltà.
6. La legge 180 e la rottura con le istituzioni totali
Nel voler sia pur brevemente richiamare i
tratti salienti della legge 180 del 1978, va sicuramente evidenziato come il testo legislativo
all’articolo primo voglia richiamarsi esplicitamente a valori e diritti costituzionali, che le
precedenti normative in materia, pur trovandosi ad operare in un contesto politico e giuridico informato dalla Costituzione repubblicana, avevano di fatto sottaciuto e ciò, è bene
ribadirlo, non tanto a causa d’un, per così dire,
conservatorismo dei funzionari pubblici preposti a tali compiti, piuttosto per una diversa
interpretazione del dettato costituzione.
Il primo comma dell’articolo 1, proprio per
voler rimarcare la rottura con la passata impostazione informata ancora dalla legge del 1904,
ribadisce, senza alcuna relazione specifica con
le patologie psichiche, che “gli accertamenti e i
trattamenti sanitari sono volontari”. Nel far ciò
il legislatore ordinario vuole offrire vigore al
principio costituzionale contenuto nell’articolo
32 del dettato, la libertà di accettare o rifiutare il
trattamento sanitario, esaltando la volontarietà del trattamento a discapito della sua obbligatorietà, che è in ogni caso prevista dal testo costituzionale nel momento in cui l’obbligo può
essere derivato da una “disposizione di legge”.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
Appare evidente che il bersaglio del legislatore
ordinario non è tanto rappresentato dalla generale tutela della salute pubblica, quanto dal
sistema coattivo posto in essere dalla legislazione precedente in materia di internamento
degli alienati. È palese la contraddizione della
disposizione se confrontata con le disposizioni
costituzionali e con quelle che, nella stessa legge, la seguono (essa infatti come evidenziato
cozza contro il comma secondo dell’articolo 32
della Costituzione, che pone accanto ai trattamenti volontari quelli stabiliti dalla legge come
obbligatori, ma è in insanabile contraddizione
con il comma seguente dello stesso articolo,
che fa riferimento esplicito a “gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori”), ma acquista significato valoriale, di principio, se confrontata con quanto disposto dal comma terzo
dello stesso articolo, per il quale “nel corso del
trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto a comunicare con chi ritenga
opportuno”. Ovvero la ratio del comma primo
non va ricercata in una assurda ipotesi negazionistica del trattamento sanitario obbligatorio, quanto nella affermazione della intrinseca
antigiuridicità della segregazione del malato
di mente, del suo isolarlo completamente dal
mondo esterno rinchiudendolo all’interno
della istituzione totale.
La spersonalizzazione, centrale nelle istituzioni totali, qui va bandita; il paziente è un
soggetto da coinvolgere nel trattamento, non
si rappresenta più come un oggetto di trattamento, un passivo organismo biologico che
altri custodiranno a causa della sua pericolosità; il soggetto deve essere compartecipe al trattamento, infatti, al comma quinto si esplicita
come “gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori […] devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione di chi vi è obbligato”.
La volontarietà del trattamento in realtà sottende, al di là del mero significato delle parole,
ad una forte istanza di deistituzionalizzazione
dell’intervento sul malato di mente, deistituzionalizzazione che si sostanzia in una sorta
di svuotamento del manicomio nella società,
perché i matti sono parte della società (se non
addirittura la società stessa, come suggerisce
155
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
l’ossimoro proposto nel 1971 da Franco Basaglia e Franca Ongaro quale titolo al loro studio su l’ideologia del controllo sociale: la maggioranza deviante).
7. Oltre il recinto della istituzione
L’intera legge è pervasa da questo spirito; l’uso
di un linguaggio “burocratico”, proprio all’austerità del legislatore, non impedisce di coglie in
questa una volontà irrefrenabile volta all’abbattimento delle mura della istituzione manicomiale.
Tale tensione è immediatamente riscontrabile nell’articolo 2 della legge; al comma secondo infatti leggiamo un “trattamento sanitario
obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiatriche tali
da richiedere urgenti interventi terapeutici, se
gli stessi non vengano accettati dall’infermo e
se non vi siano le condizioni e le circostanze
che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”.
Sicché, avuto riguardo alla disposizione, di
norma l’intervento terapeutico va condotto in
strutture extraospedaliere, fuori dalla mura del
manicomio. Questa è la via normale, quotidiana di trattamento, solo in ben circoscritti ed
eccezionali casi sarà legittimo continuare con
un trattamento intra-murario, in tutti gli altri il
paziente va immerso nella società, vive in mezzo agli altri, tanto da non poter più riscontrare
quella separazione fra il matto ed il normale che
caratterizzava invece la precedente prospettiva.
A conferma di quanto sopra, il comma
primo dell’articolo 6 stabilisce che “gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati di
norma dai servizi e presidi psichiatrici extra
ospedalieri”.
Lapidario in merito appare il comma sesto
dell’articolo 7, che racchiude, pur nella sua
concisione, la storia e le aspirazioni di più
di un decennio di psichiatria democratica: “è
in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
sezioni neurologiche o neuropsichiatriche”.
La degenza ospedaliera è, all’interno di questa prospettiva, l’estrema ratio e, a differenza
della precedente normativa, il ricovero è sottoposto ad una procedura per così dire aggravata
al fine di tutelare il soggetto debole. Tale procedura viene esplicitata all’articolo 3 e coinvolge, come noto, oltre al personale medico della
struttura sanitaria pubblica, il sindaco ed il
giudice tutelare. Ulteriori aggravi sono previsti
dalla normativa qualora il trattamento obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno.
In merito alla tutela del malato di mente,
centrale appare senz’ombra di dubbio il comma primo dell’articolo 5 (Tutela giurisdizionale), a norma del quale “chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi
abbia interesse, può proporre al tribunale competente per il territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”.
La disposizione ora richiamata fa sì che
sia il matto in prima persona ad assumere la
propria tutela rivendicando i propri diritti;
la situazione di sofferenza che lo investe non
implica, come per la precedente normativa, la
perdita della sua dignità e della sua capacità di
agire giuridicamente.
Egli è persona, non più oggetto di trattamento; la struttura sanitaria, in quanto articolazione di quella Repubblica informata
dall’articolo 3 del dettato costituzionale, è
protesa non alla custodia, alla segregazione
del malato, alla separazione dal suo contesto
sociale, bensì alla rimozione degli ostacoli che
si frappongono al suo pieno sviluppo.
156
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Considerazioni intorno al rapporto fra
pena e misura di sicurezza personale nel
processo di rieducazione del reo
issn 2035-584x
’espressione misura di sicurezza riporta alla
mente dell’osservatore di questioni giuridiche la ben nota teoria posta in essere dalla
Scuola positiva, che vede in Enrico Ferri, a cavallo fra Otto e Novecento, il suo indiscusso
animatore. La misura di sicurezza è qui, come
nel vigente ordinamento (vedi articoli 202 e
203 Codice penale), correlata alla pericolosità
sociale del reo. Per una autorevole fonte, infatti, le misure di sicurezza “storicamente si
ricollegano alle istanze della Scuola positiva
rivolte a sostituire il concetto di responsabilità con quello di pericolosità e quello di pena
con quello di sanzione criminale avente uno
scopo di difesa sociale”1.
Va effettuato immediatamente un distinguo al fine di non far palesare come specie
dello stesso genere ciò che appartiene a mondi diversi; se, infatti, il rapporto fra misura di
sicurezza e pericolosità sociale collega la riflessione dottrinaria della Scuola positiva con
il vigente ordinamento penale, le prospettive
che sottendono l’opera di ordinamento penale
sono sostanzialmente divergenti.
Per un lato, la Scuola positiva ritiene che il
presupposto soggettivo della pena sia la pericolosità sociale e non la colpevolezza; è, di fatti, la
pericolosità criminale “la causa giuridica, il titolo giuridico per l’applicazione della sanzione”2,
per altro, la stessa prospettiva ritiene che la
pena, erogata a fronte di un soggetto pericoloso
socialmente, debba svolgere funzioni essenzialmente di prevenzione speciale, ovvero mutare
la personalità del soggetto oppure eliminarlo
dal contesto sociale. Al fine di perseguire questi
scopi, la pena si deve configurare come adatta
al precipuo intervento sul reo per far cessare il
suo stato di pericolosità e deve altresì caratterizzarsi per la sua indeterminatezza, dato che
deve perdurare sino alla cessazione dello stato
di pericolosità del condannato3.
Infatti, se qui si richiama la prospettiva propria ad Enrico Ferri ed alla Scuola positiva, è
bene rammentarsi come la stessa, nel volere
porre in essere un Codice penale basato sul delinquente e non sul delitto, il cosiddetto diritto
penale dell’autore, concentra tutte le sue forze
sull’idea di pericolosità sociale e non sull’imputabilità, requisito formale che viene aggirato
con la presupposizione di una responsabilità
legale, la quale andrebbe a sostituire, in questa
prospettiva, la responsabilità morale propria
alla Scuola classica, fondata sul binomio colpapena, che pare invece informare le politiche
penali poste in essere dall’Italia repubblicana,
ove la pena, la sua erogazione e la sua esecuzione, è imprescindibilmente legata alla colpa,
meglio, alla colpevolezza dell’imputato.
Ciò a maggior ragione avviene nella sua
fase di esecuzione, dato che la pena mira esclusivamente, nell’Italia repubblicana, alla rieducazione del reo; ma, come ribadisce più volte
la Corte costituzionale, emblematica appare
la sentenza n. 364 del marzo del 1988, non vi
può essere rieducazione se non in presenza di
una colpa. La Corte sottolinea infatti, che “collegandosi il primo al terzo comma dell’articolo
27 della Costituzione agevolmente si scorge
che, comunque s’intenda la funzione rieducativa [… della pena …], essa postula almeno la
colpa dell’agente in relazione agli elementi più
significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la «rieducazione» di chi, non essendo almeno «in colpa» (rispetto al fatto) non
ha, certo, «bisogno» di essere «rieducato»”.
1 P. Nuvolone, sub voce Misure di prevenzione e misure di
sicurezza, in Enciclopedia del diritto, p. 650.
2 F. Grispini, Diritto penale italiano, vol. I, Milano, 1947,
p. VIII.
3 Vedi E. Ferri, Relazione al Progetto di Codice penale italiano, Milano, 1921, pp. 38 e 76.
1. Pericolosità sociale versus colpevolezza; 2. Il doppio binario: pena e misura di sicurezza; 3. Sulla funzione rimozionale della
Repubblica: formazione o educazione alla persona umana?; 4. Pena e misura di sicurezza fra
soggetti capaci e soggetti incapaci; 5. Misura di
sicurezza come alternativa alla rieducazione;
6. Lo straniero e la funzione preventiva della
misura di sicurezza; 7. Nota conclusiva.
1. Pericolosità sociale versus colpevolezza
L
Digressioni sull’esecuzione della pena
157
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Va altresì evidenziato come la Corte, nella
stessa sentenza, rilevi che “il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto
anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che
sarà chiamato a rispondere penalmente solo
per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate”; viene
pertanto ribadita la vigenza nell’ordinamento
italiano del binomio pena-colpa, che certe prospettive teoriche tendono a negare.
Ove non sia possibile muovere un rimprovero all’imputato, ovvero in assenza dell’elemento soggettivo del reato (la colpevolezza), la
pena inflitta non produrrebbe effetti rieducativi, si paleserebbe esclusivamente quale momento afflittivo. Infatti, per il giudice costituzionale, “soltanto quando alla pena venisse
assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò è sicuramente da escludersi nel
nostro sistema costituzionale, data la grave
strumentalizzazione che subirebbe la persona
umana) potrebbe configurarsi come legittima
una responsabilità penale per fatti non riconducibili […] alla predetta colpa dell’agente”.
Una prospettiva retribuzionistica o preventiva, che indirizzi l’erogazione e l’esecuzione
della pena, non è concepibile all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: è sicuramente da
escludersi, così si esprime la Corte costituzionale.
Ancora la Corte sottolinea che “dal collegamento
tra il primo e terzo comma dell’articolo 27 della
Costituzione risulta […] l’illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile
contrasto con i (od indifferenza ai) valori della
convivenza, espressi dalle norme penali”
Tutto ciò è accennato, per rammentare che
l’ordinamento giuridico italiano, avuto riguardo alla esperienza penalistica, si fonda su un
legame inscindibile, che collega il fatto criminoso, esplicitamente previsto nelle fattispecie
astratte componenti la parte speciale del Codice, ad una pena derivante dalla imputabilità
dell’agente e dalla sua colpevolezza e finalizzata, la pena, alla rieducazione del reo.
In proposito della stretta correlazione fra
la colpevolezza e la sanzione penale, la Corte
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
così si esprime: “per precisare ancor meglio
l’indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale
ricordare non solo che tal sistema pone al
vertice della scala dei valori la persona umana
(che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata)
ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d’attuare compiutamente la funzione di garanzia
assoluta del principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su
«congrui» elementi subiettivi”.
Il giudizio verte dunque sulla antigiuridicità di
un fatto, sull’imputabilità dell’agente e sulla sua
colpevolezza; da questo giudizio deriva, se l’imputato non è prosciolto, l’erogazione di una pena
finalizzata esclusivamente alla rieducazione.
2. Il doppio binario: pena e misura di sicurezza
Fin qui per quanto concerne la pena ex articolo 27 della Costituzione, ma, come evidente,
accanto alle pene si collocano le misure di sicurezza, da prima, dal 1930, ai sensi del Codice
penale, poi, dal 1948, ai sensi articolo 25, comma terzo del dettato costituzionale.
L’ordinamento giuridico repubblicano eredita da quello del Regno la misura di sicurezza
e poco, se non nulla, rileva che nel codice del
1930 “il legislatore si preoccupa fondamentalmente di costruire un sistema penale conforme alla realtà istituzionale costituita dal
nuovo regime autoritario e caratterizzato da
una rigida difesa sociale per assicurare la prevalenza degli interessi generali su quelli particolari e la subordinazione incondizionata del
singolo alla collettività”4. La questione da affrontare è quella relativa alla armonizzazione
della misure di sicurezza, in vero formalmente
recepite nel testo costituzionale, con i principi
dell’ordinamento giuridico vigente, informati
dallo stesso testo costituzionale. Sicché si tratta di tentare di leggere le misure di sicurezza
ora vigenti non con la lente dello storico del
diritto, alla luce della loro origine storico-poli4 E. Musco, sub voce Misure di sicurezza, in Enciclopedia
giuridica Treccani, p. 1.
158
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
tica, piuttosto con l’intento di coglierne la loro
compatibilità con l’attuale assetto giuridicoistituzionale. In definitiva osservare e giustificare, fin dove ciò appare possibile, il doppio
binario (pena e misura di sicurezza) presente
nell’ordinamento italiano.
L’uso dell’espressione del doppio binario appare correlata alla constatazione che, in prima
istanza, pena e misura di sicurezza assolvano
a compiti diversi ed abbiano differenti fonti.
Per quanto concerne il primo aspetto si rileva come in generale le misure in questione
“ontologicamente non possano considerarsi
sanzioni penali, anche se intervengono dopo
il delitto […] esse si ricollegano ad un presupposto diverso [… da quello della pena, e cioè ad
] una situazione che lascia ragionevolmente
prevedere che uno o più individui commetteranno delitti”, e “in vero, l’applicazione delle
misure di sicurezza non discende dall’accertamento del reato, che è una semplice premessa
storica, ma dall’accertamento di una situazione soggettiva di pericolosità criminale”5. Sicché in questa prospettiva, obiettivo principale
della misura erogata al soggetto socialmente
pericoloso, è l’inibizione della recidiva, ovvero di un altro attentato a beni ed interessi
giuridicamente protetti. Qui l’aspetto prevenzionistico è sicuramente esaltato; infatti, se
per prevenire un’azione criminosa si sottopone il soggetto ad un processo di rieducazione,
quest’ultima è infatti subordinata all’obiettivo da raggiungere, è misura, per così dire,
operativa che potrebbe essere sostituita, se
ciò apparisse più proficuo rispetto alla meta
da conseguire, con altre misure di sicurezza
personali, come l’isolamento del soggetto dal
contesto sociale, il suo internamento.
Ma come appare evidente, questa prospettiva può reggersi nell’attuale assetto valoriale che
informa l’esperienza giuridica solo attraverso
una operazione di natura formale: ovvero, rovesciando specularmente la rappresentazione
del rapporto pena misura precedente all’attuale assetto costituzionale, attribuendo alla pena
funzioni rieducative e ascrivendo alla misura
di sicurezza compiti di difesa sociale, i quali
5 P. Nuvolone, sub voce Misure di prevenzione e misure di
sicurezza, cit., p. 633 e 634.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
però potrebbero farla palesare come misura repressiva ed emarginativa, se non afflittiva6.
Sul versante della fonte, in passato si è sostenuto che le misure di sicurezza avessero natura amministrativa e non giurisdizionale; tale
tesi, se accolta, permetterebbe di salvaguardare
formalmente la attuale natura rieducativa della sanzione penale promanante dalla autorità
giurisdizionale, evitando di inquinarla con le
tendenze prevenzionistiche presenti nelle misure di sicurezza amministrativamente poste.
Ma questa strada è impercorribile; in dottrina si è rilevato, infatti, che, “dopo l’entrata in vigore della Costituzione […] l’applicazione delle
misure di prevenzione e, in genere, delle misure di sicurezza deve ritenersi un atto giurisdizionale. Nel procedimento relativo, infatti, vi è
un conflitto tra il diritto di libertà del cittadino
e la pretesa pubblica preventiva: conflitto che si
svolge davanti all’autorità giudiziaria su di un
piano di parità”7. D’altro canto, la stessa giurisprudenza di Cassazione da tempo riconosce
che pene e misure di sicurezza “sono sanzioni
criminali aventi la stessa natura giurisdizionale ed applicabili con processo giurisdizionale”
(Cass. Pen. 15 luglio 1960). Sulla centralità del
momento giurisdizionale, ove, nel dire e contraddire, si dispiega la difesa dell’imputato, nella erogazione di misure di sicurezza interviene
più volte la Corte costituzionale (sentenze n. 53
del 1968 e n. 74 del 1973).
La teoria del doppio binario ritrova, per tanto, delle indubbie difficoltà nel sorreggersi, e
ciò avuto riguardo alla funzione rieducativa
della sanzione penale. Si potrebbe ipotizzare,
sulla scorta del pensiero di Nuvolone8, la presenza nell’ordinamento di una legalità, per
così dire, repressiva, che si manifesta nel comminare ed erogare la pena, ed una legalità definibile come preventiva, la quale ritroverebbe la
propria attuazione nella misura di sicurezza.
La prima, nel garantire tutela ai beni ed agli
interessi giuridicamente protetti, garantisce
altresì, per tramite della riserva di legge e con
l’istituzione di precise regole procedurali, i
6 Cfr. E. Musco, sub voce Misura di sicurezza, cit., p. 9.
7 Così P. Nuvolone alla sopra richiamata voce Misure di
prevenzione e misure di sicurezza, p. 649.
8 Ibidem, p. 635.
159
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
diritti dell’imputato; la seconda, nel garantire
nuovamente i diritti dell’imputato, ha come
finalità il preservare il contesto societario da
nuovi attacchi, ovvero, per usare le parole di
Nuvolone, “di rendere più difficile all’individuo la possibilità di commettere reati”9.
Il problema è che all’interno dell’attuale
quadro valoriale tratteggiato dalla Costituzione, una ipotetica legalità preventiva, volta cioè
a preservare il contesto sociale dal crimine,
non può assumere connotati prevenzionistici,
né speciali, né generali; su questo punto la
Corte costituzionale appare inequivocabile.
Per tanto, la costituzionalmente legittima misura di sicurezza posta in essere dall’autorità
giurisdizionale competente non potrà che palesarsi quale misura rieducativa.
Appare importante sottolineare che la pena
si palesa quale rieducazione post delictum,
mentre la misura si propone quale rieducazione ante delictum, che ritrova nel reato in proprio antecedente storico, ma non la propria ragione d’essere: questa è determinata dal riconoscimento della pericolosità sociale del reo,
ovvero dalla sua accertata (nel dibattimento,
come la abrogazione della pericolosità sociale
presunta, ovvero dell’articolo 204 del Codice
civile, testimonia) propensione a delinquere.
Tale potrebbe essere la differenza, legittimata dai valori costituzionali, fra la pena e
la misura di sicurezza: l’una, la pena, erogata dopo la commissione di un reato, l’altra, la
misura di sicurezza, erogata in conseguenza
d’una sentenza di condanna, la quale accerti
anche la pericolosità sociale del reo, e finalizzata a prevenire altre infrazioni penalmente
rilevanti. Entrambe hanno però la stessa finalità; la pena, e con questa la misura di sicurezza,
non è reazione sociale, mera retribuzione o prevenzione, è rieducazione, quindi è volta a condurre il reo nell’alveo della piena socialità, per tanto,
a non commettere atti antisociali, in particolare
rieduca alla non commissione di reati.
La distinzione sopra accennata, se vale a
mantenere in piedi una sorta di dualismo
nell’unitario ambito della sanzione penale,
non giustifica certamente il suo permanere
nell’ordinamento giuridico.
9 Ibidem.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
Ciò a maggior ragione in considerazione al
fatto, ben evidenziato dalla sentenza qui richiamata della Corte costituzionale, che entrambe
ritrovano la loro legittimità sostanziale e non
meramente formale (vedi i richiamati articoli
25 e 27 del dettato costituzionale), nell’articolo 3,
al comma secondo, ove si stabilisce che il compito della Repubblica è la rimozione degli ostacoli
i quali si frappongono al pieno sviluppo della
persona umana; pertanto l’azione di rieducazione del reo (persona umana) ha di mira il suo
pieno sviluppo, sia che si tratti di pena oppure di
misura di sicurezza, non la difesa della società.
Questa, la sicurezza, si acquisisce indirettamente, attraverso una opera di rieducazione inserita
all’interno di questo quadro valoriale.
Se le articolazioni con cui ora si palesa la
sanzione penale mirano al pieno sviluppo della persona umana, attraverso la rimozione di
ostacoli e questa rimozione avviene anche con
la rieducazione del reo, allora tali articolazioni appaiono sì costituzionalmente legittime,
ma potrebbero venire ricomposte in un unico
momento rieducativo, riportando la sanzione
penale ad una unitarietà non solo sostanziale
ma anche formale, dato che una distinzione
formale, come quella ora presente nell’ordinamento pare foriera di equivoci.
3. Sulla funzione rimozionale della
Repubblica: formazione o educazione
alla persona umana?
Il richiamo qui effettuato alla persona umana, premette di far cenno ad un altro problema di non secondaria importanza e connesso
con la funzione rimozionale che la Repubblica
si è assunta.
Va evitato, a maggior ragione in un contesto culturale pluralistico, come appare il contesto sociale presente, e ciò con particolare
riguardo al nostro universo di discorso, che
volenti o nolenti ci fa volgere lo sguardo al carcere, presumere di poter effettuare un intervento rieducativo partendo da un preconcetto
modello culturale. Se la rieducazione implica
la risocializzazione questa non può palesarsi,
proprio al fine di non limitare o costringere la
persona umana a forme predefinite, quale for160
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
mazione ad un modello prestabilito. Se ciò avvenisse si correrebbe il rischio di sclerotizzare
una forma ideale, alla quale costringere l’individuo concreto, snaturando la sua personalità
e ponendo in essere un trattamento coercitivo
e non educativo. In questo senso, la tendenza
a ricercare forme ideali a cui ispirare modelli
di trattamento sanzionatorio e solo apparentemente rieducativo, si palesa, come Giuseppe
Bettiol ebbe a sottolineare più di mezzo secolo
fa, come “una forza conservatrice che sclerotizza la giustizia”10.
La meta del processo di rieducazione, da cui
la finalità della sanzione penale, non può essere
un pre-concepito modello di risocializzazione,
da applicarsi aproblematicamente erga omnes;
ciò implicherebbe, ancora per Bettiol, “una meccanica sottomissione” del reo a regole e valori
sociali precostituiti alla sua volontà. L’educazione deve esaltare la dignità della persona umana,
respingendo ogni tentativo di costringerla in
predeterminati modelli comportamentali. In
questo senso, il reo socialmente pericoloso non
deve essere sottoposto ad un trattamento di trasformazione, che è poi il fine a cui tende la prospettiva della difesa sociale; trattamento, che
al di là della etichetta di “rieducativo”, è chiaramente riconducibile a tendenze prevenzionistiche. Nell’ordinamento vigente, di contro, il trattamento è educativo, ovvero volto a ricondurre
il reo non a modelli astratti (o dominanti), ma a
se stesso, ovvero alla sua umana personalità.
In questo differiscono profondamente,
e non solo per una questione di termini, le
istanze proprie alla Scuola positiva dalle politiche penali che vanno poste in essere nella
Repubblica11; il momento chiave qui è ancora
una volta l’interpretazione del comma secondo dell’articolo 3 della Costituzione.
4. Pena e misura di sicurezza fra soggetti capaci e soggetti incapaci
Di norma, nel vigente processo di ordina10 Dal positivismo giuridico alle nuove concezioni del diritto,
ora in Scritti giuridici, vol. II, Padova, 1966, p. 863.
11 Cfr. lo studi di F. Cavalla, La pena come problema. Il superamento della concezione razionalistica della difesa sociale, Padova, 1979.
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
mento penale, la pericolosità sociale del fatto e di
chi lo ha posto in essere rilevano in maniera ben
diversa da come risultano essenziali nella prospettiva solcata dalla Scuola positiva, ove la pericolosità sociale e la conseguente misura di sicurezza si collocano in un quadro informato dalla
responsabilità legale e non dalla colpevolezza.
Di norma, ex articoli 202, 203 e 205 del Codice penale, una misura di sicurezza si accompagna ad una sentenza di condanna che comporti
il riconoscimento della pericolosità sociale del
reo (di cui all’articolo 203 del Codice penale). In
questo caso, e solo in questo caso, la misura di
sicurezza si ricollega e diventa parte integrante del percorso posto in essere della erogazione
della pena e, per tanto, è riconducibile a pieno
titolo al comma terzo dell’articolo 27 del dettato costituzionale, così come lo stesso è stato
più volte esplicitato dalla Corte costituzionale.
Si tratta di un rafforzamento della pressione
rieducativa, che nella unicità della sanzione
penale, ritrova due momenti distinti.
Ciò potrebbe però, come già accennato, palesare il problema della ridondanza, ben noto
ai teorici generali del diritto: se i due termini
designano due processi che tendono allo stesso obiettivo, ovvero denotano la medesima situazione (è il caso dell’omonimia), perché non
unificarli anche lessicalmente già nel momento della sentenza con l’erogazione di una sola
sanzione penale, la quale tenga conto, senza
menzionare la misura di sicurezza, della pericolosità sociale del reo e della necessità di
sottoporlo ad un particolare trattamento rieducativo. Di converso si può anche ipotizzare
che se il legislatore ha voluto nominare e mantenere la pena accanto alla misura di sicurezza
può darsi che le due abbiano finalità diverse;
ecco allora ricomparire il doppio binario e con
questo i possibili equivoci intorno a diverse finalità della pena e della misura di sicurezza.
Va pertanto in questo caso accolta e ribadita
l’istanza più volte emersa in dottrina relativa
al superamento di questo sistema dualistico
con l’istituzionalizzazione di una sanzione penale unitaria, che ribadisca inequivocabilmente l’esclusiva finalità rieducativa della stessa e
ponga fine a fraintendimenti relativi alla sua
funzione e derivanti dalla presenza nell’ordi161
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
namento di pene e di misure. Ma qui siamo di
fronte al caso in cui pena e misura sono contenute in (e derivate da) una sentenza di condanna, pertanto il reo è un soggetto capace e,
quindi, imputabile, ovvero rieducabile.
Diverso, totalmente diverso, appare il caso in
cui una misura di sicurezza si fonda su una sentenza di proscioglimento derivante dall’applicazione dell’articolo 85 del Codice penale; ove
manchi il requisito della imputabilità a fronte
di “un fatto preveduto dalla legge come reato”
non può essere erogata una pena, di cui all’articolo 17 del Codice penale. Ciò non di meno, il
soggetto agente, non imputabile, è sottoposto
a misure di sicurezza ex articolo 215 del Codice
penale anche in assenza di una pena erogata.
Vi è anche il caso in cui la misura di sicurezza, pur venendo erogata in una sentenza di
condanna assieme alla pena, non può essere
ricollegata alla pena stessa; indicativo è in proposito il comma terzo dell’articolo 222, che differisce, nel caso di soggetto cosiddetto semiimputabile, l’esecuzione della pena (rieducativa) “fino a che perduri il ricovero nell’ospedale
psichiatrico”. Sicché questa misura di sicurezza non ha né può avere funzione rieducativa e
si colloca, non essendo riconducibile alla pena,
fuori dall’alveo tracciato dal comma terzo
dell’articolo 27 della Costituzione.
Lungi dal voler sostenere che le misure in
questione, ovvero quelle che ineriscono a soggetti semi-imputabili o non imputabili, presentino aspetti prevenzionistici o retributivistici, va invece evidenziato il loro svilupparsi
a sostegno della persona umana proprio per
essere espletate con quelle finalità di recupero e reinserimento del diverso nella società, le
quali ritrovano nella legge 180 del 1978 il proprio fulcro; la legge manicomiale in questione e la prassi da questa sviluppatasi offrono
un metodo di intervento tale da minimizzarne l’aspetto di misura di difesa sociale, per voler qui richiamare ancora termini propri alla
Scuola positiva, ma non pare che tale prassi
possa eliminarne completamente tale natura
prevenzionistica. La misura di per sé, infatti,
pone il soggetto agente, prosciolto perché non
imputabile, nella condizione di non nuocere,
in quanto sottoposto a controllo. Il soggetto
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
appare qui, più isolato e controllato, che partecipe ad un processo di rieducazione, il quale
se mai è attivato da una determinata prassi di
intervento sul disagio sociale, che non è però
implicita nella misura di sicurezza posta in
essere, al di là del mutamento di alcuni termini (come noto l’articolo 62 dell’Ordinamento
penitenziario, nell’elencare gli istituti preposti
per l’esecuzione della misure di sicurezza, sostituisce il termine di manicomio giudiziale
con quello si ospedale psichiatrico giudiziario); la tensione ad un processo rieducativo,
che informa esplicitamente la pena, la si può
solo supporre nella misura di sicurezza, accostando, alla luce di principi dedotti dal dettato
costituzionale, disposizioni legislative fra loro
diverse, ma accomunate da intenti rimozionistici, quali quelle concernenti l’Ordinamento penitenziario e gli Accertamenti sanitari.
È solo possibile accennare in questa sede
all’importanza dell’articolo 113 del cosiddetto Regolamento penitenziario del 30 giugno del
2000, ove si stabilisce che “l’Amministrazione
penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle
infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza
tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di
trattamento psichiatrico convenuti con altri
servizi psichiatrici territoriali pubblici”.
D’altro canto, risulta indicativa di tendenze non rieducative presenti nelle misure di
sicurezza la seconda parte del comma primo
dell’articolo 222 del Codice penale, ove in caso
l’agente non imputabile venisse prosciolto per
delitti colposi o non particolarmente pericolosi socialmente (con pena massima editale
di due anni), o ancora per contravvenzioni, la
sentenza di proscioglimento non appare accompagnata da alcun esplicito intento terapeutico, che non sia la comunicazione alla Autorità
di pubblica sicurezza, alla quale viene delegato
il controllo del soggetto; è fuori dubbio che il
punto di riferimento del legislatore nel richiamare l’Autorità di pubblica sicurezza non fossero certamente i servizi alla persona.
162
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
5. Misura di sicurezza come alternativa
alla rieducazione
Ma, come si suol dire, vi è dell’altro a confermare l’ipotesi che storna le misure di sicurezza personali dalla finalità rieducativa della
pena e ciò si palesa nel momento in cui non
appare possibile erogare la pena stessa; come
evidente, le misure di sicurezza vanno ascritte
anche al minore non imputabile o al minore
riconosciuto non imputabile (vedi articolo 224
del Codice penale). A tali soggetti, in quanto
incapaci di intendere e di volere (ex articoli 97
e 98 del Codice penale), non può essere erogata una pena; ciò non di meno l’agente, qualora
venga ritenuto pericoloso socialmente, può
essere sottoposto, ex articolo 224 Codice penale, a misure di sicurezza.
In questi casi, e in generale a fronte di soggetti non imputabili, ci troviamo di fronte ad
una pericolosità sociale alla quale non corrisponde una responsabilità/imputabilità penale, in quanto la pericolosità sociale è ascritta ad un soggetto non capace di intendere e di
volere; questa non capacità rende il soggetto
non disponibile alla pena, dato che l’esecuzione della pena è caratterizzata da funzioni
rieducative, che non possono in alcun modo
esplicarsi a fronte di chi è incosciente delle
proprie condizioni di colpa.
Pare utile in proposito richiamare ancora
una volta la giurisprudenza costituzionale dalla sentenza del 1988 in materia di ignoranza
della legge. Per la Corte “trattandosi, appunto,
dell’applicazione d’una pena, da qualunque
teoria s’intenda muovere (eccezione fatta per
quella della prevenzione generale in chiave di
pura deterrenza, che, peraltro, come s’è già avvertito, non può considerarsi legittimamente
utilizzabile per ascrivere una responsabilità
penale) e dovendo la violazione del precetto
essere rimproverabile, l’impossibilità di conoscenza del precetto [… l’affermazione qui va riportata ad una condizione non di ignoranza scusabile,
bensì di incapacità di intendere e volere, che impedisce al soggetto agente di discernere fra comportamenti leciti ed illeciti e di prevederne le conseguenze
…] non ascrivibile alla volontà dell’interessato
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
deve necessariamente escludere la punibilità”.
Nel nostro caso la punibilità è esclusa perché
non può produrre, su un soggetto incapace,
alcun effetto rieducativo, solo effetti afflittivi,
di prevenzione, che, come sottolinea la Corte,
non possono considerarsi legittimi.
L’assenza del cosiddetto elemento soggettivo del reato fa sì che il comportamento criminoso non si costituisca in reato, nel senso
che ad una fattispecie concreta oggettivamente (solo oggettivamente) criminosa, perché
riconducibile a fatti espressamente preveduti
come reato dalle disposizioni legislative, non
corrisponde né la minaccia, né l’erogazione
della pena. La misura di sicurezza ivi comminata (ma è una voce che chiama nel deserto,
dato che il potenziale reo, in quanto incapace,
può forse sentirla, ma non comprenderla) e,
poi, erogata, è pertanto separata da una prospettiva rieducativa dell’agente, dato che questa non può essere posta in atto a fronte di un
soggetto non imputabile perché incapace di
intendere e di volere.
Ci troviamo di fronte a misure di sicurezza
che non possono avere finalità rieducative data
la qualifica di incapace offerta dall’ordinamento, ad esempio, al soggetto minore di quattordici anni d’età, di cui si presume la totale incapacità di intendere e di volere, e al soggetto
compreso fra i quattordici ed i diciotto anni
d’età non ancor capace di intendere e di volere.
A questi soggetti è preclusa l’applicazione
di una pena in quanto oggettivamente, i primi, soggettivamente, i secondi, impossibilitati
ad usufruire di un processo di rieducazione; di
contro, nel caso previsto dagli articoli 98 e 225
del Codice penale, se il secondo soggetto (quello
collocato fra i quattordici ed i diciotto anni d’età)
fosse psicologicamente in grado di partecipare
ad un processo rieducativo, a questo, nelle forme previste dalla legislazione vigente, sarebbe
erogata una pena, alla quale può affiancarsi una
misura di sicurezza. In questo caso, a fronte di
una sentenza di condanna, la misura di sicurezza sarebbe direttamente collegata al, ed informata dal, processo di riabilitazione ascritto
dall’ordinamento all’esecuzione della pena.
Ciò è da escludersi per quanto riguarda la
fattispecie prevista dall’articolo 224 del Codice
163
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
penale; qui la misura di sicurezza non può avere, per le cause sopra accennate, alcuna funzione rieducativa. La misura di sicurezza avrà una
forma altra rispetto alle finalità rieducative e
sarà direttamente legata alla pericolosità sociale del soggetto; appare una misura di difesa sociale che potrà recuperare solo indirettamente
funzione rieducativa per tramite di un trattamento sensibile ai valori della persona umana.
6. Lo straniero e la funzione preventiva
della misura di sicurezza
Che la misura di sicurezza possa acquisire
nell’ordinamento giuridico italiano una connotazione quasi esclusivamente ricollegabile
alla misura di difesa sociale è oltremodo evidente avuto riguardo all’articolo 15 del d. leg.
286 del 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, il quale prevede
che a seguito di una sentenza di condanna che
abbia ad oggetto reati di cui agli articoli 380 e
381 del Codice di procedura penale, il giudice
possa prevedere, per lo straniero ritenuto socialmente pericoloso, la misura di sicurezza
della espulsione.
Qui la misura di sicurezza non interviene nel processo rieducativo posto in essere
dall’esecuzione della pena; anzi, il provvedimento dell’espulsione dal territorio dello stato
lascia supporre che la pena non possa di per sé
produrre effetti rieducativi sulla personalità
del reo e che pertanto la misura di sicurezza
che determina l’espulsione sia una necessaria
misura di difesa sociale.
La difesa sociale, in questo particolare ambito legislativo, prende il sopravvento sulla
funzione rieducativa della esecuzione penale, nel momento in cui l’articolo 16 del predetto decreto legislativo configura la misura
dell’espulsione come sostitutiva alla esecuzione della pena detentiva; ove il giudice ritenga di erogare una pena detentiva inferiore a
due anni ad uno straniero clandestino ai sensi
dell’articolo 13, comma secondo del su citato
testo unico (questo straniero non è esattamente
lo straniero richiamato dall’articolo 15 del testo
unico, perché questo si qualifica, in sostanza,
Digressioni sull’esecuzione della pena
issn 2035-584x
per la mancanza di permesso di soggiorno e di
validi documenti di transito), il giudice “può
sostituire la medesima pena con la misura
dell’espulsione”.
Ora, se pena e misura di sicurezza sono fungibili, né l’una né l’altra hanno funzione rieducativa; dato che la Repubblica abidica al suo
diritto-dovere dalla rieducazione sottraendo,
con l’espulsione, il reo alla sua giurisdizione e
l’espulsione sostituisce la pena, si presume che
anche alla pena stessa, qualora venisse eseguita, possano essere attribuiti gli stessi caratteri
della misura di sicurezza. Qui ci troviamo di
fronte ad un provvedimento che ritrova la propria ratio esclusivamente nella tensione alla difesa sociale e, potremmo aggiungere, in una difesa sociale a basso costo, dato che non prevede
la presenza del reo in istituti di pena, ma solo il
suo allontanamento dal territorio nazionale.
Va sottolineato che l’articolo 16, a differenza
dell’articolo 15, entrambi qui richiamati, non
prevede al fine di erogare una misura di sicurezza quale l’espulsione, l’accertamento della
pericolosità sociale del reo attraverso i parametri offerti dall’articolo 133 del Codice penale, tanto da poter supporre che, se la misura di
sicurezza è erogata a fronte della pericolosità
sociale, la condizione di clandestinità, in cui
sostanzialmente versa questo straniero, sia da
considerarsi di per sé pericolosa socialmente;
ma se ciò fosse vero, cosa del resto dimostrata
dalla presenza nell’ordinamento del comma 11
bis dell’articolo 61 del Codice penale, allora, a
fronte della necessità di difesa sociale, verrebbero meno sostanzialmente le garanzie poste
all’articolo 199 del Codice penale e soprattutto all’articolo 25 della Costituzione, e verrebbe
reintrodotta nell’ordinamento per alcune categorie di soggetti quella idea di pericolosità
sociale presunta o oggettiva, che prescindeva
dall’accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa, che viene ricondotta
all’abrogato articolo 204 del Codice penale.
Pare in definitiva che, dalla lettura dell’articolo 16, la pericolosità sociale, da cui la necessità di misure di sicurezza, sia ascrivibile non
tanto alla persona soggetta al provvedimento,
quanto al gruppo (i clandestini), a cui la persona
è riconducibile. Se ciò fosse vero, allora ci tro164
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
veremo, per un verso, di fronte ad un caso di
difesa sociale di natura attuariale12, per altro ad
un difficilmente solubile caso di costituzionalità della disposizione in oggetto, perché qui,
fra le altre, sarebbe lesa la condizione di parità
di trattamento di fronte alla legge, che soltanto
una capziosa interpretazione letterale dell’articolo 2 della Costituzione potrebbe salvaguardare (e portarci a dover elaborare una ingegneria costituzionale dei diritti basata su una sorta
di rediviva separate but equal doctrine).
Ma al di là di quest’ultima considerazione,
che ci conduce lontano dal seminato, appare
evidente come nei casi qui descritti, e principalmente in quello riguardante lo straniero
ai sensi dell’articolo 16 del Testo unico qui richiamato, la Repubblica abdichi, nel porre in
essere sanzioni prive del requisito della rieducazione, alla sua funzione rimozionale, sancita
dall’articolo 3 della Costituzione.
issn 2035-584x
agente, oppure, ed è il caso dello straniero di
cui sopra, in sostituzione di azioni rieducative
riconducibili alla esecuzione della pena.
In questi casi, la misura di sicurezza, vuoi
nel suo essere slegata dalla imputabilità, vuoi
dal suo porsi in alternativa all’esecuzione della
pena, ci riporta nell’alveo del pensiero proprio
alla Scuola positiva, ovvero fa palesare un utilizzo delle misure di sicurezza slegato dalla funzione rieducativa della pena: qui le misure di sicurezza si dirigono verso la pura difesa sociale.
7. Nota conclusiva
Da questi brevi cenni sul rapporto fra pena,
misura di sicurezza e rieducazione appare come
la reazione penale ad un comportamento criminoso non assuma sempre e comunque aspetti
pienamente ed apertamente rieducativi.
Questi indubbiamente primeggiano nella
(ed informano la) pena, così come viene concepita dal nostro ordinamento, e possono riscontrarsi nei casi in cui la misura di sicurezza
promani da una sentenza di condanna e, quindi, si collochi a fianco della pena (con vistosa
eccezione nei casi previsti dagli articoli 15 e 16
del Testo unico in materia di immigrazione);
qui ci troviamo di fronte a soggetti imputabili,
o, sia pur con i dovuti distinguo, di soggetti cosiddetti semi-imputabili.
L’unitarietà sostanziale fra pena e misura
di sicurezza, che si evidenzia attraverso la loro
comune funzione rieducativa, non si riverbera in tutti i casi d’erogazione e d’esecuzione di
misure alternative. Queste, come osservato,
possono venire poste in essere anche in assenza di elementi oggettivi e soggettivi atti a presupporre una possibilità di rieducazione del
12 Cfr. A. De Giorgi, Zero tolleranza, Strategie e pratiche della società di controllo, Roma, 2000.
Digressioni sull’esecuzione della pena
165
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa e la
nuova positività: riflessioni per l’inquadramento del
dibattito sull’interpretazione giuridica nel novecento
italiano
Stefano Favaro
Abstract
Parole chiave
L’ermeneutica giuridica contemporanea, compenetrando filosoficamente e nel contempo superando il normocentrismo della Scuola di Torino e il carattere concreto
e giudiziale del giusrealismo italiano, evidenziando
la fisiologicità dell’azione interpretativa, rappresenta
l’esperienza giuridica come il luogo dell’incessante incontro dialettico tra fatti, norme, parti e giudice, in cui la
“nuova” positività non è data ma è, anzi, prodotta dalla
mediazione interpretativa.
Scuola di Torino;
Neopositivismo;
Giusrealismo;
Ermeneutica giuridica;
Interpretazione giuridica;
Positività;
Bobbio Norberto;
Tarello Giovanni;
Betti Emilio.
1. Premessa. l’interpretazione e la comunicazione giuridica nella dimensione
controversiale del diritto
L
a peculiarità irrimediabilmente caratteristica dell’esperienza giuridica, ove considerata nella propria complessità strutturale, che
da quando esiste il primo consorzio umano
soggiace instancabilmente a molteplici e mai
compiuti tentativi di definizione e spiegazione1, consiste in primo luogo, come è noto ed
1Cfr., per quanto riguarda la difficoltà che gli operatori giuridici incontrano nel momento in cui tentano di
definire il diritto, le parole di A. Trabucchi (Istituzioni di
diritto civile, Padova, 1996, p. 1): l’Autore, oltre a segnalare
la persistente attualità di un «problema tanto grave che
ha tormentato la mente e la coscienza degli uomini», da
sempre tesi «alla ricerca di una definizione, che già Kant
indicava come il caput mortuum del giurista», prosegue
affermando che «ancora oggi riesce difficile rispondere
a questa semplice domanda: “cos’è il diritto”?». Per i rilevanti contributi scientifici relativi alla conoscenza del
fenomeno giuridico sotto il profilo prettamente speculativo (prevalentemente risalenti ai primi decenni del
secolo scorso, dato che la scienza giuridica degli ultimi
anni si è andata indirizzando verso riflessioni maggiormente ancorate ad ambiti settoriali e legati al diritto
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
evidente, nella sua genetica dinamicità, dal
momento che la mera cristallizzazione dei
principi regolativi del tessuto politico e sociale in castelli normativi di eburnea perfezione,
ma avulsi dalla realtà effettiva della dimensione relazionale dell’uomo, ne vanificherebbe
l’esistenza e la funzione essenziali2.
In secondo luogo, e altrettanto geneticamente, l’esperienza giuridica è caratterizzata
positivo, che sembrano considerare le radici filosofiche
dell’esperienza giuridica come un fatto incontestabile e
insuscettibile di ulteriori sviluppi), si rimanda alla bibliografia che lo stesso Autore indica in nota alle citazioni riportate; in questa sede ci si limita a segnalare: S.
Cotta, Il diritto nell’esistenza, Milano, 1991; A. Ravà, Diritto
e Stato nella morale idealistica, Padova, 1950; I. Petrone, Il
diritto nel mondo dello spirito, Milano, 1910.
2 Ciò non significa, peraltro, ed è opportuno segnalarlo
in tale sede, che la stessa espressione “esperienza giuridica”, comunque, sotto la lente di un’altra angolazione,
non possa legittimamente assurgere anche a “segno”
linguistico atto a designare una realtà che venga presa
in considerazione, sebbene secondo una prospettiva
meramente descrittiva, dunque parziale e perciò stesso fuorviante, per la propria componente strutturale
di storica staticità, e, quindi, di – seppur temporanea
– “immobilità”.
166
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
anche da un’intensa ed insopprimibile problematicità, dal momento che la sua dinamicità,
nel suo emergere, si profila sempre come operativamente e necessariamente finalizzata a
porre soluzione a quelle lacerazioni, potenziali
o concretamente realizzatesi, relative alla sfera
intersogettiva dell’agire umano, che si rivelano, ove non siano ricomposte, lesive della pacificazione sociale che costituisce il parametro
di riferimento di ogni dimensione giuridica.
D’altra parte, e in terzo luogo, è altrettanto innegabile che tale dinamicità e tale problematicità, oltre ad essere fattori reciprocamente condizionanti la caratterizzazione
dell’esperienza giuridica3, non possono a
propria volta darsi, dal suo stesso interno, se
non nella – genetica – dimensione comunicativa tra i soggetti e gli strumenti coinvolti
dall’esperienza giuridica e nell’esperienza
giuridica: si può, anzi, ulteriormente affermare che l’essenza (dinamica e problematica)
dell’esperienza giuridica è, interamente, nella comunicazione, e, pertanto, anche nel linguaggio, comune e giuridico, attraverso cui
tale comunicazione si esprime.
Ove, poi, si consideri che, in via di generale
(e non esaustiva) schematizzazione, e indipendentemente dalle più o meno macroscopiche
differenziazioni giusfilosofiche stratificatesi
nel corso dei decenni, di cui si farà cenno nelle
pagine seguenti, i soggetti protagonisti della
moderna esperienza giuridica europeo-continentale sono le parti (e i rispettivi difensori)
coinvolte dalla lacerazione nella relazione intersoggettiva loro riferibile, nonché il giudice
chiamato a ricucire la lacerazione medesima,
e posto che gli strumenti a disposizione di tali
soggetti sono la legge (quale parametro per la
ricostruzione e valutazione del fatto di causa
controverso) e il processo (quale “luogo” della
3 In effetti, se è evidente che la dimensione problematica del “giuridico” non potrebbe neppure sorgere in una
considerazione eminentemente statica dell’essenza
dell’esistenza umana, che, di fatto, negherebbe ab origine
la sua ragion d’essere, d’altra parte, è altrettanto evidente che, correlativamente, la dinamicità dell’esperienza
giuridica non può non accompagnarsi alla sua problematicità, posto che, in caso contrario, essa sarebbe da
considerarsi assolutamente perfetta e, pur tuttavia, per
tale stesso fatto, assolutamente inutile.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
controversia), si può ulteriormente e più specificamente affermare che l’esperienza giuridica contemporanea, nella propria dinamicità
e problematicità, è, interamente, nella comunicazione processuale tra le parti ed il giudice, e, pertanto, anche nel linguaggio4, sia
comune che giuridico, in cui si esprimono,
nel processo, le parti ed il giudice, nella loro
opera incessante di lettura-traduzione-rappresentazione giuridica, attraverso il ricorso
alla legge (e al suo linguaggio), del concreto
fatto di vita controverso.
Una simile concezione della sfera del giuridico – germinazione di quella mentalità che,
sulla scia degli insegnamenti di alcuni tra i
massimi esponenti della dottrina giusfilosofica del ventesimo secolo5, considera l’uomo
4 Si vedano, con specifico riferimento alla fisiologica
ineliminabilità, dalla dimensione dell’esperienza giuridica, della componente linguistica, le efficaci parole di
F. Gentile in Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà,
Padova, 2005, p. 121: «Per noi, terrestri, solo nella controversia si danno giusto e ingiusto così come solo nel
discorso si danno vero e falso. E poiché non si discorre
né si controverte senza il medio del linguaggio, nella
definizione del vero come del giusto il linguaggio esercita un ruolo non accidentale ma strutturale, complementare ma determinante, organico. Più esattamente:
l’assertorietà del linguaggio, con la sua resistenza alla
problematicità del discorrere e del controvertere non è
un’accidentalità storica, propria del resto di ogni discorso come di ogni controversia, ma è la stessa determinazione dell’atto problematico intrinseco al controvertere
e al discorrere. Sicché senza l’assertorietà implicita nel
linguaggio la leva della problematicità avrebbe un’efficacia puramente illusoria e per noi, terrestri, sarebbe vano cercar di discernere il vero dal falso, il giusto
dall’ingiusto».
5 Si fa riferimento, al riguardo, alla concezione processuale dell’esperienza giuridica di E. Opocher (di cui si
veda soprattutto il testo Il diritto nell’esperienza pratica.
La processualità nel diritto, in Lezioni di filosofia del diritto,
Padova, 1983, pp. 265 ss.), alla filosofia e alla concezione
“classica”, ma lucidamente rivolta al presente, dell’esperienza giuridica di F. Gentile (tra le cui opere si segnalano: Per fare il punto sulla filosofia giuridica e politica italiana
degli anni settanta, in “Archivio giuridico”, CXXIII/1, 1977;
La cultura giuridica contemporanea fra scienza e storia, in
“Incontri culturali”, anno XIII, 1980, n. 1-2; Intelligenza
politica e ragion di stato, Milano, 1984; Politicità e positività nell’ordinamento giuridico. L’opera del legislatore,
Cusl Nuova Vita, Padova, 1992; Ordinamento giuridico.
Controllo o/e comunicazione. Tra virtualità e realtà, in U.
Pagallo, Testi e contesti dell’ordinamento giuridico. Sei studi di teorie generale del diritto, Padova, 1999; Ordinamento
167
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
come un essere eticamente orientato al Bene
e all’autoregolamentazione, cioè come quella
«straordinaria creatura a cui il Creatore non
ha plasmato soltanto il corpo materiale ma
con l’anima ha infuso il suo Spirito, assimigiuridico tra virtualità e realtà, cit.; Politica aut/et statistica.
Prolegomeni di una teoria generale dell’ordinamento politico, Milano, 2003; Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi, Padova, 2006; Legalità,
giustizia, giustificazione, Napoli, 2008), e, inoltre, al pensiero di G. Capograssi (di cui si segnala, in particolare, Il
problema della scienza del diritto, Milano, 1962, e su cui
vedasi anche E. Opocher, Giuseppe Capograssi filosofo del
nostro tempo, Milano, 1991), che si può legittimamente
considerare uno dei massimi esponenti della filosofia,
e, nello specifico, della filosofia del diritto italiana del
ventesimo secolo. In questa sede ci si limita a ricordare
che, delineando i contorni di una “filosofia della riflessione” – da intendersi come filosofia dell’azione e della volontà umane – «che sembra rappresentare il più
completo tentativo di elaborare una filosofia del diritto
muovendo da presupposti esistenzialistici di tipo positivo» (E. Opocher, Lezioni di filosofia del diritto, cit., p. 231),
Capograssi ritiene che il diritto considerato in sé e per
sé, e cioè indipendentemente dall’esperienza etica degli
uomini e dalla vita della coscienza, non possa neppure
essere oggetto di riflessione alcuna, e giunge ad operare una ricostruzione del mondo del diritto che vede
nell’esperienza giuridica, in cui l’azione e la volontà del
soggetto tendono ad oggettivizzarsi nella giustizia, una
dimensione eminentemente individuale in cui la società civile svolge il compito etico di sollecitare gli uomini
alla moralità e a scoprire l’assoluto nell’interiorità delle
coscienze. A sua volta, la successiva dimensione processuale dell’esperienza giuridica così configurata, vera e
propria dimensione principe del diritto nel momento del suo “farsi” concreto, caratterizzata dall’assoluta
ineliminabilità del momento interpretativo – attraverso cui le norme devono essere ricondotte alla propria
vera essenza spirituale e razionale –, è per Capograssi
la dimensione in cui, attraverso la composizione delle
controversie, la Verità razionale emerge dalle pieghe
dei conflitti consentendo che il diritto viva e diffonda i
propri valori etici e di giustizia nella vita dell’uomo. Le
parole dell’Autore (cfr. Il problema della scienza del diritto,
cit., passim) sono, al riguardo, chiarissime, e meritano,
anche alla luce del vasto seguito che il pensiero in esse
espresso ha avuto in parte della dottrina giuridica italiana, di essere citate: «Non sembra esagerata la veduta di
coloro che ritengono che solo nel processo il diritto sia
diritto, perché solo nel processo esso diventa comando
e volontà effettiva. […] Nel segreto della controversia è
dunque implicita la intuizione che la verità deve vincere e deve regolare la vita, e che la verità consacra, per
così dire, la “pretesa”. Nella frase “aver ragione” è proprio implicito questo profondo principio, che la ragione
deve regolare la vita e che perciò nel conflitto deve vincere la pretesa che ha la ragione per sé».
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
labile, con immagine dantesca, all’orizzonte
che sta tra il cielo e la terra, a questa appartenendo come a quello»6 – individua pertanto
nella legge positiva una – sempre indiscussa
ed imprescindibile – disposizione di condotta che però, una volta posta, e considerata così
nella propria “fattualità” oggettivamente data,
«non esaurisce le modalità dell’ordine nei rapporti tra soggetti […] ma consente di attuare
l’ordinamento della controversia, che è ordine
emergente dal disordine, mediante fluttuazione dialettica tra le due divergenti vedute
dell’ordine che la costituiscono»7, e individua,
inoltre, nella processualità la dimensione comunicativa perfetta per il concreto – dinamico e dialogante – comporsi dialettico delle interferenze intersoggettive secondo i principi
di cui le leggi sono positivizzazione, così che,
nelle aule di tribunale, «il disordine si manifesta come divergenza tra due vedute dell’ordine. E l’ordinamento si realizza se e in quanto
fra queste si stabilisca un rapporto dialettico.
[…] Dialetticamente la controversia si risolve
mediante il riconoscimento […] di ciò che è
proprio delle parti in causa»8.
Ebbene, la descritta decisa rivendicazione
di una dimensione eminentemente comunicativa e processuale dell’esperienza giuridica, nell’ambito della quale la controversia tra
i soggetti, formante la vera e propria essenza
di ogni uomo quale essere relazionale, è in sé
«innervata dalla differenza»9 e, dunque, da
6 F. Gentile, Ordinamento giuridico. Controllo o/e comunicazione. Tra virtualità e realtà, in U. Pagallo, Testi e contesti
dell’ordinamento giuridico. Sei studi di teoria generale del diritto, cit., p. 249.
7 F. Gentile, Politicità e positività nell’ordinamento giuridico.
L’opera del legislatore, cit., p. 27.
8 F. Gentile, Ordinamento giuridico. Controllo o/e comunicazione. Tra virtualità e realtà, in U. Pagallo, Testi e contesti
dell’ordinamento giuridico. Sei studi di teoria generale del
diritto, cit., p. 240. Per un ulteriore ed incisivo approfondimento relativo alla concezione processuale del diritto,
si vedano anche, tra gli altri testi in materia: F. Cavalla,
La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di
Enrico Opocher, Padova, 1991; F. Cavalla, Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica, in Atti del XX Congresso
Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e
Politica, Padova, 1948, pp. 40 ss., F. Cavalla, Retorica, processo, verità, Padova, 2005.
9 F. Puppo, L’esempio del decreto penale di condanna, in P.
168
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
un’insopprimibile esigenza comunicativa che
trova proprio nelle pieghe tecniche e dialettiche del processo il metro della propria soluzione e riconduzione a Verità e Ordine, in cui,
cioè, «il processo è l’ordinamento giuridico
della vita particolare e non l’attuazione nella
vita particolare di un ordinamento»10, implica
inoltre, necessariamente, che se certamente, in
funzione del processo e della comunicazione
processuale, «è nell’ordinamento che si reperisce la legge»11, ossia il parametro normativo
di riferimento alla luce del quale ricostruire e
rappresentare giuridicamente il fatto di causa
controverso12, d’altro canto non può essere che
l’attività interpretativa delle norme (di qualunque natura esse siano) il tramite, perennemente aperto ad ogni variazione nel “respiro” della
vita dell’uomo (così come essa è trasfusa nella
propria veste processuale), attraverso il quale,
secondo il “miracolo” ermeneutico che Carnelutti definiva arte del diritto, la controversia si
compone, sempre nuova a se stessa, mediante
l’«applicazione della legge al caso singolo»13,
Moro (a cura di), Etica informatica diritto, Milano, 2008,
p. 186.
10 G. Capograssi, Intorno al processo (ricordando Chiovenda),
in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 1938,
ora in G. Capograssi, Opere, Milano, 1959, vol. IV, pp. 131169. La citazione è tratta da M. Cossutta, Dieci riflessioni
intorno al processo come algoritmo, in P. Moro (a cura di),
Etica informatica diritto, cit., p. 68.
11 Ibidem.
12 Con riferimento al ruolo che la legge positiva riveste
nell’ambito della comunicazione processuale per la composizione della controversia in essa confluita, si vedano
le parole di F. Gentile, che in Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, cit. pp. 58-59, avvicinando analogicamente la legge ed il concetto così scrive: «Come col concetto
si rappresenta una cosa fissandone i tratti essenziali,
così col precetto giuridico, legislativo amministrativo o
giudiziario che sia, si rappresenta un’azione, fissandone
i tratti qualificanti e in tal senso essenziali. […] Come il
concetto, con la sua fissità interlocutoria, costituisce un
principio regolatore della conoscenza umana, nel senso
che l’uomo, mediante il concetto, o meglio mediante la
rete dei concetti, in cui si unificano le precedenti esperienze, si apre ad esperienze nuove, così il precetto, con
la sua fissità interlocutoria, esercita la funzione di modello per l’azione umana, nel senso che l’uomo trova nel
precetto, o meglio nella rete dei precetti, in cui si sono
raccolti i tratti qualificanti di un rapporto, le indicazioni
utili per disporsi alla relazione con gli altri».
13 F. Carnelutti, sub voce Arte del diritto, in Novissimo
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
trasformando così, attraverso l’erosione delle
imperfezioni proprie del linguaggio normativo di riferimento14, l’astratto in concreto.
L’interpretazione normativa si rivela, infatti, inevitabilmente, come il necessario veicolo
attraverso cui si realizza concretamente, nella
prospettiva processuale dell’esperienza giuridica, la comunicazione tecnico-linguistica
tra i soggetti in essa coinvolti per la composizione di una controversia: distinguendosi,
nella più grande varietà di figure interpretative esistenti nei diversi ambiti conoscitivi ed
operativi, «per essere al tempo stesso “actio
interpretans” (interpretazione-attività) e “designatum” (interpretazione-prodotto), risultando ormai un dato non più discutibile nella
dottrina giuridico-filosofica formatasi in tema
di interpretazione che ciò che caratterizza tali
attività è determinato dall’oggetto, dal risultato e dal metodo dell’interpretazione stessa»15,
essa, avente ad oggetto, sempre secondo la
più autorevole dottrina dell’interpretazione
contemporanea, «un testo giuridico, normativo e autoritativo che sia, ossia una fonte del
diritto»16, si pone quale ineludibile raccordo
comunicativo tra la rappresentazione del fatto controverso, così come operata da ciascuna
delle parti alla luce della particolare interpretazione dei fatti stessi nonché delle singole
norme che ognuna di esse ritiene applicabile
per il soddisfacimento dei propri interessi, e
l’interpretazione del medesimo fatto, nonché
delle norme applicabili al caso, anche diverse
da quelle indicate dalle parti, compiuta, dialetticamente mediando tra le opposte esigenze e
il nucleo giuridico loro comune, dall’Autorità
Digesto Italiano, Torino, 1959, p. 545.
14 Per un’attenta disamina della rilevanza nonché per
un’elencazione delle maggiormente problematiche questioni giuridiche di natura linguistica ad oggi profilabili
agli operatori del settore, quali, ad esempio, dal punto di
vista semantico, l’omonimia, la polisemia e la vicinanza
di senso tra i termini di un periodo linguistico, vedasi
M. Cossutta, Questioni sull’informatica giuridica, Torino,
2003, pp. 87 ss.
15 F. Casa, Gli argomenti del giurista tra «premesse» e «strategie» interpretative, in “L’Ircocervo. Rivista elettronica di
metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato”, 2008, n. 2, p. 1.
16 Ibidem, p. 3.
169
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
giudicante chiamata a pronunciarsi sul caso
prospettatole. In altri termini, in un’epoca,
come quella contemporanea, in cui l’esperienza della realtà, anche giuridica, è sempre più,
e sempre più consapevolmente, esperienza di
messaggi, di comunicazioni, di raccolta, organizzazione e trasmissione di informazioni che
necessitano di essere decodificati, l’interpretazione giuridico-normativa assurge a strumento, e a metodologia, per la realizzazione di
quel «complesso iter, che dal dato legislativo
o consuetudinario giunge alle nuove formulazioni attraverso l’interpretazione»17 stessa,
che costituisce i capisaldi fondanti il moderno
comunicare dialetticamente, problematico,
dinamico e quotidiano, nelle aule di giustizia,
e, pertanto, il “farsi” continuamente del diritto
nella sua più intensa dimensione processuale.
Nonostante le ambizioni di certezza giuridica proprie dell’attività interpretativa dei testi
normativi siano, in realtà, parzialmente inficiate, in nuce, dal fatto che «il significato attribuito ad un determinato documento normativo
dipenda quasi esclusivamente dall’argomento
dell’interpretazione cui il giurista ritiene di
fare ricorso, con la precisazione che “con esso
si indica non un argomento in senso logico ma
un certo tipo di considerazioni rilevanti ai fini
dell’attribuzione di significato ai testi di legge,
fatte valere in sede di argomentazione interpretativa quali ragioni a sostegno di una determinata tesi interpretativa”»18, e nonostante,
ad oggi, vi sia chi sancisce, sostanzialmente,
«l’impossibilità di costruire una unitaria dottrina dell’interpretazione, dovendosi separare
la dottrina e la teoria dell’interpretazione dalla
sua applicazione l’attività del giurista da quella
del giudice, distinguere con riferimento all’interpretazione giudiziale il “contesto di decisione” da quello di “giustificazione”»19, appare
opportuno, tuttavia, procedere ad un rapido
17 E. Paresce, sub voce Interpretazione, in Enciclopedia del
diritto, Milano, 1998, pp. 178 ss.
18 Cfr. F. Casa, Gli argomenti del giurista tra «premesse» e
«strategie» interpretative, cit., p. 17. La citazione dell’Autore fa riferimento a E. Diciotti, Interpretazione della legge e
discorso razionale, Torino, 1999, p. 307.
19 Cfr. F. Casa, Gli argomenti del giurista tra «premesse» e
«strategie» interpretative, cit., p. 12.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
excursus orientativo, nel labirintico panorama relativo alla riflessione filosofico-giuridica
italiana che, nell’immediato dopoguerra e nei
decenni ad esso successivi, si è interessata in
particolar modo della speculazione sulla teoria
e sul metodo dell’interpretazione normativa,
dei principali orientamenti speculativi che si
sono a più riprese occupati di tale rilevante
problematica. Al riguardo, è possibile procedere all’evidenziazione, che sarà oggetto più dettagliato del prosieguo del presente contributo,
della configurabilità di una tripartizione di
massima nella quale far confluire i differenti
approcci operati dalla scienza giuridica di riferimento20: il primo indirizzo, la cui massima
espressione è costituita dagli esiti della riflessione degli esponenti della Scuola di Torino, si
può definire di matrice eminentemente «geometrica», si muove nell’orbita latamente intesa del positivismo giuridico, e, fondandosi
su di una rappresentazione entusiasticamente
normocentrica dell’esperienza giuridica, sfocia, ineludibilmente, in una concezione meccanicistica e matematizzante dell’interpretazione; il secondo indirizzo, maggiormente
aderente alle istanze del realismo giuridico,
nel porre quale cardine della propria indagine
non solo le leggi ma anche i soggetti che con
esse operano, e, in particolar modo, i giudici,
focalizza la propria attenzione soprattutto sul
modus operandi, nelle aule giudiziarie, dei
soggetti titolari della funzione giurisdizionale
attraverso la loro opera di interpretazione “politica” nell’applicazione delle leggi ai casi concreti prospettati; il terzo indirizzo, ancorato
ad un approccio critico e filosofico della realtà
sociale e giuridica, innesta nel tessuto dottrinale dello studio del dato normativo e del suo
utilizzo concreto le istanze problematiche proprie della dialettica e dell’ermeneutica.
20 Per un generale inquadramento sistematico dello
stato della cultura giuridica e filosofica italiana degli
ultimi decenni si vedano, tra gli altri: L. Ferrajoli, La
cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Roma, 1999;
Enrico Pattaro, Temi e problemi di filosofia del diritto,
Bologna, 1994; F. Casa, Sulla giurisprudenza come scienza,
Padova, 2005.
170
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
2. La scuola di Torino
Per quanto riguarda la Scuola di Torino, si
ricorda che essa, sviluppatasi con esiti fecondi
soprattutto a partire dagli anni Sessanta, può
considerarsi in senso ampio inserita nel movimento – avviato negli anni Trenta in Inghilterra dal movimento di Oxford, ma operante
anche al di qua della Manica per opera del Circolo di Vienna21 – che prende il nome di neopositivismo (o positivismo logico, o empirismo
logico)22, e che si sostanzia in uno snodo attua21 Formatosi a partire dal 1923 grazie all’attività di insigni studiosi come M. Shlick, R. Carnap, e O. Neurath, il
Circolo di Vienna vede il momento essenziale per la posizione delle proprie basi sistematiche nella lettura del
Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein, e sviluppa
successivamente un programma che trova massima
espressione nel manifesto filosofico, datato 1929, sapientemente intitolato La concezione scientifica del mondo: il circolo di Vienna, in cui vengono posti i cardini concettuali per una rifondazione su basi esclusivamente
logiche ed empiriche dell’esistenza umana, e per la sua
ricostruzione in un linguaggio unificato della scienza.
22 La filosofia analitica propria del neopositivismo si caratterizza per ambire, secondo un atteggiamento antiidealistico, ad un rigore metodico analogo a quello della
scienza, e per il suo collocarsi, dunque, in una posizione
non alternativa né conflittuale rispetto ad essa, ma anzi
in una fitta rete di interazioni con le sue modalità operative e procedurali. Le idee comuni a tutti gli esponenti
dell’empirismo logico possono, così, essere riassunte
nell’utilizzo di un modo obiettivo di sviluppare le tematiche filosofiche che faccia impiego sistematico delle
più rigorose tecniche di argomentazione e dimostrazione (ricorrendo anche agli strumenti della logica e della
matematica); nel gusto per analisi minuziose e tematicamente ristrette piuttosto che per l’elaborazione di
sintesi vaste o addirittura onnicomprensive; nella preminente attenzione rivolta verso il medium linguisticoespressivo delle proposizioni. Sulla base di tali assunti, e
soprattutto con riferimento all’estrema importanza assegnata al compito di analizzare e chiarificare il funzionamento dell’espressione linguistica, il neopositivismo
si sviluppa secondo linee di pensiero che sfociano nella
convinzione che le uniche proposizioni dotate di senso
siano quelle suscettibili di verifica empirica e fattuale
(si parla in questo caso di “criterio di significanza”); nella certezza che la scienza, in quanto basata proprio sulla
verifica, rappresenti l’attività conoscitiva per eccellenza,
la sola forma possibile di razionalità, così che si definiscono senza senso le proposizioni della metafisica, in
quanto trascendenti l’orizzonte dell’umanamente verificabile; nella considerazione della religione, dell’etica
e della metafisica, per l’appunto, come attività che non
forniscono conoscenze, risolvendosi in proposizioni
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
lizzante e modernizzatore di quel “romanticismo della scienza” che è carattere fisiologico
proprio del positivismo filosofico23. La speculazione della Scuola di Torino, caratterizzandosi
per il proprio gravitare nell’orbita “geometrica”
del positivismo giuridico (o, per la precisione,
del neoempirismo logico), adotta, in materia
di interpretazione giuridica, una concezione
rigorosamente scientifica, convenzionale, operativa e meccanicistica dell’azione interpretativa24. Il “normativismo” di tale scuola, ove
per normativismo si intenda «quella corrente
della filosofia giuridica in virtù della quale il
diritto coincide con le norme poste in essere
dal legislatore»25, prende infatti lo spunto da
consistenti in mere manifestazioni esteriori di atteggiamenti emotivi, interiori, nei confronti dell’esistenza;
nel principio, infine, per il quale la filosofia non è una
scienza, ma un’attività avente funzione chiarificatrice,
finalizzata ad analizzare il linguaggio “sensato” della
scienza e a denunciare il linguaggio “insensato” della
metafisica. Per maggiori dettagli sui singoli esponenti
del neopositivismo si rinvia a N. Abbagnano, Filosofi e filosofie della storia, Torino, 1996, vol. III, pp. 491 ss.
23 Ci si limita a ricordare, in questa sede, che le convinzioni di fondo dei sostenitori di questo movimento,
come osserva N. Abbagnano (Filosofi e filosofie della storia,
cit., vol. III, pp. 281-282), sono le seguenti: «a) la scienza
è l’unica conoscenza possibile ed il metodo della scienza è l’unico valido: pertanto il ricorso a cause o princìpi
che non siano accessibili al metodo della scienza non
dà origine a conoscenza; e la metafisica, che fa appunto
tale ricorso, è priva di valore; […] b) la filosofia tende a
coincidere con la totalità del sapere positivo, o, più specificamente, con l’enunciazione dei principi comuni alle
varie scienze. La funzione peculiare della filosofia consiste quindi nel riunire e nel coordinare i risultati delle
singole scienze, in modo da realizzare una conoscenza
unificata e generalissima; […] c) il metodo della scienza, in quanto è l’unico valido, va esteso a tutti i campi,
compresi quelli che riguardano l’uomo e la società; […]
d) il progresso della scienza rappresenta la base del progresso umano e lo strumento per una riorganizzazione
globale della vita in società».
24 Per un’ampia bibliografia degli studi sulla Scuola di
Torino, cfr. F. Casa, Dalle scienze cognitive alle applicazioni
giuridiche dell’intelligenza artificiale, in U. Pagallo (a cura
di), Prolegomeni di informatica giuridica, Padova, 2003, p.
72. In particolare, si segnalano in questa sede: E. Opocher,
Lezioni di filosofia del diritto, Padova, 1983, pp. 247-254; F.
Gentile, La cultura giuridica italiana tra scienza e storia¸ in
“Incontri culturali”, anno XIII, 1980, n. 1-2; F. Gentile, Per
fare il punto sulla filosofia giuridica e politica degli anni settanta, in “Archivio giuridico”, CXXIII/1, 1977.
25 F. Casa, Dalle scienze cognitive alle applicazioni giuri-
171
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
una rappresentazione volontaristica, formale
e risolutamente convenzionale – trattasi di un
vero e proprio postulato indiscutibile, necessario affinché l’intera costruzione sistematica
possa resistere ad ogni critica – del giuridico26,
secondo la quale è diritto quanto sia concretamente posto, efficace e suscettibile di applicazione in virtù dell’ordine vincolante impartito
da chi detiene il potere: in altri termini il diritto è, in un simile approccio antimetafisico e razionale, il solo diritto positivo, quale prodotto
normativo vincolante, espressivo-linguistico,
compiuto e completo, da sottoporre a rigoroso
studio scientifico27. Ora, se per i seguaci della
scuola analitica tutto il diritto si esaurisce nel
diritto positivo (secondo l’insegnamento quod
non est in lege, nec in iure), allora la teoria
dell’interpretazione giuridica si sostanzia necessariamente nella teoria dell’interpretazione
diche dell’intelligenza artificiale, in U. Pagallo (a cura di),
Prolegomeni di informatica giuridica, cit., pp. 110-111.
26 Si vedano, al riguardo, le efficacissime parole di F.
Gentile (Intelligenza politica e ragion di Stato, cit.), secondo
cui «la presenza di un insieme coercitivo di norme, effettivamente funzionante nelle sue grandi linee, costituisce la conditio sine qua non dell’ordinamento giuridico che verrà elaborato dalla scienza giuridica». L’Autore
continua (Ibidem, p. 158) dichiarando che «una concezione scientifica del diritto che assuma il dato di fatto di
un vigente sistema cogente di norme risolve inevitabilmente la propria ricostruzione in una «elaborazione di
un sistema logico per ‘adoperare’ il diritto effettivamente esistente».
27 Ancora una volta sono le parole di F. Gentile (cfr.
Intelligenza politica e ragion di Stato, cit., p. 155) a chiarire nel modo migliore quanto si viene dicendo in ordine all’oggetto, alla scientificità e alla convenzionalità
dell’analisi dell’esperienza giuridica che contraddistinguono la Scuola di Torino. Assimilando efficacemente il
modus operandi del “normativista” giuridico a quello del
fisico, infatti, l’Autore afferma che «quello del perché
un uomo libero si deve comportare nel modo previsto
da una norma, non è problema che interessi la scienza
giuridica, più di quanto interessi la scienza fisica il perché un grave lasciato libero nell’aria deve cadere a terra.
Giacché, come le molte cadute dei gravi lasciati liberi
nell’aria costituiscono i fatti che la scienza fisica non
mette in discussione ma si propone di dominare, unificandoli mediante la loro rappresentazione sulla base di
un principio ipotetico, così i molti comportamenti conformi alle norme degli uomini liberi costituiscono i fatti che la scienza giuridica non mette in discussione ma
si propone di dominare, unificandoli mediante la loro
rappresentazione sulla base di un principio ipotetico».
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
del diritto positivo, così come la scienza giuridica non può non coincidere con la scienza
della norma, ossia con uno studio dettagliato
del testo di legge. L’indagine del giurista si focalizza, quindi, sul dato normativo, che, al fine
di essere meglio compreso, viene scomposto
e ricomposto nelle sue unità strutturali-linguistiche di matrice grammaticale, sintattica,
semantica. L’attività di interpretazione della
legge è dunque sostanzialmente assente, risolvendosi in un puro esercizio grammaticale,
linguistico, logico.
Gli esiti normativistici della Scuola di Torino si risolvono così in una rappresentazione
dell’esperienza giuridica nella quale non vi è
alcuno spazio per un’autentica attività interpretativa. L’interprete, secondo il pensiero di
tale movimento, non scopre nulla di nuovo
nel testo di legge che analizza, ma si limita
ad un’opera “meccanica”, ricognitiva di esso,
il cui esito consiste nell’esplicitare, attraverso un ragionamento “matematico” marcatamente sillogistico, ciò che, già contenuto nella
norma sin dalla sua formazione ad opera della
manifestazione di volontà del Legislatore, a
causa di disfunzioni di vario genere – linguistiche, grammaticali, sintattiche, ecc. – la disposizione non ha chiaramente espresso sì da
risultare ambigua e polisensa. Egli si limita,
sulla base delle proprie profonde conoscenze
della struttura del linguaggio normativo, ad
“estrarre” dall’errore nella redazione del testo
legislativo il contenuto originario e completo
della legge, rivelandosi così un tecnico che certamente “ascolta” con orecchio attento la voce
più profonda della legge, ma che non può in
alcun modo, pena la violazione del principio
volontaristico della presa d’atto del vigore della legge stessa così come essa è posta, lasciare
l’impronta della propria mano, della propria
sensibilità, del proprio spirito.
Una delle figure di maggior spicco dell’indirizzo di pensiero della Scuola di Torino,
nonché dell’intero panorama filosofico della
cultura italiana del secondo dopoguerra, è senza alcun dubbio Norberto Bobbio28. Autentico
28 Per una completa bibliografia delle opere di Bobbio, si
veda C. Violi (a cura di), Bibliografia degli scritti di Norberto
Bobbio: 1934-1993, Roma, 1995. In particolare, con ri-
172
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
scienziato del diritto, convinto che la filosofia
debba fungere solamente da supporto teorico all’operatività della scienza, definita come
«un sistema di proposizioni, di cui sono esattamente definite le proposizioni iniziali e le
regole di trasformazione delle proposizioni, e
che si svolge coerentemente con le premesse
poste e le regole date»29, così che «una ricerca
si dirà scientifica non già per la verità che essa
abbraccia, ma per il rigore con cui procede»30,
Bobbio vede nell’esperienza giuridica un complesso di regole di comportamento cogenti in
un dato tempo e in un dato luogo, cioè un ordinamento coattivo di disposizioni linguistiche
positive che lo scienziato del diritto ha il compito di porre ad oggetto esclusivo delle proprie
ricerche. La scienza del diritto deve dunque,
per L’Autore, innestare nel peculiare oggetto
della propria analisi le stesse procedure della
scienza genericamente intesa, e così perseguire lo scopo di rendere il più rigoroso possibile
– e in tal modo di purificare – il linguaggio del
legislatore: proprio in ciò consiste la specificità dell’attività di interpretazione delle leggi.
È sufficiente, al riguardo, a conferma del fatto che Bobbio risulta un convinto positivista,
sottolineare ulteriormente come per il filosofo torinese il compito interpretativo si snodi
nei tre passaggi, necessari e successivi l’uno
rispetto all’altro, della purificazione, del completamento, e della riconduzione a sistema
delle disposizioni linguistiche legislative, e
come, per questa via, egli dimostri di concepire l’interpretazione della legge come un’operazione tecnica e meccanica che finisce per fare
del giurista «puramente e semplicemente un
ritrovatore di norme giuridiche già implicite
nel sistema normativo dato»31.
ferimento ai testi bobbiani relativi specificatamente
alla questione interpretativa, si indicano: Teoria della
scienza giuridica, Torino, 1950; Teoria della norma giuridica, Torino, 1958; Il positivismo giuridico, Torino, 1979;
Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 1984.
29 Cfr. N. Bobbio, Teoria della scienza giuridica, cit., p. 29.
30 Ibidem.
31 Ibidem, pp. 179-189. È opportuno segnalare, inoltre,
anche la figura del più brillante allievo di Norberto
Bobbio, Uberto Scarpelli, l’opera del quale, per la comprensione delle cui tendenze neopositivistiche è sufficiente la mera lettura dei titoli dei principali contribu-
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
3. Il giusrealismo analitico italiano
Per quanto riguarda il giusrealismo analitico italiano – il secondo movimento che ha
maggiormente influito sulla moderna concezione dell’interpretazione giuridica nel
panorama culturale italiano – va osservato
che esso risulta maggiormente aderente alle
concezioni, radicalmente antimetafisiche
e antipositivistiche, proprie di quel particolare movimento giusfilosofico risalente
al secondo dopoguerra, e particolarmente
vivace sino agli anni Settanta, operante sia
oltreoceano (negli Stati Uniti d’America) sia
in Europa (in Scandinavia), che si palesa rivolto al tentativo di contrastare, sotto diverse angolazioni, i risultati raggiunti dal neoempirismo logico e dalla scuola analitica del
diritto32.
ti (si vedano: Cos’è il positivismo giuridico, Napoli, 1997;
L’etica senza verità, Bologna, 1982: Filosofia analitica e giurisprudenza, Milano, 1953; Diritto e analisi del linguaggio,
Milano, 1976; Contributo alla semantica del linguaggio
normativo, Milano, 1985; Il linguaggio del diritto, Milano,
1994), e che soprattutto nella sua prima parte si è svolta
all’insegna della più profonda continuità rispetto agli
insegnamenti di Bobbio, in una successiva fase del suo
sviluppo, senza tradursi semplicemente in una mera
conferma e ripetizione dei convincimenti raggiunti dal
filosofo torinese, acquisisce un’autonomia speculativa
affatto rilevante quanto a profondità analitica ed originalità. Se da un lato Scarpelli infatti, senza alcun dubbio
sulle orme di Bobbio, pone, nei primi anni del proprio
lavoro accademico, la filosofia analitica e la scienza giuridica al centro del proprio sistema speculativo e alla
base di un rigoroso positivismo giuridico di impronta
metodologica, che si traduce nella nota definizione (cfr.
Che cos’è il positivismo giuridico, cit., p. 88.) per cui «non si
fa una scienza del diritto come scienza del diritto positivo perché interessa conoscere scientificamente il diritto positivo e quindi se ne fa la scienza, ma si fa la scienza
come scienza del diritto positivo perché interessa fare la
scienza del diritto positivo e trovando nel diritto positivo l’oggetto che la rende possibile, le si assegna appunto
questo oggetto», dall’altro lato, però, egli, ancora più del
proprio maestro, esasperando e portando alle estreme
conseguenze le istanze di “modernizzazione” del positivismo giuridico rivendicate dalla filosofia analitica neopositivista, si dimostra particolarmente interessato alle
problematiche relative al linguaggio giuridico, alla sua
struttura, nonché alla sua “depurazione”, funzionale
al perseguimento della massima certezza giuridica, ad
opera degli interpreti.
32 Per una dettagliata e minuziosa disamina delle speci-
173
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Considerando l’esperienza giuridica come
ficità delle convinzioni dei giusrealisti americani, si veda
G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Milano, 1962:
al riguardo, in questa sede è sufficiente indicare i nomi
di Walter Wheeler Cook, William O. Douglas, Jerome
Frank, Max Radin, Felix Salten Cohen, e soprattutto
Karl N. Llewellyn. I principali esponenti del realismo
giuridico scandinavo furono, invece: Axel Hägerström,
il fondatore del movimento, il cui pensiero antimetafisico si può riassumere nella massima praeterea censeo
metaphysicam esse delendam, e la cui tesi essenziale è che
il diritto positivo è soltanto un sistema di regole per gli
organi dello Stato, risolvendosi il fenomeno giuridico,
in tutti gli altri casi, in un’idea falsa, in un’idea di poteri
soprasensibili di carattere per così dire “magico”, così
che i concetti di cui si avvale la scienza giuridica sono
entità metafisiche cui non corrisponde assolutamente nulla di reale; Vilhelm Lundstedt, autore di un libro
dall’emblematico titolo La non scientificità della scienza
giuridica, che esaspera le tesi di Hägerström, sostenendo
che tutta la scienza giuridica moderna è non scientifica,
che i diritti e gli obblighi non esistono, che l’unica cosa
reale è la “macchina del diritto”, ossia uno strumento di
organizzazione della forza per il conseguimento di certi
scopi di carattere sociale, e che, nello specifico, «le “norme giuridiche” non sono altro che l’espressione della
protezione che in certe circostanze lo stato offre a certe
utilità dei soggetti che così ne ricavano una situazione
di vantaggio» (cfr. E. Opocher, Lezioni di filosofia del diritto, cit., p. 245); Karl Olivecrona, il quale, si caratterizza,
da un lato, per aver definito il diritto come tecnica di
organizzazione della forza e non come tecnica del controllo sociale costituente il prodotto della forza preminente in un dato momento storico in un dato ambiente,
dall’altro, e soprattutto, per aver fornito ai propri studi
un’angolazione di carattere prevalentemente analiticolinguistico. Infine, va citato Alf Ross, allievo sia di Hans
Kelsen che di Hägerström, il quale si rivela come il più
originale e “indipendente” fra i seguaci della scuola giuridica scandinava: risentendo tanto degli insegnamenti
del più rappresentativo “geometra” legale del secondo
dopoguerra quanto delle convinzioni del fondatore
della scuola di Uppsala, Ross sviluppa un pensiero che,
seppur saldamente ancorato ad una visione empiristica
e realistica del fenomeno giuridico, differenziandosi da
quello dei tre filosofi svedesi sopra esaminati si avvicina, per certi versi, al realismo giuridico americano. Egli,
infatti, in perfetta consonanza di vedute con il principio
fondamentale del giusrealismo d’oltreoceano, sostiene
che la validità delle norme giuridiche è data dal fatto
che le norme stesse siano effettivamente applicate dai
tribunali: «una norma giuridica è valida quando è sentita come obbligatoria da parte dei giudici e (perciò) è
probabile che in futuro verrà applicata: in altre parole
“esistono” (in quanto norme) quelle che sono sentite
dai giudici come tali e si presentano come criterio di
giudizio anche (probabilmente) per i casi futuri» (cfr. G.
Tarello, sub voce Realismo giuridico, in Novissimo Digesto
Italiano, Torino, 1959, p. 933).
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
un’esperienza non normativa ma esclusivamente fattuale, fortemente convinti che «nella realtà il diritto […] esiste solo come meccanismo sociale»33 di organizzazione della
forza «che mira ad ottenere determinati tipi
di condotta»34, e ritenendo che la fattualità
cogente del diritto consista dunque nel condizionamento di natura psicologica cui i suoi
destinatari sono assoggettati per opera delle decisioni giudiziarie, i giusrealisti vedono
nelle norme giuridiche non tanto dei comandi provenienti da chi detiene il potere, obbligatori e vincolanti, il cui rispetto da parte dei
loro destinatari faccia funzionare la macchina
del diritto, quanto, piuttosto, delle rappresentazioni di comportamenti espresse in forma
imperativa, il cui rispetto, la cui efficacia, cioè,
sulla condotta degli uomini, non determina,
come effetto, il funzionamento del sistema
giuridico, ma anzi «dipende dalla esistenza e
dal regolare funzionamento del diritto come
meccanismo e realtà sociale, cioè dalla esistenza di forze sociali organizzate per il raggiungimento di determinati scopi»35. Sulla base
di tali convincimenti, inoltre, il giusrealismo
italiano si concentra non più sulla legge, e sul
suo dettato linguistico, ma sul giudice e sulla
sua attività concreta di interpretazione del diritto: poiché il diritto non è “dato” staticamente né “bloccato” in una serie di disposizioni,
ma è creato dagli operatori di giustizia con la
progressiva stratificazione dei provvedimenti
conclusivi dei processi, allora l’attività di interpretazione del diritto deve passare dall’analisi
delle norme poste all’analisi dei procedimenti
con cui i giudici, i più attivi protagonisti della realtà giuridica, “danno vita” al diritto da
interpretare. Conseguentemente, in modo
diametralmente opposto rispetto alle istanze
della Scuola analitica di Torino, il giusrealismo
vede nell’interpretazione giudiziale della legge non più una meccanica operazione logicosillogistica di estrazione dal testo normativo
di ogni contenuto in esso implicito, operata da
un giurista vincolato ai dettami della voluntas
33 S. Castignone, Diritto, linguaggio, realtà. Saggi sul realismo giuridico, Torino, 1995, p. 245.
34 Ibidem.
35 Ibidem, p. 247.
174
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
legis, ma un’attività autonomamente creativa di diritto, operata, sulla base di scelte soggettive di “politica giudiziaria”, nel momento
il cui diritto stesso “si fa vita” concreta, cioè
all’interno delle aule di giustizia, dai tribunali
chiamati ad applicare la legge. Poiché la logica
giuridica non coincide con la logica formale,
l’interpretazione della legge non va condotta
secondo lo stretto rigore del sillogismo giuridico, ma – inevitabilmente – secondo altri e
diversi principi guida, quali la soggettività, i
sentimenti, la psicologia, le opzioni di natura
latamente “politica” dei singoli giudici, al punto che per tale via vi è «la possibilità da parte
della magistratura di arrivare a conclusioni diverse partendo dalle stesse premesse»36. L’interpretazione, pertanto, ha carattere “politico”,
creativo e giudiziale: «non solo la sua validità
è condizionata dall’opera dei tribunali, ma si
può dire che, senza il controllo di questi, “l’ideologia interpretativa” non ha alcun vigore. […]
Un’interpretazione dottrinale o scientifica
non potrebbe avere un qualsiasi sbocco»37.
Il filosofo maggiormente rappresentativo
appartenente al giusrealismo analitico italiano è senz’altro Giovanni Tarello (1934-1987)38,
il cui pensiero in materia di interpretazione
prende l’avvio dalla critica nei confronti del
neopositivismo logico della Scuola di Torino:
il diritto, secondo l’Autore, non è suscettibile
di alcuna definizione concettuale ed esclusivamente normativa, configurandosi piuttosto, sulla base di una sua lettura fenomenica e
non astrattizzante, come un concreto insieme
non sistematico di regole normative finalizzate a disciplinare le relazioni intersoggettive.
Inoltre, per Tarello non è possibile fornire una
definizione “tradizionale” di norma giuridica,
per il fatto che, nella realtà dell’esperienza, vi
36 Ibidem, p. 27.
37 E. Paresce, sub voce Interpretazione, in Enciclopedia del
diritto,cit., p. 201.
38 Per la completa bibliografia di Tarello si rimanda a
M. Caserta, Giovanni Tarello. Teoria, ideologie e metagiurisprudenza, Napoli, 2001, pp. 131-145; per quanto riguarda, invece, le opere dell’Autore attinenti specificamente
all’oggetto del presente contributo, si indicano, tra le
tante: Il realismo giuridico americano, cit.; Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto, Bologna, 1974;
L’interpretazione della legge, Milano, 1980.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
è una netta differenza, mediata dall’interpretazione, tra ciò che è la disposizione normativa e
ciò che è la norma. La disposizione normativa
è infatti un enunciato, il testo di legge in sé e
per sé considerato, ossia l’espressione linguistica in forma compiuta che il giurista si impegna ad analizzare e interpretare o applicare
“in senso normativo”, e che, prima dell’intervento pratico dell’operatore di diritto, racchiude nel proprio nucleo linguistico una pluralità di significati possibili. La norma è, invece,
una comunicazione precettiva esprimente il
significato – quel singolo, specifico significato – che emerge in virtù dell’interpretazione
della disposizione normativa che sia stata effettuata. L’Autore, al riguardo, è chiarissimo:
«La norma non ha un significato per la buona
ragione che è (null’altro che) un significato. La
norma è il significato di un segmento di linguaggio in funzione precettiva, enunciato da
un documento in lingua. […] Per cui non si può
parlare affatto di interpretazione della norma ma solo di interpretazioni di enunciati in
lingua, di documenti (di leggi, di sentenze, di
raccolte di consuetudini): il processo interpretativo si esercita su di un enunciato, procede a
partire da un enunciato e perviene alla norma;
la norma non precede come dato, bensì segue,
come prodotto, il processo interpretativo»39.
Se, dunque, nel pensiero di Tarello, il diritto
non vive, nella prassi, se non nel momento
in cui le disposizioni normative si tramutano
in norme per effetto dell’attività interpretativa, ne esce enormemente valorizzato il ruolo
che l’interpretazione assume, concretamente,
effettivamente, nel mondo del diritto: l’interprete è l’artefice primo della dinamica e della
concreta esperienza giuridica, in quanto è il
responsabile della trasformazione della disposizione – priva di qualsiasi significato, ma in
potenza suscettibile di contenerne una enorme pluralità perché in “attesa” di essere interpretata da un singolo operatore giuridico – in
norma, cioè, in sostanza, in significato. In altri
termini, secondo Tarello l’interpretazione non
è un’attività meramente ricognitiva di significato, ma è un’attività “ascrittiva” di significato
39 Cfr. G. Tarello, Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto, cit., p. 57.
175
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
(agli enunciati), e, dunque, “creativa” (di significato, cioè di norme). Queste osservazioni
confermano, dunque, la dirompente rilevanza, stante l’inevitabile ed ineliminabile ruolo
di mediazione che l’interpretazione riveste
nell’esperienza giuridica, del ruolo svolto dai
giudici-interpreti nella vita del diritto. Inevitabile, in una simile situazione, l’ingresso, nella
norma scaturita da una simile interpretazione
giudiziale, delle opzioni latamente “politiche”
di cui ogni organo giudicante è “intriso”. Ecco
perché si parla, relativamente al pensiero di
Tarello, e, in modo più ampio, relativamente
a quello dei giusrealisti, di “interpretazione
politica” della legge: l’atto interpretativo di
ascrizione di significato all’enunciato di un documento normativo è, per sua natura, indissolubilmente legato alla soggettività, alla cultura,
alla preparazione professionale, ai pregiudizi,
anche all’onestà, e, in una parola alla visione
“politica” dell’interprete stesso. Ecco perché si
parla, facendo riferimento all’attività interpretativa operata dalla magistratura, di “governo
dei giudici”40.
40 Conviene segnalare, tra gli esponenti del giusrealismo analitico italiano, anche Riccardo Guastini, la cui
produzione scientifica (di cui si indicano le seguenti
opere: Realismo giuridico e analisi del linguaggio, Genova,
1990; Lezioni sul linguaggio giuridico, Torino, 1985; Critica
del diritto e analisi del linguaggio, Bologna, 1982; Lezioni
di teoria analitica del diritto, Torino, 1982; Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993; Dalle fonti alle norme, Torino, 1992; L’analisi del ragionamento giuridico.
Materiali ad uso degli studenti, Torino, 1989) risulta, in
senso assai generale, e pur nella sua personale specificità, tendenzialmente rivolta allo sviluppo dei principali
convincimenti di Tarello. Se si possono cogliere delle
differenze fra i due Autori, esse vanno ricercate in primo
luogo nella maggiore attenzione rivolta da Guastini allo
studio del realismo giuridico scandinavo, e in secondo
luogo in un approccio maggiormente analitico nei confronti dell’analisi dell’esperienza giuridica, soprattutto
sul versante della teoria del linguaggio giuridico-normativo. Con riferimento specifico a tale secondo aspetto, Guastini approfondisce in modo particolarmente
intenso – nell’ambito delle problematiche attinenti
all’interpretazione dei testi normativi – gli studi sul linguaggio normativo: egli, in effetti, presa coscienza della
rilevanza dell’opera ermeneutica giudiziale nell’attività
interpretativo-creativa del diritto, nonché del fatto che
l’interpretazione è un’attività di produzione di norme,
si dedica soprattutto – a fini di “terapia” del linguaggio
– all’analisi della struttura, dei difetti, delle correzioni
da apportare al linguaggio giuridico in cui si esprimono
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
4. L’ermeneutica giuridica
Per quanto riguarda l’ermeneutica giuridica, ossia la terza corrente di pensiero relativa
agli studi in materia di interpretazione giuridica che sono oggetto del presente contributo, è opportuno segnalare che si tratta di una
particolare tipologia di speculazione che, da
qualche decennio, germinando dall’ermeneutica tout court, è assai feconda di approdi conoscitivi, e che, dal punto di vista della metodologia di indagine, si rivela essere in grado di
impiegare quella capacità di sviluppare, da un
nucleo di opinioni predeterminate, una nuova
e maggiormente compiuta rappresentazione
del medesimo problema originario la quale,
partendo dal pregresso bagaglio conoscitivo, e
nel contempo partecipandone, se ne distacchi
divenendo altro rispetto ad esso superandone
nel contempo le aporie, che è carattere proprio
del più alto e profondo filosofare41.
le disposizioni normative da interpretare nella prassi
giudiziaria. Egli sostiene (cfr. Le fonti del diritto e l’interpretazione, cit., p. 348) che «i problemi fondamentali di
ogni interpretazione testuale nascono dalla vaghezza e
dalla ambiguità dei testi soggetti ad interpretazione. La
vaghezza attiene al significato, e dunque alla semantica, dei vocaboli e dei linguaggi. L’ambiguità, a sua volta,
può dipendere dal significato dei vocaboli e dei sintagmi (ambiguità semantica), dalla sintassi degli enunciati
(ambiguità sintattica), o dal contesto d’uso degli enunciati (ambiguità pragmatica)». L’interpretazione dei testi normativi da cui emergono le norme, ossia i significati delle disposizioni prese in esame, sarà così tanto
più ardua quanto più “difettoso” sarà il linguaggio utilizzato dal legislatore: di qui la necessità, per l’interprete
che voglia operare con piena cognizione di causa senza
cadere nelle “trappole” tese dalle imperfezioni linguistiche dei testi di legge, di giungere a conoscere la più
intima struttura del linguaggio in cui essi esplicitano il
proprio “messaggio” da interpretare.
41 È noto come la forma mentis di chi ambisca ad essere autenticamente e genuinamente filosofo – secondo
le linee ereditarie del precipitato speculativo classico
che storicamente, partendo da Socrate per giungere a
Platone e passando per Aristotele, delinea i tratti essenziali propri anche del pensiero moderno e contemporaneo – sia caratterizzata dalla convinzione che la “Verità”
vi sia, che tutto non possa non gravitare nell’orbita di
valori “metafisici” assoluti che fungono da guida e da
punti di riferimento nell’agire e nel pensare umani, e
che, conseguentemente, l’uomo, irrimediabilmente
immerso, nella realtà, in una complessa e inestricabile
stratificazione di continue rappresentazioni e opinioni
176
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Nel prendere atto del fatto che, oggi, costituisce un dato assodato e incontestabile la
consapevolezza che il “problema interpretativo” è assolutamente coessenziale alla natura
dell’essere umano42, nel constatare, in altri tersulla realtà stessa, per potersi avvicinare alla Verità su
ciascuna di esse debba operarne una perenne, infaticabile radicalizzazione problematica e critica, abbattendo
la barriera di tutti i preconcetti scientistici che spesso
ne inquinano la trasparenza e la nitidezza. In un simile processo di approfondimento problematico emerge
inevitabilmente, quale fondamentale ed imprescindibile baluardo metodologico di cui ogni filosofo deve
essere “armato”, la necessità di calarsi dialogicamente,
dialetticamente interrogando e interrogandosi nel contesto profondo dell’opinione analizzata, senza che residui lo spazio distorcente proprio di pregiudizi aprioristicamente ancorati ad una limitata prospettiva nei
confronti della rappresentazione della realtà sottoposta
a “critica”. Lungo questo percorso, cogliendo cioè proprio dall’interno di ogni rappresentazione (o opinione)
della realtà (o sulla realtà) la sua maggiore o minore coerenza, sia rispetto a se stessa sia rispetto al novero delle
altre rappresentazioni o opinioni afferenti alla medesima problematica di riferimento, il filosofo riesce dunque a scoprire nelle opinioni ciò che opinabile non è,
ossia la Verità, sottesa ad ogni conseguimento conoscitivo e, anzi, parametro latente e silenzioso, guida geneticamente istintiva per l’emergere proprio di qualsiasi
approdo valutativo e speculativo. Tale conseguimento
e tale approdo, peraltro, non comportano l’abbandono
tout court della rappresentazione (o opinione) stessa in
quanto parziale. Da un lato, infatti, l’atteggiamento filosofico autentico si traduce senz’altro nel disvelamento
dell’essenza prima di ogni cosa rappresentata attraverso
la radicalizzazione del problema cui l’opinione ha fornito una risposta fallace o incompiuta, l’evidenziazione
delle sue aporie e della sua parziarietà, il superamento
della sua pretesa indiscutibilità, e il raggiungimento
di conclusioni “altre” e più esaustive rispetto ad essa.
Dall’altro lato, però, esso non può, in quanto inscindibilmente gettato nel nucleo più profondo del problema
stesso da cui è sorta la rappresentazione che è stata “filosoficamente” problematizzata, ripudiare, in virtù del
suo superamento, l’opinione che ha fornito risposta al
problema. Il metodo filosofico conoscitivo autentico,
in altri termini, non rifiuta radicalmente mai nessuna
opinione, limitandosi a “svilupparla” ove ne rilevi la
contraddittorietà o l’insufficienza rispetto agli scopi che
essa si era prefissi, per andare oltre – senza cancellarla
– la sua finitezza, e per giungere così alla Verità sul suo
oggetto.
42 D’altra parte – e a riprova della giustificatezza di
un simile generalizzato convincimento – è sufficiente
prendere in considerazione la storia del pensiero filosofico, dalle sue origini ad oggi, per rendersi conto di
come il problema interpretativo, pur con le inevitabili
differenze, estensioni ed amputazioni che ogni specifi-
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
mini, che agli albori del terzo millennio si può
legittimamente affermare che il risultato di
secoli di speculazione consiste nella certezza
che l’uomo, e, con esso, la società, non possono “darsi” senza la mediazione interpretativa,
per il fatto che, assai semplicemente, esistere
è, necessariamente, anche interpretare43, l’erco contesto storico-culturale ha riverberato sull’oggetto
di tali studi, abbia sempre tagliato trasversalmente, nel
corso dei secoli, come una sorta di indispensabile e perennemente irrisolta tensione intellettuale comune a
tutte le speculazioni, ogni forma di riflessione dell’essere umano su se stesso e sulle proprie azioni. Al riguardo, per una breve ma esaustiva sintesi della storia
dell’ermeneutica, si rimanda, in particolare, alle pagine
di N. Abbagnano (Storia della filosofia, cit. vol. VII, pp. 2-8),
nonché al volume di G. Mura, Ermeneutica e verità. Storia
e problemi della filosofia dell’interpretazione, Roma, 1990,
oltre che a G. Gusdorf, Storia dell’ermeneutica, trad. it.,
Roma-Bari, 1989. In questa sede ci si limita a ricordare
che l’ermeneutica, che in una prima fase della propria
evoluzione rimase strettamente legata agli studi relativi all’efficacia delle espressioni linguistiche e all’esperienza del trasmettere i messaggi, fu sostanzialmente
trascurata nel Medioevo cristiano e scolastico, per trovare solo nel Rinascimento quel fermento culturale
idoneo a farla emergere quale disciplina autonoma rispetto a tutte le altre forme affini di sapere. Pur avendo mantenuto l’ermeneutica ancorata ad applicazioni
riferite solamente all’interpretazione e all’esegesi dei
testi sacri, il Rinascimento contribuì a porre le basi per
la svolta universalistica che il Settecento, latore di un
forte fermento razionalistico, impresse a tale scienza
filosofica, legittimando il suo sviluppo anche con riferimento all’interpretazione non solo di qualsiasi testo,
ma anche di qualsiasi segnale espressivo-comunicativo
calato nell’esperienza umana. Lungo questa direttrice, e
attraverso l’opera di illustri pensatori quali Friederich
Schleiermacher, Wilhlem Dilthey, Martin Heidegger,
l’ermeneutica progredì verso un’autoreferenzialità e
una portata filosofica sempre maggiori nell’ambito del
panorama culturale moderno, fino ai nostri giorni, in
cui sembra ormai quasi impossibile riuscire a districarsi e ad orientarsi, nella sterminata rete di comunicazioni e messaggi da cui siamo bombardati, senza l’apporto
di una “scienza” che si dedichi in via esclusiva a chiarire
i percorsi filosofici e metodologici necessari per avvicinarsi ad una corretta interpretazione di ognuno di essi.
43 È particolarmente interessante notare come l’idea
per cui la questione interpretativa risulta umanamente
imperscindibile trovi un lucido precursore nella figura
carismatica e contraddittoria di Nietzsche. Il filosofo
che più di ogni altro, nella storia della filosofia moderna, è riuscito, col proprio argomentare tagliente e profetico, a distruggere ogni certezza e a svelare all’uomo
l’illusorietà dei suoi convincimenti (Nietzsche giunse a
sostenere che le certezze degli uomini non sono che i
177
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
meneutica contemporanea deve concepirsi
come la coscienza esplicita e filosofica del “fatto dell’interpretazione”, cioè come la coscienza umana di «sapersi teoreticamente pensiero
interpretante»44 e come metodologia pienamente consapevole di se medesima: essa costituisce un «tipico parto della modernità»45, da
cui scaturisce l’esito secondo il quale la filosofia dell’uomo non può non essere una filosofia
dell’interpretazione.
Si assiste così, ai nostri giorni, quale esito
di tale acquisita coscienza dell’ineliminabilità dell’atto interpretativo come coessenziale
all’esistenza umana, non solo all’intensificarsi – come mai prima nella storia del pensiero
filosofico – degli studi sull’ermeneutica, ma
addirittura al proliferare delle “ermeneutiche”: dall’ermeneutica generale, preoccupata
di cogliere le basi per una propria “autofondazione” filosofica, all’ermeneutica relativa a
discipline più o meno circoscritte a specifici
settori, all’ermeneutica che cerca di inserirsi
in nuovi ambiti – come la medicina e la psicologia – che sempre più cercano nuovi collegamenti con la filosofia.
Ma la più rilevante differenziazione di cui
bisogna prendere atto è senza dubbio quella
tra l’ermeneutica ontologica e l’ermeneutica
metodologica: se la prima è rivolta a tracciare i
confini di un pensiero rigorosamente filosofico volto a delineare l’essenza dell’uomo inteso
come essere che in quanto esiste, interpreta, e
che, in quanto interpreta, esiste46, la seconda,
loro errori inconfutabili), oltre ad affermare l’impossibilità di esprimere in forma compiuta e corrispondente
all’intuizione avuta qualsivoglia pensiero, ritiene infatti
che nel mondo non esistano solo fatti, bensì solo interpretazioni, legittimando così una concezione dell’esperienza umana irrimediabilmente marcata, nella propria
struttura più profonda, dal carattere interpretativo di
ogni pensiero, azione, accadimento.
44 N. Abbagnano, Storia della filosofia, cit., vol. VII, p. 2.
45 Ibidem.
46 Il massimo esponente della moderna ermeneutica
ontologica – sviluppatasi sulla scia della totale radicalizzazione heideggeriana del fenomeno interpretativo,
per cui «l’interpretazione è l’articolazione o lo sviluppo
interno della comprensione, attraverso cui “la comprensione, comprendendo, si appropria di ciò che ha
compreso”» (cfr. N. Abbagnano, Storia della filosofia, cit.,
vol. VII, p. 7, in cui l’Autore fa riferimento alle parole di
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
Heidegger contenute nel paragrafo 32 di Essere e Tempo)
–, è senza dubbio Hans Georg Gadamer (1900-2002), che
è legittimamente annoverato fra i massimi pensatori
del ventesimo secolo. Nel suo capolavoro, Verità e metodo. Lineamenti di un’ermeneutica filosofica (tradotto in
italiano per la prima volta nel 1971), Gadamer sviluppa
un complesso itinerario configurante un’ermeneutica
filosofica che bandisce risolutamente dai propri scopi
ogni velleità metodologica concentrandosi, in via esclusiva, sull’intento di chiarire le strutture trascendentali
del comprendere, ossia i modi d’essere in cui si concretizza il fenomeno interpretativo. Convinto che l’uomo
sia intrinsecamente “gettato”, senza possibilità alcuna
di uscirne, nella finitudine della storia, così che l’essere “gettati nel mondo” di Heidegger diviene un essere
gettati nella “storia”, in modo che «non è tanto la storia che appartiene a noi, ma noi che apparteniamo alla
storia», Gadamer afferma, inoltre, che l’esistenza stessa
non si dà, e non si può dare, senza il linguaggio: esso
non è solo uno strumento di comunicazione, ma la dimensione ineliminabile in cui l’essere si apre al mondo
e comincia davvero ad esistere in quanto tale, è, cioè, la
totalità onniabbracciante di io e mondo, che si dispiega
– nella storia – secondo le forme linguistiche del rapporto dialogico domanda-risposta (Gadamer stesso afferma
che «in verità noi siamo sempre di casa nella lingua», e
che «chi ha linguaggio ha il mondo»). Il comprendere,
a sua volta, non è, per Gadamer, uno dei tanti possibili
atteggiamenti dell’uomo nell’esperienza, ma è piuttosto il modo di essere dell’esistenza umana come tale, un
modo di essere costitutivo dell’esistenza nella sua storicità, nella sua finitezza, e nel suo darsi linguisticamente
nel corso della storia: esistere è comprendere nella storia e nel linguaggio. Tale profonda storicità-linguisticità
del comprendere umano, attraverso cui l’uomo, per
mezzo del linguaggio e nel linguaggio, esiste e percepisce la propria esistenza (nella storia, nel linguaggio e
col linguaggio), si attua mediante un perenne “circolo
ermeneutico” in virtù del quale, mediante la dialettica
domanda-risposta, stante la continuità fluida tra presente e passato – per cui la “lontananza temporale” fra
essi è mediata dalla “tradizione storica” nella cosiddetta
“fusione degli orizzonti” – la “cosa” da interpretare, già
filtrata sulla base della “precomprensione” che la sua
distanza storica dall’interprete immette nel modo di
quest’ultimo di approcciarsi ad essa, nel contempo influenza ed è influenzata dall’interprete stesso: in pratica
il suo essere già parte della tradizione storica genera la
precomprensione dell’interprete, mentre l’interprete,
avvicinadosi alla cosa intriso dai pregiudizi di tale precomprensione, interrogherà la cosa dalla propria particolare prospettiva temporale, e perverrà così ad un esito
geneticamente diverso da tutte le precedenti interpretazioni. Efficaci al fine della comprensione di tale complesso meccanismo ermeneutico-esistenziale – di natura circolare, svolgentesi nello scorrere del tempo e della
storia – in cui interpretandum ed interprete si trovano
in una situazione di simultanea prossimità e distanza,
178
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
invece, risulta maggiormente preoccupata
– una volta constatata la necessaria imprescindibilità dell’atto interpretativo per il darsi dell’uomo nel mondo – di fornire all’uomo
stesso i parametri procedurali minimi per il
compimento di una corretta interpretazione.
In un simile panorama culturale e filosofico di estrema attualità, in cui il problema
interpretativo-ermeneutico è «un termine di
confronto con cui chiunque lavori sul terreno
delle scienze umane, e forse anche delle scienze positive, non può non misurarsi»47, il più
specifico problema dell’interpretazione giuridica tende inevitabilmente ad essere assorbito
nel più ampio nucleo di riflessioni che fanno
riferimento alla questione generale dell’“interpretare”, così da configurarsi in un rapporto
di species a genus nei confronti della riflessione ermeneutica contemporanea. Se perciò, da
una parte, il particolare modo “giufilosofico” di
porsi nei confronti dell’attività interpretativa
deve continuare ad operare tenendo conto delessendo l’interprete «dimidiato fra la sua appartenenza
a una tradizione e la sua distanza rispetto agli oggetti
che sono il tema delle sue ricerche» (cfr. N. Abbagnano,
Storia della filosofia, cit., vol. VII, p. 45), sono le parole di
Giovanni Fornero (cfr. Ibidem, p. 59): «Accostarsi ad un
testo significa ricostruire la domanda originaria di cui
esso è la risposta, al di là delle stesse intenzioni consapevoli dell’autore. […] Questo lavoro di ricostruzione della
domanda originaria che sta dietro il testo implica quindi un nostro domandare sul testo. Ma questo domandare è già, a sua volta, sollecitato dal testo medesimo,
che, all’interno di una determinata tradizione, ci pone
determinate domande. La nostra domanda sul testo è
quindi la risposta ad una domanda precedente, che il
testo stesso ci rivolge. Per cui, prima di essere e di porsi come l’interrogante, l’interprete, dal punto di vista di
Gadamer, risulta, di fatto, l’interrogato». Attraverso la
fusione degli orizzonti storici così delineata, Gadamer
giunge, conseguentemente, ad affermare l’impossibilità di un’interpretazione storica obiettiva, in quanto è
la stessa dimensione esistenziale dell’uomo che la impedisce, dal momento che ogni cosa da interpretare “altera”, dal passato nel quale l’interprete deve calarsi per
interpretare, l’atteggiamento dell’interprete stesso che
alla cosa si avvicini, e, osservata a partire da tale pregiudizio, viene inevitabilmente “letta” dall’interprete alla
luce non dell’effettivo momento storico in cui essa si
è data nel mondo, ma alla luce dell’attuale storico darsi
dell’esistenza in cui è gettato l’interprete.
47 G. Vattimo, Tempo d’interpretare, in “La Stampa”, cit.,
p. 3.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
la specificità del suo oggetto, e cioè della specificità dell’esperienza giuridica – species rispetto al genus dell’esperienza umana in generale
–, dall’altra parte esso deve, proprio in virtù di
tale rapporto assorbente la prima esperienza
nel cuore della seconda, considerare l’esperienza giuridica come “gettata” nel (e facente
parte del) mare magnum dell’odierna riflessione ermeneutica generale, e condividerne gli
slanci e le articolazioni di pensiero, poiché
se tutto, nell’esperienza umana, è interpretazione, a maggior ragione, si può dire, tutto è
interpretazione anche nella più specifica e ristretta esperienza giuridica. In virtù di questo
atteggiamento “condiviso” tra ermeneutica ed
ermeneutica giuridica, accade pertanto che,
anche nel circoscritto campo dell’ermeneutica giuridica, in cui è dato rinvenire un vero e
proprio tertium genus che, partecipando tanto
delle istanze della Scuola di Torino quanto di
quelle del giusrealismo analitico, nel contempo se ne distacchi acquisendo contorni propri
ed indipendenti dalla portata chiarificatrice e
dirompente, sia possibile individuare una diversificazione tra i sostenitori di un approccio
“ontologico” alle questioni interpretative e i
sostenitori di un’ermeneutica giuridica maggiormente interessata ai risvolti metodologici
dell’interpretazione. In Italia, fra i tanti pensatori che negli ultimi decenni hanno approfondito tali tematiche, meritano di essere citati
e osservati con particolare attenzione Emilio
Betti e Giuseppe Zaccaria.
4.1. Segue: Emilio Betti
La figura di Emilio Betti, nel panorama
filosofico-ermeneutico del cuore del ventesimo Secolo, si è contraddistinta per una decisa tensione alla configurazione di una teoria
ermeneutica generale di carattere metodologico che, antitetica rispetto alla concezione
ontologica heideggeriana e gadameriana del
comprendere – suscettibile di pervenire ad
esiti drasticamente soggettivistici – tenesse
costantemente presente l’esigenza di un’autogiustificazione, cioè di una fondazione del
sapere che, riflettendo sulla propria struttura,
fosse in grado, legittimandosi in virtù di tale
179
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
riflessione, di assumere connotati oggettivi e
razionali. Betti infatti, pur essendo consapevole della intrinseca fallibilità di ogni impresa
umana e dell’impossibilità di dare fondamento “assoluto” a qualsiasi asserto o riflessione,
non si esime tuttavia dal ritenere che sia necessario tentare, attraverso un’immensa e
capillare opera in grado di scavare fin nella
profondità estrema del meccanismo interpretativo umano in ogni settore, «di conferire
validità non meramente soggettiva alle nostre
interpretazioni, e che sia pertanto necessario
riflettere sulle procedure attraverso le quali
possiamo sottoporre a controllo le conoscenze
raggiunte»48. La teoria bettiana dell’interpretazione è, così, costruita metodologicamente
sulla base dell’idea della sussistenza e «in difesa dell’oggettività intrinseca ad ogni corretta interpretazione»49, ed è “generale” proprio
perché, secondo il filosofo di Camerino, «toutes les activités interprétatives […] affichent
une structure épistémologique commune. Le
rôle d’une herméneutique générale est d’en
éclairer les fondaments et d’en distinguer les
types afin de définir les conditions d’une interprétation qui soit objective»50.
48 F. Bianco, La Teoria generale dell’interpretazione
nel dibattito ermeneutico contemporaneo, in V. Frosini, F.
Riccobono (a cura di), L’ermeneutica giuridica di Emilio
Betti, Milano, 1994, p. 28.
49 Ibidem, p. 27.
50 J. Grondin, L’universalité de l’hermenétique selon Emilio
Betti, in V. Frosini, F. Riccobono (a cura di), L’ermeneutica
giuridica di Emilio Betti, cit., p. 115. Filosofo e giurista
dall’enorme cultura ed erudizione, immerso per l’interezza della propria attività accademica anche nelle
pieghe del pensiero filosofico tedesco (grazie anche ad
una perfetta padronanza della lingua tedesca stessa),
Betti ha lasciato una enorme bibliografia, all’interno
della quale è sufficiente ricordare, oltre alla monumentale Teoria generale dell’interpretazione, Milano, 1990:
Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, Milano, 1949; L’ermeneutica come metodologia generale delle scienze dello spirito, Roma, 1987, Teoria
generale del negozio giuridico, Milano, 1994. Interessato
ad inseguire l’ideale di un’ermeneutica obiettivistica e
metodicamente addestrata ad impedire le possibili degenerazioni soggettivistiche del lavoro interpretativo,
Betti, scagliandosi contro Gadamer e la sua ermeneutica radicalmente ontologica, accusa il filosofo tedesco,
come si è detto poco sopra, di aver creato una filosofia
dell’interpretazione suscettibile di aver indebitamente
sopravvalutato la soggettività dell’interprete, «sino a
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
La riflessione di Betti, così concepita, in ordine all’interpretazione giuridica, prende l’avvio a partire da una configurazione dell’esperienza giuridica in generale che, nei suoi
caratteri, conferma la profondità del pensiero
dell’Autore e ne dimostra chiaramente il pieno dominio di quella capacità critica, descritta
nel paragrafo precedente, per cui chi è filosofo
dimenticare che l’ermeneutica […] è una scienza e che,
come tale, non può fondarsi su quella ambigua parola
che è la “precomprensione”, la quale non fa che abolire
l’alterità del conosciuto, e, quindi, la consistenza autonoma dell’oggetto storico» (N. Abbagnano, Storia della
filosofia, cit., vol. VII, p. 108). Sulla base di questi rilievi
Betti, distinguendo tra quello che è il significato obiettivamente individuabile di un fatto storico e il significato che lo stesso fatto può assumere per un interprete
dell’epoca contemporanea, costruisce, nel proprio capolavoro, la Teoria generale dell’interpretazione, la propria
personale riflessione metodologica sul problema ermeneutico. In tale enorme e capillare lavoro di minuziosa
analisi della struttura dell’attività interpretativa in tutti
i campi del sapere, la teoria dell’interpretazione risulta
articolata nei quattro canoni ermeneutici dell’autonomia dell’oggetto (cioè della sua alterità rispetto all’individualità del soggetto interpretante), della totalità della
considerazione ermeneutica (cioè dell’essenziale correlazione tra le parti della cosa interpretata e il tutto che
dalle parti è costituito), dell’attualità dell’intendere (cioè
dell’immedesimazione dell’interprete nel punto di vista
interno, storicamente determinato, da cui ha preso vita
la cosa da interpretare), e dell’adeguazione dell’intendere
(cioè della necessità che l’interprete sia dotato, oltre che
dell’interesse ad intendere, di sufficienti apertura mentale e profondità riflessiva). L’indagine di Betti prosegue poi attraverso la descrizione dei quattro momenti
ermeneutici del processo interpretativo, che vengono individuati in «quello “filologico”, quello “critico”,
quello “psicologico” (volto a “calarsi” nel mondo interiore dell’autore), e “quello tecnico-morfologico” (volto
ad intendere il senso del mondo oggettivo-spirituale
alla stregua della sua particolare legge di formazione)»
(N. Abbagnano, Storia della filosofia, cit., vol. VII, p. 107).
L’Autore traccia, inoltre, una precisa classificazione dei
diversi tipi di ermeneutica entro i quali è possibile collocare ogni forma di interpretazione: egli parla innanzitutto di “interpretazione ricognitiva”, che è volta alla
comprensione dell’oggetto da interpretare (un’opera
letteraria o un’opera d’arte) così come esso è in se stesso, quindi di “interpretazione riproduttiva”, che è tesa
alla riproduzione e alla successiva comunicazione di
un’esperienza altrui (è quello che accade, per esempio,
nell’interpretazione teatrale o musicale), e, infine, di
“interpretazione normativa”, che è finalizzata a fornire
norme o direttive di azione (rientrano in tale categoria,
per Betti, sia l’interpretazione etica che quella religiosa
che quella giuridica).
180
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
accetta, problematizza, e supera le riflessioni
altrui in vista della formulazione di una riflessione “altra”, più esaustiva e compiuta di
ciascuna di esse. Betti, infatti, nella definizione di diritto che offre, possiede qualcosa sia
dello scienziato giuridico, sia del giusrealista,
sia del filosofo autentico. Come gli “scienziati”
giuridici “normativisti” l’autore sostiene che
il diritto è sostanzialmente norma, che esso
è, dunque, anche forma, cioè la forma in cui si
esprime linguisticamente la norma stessa, e
che esso «non può adeguatamente cogliersi se
non come ordine o ordinamento giuridico»51:
il diritto è, anche per Betti, uno strumento tecnico, e specificamente una tecnica finalizzata
alla realizzazione della civile e pacifica convivenza tra gli uomini52. Come i realisti giuridici,
inoltre, Betti ritiene che il diritto, indirizzandosi ad una specifica realtà sociale – meglio, ad
una limitata parte della specifica realtà umana
e sociale in cui opera e che vuole disciplinare53 –, non possa essere mai disancorato dalla
sua attualità contingente per essere colto solo
nella coerenza formale dell’ordinamento normativo in sé e per sé considerato. Come i giusfilosofi autentici, infine, Betti è fermamente
51 A. Catania, La definizione generale di diritto nel pensiero di Emilio Betti, in V. Frosini, F. Riccobono (a cura di),
L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, cit., p. 36.
52 Molto chiare sono, al riguardo, le stesse parole di
Betti, che in Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 817,
afferma: «Le norme giuridiche – a differenza dei giudizi
teoretici, che enunciano un sapere e sono fine a se stessi
come conoscenza di verità – non sono fine a se stesse,
ma strumenti a fini di convivenza sociale, e le norme di
diritto privato di regola rappresentano la soluzione di
un conflitto d’interessi».
53 È infatti necessario notare che per Betti «il diritto
non è […] un universo chiuso delimitato e bastante a
se stesso, ma lo strato spirituale di un processo di realizzazione dello spirito la cui vita si obiettivizza anche
in altre forme rappresentative» (G. Zaccaria, Creatività
dell’interpretazione e principi generali nell’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, in V. Frosini, F. Riccobono (a cura di),
L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, cit., p. 186). A conferma di tale principio per cui l’esperienza umana non
si esaurisce nella sola esperienza giuridica cfr. anche
E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, cit., p. 7: «I
rapporti giuridici hanno il loro substrato in relazioni
sociali esistenti già prima e anche all’infuori dell’ordine giuridico: relazioni che il diritto non crea, ma trova
dinanzi a sé, prevede ed orienta nella direttiva di qualifiche e valutazioni normative».
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
convinto che anche nella sfera dell’esperienza
giuridica sia necessario conferire la dovuta rilevanza ai valori, oggettivi e assoluti, che, radicati nell’essenza umana, contribuiscono alla
formazione e al mantenimento della società54.
L’esperienza giuridica è pertanto, secondo Betti, per effetto di questo fruttuoso, sebbene parziale, accoglimento critico delle istanze proprie delle correnti di pensiero e di metodo che
si sono analizzate nelle pagine precedenti, un
concreto e storicamente determinato mezzo
tecnico predisposto per disciplinare le relazioni sociali del consorzio umano, consistente in
un ordinamento giuridico inteso come organico e formale sistema di norme, costituente
nel contempo espressione dei valori o princìpi
assoluti, etici e politici, immanenti alla natura
umana. In altri termini, nella concezione bettiana del diritto, al quale l’Autore conferisce
«unità di senso»55 stante la sua natura di
«totalità spirituale»56, è possibile cogliere i
segni di una visione che considera rilevanti, sullo stesso piano, sia la realtà concreta,
che la positività dell’ordinamento, che i superiori principi umani di cui esso è storica
manifestazione: si potrebbe pertanto dire,
sinteticamente, che per Betti il diritto è sia
fatto che norma che Valore.
Così concepito, il diritto si dispiega concretamente, per Betti, secondo una genetica,
insopprimibile dinamicità che – in una continua “osmosi” tra dato normativo, ambiente
sociale e valori assoluti – procede all’unisono
con il variare delle esigenze e degli interessi che esso mira a regolare: sostanziandosi in
una «perenne dialettica tra eternità di valori
e contingenza»57, l’esperienza giuridica è una
54 L’Autore afferma infatti (cfr. Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 847) che «certamente le finalità
generali dell’ordine giuridico toccano i più profondi
problemi etici e politici della vita sociale; e una legislazione geniale è quella che sa trovare e apprezzare i veri
valori della civiltà nel momento storico in cui entra in
vigore».
55 G. Zaccaria, Creatività dell’interpretazione e principi generali nell’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, in V. Frosini,
F. Riccobono (a cura di), L’ermeneutica giuridica di Emilio
Betti, cit., p. 187.
56 Ibidem.
57 E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 848.
181
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
realtà irrimediabilmente in fieri che non può
esistere «fuori dall’attuazione»58, e che trova
pertanto nel momento controversiale, cioè
nella dimensione processuale in cui avviene la
composizione delle liti – sempre nuove e concretamente diverse –, il momento principe in
cui si attua la sua specifica praticità. Il diritto,
in altri termini, non si esaurisce nella norma,
«perché la norma […] ha vigore attuale in una
con l’ordinamento di cui è parte integrante, ed
è destinata a passare e a trasfondersi nella vita
sociale, alla cui disciplina deve servire»59, così
che l’ordinamento giuridico «non è né qualcosa di bell’e fatto (come può credere una visione
statica e immobilizzante, alla Kelsen), né un
organismo che si sviluppi da sé per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa»60,
trovando nella controversia (che altro non è
se non un concreto conflitto di interessi tra
soggetti) e nella sua soluzione processuale il
luogo deputato al proprio farsi, e trovando altresì nell’imprescindibile momento dell’interpretazione l’attività senza la quale è impossibile quella sintesi tra astrattezza della legge e
concretezza della situazione (cui la legge deve
venire applicata) che dalla controversia, e dal
suo esito processuale, deve emergere.
Dalla concezione bettiana di diritto emerge
dunque conseguentemente, con prepotente
evidenza, l’importanza del ruolo che l’Autore
attribuisce all’interpretazione giuridica: essa
per Betti consiste in un “intendere” che non
è esclusivamente fine a se stesso, ma è finalizzato all’ “agire”, cioè «al fine di regolare l’agire
alla stregua di massime che si desumono da
norme o dogmi. […] La giurisprudenza si trova dinanzi a testi vincolanti da interpretare:
testi, le cui enunciazioni pongono non solo
la comune esigenza teoretica di essere intesi,
ma inoltre anche un’esigenza pratica, di essere
osservati: il che conferisce alla interpretazione
giuridica […] una funzione normativa. […] Dai
testi legali promana non solo un appello di intelligenza, rivolto allo spirito contemplativo,
58 G. Marino, Principi, processualità, ermeneutica. Note su
Capograssi e Betti, in V. Frosini, F. Riccobono (a cura di),
L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, cit., p. 142.
59 E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 817.
60 Ibidem, p. 836.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
ma anche un appello di osservanza, rivolto
allo spirito pratico»61. Lungi dall’esaurirsi in
un’attività esterna al darsi del diritto come realtà a sè stante che dell’interpretazione è solo
l’oggetto di analisi, l’interpretazione è parte
integrante e formativa del diritto stesso62, poiché solo attraverso l’imprescindibile “creatività” dell’atto ermeneutico le norme generali ed
astratte possono calarsi adeguatamente nella
realtà concreta della singola controversia che
sono chiamate a disciplinare, “piegare” alla
contingenza i Valori di cui sono “positivizzazione”, respirare la “storia” della vita sociale
in cui operano, ed essere “attualizzate” ed integrate per venire quindi attuate e applicate
rispondendo con effettività alle specifiche esigenze umane che chiedono soddisfazione63. In
altri termini, per Betti l’interpretazione giuridica consiste nell’intendere per conoscere,
in modo da conoscere per poter poi attuare la
legge e garantire l’efficace soddisfazione degli
interessi in gioco nella controversia.
61 Ibidem, pp. 790-791.
62 Sotto questo punto di vista Betti è particolarmente
critico nei confronti di Kelsen, che, secondo l‘Autore,
con la sua teoria pura del diritto «trasferendo nella legislazione ogni capacità produttiva dell’ordinamento giuridico, disconosce il carattere attivo dell’interpretazione
giuridica, così costretta ad “esaurirsi in una ricognizione
meramente contemplativa del significato proprio della
norma considerata nella sua astrattezza e generalità”»
(cfr. F. Riccobono, Emilio Betti e la “malattia kelseniana”, in
V. Frosini, F. Riccobono (a cura di), L’ermeneutica giuridica
di Emilio Betti, cit., p. 175. Riccobono, in queste righe, fa
riferimento alle parole di Betti in Le categorie civilistiche
dell’interpretazione, in “Rivista italiana di scienze giuridiche”, 55, 1948, pp. 34-92).
63 Sottolineano con particolare efficacia i caratteri di
una simile «virtù etica» dell’interpretazione giuridica, che risiede «nel fine di far emergere i valori della
giustizia sotto forma di significati normativi» (cfr. F.
Riccobono, Emilio Betti e la “malattia kelseniana”, in V.
Frosini, F. Riccobono (a cura di), L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, cit., p. 177), le parole dello stesso Betti
(Interpretazione della legge e degli atti giuridici, cit., p. 142):
«Essa interpretazione ha sempre l’ufficio di vivificare
mediante un incessante ripensamento, di aggiornare
e di rimettere a nuovo – seguendo passo passo il moto
perenne della vita sociale – le espressioni e le formulazioni sorpassate, conferendo loro quel valore che, senza
distaccarsi e prescindere dal significato originario, sia
meglio conforme alle esigenze dell’attualità nella cornice del sistema».
182
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Il fenomeno interpretativo risulta in tal
modo, per Betti, strutturato in due distinti
momenti, entrambi indispensabili per una
corretta interpretazione: al momento esclusivamente ricognitivo del senso originario della disposizione, così come esso si configurava
storicamente, con riferimento allo specifico
ambiente sociale del momento della creazione della norma, deve seguire necessariamente
il momento riproduttivo o rappresentativo,
che superi tale senso originario per consentire alla legge di adeguarsi al presente al quale
essa deve essere applicata64. Parlando di interpretazione giuridica Betti è al riguardo chiarissimo: «L’interprete ha bisogno anche qui
di ricostruire, anzitutto, l’idea originaria della
formula legislativa, o il senso iniziale dell’atto
giuridico, pur non avendo, con questo, finito
di adempiere il suo compito. […] L’interprete
deve raffigurarsi nelle reazioni e ripercussioni
pratiche, e in questo senso drammatizzarsi»65,
mirando, in presenza di atti concreti disciplinati dal diritto, «a ricavare dal tipo della
dichiarazione emessa o del comportamento
tenuto il senso che vi ricollega l’ambiente sociale, e così ad integrare nel suo contenuto la
fattispecie dell’ atto giuridico, raffrontandola
alla fattispecie legale. […] E quanto più generali e astratti sono i termini in cui il precetto è
formulato, quanto più remoto esso si presenta
dalla concreta situazione di fatto per la quale
deve valere, tanto più si avverte l’esigenza che
esso venga rielaborato e rinnovato, adattato
e adeguato alla vita e alla natura dei rapporti
disciplinati»66. I due momenti in cui si risol64 Cfr. E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., p.
825: «L’interpretazione della legge viene a trovarsi dinanzi a un duplice compito: a) ricercare la valutazione
originaria immanente alla norma nella sua concatenazione con l’intero ambiente sociale in cui fu emessa: e
ciò, mediante un’interpretazione che si è chiamata sociologica e meglio si direbbe teleologica; b) inoltre, ricercare se la norma ha maturato un esito sociale ulteriore, ancorché non intenzionale, consistente nel comporre il conflitto fra le altre categorie d’interessi all’infuori
di quelli previsti».
65 Ibidem, pp. 803-804.
66 Ibidem, p. 805. Ancora più chiare, se possibile, sono le parole di Betti a p. 817 della stessa opera:
«Nell’interpretazione giuridica di un ordinamento in
vigore il giurista non si può arrestare a rievocare il sen-
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
ve l’interpretazione giuridica, afferma Betti, si
trovano in uno stretto rapporto di necessaria
complementarietà, e tale rapporto è così forte che ognuno di essi, in assenza dell’altro, fa
divenire l’interpretazione giuridica un’attività
“morta”, priva di qualsivoglia risvolto pratico:
infatti, da un lato, risolvendosi l’interpretazione giuridica, come si è visto, in un intendere
per agire e non in un intendere tout court, una
ricognizione storica del senso della legge che
non abbia “continuazione” nell’attualità rimane semplicemente fine a se stessa; dall’altro,
in assenza di un’opera storica di ricostruzione della ratio ispiratrice della norma, e cioè in
caso di assoluta mancanza di qualsiasi punto
di riferimento concretamente contestualizzato, non è possibile neppure iniziare il lavoro di
adattamento alle nuove esigenze dell’attualità
che l’applicazione della norma è finalizzata a
soddisfare67.
La disamina della configurazione bettiana
della corretta metodologia dell’interpretazione giuridica, articolata nei due momenti appena analizzati, merita di essere completata
con tre diverse osservazioni, che servono per
meglio inquadrare l’orizzonte in cui si muove
e nella cui orbita gravita la teoria dell’interpretazione di Betti, e che confermano ulteso originario della norma – come se si trattasse di un’entità storica, di un fatto del passato, avente un senso in
sé conchiuso –, ma deve fare un passo avanti. […] Qui,
pertanto, l’interprete non ha ancora finito di adempiere
il suo compito, quando ha ricostruito l’idea originaria
della formula legislativa, (cosa che deve pur fare), ma
deve, dopo ciò, mettere d’accordo quell’idea con la presente attualità, infondendovi la vita di questa, perché è
appunto a questa la valutazione normativa dev’essere
riferita».
67 Cfr., con riferimento a questa seconda osservazione,
E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 824: «La
ricognizione della valutazione originaria immanente e
latente nella lettera della legge e costituente la ratio iuris
della norma è indispensabile per accertare in qual misura essa abbia subito modificazioni col sopravvenire
di mutamenti nell’ambiente sociale o di nuovi orientamenti nell’ordine giuridico: giacché solo attraverso il
tramite di essa, e non già immediatamente, è legittimo
procedere ad un adattamento e ad una trasposizione del
testo legale nella viva attualità, e bilanciare giustamente
l’interesse statico alla stabilità, conservazione e certezza
con l’esigenza dinamica di rinnovamento nell’indirizzo
dell’evoluzione sociale».
183
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
riormente come egli possieda lo spirito tanto
dello scienziato giuridico, quanto del filofoso,
quanto ancora del giusrealista. In primo luogo, Betti osserva che, come il diritto, pur non
essendo solo norma, è anche, inevitabilmente,
norma, così l’interpretazione deve, comunque,
operare tenendo presente, come imprescindibile punto di riferimento da cui partire e come
delimitazione dei confini della propria ricerca
di senso, la legge da interpretare: «Betti intese
difendere, quale conquista non revocabile del
pensiero, la possibilità di una interpretazione
in grado di cogliere il senso del testo a partire
dal testo stesso e non dalla soggettività dell’interprete, supponendo che esso, per così dire,
fosse tutto contenuto nello scritto, sia pure
soltanto allo stato latente, ed avesse bisogno
di essere attualizzato, cioè portato a nuova vita
attraverso l’attività interpretativa»68. Risulta
assai evidente come, alla luce di tale principio, per cui l’interprete, nell’intraprendere il
proprio compito attualizzante del diritto deve
sempre, necessariamente, fare riferimento
alla legge (considerata nella sua appartenenza al più vasto sistema normativo che forma
l’ordinamento giuridico69) e al suo testo, e per
cui «le sens doit être tiré du texte et non pas
dicté de l’extérieur»70, secondo il canone latino
«sensus non est inferendus, sed efferendus»,
Betti sia avvicinabile ai sostenitori di una “geometria legale” che circoscriva l’interpretazio68 F. Bianco, La Teoria generale dell’interpretazione
nel dibattito ermeneutico contemporaneo, in V. Frosini, F.
Riccobono (a cura di), L’ermeneutica giuridica di Emilio
Betti, cit., pp. 29-30. Lo stesso Betti (cfr. Teoria generale
dell’interpretazione, cit., p. 808), afferma perentoriamente che «il giurista interprete e il giudice […] hanno una
posizione di stretta subordinazione alla legge».
69 Betti è particolarmente convinto nell’insistere
sull’importanza del canone della totalità, per cui occorre
effettuare un perenne riferimento «delle parti al tutto
e perciò anche un riferimento delle norme al loro organico complesso» (cfr. Teoria generale dell’interpretazione,
cit., p. 831). L’Autore, tornando più volte sul tema, nel
suo capolavoro (Ibidem, p. 822) afferma, per esempio:
«L’apprezzamento interpretativo rimane pur sempre
vincolato e subordinato alla linea di coerenza logica e
assiologica che si dimostra immanente all’ordine giuridico considerato nella sua organica totalità».
70 J. Grondin, L’universalité de l’hermenétique selon Emilio
Betti, in V. Frosini, F. Riccobono (a cura di), L’ermeneutica
giuridica di Emilio Betti, cit. p. 123.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
ne al testo della legge e nulla più.
In secondo luogo Betti rileva che, come il
diritto, pur essendo norma, non è solo norma,
ma Valore, così l’interpretazione non può, pur
partendo necessariamente dal testo di legge,
limitarsi ad esplicitarne il senso così come
esso emerge dalla mera considerazione della costruzione grammaticale o sintattica del
linguaggio legislativo, ma deve andare oltre
la barriera linguistica della disposizione, per
individuare il “principio generale” che ne sta
alla base, il tutto, ovviamente, in funzione
della sua attualizzazione pratica sulla base del
principio individuato. Per Betti i principi generali – particolarmente utili nei casi in cui la
legge si manifesti lacunosa e perciò inidonea
a prendere in considerazione i nuovi interessi che l’attualità storico-sociale produce ogni
giorno – sono «l’idea germinale, il criterio di
valutazione, di cui la norma costituisce la messa in opera, calata in una specifica formulazione precettiva71»: essi, diretta espressione della
più profonda e radicata essenza etica di una società, cioè, si potrebbe dire, della sua “tradizione morale”, «sono da concepire […] come somme valutazioni normative, principi e criteri di
valutazione costituenti il fondamento dell’ordine giuridico e aventi una funzione genetica
rispetto alle singole norme»72. Assurgendo a
valori e sistemi di valori che rappresentano
l’antecedente logico e cronologico delle singole norme, tali principi generali non possono,
quindi, essere mai identificati con esse, e, proprio in quanto complesso di valori fondanti
le norme stesse – le quali non li rispecchiano,
con lo specifico comando contenuto nel testo
legislativo, se non in parte –, sono caratterizzati, rispetto al sistema positivo tutto, da una
forte «eccedenza di contenuto deontologico»73
che si traduce a sua volta, inevitabilmente, in
una rilevante «forza di espansione, ma non
già di indole logica e dogmatica, bensì d’indole valutativa e assiologica: forza non già di
“verità” e di ragione teoretica, ma di valori etici e delle loro valutazioni, che gradatamente
maturano e si affermano in base a situazioni
71 E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 846.
72 Ibidem, p. 851.
73 Ibidem, p. 849.
184
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
storiche contingenti»74. Ed è proprio tale forza
di espansione dei principi generali rispetto al
contenuto del comando delle singole norme a
costituire il veicolo imprescindibile perché le
norme stesse, attraverso l’indispensabile individuazione interpretativa di tali principi, possano “attualizzarsi”, fuoriuscendo dalla stretta
veste della disposizione linguistica generale ed
astratta in cui sono espresse, e siano così in grado di comporre la controversia, cioè il conflitto
d’interessi, che sotto la rubrica di una specifica
legge va ricondotto75. È evidente, così, come
attraverso il costante riferimento a Valori che
trascendono e precedono la positivizzazione
dell’ordinamento giuridico “manifestandosi”
solo parzialmente nel contenuto delle singole disposizioni, in modo che l’interprete deve
“percepirli” in esse per “espanderne” l’operatività alle concrete esigenze controversiali che
chiedono soddisfazione, Betti, oltre che scienziato del diritto, si riveli ancora una volta, un
filosofo autentico.
In terzo luogo, e in diretta conseguenza
rispetto alla precedente osservazione, va osservato che come il diritto è, per Betti, anche
esperienza, così anche l’interpretazione della
legge si configura, per l’Autore, come un’attività profondamente calata nella concreta dinamica dell’esperienza giuridica. Essa non è
un fenomeno astratto, destinato a restare fissato nella mente di chi lo compie o a fungere
da mero esercizio di ragionamento giuridico,
ma, in quanto tramite imprescindibile per
l’applicazione della legge, è la prima, effettiva,
attività pratica da prendere in considerazione come elemento indispensabile per la vita
stessa del diritto nel suo storico, quotidiano
74 Ibidem, p. 850.
75 Cfr., al riguardo, G. Zaccaria, Creatività dell’interpretazione e principi generali nell’ermeneutica giuridica di Emilio
Betti, in V. Frosini, F. Riccobono (a cura di), L’ermeneutica
giuridica di Emilio Betti, cit., pp. 198-199: «Correttamente
Betti radica i principi generali su di un terreno assiologico e valutativo, che precede l’ambito della positività
dell’ordinamento giuridico, e, altrettanto correttamente, a partire dal riconoscimento dell’insufficienza della
positività normativa e contestualmente di una necessaria creatività di una prassi giuridica, egli individua il vitale bisogno dell’ordine giuridico di inserire nel proprio
organismo i principi stessi».
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
“farsi”. Il corollario di una simile rilevanza
concreta del fenomeno interpretativo è che
– consistendo l’interpretazione in un’operazione di rinvenimento, a partire dalla legge,
di quei principi generali alla luce dei quali è
possibile comprendere appieno il contenuto
della legge stessa, ampliarne l’ambito operativo superandone la positività, attualizzarla e
applicarla alle controversie che chiedono soluzione per il suo tramite – anche per Betti assume particolare rilievo l’operato dei giudici.
L’Autore infatti, nell’affrontare la questione
relativa all’individuazione dei soggetti competenti ad “avvertire” la presenza latente dei
principi generali, giunge alla conclusione che
«l’organo della coscienza sociale nell’adempimento di tale compito deve oggi riconoscersi
nella giurisprudenza, intesa nel senso più lato
di giurisprudenza così teorica […] come pratica76». Ora, è palese che la giurisprudenza
“pratica” alla quale Betti si riferisce non può
che coincidere con la magistratura giudicante, ossia con il concreto operato dei giudici
all’interno delle aule giudiziarie: tale operato,
realizzandosi proprio nella sede principale
del dipanarsi dell’intera dinamica giuridica
di una determinata società, si traduce, in definitiva, in una tecnica di riformulazione della
norma, alla luce del principio individuato, da
parte del giudice: in altri termini, in un’attività eminentemente creativa. Sotto questa particolare angolazione, dunque, Betti dimostra
di aderire alle rivendicazioni dei più convinti
sostenitori delle tesi giusrealiste, che vedono
nella figura del giudice – produttrice di diritto nuovo – la figura cardine per l’effettivo
dispiegarsi dell’esperienza giuridica di una
singola, specifica comunità civile e politica.
76 E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, cit., p. 858.
Betti descrive con estrema precisione, poche righe più
oltre, i caratteri dell’opera giurisprudenziale relativamente al rinvenimento e all’utilizzazione dei principi
generali, ribadendo (Ibidem, p. 858) che «la giurisprudenza è competente a identificare e ad elaborare quei
principi generali di diritto che, offrendo direttive e
criteri di valutazione non esauribili in singole norme,
costituiscono gli indispensabili strumenti di un’interpretazione integrativa dell’ordine giuridico».
185
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
4.2. Segue: Giuseppe Zaccaria
L’altra figura che – nel descrivere la concezione di interpretazione della legge propria
del panorama culturale maggiormente legato, rispetto al “normativismo” e al realismo
giuridico, alle istanze caratteristiche della filosofia più autentica e a quelle dell’ermeneutica contemporanea – merita di essere presa
brevemente in considerazione, oltre a Emilio
Betti, è quella di Giuseppe Zaccaria, legittimamente annoverabile tra i più attenti studiosi
italiani in materia, autore di numerose opere
sull’interpretazione77, anche con specifico riferimento a Gadamer ed Esser. Oltre che fine
“fotografo” del panorama giusfilosofico a sé
contemporaneo, Zaccaria sviluppa un pensiero “indipendente” sui generis, che, raccogliendo e riplasmando autonomomamente, apportandovi nuovi contorni originali, l’eredità dei
suoi predecessori e contemporanei studiosi di
ermeneutica, assurge ad emblema della riflessione sull’interpretazione giuridica italiana
contemporanea, caratterizzandosi, alla stessa
maniera di Emilio Betti, per il fatto di “mediare” filosoficamente e criticamente tra le esigenze normativistiche della Scuola di Torino
e quelle enfatizzanti il concreto ruolo creativo
del diritto del giusrealismo analitico italiano.
La speculazione di Zaccaria si caratterizza per
essere fautrice di un’ermeneutica giuridica
che, con Heidegger e Gadamer, prima ancora
di tradursi in “metodo”, sia innanzitutto pienamente consapevole di sé e del proprio fondamento filosofico-esistenziale avente il proprio perno nella rilevantissima categoria della
precomprensione.
Aderendo alle tesi di Gadamer, Zaccaria, infatti, individua innanzitutto nell’ermeneutica
una radice ontologica strettamente dipendente dalla modalità di estrinsecazione dell’esi77 Ai fini del presente elaborato si terrà in particolare considerazione, nell’ambito della bibliografia di
Zaccaria, la raccolta L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, Milano, 1990. Per
altri lavori dell’Autore in materia di interpretazione,
cfr.: Diritto positivo e positività del diritto, Torino, 1991;
Questioni di interpretazione, Padova, 1996; Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Bari,
1999.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
stenza dell’uomo nel mondo: tutto, nell’esistenza, è interpretare, il darsi dell’individuo
è un continuo, ineliminabile interpretare per
comprendere, e l’uomo può qualificarsi «come
un ente, il cui essere consiste nel comprendere: ogni teoria della conoscenza diviene immediatamente ontologica»78. Allo stesso modo
del filosofo di Marburgo, inoltre, anche Zaccaria ritiene che l’essenza umana, nel suo essere
una sola cosa con l’ontologica interpretazione
del tutto in cui essa consiste e che la sottende,
non possa darsi se non attraverso il linguaggio,
che si configura, così, sia come la forma prima
del “respiro” del darsi del mondo all’uomo, sia
come mezzo imprescindibile perché egli esista e percepisca di esistere come essere “condannato” ad una perenne interpretazione del
tutto79. E il nodo problematico dello sviluppo
dell’esistenza interpretante attraverso il linguaggio si risolve – ancora una volta secondo
una identità di pensiero rispetto a Gadamer –
nel «gioco della logica di domanda e risposta,
nella relazione dialettica tra l’interprete e l’opera da interpretare»80. Infine, per Zaccaria, così
come per Heidegger e Gadamer, l’esistenza
come interpretazione, il linguaggio come condizione comune e mezzo per l’interpretazione,
e la dialettica domanda-risposta come nodo
per il darsi dell’interpretazione nell’esistenza,
non possono prescindere dall’ineliminabilità,
alla radice di ogni atto ermeneutico, della precomprensione. Essa, effetto dell’essere gettato
dell’uomo nella storia e nell’infinità di messaggi comunicativi già interpretati di fronte ai
quali è costretto continuamente a porsi, consiste in un orizzonte precedente di conoscenza,
anteriore a qualsiasi comprensione, senza il
quale non è possibile nessuna comprensione,
cioè nessun atto ermeneutico. Identificandosi
in una vera e propria “anticipazione di senso”
78 G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, cit., p. 42.
79 Si veda, al riguardo, G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, cit.,
p. 81, in cui l’Autore afferma che il linguaggio è un «fenomeno umano originario, sul quale si fonda il fatto che
gli uomini hanno un mondo. Reciprocamente, il mondo
è tale in quanto si esprime e si costruisce nel linguaggio
e attraverso il linguaggio».
80 Ibidem.
186
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
e di risultato – condizionata dall’essere nella
storia dell’uomo – che precede qualsiasi questione interpretativa, la precompensione, in
altri termini, delimita alla radice lo spazio e la
direzione in cui i testi e gli oggetti da interpretare sono utilizzati, risultando così la conditio
sine qua non di tutti gli specifici procedimenti
interpretativi.
Zaccaria, dunque, solo dopo aver preso atto
dell’imprescindibilità della precomprensione
come dato esistenziale strettamente connesso
all’intima natura dell’uomo, identifica in essa
lo snodo concettuale alla luce del quale è possibile passare dalla fase del riconoscimento filosofico delle radici prime dell’ “interpretare”
alla fase del tentativo di delineare i tratti di un
possibile “metodo” ermeneutico che riesca a
fornire un minimo di certezza relativamente
ai risultati di ogni atto interpretativo, così da
fungere da parametro di riferimento per le interpretazioni future. L’ermeneutica filosofica
di Zaccaria diviene, in altri termini, necessariamente anche ermeneutica metodologica,
dal momento che, a causa dell’anticipazione di
(possibile) significato sulla cui base l’interprete si avvicina all’oggetto da interpretare, si rivela doveroso ricostruire i passaggi attraverso
cui egli, dalla precomprensione stessa, giunge
a fornire il significato definitivo all’oggetto
della propria analisi.
Ora, il procedimento ermeneutico in generale, coerentemente inserito tra la comprensione iniziale e quella finale, non è, per Zaccaria, lineare, proprio in virtù della non linearità
della modalità formativa della precomprensione dell’uomo, ma si risolve – dialetticamente
– «in una ininterrotta posizione di ipotesi,
in una loro successiva revisione ed infine in
un loro eventuale abbandono a favore di altre
ipotesi. Ognuno dei passi alternati in cui esso
si articola ha per scopo di chiarire l’altro e insieme di approssimarsi all’obiettivo»81, cioè
81 G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, cit., p. 67. Quanto si viene dicendo è efficacemente chiarito in modo ancora più
esaustivo dalle stesse parole dell’Autore (Ibidem): «La
precomprensione non è un concetto metodologico-prescrittivo, ma un concetto analitico-descrittivo, che pone
appunto un rilevante problema metodologico, quello
dei modi e dei controlli del passaggio dalla comprensio-
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
all’interpretazione conclusiva82.
Per quanto riguarda, più specificamente, il
pensiero di Zaccaria relativo all’ermeneutica
giuridica, è necessario sottolineare che la ricostruzione che l’Autore effettua dell’attività di
interpretazione della legge prende lo spunto
dal convincimento per cui «la legge altro non
è che uno stato necessariamente incompiuto e
transitorio, anche se dotato di una forza normativa vincolante, del processo di concretizzazione del diritto; un “semilavorato” […] che
solo ignorando il contributo decisivo di chi applica il diritto può essere confuso con un prodotto finito»83. In definitiva Zaccaria ritiene
che, a causa della genetica ed insopprimibile
distanza che non può non sussistere tra la legge, generale ed astratta, e la particolare specificità di ogni caso concreto, la fase di applicazione della prima al secondo deve sempre passare
attraverso un’opera di concretizzazione che si
realizza mediante l’integrazione produttiva
del diritto operata dall’interpretazione84: come
ne provvisoria a quella conclusiva. […] Il comprendere
consiste nell’analisi, nella penetrazione e revisione di
uno schema progettuale di significato che è all’origine
dell’accostamento al testo e che è rettificabile se nel corso del processo di comprensione si riveli inadeguato. Tra
precomprensione, quale atto di inizio del comprendere
[…] e reperimento della massima di decisione, quale
punto conclusivo, si stende una fitta rete di sondaggi e
di anticipazioni di possibili soluzioni che, grazie al metodo dialogico delle domande rivolte al testo, consente
di consultare i modelli […] in rapporto alle risposte che
possono offrire».
82 A sua volta tale obiettivo – l’interpretazione finale,
che chiude il procedimento ermeneutico – sarà sempre
suscettibile, entrando a far parte della storia come interpretazione gettata nel divenire incessante delle cose, di
costituire il fondamento di una nuova, diversa precomprensione rispetto allo stesso oggetto interpretato, e di
innescare un nuovo procedimento che da essa giunga
ad un ulteriore, differente, esito interpretativo-conoscitivo di significato, e così via, in una dinamica (gadameriana) “spirale ermeneutica” senza fine.
83 G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica giuridica contemporanea, cit., p. 87.
84 Cfr. Ibidem: «L’ermeneutica giuridica è definita teoreticamente dal riconoscimento che la norma astratta
rivela una struttura necessariamente incompleta, completabile soltanto nel procedimento ermeneutico di
concretizzazione della norma giuridica all’interno della
decisione di un caso pratico». L’autentica interpretazione si risolve, per l’Autore, «in un necessario ampliamento del testo giuridico positivo: un ampliamento che
187
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
d’altra parte Betti, egli sostiene che l’interpretazione giuridica è il tramite grazie al quale la
legge, dalla quale si deve “geometricamente”
e scientificamente pur sempre partire85, da
semplice “traccia” di ordine diviene ordine,
concretizzandosi in una massima di decisione
che la applichi al caso concreto sottoforma di
provvedimento giurisdizionale.
In quest’ottica anche la ristretta metodologia dell’interpretazione giuridica si configura,
per Zaccaria, come un’ermeneutica caratterizzata da un’ineliminabile circolarità86, la quale,
come si accennava, filosoficamente media tra
le istanze normocentriche del neopositivismo
giuridico e quelle giudiziali del giusrealismo
analitico, sostanziandosi in due fondamentali
passaggi che si trovano in perenne “osmosi”
reciproca: il primo passaggio consiste nella
trasformazione, da parte dell’interprete e alla
luce della sua precomprensione, della circostanza di fatto – la situazione controversa da
resta definito dal condizionamento rappresentato dalla
comprensione del testo normativo con riguardo al caso
da decidere».
85 Zaccaria sottolinea infatti, a questo proposito, come
l’interprete, e in particolare il giudice che la legge è chiamato ad interpretare per applicarla poi al caso concreto,
si trovi, pur nella facoltà che gli è concessa di innovare e
integrare il testo di legge per meglio calibrarlo alla controversia, in un imprescindibile rapporto di dipendenza nei confronti della legge stessa, dal momento che il
possibile ritrovamento di nuovi significati normativi
alla luce del caso sussunto nella disposizione «si sviluppa sempre muovendo dal punto di osservazione del testo di legge» (G. Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi
sull’ermeneutica giuridica contemporanea, cit., p. 56). Cfr.
anche Ibidem, p. 225: «Il testo letterale dell’enunciato
normativo conserva […] un’irrinunciabile funzione di
limite, definibile soprattutto in negativo: lo spazio di
concretizzazione della norma, e le possibilità di sviluppo che in esso si danno, non possono mai andare oltre i
confini tracciati dalla lettera del testo».
86 Il processo ermeneutico, produttivo di diritto a partire dalla legge, è per Zaccaria circolare nel senso che, coerentemente rispetto alle regole del “gioco” tra domanda
e risposta che caratterizza il dialogo dialettico e che si è
poco sopra esaminato, «mentre al testo può competere
un significato soltanto nella prospettiva di una domanda, necessaria per introdursi in esso, il testo stesso può
poi ripercuotersi sull’interprete e sulla sua comprensione, modificandone la domanda preliminare» (cfr. G.
Zaccaria, L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’ermeneutica
giuridica contemporanea, cit., p. 100).
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
risolvere in via giudiziale – in circostanza rilevante per il diritto sulla base dell’idea di diritto che è già all’origine del suo accostamento
al caso; il secondo passaggio consiste nel porre
in relazione il caso concreto, così ricostruito e
rielaborato, con il modello normativo e astratto della norma. In altri termini, a partire dalla norma si ricostruisce il fatto, e a partire dal
fatto così delineato, si ritorna alla norma, per
applicarla al caso: in questa spirale di continui
rimandi reciproci fra i termini di riferimento
del procedimento ermeneutico, accade che se,
nel primo passaggio, la norma attribuisce connotati di giuridicità ai fatti in essa sussunti, nel
secondo, invece, essa stessa si arricchisce dei
connotati di novità storica dei fatti che prende in considerazione87. A seguito, e per mezzo,
di queste fasi, avviene la vera e propria concretizzazione della norma giuridica rispetto
allo specifico caso concreto, ossia il “miracolo
interpretativo” per cui – passando dialetticamente dalla norma al fatto, dal fatto ancora alla
norma, e da essa, arricchita da tali passaggi, alla
sentenza – la norma generale ed astratta diviene un “abito” perfettamente calibrato rispetto
alle “misure” della controversia da cui è sorta
la questione interpretativa, e per cui è possibile giungere al provvedimento applicativo della
legge che compone la controversia stessa. La
circolarità dei due momenti del procedimento ermeneutico-giuridico implica, perciò, che
«nel suo concreto prodursi giudiziale il diritto
è la conclusione, la salita in cerchi concentrici
sempre più verso l’alto, che congiunge l’interpretazione della legge e l’interpretazione delle
circostanze di fatto»88, sulla base di un costan87 Le parole dell’Autore (cfr. Ibidem) in ordine alla descrizione della dialettica norma-fatto sono esemplari:
«La considerazione astrattizzante – cui il fatto concreto,
nel momento dell’interpretazione è sottoposto – in base
alla quale vengono considerati solo i tratti rilevanti al
fine di sussumerlo nella serie di tipi che formano il modello normativo, non è mai così totale da impedire che
il nuovo elemento, assimilato a quelli già costituenti la
serie, immetta in essa un residuo di quella irriducibile novità che è propria del reale. In tal modo la serie di
tipi che costituiscono la fattispecie viene ridefinita sulla base dell’aggiunta di questo nuovo elemento. Infine
questa ridefinizione si traduce in nuovo significato della regola».
88 G. Zaccaria¸ L’arte dell’interpretazione. Saggi sull’erme-
188
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
te apporto creativo del diritto “giurisdizionale” nei confronti della legge.
Va, infine, segnalato, alla luce di quanto si
è venuto dicendo, un ulteriore, fondamentale
corollario della dottrina dell’interpretazione
giuridica elaborata da Zaccaria: si tratta del rilievo per cui, se l’ermeneutica giuridica consiste in un continuo lavorìo che, partendo dalla
legge generale ed astratta, giunge alla decisione della controversia attraverso un rimando
dialogico tra disposizione e fatto concreto, in
modo che entrambi tali elementi si arricchiscano via via sempre più fino a condurre all’interpretazione più corretta rispetto al caso concreto stesso, allora muta radicalmente anche la
concezione della positività dell’ordinamento
giuridico. Zaccaria in effetti, in ciò prendendo
le distanze dalla ancora consolidata tendenza
dottrinaria contemporanea, per la quale – sulla base di una forte eredità di matrice “scientifica” – il diritto positivo è costituito solamente
dall’ordinamento normativo vigente, ritiene
che il “positivo” sia una dimensione dialetticamente integrante «l’omogeneità del “giuridico”, comprendendo organicamente […] non
solo i dati normativi del diritto scritto, ma anche i procedimenti interpretativo-creativi che
in rapporto ad esso si formano. Ciò è possibile
collocando al centro – e proprio per questo non
all’inizio, né alla fine del ciclo produttivo del
diritto – il testo normativo e riconoscendo la
stretta continuità tra fonti scritte e non scritte
di produzione del diritto»89. L’Autore affronta
a più riprese, nella sua opera, l’argomento, affermando che, non potendo essere concepita
come un semplice insieme di norme, ma dovendo allargarsi fino a ricomprendere i processi di concretizzazione del diritto, «la positività non è, ma si produce»90 dinamicamente in
un «processo ininterrotto di positivizzazione,
indissociabile dalla concretezza degli atti che
costituiscono il diritto come posto»91. In altri
termini, Zaccaria, nel sostenere che l’uomo è
esperienza interpretante gettata storicamente
in una data società, e nel ritenere che, inevitaneutica giuridica contemporanea, cit., p. 55.
89 Ibidem, p. 20.
90 Ibidem, p. 222.
91 Ibidem, p. 58.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
bilmente, anche nella più ristretta esperienza giuridica, rivesta un ruolo ineliminabile
proprio l’attività ermeneutica di interpretazione-attualizzazione delle norme, giunge a
individuare nella positività del diritto, quale
«fenomeno comprensivo sia del diritto legislativo, sia di quello giurisdizionale, con i suoi
procedimenti di valutazione ermeneutica, e
altresì […] del deposito dottrinale di massime
e orientamenti scientifici, e più ampiamente
del necessario riferimento all’intera tradizione
giuridica»92, non il presupposto del prodursi
dell’esperienza giuridica, ma il prodotto, anzi,
addirittura l’essenza profonda dell’esperienza
giuridica stessa.
Conclusione
Seguendo la traccia solcata dalla contemporanea speculazione ermeneutica di cui, nelle righe che precedono, si sono analizzati, sia pure
brevemente, anche attraverso la sintetica delineazione delle specificità del pensiero di due
tra i suoi massimi esponenti, i tratti essenziali, è possibile dunque affermare che, agli albori
del terzo millennio, l’esperienza giuridica, alla
luce e per mezzo dell’ineluttabilità umana del
fenomeno interpretativo, sia pure a fronte del
tecnicismo e della tecnologizzazione esasperata cui essa, sotto i più svariati versanti, sembra
destinata ad andare incontro negli anni a venire, si configura in maniera tale per cui «il diritto positivo è tale non in quanto semplicemente positum ma piuttosto in quanto institutum
nella realtà sociale da cui sorge»93, così che
l’ineludibilità del fenomeno interpretativo, sia
dei fatti che di quanto è meramente positum,
non può non accompagnarsi all’ineludibilità
della reciproca comunicazione, reciprocamente interpretante, di tutte le istanze e di tutti gli
strumenti tecnici che sono nella disponibilità
di tutte le parti (privati, avvocati, giudici) coinvolte nel luogo, il tribunale, in cui si sviluppa
la dinamica della vita giuridica.
Non ci si può, in ogni caso, esimere dal segnalare che i rischi connessi alla decisa rivendicazione dell’imprescindibilità del momento
92 Ibidem, p. 233.
93 Ibidem, p. 229.
189
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
interpretativo e alla conseguente ridefinizione del concetto di positività che si sono delineate sono, per la configurazione tradizionale
dell’esperienza giuridica, resa monolitica e granitica anche in virtù della propria resistenza a
scardinare concezioni fortemente saldate, nel
corso dei decenni, nella forma mentis dei giuristi continentali, notevoli. È infatti evidente
come, in una tradizione giuridica fondata, alla
luce del principio-guida illuministico della tripartizione dei poteri, sulla garanzia dei cittadini raggiunta attraverso la codificazione e la concezione dell’interpretazione come sillogistica
estrazione di significati già impliciti nelle norme, le frontiere dell’ermeneutica, legittimanti
comunque l’inserimento di componenti eminentemente soggettive nel momento interpretativo, che viene concepito come il nucleo
fondante il prodursi dinamico dell’esperienza
giuridica, conducano alla destabilizzazione
potenziale del sistema giuridico contemporaneo nella sua globalità. Sembrerebbe, cioè, che
gli argini posti all’arbitrio dell’esecutivo e del
legislatore attraverso la separazione dei poteri, la capillare codificazione legislativa, e la
concezione dell’interpretazione come attività
ricognitiva, oggettiva e “meccanica”, del contenuto della legge, possano crollare per opera
della nuova teoria dell’interpretazione dell’ermeneutica giuridica: essa, per quanto circoscriva l’imprescindibile carattere soggettivo
dell’interpretazione attraverso il forte convincimento che la norma positiva debba essere
sempre il punto fermo per ogni concreta “azione” ermeneutica, di fatto, però, apre le porte
alla crisi delle colonne portanti stesse della
nostra secolare impostazione giuridica. Se, in
effetti, dal punto di vista teorico l’esperienza
giuridica non è più esperienza esclusivamente normativa, ma esperienza complessiva, in
cui la legge positiva, i fatti, i Valori si congiungono a formare un’unica dimensione esistenziale tagliata trasversalmente, e così mediata,
dall’interpretazione, da intendersi quale momento da cui ogni istante della vita dell’uomo
è permeato; e se, dal punto di vista della prassi
giudiziaria, una simile nuova impostazione
si traduce nella ri-qualificazione del ruolo del
giudice, primo soggetto depositario del comL’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
issn 2035-584x
pito interpretativo – ossia dell’azione che più
di ogni altra “crea” l’esperienza giuridica in un
fluido rigenerarsi continuo della stessa –, così
che il “positivo” si ricrea perennemente su se
stesso, una volta contestualizzato rispetto al
caso, di fronte ad ogni nuova controversia, attraverso una decisione che “ritaglia” la legge
secondo un profilo, sempre nuovo, perfettamente calibrato agli estremi concreti della controversia stessa; se è così, allora non può non
emergere il rischio che, per una sorta di paradosso giuridico-esistenziale, le nuove tecniche
filosofico-intepretative, in grado di percepire
nella sua completezza la dimensione ontologica dell’essere umano nel mondo, si traducano,
una volta attuate nell’esperienza giuridica, in
una potenziale incrinatura di quelle garanzie
che sono poste, anch’esse, proprio a tutela e
garanzia della dimensione sociale dell’essere
umano. In un simile panorama, prima fra tutte ad entrare potenzialmente in crisi è proprio
la garanzia che, in una materia delicatissima
come il diritto penale, è attuata dalla posizione
e dal rispetto del principio di legalità, il quale
oggi, dunque, come si afferma da più parti, «è
in crisi in virtù delle acquisizioni sempre più
cogenti provenienti dalla ermeneutica giuridica, che hanno falsificato il criterio metodologico, su cui si reggeva il dogma della legalità
e della sottoposizione rigida del giudice alla
legge, ipotizzante un rapporto univoco di dipendenza del risultato dell’interpretazione dal
testo di legge»94.
94 M. Ronco, La legge penale: fonti, tempo, spazio, persone,
Torino, 2006, p. 20. Nello stesso testo l’Autore (che si
cita nelle righe seguenti) opera una descrizione approfondita, sorretta anche da un’ampia ed esaustiva panoramica storica, del significato del principio di legalità
in materia penale, secondo il quale «la norma penale è
legittima soltanto quando il suo oggetto sia stabilito da
una legge precisa e determinata». Si tratta di un principio che, inoltre, è ancorato ad un solido fondamento
giuridico-penalistico finalizzato a garantire la certezza del diritto in materia penale, e ad un fondamento
politico-costituzionale per cui esso è teso a garantire i
cittadini dall’abuso e dall’arbitrio tanto del potere esecutivo quanto del potere giudiziario. Ora, l’ermeneutica
giuridica contemporanea, rivendicante princìpi radicati nell’essenza e nella dignità di ogni essere umano in
quanto tale, sembrerebbe aprire le porte, in virtù delle
proprie istanze ontologicamente rivolte alla valorizzazione dell’imprescindibilità dell’interpretazione, al
190
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
Purtuttavia, nonostante la sussistenza dei
rischi che si sono descritti, la via maggiormente praticabile, per il futuro dell’esperienza giuridica, sembra essere comunque quella della
prosecuzione nel percorso di “introspezione
ermeneutica” della dimensione esistenziale dell’uomo e della sfera del giuridico, tanto
per la sua capacità, per ciò che attiene l’ambito
strettamente giuridico, di penetrare con precisione chirurgica nelle pieghe più profonde
del pulsare degli elementi fondanti l’esperienza giuridica stessa, quanto per la sua idoneità
a fungere da collante tra l’aspetto più tecnico
(la legge) della dinamica giuridico-processuale
contemporanea e il suo aspetto più discrezionale (l’operato del giudice). Tutto ciò, però, ad
una condizione, necessaria per fare in modo
che l’ineluttabilità dell’interpretazione non degeneri in veicolo demolitorio di ogni certezza
giuridica: a condizione che l’ermeneutica, nel
suo peregrinare tra i percorsi vibranti dell’essenza dell’umano e del giuridico, sia sempre,
filosoficamente, accompagnata dal senso, altrettanto ineludibile quanto l’interpretazione
stessa, della “giusta misura” tra gli eccessi.
Stefano Favaro, esercita in Padova la professione
forense in materia civile ed è dottorando di ricerca
in Filosofia del Diritto e Teoria Generale del Diritto
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova.
[email protected]
crollo – paradossale – di tali argini posti in realtà dal legislatore penale, a propria volta, come limite alla potenziale degenerazione in arbitrio dell’equità dell’organo
giudicante.
L’ineluttabilità dell’interpretazione normativa
191
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
La presenza Carlista a Trieste
Miguel Ayuso
Francesco Maurizio Di Giovine
Abstract
Parole chiave
La presenza Carlista a Trieste è rappresentata da tre
luoghi della città che testimoniano tangibilmente la
storia della famiglia reale proscritta di Spagna e del loro
seguito: il palazzetto di via del Lazzaretto Vecchio 24,
nel quale vissero Carlos V, la principessa di Beira, Carlos
VI e la consorte; la cappella di San Carlo in cattedrale,
dove sono seppelliti Carlos V e la consorte, Carlos VI e la
consorte, Juan III e Carlos VII; il campo III del cimitero
di S. Anna, che raccoglie i resti di uomini e donne fedeli
al tradizionalismo e che seguirono fino alla morte la
dinastia legittima di Spagna.
Carlos V
Carlos VI
Juan III
Carlos VII
Beira
Carlismo
Legittimità
Tradizionalista
Tristany
Cabrera
Q
ste del primo re Carlista (1848), alla morte della
regina Maria Teresa (1874), ultima abitante del
piccolo palazzo reale di via del Lazzaretto Vecchio. Non molti anni, ma sufficienti per aver
lasciato una profonda traccia nella storia del
Carlismo, al punto tale da poter parlare di un
Carlismo triestino. Questa, per sommi capi, è
la sua storia.
Carlos di Borbone, secondogenito del re di
Spagna Carlos IV, aveva sposato una donna
dal grande acume politico e dai fermi principi cattolici e legittimisti: la principessa Maria
Francisca di Braganza (1800 – 1834), figlia di
Giovanni VI re del Portogallo dal 1792 al 1806.
Alla morte di Ferdinando VII (1833), suo fratello, in assenza di eredi maschi del re, divenne il
legittimo successore in quanto primo maschio
in ordine di successione. Ma per le tresche della vedova di Ferdinando VII, Maria Cristina di
Borbone, nata principessa reale delle due Sicilie (1806 – 1878) e di sua sorella, la principes-
uando in Spagna, tra i cultori della storia
nazionale, si cita la città di Trieste, la memoria associa il luogo alla cattedrale di San Giusto, perché essa custodisce le spoglie mortali
della Famiglia Reale Proscritta di Spagna. Carlos
V, Carlos VI, Juan III, Carlos VII rappresentarono l’incarnazione della legittimità dinastica
conculcata dalla rivoluzione liberale che impose sul trono di Spagna una linea di successione
illegittima e fuori dalla tradizione.
Vi è, comunque, un altro luogo di Trieste
caro alla memoria storica degli spagnoli. E’ un
piccolo palazzo sito in via del Lazzaretto Vecchio. In esso, al secondo piano, vissero i primi
due Sovrani Proscritti, con il piccolo seguito, e,
dopo di loro, ancora per 13 anni, la vedova di
Carlos V, la regina Maria Teresa, nata principessa di Beira.
La presenza dei Reali di Spagna in esilio fu
fortemente significativa e si esaurì nell’arco di
26 anni, quanti ne trascorsero dall’arrivo a TrieLa presenza Carlista a Trieste
192
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
sa Carlotta (1804 – 1844), che aveva sposato il
fratello più piccolo di Ferdinando VII, Francisco de Paula, appoggiate dal potente partito
liberale, per proclamare regina la figlia di Ferdinando VII, Isabella II (1830 – 1904), sotto la
reggenza della madre. Attorno a Don Carlos si
schierarono i vecchi realistas, coloro che avevano combattuto l’ingresso dei napoleonidi
in Spagna e nella sua cultura, quanti avevano
difeso la tradizione delle Spagne nel Nuovo
Mondo. Fu la rottura. Attorno a Don Carlos si
coagulò un mondo che già resisteva alla francesizzazione della Spagna ed ora, finalmente,
prendeva un nome: carlismo. Iniziava a vivere
un movimento politico che attraverso la fedeltà a Don Carlos propagandò una idea di legittimità politica in nome di un principio e di
una dottrina che elaborò un forte pensiero in
continuo adattamento alle domande dei tempi, ma nel rigoroso rispetto con la continuità
e con la tradizione cattolica della Spagna e delle Spagne. Difendendo i diritti di Don Carlos i
carlisti rinnovavano il credo nell’idea politica
della monarchia cattolica, missionaria e federativa.
Don Carlos, quando morì suo fratello Ferdinando VII, si trovava in Portogallo, ospite del
suocero. Il soggiorno si trasformò immediatamente in esilio, che durò per tutta la vita. La
Spagna tradizionalista e cattolica entrò in conflitto con le forze liberali fedeli alla nuova dinastia liberale impostasi con l’inganno legale e
diede origine a quella che fu definita la prima
guerra Carlista (1833 – 1840) conclusasi, dopo
sette anni, con la sconfitta delle forze fedeli a
Don Carlos. Nel settembre del 1834, mentre
Don Carlos era segretamente rientrato in Spagna per mettersi al comando del sollevamento
Carlista, la principessa Maria Francisca, che
era rimasta in Inghilterra, ad Alverstoke, vicino a Portsmouth, si ammalò e l’11 settembre,
all’età di 35 anni, morì. La sorella Maria Teresa, principessa di Beira (1793 – 1874), era con
lei. Maria Francisca, morendo, le affidò la cura
dei figli. E la principessa di Beira assolse scrupolosamente al compito. Dopo aver seppellito
provvisoriamente la sorella nella cappella di
Gosport si consacrò totalmente alla causa di
Don Carlos.
La presenza Carlista a Trieste
issn 2035-584x
La principessa di Beira era vedova ed aveva
un figlio, Don Sebastian, che si mise al comando di reparti fedeli a Don Carlos nella guerra
contro le forze liberali ed isabelline. Maria Teresa di Beira nell’ottobre del 1838 entrò clandestinamente nel nord della Spagna e giunse ad
Estella dove sposò Don Carlos. La nuova regina
ricevette sul campo di guerra l’omaggio delle
forze carliste. Al termine della sfortunata guerra, Don Carlos e la nuova regina, Maria Teresa,
attraversarono la frontiera e passarono in Francia. Si stabilirono, assieme ai tre figli: Carlos
(1818 – 1861), Juan (1822 – 1887) e Ferdinando
(1824 – 1861), a Bourges, sotto la sorveglianza
di agenti della quadruplice Alleanza1. Nell’autunno del 1847 il Re Carlos V, protetto dalla
casa imperiale d’Austria, si trasferisce a Venezia, stabilendosi a palazzo Rezzonigo (oggi
sede del museo del Settecento Veneziano) e di
qui, a causa dell’instabilità politica della città,
il primo di aprile del 1848 passa a Trieste, sua
definitiva, benché ritenuta provvisoria, dimora nell’attesa di rientrare a Madrid.
A Trieste, i Reali di Spagna presero alloggio al secondo piano di un austero palazzetto
neoclassico sito in via del Lazzaretto Vecchio.
In quell’epoca, la via attraversava un quartiere
residenziale elegante e di recente formazione.
La via conduceva al primo Lazzaretto triestino
voluto dall’imperatore Carlos VI nel 1721, nel
quadro dei lavori di riqualificazione portuale
della città, divenuti indispensabili in seguito alla investitura di Trieste quale città porto
franco (1719). Il Lazzaretto fu realizzato in dieci anni nell’area di Campo Marzio, tra la Sacchetta e Sant’Andrea, per la contumacia delle
navi sospette. Il Lazzaretto comprendeva una
cappella, consacrata nel 1732 e dedicata a San
Carlo Borromeo, cosa che determinò la chiamata del posto con il nome di Lazzaretto San
Carlo. Nel 1769, Trieste venne dichiarata libera
città marittima, vale a dire con l’estensione del
porto franco a tutto il suo territorio. Per l’occasione fu costruito un nuovo Lazzaretto, sito
in un luogo più lontano dall’abitato, a Roiano.
Esso fu chiamato Lazzaretto di Santa Teresa in
1 Stipulata nel 1834, la Quadruplice Alleanza era formata da Francia, Inghilterra, Spagna liberale e Portogallo
contro gli interessi di Don Carlos.
193
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
onore dell’imperatrice d’Austria. Perciò il precedente Lazzaretto fu chiamato “vecchio” e la
denominazione si conservò nel nome della
strada. Il costruttore e primo proprietario del
palazzo di via Lazzaretto Vecchio fu Francesco
Gossleth (1792 – 1879). Ebanista affermato, nel
1828 aveva fondato a Trieste una grande fabbrica di mobili artistici che erano stati utilizzati
per arredare i palazzi delle più facoltose famiglie triestine. Anche il castello di Miramare era
stato arredato con i mobili usciti dalla fabbrica
del Gossleth. La sua falegnameria era sistemata nei vasti locali di pianterreno del palazzo
di via del Lazzaretto Vecchio. Di qui uscirono
i mobili che arredarono l’appartamento della
Famiglia Reale Proscritta, tra i quali il massiccio letto in cui morì Carlos V. Il 10 ottobre 1840
il Gossleth, avendo acquistato una villa in Largo del Promontorio, vendette l’edificio di Via
del Lazzaretto Vecchio 24, appena terminato,
al conte Don Ettore Lucchese Palli Pignatelli
de’ principi di Campoformio (1806 – 1864),
marito morganatico della duchessa di Berry2,
Maria Carolina di Borbone (1798 – 1870). La
duchessa di Berry aveva messo a disposizione dei congiunti, i Reali di Spagna, il secondo
piano del palazzo, riservandosi il primo piano
dove viveva quando, dalla Stiria, si trasferiva a
Trieste per essere più vicina ai due figli avuti
dal duca di Berry, Enrico e Luisa Maria3.
Il rigido cerimoniale spagnolo di corte cadenzò le giornate della famiglia reale proscritta e sebbene il Re Carlos V avesse rinunciato ai
diritti regali in favore del figlio maggiore, assumendo il titolo di conte di Molina, tutto il
seguito continuò a comportarsi come se egli
fosse ancora il Re della Spagna. Così via del
Lazzaretto Vecchio cominciò ad essere crocevia di incontri politici, diplomatici e cospirativi. I Reali di Spagna fecero del palazzetto di via
del Lazzaretto Vecchio il luogo di udienze di
un incessante pellegrinaggio di fedeli carlisti
2 Il palazzo dei reali di Spagna in esilio a Trieste, a cura di
Giuliana Marini ed Edoardo Marini, Trieste 1989, pagg.
8 -10
3 Il palazzo fu alienato dalla duchessa di Berry nel 1852,
quando acquistò a Venezia il palazzo Vendramin Calergi.
Qui, nel 1883 morì Richard Wagner ospite del Conte di
Chambord, Enrico di Borbone.
La presenza Carlista a Trieste
issn 2035-584x
che giungevano a Trieste, dopo mille difficoltà,
dalla penisola spagnola e dalle altre città europee in cui vivevano anch’essi in esilio. Il generale Cabrera, per fare un solo esempio, diede
inizio ad un nuovo sollevamento a favore della
causa Carlista dopo una udienza a Trieste.
La permanenza dei reali di Spagna a Trieste
è ancora tutta da studiare. Del lungo soggiorno
borbonico sappiamo ancora poco. Lo storico
José Maria Carulla, combattente Carlista nella terza guerra, visitò Trieste nel 1867 e lasciò
una vivace descrizione della corte Carlista nel
suo Viaje de Madrid à Roma. In esso rivela che i
Carlisti abitavano “in un povero palazzo”4.
Nei primi anni, Don Carlos e Donna Maria
Teresa vissero pressoché lontani dai figli. Il
primogenito Carlos, dopo il matrimonio con
la principessa Carolina di Borbone delle Due
Sicilie, si era stabilito a Napoli. Il secondogenito, Don Juan, allontanatosi dottrinalmente dal
carlismo dopo essersi separato dalla cattolicissima consorte Maria Beatrice d’Austria Este,
principessa reale di Modena, vagabondava per
l’Europa, sicuro di sé per il ricco appannaggio
annualmente concesso dalla arciduchessa Maria Beatrice per avere libertà libera nell’educazione dei due infanti nati dal matrimonio:
Carlos ed Alfonso Carlos. A Trieste era rimasto
in famiglia solo il principe Don Ferdinando.
Con essi vi era un piccola corte di fedeli che
in parte abitava nel palazzetto, mentre i più
erano alloggiati nelle vicinanze. Questa era la
piccola corte della famiglia reale proscritta a
Trieste: Don Niceto Monino y Pinar, generale
di brigata, maggiordomo e segretario; donna
Teresa Flerus, cameriera della Regina; Don José
Domingo de Azcoaga y Medinaveira, segretario della regina Maria Teresa; Don Gabriel de
Flòrez, conte de Flòrez, ciambellano della Regina; Don Iosé Villavicencio, maggiordomo e
gentiluomo; Don José de Flòrez, gentiluomo;
Don Juan Guillén, gentiluomo; Don José Ibarra, gentiluomo; Don José Antonio Sacanell,
maresciallo di campo, aiutante di camera; Don
Pedro Barrera Ratòn, confessore; Donna Maria
José de Torres Ruiz de Ribeira Pimentel y Connock, contessa di Matallara, dama d’onore della
Regina; Donna Maria de la Concepcion de Le4 J. M. Carulla, , Madrid, 1867, pag. 25
194
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
saca, contessa de la Lealtad, dama d’onore della
Regina; donna Maria Benita Calvet, contessa
di Florez, dama d’onore della Regina; donna
Maria de Lopez Nuno, dama d’onore della Regina; donna Gregoria de Azcoaga y Medinaveira, dama; don Francisco de Cardona y Almagro,
archiatra; Don José Domingo de Azcoaga, (cameriere); Don Lorenzo de Angulo, sarto; Don
José de Angulo, servitore; Donna Maria del Patrocinio de Angulo, domestica; Don Diego Zarranz, servitore; Don Joaquin Zarranz, servitore
della Regina; Don José Yel y Mejia, servitore
della Famiglia Reale; Don José Troitino, cuoco;
Elisa ?, domestica; Augustin, paggio5.
All’inizio del 1855, il Re Carlos V cominciò
a sentirsi male. In febbraio le sue condizioni
peggiorarono al punto da non riuscire più ad
alimentarsi con regolarità. L’archiatra di corte
consultò alcuni luminari della medicina, tra
cui il professor Lorenzutti, primario dell’ospedale generale di Trieste. Riunitisi il 9 marzo, i
clinici ritennero il reale paziente in condizioni
estremamente gravi al punto da consigliare la
somministrazione dell’estrema unzione. Il Re
fu messo al corrente della situazione. Chiamò
il suo confessore, padre Pedro Barrera Raton
per quella che fu la sua ultima confessione.
Poco dopo giunse il Vescovo di Trieste e Capodistria, Bartolomeo Pegat che amministrò il
viatico alle ore 23. La notizia dell’imminente
morte si sparse in tutto il quartiere. La commozione fu generale perché il Re era conosciuto ed amato. Si formò una processione spontanea che silenziosamente giunse fino alle porte
del palazzo. Essa era guidata dal barone Carlo
Pascotini, consigliere aulico e vicegovernatore
della città. Per tutta la notte l’infermo fu vegliato dalla Regina, dall’infante Fernando e da Don
José de Villavicencio, conte de la Constancia.
Alle 4 del mattino il medico acconsentì a dare
all’infermo l’estrema unzione. Alle ore 9,30 del
mattino del 10 marzo, il Re che aveva alzato
per primo la bandiera della legittimità e della
tradizione cattolica in Spagna contro il principio dell’eresia liberale rendeva l’anima a Dio.
Aveva compiuto 66 anni, 11 mesi e 9 giorni di
5 Antonio Manuel Moral Roncal, Carlos V de Borbòn,
Madrid, 1999, pag. 405, Anna Monteduro, L’Escorial
dell’Esilio, Trieste, 2006, pag. 125 - 144
La presenza Carlista a Trieste
issn 2035-584x
età. Il suo corpo fu imbalsamato e sepolto nella cattedrale di San Giusto con indosso l’uniforme di capitano generale dell’esercito reale
di Spagna. Ai funerali partecipò un gran folla
di popolo Triestino. Accorsero a Trieste molti
principi reali, in testa ai quali vi era Enrico di
Borbone, conte di Chambord6.
Il conte di Montemolin, suo figlio, ora era il
Re legittimo di Spagna, a tutti gli effetti, con il
nome di Carlos VI. Nella primavera del 1860,
sempre a Trieste, nella discreta cospirazione
dei saloni di via del Lazzaretto Vecchio, si organizza un nuovo tentativo per portare sul trono
di Spagna il nuovo re Carlista. Il generale Jaime
Ortega, comandante delle isole Baleari, segreto
sostenitore del Carlismo, si mise a disposizione del re legittimo per tentare la realizzazione
di un progetto estremamente audace. Il 2 aprile 1860, il generale Ortega, al comando di 3.500
uomini, sbarcò a San Carlos de la Rapida, una
località costiera nei pressi di Valencia. Con lui
sbarcarono Carlos VI ed il fratello più giovane,
l’infante Don Ferdinando. Ma l’operazione fallì. Carlos VI e suo fratello furono arrestati dalla polizia ed in cambio della libertà dovettero
sottoscrivere una rinuncia ai diritti dinastici.
I quali passarono automaticamente al secondo
dei tre figli di Carlos V: Don Juan. Il meno Carlista, sotto il profilo dottrinale, dei tre fratelli.
Egli, con un atteggiamento estremamente superficiale, accettò la successione ma spaventò
il mondo tradizionalista per le sue idee molto
vicine al liberalismo. In questo contesto politico, caratterizzato da una notevole confusione ideologica, Montemolin, il rinunciatario
Carlos VI, appena libero, diffuse un pubblico
disconoscimento della rinuncia estortagli durante la prigionia, definendola priva di valore
legale. Anche il fratello Ferdinando fece una
analoga dichiarazione. Ora il carlismo, paradossalmente, si trovava nella intima situazione di avere due sovrani, entrambi in esilio.
I primi giorni di gennaio dell’anno seguente, il conte di Montemolin, sua moglie Carolina
ed il fratello Ferdinando si trovavano in Stiria,
nel castello di Brunnensee, ospiti della duchessa di Berry, zia della moglie di Montemolin.
6 Jean Paul Bled, L’esilio dei gigli. I Borboni di Francia e di
Spagna a Gorizia e Trieste, Gorizia, 2003, pag. 101
195
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
Ferdinando, improvvisamente, si sentì male
e poco dopo morì. La coppia reale, spaventata,
fece immediatamente ritorno a Trieste con la
salma dell’infante Ferdinando. Appena giunti a Trieste anche Montemolin e la moglie si
sentirono male, avvertendo gli stessi sintomi
accusati dal principe Ferdinando. Al tramonto
del 13 gennaio Carlos VI, conte di Montemolin,
moriva. La sposa, Carolina, colpita dal dolore,
non si volle staccare dal corpo esanime del
marito. Dopo poche ore era morta anche lei.
Tutti e tre i reali congiunti vennero sepolti in
San Giusto, nella cappella di San Carlo, accanto
alle spoglie di Carlos V. I medici non seppero
spiegare le cause dei repentini decessi: qualcuno parlò di morbillo, qualcun altro di scarlattina, altri ancora di tifo. Ma non si venne a capo
della vera causa. Tra la popolazione di Trieste,
soprattutto tra i poveri del quartiere, perennemente beneficati dalla coppia reale, serpeggiò
la convinzione che i due fratelli fossero stati
avvelenati durante la prigionia. Prontamente
il fedele domestico di Montemolin, Manuel de
Echarry, volle smentire la diceria affermando
che, subita la stessa sorte del suo padrone e Re
durante la prigionia, aveva sempre assaggiato
tutti i suoi pasti. E non era morto. Ma il popolo
triestino, diffidente, restò nelle originarie convinzioni. Don Juan rimaneva l’unico re legittimo e ciò complicava la questione proprio nel
campo tradizionalista.
In questo periodo si trovava a Trieste, tra il
seguito militare della Famiglia Reale Proscritta, il generale Rafael Tristany in qualità di aiutante di campo del re Carlos VI. Ed in tale veste
accompagnò in San Giusto il feretro del sovrano defunto. Tenente colonnello al termine
della prima guerra Carlista, divenne generale
di brigata nella campagna del 1847 – 1849. Era
emigrato in Francia per sottrarsi all’arresto ed
aveva fatto ritorno in Catalogna nel 1855 dove
per oltre un anno assunse il comando di una
formazione di 200 carlisti. Nel 1856 si recò a
Napoli e poi a Modena, dove non riuscì ad entrare nell’esercito ducale per mancanza di un
ruolo adeguato al suo grado. Tuttavia svolse
alcune missioni delicate per conto del duca
regnante Francesco V. Alla caduta del ducato,
nel 1859, aveva seguito il duca a Verona e di lì
La presenza Carlista a Trieste
issn 2035-584x
era passato a Trieste per entrare nel quartier
generale di palazzo reale. Da Trieste tornò in
Spagna per partecipare alla cospirazione di
San Carlos de la Rapita ed in seguito al suo fallimento fece rientro a Trieste. Nel 1861 il Re
delle due Sicilie Francesco II di Borbone, giunto da poco a Roma, in esilio, chiese la sua presenza per organizzare la resistenza militare in
Abruzzo ai piemontesi. Il generale Don Rafael
Tristany prima di accettare l’offerta chiese il
nulla osta alla regina madre di Spagna e dopo
averlo ottenuto si trasferì prima a Roma e poi
nei pressi di Sora per organizzare la guerriglia
antipiemontese e antiliberale in nome degli
stessi principii tradizionalisti.
E’ a questo punto che entra in scena, con un
ruolo politico di spicco, la vedova di Carlos V,
Maria Teresa, per riprendere le file della battaglia dal palazzo di via del Lazzaretto Vecchio. E’
questo il periodo di transizione del carlismo.
I combattenti della prima guerra, la generazione di Don Carlos e Ferdinando VII se non
è morta è al tramonto dell’esistenza. I tempi
stanno mutando sotto la spinta di un’accelerazione scientista che sta allontanando l’uomo
dalle campagne. Nasce il mondo delle fabbriche e dello sfruttamento più evidente dell’uomo sull’uomo. La principessa di Beira ed i suoi
consiglieri avvertono il mutamento socio-politico in corso e rilanciano la dottrina Carlista
adattandola alle domande che vengono dalla
società, pur rimanendo nella piena ortodossia
cattolica sul terreno della tradizione delle Spagne. Il cenacolo di intellettuali che si stringe
attorno al palazzo reale di via del Lazzaretto
Vecchio è sempre più ostile a don Juan, alle sue
teorizzazioni, soprattutto ora che l’infante manifesta segni di ripetuto cedimento dottrinale
avvicinandosi alla dinastia isabellina che aveva usurpato il trono.
Il carlismo ha bisogno di un Re e dal palazzo
di via del Lazzaretto Vecchio le speranze politiche della corte spagnola in esilio si riversano
sul figlio primogenito di Don Juan, il giovane
Carlos che viveva in Boemia, nel palazzo reale Praga, con il fratello Alfonso Carlos sotto la
vigile tutela della madre, arciduchessa Maria
Beatrice. La principessa austro-estense era fortemente contraria a che i figli abbracciassero
196
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
i principii del carlismo, non per un dissenso
dottrinale, essendo l’arciduchessa una intransigente cattolica di orientamento tradizionalista. La regale madre temeva le dolorose conseguenze a cui sarebbero andati incontro i figli se
si fossero messi alla testa delle rivendicazioni
dei tradizionalisti spagnoli. Per questo motivo
aveva allontanato tutti gli istitutori spagnoli,
fidandosi soltanto di professori di lingua italiana, fuoriusciti dal cessato ducato di Modena perché fedeli al deposto duca Francesco V.
Ma nei due giovani infanti batteva un cuore
spagnolo. Il generale Cabrera, eroe della prima
guerra Carlista, si recò a Praga per conoscere il
futuro sovrano della linea Carlista, ma l’arciduchessa Maria Beatrice vietò l’incontro. Giunse
a far montare di guardia due granatieri ungheresi fuori dall’appartamento dei due infanti per
evitare contatti con spagnoli. Nonostante ciò i
messaggi della principessa di Beira giungevano al giovane Carlos. Il quale era spagnolo. Parlava e rispondeva in castigliano, e, soprattutto,
era consapevole di incarnare l’essenza storica
del tradizionalismo spagnolo. Le insistenze
del giovane Carlos fecero breccia nel cuore di
donna Maria Beatrice la quale autorizzò il giovane a recarsi per otto giorni a Trieste dalla
principessa di Beira. “Nella casa di mia nonna”
scrisse il giovane Carlos “sono tutti spagnoli; il
cibo è spagnolo, i letti sono spagnoli, ogni cosa
è spagnola”7. Iniziò, per l’infante, la formazione dottrinale tradizionalista.
Finalmente la principessa di Beira aveva incontrato la persona che poteva garantire al tradizionalismo spagnolo la continuità dinastica
e forte di ciò nel 1864, quando Carlos, ormai
trasferitosi a Venezia con il fratello e la madre,
aveva 16 anni, rese pubblica la celebre Carta a
los espanoles. Nell’efficace manifesto politico
la principessa riaffermò i diritti intangibili
del carlismo alla corona di Spagna, propose il
programma del legittimismo in cui si stabiliva
che alla legittimità di origine doveva esserci la
legittimità di esercizio e presentò il sedicenne
Carlos come il nuovo Re. Singolarmente l’investitura era stata concorda a Trieste. Il manifesto si chiudeva con un saluto a quello che da
7 Citato da T. Aronson, I Borboni e la corona di Spagna,
Milano, 1969, pag. 147
La presenza Carlista a Trieste
issn 2035-584x
ora in poi sarebbe stato chiamato Carlos VII.
L’astro del nuovo Re spuntò nel 1872 allorchè la Spagna legittimista prese le armi contro
la falsa monarchia di Amedeo di Savoia e nel
1874, quando le fortune belliche sembravano
favorevoli al carlismo, la principessa di Beira
morì nel palazzo di via del Lazzaretto Vecchio.
Aveva 81 anni. Era conosciuta soprattutto fra i
poveri della città per le inesauribili opere assistenziali. Poco prima di morire fece chiamare
al capezzale Isabel Burton, moglie del console
britannico a Trieste e le raccomandò di continuare le sue opere di beneficenza8. Le spoglie
mortali della principessa di Beira furono inumate in San Giusto, nella cappella di San Carlo,
accanto a quelle del suo sposo.
Non c’è dubbio che la figura più interessante del carlismo che visse nel piccolo palazzo
della famiglia reale proscritta di Spagna di via
del Lazzaretto Vecchio, fu la principessa di Beira. Di lei, il console spagnolo a Trieste, Joaquin
Garcia Miranda, console del governo liberale,
disse: “Quando morirà Maria Teresa si risentirà molto a Trieste. Migliaia di fiorini cesseranno di andare ai poveri”9. La vita della regina
non è stata ancora studiata nella sua interezza.
Ora è imminente la pubblicazione di una biografia in lingua inglese realizzata dalla storica
statunitense Alexandra Wilhelmsen che, alla
fine degli anni ‘90 ha svolto varie ricerche in
Trieste.
Maria Teresa di Braganza era nata ad Ajnda il
22 aprile 1793, prima figlia del re Giovanni VI di
Portogallo e di Carlotta. Le fu assegnato il titolo
di principessa di Beira, normalmente riservato
all’erede presuntivo al trono. Il 13 maggio 1810
sposò a Rio de Janeiro, dove la famiglia reale portoghese si era rifugiata in seguito all’invasione
napoleonica, l’infante Pietro Carlo che morì due
anni dopo. Dal matrimonio nacque, postumo,
l’infante Sebastiano. Donna dotata di un acume
politico di notevole spessore, divenne una co8 Isabel Eagle Burton, moglie di Richard Francis Burton,
console britannico a Trieste dal 1871 fondò la Croce
Triestina, collegata alla Croce Rossa Internazionale. Di
lei, nel duomo cittadino, è detto in una lapide “donna
pia e devotissima”.
9 La dichiarazione è riportata in A, Monteduro, L’Escorial
dell’Esilio, Trieste, 2006, pag. 104
197
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
lonna portante del Carlismo dottrinario.
Pochi anni dopo la morte della principessa di
Beira, nel novembre del 1887 morì a Brighton,
all’età di 65 anni, Don Juan, il padre del re Carlos VII. In quella lontana città era conosciuto
sotto il nome di Montagu ed alla morte i giornali locali ignorarono l’effettiva identità del
defunto. I funerali si svolsero nella Chiesa del
Sacro Cuore a Hove ed il corpo venne sepolto in
una tomba allestita al cimitero presbiteriano.
Pochi mesi dopo i funerali, le spoglie di Don
Juan, assieme a quelle di sua madre, la principessa Maria Francisca di Braganza, sepolta a
Gosport più di cinquanta anni prima, vennero
portate a Trieste ed inumate nella cattedrale di
San Giusto, sempre nella cappella di San Carlo. Furono seppellite al fianco di Carlos V. Sulla pietra sepolcrale di Don Juan, che i carlisti
avevano più volte definito “l’apostata”, la carità
cristiana degli stessi carlisti, in obbedienza al
principio della legittimità dinastica, impose
che si scrivessero in lettere d’oro le seguenti
parole: “Joannes III Hispaniarum Rex”.
Con la morte di Maria Teresa di Braganza,
principessa di Beira, il palazzo di via del Lazzaretto Vecchio si chiuse per sempre per la corte proscritta. Ma non San Giusto. Passarono
molti anni. Il secolo decimo nono si chiuse e si
affacciò, pieno di speranze, il nuovo secolo. A
Venezia viveva, in esilio, il re Carlos VII, figlio
di Don Juan e nipote di Carlos V. Il 17 luglio del
1909, mentre si trovava in vacanza a Varese, in
seguito ad un arresto cardiaco cessava di vivere. Il suo corpo, rivestito, come quello dei suoi
predecessori, dell’uniforme di capitano generale dell’esercito reale di Spagna che usò durante la terza guerra Carlista, con l’insegna del
Toson d’oro, la placca di San Fernando e le medaglie di Montejurra e Somorrostro, fu trasferito a Trieste e sepolto il 23 luglio dello stesso
anno nella cappella di San Carlo, in cattedrale.
Il funerale raccolse nella città adriatica i legittimisti provenienti da tutte le province spagnole ed i principi reali che si riconoscevano negli
ideali di Don Carlos. Essi erano guidati da Don
Saverio di Borbone, nipote della prima consorte di Don Carlos, la regina Margherita, nonché
figlio dell’ultimo duca regnante di Parma, Don
Roberto I, padre di numerosa prole tra la quale
La presenza Carlista a Trieste
issn 2035-584x
è da ricordare Zita, l’ultima imperatrice d’Austria – Ungheria.
Da questo momento, la piccola cappella di
San Carlo cominciò ad essere appellata l’Escorial dell’esilio per il numero dei legittimi sovrani di Spagna qui sepolti.
I carlisti convenuti nella penisola italiana
proclamarono Don Jaime, figlio del Re Carlos
VII, suo successore.
A cento anni di distanza dalla morte di Carlos VII i tradizionalisti spagnoli non hanno dimenticato il valore di questo sovrano. Mutati
i tempi, entrati ancora una volta in un nuovo
secolo, morti tutti i vecchi legittimisti, il 17 luglio dell’anno che sta per terminare sono giunti da varie province spagnole uomini, Donne e
giovani in nome del tradizionalismo e nel più
puro stile Carlista, che ha sempre coniugato
dottrina, religiosità e fedeltà dinastica, aiutati
da tradizionalisti della penisola italiana, hanno
organizzato un convegno di studi, patrocinato dal comune di Trieste, sul tema “Il Carlismo
e la Trieste Asburgica” che si è tenuto nella sala
Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich. Il convegno
si è svolto sotto la presidenza del principe reale Don Sisto Enrico di Borbone, duca di Aranjuez, figlio di Don Saverio, che, come è stato
già detto, cento anni prima capeggiava la pattuglia dei principi reali presenti al funerale di
Carlos VII, testimoniando così una continuità
dinastica di fedeltà ai principii del Carlismo. Al
temine del convegno è stata celebrata un messa di requiem nella cappella di San Carlo, nella
cattedrale, con il rito romano antico, officiata
da Mons. Ignacio Barreiro - Carambula, un generoso figlio delle Spagne accorso a Trieste per
la celebrazione commemorativa.
La storia del Carlismo triestino non è, comunque, ancora completa. Abbiamo iniziato
la ricognizione storica citando due luoghi di
Trieste cari al tradizionalismo delle Spagne:
la cappella di San Carlo in San Giusto ed il
palazzetto di Via del Lazzaretto Vecchio. Vi è
un terzo luogo che completa l’itinerario Carlista di Trieste: è il Campo III del Cimitero di
Sant’Anna. La famiglia reale proscritta decise,
con l’accordo dei fedeli di corte, di raccogliere
tutte assieme le spoglie dei fedeli man mano
che morivano. E per lo scopo fu acquistato un
198
Tigor: rivista di scienze della comunicazione - A.I (2009) n.2 (luglio-dicembre)
issn 2035-584x
campo nel cimitero monumentale. La prima
salma fu sotterrata nel maggio del 1858 ed
appartiene alla contessa Maria José de Ribera
Pimentel y Connock, dama d’onore della Regina. L’ultima a Diego Zarranz, figlio di Joacquin,
morto il 10 febbraio 1895. I loro nomi, scolpiti
nella pietra tombale, segnano nel tempo un atteggiamento umano contraddistinto dalla fedeltà fino alla morte all’ideale della Legittimità
storica, politica e dottrinale che, indipendentemente dalle contingenze temporali, resta di
grande validità.
Miguel Ayuso, ordinario di Diritto Costituzionale
nella Università Comillas di Madrid; Dottore honoris causa della Università degli Studi di Udine,
presidente della Union Internationale des Juristes
Catholiques (Città del Vaticano); direttore del
Consiglio di Studi Ispanici Philippo II (Madrid);
vicepresidente del “Institut International d’Études
Europeénnes Antonio Rosmini” (Bolzano).
È autore di venti libri e circa trecento articoli.
[email protected]
Francesco Maurizio Di Giovine è uno studioso
del Carlismo, in generale, e del pensiero politico
dell’antirisorgimento italiano. Ha curato la pubblicazione delle intere collezioni di due giornali
Napoletani editi a cavallo dell’unità d’italia: La
Tragicommedia e L’Equatore. Ha curato la ripubblicazione dell’opera di Teodoro Salzillo, “L’assedio
di Gaeta”; ha scritto il saggio “1799. Rivoluzione
contro Napoli” e “L’età di Ferdinando II”.
[email protected]
La presenza Carlista a Trieste
199