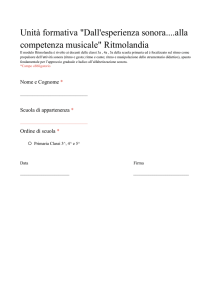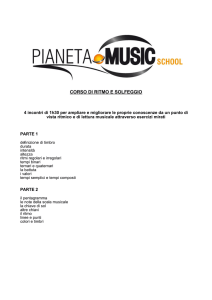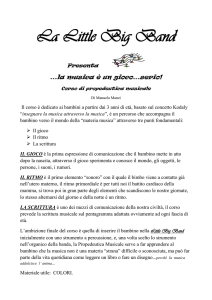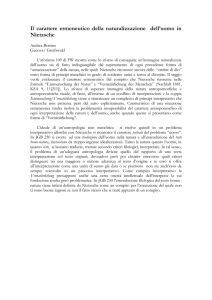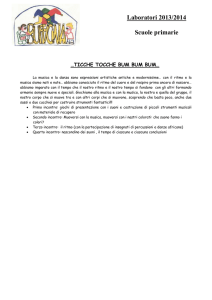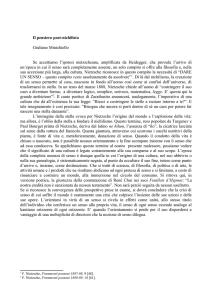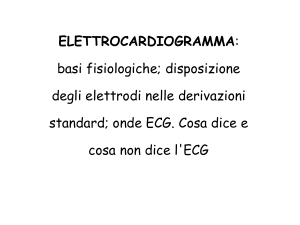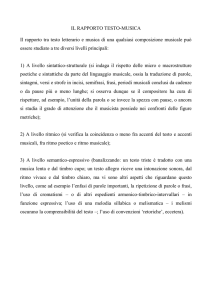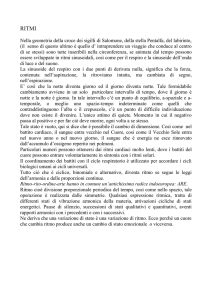Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
Nietzsche e il ritmo degli antichi
«In sé è un enigma perché l’uomo non esprima i suoi pensieri nel
modo più determinato e semplice possibile: tutto ciò che è ritmico oscura», annota Nietzsche nel manoscritto delle lezioni sulla Storia della letteratura greca che tiene tra il 1874 e il 1875 all’università di Basilea
(KGW II. 5, 284)1. In esse viene avanzata una tesi sulla nascita della poesia che sarà riproposta in un aforisma della Gaia scienza intitolato, appunto, Dell’origine della poesia. Tenendo conto delle parti del manoscritto
appena citato che ne costituiscono una prima versione, le pagine che
seguono propongono un commento di questo testo, in cui Nietzsche
discetta soprattutto sugli effetti che i Greci dell’Antichità attribuivano al
ritmo o che da esso si attendevano quando crearono quella nuova «ritmica del discorso» (KGW V.2, 115) che è la poesia. E discutendo su tali effetti, egli discute in una prospettiva storico-antropologica alcune delle caratteristiche più proprie del fenomeno del ritmo, che in fondo soltanto a partire dai suoi effetti è possibile pensare e tentare di comprendere.
L’argomentazione di Nietzsche parte da un implicito postulato: il
ritmo non appartiene originariamente al linguaggio, ma è qualcosa che
ad esso è esterno ed estraneo, che è in contraddizione con l’economia
della ragione discorsiva. Poiché – questa la sua tesi - la poesia nasce
«allorquando si introdusse il ritmo nel discorso, quella potenza che dà
un ordine nuovo a tutti gli atomi della frase, impone la scelta delle
parole e conferisce un nuovo colore al pensiero rendendolo più cupo,
più estraneo, più lontano» (KGW V.2, 116).
Il ritmo è un potere che assoggetta alle proprie regole il discorrere del
pensiero, che scompone l’unità della frase per ricomporne i frammenti
secondo un ordine eterogeneo rispetto a quello semantico. Il ritmo lavora
la parola per desemantizzarla ed esibirla come suono. Una dissociazione
e un attrito tra suono e significato vengono ad irritare l’attività di significazione, ad oscurare i pensieri, a mandarli lontano, a sospendere continuamente il nostro ragionare. E non è proprio questo che della poesia ci
procura piacere? La bellezza della poesia deriva dall’irragionevolezza che
le conferisce il ritmo, questa energia che sottrae la parola alla sua funzione comunicativa trasformandola in parola poetica, il cui carattere peculiare sta allora nella sua mancanza di funzione, nella sua inutilità, la quale sta
a dimostrare l’esistenza di una moralità che viene prima della ragione e
5
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
mette radicalmente in questione il principio dell’utile, il suo dominio che
si ritiene incontrastato. Così, almeno, sostengono i cultori idealisti dell’autonomia dell’arte. Nietzsche:
Coloro che amano il fantastico nell’uomo, e che sostengono al tempo stesso la teoria della moralità istintiva, giungono a questa deduzione: «Posto
che in ogni tempo si sia venerato l’utile quale divinità suprema, donde è
mai venuta la poesia? Questa ritmica del discorso che non è tanto vantaggiosa, quanto invece controproducente per la chiarezza della comunicazione e che, nondimeno, quasi irridendo ad ogni utile funzionalità, è sgorgata ovunque sulla terra e sgorga ancor oggi! L’irrazionalità barbaramente bella della poesia è confutazione per voi, per voi utilitaristi! Proprio il
volersi sbarazzare una buona volta dell’utile ha elevato l’uomo, lo ha ispirato alla moralità e all’arte!» (KGW V.2, 115-6).
Se la si considera dal punto di vista di chi vede nell’utilità il valore
supremo che governa tutte le azioni umane e assegna perciò alla parola il solo ruolo di medium di comunicazione del pensiero, la poesia si
rivela un’assurdità bella e buona: un’assurdità che però viene a confermare il nesso tra i valori del bello e del buono, e la loro contrapposizione al principio dell’utile. Che è un principio immorale, dicono gli
amici del fantastico, perché la morale, come l’arte, nasce dal desiderio
di lasciarselo alle spalle.
E invece le cose non stanno così, sostiene Nietzsche:
Ebbene, a questo punto, devo una volta tanto parlare a favore degli utilitaristi: hanno ragione così di rado da far pietà! In quei tempi antichi che videro il nascere della poesia, si ebbe sempre di mira l’utilità e una grandissima
utilità […]: un’utilità superstiziosa senza dubbio! (KGW V.2, 116).
Questa volta sono loro ad aver certamente torto, gli amici del fantastico che si fanno assertori di una moralità prerazionale. La loro deduzione non regge e falsa è la premessa su cui si basa. L’utile è ben lungi
dall’essere il valore supremo che orienta «in ogni tempo» le azioni dell’uomo e la poesia è tutt’altro che una confutazione di questo credo.
La poesia greca, ha scritto Bruno Gentili, «ebbe un carattere essenzialmente pragmatico, nel senso di una stretta correlazione con la realtà
sociale e politica e col concreto agire dei singoli nella collettività»
(Gentili 2006: 15). Ma il pragmatismo che portò alla creazione della
poesia e che originariamente presiedeva al suo esercizio, sottolinea
Nietzsche, ha una determinazione religiosa. Perché religiosa è la «più
antica destinazione» della poesia (KGW II.5, 283), che nasce quando si
affida alla parola una funzione rituale che è essenzialmente legata al
ritmo. È il culto il luogo dell’origine del dire poetico e, quindi, della
6
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
storia della letteratura, che Nietzsche intende come «Geschichte der
kunstmäßigen Behandlung der Sprache» (KGW II.5, 8), come storia del
trattamento artistico del linguaggio, il cui inizio va ricercato nei rituali
religiosi di una società in cui la comunicazione culturale si svolge nei
modi dell’oralità (Emden 2000: 221-4). Nell’Antichità, scriveva
Thrasybulos Georgiades (1958: 52), «il linguaggio strutturato artisticamente poteva essere solo la mousiké», la quale – come si sa – non coincideva con quello che oggi intendiamo per musica, ma era l’insieme
delle arti ispirate dalle Muse che confluivano “sinesticamente” nell’espressione “musicale” in senso lato (Mersch 2005: 37). E ciò che nella
mousiké unisce «lingua, verso, musica e danza», il loro «comune
sostrato», afferma ancora Georgiades (1959: 7-8), è il «ritmo musicale», il quale sta quindi all’origine di tutte le pratiche artistiche.
Ma queste, all’origine, sono parte di pratiche religiose che per
Nietzsche, come abbiamo appena visto, sono determinate da un pragmatismo “superstizioso”, che è tale perché scaturisce da una percezione magica del mondo che non conosce «l’opposizione tra sacro
(Geistlich) e profano (Weltlich)» (KGW II.5, 285). Come non esiste una
netta distinzione tra arte e religione, non esiste neanche una sfera del
sacro intesa come dimensione spirituale, trascendente, soprannaturale
chiaramente separata da una sfera del profano fatta coincidere con
l’ambito di ciò che è soltanto terreno, mondano. Forte e costante è il
senso della limitata capacità dell’uomo di controllare il corso delle cose
e delle azioni: dovunque si credono all’opera presenze sovraumane
che, imprevedibili e minacciose, governano le sorti dei mortali e che
perciò questi debbono rendere ben disposte nei loro confronti.
La poesia nasce, dunque, da un sistema culturale in cui si dà la necessità di comunicare con gli dèi. E il ritmo è, per Nietzsche, il medium principale di tale comunicazione, è il mezzo principale di cui i Greci dell’antichità credono di disporre per sedurre gli dèi e i dèmoni, per conquistarsi il loro favore, per esorcizzare le minacce che da essi provengono. È per
conferire alla parola questo potere di seduzione e di coercizione che gli
uomini della Grecia antica introducono il ritmo nel discorso, dando luogo
a quella che sarà la poesia: «Evidentemente si utilizzava il discorso ritmato e cantato per scopi simili a quelli per cui si utilizzavano il ritmo e la
musica in generale». E cioè: «Per esercitare un effetto (magico) sugli dèi
nel culto o al di fuori del culto, dopo che si era appreso il loro effetto e il
loro potere sugli uomini» (KGW II.5, 283-4).
Questo vale prima di tutto per l’effetto mnemonico del ritmo e la
sua capacità di estendere il campo di risonanza della parola:
In virtù del ritmo una richiesta umana doveva imprimersi più profondamente negli dèi, essendosi notato che l’uomo tiene a mente con più
7
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
facilità un verso che un discorso in prosa: ugualmente si riteneva di
farsi udire a più grandi distanze mediante il ritmico tic-tac; pareva che
la preghiera ritmica potesse approssimarsi maggiormente all’orecchio
degli dèi (KGW V.2, 116).
Se l’uomo affida il suo dire al ritmo, andando contro ogni esigenza
di chiarezza, è per conferire alla parola un potere di comunicazione che
va oltre la sfera dell’umano, per far sì che il linguaggio sia qualcosa di
più che un medium di comunicazione tra uomini. Quegli esseri imprevedibili che possono soccorrere ma anche far danno agli uomini sono
lontani ma non irraggiungibili. In quel mondo che ha visto nascere la
poesia, le potenze divine non si sono ancora ritirate in una sfera trascendente. Perciò il commercio con esse non avviene soltanto nello
spazio altro del culto:
E non solo nel canto cultuale, ma anche nel canto profano dei tempi più
antichi, vige il presupposto che l’elemento ritmico eserciti una forza
magica, per esempio nell’attingere acqua o nella voga: il canto è
l’incantamento dei demoni che si pensano operanti in queste circostanze, li rende condiscendenti, servi e strumenti dell’uomo. E ogniqualvolta si compie un’azione, si ha un motivo per cantare – ogni azione è
connessa all’assistenza di spiriti: canto magico ed esorcismo sembra
siano stati la forma originaria della poesia (KGW V.2, 117).
Ma non soltanto della poesia. Perché per scopi del tutto simili a quelli per cui il ritmo è stato introdotto nel discorso, esso «è stato introdotto
nel movimento del corpo», si legge nei manoscritti delle lezioni. «Si
dimentica troppo facilmente l’originario effetto magico di tutte le danze;
si riteneva, battendo i piedi sul terreno, di evocare la presenza degli dèi»
(KGW II.5, 287). Naturalmente non si tratta soltanto di costringere gli dèi
ad avvicinarsi, a prestare ascolto alle preghiere dell’uomo. Attraverso il
ritmo, l’uomo crede di poterli dominare:
Ma, soprattutto, si voleva trarre utilità da quel soggiogamento elementare
che l’uomo prova dentro di sé ascoltando la musica: il ritmo è una costrizione; genera un irresistibile desiderio d’assecondare, di mettersi in consonanza; non soltanto il movimento dei piedi, ma anche l’anima stessa
segue la cadenza – probabilmente, si concludeva, anche l’anima degli dèi!
Si tentava di costringerli mediante il ritmo e di esercitare un potere su di
essi: si gettava loro la poesia come un laccio magico (KGW V.2, 116).
Ciò che della musica soggioga è il ritmo: un laccio che imbriglia magicamente i sensi come gli affetti, perché genera un’induzione mimetica che
agisce non soltanto sul corpo ma anche sull’anima. La danza e la poesia
8
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
sono state create allo stesso scopo, dice Nietzsche, e cioè per «potenziare
gli effetti propri della musica» (KGW II.5, 287). In realtà nella poesia è
piuttosto la musica ad accrescere la potenza della parola, a conferirle una
trascinante intensità persuasiva. Nel passo appena citato, Nietzsche si rifà
a una pagina del Mondo come volontà e rappresentazione che egli cita o
parafrasa anche altre volte nei suoi appunti (KGW II.5, 284; Nietzsche
1922: 474-5). Il ritmo e la rima, scriveva Schopenhauer, esercitano su di
noi un tale «effetto incredibilmente possente» perché
la nostra facoltà di rappresentazione, essenzialmente legata al tempo,
acquista, attraverso essi, una cadenza particolare, che ci induce a seguire interiormente ogni rumore che si ripete a intervalli regolari e per così
dire a metterci in consonanza con esso. In tal modo, ritmo e rima divengono un mezzo che incatena la nostra attenzione, facendoci seguire più
docilmente il discorso, inoltre generano in noi una disposizione cieca,
precedente ad ogni giudizio ad accordarci a quello che ascoltiamo, che
acquista così una certa forza di persuasione enfatica, indipendente da
ogni ragionamento (Schopenhauer 1986: I, 341).
Essendo legata al tempo, la facoltà di rappresentazione può essere
suggestionata da strutture ritmiche e metriche che strutturano il flusso
temporale della percezione imponendole una selezione degli stimoli che
la investono. L’attenzione è catturata da un numero ristretto di dati, ogni
spazio di libertà percettiva e critica si chiude, così che la coscienza smette di operare concettualmente, abbandona la sfera del ragionamento per
aprirsi a quella dell’intuizione. È questo, almeno, ciò che per
Schopenhauer si attua o deve attuarsi nell’arte. La quale ha il fine di
«rivelare» le idee, che sono «essenzialmente intuitive», e di comunicarle
«in tutta la chiarezza e la vivezza in cui l’animo geniale le ha comprese»
(Schopenauer 1986: I, 340). Ma ciò può aver luogo soltanto se l’attività
conoscitiva si sottrae alla volontà, per cui l’artista dovrà far sì che il fruitore della sua opera cessi, seppur momentaneamente, di percepire e
conoscere in modo interessato, cercando cioè rappresentazioni che appaghino il suo volere. La poesia presenta però una difficoltà particolare,
perché si esprime con le parole e «ciò che viene comunicato in modo
immediato attraverso le parole» sono soltanto «concetti astratti». Il poeta
dovrà pertanto rendere manifeste le «idee della vita» nei «rappresentanti
di tali concetti», ossia, appunto, nelle parole, utilizzandole in modo tale
da far sorgere nella fantasia un’immagine intuitiva (Schopenhauer 1986:
I, 340). Rima e ritmo sono due dei mezzi di cui dispone per raggiungere
questo scopo, vale a dire per addormentare la volontà, come anche la
ragione, poiché le rappresentazioni intuitive non sono prodotte da un
ragionamento, ma hanno «la loro origine in un eccitamento della sensazione del nostro corpo sensitivo» (Schopenhauer 1986: III, 42).
9
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
È sul nostro corpo sensitivo, dunque, che la poesia opera attraverso
il ritmo e la rima. Le parole smettono di essere “rappresentanti” di concetti e si trasformano così in corpi sonori che agiscono in modo immediato sui sensi, attirando il movimento della comprensione nel territorio dell’intuizione, che è al di qua di «ogni giudizio». Il ritmo instaura
dunque – come è stato spesso constatato e da prospettive diverse - un
livello di comunicazione non discorsiva all’interno del discorso attraverso un’organizzazione specifica del movimento percettivo, che può
conferire «a quello che ascoltiamo» una potenza retorica elementare,
irrazionale o, comunque, pre-concettuale.
In tal senso, è stato affermato, il ritmo può essere un agente di
regressione. Per Hans Ulrich Gumbrecht, esso riconduce «dallo stadio
della civiltà a quello della preistoria», fa regredire a un livello
dell’«interazione umana» in cui la percezione non è mediata da concetti, non produce ancora «anticipazioni concettuali di possibili percezioni» che preparano ad affrontare situazioni future, ma genera immagini che sono strettamente connesse a sensazioni cinestetiche e stimolano moti corporei a cui diventa tanto più difficile resistere tanto più la
percezione si accorda a una forma ritmica. Gumbrecht non mira a una
condanna del ritmo in quanto operatore di regressione. Ciò che gli
preme è piuttosto mostrare come in esso si manifesti una forma o un
livello di comunicazione che non appartengono alla «dimensione della
‘rappresentazione’ (del ‘senso’, della ‘semantica’)» e non si lasciano
«armonizzare concettualmente», come invece pretenderebbe la poetica
fin dai tempi di Aristotele (Gumbrecht 1988: 715-28).
Questa qualità anti-rappresentativa del ritmo, su cui molti hanno
giustamente insistito, diventa però percepibile solo a partire dai suoi
effetti nel campo della rappresentazione: come qualcosa che lo attraversa e, insieme, ne diserta i meccanismi, esponendoli alle leggi di un
territorio che non sta più sotto il loro controllo, ma non per questo deve
essere inteso come un territorio “arcaico”, altro rispetto allo spazio
della “civiltà”. Per quanto possa eludere, irritare o straniare i meccanismi della significazione semantica, il ritmo non si pone al di là della
dimensione del senso, la quale non può essere equiparata, come fa
Gumbrecht, a quella della semantica, della rappresentazione. È sempre
nel campo del significato che il ritmo agisce: rendendo il pensiero «più
oscuro, più estraneo, più lontano», come scrive Nietzsche, o facendo
acquisire alla parola una «certa forza di persuasione enfatica», come
dice Schopenhauer. Il ritmo lavora dentro il discorso. E poiché «il
discorso non è separabile dal suo senso», scrive Henri Meschonnic, «il
ritmo è inseparabile dal senso del discorso»; è la forza che lo configura e «mostra che il discorso non è fatto solamente di segni», che «il linguaggio include […] anche le azioni, le creazioni, le relazioni fra i
10
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
corpi, ciò che l’inconscio rivela e, insieme, nasconde, tutto quello che
non arriva al segno» (1982: 70-72).
Il ritmo è ciò che costituisce il “senso” corporeo e inconscio di un
discorso. Per questo può essere utilizzato per manipolare i sensi e
l’affettività elidendo l’appercezione, ma può anche fungere da stimolo
per processi creativi, agendo su un livello dell’espressione che non è
governato dalla coscienza. È sempre una dimensione “elementare” del
sentire e dell’operare ad essere investita e chiamata in gioco. Così,
almeno, suggerisce Nietzsche, richiamandosi a Platone:
Quanto più un uomo è eccitabile, quanto più è originario, tanto più il
ritmo agisce su di lui come una costrizione: esso produce una disposizione cieca ad accordarci a ciò che è indicato ritmicamente e risveglia
una voglia insopprimibile di cedergli, di imitarlo. L’uomo si sente non
libero, costretto, sopraffatto e conclude che in questo modo si potevano costringere anche gli dèi. Così [l’arte] il ritmo e la poesia entrano
nel culto, come mezzo per esercitare un effetto. Nello Ione dice
Platone: «Proprio come coloro che vengono sopraffatti dal delirio coribantico non eseguono le loro danze e i loro salti con chiara coscienza,
così i buoni poeti lirici non compongono le loro belle canzoni con chiara coscienza, bensì quando la potenza dell’armonia e dei ritmi li assale
[gerade wie die vom Korybantentaumel Überfallenen nicht mit klarer
Besinnung ihre Tänze u. Sprünge machen, so dichten auch die guten
lyrischen Dichter nicht mit solcher ihre schönen Lieder, sondern wenn
die Gewalt der Harmonie u. der Rhythmen über sie kommt]». Così
come il poeta si sente costretto, così si crede di poter costringere gli dèi
con il potere del ritmo (KGW II.5, 284-5).
La poesia nasce dalla costrizione esercitata dal ritmo: una tesi che si
presenta come una variazione della concezione platonica del fondamento divino della poesia, la quale ha il suo luogo classico nella seconda parte dello Ione. Per Platone (cito dalla versione di Giovanni Reale,
il passo riportato da Nietzsche è in corsivo)
tutti i buoni poeti epici non per possesso di arte, ma perché sono ispirati e posseduti dal dio compongono tutti questi bei poemi, e, così,
anche i buoni poeti melici: e come i coribanti danzano fuori di senno,
così, fuori di senno, i poeti melici compongono i loro bei carmi, e quando entrano nell’armonia e nel ritmo, sono invasati e squassati dal furore bacchico (Platone 2000: 1027).
In Nietzsche, la poesia non è più la voce degli dèi che parlano attraverso il poeta, ma è il mezzo che gli uomini utilizzano per dominarli. È a
tal fine che viene introdotta nel culto. Non nasce, dunque, da questo, né
per ispirazione divina: non quando sono rapiti e posseduti da un dio i poeti
levano la loro voce, ma quando sono assaliti dal potere del ritmo, la cui
11
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
forza coattiva induce uno stato dell’immaginazione che è insieme di passività e di operosità. Il poeta non fa che dar luogo e partecipare all’accadere di un ritmo, che precede e produce l’articolazione linguistica.
Nella Nascita della tragedia è la «melodia» ad essere indicata
come «l’elemento primario e universale» che «genera da sé la poesia,
ossia la genera sempre di nuovo; nient’altro vuol dirci la forma strofica del canto popolare» (KGW III.1, 44-5). La poesia si produce dall’imitazione della musica: una tesi che può essere considerata anch’essa come una rilettura della concezione platonica sopra ricordata.
Anche in Nietzsche il poeta è fuori di sé quando crea; ma non è la voce
del dio a invasarlo e ispirarlo, bensì l’«uno originario» col quale egli
si fonde per poi riprodurlo «come musica», che a sua volta produce
figurazioni e parole della poesia (KGW III.1, 40). Ritmo e armonia
sono le forze mediante le quali si attua la «fulgurazione imitativa della
musica in immagini e concetti» (KGW III.1, 46)2. L’ imitazione è qui
intesa come un «processo di scarica» (KGW III.1, 46) di cui il «genio
lirico» è soltanto il medium, che «sente scaturire dallo stato mistico di
alienazione da sé e di unità un mondo di immagini e di simboli» (KGW
III.1, 40). Le figure della comunicazione segnica sono generate da una
forza che agisce al di là della volontà soggettiva e che alla comunicazione segnica è sostanzialmente estranea, perché se la lirica dipende
dallo «spirito della musica», questa, «nella sua assoluta illimitatezza,
non ha bisogno dell’immagine e del concetto, ma li tollera soltanto
accanto a sé» (KGW III.1, 47).
L’atto della creazione poetica è perciò l’evento in cui il soggetto è
preso da questa forza che lo trascina fuori di sé, trasformandolo in uno
strumento attraverso cui risuona ciò che è irriducibile all’economia del
linguaggio e della coscienza, e che si manifesta attraverso il «potere
dell’armonia e dei ritmi». Il poeta crea ubbidendo a un’energia impositiva che resta profondamente inscritta nel suo discorso e induce in chi
lo ascolta un impulso mimetico irresistibile. «È una costrizione», afferma Nietzsche, «che è abitualmente legata a un piacere, ma può sopraffare l’anima con spasimi così improvvisi da essere pari piuttosto a un
doloroso crampo» (Nietzsche 1922: 474-5).
Non si tratta, dunque, di un annullamento completo della coscienza.
Perché se c’è piacere, o dolore, allora la coscienza non si perde del tutto3,
ma si ritrova piuttosto nell’eco di se stessa mentre cade in balìa di qualcosa che la assale e la disarma. E se una tale condizione è «abitualmente
legata a un piacere», ciò significa che nella coscienza c’è anche qualcosa
che vuole quel soggiogamento e che perciò ad esso resta sottratto, qualcosa che si sente afferrato dal desiderio incoercibile di assecondare il
ritmo che invade il corpo e la mente. La percezione si accorda all’ordine
di suoni che si ripetono con regolarità, ma quei suoni non riempiono e non
12
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
spengono del tutto la coscienza né la volontà individuale, che permangono, ma si esperiscono come mosse da energie che provengono da altrove.
Credo che il tratto forse più inquietante e seducente dell’esperienza del
ritmo stia proprio in questo: nel movimento in cui coscienza e volontà
aderiscono alla loro espropriazione e si ritrovano nella scissione tra se
stesse e una ulteriorità che le tiene aggiogate.
La più antica attestazione del termine rhythmos è una frase di
Archiloco che recita: «Riconosci quale ritmo domina l’uomo». Lo
ricordava Werner Jaeger in uno studio del 1936, dove rammentava
anche un verso che Eschilo faceva pronunciare al suo Prometeo incatenato: «Sono qui, avvinto in questo ritmo»4. Nel suo significato più
originario, il termine rhythmos rimanda quindi a un’istanza che tiene
l’uomo assoggettato e lo espone perciò all’esperienza di sé in quanto
subiectum: in quanto essere sottoposto all’azione di forze che trascendono il suo volere e gli dettano gli ordini del suo sentire, del suo desiderare, del suo immaginare, le sue “disposizioni”, per dirla con
Foucault. Attratto fuori di sé, l’individuo scopre il suo nucleo di determinazione al di là di se stesso: nelle trame solo parzialmente perscrutabili dell’accadere come in quelle del corpo e della sua «grande ragione» di cui lo «spirito» non è che «un piccolo strumento e un giocattolo», fa dire Nietzsche al suo Zarathustra. Ma lo spirito dispone, nel
ritmo, di uno strumento per governare questo «possente sovrano» che
tiene le redini delle sue azioni, questo «saggio ignoto» che sta dietro
ogni suo pensiero e sentimento (KGW VI.1, 35-6). Perché il ritmo, ci
dice Nietzsche, può essere anche utilizzato come una tecnica per manipolare e padroneggiare quelle forze che sfuggono al controllo della
coscienza, del volere, del giudizio e perciò li minacciano, ma li soccorrono anche, perché minacciandoli li spingono sempre nuovamente a
ritrovarsi. Il ritmo può diventare l’operatore di una frode dei sensi e
degli affetti mediante la quale è possibile curare gli squilibri del corpo
e dell’anima che lo abita. Così, almeno, credevano gli antichi:
Esisteva anche un’idea più singolare, e proprio questa, forse, ha influito in maniera quanto mai potente sull’origine della poesia. Nei
Pitagorici essa appare come teoria filosofica e artificio pedagogico: ma,
gran tempo prima che esistessero dei filosofi, si attribuiva alla musica
la forza di sgravare gli affetti, di purificare l’animo, di ammansire la
ferocia animi – e in verità proprio in virtù dell’elemento ritmico della
musica. Quando la giusta tensione e armonia dell’anima erano andate
perdute, si doveva danzare, seguendo la battuta del cantore: era la ricetta di questa terapia. Con questa Terpandro pacificò un tumulto,
Empedocle ammansì un delirante, Damone purificò un giovinetto languente d’amore: con essa anche gli dèi, divenuti selvaggi e bramosi di
vendetta, venivano curati. Questo era possibile spingendo innanzitutto
al colmo il delirio e la sfrenatezza dei loro affetti, rendendo quindi furi13
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
bondo il delirante, ebbro di vendetta il vendicativo - tutti i culti orgiastici vogliono sgravare in una sola volta la ferocia di una divinità e portarla all’orgia perché dopo si senta più libera e più quieta e lasci l’uomo
in pace. Melos significa, secondo la sua radice, un mezzo di ammansimento, non perché sia in se stesso mite, ma perché il suo effetto rende
miti (KGW V.2, 116-7).
Se l’uomo antico introduce il ritmo nel discorso è dunque per investire il linguaggio del potere catartico che egli attribuisce alla musica e che
a questa, secondo Nietzsche, deriva dal suo «elemento ritmico». È «in
virtù» del ritmo che musica e poesia possono esercitare una funzione
magico-sedatrice e guarire le malattie dell’anima che colpiscono non soltanto gli uomini ma anche gli dèi. Uomini e dèi sono parimenti impotenti di fronte a passioni che in ogni momento possono diventare selvagge,
ma l’uomo soltanto ha il potere di manovrarle: attraverso il ritmo, appunto, che permette di curare anche gli dèi, di affrancarli dalle loro brame crudeli e renderli così più liberi. Perché gli dèi sono del tutto liberi. In fondo,
oscuramente, l’uomo antico sa che essi non vivono di forza propria, che
anzi sono «opera delle sue mani e argilla nelle sue mani» (KGW V.2, 219).
Sono finzioni che l’uomo antico ha costruito per rispondere ad esigenze
vitali, non da ultimo alla necessità pratica di governare la dimensione
feroce delle passioni, alla quale si vedeva continuamente esposto. In ogni
rappresentazione culturale Nietzsche invita a ravvisare un «travestimento
di bisogni fisiologici sotto il mantello dell’obiettivo, dell’ideale, del purospirituale» (KGW V.2, 16) e, insieme, il prodotto delle tecniche messe in
atto per appagarli. In tal senso vanno intesi gli dèi dell’antichità: come traduzioni immaginali di impulsi fisiologici e come frutto di una divinizzazione che li rende manipolabili. I Greci, scrive Nietzsche, «hanno rivolto
il loro impulso ideale proprio alle passioni e le hanno amate, elevate, rese
auree e divinizzate» (KGW V.2, 167). È insieme un’apologia e una sublimazione che le consegna alla sfera altra del sacro. «Non io! non io! bensì
un Dio attraverso me» (KGW V.2, 168) è la formula di questa metaforizzazione proiettiva che permette all’uomo antico di esorcizzare la parte
mostruosa e maledetta di sé, di farne l’immagine di un altro, che può essere incantato e manovrato.
In questa manipolazione sta per Nietzsche il senso dei culti orgiastici
dell’Antichità, che affidano all’elemento ritmico della musica e del linguaggio il compito di purificare l’animo degli dèi e degli uomini. L’effetto
costrittivo che esso esercita si trasforma così in una potenza di liberazione. Il ritmo diventa il medium di una pratica di controllo dell’affettività
che – come direbbe forse Foucault – è al contempo una pratica di libertà.
Per Foucault (1998: 277), quella dell’Antichità era «un’etica imperniata
intorno alla cura di sé», a una cura di sé che – stando a Nietzsche – si attua
in primis attraverso il ritmo, il cui dio non poteva che essere Apollo, la
14
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
«divinità etica», che esige «la misura e, per poterla osservare, la conoscenza di sé» (KGW III.1, 36). Anche misura e conoscenza di sé sono
«passioni» che l’uomo antico divinizza, perché sono necessarie per conseguire la «libertà dalle emozioni più selvagge» (KGW III.1, 24) o – come
dice Foucault (1998: 277-79) – per «padroneggiare dentro di sé gli appetiti che rischierebbero di prendere il sopravvento» e per stabilire quindi
«con se stessi un certo rapporto di dominio, di padronanza». Se è così,
allora Apollo, l’Apollo di Nietzsche, è il dio della cura di sé. Il dio che
umanizza la potenza di Dioniso.
Ma anche Dioniso – il messaggero della follia, dell’ebbrezza, della
deregolarizzazione dei sensi - è necessario alla cura di sé. Perché, dice
Nietzsche, soltanto «in tempi di eccitazione estatica la natura acquista nuovamente il suo equilibrio» (KWG II.5, 147): quell’equilibrio che, quindi,
l’ordine della cultura le sottrae e non può non sottrarle per poter essere se
stesso, ma che tuttavia, per potersi conservare, deve di tanto in tanto restituirle. Perciò in quegli antichi culti orgiastici non ne va soltanto di neutralizzare impulsi socialmente dannosi o interdetti, ma anche e soprattutto di
«dare alle passioni una festa» (KWG II.5, 285): cioè di liberarle e lasciarle essere in una cornice rituale in cui il sentire esorbita dalla sue forme abituali, trasgredisce le norme che la cultura gli impone - e restituisce così alla
natura il suo equilibrio. Perché l’eccesso non è soltanto l’interruzione e la
latenza di quelle norme, ma è una tendenza naturale degli impulsi, che la
cultura non può integrare se non catturandola nella zona di eccezione del
culto. «Ovunque nel culto greco è riconosciuto che tutti gli impulsi tendono all’eccesso e vanno periodicamente sgravati», afferma Nietzsche (KGW
II.5, 286). I Greci riconoscono nell’eccesso una dimensione necessaria dell’affettività, che va presa in carico e governata. Perciò non cercano di reprimerlo, né gli cedono del tutto, ma ne fanno piuttosto una «forma d’arte»
(Figal 2002: 51). Ne fanno il momento essenziale della loro arte, che è, originariamente, produzione di stati dionisiaci sotto la regia apollinea del
ritmo. L’arte è, originariamente, una tecnica di governo del sé attraverso
pratiche rituali in cui la tendenza eccessiva, anarchica, distruttiva delle pulsioni trova un appagamento mediato dal ritmo, la cui funzione è, appunto,
questa mediazione tra l’ordine della cultura, della civiltà e della coscienza
e ciò che ad esso resta irriducibile, che lo minaccia, eppure è necessario alla
sua economia. Poiché la coscienza deve perdersi, periodicamente, per desiderare sempre di nuovo se stessa, deve vivere l’esperienza dell’assoggettamento al potere eteronomo di passioni divenute selvagge per desiderare la
sua libertà nell’autolimitazione.
Sacri sono i precetti apollinei della conoscenza di sé e della misura,
ma sacre sono anche la smisuratezza e l’incoscienza a cui continuamente ci richiama la fascinazione del dionisiaco. Sacra è anche la relazione con una zona in cui i poteri delle misure e delle conoscenze abi15
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
tuali non possono più articolarsi e perciò possono anche rigenerarsi al
contatto con ciò che li trascende. «Infatti», scrive Nietzsche, «occorre
saper perderci per qualche tempo, se vogliamo imparare qualche cosa
da ciò che noi stessi non siamo» (KGW V.2, 223). Anche questo è
necessario alla cura di sé, forse soprattutto questo. «Si ha buona cura di
se stessi», scrive Foucault, se «si sa ontologicamente quello che si è, se
si sa anche quello di cui si è capaci» (Foucault 1998: 280). Ma per
sapere ciò che si è, dice Nietzsche, è necessario ogni tanto dimenticarlo, per andare oltre se stessi e misurarsi con lo sconosciuto; è necessario perdersi per attingere il punto in cui il nostro sapere è perduto e può
ritrovarsi nella relazione con la propria latenza.
Questa concezione del ritmo diventerà per Nietzsche uno strumento critico per la diagnosi della modernità come epoca della décadence
e, soprattutto, dell’arte che essa produce: un’arte incapace di liberare la
pulsionalità dando ad essa una forma e, quindi, costruendo uno spazio
etico in cui poter vivere la sregolatezza pulsionale senza esserne travolti e, anzi, rigenerando il proprio equilibrio psico-fisico. «La nostra
ritmica barbarica (o germanica)», si legge in una lettera a Carl Fuchs
dell’agosto 1888,
è un mezzo di espressione degli affetti: il ritmo antico, il ritmo temporale [Zeit-Rhythmus], ha invece il compito di dominare gli affetti e,
fino a un certo grado, di eliminarlo. La declamazione del rapsodo antico era estremamente passionale (…): la regolarità temporale [ZeitGleichmaß] veniva sentita come una specie di olio sulle onde. Per gli
antichi, il ritmo è, moralmente ed esteticamente, la briglia che viene
messa alle passioni. Insomma: il nostro tipo di ritmica appartiene alla
patologia, quello antico all’‘ethos’ (Nietzsche 1984: 404-5).
Se la ritmica antica si configurava come un medium della cura di sé,
come un pharmakon che garantiva la salute del corpo sociale, quella
moderna appare piuttosto come un veleno che è, allo stesso tempo, il
sintomo di una malattia: di una malattia che per Nietzsche, per il
Nietzsche critico della décadence, porta il nome di Richard Wagner.
Nel Tentativo di autocritica che introduce la terza edizione della
Nascita della tragedia (1886), la sua musica - e con essa l’«attuale
musica tedesca» in generale - viene definita «in tutto e per tutto romantica e la meno greca di tutte le forme d’arte possibili; e inoltre una guastatrice di nervi di prim’ordine, doppiamente pericolosa […] nella sua
duplice qualità di narcotico inebriante e insieme annebbiante» (KGW
III.1, 14). La coscienza è stordita e rimane chiusa nel proprio stordimento, perché è catturata in un movimento di dispersione che è senza
ritorno. L’ebbrezza che scende su di essa non è compensata o temperata da una «misura» che permette all’ascoltatore di restare anche presso
16
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
di sé. Per questo Wagner ha rovesciato «il presupposto fisiologico della
musica esistita fino a oggi»: perché la sua musica non ha e non esige
una misura, non richiede più all’ascoltatore di «attenersi a determinati
gradi equivalenti di tempo e di forza», ma vuole al contrario
rompere ogni proporzione matematica di tempo e di forza, arriva talvolta a schernirla; essa è ricchissima nell’invenzione di simili effetti,
che a un orecchio d’altri tempi suonano come blasfemie e paradossi ritmici. Egli teme la pietrificazione, la cristallizzazione, il trapasso della
musica nell’architettonico – e così contrappone al ritmo a due tempi un
ritmo a tre tempi, introduce non di rado quello a cinque o sette tempi,
ripete subito la stessa frase, ma con una estensione tale da farle acquisire una durata doppia e tripla (KGW IV.3, 70-1).
Una mescolanza di discontinuità si sostituisce al movimento regolato
della «musica passata» (KGW VI.3, 419-20). La materia sonora non è più
organizzata in un tessuto ritmico stabile e si sbriciola in un susseguirsi di
momenti irrelati. Così però la musica smette di essere tempo strutturato e
il ritmo smette di essere ciò che era stato per l’estetica classico-romantica: il principio che collega il disparato in una totalità, che – come voleva
Schelling - trasforma lo scorrere casuale degli eventi sonori in una necessità, facendo percepire una unità immaginaria nella reale molteplicità del
materiale sonoro (Corbineau-Hoffmann 1992: 1030). È con l’orecchio
educato da questa tradizione estetica e non – come voleva Adorno – «con
l’orecchio del Biedermeier» che Nietzsche ha ascoltato Wagner «quando
l’ha definito informe» (Adorno 1971: 61).
Ma non è soltanto in gioco l’orecchio. È tutto il corpo – dice
Nietzsche - a soffrire ascoltando quella musica disgregata che eccita gli
affetti senza allo stesso tempo alleggerirli e sedarli mediante ritmi
«sfrenati» ma «sicuri di sé», capaci di distendere il loro fluire in una
modulazione regolare. È una catarsi temperata ciò che Nietzsche chiede alla musica per il suo corpo: un’accelerazione coordinata delle «funzioni animali» che lo sollevi dalla pesantezza e dall’opacità di una
«plumbea vita» (KGW VI.3, 147). E invece la «melodia infinita» di
Wagner attira in un «pantano» (KGW VI.3, 38) che si agita, che viene
agitato da ritmi che non sono più ritmi. È il trionfo amorfo dell’affettività. «Indubbiamente la cosa più sinistra resta lo sfacelo dei nervi», si
legge nel Caso Wagner (KGW VI.3, 38). Ma ancora più sinistra è
un’altra prospettiva: «Dall’imitazione, dalla supremazia di un simile
gusto», scrive Nietzsche, «nascerebbe un pericolo per la musica, di cui
è impossibile immaginare uno maggiore – la completa degenerazione
del senso ritmico, il caos al posto del ritmo» (KGW VI.3, 420).
Senza ritmo c’è solo caos. Senza la percezione o meglio la produzione di strutture ritmiche non può esserci qualcosa come un ordine del reale,
17
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
perché non possono esserci spazio e tempo, essendo spazio e tempo – per
Nietzsche - «unicamente cose misurate, commisurate a un ritmo» (KGW
III.4, 55). In tal senso, il ritmo non è soltanto la «forma del divenire», ma
è «in generale la forma del mondo fenomenico» (KGW II.3, 338). Ciò non
significa che la realtà si manifesti in forme ritmiche, quanto piuttosto che
è l’uomo – in quanto «essere che misura» (KGW III.4, 56) – che configura lo scorrere indifferenziato delle sensazioni mediante ritmi che gli permettono di identificare forme finite nella natura, la quale «non conosce né
figura né grandezza» e «non ha alcun limite, da nessuna parte. Il finito esiste soltanto per noi» (KGW III.4, 50). Ciò che consente all’uomo di ravvisare un ordine in una realtà che in sé non ha ordine, è la «capacità fondamentale» di «percepire la figura»: e i ritmi sono figure mediante le quali
l’uomo costituisce qualcosa come il tempo, che non esiste «in sé» ma
«soltanto per un soggetto senziente» (KGW III.4, 55; 52).
Se è così, allora le diverse forme ritmiche sono espressione di esperienze diverse del tempo, di determinati modi di misurarlo e di rappresentarlo. È in primo luogo come tali che, secondo Nietzsche, vanno
considerate le strutture metriche e ritmiche della lirica greca: come rappresentazioni mimetiche di una determinata esperienza e misurazione
del tempo, che nella poesia e nel culto con cui essa è originariamente
intrecciata diventa oggetto di una ritualizzazione (Emden 2002: 22829). E tale ritualizzazione, suggerisce Nietzsche, è mossa anzitutto dal
bisogno di esorcizzare il flusso imprevedibile dell’accadere:
Se il verso venne usato anche dall’oracolo – i Greci dicevano che
l’esametro era stato inventato a Delfi -, fu perché, anche in questo caso,
il ritmo doveva esercitare una costrizione. Farsi esprimere delle profezie – originariamente significa (secondo l’etimo per me probabile della
parola greca): farsi destinare [bestimmen] qualche cosa; si crede di
costringere il futuro col conquistarsi Apollo: lui che secondo la rappresentazione più antica è molto più di un dio preveggente. Non appena la
formula viene pronunciata, letteralmente e ritmicamente esatta, essa
vincola il futuro: ma la formula è il ritrovato di Apollo che, come dio
dei ritmi, può vincolare anche le dee del destino (KGW V.2, 117-8).
Apollo è molto di più che un dio della preveggenza: è il dio dei ritmi.
E in quanto tale, può qualcosa che nessun altro dio può: può vincolare
anche le Moire. E conquistandosi il suo favore possono farlo anche gli
uomini, appunto perché Apollo è molto più che un dio che pre-vede, che
ha cioè il potere di vedere prima ciò che accadrà dopo, perché egli non
prevede, ma determina il futuro: e questo in quanto dio dei ritmi, in quanto inventore di formule che hanno il potere di vincolare l’avvenire, di
determinare, cioè, la destinazione del presente. È «mediante il ritmo» che
«la poesia degli oracoli [Orakelpoesie] crede di costringere il futuro»
18
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
(KGW II.5, 286). Le sentenze che Apollo detta all’oracolo sono poesia:
agiscono in forza della loro struttura ritmica, danno l’illusione di poter
esercitare una costrizione sul tempo in quanto formule in versi. È il verso
ad alimentare una tale illusione, trasmettendo la sensazione di una prevedibilità dell’accadere. Il verso, ha scritto Heiner Goebbels, «gioca sempre
con l’anticipazione di ciò che verrà, rappresenta l’affidabile» (Goebbels
2002: 104) e va incontro perciò al nostro bisogno di esorcizzare l’angoscia
dell’ignoto, dell’indeterminato.
Il destino di cui dicono le profezie, suggerisce Nietzsche, è una determinazione il cui oggetto, in ultima istanza, è il tempo (Payot 2005: 175).
Se gli oracoli dettati da Apollo hanno una forma ritmica è perché il loro
senso sta nel fornire una schematizzazione del divenire del presente che
trasforma il succedersi casuale e imprevedibile degli eventi in una forma
di tempo che viene sentita come determinata, vincolata da una costrizione (Payot 2005: 175); una costrizione, però, che è esercitata non dagli
eventi stessi, ma dall’uomo, attraverso le formule ritmiche ispirate dal dio.
È possibile allora rilevare una segreta affinità tra la profezia (così come la
intende Nietzsche) e la musica, se è vero, come è vero, che essa è l’arte
che, più di ogni altra, ha come propria materia il tempo; e che il senso di
un’opera musicale – come scrive Rüdiger Görner (1991: 11) commentando Schelling - coincide con le strutture temporali che essa offre alla percezione. Per Schelling è il ritmo che, nella musica, lavora il tempo. Si
legge nella sua Filosofia dell’arte: «Trasformazione della casualità della
successione in necessità = ritmo, attraverso il quale il tutto non è più sottomesso al tempo, ma ha tempo in se stesso» (Schelling 1979: 137). Il
ritmo è il principio che sottrae la musica allo scorrere del tempo, conferendole una propria, particolare temporalità, capace di sollevare il contingente nella sfera di una necessità determinata dall’uomo.
Grazie al ritmo, dunque, l’uomo dispone della temporalità in un
duplice senso: perché, dice Nietzsche, è soltanto tramite il ritmo che
egli può costituire qualcosa come il tempo, che in sé non esiste, ma
anche perché, servendosi del ritmo, l’uomo può dar forma al tempo e
dunque esercitare un controllo sul suo divenire. Così almeno, dice
Nietzsche, credevano gli antichi.
Naturalmente è soltanto un’antica credenza, che appartiene in tutto
alla sfera dell’illusione, dell’immaginario, del desiderio. Ma non appartiene a questa sfera anche ogni rappresentazione del futuro? Non sono
sempre in gioco l’illusione e l’immaginario quando cerchiamo di figurarci l’avvenire del presente, parlando, ad esempio, di ritmi storici o
economici o cosmici? Non è in gioco anche qui, supportato da cognizioni e conoscenze scientifiche, il desiderio di esercitare una costrizione sull’avvenire, come, secondo Nietzsche, faceva Apollo per bocca
dell’oracolo? Ogni profezia, una volta accolta, “vincola” il futuro in
19
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
quanto tempo dell’attesa, lo determina nel presente e a partire dal presente, dalle sue cognizioni e convinzioni, dalle sue credenze. Ogni previsione sull’avvenire è fondata su credenze e cade perciò nell’ordine
superstizione: anche quando parla il linguaggio della scienza. Perché
anche la scienza si muove nell’ambito dell’illusione e dell’errore, nei
quali, dice Nietzsche, vanno riconosciute le «condizioni dell’esistenza
conoscitiva e sensibile». E una tale «cognizione» è proprio la scienza a
fornircela (KGW V.2, 140). È grazie ad essa che oggi sappiamo che se
l’umanità è sopravvissuta è perché alcuni degli errori che l’intelletto ha
prodotto si sono dimostrati «utili e atti alla conservazione della specie»
(KGW V.2, 147). Tali sono stati anche quelli di quell’«antico e superstizioso genere umano» per il quale sembrava non esserci nulla di «più
utile del ritmo». Con esso si credeva di poter tutto, riassume Nietzsche:
dare magicamente incremento a un lavoro; imporre a un dio d’apparire,
di farsi vicino, di porgere ascolto; predisporsi il futuro secondo i propri
voleri; sgravarsi l’anima di qualsivoglia eccesso (di paura, di follia, di
pietà, di spirito vendicativo) e non soltanto l’anima propria, ma anche
quella del peggior demone.
Insomma: «senza il verso non si era nulla, col verso si diveniva
quasi un dio». Un’illusione che appartiene a un passato arcaico, ma non
per questo superato:
Un tale sentimento fondamentale non si lascia più sradicare completamente; e ancor oggi, dopo un lavoro di millenni nel combattere tale
superstizione, anche il più saggio di noi diventa all’occasione un invasato del ritmo, non fosse altro per il fatto che egli sente più vero un pensiero ove abbia una forma metrica e venga incontro con un divino oplà.
Non è una cosa assai divertente che ancor oggi i filosofi più seri, nonostante il rigore con cui sono soliti prendere ogni certezza, si richiamino
a sentenze di poeti per dar forza e credibilità ai loro pensieri? Eppure è
più pericoloso per una verità il fatto di trovarsi d’accordo con un poeta
che l’essere da lui contraddetta! Poiché, come dice Omero: «Molto
mentono gli aedi!» (KGW V.2, 118).
La forza di suggestione del ritmo continua ad agire, perché la superstizione che la produce e la alimenta ancora non è stata sconfitta. Non è
bastato il lavoro millenario della ragione, che per Nietzsche inizia già
nell’Antichità: quando i Greci prendono ad essere via via «meno superstiziosi», perché sviluppano il «senso per la causalità naturale» e quanto
più questo si desta, «quanto più la vita si fa cosciente, tanto più viene
meno la coercizione al discorso ritmico». L’uomo ha sempre meno bisogno del ritmo, perché questo bisogno, per Nietzsche, è inversamente pro20
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
porzionale alla «misura di raziocinio e consapevolezza» presente in un
popolo o in un individuo (KGW II. 5, 288). Ma allora in nessun popolo e
nessun individuo il magnifico cammino e progressivo verso una coscienza finalmente rischiarata dalla ragione è giunto ancora a termine, dato che
continua ad esistere la poesia e che tutti continuano a subire il suo fascino ingannevole. Il fatto è che i «molti millenni in cui si credeva di dovere al discorso ritmico grandi benedizioni» hanno prodotto un «istinto»,
un’inclinazione «inestirpabile» a patire l’incanto dell’evidenza apparente
che il ritmo conferisce al discorso (KGW II. 5, 288).
Ed è questo che rende pericolosa la poesia: il fatto che essa produce
sempre e soltanto una suggestione di verità. Come si può credere, infatti,
alle sentenze dei poeti? Come si può credere a chi formula sentenze affidandosi non alla riflessione ma al ritmo, questo potere che oscura e allontana i pensieri? Eppure questo potere sa sospendere la presenza a sé della
coscienza e far sentire i pensieri più veri, tanto che persino «i filosofi più
seri» ricorrono ad esso per dare «forza e credibilità» alle loro verità. Ma
se la verità di un filosofo può trovare conferma e finanche essere potenziata attraverso la menzogna di un poeta, questo significa che quella verità
è essa stessa una menzogna. Oppure, al contrario, le menzogne del poeta
possono coincidere con le verità del filosofo perché sono esse stesse
verità. Ma se il poeta, affidandosi al ritmo, era già approdato alle verità cui
il filosofo perviene attraverso il lavoro metodico e faticoso della riflessione, allora quel lavoro è inutile.
Perciò è pericoloso per un filosofo trovarsi d’accordo con un poeta:
perché questo lo espone al rischio di dover riconoscere la falsità delle sue
certezze o la vanità delle proprie fatiche. Le sue verità ne escono comunque profondamente compromesse. La luce della poesia fa apparire la filosofia come qualcosa di profondamente problematico. Ma si tratta di una
luce ingannevole: poiché se «i poeti mentono», come scrive Nietzsche
citando Omero, un poeta, allora questa affermazione è una menzogna,
appunto perché è un poeta a pronunciarla. E come si può credere a un filosofo che, per metterci in guardia dalla fascinazione menzognera del
discorso ritmico, si richiama alla parola di un poeta?
Dunque anche Nietzsche, almeno in questa occasione, si fa prendere
dall’invasamento del ritmo? Certo, ma lo fa con metodo. Lo fa per dirci
che esiste un’affinità segreta e perturbante tra poesia e filosofia: «Ma che
ti disse una volta Zarathustra? Che i poeti mentono troppo? – Ma anche
Zarathustra è un poeta. Ma tu credi che abbia detto il vero?» (KGW VI.1,
159). Anche il filosofo, in fondo, è un poeta e non può mai dire di aver
detto la verità, perché la verità, in fondo, non è altro che poesia: «un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi […] che dopo un
lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche, vincolanti» (KGW
III.3, 374). Anche il filosofo, in fondo, è un poeta e non dice la verità, non
21
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
può dirla, perché non c’è modalità della conoscenza alcuna che possa dirsi
al di fuori del territorio dell’illusione e della superstizione in cui la poesia,
per Nietzsche, è fiorita e resta radicata.
E forse è bene che sia così. Forse il contatto con quel territorio è indispensabile alla ragione, e la poesia è preziosa proprio perché ce lo garantisce. I poeti, si legge in Umano troppo umano, sono «esseri rivolti all’indietro: sicché possono essere utilizzati come ponti verso epoche e concezioni lontanissime» (KGW IV.2, 145). Ed è di questo che ne va, per
Nietzsche: non certo di smascherare e combattere la poesia come il prodotto di antiche abitudini superstiziose che, attraverso la parola dei poeti,
parlano ancora nel presente, mettendo a rischio la difficile e necessaria
opera della ragione. Si tratta piuttosto di concedersi ad esse criticamente
per comprendere la loro funzione storica, come anche l’utilità della loro
sopravvivenza nel presente:
Un grado, certo molto elevato, di cultura è raggiunto quando l’uomo si
libera dalle idee e dalle paure superstiziose e religiose […]. Poi, però,
è necessario un movimento all’indietro: egli deve capire la giustificazione storica, come pure quella psicologica, di tali rappresentazioni,
deve riconoscere come sia di là venuto il maggior progresso dell’umanità (KGW IV.2, 37).
È un momento determinante del pensiero di Nietzsche: l’idea che a
una comprensione adeguata delle rappresentazioni e delle attitudini percettive che governano l’orizzonte discorsivo del presente si arriva soltanto mediante uno sguardo retrospettivo che ne mette a nudo l’origine
(Figal 2000: 70). È perciò al presente, a una sua critica genealogica, che
Nietzsche mira interrogandosi sugli inizi della poesia: alla “decostruzione” di una Kunstanschauung assolutamente moderna che relega la poesia in una sfera altra e metastorica dell’“estetico”, proclamandola autonoma rispetto al dominio della ragione strumentale che determinerebbe
«in ogni tempo» il mondo della vita, da cui l’arte sarebbe, dunque, radicalmente dissociata. Il metodo genealogico di Nietzsche lavora invece
per ricollocare la riflessione sull’arte in un ambito più ampio di quello in
cui l’ha confinata il gioco linguistico di una critica estetica d’impronta o
di ascendenza idealistica, allacciandola all’interrogazione sui bisogni alla
cui luce l’uomo percepisce il mondo e sulle tecniche che egli sviluppa
per soddisfarli. «Originariamente non era un gioco e neanche un piacere
estetico», leggiamo nel manoscritto delle lezioni, «si credeva, applicando il ritmo al discorso, di aver veri e propri vantaggi» (KGW II. 5, 288).
È una credenza da cui l’uomo antico trae effettivamente grande beneficio, sostiene Nietzsche, poiché la «nuova ritmica del discorso» cui essa
dà origine assolve una funzione determinante nell’economia pulsionale
di quella società arcaica: contribuisce in maniera decisiva alla stabilizza22
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
zione dell’equilibrio del corpo sociale e perciò anche alla creazione dei
presupposti per la formazione di una coscienza razionale. Ma con
l’avanzare della ragione, sostiene ancora Nietzsche, vengono meno il
bisogno e, dunque, il senso di quelle pratiche sociali superstiziose che
costituiscono il contesto d’origine della poesia, la quale però a quel contesto sopravvive e viene ad esplicare altri compiti. Uno di questi è quello di «conservare e benanche di ricolorire un po’ di concezioni spente,
sbiadite», di far «ritornare gli spiriti» di epoche trascorse, così che «per
alcuni istanti l’antico sentimento si ridesta e il cuore pulsa con un ritmo
ormai dimenticato» (KGW IV.2, 144). Sta qui, per il Nietzsche di Umano
troppo umano, la «generale utilità dell’arte» e in particolare della poesia:
nel ridestare antichi modi del sentire, facendoli tornare nel presente come
spettri che portano confusione nelle sue verità ed espongono a
un’incertezza a cui il sentire moderno, come il sapere che lo governa,
segretamente anelano. È una destabilizzazione dei sensi e dello spirito
che la poesia insegue da sempre. E «ancora oggi», afferma Nietzsche,
i poeti cercano (come nuovo inizio) i limiti della conoscenza, dello
scetticismo, per sottrarsi all’incantesimo della logica. Essi vogliono
insicurezza, perché allora la magia, il presagio, e i grandi effetti dell’anima diventano nuovamente possibili (KGW II. 5, 351-2).
I poeti non smettono di indicare alla coscienza le zone d’ombra di
quella realtà che l’occhio della ragione le dà a vedere, attirandoci nello
spazio di quell’irragionevolezza di cui abbiamo bisogno per esperire la
limitatezza della nostra percezione apparentemente disincantata del
reale e presentire possibilità nuove di accogliere il mondo nella nostra
coscienza. È per questo che proprio i «filosofi più seri», quelli che sono
soliti interrogare con rigore le proprie verità, subiscono l’inganno della
parola ritmica del poeta, rivelando così un senso intimo di incertezza,
una lacuna, una perplessità sui propri giudizi come sui propri dubbi. Se
irragionevolmente si rivolgono alle sentenze dei poeti per dare ai propri pensieri forza e credibilità, è perché sentono che il discorso razionale di forza e credibilità non ne ha abbastanza. Perciò la ragione si fa
cogliere dall’invasamento del ritmo, in cui, dunque, è all’opera un
impulso del pensiero ad evadere dai limiti che esso si pone e necessariamente deve porsi, per aprirsi all’ulteriorità elusiva in cui trova la sua
fine e la sua linfa vitale.
FRANCESCO FIORENTINO
23
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
NOTE
1. I rimandi alle opere di Nietzsche si riferiscono alla seguente edizione:
Werke. Kritische Gesamtausgabe (= KGW), a cura di G. Colli, M. Montinari, W.
Müller-Lauter, K. Pestalozzi, Berlin-New York, de Gruyter, 1967 sgg., riportando, con qualche licenza, la versione italiana delle Opere di Friedrich Nietzsche,
Milano, Adelphi, 1964 sgg. Nel caso dei brani tratti dalle lettere e dalle lezioni
sulla Storia della letteratura greca, invece, la traduzione è di chi scrive.
2. Bisogna però precisare che, per Nietzsche, il ritmo è tale soltanto nel
mondo dei «Greci dionisiaci», mentre in precedenza la musica era un’arte
puramente apollinea, della quale non si conosceva che «il colpo d’onda del
ritmo, la cui forza plastica veniva sviluppata per la rappresentazione di stati
apollinei. […] Cautamente è tenuto lontano, come non apollineo, proprio
l’elemento che costituisce il carattere della musica dionisiaca e quindi della
musica in genere: la violenza sconvolgente del suono, il flusso unitario della
melodia e il mondo assolutamente incomparabile dell’armonia». Così è finché
il mondo greco rifiuta gli istinti dionisiaci. Quando finirà per doverli accogliere, invece, il ritmo cambia segno e si fa articolazione del dionisiaco stesso, il quale produce uno «scatenamento totale di tutte le forze simboliche», stimolando «anzitutto l’intero simbolismo del corpo, non soltanto il simbolismo
della bocca, del volto, della parola, ma anche la mimica totale della danza, che
muove ritmicamente tutte le membra». L’armonia diventa ora, insieme a «ritmica» e «dinamica», una delle «forze simboliche» della musica che «in seguito crescono all’improvviso e impetuosamente» (KGW III.1, 29-30).
3. Riprendo qui una considerazione sull’estasi dionisiaca di Günter Figal
(2002: 47).
4. Lo studio di Jaeger cui faccio qui riferimento è Paideia ed è citato da
Georgiades (1958: 65).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ADORNO, TH. W.
1971
Versuch über Wagner, in Gesammelte Schriften, a cura di G. Adorno e
R. Tiedermann, vol. 13, Frankfurt/M.: Suhrkamp; 7-149.
CORBINEAU-HOFFMANN A.
1992
Rhythmus, in J. Ritter e K. Gründer (a cura di), Historisches
Wörterbuch der Philosophie, vol. 8, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, coll. 1026-1033.
EMDEN, CH. J.
2002
Sprache, Musik und Rhythmus. Nietzsche über die Ursprünge von
Literatur, 1969-1879, in «Zeitschrift für deutsche Philologie», 121;
203-230.
24
Igitur 2006 - Il ritmo nelle arti e nei saperi
FIGAL, G.
2002
Nietzsche. Un ritratto filosofico, Roma: Donzelli.
FOUCAULT, M.
1998
Archivio Foucault 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, a cura di A. Pandolfi, Milano: Feltrinelli.
GENTILI, B.
2006
Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo,
Edizione aggiornata, Milano: Feltrinelli.
GEORGIADES, T.
1958
Musik und Rhythmus bei den Griechen. Zum Ursprung der abendländlichen Musik, Hamburg: Rowohlt.
GOEBBELS, H.
2002
Puls und Bruch: Zum Rhythmus in Sprache und Sprechtheater, in W.
Sandner (a cura di), Heiner Goebbels. Komposition als Inszenierung,
Berlin: Henschel; 99-108.
GÖRNER R.
1991
Schattenrisse und andere Ansichten vom Ich, in N. Saul (a cura di),
Die deutsche literarische Romantik und die Wissenschaften,
München: iudicium; 1-18.
GUMBRECHT, H.U.
1988
Rhythmus und Sinn, in H.U. Gumbrecht, K.L. Pfeiffer, Materialität
und Kommunikation, Frankfurt a.M.: Suhrkamp; 714-29.
MERSCH, D.
2005
Maß und Differenz. Zum Verhältnis von Mélos und Rhythmós im
europäischen Musikdenken, in P. Primavesi, S. Mahrenholz (a cura
di), Geteilte Zeit. Zur Kritik des Rhythmus in den Künsten, Schlingen:
Argus; 37-51.
MESCHONNIC, H.
1982
Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Paris:
Lagrasse.
NIETZSCHE, F.
1922
Ueber den Rhythmus, in Id., Gesammelte Werke, vol. 5, München:
Musarion, pp. 474-75.
1967sgg. Werke. Kritische Gesamtausgabe, a cura di G. Colli, M. Montinari, W.
Müller-Lauter, K. Pestalozzi, Berlin-New York: de Gruyter.
1967sgg. Opere di Friedrich Nietzsche, a cura di G. Colli e M. Montinari,
Milano: Adelphi.
1984
Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, a cura di G. Colli e M.
Montanari, vol. III.5, Berlin-New York: de Gruyter.
PAYOT, D.
2005
Der Rhythmus des Kunstwerks: zwischen Atmen und Beschwörung, in
P. Primavesi, S. Mahrenholz (a cura di), Geteilte Zeit. Zur Kritik des
Rhythmus in den Künsten, Schlingen: Argus; 171-77.
25
Francesco Fiorentino: Nietzsche e il ritmo degli antichi
SCHELLING, F.W J.
1976
Philosophie der Kunst, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
SCHOPENHAUER, A.
1986
Sämtliche Werke, a cura di W. Frhr. von Löhneysen, 5 voll.,
Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
26