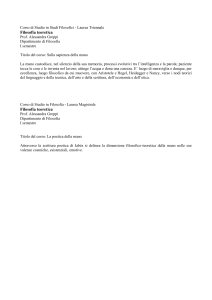Numero 2 - Dicembre 2016
Direttore: Franco Sarcinelli
Vicedirettori: Matteo Canevari, Sara Fumagalli
Comitato scientifico
Joselyn Benoist (Université Paris1), Alberto Giovanni Biuso (Università di
Catania), Silvana Borutti (Università di Pavia), Vinicio Busacchi (Università
di Cagliari), Eduardo Casarotti (Rector de la Universidad Católica del Uruguay), Vincenzo Costa (Università del Molise), Umberto Curi (Università
di Padova), Guido Cusinato (Università di Verona), Roberto Diodato (Università Cattolica di Milano), Rossella Fabbrichesi (Università degli studi di
Milano), Marco Ferraguti (Università degli Studi di Milano), Sandro Mancini (Università di Palermo), Diego Marconi (Università di Torino), Patricio Mena Malet (Universidad de la Frontera Chile), Fabio Merlini (IUFFP
Lugano), Fulvio Papi (Professore Emerito Università di Pavia), Dario Sacchi (Università Cattolica di Milano), Gabriele Scaramuzza (Università degli
Studi di Milano), Carlo Sini (Professore emerito Università degli Studi di
Milano), Paolo Spinicci (Università degli Studi di Milano), Nicla Vassallo
(Università degli Studi di Genova), Salvatore Veca (Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia), Andrea Zhok (Università degli Studi di Milano)
Redazione
Alessandro Vigorelli Porro (caporedattore), Gioacchino Orsenigo (segretario di redazione), Andrea Araf, Francesca Carta, Simone Canziani, Gianandrea Rizzi, Federica Sordini, Chiara Zancan
Collaboratori
Claudio Muti (responsabile), Diego D’Angelo, Massimo Flematti, Pietro
Garofalo, Oujedine Mejri, Massimo Mezzanzanica, Raffaele Mirelli, Sara
Pasetto, Sabrina Peron, Veronica Ronchi, Gianni Trimarchi
Progetto editoriale web: Marco Ferrero
Direttore responsabile: Emilio Renzi
Rivista semestrale - ISSN 2531-4092
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 358 del 23/12/2015
Editore: Franco Sarcinelli – Luogo di produzione: via L. Settembrini, 47
20124 Milano
I contributi inviati alla rivista per la pubblicazione sono sottoposti a blind
peer review
Tutto il materiale testualle degli autori di “InCircolo” è reso disponibile secondo i termini della Creative Commons License, Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Unported (CC-BY-NC--ND 3.0).
Presentazione
Il secondo numero di InCircolo ricalca l’impianto complessivo del
precedente.
La serie dei “Contributi speciali” si avvale di due presenze significative: Ágnes Heller e Diego Marconi. Heller analizza, a partire
dalla sua esperienza americana, le tappe e i caratteri che configurano
in senso globale l’istituzione universitaria attuale per l’insegnamento
della filosofia ed evidenzia i rischi dell’acutizzarsi delle sue criticità
nel prossimo futuro. Il dialogo con Diego Marconi mette a fuoco –
sulla base di solide e articolate risposte – le sue posizioni sul ruolo
teorico della filosofia all’interno dell’orizzonte dei cosiddetti filosofi
analitici e, in chiusura, sulle finalità professionali degli studi universitari per i giovani del giorno d’oggi.
Filosofia alla prova dell’Europa è il tema generale per la sezione
1, denominata “La questione filosofica”. Matteo Canevari l’affronta
facendo riferimento all’area balcanica come paradigma per la comprensione dei problemi attuali e perviene a presupporre una idea
d’Europa plurale e insieme capace di traduzione tra le differenti lingue e culture che la compongono.
Gli interventi successivi riprendono i temi dei conflitti e della crisi a partire dalle elaborazioni di importanti autori europei: Natalia
Rodríguez Martín fa riferimento a Miguel de Unamuno, Laura Sanò
ad Hannah Arendt, Sara Pasetto a Edmund Husserl.
La sezione “Culture” vede i contributi sulla cultura araba con l’intervista a Massimo Campanini e con le riflessioni di Wael Farouq
su Averroè, filosofo per molto tempo ignorato nello stesso contesto
iv InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
al quale apparteneva. Nella stessa sezione compare anche la ricostruzione che Federico Fagotto conduce con grande accuratezza sugli
studi inerenti le culture orientali – in particolare sul buddhismo – prodotti in area mitteleuropea tra il 1800 e il 1900.
La sezione “Laboratorio” conferma l’obiettivo di fornire strumenti utili a proporre percorsi di ricerca da saggiare in differenti direzioni
teoriche. Gianni Trimarchi affronta un testo di Alfred Schutz come
cartina di tornasole per introdurre proposte di modelli fecondi per le
scienze umane, in particolare per l’antropologia. Vittoria Sisca ricorre
alle considerazioni di Martin Heidegger per riproporre il tema della
tecnica al giorno d’oggi. Infine, Andrea Araf e Gioacchino Orsenigo
adottano punti di vista filosofici per confrontarsi sulla figura del terrorista nella realtà del mondo globale contemporaneo.
Nella sezione 4, “Intersezioni”, Emilio Renzi individua l’antropologia della modernità attraverso una serie di personaggi letterari
che vanno da Robinson Crusoe a Jean Sorel fino a Mattia Pascal,
mentre Daniela Canavero rilegge la figura del ‘barbaro’ attraverso le
lenti euripidee dell’Andromaca, una figura femminile non meno incisiva della ben più nota Medea. Sulla natura filosofica dell’azione
terapeutica offre spunti interessanti nel suo intervento la psicoanalista
Alessandra Zambelli.
Nella sezione 5, dedicata alle “Controversie”, troviamo esposto
con chiarezza da Alberto Giovanni Biuso la distinzione sulla questione della temporalità tra l’approccio ontologico di Heidegger e quello
narrativo di Paul Ricoeur, mentre Stefano Canziani entra nel merito
della dura polemica tra Sloterdijk e Habermas, evidenziando i punti
che determinano la loro contrapposizione.
Nella sezione sulle “Corrispondenze” si colloca la testimonianza
di Nicola Polloni sulle incertezze che gravano sul sistema universitario inglese a causa della “Brexit”, mentre il contributo di Rolando
Vitali denuncia i rischi di svuotamento della formazione universitaria
in Germania in correlazione con l’impoverimento dell’insegnamento
filosofico, vale a dire una pesante ipoteca sulla qualità dei processi
formativi che di fatto le scelte politiche in atto stanno diffondendo
nell’intero continente europeo.
Infine, la sezione “Letture/Eventi” contiene note di lettura di libri,
di un film e un reportage sul Festival Internazionale di Filosofia svoltosi fra il 29 settembre e il 2 ottobre scorsi a Ischia.
Presentation
This second issue of InCircolo follows the same structure of the previous one.
The “Special Contributions” series is enriched by two meaningful
guests: Ágnes Heller and Diego Marconi. Starting with her American
experience, Heller analyzes the steps and the characteristics that globally configure the present university structures for the teaching of
philosophy and points out the risks that might affect its future development. Through a dialog, Marconi sharply pinpoints his positions
about the theoretical role of philosophy in the wider context of the so
called analytical philosophy and about the professional development
that young people might obtain from the universities.
Philosophy to the test of Europe is the general theme for Section
1, “The Philosophical Question”. Matteo Canevari approaches the
theme using the Balkan area as a paradigm for understanding the
present problems and formulates an idea of Europe at the same time
plural and capable of translating between the various languages and
cultures that exist in it.
The other contributions debate the themes of the conflicts and
crisis starting with the conceptions of important European authors:
Natalia Rodríguez Martín refers to Miguel de Unamuno, Laura Sanò
to Hannah Arendt, Sara Pasetto to Edmund Husserl
In Section 2, “Cultures” we find contributions about Arabian culture with an interview with Massimo Campanini and the considerations of Wael Farouk about Averroes, a philosopher long time ignored
in the same context where he belonged. In this same section we find
vi InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
the reconstruction that Federico Fagotto develops with great accuracy
of the studies about Oriental cultures – specifically about Buddhism
– developed in the Middle European area between the XIX and the
XX centuries.
Section 3, “Laboratory”, confirms its aim to provide tools that might be useful for developing research patterns along various different
directions. Gianni Trimarchi approaches a text of Alfred Schutz as a
litmus test for introducing proposals of models that may be fertile for
the development of human sciences, particularly for anthropology.
Vittoria Sisca refers to some considerations of Martin Heidegger in
order to propose the theme of the technique in present times. Finally,
Andrea Araf and Gioacchino Orsenigo recur to philosophical points
of view in order to evaluate the image of the terrorist in the contemporary reality of a globalized world.
In Section 4, “Intersections”, Emilio Renzi focuses on the anthropology of modernity through a series of characters from literature
who go from Robinson Crusoe to Jean Sorel up to Mattia Pascal while
Daniela Canavero reexamines the image of the “barbarian” through
the Euripidian lenses of Andromache, a female character not less incisive than the more notorious Medea. About the philosophical nature
of the therapeutic action, Alessandra Zambelli, psychoanalyst, offers
some interesting hints.
In Section 5, reserved for “Controversies”, one can find a paper by
Alberto Giovanni Biuso that explains with great clarity the differences on the question of temporality between the ontological approach
of Heidegger e the narrative approach of Paul Ricoeur, while Stefano
Canziani examines in depth the harsh polemics between Sloterdijk
and Habermas, outlining the main points that determine their contrast.
Section 6, “Correspondence” contains the testimony of Nicola
Polloni about the uncertainties that bear on the British universities
due to “Brexit”, while the paper of Rolando Vitali exposes the risks of
the emptying of university education in Germany in connection with
the impoverishment of the teaching of philosophy, that is to say a heavy mortgage on the quality of the educational processes that actually
the political choices currently being made are diffusing in the entire
European continent.
Presentation vii
To sum it up, Section 7, “Readings/Events”, contains reviews of
some books and a film, and a reportage on the International Festival
of Philosophy, held in Ischia between September 29 and October 2 of
the current year
Sommario
Presentazioneiii
Presentationv
Agnes Heller, Past, present, and future of Universities1
Franco Sarcinelli, In dialogo con Diego Marconi11
La questione filosofica
Matteo Canevari, Visioni balcaniche.
Problemi di messa a fuoco dell’idea d’Europa27
Natalia Rodríguez Martín, La Europa de Miguel de Unamuno65
Laura Sanò, Morfogenesi dell’Europa: guerra e potere77
Sara Pasetto, L’“Europa” secondo Husserl:
l’enigmatica sfida del filosofo97
Culture
Massimo Campanini, Sul pensiero islamico.
Intervista raccolta da Alessandro Vigorelli Porro
125
Wael Farouq, Averroè fra fiqh e filosofia
133
Federico Filippo Fagotto, Attraverso la parete di vetro.
Ricezopmo deò buddhismo nell’arte e nel pensiero mitteleuropei151
Laboratorio
Gianni Trimarchi, La logica del pensiero quotidiano177
Vittoria Sisca, La prova del filosofo: domandare in maniera iniziale
nell’epoca della finale determinazione tecnica197
x InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo, La figura del terrorista nello
spazio globale contemporaneo215
Intersezioni
Emilio Renzi, Robinson Crusoe Julien Sorel Mattia Pascal239
Daniela Canavero, Il “barbaro” spartano. Identità culturale
e polemica antispartana nell’Andromaca di Euripide249
Alessandra Zambelli, La Sfida dell’Altro.
Sulla natura filosofica dell’azione terapeutica259
Controversie
Alberto Giovanni Biuso, Identità e differenze temporali.
Su Heidegger e Ricoeur 277
Simone Canziani, Viaggio al centro della sfera. Immunologia
e antropometrica attraverso la polemica Haermas-Sloterdijk291
Corrispondenze
Nicola Polloni, L’ombra di Brexit sull’accademia inglese303
Rolando Vitali, Nota sull’avvenire delle nostre scuole: università
e formazione in Germania e in Europa307
Letture/Eventi
Andrea Loffi: Karl Jaspers, Della verità. Karl Jaspers, Von der
Wahrheit. Philosophische Logik. München, Piper, 1947. A cura
di Diego D’Angelo, Della verità. Logica filosofica. Milano,
Bompiani, 2015.
315
Diego D’Angelo: Fabiola Falappa, Sul confine della verità. La
metafisica di Karl Jaspers e il futuro della coscienza europea,
Milano: Franco Angeli 2016.
322
Katia Serena Cannata: Alberto Giovanni Biuso, Temporalità e
Differenza, Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2013
328
Lorenzo Musante: Limiti e la condizione umana
sospesa tra due assoluti336
Sara Fumagalli: Ischia International Festival of Philosophy 2016343
Franco Sarcinelli, Note sul film El abrazo de la serpiente:
un approccio filosofico351
Gli autori
355
Past, present, and future of Universities
Agnes Heller
Heller voices her pessimistic view on the dcline of the university
system worldwide. Starting from the definition of the term “Bildung”
by Hegel, she gives a brief outline of the history of higher education through the centuries, and shows how class divisions are still
an important factor in modern universities. The ever-increasing role
of bureaucracy has also a negative impact on the quality of teaching
and learning, undermining creativity and the development of talents.
In one section of Hegel’s Phenomenology of the Spirit the common
German word Bildung appears in a very specific interpretation. Hegel
ascribes Bildung to a transitory period between a period termed by
him “alienation” and the period of enlightenment. There the externalization, objectification of the persons is still the case, yet they are
already preparing enlightenment as its condition.
The tendency characterized in Hegel’s philosophy as Bildung
is addressed by the historical sociology of Norbert Elias as ”the civilizing process”. He tells the story as follows. Roughly until the
Renaissance the aristocracy, and also the minor nobility lived amidst
of and according to the rules of their estates. Those rules encompassed beliefs, consciousness, knowledge, ethics, dressing code, language use, norms of reciprocity and much else, that is a way of life. This
way of life, divided the upper estates from all the lower ones, be their
members rich or poor. Those who crossed the border of estates became ridiculous, like in the comedies by Moliere. As the caste of bur-
2 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
ghers gained strength, their needs for establishing their own norms,
rules, codes, that is forms of life, gained momentum.
To put it shortly, Bildung was the name of the process through
which a specific bourgeois form of life has been established. Hegel
mentioned two kinds of Bildung. One being theoretical, the other
pragmatic. The first creates and establishes the norms of social behavior, the ethical concepts, norms of tastes,judgments, modes of communication, the second establishes the codes of honor in practicing
one’s vocation. The good burgher has a vocation, different burghers
different ones, everyone should perform their own work honestly.
From the end of the 18th century, European gymnasiums and universities were supposed to fulfill the double task of Bildung. They
became essential for the establishment of a double (a bourgeois and
a national) identity combined with good scientific training in the then
developing nation states. In the already modern countries, which were
born prior to nation states, such as the United States, there were no
universities until the mid 19th century. In Europe, philosophy stepped
in the shoes of theology. In Berlin, Hegel told his students at the last
class of his lectures in the history of philosophy, that the standpoint of
the individual is seizing the substantial spirit. His closing words were
“I wish you live a good life” (Ich wünsche ihnen recht wohl zu leben”
To sum up: the task of the universities was, at least on the European
continent, to form a new bourgeois elite that will serve simultaneously as a cultural elite. Ranks inherited at birth were replaced by social
classes, and the wealthy parents, even if uneducated, wanted their
sons to be well educated. Whereas in the United States “eggheads”
did not enjoy great prestige, they did so in Europe. Not all diplomas
had the same worth, but political leadership required one, preferably
of certain important faculties such as law.
Class societies were slowly transformed into mass societies. The
transformation started after WW1, became rapid after WW2, and
terminated in and after 1968. The forms of life of the burgher were
shaken, the so-called civilizing process stopped or rather reversed. It
would be unheard of to close a university course with the words of
Hegel. The task of universities in mass societies is no more to prepare
students for living a decent, good life.
Due to the transformation of societies (at least on the European
continent) the social mission of universities assumes a paradoxical
form.
Agnes Heller - Past, present, and future of Universities 3
Modern society in general differs from all pre-modern societies,
insofar as it is not the place occupied in the social hierarchy by the
time of or place of birth which will determine roughly the function the
person will perform throughout his life. Just the contrary is the case.
The function a person performs will determine his place in the social
hierarchy. Thus modern society is a functional society.
Class societies, where Bildung played an eminent role, were transitory, while mass society, the outcome of class societies, becomes,
finally, entirely functional.
The entirely functional mass society could, however not entirely
eliminate the characteristic of pre-modern societies based on stratification. Up to a degree, the accident of birth if it does not determine
yet at least still conditions the main functions men and women will
perform later on in life, Still, modernity, class society at first, and then
mass society changed the logic of stratified societies, by reversing the
connection between birthplace and function. Namely, they inserted
education between the time and place of birth and the establishment
of one’s place in the social hierarchy by performing a function. Birth
is no more destiny. How many classes follows a child, where and
when, whether she will gain a place in an institution of tertiary education and in which one,will matter as much as the accident of birth.
At first, in bourgeois class society to attend primary school became
obligatory for lower classes, in view of disciplining the children of
the poor, shaping them for becoming raw material in factories, whereas children of higher classes were still taught by private tutors..To
discipline meant to punish, to beat up the arrogant, disobedient children, and not just lower class children. One step higher, “burgher”
schools were established for the lower middle class and for all the
girls, whereas gymnasium served the upper middle class and the upper class boys.
The dominant status of natural sciences was not immediately
incorporated in the school system, but soon so called “real” classes
appeared beside the so called “human” ones. Without high school certificate, no one could enroll in any university.
We know, however, that the mediation via educational institutions
cannot entirely outbalance the accident of birth. Not even in the present day. For example, the program launched by President Bush “No
child left behind” failed. All the earlier and subsequent school reforms failed, and there were many.
4 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Modern educational institutions were always teaching to be good
at performing certain functions. Contrary to the times of class societies, nowadays, in our mass societies, this remained almost the sole
task of educational institutions. The higher level institutions, especially elite universities, teach how to perform the better paid functions.
One aspect of Bildung, mentioned by Hegel, the preparation of
students for a better, more dignified life, became outdated, and rightly
so. In mass societies ways of life diverge, and no educational institution can superimpose on all the students the same form of life as the
only dignified one. Forms of life are now open for choice, at least in
principle, except in dictatorships.
Still, institutions of education in liberal democracies can contribute to the Bildung of good citizens. Several American universities do
it, but the tradition of European universities does not further educate
students to become citizens..
Another aspect of the Hegelian Bildung, the acquisition of the
cultural tradition, literature, philosophy included, is still preserved in
some elite universities, but not in others.
It seems paradoxical defend the idea of democracy on the one
hand and suggest at the same time the Bildung of a cultural elite .
Those who occupy the higher levels in the social hierarchy of the financial or political spheres claim the role of the elite even without any
knowledge of the cultural tradition, art, literature, history. Democracy
needs a cultural elite, which cannot be located in a precise place of
the social hierarchy, being characterized, again, by the function it performs, namely the general function of social and cultural criticism.
The function of meaning, rendering, interpreting, asking questions,
doubting. This (the contradiction between the principle of democracy,
and the need for a cultural elite in democracy) is a paradox one has
to live with.
Mass society produces mass universities. This leads to further
paradoxes.
Modern functional society is based on the idea of equal opportunity. Although in fact there is no equal opportunity the idea itself is
a constitutive factor of modern society. One has to presuppose that
everyone who wants to study in the institutions of higher learning
should have the opportunity to do so. At the same time, another constitutive factor of modernity is the developmental logic of science and
technology. This is the only sphere where one can legitimately speak
Agnes Heller - Past, present, and future of Universities 5
of progress, namely the accumulation of knowledge: both in terms of
know what and of know how.
In mass universities, however, the level of teaching and the quality of accumulative knowledge equals in the average roughly to the
quality and level of knowledge accumulated a half century ago in a
gymnasium. In many universities and in the majority of colleges one
knows less at 24 than our fathers at 18.
Equal opportunity or first class education? This paradox, as it
happens with paradoxes in general, can also not be solved. One has to
give preference to one or the other “factor” or “thesis” of the paradox.
One can establish, for example, a hierarchical order between institutions of higher education, some for mass education, some for high level education, some mass universities, some select-elite universities.
The way to select can be entry examination or tuition fees, or
both. Neither of them is without problems.
As far as entry examinations go, they seem objective, yet they
are entirely subjective.The usual tests favor the average, not the
best, they punish the marginal and the intellectually curious. Jacques
Derrida, for example, failed twice at the entry examination of the
École Normale. In addition, lately even political correctness transformed the character of entry examinations from bad to worse Tuition
fees,on the other hand, discriminate against the poor. Both hurt the
principle of equal opportunity even without success in furthering the
education of those who might in the future play a role in the further
development of sciences and technology.
In America, for example, tuition fees are constantly increasing
in the most frequented universities, and not just in private ones.
Whereas in community colleges, where tuition is free, students can
hardly write or read. In some European states tuition is getting also
more and more expensive. As a result, upwards mobility, so important
for the functioning of modern societies, constantly diminishes and in
some places it even stops. That is the learned people reproduce their
stratum in their children.
Three other tendencies characterize more and more modern education, and especially tertiary education. First, the loss of authority of
learning, second a special school certificate as the entry ticket of most
positions, third bureaucratization.
The student movement of 1968 led to an essential change in the
university structure. First, liberalization. Students acquired the possi-
6 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
bility to actively participate in the life of their schools. They now can
choose among school books, among subject matters, in universities
also their classes, their professors. The power of a professor depends
more on his or her personal authority than before, and the personal
authority can depend more on the professors teaching and their ability
to establish human relations with students. Although the change of
university structures is a general tendency, there are essential differences among the states, for example, the professors personal power
to place their students after graduation is very different in Europe,
USA, and several Latin-American cities and states..
The same development – the liberalization of universities and the
greater power of students – a desirable development in itself, went
together with some (in my opiniom) less desirable ones. For example,
several new subject matters without any academic worth were included into the curriculum, partly due to political correctness, partly to
the students desire to get a grade without mental effort, and finally to
the desire of some teachers to get a position at all.
The second tendency which gained momentum in the last decades
was to tie many occupations and positions to a degree from a tertiary
institutions or a high school certificate: several occupations which
were filled and well practiced without degrees or certificates, are not
allowed to be practiced without them. Although the certificate does
not prove at all that those who own it are more able to perform the
task than those who do not. Many young men and women, who do
not need any diploma or certificate at all, must spend many years in
schools, where they may learn something they could learn just by
practicing the skill, or learn something they can not use at all. They
need just a piece of paper as a condition for being employed.
The above mentioned tendencies lead to a new kind of frustration. The idea of equal opportunity was tied with that of equal worth.
According to these ideas, every kind of occupation is of equal worth
if someone works well or if someone excels in performing a function
well. The slowing down of upwards mobility simultaneously with the
pressure to get degrees for occupation where prevously such degrees
were not required, frustrated people. This frustration is a hotbed for
the eruption of all kinds of populist demagogy, racism included.. Less
in the United States, than in many European societies where the earlier feudal habits and attitudes were not entirely forgotten, where the
“low” occupations are still despised.
Agnes Heller - Past, present, and future of Universities 7
The last thirty-forty years saw the until then unheard of growth of
bureaucracy in the university system and in many institutions of research. Peter Murphy proved statistically that whereas in the eighties of
the 20th century universities all around the globe spent 40 percent of
their funds on bureaucracy, by now they spend 60 percent of all their
funds. Thus only 40 percent remains for everything else, students’
stipend and professors’ salary included. From this follows that the
increasing tuition fees are not spent on education, but on the upkeep
of bureaucracy. The upkeep of an entirely useless bureaucracy. The
main task of professors is no more to teach but to fill out hundred of
papers, to document all their actions and the actions of their students.
To offer my own example. To teach two weeks in a summer seminar,
I had to present four documents (among others my university degree
certificate) and fill out at least four papers to answer at least 10 different questions. I presume that in all universities at least ten if no more
people are hired to invent the questions, collect answers from some
twenty professors, group them and give a report of them. For what
reason? For no other reason than keeping bureaucracy growing and
swallowing up all the rest.
What can be the reason behind this unreason? Total loss in the
trust of personal honesty. Everyone needs to be controlled many times
over. It is presumed that student do not enroll in order to learn something, to hear something that interests them, but for the sole reason
to get a good job and to earn much money. Since the motivations cannot be controlled and tested unless through a mind reading machine,
they control what can be controlled, namely the data. As if the data
could tell anything about the motives! How many of them (several
teachers included) work through the internet to find out whether a
student copied his term paper from there. Only a half an hour of consultation with a student would give them full answer to this inquiry.
One can discuss the cheating with the guilty student and make him
ashamed and change his mind. But writing long reports looks easier.
The sin, detected yet also corrected, would not be documented.
In a mass university there are so many students, one cannot know
them, one cannot talk to them, one can only register them. And they
need to be registered.
Needless to say, that bureaucracy, this Big Brother spies also on
the professors Perhaps their autobiographies are phony, perhaps their
date of birth and marital status is incorrect. Everything needs to be
8 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
checked, except the quality of teaching, the only thing that matters.
(Bureaucracy has no qualification to check it.) We all know that one
professor among circa a thousand is a cheat. But this shows rather sooner than later, thus no constant checking will eliminate this to occur
.And what is more important: real cheats are the best at cheating bureaucracy itself, they will answer all the thousand questions fluently
and satisfy them by presenting all the fake documents.
The desire to control, the distrust in the honesty of individuals,
the distrust in the mental and intellectual power of single individuals
characterize not just universities, but also institutions and laboratories
of research.
Mass society distrusts the individual also if it comes to scientific
research..Everyone believes in team work.
Let me accept Kuhn’s distinction between revolutionary and normal science. I could accept that in case of normal science team work
is more fruitful.. But I doubt very much whether revolutionary science can flourish under the condition of team work. The distrust against
individual scientific work has also to do something with the increase
of bureaucracy.
Needless to say, modern science requires a lot of money. States,
individual donors, funds etc need to spend enormous sums only for
the equipments needed for research. No wonder then that neither states nor endowments are ready to give money for a single individual
who claims to be on the way of a revolutionary discovery, but has not
done it yet.Yet we also know, that revolutionary science is never the
continuation of something that we already know, even if this knowledge is not exhausted. Scholars trotting on roads already known, can
always add a little something to what is known, and this little something is very often important for keeping newborn alive or curing
a rare illness, albeit not to make us understand its cause. They do not
require a new paradigm.
New paradigms are always the results of the discovery by one
or two persons, they are not fruits of team work. For, as we know it
also from Einstein, the unconscious of the individual plays a pivotal
role in it. As Koestler, writing on the most significant discoverers,
showed, revolutionary science presupposes not association but dissociation. Not to think in line of previous discoveries, but in thinking
together symptoms, phenomena, or occurrences which where hitherto
not combined nor thought together. Dissociation can appear in dre-
Agnes Heller - Past, present, and future of Universities 9
ams, takes mostly the form of an “intuition”. Intuition has no place in
teamwork, it can not occupy a place in it, for teams have no common
unconscious.
When Murphy shows in the book I mentioned, that since the eighties no single new paradigms appeared, on the scientific heaven,
that what goes on since this time onwards is the slow building up of
the results by normal science. he has a strong point.
Let me return to universities. The most lasting impression students receive comes from individuals not group, from a meaningful teacher of a passionate character, from someone unfitting to the average,
not “normal” in the traditional sense. Once upon a time, even in my
youth, middle schools were also rich in funny, sometimes ridiculous,
always impressive personalities. Some teachers were mocked, parodized, because they were fascinating in a different way. At present
university bureaucracy purifies universities from those dying out animals, giving preference to the mediocre and the avarage. No one has
to stand out. How will then our students stand out?
All this was not meant as an indictment against mass universities,
even less as a defense of traditional universities. Bu what I strongly
suggest for the reform of universities is to get rid of half of the bureaucracy, to invest more trust into the single individual. From the
money at the university’s disposal much more should be spent on
students’ grants and researchers’ stipends. More freedom for students
and young faculty to develop their best abilities, their best potentials
into talents. I would suggest also more concern for general culture,
what can be termed universalism.
Surely, in a music school a violin student must concentrate on
learning how to play well, a chemistry student how to enter in the
footsteps of present inquiries, and so on and so forth. But simultaneously the old recipe of Bildung needs to accompany the project. To
understand history, to get a view on the state of the world in general,
to become interested in fine arts. All those contribute to their ability
and also to their readiness to play an active part as a well informed
citizen in the matters of their states. To participate as concerned and
rational thinking individuals and not just as members of one or the
other pressure group.
I do not know whether the tendency toward bureaucratic rule of
universities and also of many research institutes can be reversed, I
suggest only that it should be reversed. For if it is not, creativity of our
10 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
culture will get entirely lost and so will be upwards mobility. Political
activity will be limited to professional politicians. Our iron age will
set in.
In dialogo con Diego Marconi
Intervista raccolta da Franco Sarcinelli
Il gruppo milanese di “Filosofia in circolo” ha avuto nel corso del
2015 un significativo incontro con il Professor Diego Marconi della
università di Torino a proposito del suo recente libro Il mestiere di
pensare. Questo dialogo è stato sintetizzato in sette domande, alle
quali Marconi risponde offrendoci un quadro ampio e articolato delle
sue posizioni che offrono spunti interessanti a proposito del dibattito
filosofico contemporaneo. Lo ringraziamo vivamente per la sua disponibilità e per aver accettato la pubblicazione di questo resoconto
sulla nostra rivista.
InCircolo: Specialmente nel primo capitolo del Suo recente libro,
Il mestiere di pensare, per descrivere la situazione della ricerca filosofica contemporanea ci sembra che lei utilizzi un lessico di matrice kuhniana. I contributi specialistici, per esempio, sono definiti
“intraparadigmatici” e poco più oltre lei scrive che «hanno senso e
importanza, se ce l’hanno, perché rafforzano o indeboliscono il paradigma», ricalcando piuttosto fedelmente la teoria della scienza di
Thomas Kuhn. Ora, come è noto il pensiero di Kuhn è stato sviluppato e ampliato dalla sociologia della scienza degli anni ‘70 e ‘80, ed
è tuttora alla base dei Science and Technology Studies (STS). In base
a ciò vorremmo porle due domande: innanzitutto chiederle fino a che
punto la teoria di Kuhn sia applicabile anche alla storia della filosofia (esistono rivoluzioni filosofiche analoghe alle rivoluzioni scienti-
12 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
fiche? Si può parlare di “incommensurabilità” tra epoche, tradizioni
o stili filosofici differenti? Per esempio le differenze tra analitici e
continentali possono essere descritte in termini di incommensurabilità?). In secondo luogo, se una metodologia di indagine di tipo
sociologico, ispirata ai Science and Technology Studies, potrebbe, a
suo parere, essere applicata alla filosofia contemporanea e aiutarci a
scrivere una storia della filosofia che non sia soltanto “interna” (cioè
focalizzata sui soli contenuti intellettuali), ma che prenda in considerazione anche fattori “esterni”, come l’evoluzione dell’istituzione
universitaria.
Marconi: In quel testo ho usato l’espressione un po’ en passant; avrei
potuto dire, senza usare la parola ‘paradigma’, che molti contributi filosofici specialistici sono interni a una teoria o a una famiglia di teorie
di cui condividono alcune assunzioni di base; se non si conoscono o
non si condividono quelle assunzioni, i contributi risultano poco comprensibili e di scarso interesse. Detto questo, mi pare che sia lecito -e
ormai abbastanza frequente- usare la nozione di paradigma anche in
filosofia. Come è noto, si tratta di una nozione fin dall’inizio un po’
vaga. In filosofia viene usata (mi pare) per intendere un insieme di
tesi condivise che caratterizza un periodo della storia della filosofia,
una scuola, un gruppo di filosofi, e che per un certo periodo orienta
molte ricerche.
Se ci sono state rivoluzioni scientifiche, allora, più o meno nello
stesso senso, ci sono state anche rivoluzioni filosofiche: ad esempio
il cartesianismo o l’idealismo post-kantiano. E le rivoluzioni si portano sempre dietro una certa dose di incommensurabilità: come diceva
Richard Rorty, vengono introdotti nuovi “vocabolari”, che non hanno
nomi per ciò di cui parlavano i filosofi di prima. Non so se questo
valga, in particolare, per la relazione tra filosofia analitica e filosofia
continentale. Né l’una né l’altra sono, plausibilmente, un paradigma:
tra le varie filosofie etichettate come continentali (l’ermeneutica, la
fenomenologia, la teoria critica...) c’è al massimo un po’ di aria di
famiglia, e la filosofia analitica condivide -peraltro sempre meno- una
cultura di sfondo, ma ospita le teorie più diverse e incompatibili tra
di loro (“se vuoi essere un -ista, puoi essere un -ista analitico”, M.
Beaney 2013).
Franco Sarcinelli - In dialogo con Diego Marconi 13
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda credo di sì, penso ci sia spazio per una sociologia delle istituzioni della filosofia. A
Torino, ad esempio, c’è chi sta facendo una ricerca sistematica sulle
tesi di dottorato in USA nella seconda metà del Novecento per vedere
(tra l’altro) se il presunto primato della filosofia analitica trova riscontro nella distribuzione tematica delle tesi.
InCircolo: L’imperativo socratico “Conosci te stesso” è stato matrice di molti percorsi filosofici. Ma è traducibile in una domanda
plausibile e feconda sul terreno filosofico? Non è questo imperativo
che è “generalista” a ingenerare l’idea nel popolo, colto e non colto,
che la filosofia disponga della specifica e caratterizzante peculiarità
rispetto ad altre discipline di porre questioni cruciali e universalmente valide, capaci di coinvolgere l’umanità nel suo complesso?
Marconi: La filosofia ha sempre posto, e continua a porre, questioni
cruciali, “capaci di coinvolgere -almeno in linea di principio- l’umanità nel suo complesso”. In che cosa siamo diversi dagli altri animali?
La morte è un male? Esistono norme morali universali e qual è il fondamento della loro autorevolezza? Che cos’è la verità? Sono alcuni
esempi di domande filosofiche che sono tuttora poste con insistenza
e su cui riflettono migliaia di ricercatori. Ciò di cui si dubita, fin dai
tempi di Socrate, è la capacità della filosofia di fornire risposte convincenti a domande di questo genere. Il problema che io intendevo
sottolineare, però, è un altro. I filosofi di professione sanno che per
rispondere in modo soddisfacente a questo genere di domande bisogna prima rispondere a molte altre; e di queste altre domande, di
solito, non è immediatamente percepibile la pertinenza, l’interesse,
o addirittura il senso. E’ soprattutto per questo che la filosofia dei
filosofi di professione risulta arcana e irrilevante per i non specialisti.
Questo vale anche tra filosofi di diversa specializzazione: anch’io, se
leggo un articolo di filosofia morale, spesso faccio fatica a capire bene
di che cosa parla e perché ciò di cui parla è importante. E’ normale
che sia così, e avviene anche (anzi, di più) nelle scienze. Ma, nel caso
della filosofia, ci deve essere un momento in cui la ricerca specialistica viene ricondotta alle sue motivazioni di fondo; altrimenti diventa
una sorta di enigmistica. Intendiamoci, la dispersione specialistica in
questioni marginali o addirittura futili è un rischio anche nelle scienze
“dure”; ma nel caso della filosofia sembra radicalmente incompatibile
14 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
con la sua vocazione, che è di parlare a tutti di questioni che toccano tutti. Di qui l’importanza di quella che io chiamo “divulgazione”
filosofica, che è in realtà il ricupero del senso e dell’interesse delle
ricerche specialistiche per le domande che interessano (o dovrebbero
interessare) a tutti. Segnalo un esempio recente che mi pare molto ben
riuscito: il libro di Timothy Williamson Io ho ragione, tu hai torto,
che presenta attraverso un dialogo tra persone qualsiasi alcuni decenni di ricerche filosofiche su verità e relativismo.
InCircolo: Nel nostro gruppo c’è chi nel remoto 1959 è stato il traduttore in italiano di Methods of Logic di W. V. Quine, nel 1960 si è
laureato su questo autore all’Università degli Studi di Milano e, in
seguito, ha letto altri suoi testi, fino a Word and Object. Ci piacerebbe avere da Lei qualche indicazione circa gli sviluppi successivi del
pensiero di Quine e la sua influenza sul pensiero filosofico dei nostri
giorni negli USA e nel mondo.
Marconi: L’influenza di Quine è stata enorme: Quine è vissuto quasi
cento anni e ha sempre svolto un ruolo di primo piano nella comunità filosofica analitica. Negli ultimi decenni del XX secolo è stato
influente, in parte, per via di un fraintendimento: ancor oggi si dice
che se la filosofia ha assunto un orientamento naturalistico così accentuato lo si deve alla critica di Quine alla distinzione analitico/sintetico. Criticando questa distinzione, Quine metteva in discussione
la distinzione tra scienza e filosofia. Fino a (circa) il 1960, se c’era
una tesi largamente condivisa tra i filosofi analitici (che peraltro non
si chiamavano ancora così) era quella della distinzione radicale tra
scienza e filosofia. Lo pensavano i wittgensteiniani, i filosofi del linguaggio ordinario e gli stessi neopositivisti. La posizione di Quine,
contestando la distinzione, sembrava aprire le porte ad una filosofia
che si identifica con la scienza. In realtà, se si mette in discussione
quella distinzione il confine tra filosofia e scienza certamente si attenua: non c’è più un dominio della filosofia (quello delle verità analitiche) e un dominio della scienza (quello delle verità sintetiche), l’uno
nettamente delimitato rispetto all’altro. Ma non ne segue affatto che
filosofia e scienza siano la stessa cosa, né che la filosofia debba diventare scienza. Se anche ci sono persone di cui è difficile dire se sono
calve o non calve, questo non vuol dire che non ci siano persone che
sono chiaramente calve e altre che sono chiaramente non calve. La
Franco Sarcinelli - In dialogo con Diego Marconi 15
negazione della distinzione analitico/sintetico non comporta affatto
l’identificazione di scienza e filosofia (né la riduzione della filosofia a
scienza). E’ invece vero che Quine ha influito nella direzione del naturalismo con la sua proposta di naturalizzazione della epistemologia
(alla fine degli anni ’60, nell’articolo “Epistemology Naturalized”).
Qui egli sosteneva che la teoria della conoscenza doveva diventare
una descrizione scientifica del modo in cui la conoscenza si forma: di
come, a partire da quelle che chiamava le “irritazioni superficiali” dei
nostri organi di senso, si formano le nostre credenze sul mondo. Un
discorso genetico, di scienza naturale, doveva sostituirsi a un discorso
fondativo e normativo. L’epistemologia tradizionale è una disciplina normativa, che dice a quali condizioni qualcosa deve o non deve
essere considerato come conoscenza. Quine dice invece: proviamo
a vedere come si formano quelle che normalmente consideriamo conoscenze. La proposta ha incontrato molte critiche, perché sembra a
molti che la dimensione normativa dell’epistemologia sia ineliminabile; tuttavia, essa ha spostato il focus dell’attenzione su certi ambiti
di indagine e certi tipi di problemi, per esempio in discipline filosofiche come la filosofia della mente e la filosofia del linguaggio. Non ci
sarebbe l’attenzione che oggi si ha per le neuroscienze se non ci fosse
stata l’operazione di naturalizzazione dell’epistemologia proposta da
Quine.
Quindi, il percorso è un po’ intricato e tutt’altro che lineare, ma
non c’è dubbio che la sua influenza nella direzione del naturalismo ci
sia stata. Una cosa che di solito non si dice ma che per me è altrettanto importante, per quanto riguarda l’influenza di Quine, riguarda la
riabilitazione della metafisica. Di solito essa viene ricondotta a David
Lewis e Saul Kripke; ma si dimentica che già negli anni ’50, in articoli come “On What There Is”, Quine svolgeva temi che oggi si
direbbero di metafisica analitica. Ci era arrivato attraverso una critica
serrata del suo maestro Carnap, in particolare attraverso l’abolizione
della distinzione tra questioni interne e questioni esterne, che era il
modo in cui alla fine degli anni ’30 Carnap aveva ripresentato la posizione antimetafisica del Circolo di Vienna. Carnap aveva detto che
una questione sensata, una domanda che può avere una risposta, deve
essere posta in un qualche framework linguistico. Prendiamo la questione se esistono i numeri. Se pongo questa domanda all’interno del
contesto dell’aritmetica allora la risposta è chiara: certo che ci sono
numeri; per esempio, si dimostra nell’aritmetica che 7 è un numero.
16 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Se invece pongo la domanda senza specificare nessun contesto linguistico allora la domanda è priva di senso, perché non sono in grado
di dire attraverso quali procedimenti potrei stabilire se la risposta è
sì oppure no. Attraverso la critica della distinzione analitico/sintetico, e cioè della distinzione tra enunciati veri in virtù delle proprietà
semantiche del linguaggio ed enunciati veri in virtù dell’esperienza,
Quine aveva criticato la distinzione tra questioni interne e questioni
esterne, e quindi aveva indebolito in maniera decisiva la critica della
metafisica, almeno nell’ultima e più aggiornata versione che era stata
proposta dagli empiristi. Diventava del tutto legittimo domandarsi se
esistono i numeri, se esiste Babbo Natale o se esistono enti contraddittori (anche se erano domande alle quali Quine non era particolarmente interessato). Si dice spesso che, lungi dall’aver riabilitato la
metafisica, Quine ne era stato un critico durissimo; lo si dice avendo
in mente la sua critica della metafisica della modalità (dell’apparato
dei mondi possibili, con gli individui possibili, le proprietà essenziali
ecc.). Questa critica però non riguardava la metafisica in quanto tale
bensì, appunto, la metafisica modale, a cui i nuovi metafisici come
Lewis e Kripke erano soprattutto interessati. Su questo c’era effettivamente una contrapposizione. Tuttavia, la riabilitazione della metafisica in quanto tale era una conseguenza importante, e pienamente
consapevole, delle posizioni di Quine.
InCircolo: Sul problema della argomentazione ha spazio l’opinione, per lo meno discutibile, che essa sia appannaggio peculiare solo
degli analitici come se le altre scuole filosofiche non esibissero adeguate attitudini argomentative. Inoltre, anche sulla sua concezione
del rapporto fra storia della filosofia e filosofia teoretica ci sarebbe
da avanzare qualche riserva. Infatti, si potrebbe pensare che il modo
più equilibrato di impostare il suddetto rapporto sia quello che lei
attribuisce ai cosiddetti tradizionalisti (né analitici né continentali,
dunque): costruire pazientemente il proprio personale punto di vista teorico attraverso un dialogo pacato e sereno con i pensatori del
passato. Invece lei - pur ammettendo che mettersi a teorizzare da
soli comporta il rischio di scoprire l’acqua calda e che gli analitici
fino a non molti anni fa, per sua stessa ammissione, erano in generale piuttosto ignoranti in materia di storia della filosofia - non
è comunque d’accordo con questa impostazione, e nell’insieme non
tratta i tradizionalisti molto meglio dei continentali. La etichetta di
Franco Sarcinelli - In dialogo con Diego Marconi 17
filosofo “tradizionalista” potrebbe essere assunta nel senso di “conservatore” volto al passato, ma il tradizionalismo può essere inteso
come percezione e senso della continuità della ricerca filosofica, per
cui ne viene che essa è sempre situata in un determinato contesto e
si avvale di una precomprensione del problema che affronta in base
alla eredità della tradizione. Ora, rispetto alla identificazione di tradizionalista in quanto conservatore, impostazione che sembra essere
prevalente in Il mestiere di pensare, viene invece da pensare la storicità come distinta dallo storicismo. L’impressione è che in tutta la
prospettiva della filosofia analitica ci sia questa dicotomia netta: o
una concezione storicistica del filosofare o una concezione che non
fa posto alla storicità di cui non si elabora una nozione. Sembra che
se si introduce una qualche storicità, già per questo si è considerati
storicisti. Può darsi che i non analitici non siano riusciti ad elaborare questa differenza tra una sana comprensione di quello che è la
storicità del sapere filosofico e lo storicismo inteso come risoluzione,
assorbimento totale della problematica filosofica nella storia, cosa
assai discutibile, e ci sarebbe quindi da chiedere: “Si può configurare
una storicità che si renda conto del fatto che il ricercatore è in qualche
modo calato in un contesto storico senza finire in uno storicismo in
senso deteriore?”
Marconi: Sul primo punto -solo gli analitici argomentano- faccio
solo una osservazione: non credo che, a parte qualche eccezione, i filosofi continentali teorizzino che le argomentazioni non hanno nessun
ruolo in filosofia o perseguano l’obiettivo perverso di produrre cattive
argomentazioni. Si può forse dire che la nozione di argomentazione non è centrale nella loro visione della filosofia, ma niente di più.
Tuttavia, il fatto che i filosofi continentali appartengano ad una comunità in cui non è istituzionalizzata la critica li rende meno preoccupati
della bontà di una argomentazione. Noi filosofi non continentali apparteniamo ad una comunità usa a sottoporre a controllo critico ogni
riga di quanto scriviamo: se c’è un passaggio che non funziona quel
determinato articolo non viene pubblicato. I filosofi continentali, in
generale, sono meno preoccupati dei dettagli argomentativi. Questo
lo so per esperienza: da giovane sono stato un filosofo continentale,
mi sono laureato con Luigi Pareyson, ho scritto su Wittgenstein; scrivevo articoli che portavo alla rivista “Filosofia” di Augusto Guzzo e
questi articoli venivano pubblicati ‘pari pari’, così come erano stati
18 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
scritti. Questa pratica, quali che ne siano i meriti, non presuppone che
la qualità argomentativa sia un parametro importante per valutare un
articolo di filosofia (oppure i miei articoli erano, da questo punto di
vista, perfetti; ma ne dubito).
Sul secondo punto: “Dialogare con i filosofi del passato per costruire un proprio punto di vista”. Anzitutto, interessa costruire un
proprio punto di vista, è un obiettivo del filosofo? A me interessa
piuttosto capire quali sono le soluzioni migliori di certi problemi, o
chiarire l’uso ottimale di certi concetti in certi contesti teorici; poi
uno può giungere a qualcosa che può essere chiamato il suo punto di vista -la “sua” filosofia- ma è un risultato, non un obiettivo: si
cerca di capire come stanno le cose, non si lavora per costruire la
propria filosofia. Un’altra osservazione: i filosofi del passato dialogavano con i filosofi del passato? Alcuni sì; per esempio la cultura
filosofica ottocentesca era piena di storia della filosofia. Poi ci sono
stati filosofi che dialogavano solo con certi filosofi del passato: per
esempio Spinoza avrà anche studiato tanta cultura giudaica, ma il suo
interlocutore era Cartesio. Aristotele viene sempre citato per aver fatto quella ministoria della filosofia nel libro alfa della Metafisica, ma il
suo interlocutore era Platone; e non gli interessava Platone in quanto
filosofo del passato, ma perché aveva posizioni su cui Aristotele non
era d’accordo con lui; ed era interessato a risolvere certi problemi
che condivideva con Platone, ad esempio su come dovessero essere concepiti gli universali e il rapporto tra gli universali e le cose.
Altri invece non dialogavano affatto con i filosofi del passato; che
è altra cosa dall’usare un vocabolario che è il vocabolario ereditato da qualcun altro. Si veda Wittgenstein, che nel Tractatus sostiene
che non gli interessa se altri abbiano pensato i suoi pensieri prima
di lui; di fatto usa il vocabolario di Frege e di Russell (e in qualche
caso di Schopenhauer e dei kantiani), ma una cosa è far questo, una
cosa diversa è discutere con i filosofi del passato, e una cosa ancora
diversa è sostenere che la filosofia consiste nel discutere con i filosofi
del passato. Questo è un atteggiamento piuttosto recente, comparso
nella stagione post-hegeliana della filosofia: solo una stagione della
storia della filosofia, durata, secondo me, non molto più di un secolo.
Sottolineo che io sono stato sempre un difensore della utilità della
conoscenza della storia della filosofia (potrei definirmi uno “storicista
moderato”): penso che quando ci si occupa di un problema filosofico
è utile trarre suggerimenti dalla filosofia precedente, perché spesso
Franco Sarcinelli - In dialogo con Diego Marconi 19
ha visto cose che il dibattito contemporaneo non ha visto o ha visto
in modo diverso. Mi sembra difficile sostenere (in alternativa) la posizione “darwiniana” per cui le idee e teorie che sono in campo nel
momento attuale sono tutto ciò che valeva la pena fosse conservato
del passato. D’altra parte è anche vero quel che dice un mio amico,
filosofo insigne: può anche esserci una tesi di Avicenna che, lavorandoci per tre mesi, si riesce a rendere pertinente alla discussione
contemporanea; ma il tempo richiesto è eccessivo rispetto al tempo
complessivo che si ha a disposizione. Certamente c’è un vocabolario
che i filosofi ereditano dal passato con la problematica ad esso connessa. Lo stesso è vero nel caso della scienza. Ma nessuno chiede agli
scienziati consapevolezza storica; viene chiesto loro di usare i termini
in modo competente, conformemente all’assetto attuale della loro disciplina. Perché ai filosofi è richiesto un rapporto diverso con i loro
vocabolari, con i concetti e problemi che hanno ereditato? Una risposta è quella di Bernard Williams: secondo lui, mentre la scienza è in
grado di scrivere una storia in cui si dà ragione della scienza attuale,
della scienza passata e della transizione dalla passata alla attuale in un
modo che sarebbe convincente anche per un partigiano della scienza
passata (quella di Williams è quindi un’immagine non kuhniana della
storia della scienza), in filosofia non è così perché qui, a differenza
che nella scienza, i quadri argomentativi sono parte integrante della
nuova concezione. Williams fa il caso della filosofia politica (che è
quella che gli interessa di più): gli argomenti che accreditano la teoria politica liberale sono parte integrante della teoria stessa, e non
sarebbero accettabili per un sostenitore dell’ancien régime. In altre
parole, non è possibile presentare la transizione dal vecchio al nuovo
come universalmente razionale, nel senso di essere mediata da una
argomentazione che sarebbe accettabile anche da un sostenitore del
vecchio regime. Ovvero, mentre la storia della scienza può essere presentata come storia di scoperte, questo non vale per la filosofia. Quel
che è curioso è che il modo in cui Williams presenta la storia della
filosofia è esattamente il modo in cui Kuhn presenta la storia della
scienza; quindi questa contrapposizione su come vanno le cose in filosofia e come vanno invece nella scienza è controversa, perché c’è
chi dice che le cose nella scienza vanno esattamente come in filosofia.
Comunque ritorno alla domanda: perché al filosofo e alla filosofia si
chiede di avere con il suo passato un rapporto speciale che invece non
si chiede agli scienziati? Perché gli scienziati possono non sapere chi
20 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
è stato Mendel mentre un filosofo analitico non può non sapere chi
sono stati Russell e Frege?
InCircolo: Lei pensa che anche per uno scienziato – ad esempio un
chimico o un biologo - un sapere storico potrebbe essere proficuo a
proposito di determinati problemi del giorno d’oggi?
Marconi: Però il lavoro richiesto sarebbe molto. L’anno scorso sono
andato a un convegno in cui si parlava di origini dell’analisi. Si parlava di Cartesio, di Newton, di Leibniz, ma io, pur avendo dato un
esame di analisi all’università, non capivo neanche di cosa parlavano:
non riconoscevo in quel che dicevano gli elementi dell’analisi che
avevo studiato. Ci vuole molto lavoro per riuscire a vedere nei padri
del calcolo la teorizzazione moderna dell’analisi. Sono d’accordo che
possa essere interessantissimo e forse anche illuminante per la ricerca
attuale, ma se uno si occupa di analisi e studia, mettiamo, le varietà
proiettive, ha tempo di fare anche questo lavoro? Qualche volta anche
in filosofia si ha l’impressione che la conoscenza del passato potrebbe accelerare la ricerca attuale e che certe interminabili discussioni
su microproblemi filosofici potrebbero essere risolte o spazzate via
da una certa consapevolezza storica. Tra l’altro la filosofia analitica,
oltre ad avere scarso interesse per la storia altrui ne ha poco anche
per la propria, e quindi la dimentica continuamente. La concezione
ontosemantica del Tractatus di Wittgenstein è stata reinventata due
o tre volte. Peraltro, qui si tratta di un passato recente, cioè di una
tradizione direttamente pertinente sul piano teorico alle cose di cui
ci occupiamo; non stiamo parlando di Parmenide, di Platone e nemmeno di Kant. Mentre nella filosofia di orientamento tradizionalista
quando si parla di rapporto con il passato di solito non si parla della
tradizione prossima, si parla della intera tradizione della storia della
filosofia. Rispetto a ciò mi domando: ma davvero per occuparmi della
semantica oggi devo studiare il Cratilo di Platone? Studiandolo, non
ho avuto l’impressione che mi potesse servire più che tanto. C’è qualcosa in ciò che dice Socrate che potrebbe riabilitare il fonoiconismo?
So benissimo che esiste il fonoiconismo, ed è una teoria sbagliata:
non è vero che il linguaggio è fondamentalmente onomatopeico.
Franco Sarcinelli - In dialogo con Diego Marconi 21
InCircolo: C’è una responsabilità del filosofo nel mestiere del pensare? Ci sono delle domande che hanno una coloritura filosofica che
provengono da un contesto più ampio, diciamo sociale, popolare. Un
filosofo deve lavorare esclusivamente per sé, o ha il compito di rispondere a determinate domande che la società tende a proporgli o
che, comunque egli suppone possano da essa essergli poste?
Marconi: Un professore appartiene ad una comunità, che ha le sue
regole e le sue richieste, da cui non può prescindere in nome di una
certa immagine di quello che la filosofia dovrebbe fare per la società.
Se uno è un industriale dell’automobile, può avere anche delle idee
su come sarebbe bello costruire automobili di un certo tipo, ma il suo
primo interlocutore è il mercato dell’automobile. Quello che corrisponde al mercato nel nostro caso non è la società, ma è la comunità
ristretta dei professionisti della filosofia, che è ciò che corrisponde
all’interesse dell’industriale dell’auto, che non è un benefattore ma
deve fare profitti, quindi vendere le sue automobili. Da un lato, quindi, c’è non la società nel suo insieme ma la comunità a cui apparteniamo. Dall’altro lato c’è non ciò che la società richiede, ma ciò che secondo il filosofo dovrebbe richiedere. Il filosofo può anche trascurare
ciò che la società gli chiede di fatto, quello che non può trascurare è
ciò che la società dovrebbe chiedergli, cioè quelle che dovrebbero
essere secondo lui le domande che la società rivolge alla filosofia:
deve cioè fare i conti con la sua concezione del ruolo sociale della
filosofia. Una cosa che io ho cercato di sottolineare (nella parte finale
del primo capitolo del mio libro) è che oggi si è creata una discrasia
tra queste due cose: le richieste della comunità scientifica e quelle che
noi stessi riteniamo dovrebbero essere le domande sociali della filosofia sono fortemente divaricate. Per far parte della comunità dobbiamo
fare certe cose, mentre per rispondere a quello che noi pensiamo che
la società dovrebbe volere da noi (indipendentemente da quello che
di fatto vuole da noi) dobbiamo farne altre. Quello che la società di
fatto vuole da noi è che svolgiamo la funzione di un settore del dipartimento dei beni culturali: come c’è gente che si occupa della conservazione dei quadri di Caravaggio, o di far sì che le opere di Verdi
continuino a essere rappresentate, così noi dovremmo garantire che
si continui a parlare di Platone, di Cartesio e di Kant; che sia conservata la memoria di questo patrimonio, che viene considerato un bene
culturale. Quello che noi pensiamo, invece, che la società dovrebbe
22 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
chiederci è, per esempio, che forniamo elementi di chiarezza al dibattito pubblico, cioè che siamo in qualche modo antagonistici rispetto
alle confusioni concettuali in cui continuamente si avvita il dibattito
pubblico. La società dovrebbe chiederci di chiarire i contenuti della
ricerca scientifica, di mediare il lavoro degli scienziati, cosa che gli
scienziati hanno dimostrato di non essere interessati a fare e/o di non
saper fare (sono pochi gli scienziati come Carlo Rovelli che hanno
grandi doti di mediazione comunicativa). Ci sono nel mondo filosofi
che fanno questo genere di cose: che lavorano come consulenti dei
governi sui regolamenti, sugli artefatti cognitivi, sul ruolo della tecnologia nei processi educativi, sui processi di produzione delle scelte
intelligenti degli utenti dei servizi pubblici o dei consumatori, ecc.
Tutta questa gamma di attività che rispondono a domande sociali potenziali sono, secondo me, antagonistiche con i compiti professionali
che vengono assegnati al filosofo dalla sua comunità di appartenenza,
la quale non solo ci chiede di essere degli specialisti e di lavorare alla
frontiera della ricerca nel campo della specializzazione di ciascuno,
ma tende a penalizzare chi si occupa di rispondere a domande sociali.
C’è quindi antagonismo tra ciò che la filosofia potrebbe fare per la
società e ciò che la comunità di appartenenza chiede al filosofo.
InCircolo: La filosofia non può coincidere con il mestiere accademico: per esempio, alla Statale di Milano ogni anno a Filosofia si
iscrivono 500 matricole e ne escono più o meno altrettanti, e uno dei
problemi più pressanti a cui i filosofi professionali devono rispondere
è la missione che la didattica della filosofia ha. Il problema di oggi è
cosa vuol dire e come si insegna la filosofia in relazione a quali nicchie del mondo del lavoro ha disponibile per chi è iscritto a questa
facoltà e per chi sta valutando l’opzione di iscriversi a essa.
Marconi: Il nostro difetto di comunicazione dipende dal fatto che si
è creata una situazione alla quale abbiamo dato una risposta sbagliata
(anch’io ho contribuito a questa risposta sbagliata). Noi abbiamo pensato che la possibilità occupazionale dei filosofi fosse una questione
di contenuti didattici e quindi abbiamo creato corsi come Scienze della comunicazione, cercando di ibridare la filosofia con qualcosa che
“vende”, che promuove canali occupazionali. Ma l’occupabilità dei
filosofi dipende soprattutto dalla nostra capacità di convincere i datori
di lavoro che i filosofi sono il miglior personale manageriale disponi-
Franco Sarcinelli - In dialogo con Diego Marconi 23
bile in questo momento in Italia; e lo sono non in quanto hanno una
formazione funzionale alle aziende perché hanno studiato un po’ di
economia o di psicologia, ma proprio in quanto hanno studiato filosofia. Questa è la nostra esperienza: la filosofia, ben studiata, risulta
essere una grande formazione polivalente. Noi abbiamo due compiti:
da un lato insegnare la filosofia bene, dall’altro convincere i datori di
lavoro che i filosofi vanno bene così.
L’essenziale è che gli studenti vengano abituati a pensare, a prospettare alternative, ad argomentare per le varie scelte possibili. Per
anni, invece, abbiamo fatto l’esatto opposto: abbiamo cercato di mescolare la filosofia con dei contenuti spendibili, e la nostra istituzione
di appartenenza - l’Università- ci ha chiesto di fare così: di metterci
dentro un po’ di economia, un po’ di informatica, qualcosa di immediatamente commercializzabile. Studiare filosofia ed economia, o
filosofia e psicologia, è molto interessante e sensato da un punto di
vista scientifico, ma non si deve pensare che sia questo a rendere un
laureato in filosofia più “occupabile”. Un laureato in Psicologia di
Padova o un laureato in Economia alla Bocconi sarà sempre preferito a un filosofo, se il parametro sono le conoscenze economiche o
psicologiche. I pregi caratteristici dei laureati in Filosofia sono invece l’apertura mentale, la ricchezza culturale, le capacità di analisi
e di argomentazione applicabili a qualsiasi contenuto, e soprattutto
la capacità di pensare alternative possibili - l’immaginazione, in una
parola. È su questo che bisognerebbe puntare nella formazione dei
giovani filosofi.
La questione filosofica
Visioni Balcaniche
Problemi di messa a fuoco dell’idea d’Europa
Matteo Canevari
Contemporary philosophy is attempting to devise a clear idea of
Europe, which is one of his most important aim today. The article
pose a question about that: “what does it means to have a concept
for Europe?” A common way to answer is to say that philosophers
should rediscover the fundamental values and principles on which
the European conscience is based. On the contrary, following Michel
Foucault’s thought, the article affirm that we need also to analyze
the practices of speech through which Europe created his borders,
in present times and in the past. The problem of the geographical
localization of the Balkan region is a perfect case study on this. The
Yugoslavian’s war in the Nineteens, the first “post bipolar world”
conflict, is only the last example of the different interests involved
in defining territorial borders of such a strategical region. In the
same way, European identity is based on the management of his internal and external borders in a new, democratic way, keeping distance to other global powers such as USA or Russia. According to
Etienne Balibar’s opinion, the writing propose the idea of Europe
as “Vanishing Mediator”, considering the practice of translation the
deep European essence.
28 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Per un’idea d’Europa
Alcuni anni fa Jocelyn Benoist affermava, in un suo libro dedicato
alla natura dei concetti, che non abbiamo un concetto di “Africa” e
aggiungeva che
il fatto che non siamo (ancora, direbbe l’ottimista) capaci di pensare
l’Africa, per delle ragioni che dipendono da noi – il che non vuol dire
che siano senza effetto sulla storia di quella realtà, e neppure che non ne
siano parte, in un senso molto essenziale – non significa, tuttavia, che
essa non sia pensabile “in sé”, che essa non sia, oggi stesso, pensata da
altri, o che, in ogni caso, non possa esserlo un giorno. In altre parole, la
supposta inesistenza di un concetto di Africa non ha nulla di essenziale.
E’ un fatto storico, non una verità a priori.1
Benoist in questo modo segnalava una difficoltà di concettualizzazione che il nostro intelletto incontra di fronte all’oggetto “Africa”,
che non dipende in prima istanza dalla realtà dell’oggetto ma invece
dal momento storico dello sviluppo del nostro pensiero o da un limite
intrinseco, seppur non invalicabile, della nostra capacità di pensare.
Non vi è alcun oggetto “troppo esotico” per il pensiero e se di un
oggetto non abbiamo ancora un concetto, ciò manifesta l’urgenza per
la filosofia del confronto con una realtà che dà da pensare2. L’idea
dell’esotismo va anzi decisamente rifiutata, secondo Benoist, poiché
«in questo tema dell’esotico di certi oggetti del pensiero […] vi è
qualcosa di profondamente sospetto».
L’assenza di un concetto, dunque, non decreta di principio lo statuto di inesistenza del concetto stesso, né tanto meno della realtà empirica che il concetto vorrebbe esprimere, che continua a sussistere
di per sé. Ma prospetta un rischio, ovvero che la realtà impensata
scivoli nell’inesistenza ovvero nell’indeterminato del pensiero, dove
qualunque immagine si può affacciare. In verità, ciò che si mostra
nell’assenza del concetto è solo il fatto che non abbiamo saputo o
voluto pensare tale realtà, che dunque non è irreale ma è invece un
Jocelyn Benoist: Concepts. Introduction à l’analyse, Paris: Èdition du Cerf,
2010, tr. it. di Matteo Canevari con supervisione di Fabio Merlini, Concetti e frontiere. La mappa del nostro mondo, Torino: Rosenberg & Sellier, 2011, 12.
2
Ivi, 13.
1
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 29
impensato, e, per lo stesso motivo, un taciuto, qualcosa di passato
sotto silenzio3.
Nel caso specifico dell’Africa, la mancanza di un concetto per essa segnala senza dubbio una difficoltà del pensiero davanti al compito
di definire contorni e confini di una realtà geografica ben concreta e
complessa, che non è mai riducibile solo a un territorio su una mappa.
Attorno alla questione dei confini si giocano molte dispute di discorso, che mostrano in controluce le posizioni di potere che le sostengono, a partire dalla domanda chiave su chi è legittimato a tracciare
i confini per arrivare a quella non meno complessa sui principi che
li determinano. I confini definiscono sempre un dominio, strategico,
politico e discorsivo, e mai solo un territorio. La geografia non appartiene in prima istanza solo alle scienze naturali.
Una difficoltà analoga a quella sollevata da Benoist riguardo
all’Africa è oggi quella relativa all’Europa. Ma se, seguendo il suggerimento di Benoist, riteniamo che tale difficoltà non abbia la forza destinale dell’irrimediabile, intraprendere la ricerca di un’idea d’Europa
si presenta allora come un compito attuale per il pensiero. Tuttavia la
difficoltà segnalata da Benoist rivela anche un problema epistemologico relativo a cosa si intende per “avere un concetto” di una realtà
territoriale, politica, storica e sociale come l’Europa.
Una risposta ricorrente a questa domanda afferma che è necessario riconoscere e riattualizzare i principi spirituali e valoriali che ne
definirebbero l’identità. L’impegno è più facile da pronunciare che da
realizzare perché rischia di lasciare dietro di sé molti presupposti impensati, a partire dalla nozione di identità, che invece meriterebbero
di essere problematizzati. Afferma Tzvetan Todorov in una conferenza del 2014 che
elle suscite aussi une objection plus fondamentale, concernant toute tentative de définir l’identité en termes substantiels. Quand nous essayons
de préciser ses traits constitutifs, nous découvrons que la tâche est plus
difficile qu’on ne pouvait l’imaginer. La raison de la difficulté est double, et un peu paradoxale : on pourrait dire que les caractéristiques sur
lesquelles nous nous accordons sont tantôt trop générales et tantôt trop
particulières. Trop générales dans la mesure où elles ont une vocation
universelle, et non spécifiquement européenne. [...] Mais trop particu3
Ibidem.
30 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
lières d’autre part, ne serait-ce que parce que la culture d’une population
est intimement liée à sa langue – laquelle, comme on le sait, contribue à
constituer une vision du monde spécifique. La mémoire collective, propre à chaque population, joue le même rôle […] On pourrait dire qu’en
Europe, chaque doctrine a suscité aussi son contraire, car l’une des caractéristiques de la tradition européenne est précisément l’exercice de la
pensée critique: toutes les valeurs peuvent y être soumises à l’examen.4
Quand’anche tale compito dovesse essere portato a termine una
volta per tutte, in modo univocamente convincente (cosa di per sé poco probabile) e senza oscurità di sorta, ciò non esaurirebbe comunque
la realtà storico-geografica dell’Europa, che non si configura come
una sostanza dotata di un’essenza immutabile ma invece si presenta
come una realtà storica processuale, caratterizzata dalla variabilità e
dalla trasformazione delle sue modalità di costituzione. Per quanto sia
rassicurante pensare che l’Europa sia l’espressione di una coscienza
immobile e compiuta, o anche dialettica e in via di compimento, la
realtà è che essa è molteplice e incerta nella sua forma come nel suo
sviluppo. Dunque, se in un possibile concetto di Europa sono compresi i suoi principi ispiratori (magari considerati nella loro genesi storica più che nella loro astrattezza ideale), perché non c’è realtà sociale
che non ne abbia, fanno parte della sua idea anche la consapevolezza
critica delle pratiche di discorso che pretendono di definirne l’identità
e le strategie di gestione che ne tracciano la forma, determinandone
l’estensione dei confini.
Ha ragione Zygmunt Bauman a scrivere che «l’Europa non è
qualcosa che si scopre, bensì una missione, qualcosa da fare, creare,
costruire»5. Ma in questa autopoiesi della realtà europea hanno tanto
dimora la coscienza dei suoi valori eterni quanto la consapevolezza
delle sue pratiche transeunti, che al pari e più del suo orizzonte assiologico, sono terreno di scontro, di confronto e di ridefinizione senza
soluzione.
4
Tzvetan Todorov: “À la recherche de l’Europe. Huitième débat du cycle de conférences sur l’identité européenne”, Études européennes. La revue permanente des
professionnels de l’Europe, 13 febbraio 2014, 5. http://www.etudes-europeennes.eu/
images/stories/Variations_europennes/Speech_Todorov_fr.pdf.
5
Zigmunt Bauman: Europe. An Unfinished Adventure, Cambridge-Malden,
Mass.: Polity Press, 2004, tr. it. di Marco Cupellaro, L’Europa è un’avventura,
Roma-Bari: Laterza, 2006, 4.
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 31
Intermezzo foucaultiano
L’intervista che Michel Foucault rilascia alla rivista Hérodote nel
1976 sul valore scientifico della geografia ha una grande importanza
per l’evoluzione del pensiero del filosofo e per il rapporto tra filosofia
e geografia6. Com’è noto, Foucault ha riflettuto sul tema dell’Europa
in altri testi significativi (senza però tematizzare l’oggetto in quanto
tale) mentre in questa intervista non si occupa né della sua definizione, né della genesi del suo spazio. Tuttavia, rispetto ad altri scritti,
questo breve intervento risulta significativo per il nostro argomento
perché definisce alcuni parametri propri di una riflessione storico-geografica che pretenda di avere un valore filosofico capace di elevarla
al di sopra della semplice descrizione, individuando in questo compito alcuni nuclei problematici da portare a coscienza.
Per tale motivo, questo testo minore può suggerire alcuni principi metodologici utili per una rilettura della nozione di Europa.
L’intervistatore mette in luce per primo che il sapere geografico è
implicato con ideologie e strategie dello spazio sottese alle sue pratiche descrittive che, dunque, nascondono «des points d’affrontement,
des tensions, des lignes de force», che sono ben presenti nonostante
l’apparente «absence de polémique en géographie»7. Sulla stessa linea di discorso, egli propone in seguito un parallelo tra le problematiche poste dalla periodizzazione in storia, analizzate da Foucault, e
le questioni della «discontinuité à propos de l’espace et des échelles
spatiales»8, che, a suo avviso, meritano un’attenta riflessione metodologica. Emerge dalla riflessione che le estensioni geografiche e le
periodizzazioni storiche condividono un analogo rapporto con le domande relative all’origine e all’incidenza delle forze che segmentano
il continuum spaziale come anche quello temporale, che ne definiscono i punti notevoli, ne individuano le svolte e i livelli di osservazione
e ne indicano i confini e le appartenenze. Citando Foucault, l’intervistatore dice:
6
Cfr. Michel Foucault: “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, in
Daniel Defert e François Ewald, cur.: Dits et écrits – 1954-1988, II, Paris: Quarto
Gallimard, 2001, (28-40)
7
Ivi, 28, 29.
8
Ivi, 31.
32 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
chaque périodisation découpe dans l’histoire un certaine niveau d’événements et, inversement, chaque couche d’événement appelle sa proche
périodisation, puisque, selon le niveau qu’on choisit, on devra délimiter
des périodisations différentes, et que, selon la périodisation qu’on se
donne, on atteindra des niveaux différents . On accède ainsi à la méthodologie complexe de la discontinuité.9
E conclude con parole sue affermando che «on peut, et même il
faut, concevoir et construire une méthodologie de la discontinuité à
propos de l’espace et des échelles spatiales»10. Al pari della storia,
anche la geografia è percorsa da linee di individuazione differenti e
compresenti nella stessa distesa territoriale, che definiscono spazi, livelli, pieghe, strati analizzabili a partire dal presupposto teorico della
discontinuità eterogenea, che si contrappone tanto in storia quanto
in geografia all’idea della continuità omogenea. In altri termini, esistono tanti spazi in uno stesso territorio, come esistono tante storie
comprese in uno stesso arco temporale, che emergono o scompaiono
a seconda dei livelli di demarcazione che mettiamo in atto. L’esempio
dei molteplici piani di segmentazione che percorrono lo spazio europeo è fin troppo ovvio: l’area Schengen, la zona euro, l’UE, il Patto
Atlantico, i confini nazionali, etc. etc.; nessuno di questi coincide con
gli altri e la forma dell’Europa varia a seconda dei criteri che adottiamo, e con essa cambia il senso ad essa connesso.
Il territorio, in questo senso, equivale allora a ciò che l’estensione temporale rappresenta per la ricerca storica, e come tale è un
campo su cui agiscono forze diverse di dominio, dove si dispiegano
forme di potere e di controllo, che si esercitano attraverso il conflitto
di strategie di delimitazione concorrenti. Nel pensiero foucaultiano
troviamo molte metafore spaziali e geografiche, ed è il filosofo stesso
a sottolineare che esse non sono mai solo improntate alla geografia,
ma derivano da diversi campi del sapere, come è vero per molte altre nozioni di quella disciplina: domini pragmatici come la strategia
militare; la gestione amministrativa del territorio; il controllo della
popolazione da parte del potere sovrano, etc. etc. Ogni parola della
geografia rimanda a una forma discorsiva differente attraverso cui si
9
Foucault, “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, 31.
Ibidem.
10
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 33
dispiega qualche strategia di controllo. E’ lo stesso Foucault a farne
l’elenco quando afferma:
Eh bien, reprenons-les un peu, ces métaphores géographiques. Territoire
[…] c’est d’abord une notion juridico-politique : ce qui est controlé
par un certain type de pouvoir. Champ : notion économico-juridique.
Déplacement : se déplacent une armée, une troupe, une population.
Domaine : notion juridico-politique. Sol : notion fiscale, administrative,
militaire. Horizon : notion picturale, mais aussi stratégique.11
I grandi temi del Foucault della fine degli anni Settanta e dei primi
Ottanta sono già tutti presenti. L’idea della governamentalità è già
contenuta in nuce in queste brevi considerazioni. La domanda chiave
che guiderà la riflessione filosofica successiva su queste nozioni “più
che geografiche” è «à quoi la géographie précisément les a empruntée?»12. Foucault, a partire da questa svolta decisiva della riflessione, mette in luce le vere problematiche implicate nel discorso sullo
spazio. Innanzitutto privilegiare le metafore spaziali nella riflessione
mette al riparo dal rischio di cadere nello psicologismo dell’evoluzione della coscienza per interpretare i fatti storici e privilegia, di converso, lo sguardo sui processi che si dispiegano, cogliendo i punti
nei quali i discorsi (anche quelli territoriali) «se transforment dans, à
travers et à partir des rapports de pouvoir»13.
In secondo luogo, la descrizione spazializzante dei fatti di discorso apre la riflessione all’analisi degli effetti di potere che vi sono implicati, a partire dal «repérage des implantations, des délimitations,
des découpages d’objet, des mises en tableau, des organisations des
domaines»14, tutti processi a cui sottendono singolari strategie discorsive di controllo. Tra queste, ad esempio, l’uso delle carte e delle
mappe geografiche che risultano allora strumenti di sapere-potere che
attraversano il tempo con diversi scopi, fino ad arrivare, nel nostro
discorso, alle questioni attuali relative ai confini d’Europa15. Ad esse
si aggiungono il catalogo e l’inventario, comprese le diverse ed evo11
13
14
15
12
Ivi, 32.
Ivi, 33.
Foucault, “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, 33.
Ibidem.
Ivi, 37.
34 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
lute tecniche di controllo securitario e di identificazione della popolazione, che preparano l’equivalenza astratta tra frontiera e identità,
su cui si è costruita la politica della sovranità dall’epoca moderna in
poi16. Nella stessa direzione si sono evoluti alcuni tra gli apparati più
recenti messi a punto in Europa, come riporta Bauman, citando Jelle
van Buuren, quando scrive che «creata per garantire la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea, l’“area Schengen” è divenuta
un formidabile strumento per controllare e registrare i movimenti dei
suoi cittadini», dando sostanza all’identificazione dell’Europa con un
«continente fortezza»17.
Seguendo questo discorso, la definizione di un concetto d’Europa, dunque, non rimanda tanto a un’astratta aspirazione ideale, a un
principio spirituale da realizzare, ma si può concepire, al contrario, a
partire dalla riflessione critica sulle modalità e sugli attori attraverso i
quali si forma il discorso pubblico che definisce, individua, determina
i suoi spazi e che distribuisce soggetti, ruoli e posizioni in tali spazi ritagliati, istituendo dei domini di senso prima che di fatto, e favorendo
certe possibilità singolari di soggettivazione al posto di altre. Per dirla
con Foucault, la questione dell’Europa è comprensibile non a partire
dalle forme di coscienza che vi si esplicano, o dalle ideologie che vi
si esprimono, ma invece considerando
tactiques et stratégies qui se déploient à travers des implantations,
des distributions, des découpages, des contrôles de territoires, des organisations de domaines qui pourraient bien constituer une sorte de
géopolitique.18
Alain Brossat chiama questo approccio rinnovato alla questione
del concetto «dédisciplinarisation»19 della filosofia, e lo considera
parte di un ampio progetto di destituzione della filosofia universitaria e sapienziale portato avanti da Foucault a partire dalle sue prime
opere. Al di là delle intenzioni polemiche insite in questo approccio,
da ricondurre alla fase dello sviluppo della filosofia francese proprio
16
Ivi, 36, 37.
Bauman, L’Europa è un’avventura, 23.
18
Foucault, “Questions à Michel Foucault sur la géographie”, 39, 40.
19
Alain Brossat: “Quand Foucault dit « nous » ...”, Appareil [En ligne], 8, 2011, 2.
http://appareil.revues.org/1265.
17
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 35
di quegli anni, ciò che è interessante in questa sede è che, secondo
Brossat, esso si qualifica per il gesto di découpe che lo caratterizza in
quanto pensiero critico. Tale gesto non implica
le choix d’un objet qui suppose l’exclusion de tous les autres, mais ceuxci n’étant pas ignoré ou rejetés, mais au contraire identifié comme l’extérieur légitime du champ de recherche.20
Ovvero identifica un fuori del concetto sul quale la riflessione filosofica deve tornare continuamente a confrontarsi, in un’ineludibile
necessità di interlocuzione infinita.
Scrive ancora Brossat che «il faut nommer les espace découpés,
c’est-à-dire topographier l’objet de la recherche, en baliser le champ –
un travail de géomètre»21. Un’opera di ridefinizione, dunque, attende
il filosofo, a maggior ragione quando si occupa di uno spazio geografico che pretende di essere uno spazio politico e sociale, che dunque
non può essere compreso tutto all’interno del concetto, solo in quanto
sviluppo della coscienza e dei suoi principi. Tale sforzo di ridefinizione della verità del concetto comporta il lavoro di decodifica di quelle
forme di inquadramento, di découpe, che come faglie di frattura lo
percorrono, lo designano e lo disegnano.
E’ possibile sottoporre l’Europa a una simile opera di ridefinizione? Forse è anche necessario, a partire però da un approccio rinnovato
alla questione, ovvero dalla convinzione preliminare che ciò che la
distingue non è solo un sistema politico, un principio spirituale comune, un sistema di valori di riferimento, ma invece «des pratiques communes, des dispositifs, un champ d’expérience partagée»22 (e con essi
le forme di resistenza messe in atto nei secoli) che l’hanno costituita
storicamente e che, dunque, come tali possono essere riconosciuti,
riattivati, criticati e trasformati.
Seguendo ancora la linea di discorso di Brossat, possiamo affermare che la storia della formazione della cultura europea, e con essa
quella occidentale, è una vicenda fatta di scelte, di biforcazioni, di
pieghe e di svolte del corso storico che si sono manifestate nel campo
d’azione delle pratiche collettive. Per riprendere le espressioni usate
20
Ivi, 2.
Brossat,“Quand Foucault dit « nous » ...”, 2.
22
Ivi, 4-5.
21
36 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
da Martin Heidegger, citate da Zigmunt Bauman, il mondo umano
non è uno zuhanden ma al contrario esso è vorhanden, ovvero è mondo-come-cultura e dunque è consegnato nelle mani dell’uomo per la
sua forma e il suo destino23. Che la consapevolezza di tale caratteristica sia prerogativa della sola coscienza europea, inquieta e sempre pronta a cambiare se stessa e il proprio mondo con uno slancio
prometeico inesauribile, come sembra sostenere Bauman, è oggetto
di critica e motivo di dubbio in diversi autori24. E con essa anche la
pretesa dell’unicità dei principi spirituali che definirebbero l’essenza
del continente, come la propensione alla tolleranza, l’inclinazione alla democrazia, l’amore per la libertà, secondo una contrapposizione
noi/loro (Europa/resto del mondo) che, al di là delle buone intenzioni
di chi afferma questa singolarità, rischia di riproporre lo schema del
conflitto proprio dello scontro di civiltà.
Tra le voci critiche rispetto a questa impostazione del discorso
identitario, Amartya Sen sta da diversi anni portando avanti un progetto di riconsiderazione completa della storia globale delle idee, non
più euroecentrica ma invece attenta a quegli elementi di modernità
“alla occidentale” affacciatisi, in diverse epoche, in altri orizzonti culturali, non ultima l’India multiculturale e multiconfessionale dell’epoca Moghul, da cui lo stesso autore proviene25. In generale, secondo
Sen, insistere sull’eccezionalità del fattore europeo non facilità la reciproca accettazione e il dialogo con altri contesti culturali. Resta pur
vero, però, secondo le parole di Bauman, al netto delle polemiche di
impostazione del discorso, che l’Europa è
il prodotto di una scelta, di un progetto e di una gestione, e così facendo
ha rimodellato la totalità delle cose, compresa se stessa, come qualcosa
di non finito in linea di principio, oggetto di attento esame, di critica e
magari di intervento riparatore.26
Bauman, L’Europa è un’avventura, 10.
Ivi, 9.
25
Cfr. Amartya Sen: Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New YorkLondon: W.W. Norton & Company, 2006, tr. it. di Fabio Galimberti, Identità e violenza, Roma-Bari : Laterza, 2008, e Amartya Sen: The Argumentative Indian, UK:
Penguin Books, 2005, tr. it di. Gianni Rigamonti, L’altra India. La tradizione razionalista e scettica alle radici della cultura indiana, Milano: Mondadori, 2005.
26
Bauman, L’Europa è un’avventura, 9.
23
24
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 37
Secondo Bauman, essa si presenta come «un modo di vita allergico alle frontiere»27. Eppure, al pari di ogni altra realtà territoriale,
come tutti i fatti veri, L’Europa, a dispetto di tutto ciò che l’ha resa
ciò che è diventata, dev’essere una realtà e potrebbe (dovrebbe?) essere
localizzata, inventariata e registrata. In un’epoca di territorialità e sovranità territoriale, si presume che tutte le realtà siano definite a livello
spaziale e stabilite a livello territoriale, e l’Europa non fa eccezione.
Nemmeno il “tipo europeo” o gli “europei” stessi fanno eccezione.28
Dunque, nella ricerca di una specificità europea, si rivela una
tensione irrisolta tra una tendenza a eccedere il proprio limite e il
bisogno di definire i propri confini, che mostra che la questione delle
frontiere è un aspetto cruciale per la produzione delle forme di soggettivazione europee più ancora e prima della definizione dei principi
che le costituirebbero. In altri termini, le stesse coscienze europee
sono costituite da quelle pratiche di definizione che non discendono
da principi astratti, ma invece sono il prodotto di “decisioni” che disegnano lo spazio culturale europeo come un «champ de dispersion et
inclusion, plutôt que de réalisation de quelques valeurs cardinales»29.
Ha ragione Bauman a sostenere che l’Europa non è riducibile a un
mero fatto geografico, e che i tratti dell’europeo si trovano anche fuori dei suoi confini30. Ma al di là delle intenzioni del sociologo, a mio
avviso, ciò dimostra che la questione dei confini, la loro definizione
e la loro estensione, è un fatto geografico nella misura in cui è un
fatto geopolitico che implica pratiche di inclusione ed esclusione, di
integrazione e di segregazione su cui agiscono un dentro e un fuori
dell’Europa, delle spinte interne ben concrete e delle forze esterne
agenti a livello globale. È in questo incrocio e scontro di forze che
si costituiscono i soggetti singolari e collettivi che rappresentano la
coscienza dell’Europa.
Tali pratiche, riconoscibili nel passato, non sono relegate al tempo
storico, ma sono in atto nel tempo presente e continuamente. Quando
diciamo “noi” (europei, ad es.), presupponiamo in modo più o meno
Ibidem.
Ivi, 6.
29
Brossat, “Quand Foucault dit « nous » ...”, 5.
30
Bauman, L’Europa è un’avventura, 6, 7.
27
28
38 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
inconsapevole questo insieme di pratiche di segmentazione e le forze
che le determinano. Quest’azione merita di passare al piano cosciente
grazie allo sforzo di un pensiero critico capace di decentrarci da noi
stessi per poterci conoscere in quanto “noi altri”. Lungi dall’avere
solo un valore decostruttivo, il gesto della presa di distanza da noi
stessi ha un potere antidestinale rispetto all’evoluzione dei fenomeni
sociopolitici che ci hanno costituito e che continuano ad agire. Esso è
capace di aprire spazi di discorso nuovi, creativi, prospettici a partire
dalla variabilità delle linee di esclusione e inclusione che delimitano
il campo sociale nel quale ci costituiamo come soggetti. Osservare
l’azione di queste forze strutturanti nello specchio della distanza storico-geografica permette, allora, di prenderne coscienza grazie alla
messa in prospettiva che questo approccio realizza.
In quest’ottica, la questione posta dalla collocazione geografica
dei Balcani risulta una sorta di caso studio che ci aiuta a delineare
alcune di queste dinamiche di definizione e segmentazione che riconosciamo in azione anche nell’attuale fase storica dell’Europa. In
effetti, la collocazione topografica del territorio dei Balcani, e dunque
la definizione di quel territorio sottesa a questo problema geografico,
ha rappresentato a lungo una sfida per molte menti. Lungi dall’essere
una vicenda isolata e relegata all’eccezionalità del contesto storico
culturale balcanico, tale problematicità conflittuale, legata alle dinamiche proprie della pluralità etnica, linguistica e culturale, continua
a ripresentarsi tanto in Europa quanto altrove. Del resto, essa ha costituito la dinamica storica della formazione dell’intero continente
europeo, almeno dalla fine dell’Impero romano, che com’è noto è da
sempre qualificato da una pluralità, che solo con grandi sforzi tesi al
dominio e al controllo in territori circoscritti è stata ricondotta a una
relativa uniformità dagli Stati nazionali, e oggi è oggetto del difficile
processo di integrazione europea. Il caso ucraino è solo l’ultimo in
ordine di tempo di questo tipo di difficoltà. E il dibattito sulla entrata della Turchia nell’Unione Europea si inserisce nella stessa area
problematica. Ciò fa pensare che in questo tipo di discorso vi sia un
nucleo di riflessione importante che riguarda l’intera questione della
ricerca di un concetto per l’Europa. La vicenda dell’identità balcanica
risulta, allora, emblematica.
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 39
Il vilaiet oscuro
Nella sua raccolta di fiabe dei Balcani, Aleksandra Šućur riporta
la storiella del «vilaiet oscuro»31. La vicenda racconta dell’esercito
dello zar che, arrivato ai confini del mondo, si trova al limitare di
un misterioso territorio «dove non si vede assolutamente niente»32.
Timorosi d’entrare, i valorosi soldati sostano titubanti al margine
dell’oscurità ma poi, convinti dalla curiosità e dalla speranza di arricchirsi, si avventurano nel buio. Varcata la soglia delle tetre terre
misteriose avvertono scricchiolare qualcosa sotto i piedi mentre una
voce imperiosa li ammonisce: «Chi porterà via un po’ di questi sassi
si pentirà, chi non li porterà via, se ne pentirà!»33. L’immagine del
“vilaiet oscuro” e la storia che vi si svolge mi sembrano una metafora
straordinaria capace di evocare una serie di significati simbolici che
prestano la loro sostanza per esprimere la sensazione di eccezionale
complessità nota a chi si accosta alla questione dei Balcani. Se ha
ragione Paul Ricoeur a sostenere che il metaforico è uno strumento ermeneutico di organizzazione del campo dell’esperienza e che,
dunque, ha una piena dignità cognitiva 34, vorrei appoggiare le mie
riflessioni sul terreno della densità espressiva inesauribile di alcune
costruzioni simboliche che la fiaba del vilaiet offre. Proviamo allora a
segnalarne e svilupparne qualcuna.
La storiella ci presenta un territorio oscuro e sconosciuto ai confini del mondo; non del tutto al di là del mondo, in un completo “altrove”, ma nemmeno parte dell’universo illuminato di cui è il margine
d’ombra. Un esercito straniero vi penetra animato da sentimenti ambivalenti di timore, curiosità e desiderio di arricchimento. Ad attendere i soldati vi è un sinistro ed enigmatico ammonimento, che viene
nessuno sa da dove, che intima a questi cavalieri di non prendere alla
leggera la loro esperienza di quel luogo, poiché sarà comunque piena
di contraddizioni. La fiaba si conclude con la rivelazione che quei
sassolini altro non erano se non splendidi diamanti preziosi e purissimi nascosti nel buio e protetti da un velo di sospetto e diffidenza.
“Il vilaiet oscuro”, in Aleksandra Šućur, cur.: Fiabe dei Balcani, Torino: Einaudi,
2000, 232.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Cfr. Paul Ricoeur: La métaphore vive, Paris: Seuil, 1975, tr. it. di Giusepppe
Grampa, La metafora viva, Milano: Jaca Book, 1981.
31
40 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Chi non ne avrà presi, allontanandosi dal luogo misterioso in tutta
fretta, si troverà ad invidiare a mani vuote quelli che con più coraggio
ne avranno raccolta una manciata, abbandonandosi con più fiducia.
Chi ne avrà presi pochi, si pentirà di non aver sostato di più in quel
territorio, di non aver indagato meglio e di essersi accontentato di ciò
che stava in superficie, senza cercare il filone profondo da cui quei
diamanti provengono.
L’impressione generale che si ricava da questa fiaba è di un luogo
avvolto dall’incertezza, di cui nessuno conosce la collocazione esatta,
ma dal quale promana un fascino di sirena, selvaggio e suadente insieme. Esso attira gli stranieri nelle sue profondità, offrendo loro una
sfida d’astuzia e d’intelligenza, invitandoli a cogliere e apprezzare nel
suo vero valore l’impressione di ambiguità, di strana prossimità che
lo caratterizza, senza pretendere di risolverla né dal lato dei giudizi
che vengono dall’ignoranza sdegnosa, né da quello delle valutazioni
che pretendono per sé l’esaustività.
Non è quindi una domanda retorica chiedersi “dove sono” i
Balcani, prima ancora di domandarsi “cosa sono”.
Per gli antichi Greci erano le terre dei Traci e degli Sciti, popolazioni che essi consideravano semi-barbare, nel senso che gli Elleni
avvertivano con loro una prossimità di costumi, di credenze e di tradizioni (più coi Traci che con gli Sciti, collocati più a nord-est) che
consideravano certamente più rozze delle proprie. Questa vicinanza risultava inquietante per essi stessi proprio a causa del fatto che
queste popolazioni, pur somigliando ai Greci, non parlavano greco,
ma barbagliavano una qualche lingua sconosciuta. I Traci e gli Sciti,
dunque, non sono per i Greci come il mitico popolo degli Iperborei
dell’estremo nord, coi quali non c’è nessuna somiglianza, ma sono
invece quei diversi dei quali si può cogliere la differenza proprio a
partire dalle somiglianze, di cui quest’ultimi sono una forma straniante, insolita o semplicemente degradata.
La tradizione mitica che indica nella Tracia la terra di provenienza
di Dioniso, il dio straniero e straniante, semi-selvatico ed alieno alla
chiarezza olimpica della polis, forse non è utile per conoscere il luogo
di provenienza del dionisismo (questione com’è noto dibattutissima),
ma certamente è rivelatrice di ciò che pensano i Greci antichi dei loro
vicini di nord-est.
Ma resta la domanda, dove si collocano queste zone semi-barbare? I Greci, pur conoscendole per esperienza e per avervi impiantato
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 41
delle colonie, non ne offrono una descrizione geografica che va al di
là del mito. Ciò che gli interessa non è collocare quelle zone territorialmente, ma invece posizionarle culturalmente rispetto a sé in modo
da poterle contemplare e dominarne intellettualmente la complessa
relazione simbolica che esse intrattengono con la loro identità. Ho
l’impressione che questo atteggiamento abbia caratterizzato gran parte dei rapporti col mondo balcanico nelle varie fasi del suo sviluppo.
Questo non vuol dire attribuire alcun presunto primato ai Greci nella
fondazione dell’Occidente, un presupposto dalle categorie molto incerte e degne di ripensamento, ma piuttosto significa considerare che
i Balcani sono sempre stati visti “a partire da”. L’atteggiamento di cui
sopra si è riattivato nel tempo via via in modi nuovi, ma fondati su
un sentimento radicato. È come se vi fosse sempre un nuovo esercito straniero pronto ad entrare nel territorio sconosciuto per portarne
fuori i tesori, lasciando però quelle terre al loro destino di oscurità,
che nessuna lampada rischiara dall’esterno e nessuna luce illumina
dall’interno.
I confini dei Balcani variano sempre perché sono considerati sempre da punti di vista differenti e, perciò, non è mai chiaro, e non è
mai definito una volta per tutte, quali territori ne fanno parte e quali
invece appartengono ad altre realtà. Fino a dove si estende la Grande
Montagna, l’Haemus dei latini, il Bal.kan dei turchi, se dall’Adriatico
al Mar Nero, oppure dalla Grecia all’Ungheria, dai cristiani ai musulmani, questo nessuno è in grado di affermarlo con sicurezza. Un
termine, quello di Balcani, che per la sua indeterminatezza è come la
chora platonica: attende sempre il suo Demiurgo che le imponga una
forma. E questo spiega il fatto che, nei secoli, abbiano potuto significare cose estremamente diverse: la Turchia in Europa, dove un impero degno di rispetto e di considerazione per la sua potenza, seppur
nemico perché musulmano, teneva sotto il giogo delle popolazioni
semi-europee imbarbarite, rozze, violente e terribilmente deludenti
al cospetto dei loro gloriosi antenati che l’Europa colta cercava di
riconoscere in esse, a partire dalle sue letture erudite; il guazzabuglio
inestricabile di nazionalità a cui si deve imputare la responsabilità
della Prima Guerra Mondiale, dimenticando tutti i nazionalismi e gli
imperialismi delle potenze che hanno generato le tensioni esplosive
poi detonate a Sarajevo; l’alternativa del socialismo dal volto umano da contrapporre al totalitarismo dell’Impero del Male sovietico;
la speranza, delusa dalla guerra, della società multietnica che l’oc-
42 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Figura 1. Mappa del XVII secolo, disegnata da Ferdinando Marsili.
cidente europeo sogna, ma che di fatto stenta a realizzare; il luogo
dove si nasconde il germe della cattiva coscienza occidentale che fa
rinascere il morbo dell’odio etnico, la persecuzione razziale la deportazione, fino a forme arcaiche di violenza tribale, come lo stupro
sistematico che l’Occidente pensava di aver rimosso e di cui sente un
fascino perverso e oscuro. Prima ancora di chiedersi dove sono, quindi, vale la pena di domandarsi a partire da dove vengono osservati i
Balcani. Com’è noto dopo Heisenberg, l’osservatore è parte non neutra dell’osservazione e, dunque, incide sulla determinazione dell’oggetto. Risulta allora comprensibile l’effetto straniante che suscita la
mappa dei Balcani che propongo di considerare. (Fig. 1)35.
35
Mappa del XVII sec. disegnata da Ferdinando Marsili tratta da Giancarlo Susini:
“I Traci a Venezia: per la conoscenza dei fondamenti dell’Europa”, in Traci, arte e
cultura nelle terre di Bulgaria dalle origini alla tarda romanità, Milano: Catalogo
della mostra a cura di Marco Lupis di Santa Margherita, Stefania Manicardi, Daniela
Rigato, Chiara Sabattini, Art World Media, 1989, 9-10.
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 43
Cosa produce lo straniamento? La spiegazione è da ricercare nel
fatto che le cose “non sono al loro posto”. Sembrano invertite e sovvertite poiché quel territorio non è osservato da ovest verso est, come
siamo abituati a fare, senza renderci conto dell’artificialità della percezione, che sentiamo come naturale, normale, facendo scomparire
sullo sfondo la sua dimensione di artificio ermeneutico fino a farne
un habitus mentale implicito e innavertibile. Invece, il territorio si
estende sulla mappa da nord-est verso sud-ovest, creando un effetto di
perdita dell’orientamento, che genera in noi una sensazione di smarrimento e di fastidio. Ma è proprio questa sensazione di malessere e
di disordine che dobbiamo indagare in senso riflessivo, per scoprire
che essa ci rivela l’esistenza di un quadro di riferimento per la nostra
comprensione di quell’oggetto che diamo per scontato, perché non
ne siamo consapevoli, che agisce come il nostro approccio di fondo
in tutte le percezioni che abbiamo di esso con la forza plastica di un
pre-giudizio, di una pre-comprensione36. A seconda di come si sposta
il quadro, si spostano i “giusti” confini del territorio dei Balcani.
Il fantasma nello specchio
Da che punto di vista vanno, dunque, visti i Balcani? Da oriente (sono turchi) o da occidente (sono semi-europei)? Da nord (sono
parte del mondo centro-europeo), o da sud (sono parte del mondo
mediterraneo)? Da vicino (sono come noi), o da lontano (sono posti
esotici)? Dall’interno (sono caratterizzati da forme di civilizzazione
proprie, come l’egualitarismo rurale), o dall’esterno (sono qualificati
da un grado minore di civiltà)? Dal passato, al quale sono relegati in
un’eterna immobilità astorica, e quale (l’antichità classica, o l’epoca
ottomana), o dal futuro (sono la realizzazione della società multietnica)? Sono da proteggere (la liberazione dai Turchi), o da conquistare
(sono lungo le linee d’espansione dell’Austria e delle Russia)?37
Cfr. Marinella Sclavi: A una spanna da terra, Milano: Bruno Mondadori, 2005,
e: Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte,
Milano: Bruno Mondadori, 2003.
37
Non meno problematica risulta in questi anni la designazione della “giusta”
prospettiva da cui dobbiamo guardare l’Europa intera. Essa va osservata da settentrione al meridione, a partire dai virtuosi paesi che si affacciano sui mari freddi del
nord verso i pigri PIGS mediterranei? Oppure deve essere considerata iniziando dal
36
44 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Comunque li si guardi, ciò che emerge è uno strano effetto di prossimità che può suscitare reazioni molto diverse tra loro, per non dire
contrastanti. I Balcani sembrano rientrare nella categoria freudiana
del perturbante, nella quale l’opposizione netta tra heimlich e unheimlich cade, per lasciare il posto invece all’impressione di una strana
vicinanza tra il proprio e l’improprio, il famigliare e l’estraneo38. Il
perturbante indica una sorta di sfocatura dell’oggetto che, mentre lo
rende sfuggente e indefinibile, più per eccesso di somiglianza che per
l’eccesso opposto della differenza radicale, produce anche il conseguente decentramento del soggetto rispetto all’immagine consueta di
sé. Mentre ci sforziamo di definire l’altro prossimo, perché sentiamo
il bisogno di controllare il sentimento di disturbo che l’esperienza del
perturbante produce in noi, per lo stesso motivo siamo consapevoli
di dover definire nello stesso momento anche noi stessi. Il compito
però è reso difficile della somiglianza con l’altro, poiché essa rende
più sfumati i contorni del proprio e più indeterminati i confini dell’identico, lasciando spazio alla presenza destabilizzante dell’ibrido. In
tale rapporto con l’alterità prossima, si agita come una vibrazione,
che dinamizza qualunque forma di identità statica e la costringe a
trascendersi nell’altro. L’oggetto perturbante si costituisce allora come doppio dell’identico, di cui manifesta il limite e l’artificio. Come
tale, esso attiva un meccanismo psichico regressivo che produce ansie, paure, inquietudini, che si proiettano sull’immagine dell’oggetto
perturbante, finendo per costituirlo nella sua identità.
I Balcani sono stati un doppio dell’Occidente, un duplicato immaginifico in cui proiettare desideri e pulsioni (doppio buono e premiante), o istinti aggressivi (doppio cattivo e frustrante), tanto più
efficace come valvola di sfogo dei turbamenti occidentali quanto più
simile all’Europa, ma comunque diverso, e a distanza relativa. La
difficoltà attuale della coscienza europea nel trovare una concezione
valore millenario delle culture del sud, senza le quali non esisterebbe nemmeno l’idea
di Europa? Va vista dal posato ovest verso l’est inquieto o invece si estende verso
occidente dai suoi confini orientali, che fanno da argine contro pericoli indeterminati,
permettendo ai paesi centrali di godere della loro tranquillità? Forse va compresa
dal centro, dall’asse franco-tedesco che la costituisce e la innerva, dandogli unità e
compattezza nelle regole che da quel punto si dispiegano su tutto il territorio.
38
Cfr. Sigmund Freud: “Das Unheimliche”, Imago, vol. 5 (5-6), 1919, (297-324),
tr. it. di Silvano Daniele: “Il perturbante”, in Opere 1917-1923, a cura di Cesare Luigi
Musatti, Torino: Bollati Borighieri, 1989, vol. 9, 79-114.
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 45
univoca e stabile di sé ha molto a che spartire con questa dinamica.
Il progetto dell’integrazione mette in contatto dei vicini diversi ma
simili e obbliga ciascuno a uno sforzo inesauribile di ridefinizione
di sé, che non può limitarsi a ripetere lo schema dell’identificazione contrastiva rispetto alla differenza dall’altro, ma deve sforzarsi di
integrare nell’immagine di sé anche la prossimità relativa dell’altro.
In aggiunta a ciò, oltre al problema posto dai rapporti interni tra le diverse identità nazionali, vale la pena di chiedersi qual è oggi il doppio
perturbante dell’idea d’Europa che agita le sue coscienze nazionali,
dove si colloca, se fuori del continente o viceversa al suo interno, e
quali dinamiche psicosociali è in grado di provocare.
Di tali dinamiche e degli attori che le alimentano, l’esempio dei
Balcani è ancora una volta illuminante. Le crisi nazionalistiche delle
diverse guerre balcaniche ci ricordano che quei territori hanno rappresentato il rifugio della cattiva coscienza dell’Europa, quando non
esplicitamente l’incarnazione dei suoi incubi rimossi. Essi sono stati
il luogo dell’atrocità barbarica che l’Occidente ha espulso, la terra
della violenza che la civiltà europea ha superato e relegato al tribalismo, le lande dell’odio etnico razionalmente risolto col multiculturalismo, che però nel doppio ritornano a mostrarsi ai suoi confini più
prossimi, offrendogli uno specchio inquietante dal quale distogliere
lo sguardo, da cui prendere le distanze con sdegno o da velare con
qualche artificio retorico.
Di questo specchio che mostra e deforma, la pubblicistica popolare dell’Ottocento e la sua evoluzione contemporanea, la televisione
(e più di recente l’universo telematico), sono state la rappresentazione
più convincente ed efficace nel produrre nell’immaginario collettivo
una certa idea dei Balcani come di una terra immobile nel tempo indeterminabile della sua barbarie primordiale e contemporaneamente
animata da una continua ebollizione incontrollabile dalle prospettive
funeste. Tale immagine si è via via consolidata, fino a diventare convinzione condivisa anche dalle maggiori cancellerie, come si evince
da alcune analisi americane ed europee del conflitto in Jugoslavia degli anni Novanta. In questo senso, colpisce per la sua evidenza il rilievo mosso da Maria Todorova alla pretesa della Carnegie Endowment
di riproporre il documento di condanna delle guerre balcaniche del
1913 ottanta anni più tardi, al momento delle scoppio della violenza
in Bosnia-Erzegovina, come uno strumento euristico ancora efficace
per presentare la realtà storica balcanica all’opinione pubblica ingle-
46 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
se; come se quei luoghi fossero rimasti immobili nel tempo senza
subire l’impatto della dissoluzione dell’URSS, della formazione della
Comunità Europea, del protagonismo della NATO e senza partecipare ai due conflitti mondiali con tutte le loro conseguenze politiche,
morali, economiche e territoriali39. L’Europa, da parte sua, di fronte
all’orrore inequivocabile degli stupri etnici in Bosnia ha pensato di
poter evocare come spiegazione la violenza tribale e il primitivismo
delle popolazioni slave balcaniche; e perciò ha fatto fatica ad affermarsi, invece, la visione di quelle donne che denunciavano il carattere
sistematico di quella violenza e non occasionale, che ne affermavano
la realtà di progetto pianificato, parte di un vasto programma di pulizia etnica, che aveva molti punti in comune con analoghi fatti avvenuti nel cuore dell’Europa pochi decenni prima.
In aggiunta a ciò, anche le ricostruzioni televisive hanno avuto
la loro importanza nel creare e diffondere un certo immaginario collettivo. Lo storico dei Balcani Jože Pirjevec ci offre una descrizione
sintetica della loro efficacia nel caso del conflitto jugoslavo quando
scrive che l’errore dei Serbi
fu quello di non prendere in considerazione la realtà del villaggio globale. Per loro sfortuna il cosiddetto “effetto CNN”, cioè le immagini di
guerra trasmesse dalla televisione in tutto il mondo, ebbe un enorme
impatto sull’audience internazionale, costringendo i politici dell’Europa
occidentale, degli Stati Uniti, della Russia e degli Stati musulmani “a
fare qualcosa”40.
Cosa fecero gli Stati che si sentirono coinvolti e con quali intenzioni è significativo:
Per primi si mossero gli europei, convinti che la vicenda jugoslava,
svolgendosi nel “cortile di casa” fosse un problema di loro competenza.
Partirono però fin dall’inizio col piede sbagliato, mossi dal desiderio
Maria Todorova: Imagining the Balkans, New York: Oxford University Press,
1997, tr. it di Ilaria Bleve e Fernando Ghezzi, Immaginando i Balcani, Lecce: Argo,
2002, 19
40
Joẑe Pirjevec: Le guerre jugoslave (1991-1999), Torino: Einaudi, 2001, XV.
39
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 47
di aiutare le popolazioni in pericolo, ma anche da quello di dimostrare
finalmente agli Stati Uniti le proprie capacità militari41.
All’epoca del conflitto jugoslavo, la posizione dell’Europa ricorda ancora una volta l’immagine dell’esercito straniero della favola,
fermo al limitare del confine del mondo oscuro, che sembra trovare
nel sentimento umanitario la ragione per entrarvi, inorridito davanti
all’inaccettabile turpitudine della violenza barbarica che avviene alla
frontiera del mondo civilizzato, nel “cortile di casa”; non esattamente
nella casa ma molto vicino ad essa, seppur al margine e a una distanza sufficientemente ampia da permettere all’Europa di preservare un
adeguato senso di superiorità. Del resto, l’umanitarismo non va mai
solo, ma si accompagna spesso al desiderio di mostrare ad altri quanto alto è il proprio grado di civiltà e di quale potenza essa è dotata
per intervenire con tanta efficacia. Nel caso jugoslavo, erano gli Stati
Uniti ad incarnare l’interlocutore a cui dimostrare la propria determinazione. Del resto, non diversamente, anche nelle crisi attuali il
rapporto con l’altro Occidente rappresentato dagli USA resta una questione problematica nella definizione della realtà europea, che dunque
a maggior ragione non può essere ridotta a un semplice problema di
confini territoriali interni.
In realtà, il “margine della civiltà” oggi si è spostato rispetto agli
anni del conflitto jugoslavo, ma le problematiche sembrano ripetersi
identiche da una parte e dall’altra dei nuovi confini e aggiungere nuove questioni. All’estremo sud-est del confine, nel suo bordo esterno,
esse riguardano le ragioni degli interventi militari e umanitari che
coinvolgono gli Stati europei nei diversi conflitti mediorientali. Dal
lato meridionale, comprendono le frontiere di Italia e Grecia, dove si
gioca la partita europea della solidarietà e dell’umanitarismo. Ai suoi
bordi sud-orientali (dalla Turchia all’Ungheria), al contrario, l’Europa sembra poter derogare ai principi elementari dei diritti umani senza, per questo, soffrire troppo di una crisi di identità, che in quei luoghi si consolida invece nella forma del «continente fortezza», chiuso
nei propri limiti sigillati e sorvegliati. Al proprio interno, numerose
faglie frammentano lo spazio comune degli Europei, impedendo loro
a vari livelli ciò che è affermato di principio nei patti costitutivi che li
uniscono. In tutte queste questioni aperte, giocano una parte anche le
Ibidem.
41
48 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
forze globali e le potenze mondiali che vediamo già all’opera durante
il conflitto jugoslavo, che si presenta allora come prima guerra paradigmatica dell’era della fine del mondo bipolare. Tra le forze di pressione sull’area balcanica, all’epoca, in primo luogo, troviamo proprio
gli americani che, scrive ancora Pirjevec:
Per parte loro, assistettero alla vicenda jugoslava mossi da due opposti
impulsi, riconducibili entrambi al presidente Woodrow Wilson: l’idealismo, che li spingeva a soccorrere la gente in pericolo e la paura d’immischiarsi nelle complesse faide etniche dei Balcani42.
Ci troviamo di nuovo di fronte all’enigma insolubile di quanti
sassolini portare via dal vilaiet oscuro, una questione che riserva comunque un esito pieno di contraddizioni.
Ne nacque una situazione di stallo, gravida di tensioni, durata fino alle
soglie del ’94, quando Clinton cominciò a rendersi conto che l’immagine degli Stati Uniti nel mondo e il suo stesso ruolo in politica interna avrebbero sofferto, se non avesse cercato di sbrogliare la matassa
balcanica43.
Ciò che conta, da sempre, è l’immagine che lo specchio restituisce a chi vi si affaccia, e non ciò che è oltre lo specchio. Del resto i
Russi non trovarono di meglio che riattivare uno stentato panslavismo
da questione d’Oriente di sapore imperialistico e gli Stati musulmani videro nella dissoluzione jugoslava un’occasione di protagonismo
sulla scena internazionale, finalmente per una causa ritenuta universalmente buona, proteggere le popolazioni indifese, ma contemporaneamente ribadire la distinzione dell’identità islamica rispetto al
crudele Occidente.
Rispetto all’effetto CNN, evocato da Pirjevec, Jean Baudrillard
svolge un’analisi critica acuta quando dice che noi occidentali (ma
può valere in senso generale) siamo andati là, nei Balcani, a cercare
noi stessi durante la guerra jugoslava costruendo, a partire da quella
realtà, un oggetto ad hoc ad uso dei bisogni di quelli rimasti a casa,
tanto trepidanti e commossi davanti alle televisioni quanto desiderosi
42
43
Pirjevec, Le guerre jugoslave (1991-1999), XV-XVI.
Ivi, XVI.
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 49
di provare quel sentimento del reale che solo il dramma può dare.
Scrive Baudrillard che
noi però sappiamo meglio di loro che cos’è la realtà, poiché li abbiamo
designati a incarnarla. O semplicemente perché si tratta di ciò di cui noi,
e tutto l’Occidente, manchiamo maggiormente. Bisogna andare a rifarsi
una realtà là dove c’è sangue44.
Nei Balcani, abbiamo costruito un’alterità relativa per ritrovare
un’identità perduta. Non meno contraddittoria è stata la pratica della
solidarietà, durante il conflitto bosniaco. Con tono provocatorio, scrive ancora Baudrillard all’epoca che
Tutti questi “corridoi” che apriamo per spedire loro i nostri viveri e la
nostra “cultura” sono in realtà corridoi di miseria, attraverso cui importiamo le loro forze vive e l’energia della loro sventura. Scambio ancora
una volta ineguale. Essi trovano nella disillusione radicale del reale e
dei nostri principi politici una specie di secondo coraggio, quello di sopravvivere a quanto non ha senso – e noi ci mettiamo a convincerli della
“realtà” della loro sofferenza, rendendola culturale, certamente, teatralizzandola perché essa possa fungere da riferimento al teatro dei valori
occidentali, di cui la solidarietà fa parte […] Si è addirittura venuti da
New York per rappresentare Aspettando Godot a Sarajevo. Perché non
Bouvard e Péuchet in Somalia o in Afganistan?45
Ora non meno di allora, l’Europa è in cerca di un’alterità relativa
dove mettere alla prova, davanti a se stessa innanzitutto, la solidità
della propria identità, con esiti fino a qui contraddittori, che oscillano
tra l’afasia diplomatica, che ha finito per rendere evanescenti i principi ispiratori del progetto europeo, e una volontà di potenza bellica
disordinata e di fatto insufficiente per agire in autonomia rispetto ad
altre, più agguerrite, forze.
Sarajevo, dunque, è stato un “altrove” come altri? O è stata costruita come “altrove” dell’Occidente? Ed è stata oggetto di interesse
perché è Europa o perché è solo simile ad essa? E, infine, lo slancio
Jean Baudrillard: Le crime parfait, Paris: Éditions Galilée, 1995, tr. it. di
Gabriele Piana, Il delitto perfetto, Milano: Raffaello Cortina Editore, 1996, 138.
45
Ivi, 138,137.
44
50 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
umanitario verso di essa, così come verso altre realtà di sofferenza,
è stato motivato dalla compassione o era funzionale all’affermazione
dei principi in cui ci si voleva specchiare, di cui è stata l’occasionale messa in mostra, o ancora è stato l’espressione di una cinica
politica di potenza? Questo insieme di domande circoscrive il campo
dove riconosciamo la reale natura del continente europeo, un campo
in cui diverse forze in tensione disputano tra loro per l’affermazione
di un’immagine dell’Europa o dell’altra. Il loro rapporto disegna via
via il perimetro discorsivo in cui si sviluppano diverse strategie identitarie che, nell’esercizio del loro dominio, contribuiscono a formare
l’idea che l’Europa ha e vuole mostrare di sé e, così facendo, ne delimitano i confini in quanto territorio. Tuttavia, questa dinamica presenta un rischio: se il termine “balcanizzazione”, e le sue varianti come “balcanismo”, hanno finito per divenire sinonimi di guazzabuglio
inestricabile, caos e conflitto generalizzato, “europeizzazione” finirà
per indicare una situazione di litigiosità permanente, il prevalere degli
egoismi e della frammentazione e una volontà di dominio inefficace,
e “europeismo” significherà debolezza, incapacità di decidere, ambiguità di condotta verso i propri stessi principi.
Il serto della montagna
«Intorno al 1830, il geologo e geografo francese Ami Boué […] descrisse correttamente la montagna – scrive Todorova – essa si estendeva per 550 chilometri da ovest a est (dalla valle del Tumok al Mar
Nero), con una larghezza che variava dai 20 ai 60 chilometri»46. Ideò
anche una formula sintetica per descriverla, chiamandola «La Turquie
d’Europe»47. Dunque, a metà dell’Ottocento, grazie al buon geografo francese animato dal sincero spirito progressista del positivismo,
desideroso di rischiarare l’oscuro e debellare il demone della superstizione, dove si collochi esattamente la Grande Montagna balcanica
e quali siano i suoi confini propri finalmente lo si sa con certezza. Ma
questo non ha impedito ad alcuno di continuare a domandarsi fino a
dove si estendessero i Balcani. Evidentemente non è, non è mai stata,
una questione puramente geografica quella della delimitazione di queTodorva, Immaginando i Balcani, 53.
Ibidem.
46
47
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 51
ste terre incerte. L’immagine della Grande Montagna selvaggia, che
rappresenta quei luoghi da sempre, va indagata e compresa con altri
mezzi che non la squadra e il compasso dello scienziato naturalista.
Negli stessi anni in cui il francese celebrava il suo culto dell’esattezza misurando la montagna balcanica, Austria e Russia la osservavano dall’alto come l’avvoltoio guarda la bestia che agonizza,
aspettando il momento buono in cui stramazza al suolo per cibarsi
del suo corpo, strappandone dei pezzi a forza. Nell’immaginario di
queste due potenze, quella zona non è mai stata davvero “altra” in
senso assoluto; essa era una proiezione possibile di sé secondo linee di espansione imperialistica che l’avrebbero ricondotta ai suoi
“confini naturali”, smembrandola secondo i diversi domini dell’una
o dell’altra.
Mio padre sognava un regno slavo sotto il dominio degli Asburgo.
Sognava una monarchia degli austriaci, degli ungheresi e degli slavi. E
a me, che sono suo figlio, sia concesso dire a questo punto che, se mio
padre fosse vissuto più a lungo, m’immaginino che avrebbe potuto forse
cambiare il corso della storia. Invece morì, circa un anno e mezzo prima
dell’assassinio di Francesco Ferdinando. Io sono il suo unico figlio48.
Così scrive l’ultimo erede dei von Trotta, alter ego di Joseph
Roth, mentre osserva l’Impero asburgico reclinare il capo verso i
giorni del tramonto nel suo languido declino. Come poi la storia sia
andata, lo sappiamo e non fu certo nella direzione sperata dal nipote
dell’eroe di Solferino. L’atteggiamento che Roth ci descrive nella sua
novella è emblematico di una tendenza consolidata a considerare l’area balcanica come un luogo che ha bisogno di definizione e attende
chi sappia dargliela. Ma la vicenda balcanica, vista da Vienna, è anche
espressione di un progetto di unificazione multinazionale sotto una
sola corona, fallito miseramente nella deflagrazione centrifuga dei nazionalismi che laceravano l’Impero austro-ungarico.
Lo specchio balcanico ci ricorda ancora una volta che, nell’opera
di definizione di un territorio, la qualità dello sguardo che altri gettano
su quello spazio è parte integrante e non neutra del processo. Sarebbe
limitante pensare che l’identificazione avvenga in una sorta di vuoto
Joseph Roth: Die Kapuzinergruft, Amsterdam: Allert de Lange, 1950, tr. it. di
Laura Terreni, La cripta dei cappuccini, Milano: Adelphi, 1989, 11.
48
52 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
metafisico e per virtù propria di forze provenienti dall’interno, capaci
da sole di plasmare una forma universalmente riconosciuta. E non è
pertinente l’obiezione secondo cui i Balcani dell’Ottocento erano un
territorio debole dal punto di vista politico, frammentato e dominato,
diplomaticamente ininfluente, e dunque le attenzioni dei suoi vicini
erano tanto più legittime e inevitabili nel gioco dei rapporti di forza
del tempo. Nel sistema mondo «post pace di Westfalia»49 che caratterizza la nostra epoca, tale situazione non è eccezionale, ma invece
strutturale.
Senza trascurare il fatto che ogni definizione è una finzione, è
altrettanto palese che il processo della designazione è un atto politico in relazione a forme di potere. Vi è una stretta connessione tra
descrizione, designazione e assegnazione di un’identità, che tende a
consolidarsi nel tempo e autoalimentarsi, connettendosi con altri gangli del sistema simbolico, fino a vivere di vita propria e a presentarsi
come una verità in sé dall’aspetto solido, poiché ben radicata nella rete di precomprensioni che è data comunemente per acquisita. Ciò che
chiamiamo identità collettiva è riconducibile in buona parte a questo
tipo di processi, che hanno in sé la virtù di far dimenticare la loro
origine e perciò di presentarsi come delle datità naturali50. Il concetto
di “identità” presenta tali insidie che alcuni autori sostengono da anni
la necessità di eliminarlo dal discorso scientifico, in quanto usurato
da un impego improprio e ambiguo per natura51. Fa bene Todorova, al
termine del suo studio critico e genealogico sull’identità balcanica, a
sottolineare questo aspetto nelle sue conclusioni.
In questo modello [di identità, n.d.a.], è l’autorità che dà forma alla rappresentazione (o a idonei tipi esistenti di rappresentazione) in qualunque
momento l’interesse politico sorga. Che qualcuno operi completamente
all’interno dell’apparato concettuale di questo discorso non è, dunque, il
risultato delle costrizioni di questo discorso ma una scelta consapevole e
deliberata. Nelle parole di Iser, esso è una “mobilitazione con intenti di
comando” da parte dell’attivatore52.
Etienne Balibar: “L’Europe-frontière et le «défi migratoire»”, Vacarme, 73, autunno 2015, 136-142. http://www.vacarme.org/article2819.html.
50
Cfr. Ugo Fabietti: L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco,
Roma: La Nuova Italia Scientifica, 1995.
51
Cfr. Francesco Remotti: Contro l’identità, Roma-Bari: Laterza, 1996.
52
Todorova, Immaginando i Balcani, 309.
49
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 53
La domanda è allora: “come ci si salva dalla ‘tentazione asburgica’?”. Difficilissima questione che merita ben altra risposta rispetto
a quella che è possibile dare in questo scritto. Ma invece è possibile
indicare alcune linee su cui indirizzare la ricerca della soluzione.
Forse è necessario osservare il problema dell’identificazione da
una maggiore distanza, per evitare di sentirsi troppo implicati nella
cosa, ricercando una forma di straniamento da sé sull’esempio del
viaggiatore delle Lettere persiane di Montesquieu. Un’eccessiva
prossimità rende impossibile la messa a fuoco della vista, creando
strani effetti di distorsione. Di contro, una distanza maggiore permette di vedere non solo con più chiarezza e larghezza, ma di cogliere in
quella vastità anche gli altri che guardano, affacciati sul limitare della
frontiera da più presso, e l’ombra proiettata dalle loro mire, dalle loro
aspettative e contraddizioni. Sostiene Balibar che «une frontière n’est
pas ce qu’un État décide, mais ce qu’un contexte global lui prescrit»53
e, a questo proposito, già nel 2003, sottolineava il rapporto tra identità
attribuita e potere, distinguendo due forme di influenza europea nel
mondo rispetto a quella esercitata dagli USA. Scrive il filosofo che
A double question is at stake here. There is a question concerning the
“power”of Europe. In a sense, Europe as a whole is even less powerful
(not more) than its constitutive nation-states, or its power is less effective, harder to implement (hence the project of many: to “reinforce” it,
to achieve more “integration” . . . ). And there is a question concerning
the “political capacity” of Europe in today’s world, in particular its capacity to help resolve conflicts54.
Dal punto di vista della politica di potenza statunitense, l’Europa
spicca per la propria incapacità storica a risolvere i propri problemi senza l’aiuto americano, e proprio la guerra jugoslava è portata ad esempio. Non meno inetta appare nell’imporsi nelle questioni
post-coloniali che essa stessa ha generato. Questa incertezza inefficace dimostra oltreoceano l’inesistenza di fatto dell’UE come soggetto
politico. Ma dal punto di vista promosso da Balibar, questa innega53
Balibar, “L’Europe-frontière et le «défi migratoire»”, 137.
Etienne Balibar: “Europe: Vanishing Mediator”, in Constellations, 9600
Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK e 350 Main Street, Malden, MA 02148,
USA: Blackwell Publishing Ltd., Volume 10, 3, 2003.,(312-338), 320.
54
54 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
bile impotenza mondiale non è solo l’indice di un’insufficienza, ma
al contrario è il segno di una caratteristica positiva, che deve essere
compresa nel giusto senso per promuovere politiche globali efficaci.
L’Europa deve essere osservata all’interno del sistema-mondo, considerando il ruolo che essa può e vuole avere nella realtà globale.
Dalla sua storia di luogo che ha conosciuto la divisione, l’ebbrezza
ideologica e il conflitto mortale (the lesson of tragedy) ma che ha saputo anche creare le vie per la mediazione e la conciliazione (institutionalising conflicts) e integrare la diversità (lesson of otherness) essa
può trarre insegnamento per riconoscere il proprio posto nel mondo55.
Da quella prospettiva potrà cercare una via per identificarsi, differenziandosi da altri attori mondiali. La sua forma può essere quella del
“mediatore evanescente”, secondo l’espressione coniata da Balibar:
J’entendais par là, évidemment, non une médiation imperceptible ou
purement virtuelle, mais une intervention en tiers, devant « disparaître
dans ses effets » (Althusser), parce que l’objectif qu’elle vise n’est pas
l’acquisition d’une position de puissance pour son propre compte mais
la transformation des conditions générales dans lesquelles se développent les conflits (en particulier la restauration du droit international).
Cela suppose que ses populations y trouvent en même temps un intérêt.
Il me semble que c’est devenu aujourd’hui l’évidence absolue, et même
une question de vie et de mort56.
Secondo il pensatore francese, dunque, l’Europa deve saper prendere le distanze dalla politica di potenza e interventismo militare degli USA per affermarsi, invece, a livello globale, come forza diplomatica mediatrice dei conflitti, che basa il proprio potere sul primato
del diritto e della conciliazione, e si presenta come promotrice dei
processi democratici in tutto il mondo. Una posizione, questa, in grado di depotenziare il rischio della risorgenza dei conflitti identitari
etnici e nazionalistici, alimentati dalla logica dello scontro di civiltà.
Tale è il ruolo che essa dovrebbe assumere, un compito che le darebbe
una ben definita immagine a livello mondiale, che rappresenterebbe
un modello globale a cui altri possono guardare con speranza e attesa,
55
Ivi, 324, 325.
Etienne Balibar: “Après la fin de l’Europe”, Vacarme, 74, inverno 2016,154:
http://www.vacarme.org/article2834.html.
56
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 55
come motivo di ispirazione. Anche secondo Bauman, che si colloca
sulla stessa linea di discorso, in questo aspetto si dovrebbe riconoscere una nuova fase della “missione civilizzatrice” dell’Europa nel
mondo, ben diversa, per non dire opposta, rispetto a quella dell’epoca
coloniale, basata su un profondo ripensamento di ciò che si intende
per potere. Ma proprio per l’importanza che questo nuovo protagonismo europeo ha per l’immagine globale dell’Europa, nulla la danneggia di più dell’ipocrisia dell’affermazione dei suoi principi eterni,
come la difesa dei diritti dell’uomo, seguita da una pratica politica
dei suoi governi che all’interno dei confini europei, alle sue frontiere
e fuori del suo territorio li nega, destituendoli della loro legittimità. Balibar non esita a definire questo atteggiamento una «indignité
collective [qui, n.d.a.] est une forme de l’autodestruction»57, ovvero
esso equivale a un suicidio politico che porta l’Europa ad abbattere
i pilastri del suo stesso edificio comunitario. All’«Europa fortezza»
evocata da Bauman come risultato della logica dello scontro di civiltà, è possibile opporre l’immagine dell’«Europa Borderland» nel
senso evidenziato da Balibar quando afferma che
L’Europe a cru se doter de frontières propres, mais en réalité elle n’a pas
de frontières, elle est elle-même, en tant que telle, une “frontière » complexe : à la fois une et multiple, fixe et mobile, tournée vers l’extérieur
et vers l’intérieur. Pour le dire dans un anglais ici plus explicite, elle est
un Borderland ou “pays-de-frontières” »58.
Nella prospettiva del francese, ciò è vero non solo perché le sue
frontiere sono per loro stessa natura indefinibili, perché il territorio
europeo non coincide con le numerose istituzioni di cui i suoi Stati
sono membri, e nemmeno perché i suoi confini sono variabili persino
al suo interno e soggetti a strategie di potere ora tese a espellere un
territorio o un altro (il caso Grecia) ora a includerne qualcuno nella
difficile posizione di stato cuscinetto rispetto alle insidie provenienti
dall’esterno (la Turchia, l’Ucraina). In maniera ben più radicale, l’Europa è una frontiera perché è una terra che da sempre si è costituita
nella sua forma storica attraverso il rapporto incessante con la sua
alterità.
57
Balibar, “L’Europe-frontière et le «défi migratoire»”, 137.
Ibidem.
58
56 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Roberto Esposito ritrova in questa attenzione attuale di Balibar per
la frontiera la ricaduta positiva del dibattito decostruttivo sull’identità europea aperto da Jacques Derrida all’inizio degli anni Novanta
col testo L’autre cap, con cui il filosofo apriva il discorso europeista
nella direzione dell’altra sponda mediterranea, rilanciato da diversi
intellettuali francesi nelle discussioni di Strasburgo del 199259. Se è
vero che esso ebbe degli esiti impolitici nella radicalità delle sue posizioni critiche contro un’idea sostanzialistica dell’identità europea,
che rischiava di riattivare la «macchina teologico-politica dell’autoidentificazione»60 attraverso cui l’Europa ha costituito se stessa e
ha propagandato come universale il proprio interesse particolare, il
ripensamento della questione delle frontiere operato da Balibar esce
dall’impasse dell’immobilismo decostruttivo. Sostenere, come fece
Derrida, che non esiste l’Europa ma solo l’europeizzazione, risolvendo la questione europea nella costruzione possibile e variabile della
sua realtà, secondo l’idea chiave dell’unitas multipelx, significa tenere conto che di tale processo, da sempre, sono parte le alterità verso
cui l’Europa si è aperta fuori e dentro dei suoi confini e che di fatto
l’hanno costituita. Scrive ancora Esposito, riprendendo il pensiero di
Marc Crépon che
per alterità vanno intese da un lato le relazioni che intrecciano i Paesi
europei tra loro, dall’altro quelle che li legano, in un continuo scambio
osmotico, al resto del mondo. In questo senso l’Europa è da sempre
contaminata e alterata, ecceduta e differita. Essa si è costruita trasformandosi, traducendo il fuori in dentro e viceversa61.
In quest’ottica, allora, è possibile ripensare politicamente la questione della frontiera, come intende fare Balibar, innestando sul discorso decostruttivo la considerazione storica della radicale trasformazione del regime della circolazione delle merci e delle persone
nell’epoca attuale. Nella nuova situazione, ancora più di prima, è
chiaro che la funzione del confine può essere interpretata da due lati:
Cfr. Roberto Esposito: Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino: Einaudi,
2016, 216-226.
60
Ivi, 218.
61
Ivi, 219.
59
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 57
Considerato generalmente come linea di esclusione, esso può essere
visto anche come articolazione tra elementi diversi, modificazione di
categorie spaziali e temporali, produzione di nuove forme di soggettività […] Da semplice soglia, la frontiera diventa campo di ritenzione,
dispositivo performativo, forma di vita per segmenti sempre più ampi
della popolazione62.
Ritroviamo nelle parole di Esposito gli accenti foucaultiani propri
della governamentalità con cui Balibar ha rilanciato in senso politico
la critica decostruttiva del concetto di frontiera. La gestione del fuori
è la questione politica su cui si gioca l’identità del dentro. Ciò innanzitutto a partire dal ripensamento dei rapporti coi paesi ex coloniali
dell’Europa, da cui partono i flussi migratori che premono alle frontiere per il riconoscimento del loro diritto. Alla tendenza alla segmentazione nazionalistica e alla spinta verso nuove forme di segregazione
che percorrono l’Europa, che ricordano da vicino i fantasmi emersi
coi conflitti balcanici degli anni Novanta, Balibar oppone non l’abolizione delle frontiere ma, dice Esposito, la loro democratizzazione.
Proprio a partire dall’impossibilità di trovare una sola identità unitaria
dell’Europa
ancora una volta occorre lavorare sulle frontiere, materiali, immateriali,
fisiche e mentali per riarticolare in modo inedito spazi, tempi, mondi apparentemente separati e giustapposti […] Le frontiere vanno ricondotte
dal ruolo attuale di retroguardia – di punto limite in cui la semantica politica rischia sempre di scivolare in quella della polizia – ad avamposto
della democrazia63.
Ecco allora il senso del rilancio di quel progetto mondiale che
Balibar ha chiamato «mediazione evanescente» nel 2003 e che il filosofo sente oggi di dovere precisare quando afferma che
il faut changer de dénomination si l’on veut lever les équivoques, et
parler plutôt d’une résistance obstinée au “choc des civilisations” et à
l’instrumentalisation des conflits religieux par les calculs impériaux,
ou inversement. L’Europe n’est plus simplement médiatrice puisqu’elle
62
Ivi, 223.
Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, 224-225.
63
58 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
est directement actrice : c’est sur elle-même en même temps que sur
d’autres qu’elle doit exercer sa capacité de transformation des données
du problème. L’Europe n’est plus simplement médiatrice puisqu’elle
est directement actrice : c’est sur elle-même en même temps que sur
d’autres qu’elle doit exercer sa capacité de transformation des données
du problème64.
Se l’Europa è un’unità senza popolo, come molti autori l’hanno
definita, tre sono le possibilità che si affacciano: la prima rilancia a
livello continentale il modello idealistico della creazione degli Stati
nazionali, anch’essi nati per superare la frammentazione e il conflitto,
basato sull’invenzione dell’unità di spirito del popolo, che ha prodotto le «comunità immaginate»65 di cui parla Benedict Anderson; la seconda è il modello dell’unione debole proposto da Jurgen Habermas,
basato sull’universalità formale del diritto comunitario, che non ha
bisogno per mantenersi della pericolosa rinascita del nazionalismo su
scala europea, ma risulta fragile e astratto nella sua capacità di unificare le differenze66; l’ultima è l’idea di Balibar basata su un radicale
riorientamento del quadro di riferimento della questione identitaria
europea. La sua proposta è tesa al riconoscimento delle differenze
e dell’alterità attraverso la messa in opera di strategie politiche inclusive che si spingono al di là dei confini politici dell’Europa, fino
a ricomprendere, in una pratica democratica allargata, anche i paesi
che non sono parte del continente, come le coste del nord-Africa, in
un’ottica panmediterranea, e gli Stati ex coloniali, di cui l’Europa può
essere l’interlocutore privilegiato e sostenitore dei loro processi di
sviluppo democratico. Scrive Balibar nel 2003:
I believe that the “Euro-Mediterranean ensemble,” whose development
is at the same time advocated and constantly hindered by multiple obstacles, including phobias profoundly buried in the collective unconscious
64
Balibar, “Après la fin de l’Europe”,154.
Cfr. Benedict Anderson: Imagined Communities, London-New York: Verso,
1991, tr. it di Marco Vignale, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Roma: Manifestolibri,1996.
66
Cfr. Jurgen Habermas: Die Postnationale Konstellation. Politische Essay,
Frankfurt am Main: Suhrkamp,, 1998, tr. it. di Leonardo Ceppa, La costellazione
postnazionale, Milano: Feltrinelli,1999.
65
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 59
stemming from centuries of religious and colonial conflicts, is nevertheless exactly such a frame of reference. Its progressive construction,
through negotiations, common projects, and simultaneous mediations in
the common interest, is itself a way to affirm the originality of Europe’s
positions in international relations, where the assertion of a specific
identity goes hand in hand with its (seeming) opposite: the inclusion of
the other within itself 67.
Tale cambiamento di prospettiva implica lo sviluppo di una coscienza critica europea capace di riflettere su di sé nell’atto di definire
la sua identità, per avere consapevolezza della sua origine e dei propri
limiti. Se l’identità europea si cositutisce anche per differenziazione
rispetto a quella d’altri soggetti, com’è normale che sia, è necessario
riconoscere innanzitutto, seguendo la riflessione di Todorov che « par
rapport à ces autres parties du monde, l’Europe se distingue par la
multiplicité des États établis sur son territoire, ce qui à son tour renvoie à la multiplicité des cultures et des langues »68.
Ancora una volta il caso dei Balcani ci permette di fare chiarezza
rispetto alle qualità positive che la molteplicità europea può incarnare. Se “balcanismo” è divenuto un sinonimo di ambiguità, Todorova
sostiene che in verità «[esso] è un discorso su un’ambiguità attribuita»69. Per questo motivo propone, come provocazione, di adottare per
il termine Balcani, con tutte le sue efflorescenze linguistiche come
“balcanismo”, “balcanizzazione”, “balcanico”, la soluzione che ideò
Heidegger per tornare a parlare di ontologia nell’epoca post-metafisica: quell’«essere»70che avrebbe dovuto rappresentare a livello grafico
ciò che la riflessione filosofica aveva prodotto in termini di consapevolezza rispetto all’antica questione: «Perché l’essere e non il nulla?».
Lo stesso si potrebbe dire per il termine “identità”, ma credo che la
proposta valga per la stragrande maggioranza del lessico delle scienze
67
Balibar, “Europe: Vanishing Mediator”, 332.
Todorov, “À la recherche de l’Europe”, 6.
69
Todorova, Immaginando i Balcani, 40.
70
Martin Heidegger: “Zur Seinsfrage”, in Armin Mahler, cur.: Freundshaftliche
Begegnungen. Festschrift für Ernst Jünger zum 60. Geburstag, Frankfurt am Main:
Klostermann, 1955, (9-45), tr. it. di Alvise La Rocca e Franco Volpi, “La questione dell’essere”, in Ernst Jünger, Martin Heidegger: Oltre la linea, Milano: Adelphi,
1989, (107-167).
68
60 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
umane e della filosofia. Di qui il suo limite e la sua insufficienza; non
farebbe altro che sostituire una terminologia scolastica ad un’altra.
Più proficua può essere la ripresa critica della riflessione sulla
differenza di Gilles Deleuze, che nella nozione di “pensiero nomade”
sviluppa una concezione della descrizione basata sulla consapevolezza della complementarietà dei diversi punti di vista, che potrebbe
essere una valida base di partenza per il ripensamento della questione
della definizione. Sulla stessa linea troviamo il discorso di Todorov
quando parla dell’identità europea nei termini di un pluralismo che
«empêche l’un des participants d’assumer une position hégémonique
et d’exercer une tyrannie sur les autres»71. Un approccio questo che si
riconosce nella costruzione di una memoria collettiva condivisa basata non sull’idea della riduzione delle storie particolari all’identico,
compito irrealizzabile e poco desiderabile, ma invece sul convincimento che i cittadini europei di domani saranno coloro che sapranno
«tenir compte du point de vue des autres, de relever ressemblances
et différences, et de les situer sur un plan général [et, n.d.a] que la
mémoire du voisin est aussi légitime que la leur»72.
In aggiunta a ciò, la questione dell’identità dei Balcani ci ricorda
che una coscienza rinnovata della loro identità dovrebbe partire dalla considerazione del problema dalla loro collocazione marginale73.
La dinamica descrittoria che li ha interessati può essere compresa in
una luce diversa, seguendo le linee di sviluppo evidenziate da Mary
Douglas, se messa in relazione con le problematiche connesse alla
loro collocazione provinciale, marginale, liminare74. I Balcani sono
stati un tipico esempio di un oggetto funzionale alle logiche di autoaffermazione di quei soggetti che, definendo in modo esclusivo i
limiti e i caratteri dell’altro, segnano i propri confini ora più larghi,
ora più stretti, ora più rigidi, ora più lassi. Questa stessa dinamica
spiega come possa accadere che la varietà culturale presente nelle
terre balcaniche possa essere ricondotta semplicemente a un’inestricabile contraddizione. Contraddittorio è il modo in cui è osservato
l’oggetto balcanico, fenomeno certamente complesso, ma non più di
71
Todorov, “À la recherche de l’Europe”, 8.
Ibidem.
73
Todorova, Immaginando i Balcani, 40 e segg.
74
Cfr. Mary Douglas: Purity and Danger. An Analysis of Concept of Pollution and
Taboo, Harmondsworth: Penguin Books, 1970, tr. it di Alida Vatta, Purezza e pericolo.Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù, Bologna: Il Mulino, 1993.
72
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 61
altri percorso da spinte divergenti e contrastanti; ambivalente è stato
il sentimento con cui vi ci si è accostati; ambigue sono state le intenzioni con le quali ci si occupati di quel territorio.
Non meno incerti sono gli attuali approcci alla questione europea, non a caso rivelatisi nella loro problematicità dal momento in
cui l’Europa ha perduto la sua centralità e ha preso a gravitare in un
ancora imprecisato margine del mondo, come una sorta di provincia
degli Stati Uniti e nelle mire di altri soggetti. Ciò che è mancato nel
dibattito balcanico, come sempre, è la voce che viene dall’interno,
quel lume che da dentro può rischiarare il vilaiet oscuro. Allo stesso
modo, sarà la luce che l’Europa saprà gettare su di sé e fuori di sé a
sollevarla dalla catalessi identitaria in cui sembra caduta.
Il ponte e la montagna
Torniamo ora alla pregnanza del linguaggio metaforico per esprimere qualche considerazione finale. Due figure, tratte dall’immaginario
balcanico, indicano la strada per una diversa comprensione del problema: quella del ponte e quella della Grande Montagna.
Al ponte si attribuisce la virtù di mettere in comunicazione ciò
che è separato; luogo carico di attese e di speranze, il ponte non ha
nulla della marginalità, piuttosto la supera nella direzione di una più
vasta conoscenza della realtà. I Balcani come ponte sono quanto di
meglio una coscienza esterna ad essi possa immaginare per coglierne
l’essenza senza imporvi la propria. Forse, nel tempo, si è sviluppata in Occidente una simile consapevolezza, come dimostra l’enorme
impressione che fece in Europa la distruzione deliberata, durante la
guerra, dell’antico ponte di Mostar, oggi ricostruito, di cui fu subito
chiara la natura simbolica.
Non meno delle molte frontiere del dedalo etnico e nazionale
balcanico, l’intera Europa può essere concepita come un ponte verso
altre realtà e essa stessa percorsa da ponti che superano gli steccati e
oltrepassano i fossati al suo interno. L’Europa non ha una sua lingua,
e dunque per i suoi detrattori non avrà mai un suo spirito unitario. Ma
da un altro punto di vista, questo non è d’ostacolo all’integrazione, al
contrario è una qualità essenziale della sua realtà incompiuta, che può
rivelarsi la sua più grande opportunità di affermazione.
Ciò che costituisce l’identità europea, secondo Todorov, è
62 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
sa manière de gérer les différentes identités régionales, nationales, religieuses, culturelles qui la constituent, en leur accordant un statut nouveau et en tirant profit de cette pluralité même”- e in modo ancora più
esplicito - : Elle consiste, non en une liste de noms propres ou un répertoire d’idées générales, mais en l’adoption d’une même attitude face
à la diversité. [en une, n.d.a.] manière de donner le même statut aux
différences75.
Il mosaico linguistico europeo ha sempre costretto gli europei allo
sforzo della traduzione, li ha obbligati a gettar ponti comunicativi.
Ricorda Umberto Eco che la «vera lingua d’Europa» è «la pratica
della traduzione»76, la sola forma di unità del molteplice che non cancella le differenze ma le integra ad un livello superiore di relazione.
L’impegno traduttivo non si realizza mai con il semplice trasferimento di un lessico in un altro, ma invece comporta il confronto creativo
di un sistema linguistico di riferimento con un altro, teso a uno sforzo
interpretativo interminabile, che amplia le possibilità espressive di
entrambi i mondi simbolici, e così facendo ne allarga gli orizzonti di comprensione. Il compito ermeneutico della traduzione avanza
trovando le mediazioni, i compromessi, le giuste compensazioni comunicative, che creano una realtà simbolica terza, che non è il terreno proprio né di un soggetto linguistico né dell’altro, ma rappresenta invece il ponte aperto dalle due parti, su cui si incontrano l’uno
nell’altro. “Farsi capire” e “sforzarsi di capire” sono le figure polari e
inseparabili di una sola struttura relazionale, basata sul principio della
coappartenenza all’atto comunicativo, che oppone alla logica oppositiva io/l’altro quella inclusiva altro-altro. La traduzione istituisce la
frontiera porosa dello scambio e della contaminazione. Inoltre, come
ben sanno gli antropologi, la lingua è espressione di una concreta forma di vita collettiva, che chiamiamo cultura. La traduzione è allora un
incontro creativo di culture, che produce l’orizzonte di senso dove si
sviluppano i modi di vita a venire, dove prendono forma nuove modalità di convivenza e di condivisione77. Scrive a proposito Bauman che
75
Todorov, “À la recherche de l’Europe”, 6.
Cfr. Umberto Eco: La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, RomaBari: Laterza, 1993.
77
Cfr. Silvana Borutti, Ute Heidmann: La babele in cui viviamo. Traduzioni, riscritture, culture, Torino: Bollati Boringhieri, 2012.
76
Matteo Canevari - Visioni Balcaniche 63
esiste poi un altro prezioso lascito con cui l’Europa può contribuire al
futuro “processo di civilizzazione” della terra di frontiera planetaria […]
L’Europa è stata, per secoli, un insieme composito che ogni giorno metteva in contatto tante lingue e tanti filoni culturali e li faceva dialogare
tra loro. Si può dire che l’Europa sia stata, proprio per questa ragione,
un naturale terreno di fioritura dell’ermeneutica, arte dell’interpretazione e della comprensione. L’Europa è stata e rimane la madrepatria
della traduzione perenne; nel corso di questo processo ha imparato a
rendere il dialogo tra idiomi culturali e linguistici efficace e proficuo
senza eclissare l’identità di nessuno […] Questa tradizionale capacità di
parlare/ascoltare, insegnare/apprendere, capire/farsi capire (in breve, di
tradurre) potrebbe essere sviluppata “estendendo l’idea di traduzione da
traduzione delle lingue a traduzione delle culture”. L’Europa può svolgere ancora un ruolo fondamentale nel concepimento, nella nascita e
nella maturazione di una comunità planetaria, facendo valere la propria
capacità di “traduttore del mondo”78.
L’identità europea, dinamica e aperta qual è, indica una capacità
più che una sostanza e in questo aspetto si riconosce la sua vocazione
universale. In quanto tale, non prende il posto di quella nazionale o
regionale, che restano un importante «capitale sociale»79 per le persone, ma vi si aggiunge, secondo la logica delle affiliazioni concorrenti
ben descritta da Sen come strategia per depotenziare i conflitti etnici:
Queste identità possono naturalmente includere l’elemento, comune a
chiunque, dell’appartenenza alla razza umana, ma anche le molte altre identità che tutti noi possediamo simultaneamente […] Nella nostra
vita di tutti i giorni, ci consideriamo membri di una serie di gruppi, e a
tutti questi gruppi apparteniamo. La cittadinanza, la residenza, l’origine
geografica, il genere, la classe, la politica, la professione, l’impiego, le
abitudini alimentari, gli interessi sportivi, i gusti musicali, gli impegni
sociali e così via discorrendo ci rendono membri di una serie di gruppi.
Ognuna di queste collettività, a cui apparteniamo, ci conferisce un’identità specifica. Nessuna di esse può essere considerata la nostra unica
Bauman, L’Europa è un’avventura, 90.
Amartya Sen: Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New York-London:
W.W. Norton & Company, 2006, tr. it. di Fabio Galimberti, Identità e violenza,
Roma-Bari: Laterza, 2008, 5.
78
79
64 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
identità […] Oltre a riconoscere la pluralità delle nostre identità e delle
loro diverse implicazioni, c’è l’esigenza, di fondamentale importanza,
di comprendere quale ruolo giochi la scelta nel determinare il peso e la
persuasività di identità specifiche, che sono inevitabilmente diverse80.
La consapevolezza e la capacità di scelta tra molteplici identità
concorrenti in contesti e in momenti differenti si rivelano, quindi, una
competenza sociale chiave per i soggetti collettivi e singolari, nell’attuale contesto culturale mondiale.
Ancora più promettente mi sembra l’immagine della Grande
Montagna balcanica, come la concepivano gli antichi e che la scienza
geografica non ha reso inutile. Una leggenda narra che, dall’alto della
sua cima, si potessero vedere il Mar Adriatico a ovest e il Mar Nero
a est. Subito gli scienziati si sono affrettati a smentire l’assurda creduloneria, privando il mondo moderno di una metafora straordinaria,
di grande efficacia ermeneutica. Chiedersi cosa si veda a partire dai
Balcani è l’unica possibilità per incominciare a osservarli davvero da
un altro punto di vista. Che da lì si scorgano, in lontananza, l’ovest
dell’Europa e l’est del Caucaso, ma anche il nord della Russia e il sud
del Mediterraneo, è il cuore della questione. Anche l’identità dell’Europa è una simile montagna
immaginaria, che ricorda il Monte Analogo descritto da René
Daumal:
Perché una montagna possa assumere il ruolo di Monte Analogo […] è
necessario che la sua cima sia inaccessibile, ma la sua base accessibile
agli esseri umani quali la natura li ha fatti. Deve essere unica e deve
esistere geograficamente. La porta dell’invisibile deve essere visibile81.
La montagna, nella sua valenza simbolica, è la porta accessibile
verso una realtà ideale, che deve resta inviolata e vuota, perché essa
sia preservata dal rischio di divenire una sostanza troppo concreta e
maneggiabile a piacere dagli uomini.
80
Ivi, 5, 6.
René Daumal: Le Mont Analogue, Paris: Gallimard, 1952, tr. it. di Claudio
Rugafiori, Il Monte Analogo, Milano: Adelphi 1992, 17.
81
La Europa de Miguel de Unamuno
El conflicto como camino
hacia un nuevo humanismo
Natalia Rodríguez Martín
In the context of the current proliferation of a protectionist and xenophobic nationalism in Europe, the United States and the rest of
the world, this article aims to analyze Unamuno’s ideas of an europeanization of Spain and an hispanization of Europe like two facets
of the same cultural and political dialectic (this opposed to various
interpretations of Unamuno’s thinking). This theory is used as a
model to deal with the relations between national cultures as well as
every nation relations with supranational communities. Within this
context, imposition plays a central role, in so far it brings to the development of solidarity within the conflict, which is why Unamuno’s
theory leads to a humanism which only can emerge in the encounter
between human beings and cultures.
El nacimiento y resurgimiento de partidos xenófobos nacionalistas
como Alternative für Deutschland en Alemania o el Front National de
Marine Le Pen en Francia, así como la victoria de Trump en Estados
Unidos, plantean la necesidad de una nueva reflexión sobre la identidad europea. Para hacer frente a estos discursos, no es suficiente
con acusar a sus portavoces de populistas o xenófobos, sino que es
necesario recordar cuáles son las razones por las que la convivencia pacífica entre culturas y naciones y la aceptación del extranjero
nos parece la respuesta más adecuada a los conflictos que plantea la
globalización.
66 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
El encuentro entre naciones que se da dentro de la Unión Europea
nos enfrenta a la pregunta sobre cómo conservar el carácter propio de
cada nación y a la vez convivir en un espacio de valores comunes y
de comprensión. Si los estados pasan a ser englobados en una entidad política y económica de mayor calado, ¿cuál debe ser la relación
que debe darse con esta?, ¿cómo redefinir la identidad nacional en un
contexto de intercambio cultural entre naciones y de reivindicaciones
soberanistas? En el contexto de la literatura española encontramos
apasionadas reflexiones sobre el tema, algunas incluso de una actualidad insospechada. Un lugar eminente lo ocupan las de Miguel de
Unamuno (1864-1936), filósofo y literato español que, como tantos
otros de su generación, dedicó algunos de sus libros y artículos a la
cuestión de Europa, desarrollando agudos análisis que aún resultan
vigentes en los debates contemporáneos.
En España, la necesidad de definirse en relación a Europa es
algo que se ha dado de forma continua en la historia. Así lo muestra
Gumbrecht en su ensayo For a History of Spanish Literature “Against
the Grain”:
Spanish history might be written by employing typical sequences and
structures from the development of Central European societies as a background whose application to Spanish society helps to define its identity
in terms of differences and resemblances with the histories of Central
European societies1
España ha sido definida, pues, o bien por su carácter único (“Spain
is different”) o bien por su similitud al resto de países europeos y su
pertenencia a esta comunidad cultural e intelectual.2 Hay, por lo tanto,
1
Hans Ulrich Gumbrecht: “For a History of Spanish Literature “Against the
Grain””, in New Literary History. A Journal of Theory and Interpretation, XI, 19791980, 279.
2
«There are two current models employed for presenting the identity of this society.
Until recently, the official motto was “España es diferente”. Though it also served for
tourist propaganda, its primary function was to legitimate the denial of those democratic rights that are self-evident in other societies. […] Beside this, there is the -till
recently always progressive- condition that Spain is “just like the countries of Central
Europe”. This motto could be used for justifying plans for grafting onto Spanish society those political orders which have allegedly been successful in Central Europe».
Ibid., p. 279.
Natalia Rodríguez Martín - La Europa de Miguel de Unamuno 67
una tensión entre el intento de asimilación al contexto europeo y la
necesidad de diferenciarse y de definir la propia nación en contraste
con Europa. Esta necesidad de definición se hace patente sobre todo
en el contexto de las crisis, puesto que en ella se pone en juego, más
allá del sistema económico, la estructura total de la sociedad y su
disposición a la hora de enfrentar transformaciones.
En el presente artículo proponemos un acercamiento al pensamiento de Unamuno, pues este profundiza en la tensión entre la necesidad de definir a España por su carácter propio y la necesidad de
modernización en España a través de la inclusión de las ideas y el
progreso europeos. Esta tensión se ha reducido en algunas de las interpretaciones de su obra a dos conceptos: la europeización de España
y la españolización de Europa. Así, el pensamiento de Unamuno se
interpreta como marcado por dos movimientos: uno que cede a la
admiración de la modernización europea y ve con buenos ojos una
mayor influencia de Europa en el pensamiento y la vida españolas,
y otro movimiento contrario, tardío en su obra, en el que se reclama
una recuperación del carácter español – castizo – y quiere alejarse
de la ciencia y la modernización europeas. En este artículo proponemos una tesis distinta, también defendida por otros estudiosos de
Unamuno3: que europeización y españolización son dos caras de la
misma moneda y que la propuesta de Unamuno es, en el fondo, siempre la misma: la lucha entre culturas y nacionalidades por la imposición de un carácter sobre otro, para llegar así a su regeneración .
Empezaremos este artículo, no obstante, aclarando cuál es el
contexto en el que surge el pensamiento de Unamuno e intentando
mostrar a su vez las similitudes con la situación actual en Europa.
Después pasaremos a mostrar qué entiende Unamuno bajo europeización y españolización y cómo estos dos conceptos surgen de una teoría más general de la imposición entre regiones, para después señalar
una correspondencia entre esta y el análisis antropológico presentado
en Del sentimiento trágico de la vida. Más adelante, mostraremos
qué se entiende exactamente por imposición y cómo se delimita este
concepto con los de guerra e invasión. Para acabar, recuperaremos
las ideas anteriores para mostrar que la dominación lleva, según
Unamuno, a la solidaridad, mostrando así que lo que se esconde bajo
Cfr José María Beneyto, Tragedia y razón. Europa en el pensamiento español del
siglo XX, Madrid: Taurus, 1999.
3
68 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
su teoría se puede entender también como un encuentro entre culturas
que no tiene por qué ser entendido como choque entre civilizaciones.
Crisis y ambigüedad
La pérdida en 1898 de las colonias de Filipinas, Puerto Rico y Cuba
desató una crisis en España en relación a su necesidad de modernizarse y dejar atrás antiguos modelos, como el del caciquismo o el colonialismo, para entrar así en una nueva época de progreso y mejora
social. Este ambiente de crítica social y política influyó a la mayoría
de autores del momento, que han sido posteriormente agrupados bajo
la denominación de ‘Generación del 98’, a la cual pertenecen escritores como Antonio Machado, Ramiro de Maeztu o el que aquí nos
ocupa, Miguel de Unamuno. Todos ellos quisieron reflejar en sus escritos la coyuntura en la que se encontraba España, fuera a través de
descripciones de la vida y del paisaje castellano, como en Campos de
Castilla, o con propuestas concretas ante el problema nacional, como
en la Defensa de la Hispanidad de Maeztu.
Miguel de Unamuno se ocupa del problema de la identidad de
España en una colección de cuatro ensayos titulada En torno al casticismo. En ella, Unamuno describe la situación en España de la siguiente manera:
Atraviesa la sociedad española honda crisis; hay en su seno reajustes
íntimos, vivaz trasiego de elementos, hervor de descomposiciones y recombinaciones, y por de fuera un desesperante marasmo. En esta crisis
persisten y se revelan en la vieja casta los caracteres castizos, bien que
en descomposición no pocos.4
‘Marasmo’ podría definirse aquí como inmovilidad, y precisamente de eso es de lo que acusa Unamuno a la sociedad española: no
hay una respuesta social ni política ante la crisis, España debe reajustarse y recomponerse pero no actúa, es un país paralizado.
Miguel de Unamuno, “En torno al casticismo” en Obras completas, Vol. IX,
Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2009, 179.
4
Natalia Rodríguez Martín - La Europa de Miguel de Unamuno 69
Para entender qué propone Unamuno en En torno al casticismo,
hay que prestar especial atención a sus primeras páginas, en la que el
autor nos advierte de que el método que va a usar en su texto no es el
de la “exclusión de extremos”, es decir, la presentación de la verdad
a partir del enfrentamiento entre dos pensamientos contrarios, de los
cuales uno es refutado, sino que:
Es preferible, creo, seguir otro método, el de afirmación alternativa de
los contradictorios; es preferible hacer resaltar la fuerza de los extremos
en el alma del lector para que medio tome en ella vida, que es resultante
de lucha. Tenga, pues, paciencia cuando el ritmo de nuestras reflexiones
tuerza a un lado, y espere a que en su ondulación tuerza al otro y deje
se produzca así en su ánimo la resultante [...] ello da ocasión a que el
lector colabore conmigo, corrigiendo con su serenidad el mal que pueda
encerrar tal procedimiento rítmico de contracciones.5
Así pues, Unamuno no nos va a presentar los argumentos de forma ordenada y dejando claro cuál es su postura hacia ellos, sino que
quiere que los pensamientos contradictorios luchen dentro del mismo
texto y que el lector sea activo, dilucidando junto con el autor cuáles
son los argumentos ganadores de la batalla. Con Unamuno va intrínseca una ambigüedad que no es indiferencia o indefinición, sino puro
método: enfrentando contrarios, oponiendo ideas es como se puede
llegar a la verdad.
Esta misma técnica es la que aplica Unamuno en su intento de
pensar una posible regeneración de España: “Para hallar la humanidad en nosotros y llegar al pueblo nuevo conviene, sí, nos estudiemos,
porque lo accidental, lo pasajero, lo temporal, lo castizo, de puro sublimarse y ocultarse se purifica destruyéndose”.6 Primero, Unamuno
quiere dar con la definición de qué es lo propiamente castizo, es decir,
lo español, lo castellano, para después destruirlo en un intento por
llegar a la idea de humanidad. Esta destrucción es entendida como
regeneración del carácter castizo y se puede lograr enfrentando lo
castizo a la “ducha”7 europea, es decir, a la entrada de la moderniza-
Ibid., 66ss.
Ibid. 87.
7
Ibid. 196.
5
6
70 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
ción proveniente de Europa a España. Llegamos así, pues, al tema de
la europeización de España.
¿Europeización de España o españolización de Europa?
Sobre la dominación
Unamuno resume las intenciones de su texto al final del cuarto ensayo, “Sobre el marasmo de España”, donde denuncia claramente “que
la miseria mental de España arranca del aislamiento en que nos puso
toda una conducta cifrada en el proteccionismo inquisitorial que ahogó en su cuna la Reforma castiza e impidió la entrada a la europea”.8
El aislamiento respecto a Europa y el proteccionismo se ven, pues,
como un freno a la evolución cultural e intelectual. Según el filósofo
bilbaíno, es precisamente la apertura al exterior lo que puede permitir
la regeneración cultural de España, su salida de la inmovilidad:
que sólo abriendo las ventanas a vientos europeos, empapándonos en el
ambiente continental, teniendo fe en que no perderemos nuestra personalidad al hacerlo, europeizándonos para hacer España y chapuzándonos en pueblo, regeneraremos esta estepa moral. 9
La europeización consiste, pues, en dar entrada a lo de fuera para
volver a uno mismo. En este sentido, dice Unamuno: “con el aire de
fuera regenero mi sangre, no respirando el que exhalo”10, puesto que
respirar el mismo aire que se exhala sólo podría llevar al ahogamiento, al marasmo. La europeización no se refiere a una simple asimilación de todo aquello que ya se da en Europa y que es consecuencia de
la avanzada industrialización o de su prolífica actividad cultural, sino
a un ideal según el cual para la perfección de un pueblo es necesaria
la asimilación de los otros: “Un pueblo perfecto ha de ser todos en
él y él en todos, por inclusión y paz, por comunión de libre cambio.
Sólo así se llega a ser un mundo perfecto […] abriéndose lleno de fe
al progreso, que es la gracia humana, dejando que su corriente de-
Ibid. 199.
Ibid.
10
Ibid.
8
9
Natalia Rodríguez Martín - La Europa de Miguel de Unamuno 71
posite en nuestro regazo su sustancioso limo.”11 Los encuentros con
otros pueblos y culturas van dejando estratos sobre la propia, creando
así un terreno fértil y sirviendo de abono para las nuevas ideas. Estas
palabras, interpretadas a la ligera, pueden sonar a relativismo cultural
o incluso a cierta ingenuidad por parte del autor, puesto que parecen defender una convivencia pacífica de culturas, en las que éstas se
mezclan y entrelazan de forma natural. Sin embargo, para Unamuno
la regeneración sobre todo se da a través de la imposición y de la
invasión. Un ejemplo de esto lo encontramos en un texto referido al
“barbarismo”, palabra que no tiene un sentido negativo:
inconcientemente [sic], suponemos que hay algo de barbarie en el barbarismo, que la invasión de éstos lleva a nuestra lengua a la barbarie,
sin recordar […] que la invasión de los bárbaros fue el principio de la
regeneración de la cultura europea ahogada bajo la senilidad del imperio
decadente.12
La invasión bárbara no es, pues, algo negativo, sino una oportunidad para mejorar, tomando de los invasores aquello que puede
volver a dar vida a una cultura ya moribunda. Podríamos considerar
este fragmento como el primer atisbo de una teoría que Unamuno irá
desarrollando más tarde en tres pequeños ensayos: Crisis del patriotismo español (1905), La crisis actual del patriotismo español (1905)
y Más sobre la crisis del patriotismo español (1906); así como también en su famosa obra filosófica Del sentimiento trágico de la vida
(1913) y en el ensayo de 1906 que ha llevado a algunos críticos a
hablar de un giro en Unamuno hacia la españolización de Europa:
Sobre la europeización (Arbitrariedades). Se trata de una teoría que
propone que “las únicas uniones fecundas son las que se hacen sobre
un fondo, no ya de diferencia, sino de oposición.”13
Es en este marco teórico en el que se inserta tanto su propuesta
de europeización como la posterior defensa de la españolización de
Europa, consistiendo ambas, pues, en una propuesta de encuentro o,
Ibid. 171.
Ibid. 77.
13
Miguel de Unamuno, “La crisis actual del patriotismo español”, en Obras completas, Vol. IX, op. cit., 839.
11
12
72 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
más concretamente, de enfrentamiento entre estas culturas, para darles así nueva vida a ambas. Precisamente en Sobre la europeización
(Arbitrariedades) encontramos un fragmento en el que se presenta
esta teoría unamuniana, donde primero se dice: “mucho hay, sin duda,
en la cultura europea moderna y en el espíritu moderno europeo que
nos conviene recibir en nosotros para convertirlo en nuestra carne”,
pero más adelante se añade:
Tengo la profunda convicción [...] de que la verdadera y honda europeización de España, es decir, nuestra digestión de aquella parte del espíritu
europeo que pueda hacerse espíritu nuestro, no empezará hasta que no
tratemos de imponernos en el orden espiritual a Europa, de hacerles tragar lo nuestro, lo genuinamente nuestro, a cambio de lo suyo, hasta que
no tratemos de españolizar a Europa.”14
Mientras que en las primeras líneas Unamuno sigue apostando
por la recepción de la cultura europea, luego muestra que no es posible su auténtica asimilación sin antes lograr la españolización de
Europa. Vemos así como lo que se esconde en la idea de recepción y
apertura es más bien la propuesta de dominio, un dominio que nos
aleja de una idea superficial de concordia en el intercambio cultural entre naciones. En este contexto, cabe preguntarse cómo entiende
Unamuno esta dominación o imposición y qué papel juega en ella la
violencia.
Invasión y progreso
¿Afirma Unamuno en sus escritos un espíritu belicista? Si lo que
mantiene vivos a hombres y culturas es su intento de imponerse a
los otros, ¿cómo hablar de humanidad o de paz? La solución a estos conflictos la da el mismo Unamuno cuando presenta la lucha y
el conflicto como medio para llegar a la humanidad, es decir, para
descubrir aquello que es igual en todos los hombres: “Cuanto más se
diferencien los pueblos, más se irán asemejando, aunque esto parezca
forzada paradoja, porque más irán descubriendo la humanidad en sí
Miguel de Unamuno, “Sobre la europeización (Aribtrariedades)”en Obras completas, Vol. IX, 1014.
14
Natalia Rodríguez Martín - La Europa de Miguel de Unamuno 73
mismos.”15 Justamente al intentar imponerse, resaltando sus diferencias y oponiendo sus caracteres, es como los pueblos verán qué es
aquello común, es decir, la humanidad universal que se esconde tras
su particularidades. No olvidemos que lo que le interesa a Unamuno
es encontrar la tradición eterna, el universal común a todos los hombres particulares, aquello que él llama el “sustento al perpetuo flujo de
las cosas”16, “el fondo del ser del hombre mismo”17.
Así pues, la lucha,de la que habla Unamuno tiene un objetivo
noble e incluso lleva a fomentar la solidaridad: “Hay que luchar y luchas de veras, y buscar sobre la lucha, y merced a ella, la solidaridad
que a los combatientes une. Se entienden mucho mejor las personas y
los pueblos, y están más cerca de llegar a un cordial acuerdo, cuando
luchan leal y sinceramente entre sí”.18
En el nivel antropológico, no sólo pone el pensador español el
conocimiento como condición necesaria de este tipo de la lucha noble
por la dominación, sino también el amor, puesto que “amar al prójimo es querer que sea como yo, que sea otro yo, es decir, es querer yo
ser él”.19 Para esta peculiar concepción del amor, Unamuno parece,
por un lado, partir de la idea de amor divino, en tanto que Dios crea
al hombre a su imagen y semejanza; por otro lado, el autor bilbaíno
entiende el amor como deseo de perpetuación.20 Lo contrario al amor
sería para él el egoísmo, que consiste en querer mantenerse siendo lo
que uno es, buscando una conservación del yo que exige cerrarse ante
el otro, en lugar de “tratar de perennizarse dándose”.21 Si un hombre
o un pueblo son generosos, querrán darse a los otros.
La invasión y la dominación se convierten así en deberes nacidos
del amor, de la fraternidad y la solidaridad entre pueblos, puesto que
lo natural –una vez fuera del egoísmo – es valorar lo propio y querer
La crisis del patriotismo, op. cit., 364.
Ibid, 79.
17
Ibid, 82.
18
Miguel de Unamuno, “La crisis actual del patriotismo” en Obras completas, Vol.
IX, 839.
19
Miguel de Unamuno, “Del sentimiento trágico de la vida” en Obras completas,
Vol. X, Madrid, Fundación Antonio de Castro, 2009, 495-496.
20
Es clara la relación entre esta concepción del amor y el deseo unamuniano de
inmortalidad, que supera el marco de este artículo y por eso sólo puede ser aquí
nombrado.
21
Miguel de Unamuno, “Del sentimiento trágico de la vida”, op. cit., 500.
15
16
74 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
entregarlo a los otros. Esta visión presupone, no obstante, que la total
igualdad entre regiones o nacionalidades no es posible y que siempre
habrá algunas superiores en unos aspectos e inferiores en otros. En
este sentido “el deber de amor fraternal entre los pueblos es tratar
cada uno de imponer a los otros lo que siente ser su superioridad y
resistir el que se le imponga una que siente inferioridad en cualquier
respecto.”22 Partiendo de la desigualdad entre estados sí es posible
ver la dominación como algo positivo, en tanto que permite llevar a
otros lugares las superioridades de un país, mientras que las del país
invadido pueden ser mantenidas. Se trata, pues, de una lucha entre
cosmovisiones o valores distintos que lleva a un intercambio, en tanto
que lo superior siempre vence sobre lo inferior o peor.
Unamuno considera que hay una gran variedad de modos de dominar. La pasividad del acomodarse a un nuevo modo de vida o incluso el haber sido vencido, o parecerlo, pueden ser muchas veces
formas de dominar al otro.23 Ahora bien, no hay que confundir esta
teoría de la dominación con una apología de la guerra, a pesar de
que en Del sentimiento trágico de la vida encontremos fragmentos
como este: “La guerra es escuela de fraternidad y lazo de amor; es la
guerra la que, por el choque y la agresión mutua, ha puesto en contacto a los pueblos, y les ha hecho conocerse y quererse.”24 A pesar de
estas palabras, Unamuno no es un belicista. En un texto escrito bajo
la influencia de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial,
¡Guerra a la guerra! se afirma que la guerra quizá es elemento de
progreso en minúscula, pero no de Progreso y además afirma que no
puede defenderse la guerra, en tanto que esta siempre trae muerte.25
Podemos deducir de ello que cuando en otras obras habla de guerra,
no se refiere principalmente al enfrentamiento bélico, sino a la guerra
entendida como el pólemos de Heráclito, una armonía entre dos contrarios. Esta es también la interpretación que propone García Mateo26,
Miguel de Unamuno, “Más sobre la crisis del patriotismo” en Obras completas,
Vol. IX, op. cit., 911.
23
Miguel de Unamuno, “Del sentimiento trágico de la vida”, op. cit., 498.
24
Ibid, 487.
25
Miguel de Unamuno, ¡Guerra a la guerra! Mundo Gráfico, año II, número 59,
diciembre de 1912.
26
Rogelio García Mateo, La dialéctica de Unamuno. Ni Hegel ni Kierkegaard:
Particularidad de su pensamiento, María Dolores Gómez Molleda (Ed.): Actas del
Congreso Internacional Cincuentenario de Unamuno, 1989, 475-478.
22
Natalia Rodríguez Martín - La Europa de Miguel de Unamuno 75
que hace referencia a la famosa sentencia: “La guerra es el padre de
todas las cosas”.
¿Retomar a Unamuno para pensar Europa?
Las propuestas de Unamuno presentan algunos puntos débiles. Por
un lado, su teoría de la imposición entre regiones y naciones es un
pensamiento que puede ser fácilmente malinterpretado o incluso
manipulable. Si el resultado de la lucha es el único criterio para la
conservación y promoción de ciertos valores culturales o nacionales,
¿qué protección nos queda ante el totalitarismo? Si bien Unamuno
no vio el alcance de los estragos del fascismo en Europa, puesto que
murió durante los primeros meses de la guerra civil española, hoy no
podemos evitar este cuestionamiento. Unamuno no nos protege del
racismo ni del populismo nacionalista -peligros que hoy en día crecen
en la sociedad global- en tanto que para este pensador es la victoria
del más fuerte – aunque a veces la fortaleza consista en parecer vencido – lo que decide la supervivencia cultural.
Sin embargo, la idea unamuniana de una lucha noble sí permite
combatir la idea nacionalista conservadora y proteccionista de una
nación cerrada que debe protegerse ante lo extraño.
Unamuno nos permite ver que una tradición o una nación que
no está en contacto con otras y se aísla está condenada a una muerte
en vida. Igual que llamamos lenguas muertas a aquellas que ya no
tienen hablantes maternos, a las que no cambian porque ya no están
en contacto con otras y han quedado inmóviles con sus gramáticas y
léxicos fijados, podríamos hablar con Unamuno de culturas y naciones muertas, aquellas que se cierran sobre sí mismas e intentan vivir
sin influencia de lo exterior. El encuentro con lo otro, con lo distinto,
es un impulso o acicate a lo propio, que puede revalorizarse y crecer a
partir de este acontecimiento. Así, cada nación o cultura va recibiendo de las otras un resto, un poso que sedimenta. Y es justamente la
continua superposición de capas lo que hace fructíferas a las naciones
y a las culturas.
El encuentro con el otro, el entendimiento con el francés, el alemán o el italiano sólo puede darse si primero evidenciamos todo aquello que queremos imponerle, si, más allá o más acá de todas las capas
nacionales, culturales o ideológicas, logramos mostrar lo humano en
76 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
nosotros. Esto se entiende si remitimos a la idea unamuniana de espíritu colectivo, un espacio común que comparten todos los hombres
en el que se encuentran sus sentimientos, deseos y aspiraciones, que
quizá no tienen la misma forma, pero están hechos del mismo material. Respecto a esta colectividad nos dice “En torno al casticismo”:
“En esa muchedumbre que no ha oído hablar de nuestros literatos de
cartel hay una vida difusa y rica, un alma inconciente en ese pueblo
zafio al que se desprecia sin conocerle”. Y añade:
Cuando se afirma que en el espíritu colectivo de un pueblo (...) hay algo
más que la suma de los caracteres comunes á los espíritus individuales
que le integran, (...) se afirma la existencia de un nimbo colectivo (...)
que no hay pensamiento alguno individual que no repercuta en todos
los demás, aun en sus contrarios, que hay una verdadera subconciencia
popular. El espíritu colectivo, si es vivo, lo es por inclusión de todo el
contenido anímico de relación de cada uno de sus miembros.27
El humanismo que propone Unamuno y que aquí queremos recuperar, es uno que no busca ideas universales preestablecidas ni definiciones reduccionistas de lo humano, sino que va al encuentro del otro
para ver en él lo que uno también es y que sin ese encuentro no podría
volverse patente.
Miguel de Unamuno, “En torno al casticismo”, op. cit., 195-196.
27
Morfogenesi dell’Europa:
guerra e potere
La violenza secondo Hannah Arendt
Laura Sanò
With reference to the twentieth century wars, in her writings Hannah
Arendt gives a definite answer, both from historical and ontological
viewpoint, to the question regarding the roots of the violence and the
relationship between violence and power. The origins of Europe, as
a distinguished reality, having a specific identity and well defined
boundaries, has been a war – the first war in the history of mankind,
e.g. the war of Troy. The birth of Europe corresponds to its destiny
– to be always on the path of sunset. Nevertheless, the innovations
occurred in the same nature of war in itself, during the twentieth century, and mainly the tragedy of the Holocaust, tied with the possibility of a nuclear war, deeply changed the traditional way of thinking
of war. According to Arendt, nowdays we must recognize a sharp
discontinuity in the meaning of war, as regard to the whole western
philosophical tradition, from Heraclitus and Plato up to Carl Schmitt.
1.
I primissimi documenti letterari e mitologici, volti a ricostruire il processo storico che ha portato alla definizione dell’Europa come realtà
culturalmente determinata, convergono nel segnalare come inizio di
quel processo un atto di violenza, e più specificatamente una commistione di inganno e sopraffazione. Si narra, infatti, che la bellissima e
giovane Europa venne rapita da Zeus, mentre giocava spensierata sulla spiaggia con altre fanciulle. Nascosto dietro le sembianze seducenti
78 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
e apparentemente innocue di un toro bianchissimo, il re dell’Olimpo
la condusse sulla sua groppa al di là del mare, per poi possederla. È lo
stesso Apollodoro a raccontarci l’accaduto in questi precisi termini:
«di Lei (Europa)», scrive, «si innamorò Zeus: prese la forma di un
toro mansueto, che emanava un profumo di rose, se la fece salire in
groppa e la trasportò per mare a Creta. Qui si unì a lei».1
Altre fonti raccontano invece di una differente genesi di Europa,
anche se il contesto a cui esse rimandano è sempre caratterizzato dalla presenza della violenza. Secondo questa ricostruzione mitologica,
Europa, mentre giaceva serena nella sua stanza del palazzo reale, aveva fatto un sogno: si trovava fra due donne, una era l’Asia, l’altra era
la terra che le stava di fronte, e che ancora non aveva un nome: «le
due donne si battevano con violenza, per lei. Ciascuna la voleva per
sé. L’Asia sembrava a Europa una donna del suo stesso paese; l’altra
era per lei una totale straniera. E la straniera, alla fine, con mani possenti, la trascinava via».2
In tutte le fonti del mito pervenuteci, la genesi di Europa viene
comunque sempre attribuita ad un gesto ingannevole e violento, il
primo di una serie infinita di discordie e vendette che daranno corso
alla contrapposizione, mai conclusa, tra Est ed Ovest. Se ne può concludere che Europa è innanzitutto il nome di un’identità assoggettata
alla violenza che deve la sua nascita ad un grande evento bellico.3 La
guerra di Troia, narrata nell’Iliade, è la più antica guerra di cui ci è
pervenuta testimonianza scritta. Si è trattato di una svolta epocale da
cui è conseguita la distinzione netta tra Asia ed Europa, al punto che
non è azzardato sostenere che la demarcazione dei confini dell’Occi
Apollodoro: I miti greci, Milano: Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 2008,
III, 1, 2-5. Ma la medesima testimonianza ci perviene da Ovidio nelle Metamorfosi,
in cui si parla di Europa nei termini di una fanciulla ingenua sedotta dalla subdola
astuzia del dio: «Osò la regale fanciulla, senza sapere su cui mai gravasse, assettarsi
sulla schiena del toro: quand’ecco il dio, senza parere, dalla terra, dalla asciutta arena,
pone dapprima le contraffatte orme nelle onde marine, poi procede oltre e reca la sua
preda attraverso i flutti nell’alto mare» (Ovidio: Metamorfosi, II, 864-874).
2
Per la ricostruzione di questa versione del mito si veda Roberto Calasso: Le nozze di Cadmo e Armonia, Milano: Adelphi, 1988, 17. Riprendo qui alcune illuminanti
suggestioni di Massimo Cacciari: Geofilosofia dell’Europa, Milano: Adelphi, 1994.
3
Cfr. A.a. V.v: Geofilosofia, Sondrio: Lyasis, 1996. Per un approfondimento sulla
genesi di Europa e il suo rapporto con la guerra rimando alla ricostruzione proposta
da Umberto Curi: Pensare la guerra, Bari: Dedalo, 1999, 9-34.
1
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 79
dente, come identità politica e culturale, sia la conseguenza dei principi espressi da quella guerra.
L’atto generativo di Europa, ciò che ad essa ha potuto conferire
una dimensione di realtà distinta, dotata di precisi confini e di una
peculiare identità, è dunque una guerra. Un atto con il quale essa ha
in un qualche definito anche il suo destino.
Infatti, l’Europa si è caratterizzata in ogni tempo per il ripresentarsi continuo di lotte e guerre. Di qui, come sottolinea Karl Jaspers, un
aspetto che marchia in maniera inconfondibile la specificità dell’Europa: il suo essere «sempre e di continuo sull’orlo del tramonto».4
Jaspers indica due aspetti peculiari dell’Europa: da una lato la sua
connaturata propensione alla guerra, dall’altra l’identificazione con
l’Occidente, e dunque letteralmente con il tramonto, l’Occaso.5
Quale sia la funzione e al tempo stesso la capacità morfogenetica della guerra, lo spiegano perfettamente i filosofi antichi. Secondo
Eraclito «la guerra è comune e la giustizia è conflitto, e tutto accade
secondo contesa e necessità».6
Come sottolinea Vernant, la guerra, e quindi la violenza, costituiva per le città greche la condizione normale delle relazioni politiche.
Una presenza del tutto naturale e necessaria, che andava a confondersi con il regolare svolgimento della vita. La guerra non era soltanto
l’essenza stessa della vita, ma era anche l’espressione della stessa politica, si identificava con la città, poiché il guerriero coincideva con
il cittadino. 7
Platone, d’altra parte, dimostra chiaramente di intendere la guerra
come una condizione fondamentale per mantenere l’ordine all’interno
della polis. Ben lungi dall’essere considerata un elemento negativo, la
guerra si rende invece necessaria all’attività di ogni governo e quindi
Karl Jaspers: Wahrheit und Bewährung. Philosophieren für die Praxis,
München: Piper, 1983, tr. it. di Giancarlo Russo e Gaetano Rametta, Verità e verifica.
Filosofare per la prassi, Brescia: Morcelliana, 1986, 125 e ss.
5
Cfr. Umberto Curi: Pensare la guerra, 22. Cfr. Agostino Carrino, Oltre l’Occidente: critica della Costituzione europea, Bari: Dedalo, 2005, 204 e ss.
6
Eraclito, B 114, in H. Diels e W. Kranz: I presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di G. Giannantoni, Bari: Laterza, 1969, I, 213.
7
Cfr. Jean-Pierre Vernant: Mythe et société en Grece ancienne, Paris: François
Maspero, 1974, tr. it. di Pasquale Pasquino e Letizia Barrini Pajetta, Mito e società nell’antica Grecia, Torino: Einaudi, 2007, 43-44; cfr. inoltre Id. (a cura di),
Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Paris-La Haye: Mouton & Co.,1962.
4
80 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
indispensabile per l’arte politica. A differenza della pace, che riguarda
più che altro l’interesse del singolo individuo, la guerra è ineliminabile e necessaria, e si fa carico del bene della comunità.8 Nel Protagora
Platone riconosce una correlazione strettissima tra città (pólis), guerra (pólemos) e politica (politiké téchne), termini che, anche sul piano etimologico, condividono la medesima radice indeuropea -ptol.9
Affermando inoltre, che il pólemos (guerra) è méros10 della politica,
Platone non indica soltanto che la guerra è “parte” della politica, ma
piuttosto che la guerra è ad essa così connaturata da rappresentarne lo
stesso destino.11 Se ne può evincere che, secondo Platone, la “guerra
è destino della politica”.12
8
Si può comprendere, pertanto, per quali motivi di fondo Platone, nella
Repubblica (Platone: “Repubblica”, in Le Opere, Roma: Newton, 2005, IV, 394c
– 399a, (27-531), 145-155), affermi che i guardiani (oi phylakes), definiti come “artefici della libertà cittadina”, debbano essere lodati come uomini valorosi proprio
in virtù delle loro capacità guerriere. Queste capacità, secondo il filosofo, non sono
riducibili «banalmente al valore militare genericamente inteso, ma che comunque
egli vede emergere proprio nelle azioni di guerra e in ogni altra prassi violenta: […]
guerra e violenza fanno parte della storia della polis e costituiscono conseguentemente una delle possibili misure del valore dell’uomo» (Francesco D’Agostino: Bia,
Milano: Giuffrè Editore, 1983, 10). Questo perché in guerra emergono qualità non
solo tecniche, ma anche una serie di qualità morali, come il coraggio, il valore, l’eroismo, l’amore per la patria, la costruzione di idealità importanti, l’identificazione
in identità gloriose (cfr. Pierre Ducrey: Guerre et guerriers dans la Grèce Antique,
Paris: Hachette, 1978; Victor Davis Hanson : Le Modèle occidental de la guerre. La
bataille d’infanterie dans la Grèce classique, Paris: Les Belles Lettres, 2004).
9
Per un approfondimento cfr. Gianni Baget Bozzo: Della guerra, Venezia:
Arsenale cooperativa editrice, 1982,78.
10
Gli uomini, sostiene Platone, con i soli doni forniti da Prometeo, «non possedevano ancora l’arte politica, di cui l’arte della guerra è parte», e quindi erano destinati
all’estinzione (Platone: “Protagora”, in Le Opere, III, 322b, (248-341), 277).
11
Aldo Magris (in L’idea di destino nel pensiero antico, Udine: Del Bianco
Editore, 1984, 41-42) a proposito del termine greco moira scrive: «Il nome usato
più frequentemente nella cultura greco arcaica per designare la divinità del destino
è Moira. Sennonché, in greco, questo vocabolo è anche un sostantivo che significa
“parte” o “porzione” di una qualsiasi cosa, e come tale lo si ritrova nel linguaggio
ordinario. […] L’esperienza della guerra favorisce una mentalità per cui la morte sul
campo, rischio tanto inevitabile quanto imprevedibile, non giunge se non quando una
misteriosa logica non ne abbia decretato il momento opportuno. Sicché ad ognuno
appartiene la propria morte…».
12
Questo è quanto sostiene Umberto Curi nell’analisi del concetto di guerra proposta in Polemos. Filosofia come guerra, Torino: Bollati Boringhieri, 2000; cfr. anche Id.: Il farmaco della democrazia. Alle radici della politica, Milano: Marinotti,
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 81
L’individuazione del rapporto di mutua continuità tra l’ambito
della politica e quello della guerra non è certamente appannaggio della cultura moderna. Non è necessario riferirsi a Clausewitz per riconoscere che la «guerra è la continuazione della politica con altri mezzi»,13 né tantomeno ci si deve attenere a quanto sostiene Carl Schmitt
quando dice che «la guerra non è scopo o meta o anche solo contenuto
della politica, ma ne è il presupposto, sempre presente come realtà».14
L’idea della strettissima connessione fra questi due ambiti risale, al
contrario, alla tradizione della cultura occidentale. Si può addirittura
sostenere che non vi sia, in realtà, una corrente teorico-filosofica che
abbia avuto rilievo nella storia, che non abbia riconosciuto il significativo intreccio fra guerra e politica.15
Nei confronti della violenza, o meglio ancora, per usare l’espressione di Tucidide,16 “della guerra come maestra di violenze” (biaios
didaskalos), il mondo greco non ha, dunque, mai assunto un atteggiamento di rifiuto pregiudiziale, né tantomeno di condanna moralistica.
Innanzitutto, la prima considerazione su cui vale la pena riflettere è
che la violenza, fin dalle origini della nostra tradizione occidentale,
2003, 43 e ss. Curi sostiene che lo stesso termine impiegato da Platone nel Protagora
per indicare il rapporto fra guerra e politica, vale a dire méros, oltre che più letteralmente come parte, in quanto riconducibile al verbo méiromai, da cui viene móira,
può essere tradotto come “parte assegnata”, e dunque appunto come destino.
ia pure muovendo da una prospettiva diversa su questa prospettiva concorda
Francesco D’Agostino: Bia.
S
Karl Von Clausewitz: Della guerra, tr. it. di Ambrogio Bollati ed Emilio
Canevari, Milano: Mondadori, 1997, 38. Come è risaputo, secondo Clausewitz la
guerra va considerata come la reazione violenta di due volontà animate da un’intenzione ostile; essa è dunque un atto di violenza senza limiti dove ciascuno dei due
avversari è pronto ad arrivare all’estremo pur di raggiungere i propri obiettivi. Tali
obiettivi hanno a che fare sempre con il potere e la politica e infatti la teoria della
violenza bellica di Clausewitz è famosa soprattutto per un aspetto, riassunto nella
nota affermazione secondo la quale «La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è dunque, solamente un atto politico, ma un vero
strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione
con altri mezzi» (ibidem).
14
Carl Schmitt: Le categorie del «Politico», Bologna: il Mulino, 1972, 193.
15
Cfr. Jean Pierre Vernant (a cura di): Problèmes de la guerre en Grèce ancienne; per una riflessione sul nesso guerra-politica si è tenuto costantemente presente il volume di Umberto Curi: Pensare la guerra, a cui rimando per ogni ulteriore
approfondimento.
16
Tucidide: Le Storie, Torino: Utet, 1982, III, 82, 2.
13
82 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
appare costantemente come compagna inseparabile del potere. Nella
maggior parte delle raffigurazioni mitologiche antiche, il potere e la
violenza, compaiono infatti insieme, fedeli paredri di Zeus, inseparabili fra loro, e sempre a fianco del Cronide. Per prevalere nella contesa
con gli altri dei, Zeus ha dovuto prima di tutti, dunque, impadronirsi
del potere e della violenza.17 Ne consegue che la violenza è necessariamente connessa alla presa di potere di Zeus, e non ha quindi una
sua dimensione autonoma, né rispetto a Dio, né rispetto al potere.
Nella tradizione mitologica arcaica, ma poi anche nei tragici del
V sec., la violenza è, inoltre, costantemente rappresentata come una
forza muta, priva di parola, eppure potentissima, capace di far eseguire gli ordini di Zeus grazie alla sua sola presenza. La violenza agisce,
coopera alla realizzazione della volontà di Zeus, restando in silenzio,
non si serve dunque del discorso, non propone argomentazioni e non
ha bisogno della dialettica.18
Va sottolineato che le numerose tragedie pervenuteci, le stesse
commedie, e anche le opere di carattere più prettamente storiografico,
sottolineano concordemente il rapporto irriducibile violenza-potere.
2.
In questo contesto, può risultare interessante prendere in esame la posizione della filosofa Hannah Arendt. Nel prendere atto che, a partire
dai primissimi testi greci pervenutici, in ogni riflessione che riguardi
Nella Teogonia Esiodo si sofferma ampiamente sulla genealogia di questi due
valletti di Zeus, indugiando nella descrizione della loro fedeltà al nume olimpico. La
loro dimora non è separata da quella di Zeus, «non è luogo che non sia ad essi comunque, non via, in cui il Dio non proceda insieme ad essi, ma per sempre essi hanno il
loro posto presso Zeus dal tuono profondo» (Esiodo: “Theogonia”, in Opere, Torino:
Utet, 1997, 383-403. Altre fonti antiche alle quali si può attingere per la delineazione
delle figure mitologiche di Kratos (potere) e Bia (violenza) – oltre a Esiodo, sono
lo Pseudo-Apollodoro: Bibliotheca; Milano: Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla,
2006, 1. 9; Pausania: Guida della Grecia, Milano: Mondadori, Fondazione Lorenzo
Valla, 2010, 2.4.7).
18
Cfr.: Eschilo: “Prometeo incatenato”, in Prometeo incatenato. I persiani. I sette
contro Tebe. Le supplici, tr. di Ezio Savino, Milano: Garzanti, 1992,42; uno studio accurato e ampio sul concetto di violenza di deve a Francesco D’Agostino: Bia;
cfr. anche Laura Sanò: Donne e violenza. Filosofia e guerra nel pensiero del ‘900,
Milano-Udine: Mimesis Edizioni, 2012.
17
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 83
lo statuto della politica, la violenza appare sempre indissolubilmente
associata al potere, la Arendt si pone infatti di fronte ad una questione
molto importante: è possibile concepire un potere al cui interno sia
assente la violenza?
Si deve riconoscere che abitualmente il giudizio che viene fornito
sulla violenza consiste in una descrizione puramente negativo-residuale. La violenza altro non è che il venir meno della razionalità, è
l’antitesi del logos, è l’irruzione della follia in un universo che dovrebbe essere dominato dalla pace.
In realtà, se da un lato, la storia sembra rispondere a questa interpretazione in modo opposto, dal momento che proprio la storia
dell’Europa comincia con una guerra, e con un atto di violenza, e
appare essere inchiodata a questo destino, l’idea che alla base di ogni
guerra vi sia una componente irrazionale si afferma come assunto solamente nella storia recente, e come conseguenza della devastazione
creata dalla due grandi guerre mondiali, e più ancora quale effetto della minaccia insita nel possibile impiego di armi atomiche e chimiche.
Di fronte allo scenario delle guerre che si sono scatenate in Europa
nel ‘900, Hannah Arendt cerca, nei suoi scritti, di offrire una risposta
articolata, in chiave storica e ontologica, all’interrogativo riguardante
l’origine della violenza e il rapporto conflittuale che lega quest’ultima
al potere. In particolare, nel testo intitolato Sulla violenza,19 l’Autrice
fornisce una lucida e penetrante analisi sul fenomeno della violenza
ripercorrendo gli avvenimenti politici e culturali del XX secolo, caratterizzati prima dalla Seconda Guerra mondiale e dall’Olocausto,
poi dalla Guerra Fredda e dalle lotte sociali. Ne emerge una riflessione a tutt’oggi di grandissima attualità, che mira a scandagliare le
cause che soggiacciono al concetto di violenza, in stretto rapporto
con i temi del potere e della forza, cercando di individuarne la razionalità e l’origine. È opportuno precisare che nell’analisi proposta nel
saggio dedicato alla violenza, la Arendt non sembra mai interessata
a una ricostruzione filologica dell’eredità greca alle radici della cultura del Vecchio Continente. Piuttosto, ella procede con una strategia
argomentativa di liberi rimandi con i quali presuppone i concetti e le
istanze della filosofia classica quali interpreti della catastrofe dell’Europa moderna.
Hannah Arendt: On Violence, New York: Harcourt Brace and World, 1970, tr. it.
di Savino D’Amico, Sulla violenza, Parma: Guanda, 1996.
19
84 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Riflettere sul concetto di violenza in quegli anni diviene una responsabilità intellettuale a cui la filosofa non vuole e non può sottrarsi: «Chiunque abbia avuto occasione di riflettere sulla storia e sulla
politica non può non essere consapevole dell’enorme ruolo che la violenza ha sempre svolto negli affari umani, ed è a prima vista piuttosto
sorprendente constatare come la violenza sia stata scelta così di rado
per essere oggetto di particolare attenzione».20
Le osservazioni di Arendt muovono dalla constatazione che, nel
mondo contemporaneo, lo sviluppo tecnologico degli strumenti idonei alla violenza abbia raggiunto un potere distruttivo tale da essere
incompatibile con la vita stessa. La minaccia di una guerra apocalittica ha soppiantato il tradizionale concetto di guerra concepito come
conflitto armato, salvo restando che la guerra è in ogni caso considerata ancor oggi l’unico strumento di deterrenza per garantire la pace.
La minaccia della guerra resta dunque l’unico decisivo arbitro che
regola gli affari e gli interessi internazionali.21
Alla base del ragionamento di Arendt vi è innanzitutto il tentativo di capire fino a che punto può reggere ancora oggi la schematica
contrapposizione fra violenza e razionalità, e più specificamente se è
davvero possibile concepire un mondo senza violenza. Il problema
nasce proprio a seguito degli eventi che hanno caratterizzato l’Europa
nel ‘900. La sostituzione del classico concetto di guerra, per quanto
estesa e sanguinosa, con un olocausto che ha riguardato un popolo
intero, e successivamente l’incombere della minaccia di una guerra
nucleare, hanno profondamente modificato ogni tipo di riferimento
tradizionale, introducendo una netta discontinuità nella stessa relazione politica-guerra, secondo la concezione che da Platone raggiunge
l’elaborazione contemporanea di Schmitt.22
Di fronte al conflitto quale è stato la Seconda Guerra mondiale,
di fronte soprattutto all’utilizzo di armi nucleari in grado di generare
un’ecatombe di dimensioni planetarie, l’originaria valenza morfogenetica della guerra ha perduto ogni tipo di plausibilità, così come ogni
Ivi, 11: «naturalmente - aggiunge in nota l’Autrice - c’è una vasta letteratura
sulla guerra, ma tratta dei mezzi della violenza, non della violenza in quanto tale».
21
Cfr. ivi, 5-12.
22
Per un approfondimento ulteriore sul rapporto politica-guerra cfr. Hannah
Arendt: The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt Brace and Co., 1951;
tr. it. di Amerigo Guadagnin, Le origini del totalitarismo, Torino: Piccola Biblioteca
Einaudi, 2004.
20
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 85
connessione con gli affetti più specificatamente politici di “trasformazione” e “stabilizzazione” che essa potrebbe diversamente garantire.
La guerra nucleare non può più quindi essere concepita come
strumento a servizio della politica, ma funge altresì come rottura irreversibile, come punto di non ritorno, oltre il quale i conflitti perdono
ogni connotato politico. Lo spettro dell’olocausto e la minaccia delle
armi chimiche e atomiche hanno dunque spezzato per sempre ogni
legame tra politica e guerra: tra i due termini non può più esserci continuità, fra essi vige un’opposizione che inibisce, dunque per sempre,
la reversibilità e la traducibilità dell’una nell’altra.23
La violenza, secondo Arendt, come concetto politico, dovrebbe
essere distinta dal potere, così come dalla forza e dall’autorità.24 Per
esprimersi, la violenza necessita inevitabilmente di strumenti, essa
stessa è uno strumento. In questo senso gli strumenti di guerra sono
l’espressione massima della violenza, motivo per cui lo sviluppo tecnologico ha raffinato sensibilmente questo legame implicito tra violenza e strumenti militari.
Fino ad oggi ci si è soffermati sul concetto di violenza come mezzo funzionale ad obiettivi economici e politici, ma mai come concetto
dallo statuto autonomo sul piano del significato. La verità, sostiene
l’Arendt, è che oggi il nesso guerra-politica, e violenza-potere, secondo la classica posizione di Clausewitz, è diventato inapplicabile.25
Ci si trova inoltre di fronte ad un paradossale capovolgimento
della relazione potere-violenza, con una conseguente ridefinizione
dei rapporti tra piccole e grandi potenze. Se prima era la quantità di
violenza a disposizione di un paese a determinarne la forza, ora ci si
trova di fronte ad un rovesciamento degli equilibri, per cui la violenza
non è più garanzia di potenza, né può divenire garanzia «contro la
Cfr. Hannah Arendt: Sulla violenza, 12.
Cfr. ivi, 46 e ss.
25
Cfr. ivi, 12 e ss. Secondo Arendt l’esperienza devastante della Seconda Guerra
mondiale ha generato un capovolgimento complessivo degli ordini precedenti. Alla
Seconda Guerra mondiale, inoltre, non è affatto conseguita la pace, come dimensione
riequilibrante delle forze, ma è subentrato un concetto di guerra ancora più subdola
e paralizzante, come la guerra fredda, con una conseguente rincorsa agli armamenti
che ha introdotto, grazie al progresso tecnologico, armi biologiche e chimiche dal
potere devastante.
23
24
86 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
possibilità di distruzione da parte di una potenza notevolmente più
debole e più piccola».26
Il problema della violenza coinvolge certamente, in modo diretto,
il concetto di potere. È altresì opinione consolidata da parte dei teorici
della politica ritenere, insiste Arendt, che la violenza non sia altro
che la più macroscopica manifestazione del potere. La politica non
sarebbe altro, dunque, che una lotta per il conseguimento del potere,
e il genere ultimo del potere consisterebbe appunto nell’organizzazione della violenza legittima. La guerra stessa viene concepita come
ciò che costituisce la vera essenza degli Stati, a tal punto che è lecito
domandarsi se l’eliminazione della violenza possa comportare la fine
dello stesso potere. La risposta, scrive Arendt, dipende da quello che
si è soliti intendere per potere.27
Abitualmente il potere viene delineato mediante le varie forme
di comando e di dominio. A questo schema interpretativo la Arendt
contrappone in prima istanza l’esperienza della polis greca o della civitas romana come esempi di una concezione del potere e della legge
del tutto differente. Nella città-stato ateniese, ma anche nella civitas
romana, il governo era basato su «un concetto di potere e di legge la
cui essenza non si basava sul rapporto comando/obbedienza e che
non identificava il potere col dominio né con la legge del comando».28
Nella polis greca il potere non aveva niente a che vedere con il comando o la coercizione, ma rappresenta invece il prodotto del consenso e della negoziazione collettiva di individui liberi. Era il sostegno
del popolo che conferiva il potere alle istituzioni, così come era il
consenso che dava origine alle leggi. L’idea del potere era associata
alla possibilità di decidere e di costruire, e pertanto andava assolutamente distinta dall’idea distruttiva della violenza che, secondo la
filosofa, resta incapace di generare un discorso e quindi di costruire
uno spazio di azione.29
Ivi, 14. D’altra parte, aggiunge Arendt, «questo comporta una sinistra somiglianza con una delle più antiche intuizioni della scienza politica, vale a dire che
la potenza non può essere misurata in termini di ricchezza, che un’abbondanza di
ricchezza può intaccare la potenza, che le ricchezze sono particolarmente pericolose
per la potenza e il benessere» (ibidem).
27
Cfr. ivi, 38 e ss.
28
Ivi, 42-43.
29
La questione affrontata dalla Arendt relativa al concetto di “azione” viene
sviluppata in particolare nel suo testo intitolato The Human Condition, Chicago:
26
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 87
Il potere delle democrazie si esprime proprio attraverso il libero
incontro nello spazio del discorso; mentre la violenza, considerata
l’opposto del potere, è per definizione muta, 30 in quanto non ha niente
da dire perché è basata sulla semplice distruzione. Di conseguenza è
proprio dove il discorso perde terreno, dove non è più possibile incontrarsi liberamente attraverso il dialogo, che la violenza finisce col
prevalere, mettendo “a tacere le sue vittime e riducendole al silenzio”,
come accade in tutti i regimi totalitari o nelle situazioni i cui il trauma
estremo causato dalla violenza costringe per sempre al mutismo.31
Una delle più ovvie distinzioni fra potere e violenza consiste per
la Arendt nel fatto che il potere è proporzionale al numero a cui si
associa, mentre la violenza può in un certo senso anche prescindere
dal numero di adesioni, perché si affida soprattutto agli strumenti di
cui dispone: l’«estrema forma di potere è Tutti contro Uno, l’estrema
forma di violenza è Uno contro Tutti».32 Paradossalmente è possibile
affermare che la tirannide è senza dubbio la più violenta ma anche la
meno potente delle forme di governo. Tutto ciò starebbe a dimostrare
che il potere e la violenza non sono affatto proporzionali fra loro.
University of Chicago Press, 1958; tr. it. di Sergio Finzi, Vita Activa. La condizione
umana, Milano: Bompiani, 2014. Per uno studio dettagliato sulla filosofia pratica di
Arendt si vedano, tra gli altri, in particolare i seguenti testi: Laura Boella: Agire politicamente, pensare praticamente, Milano, Feltrinelli, 2005; Giuseppe Duso (a cura
di): Filosofia politica e pratica del pensiero: Eric Voegelin, Leo Strauss, Hannah
Arendt, Milano: FrancoAngeli, 1988; Roberto Esposito (a cura di): La pluralità irrappresentabile. Il pensiero politico di Hannah Arendt, Urbino: QuattroVenti, 1987;
Ebe Faini Gatteschi, Soggetto e azione. Unicità e essere in comune nel pensiero di
Hannah Arendt, Milano: Glossa, 2009; Olivia Guaraldo (a cura di): Il Novecento di
Hannah Arendt. Un lessico politico, Verona: Ombre Corte, 2008; Natascia Mattucci:
La politica esemplare. Sul pensiero di Hannah Arendt, Milano: FrancoAngeli, 2012;
Alessandra Papa: Nati per incominciare. Vita e politica in Hannah Arendt, Milano:
Vita e Pensiero, 2011; Teresa Serra: L’autonomia del politico. Introduzione al pensiero di Hannah Arendt, Roma: Aracne, 2005.
30
Come è stato specificato, nella tradizione mitologica arcaica la violenza è costantemente rappresentata come una forza muta, priva di logos (cfr. in particolare
Eschilo: “Prometeo incatenato”,42; cfr. inoltre il saggio sulla violenza di Francesco
D’Agostino: Bia).
31
Cfr. Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo; cfr. inoltre Paola Rebughini: La
violenza, Roma: Carocci, 2004, 78. Sul rapporto violenza-filosofia nel pensiero contemporaneo si segnala un ampio e documentato volume di Giuseppina Strummiello:
Il logos violato. La violenza nella filosofia, Bari: Dedalo, 2001.
32
Hannah Arendt: Sulla violenza, 44.
88 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Anche se si è spesso portati a mettere sullo stesso piano la violenza con il potere, come se fossero l’una il prerequisito dell’altro,
in maniera particolare proprio questi due termini restano, e devono
restare, costitutivamente antitetici. E se davvero di rapporto si deve
parlare, allora resta innegabile il ruolo di indiscutibile superiorità e
preminenza del potere rispetto alla violenza: un governo che si basi
esclusivamente sui mezzi della violenza non ha alcuna possibilità di
permanenza; anche il dittatore più totalitario e violento ha bisogno di
un consenso e quindi di un potere riconosciuto per poter sussistere.33
A rendere inattaccabile un governo è l’organizzazione del potere,
e non i mezzi della coercizione in quanto tale. Se dunque «il potere
fa senz’altro parte dell’essenza stessa di tutti i governi», la violenza
possiede una natura meramente strumentale e, «come tutti i mezzi, ha
sempre bisogno di una guida e di una giustificazione per giungere al
fine che persegue. E ciò che ha bisogno di una giustificazione da parte
di qualcos’altro non può essere la sostanza di niente».34 Il potere è
definito dalla Arendt come «un fine in sé», che pur perseguendo degli
obiettivi politici, resta tuttavia estraneo al rapporto mezzi-fine.35 Esso,
ha soprattutto una propria identità autonoma e indipendente, che non
necessita di giustificazioni, perché costituisce l’essenza stessa della
società politica. L’unica cosa di cui ha bisogno è la legittimazione che
trae sostegno da un riscontro con il passato. Mentre la giustificazione
implica il rimando ad un fine esterno, proiettato nel futuro, la legittimazione è invece un appello al passato, rivolto al consenso originario
che ha dato origine allo stesso potere. La violenza può arrivare ad essere giustifica, insiste la Arendt, ma non potrà mai essere legittimata.36
Cfr. ivi, 49-53. E su tale questione aggiunge la Arendt: «soltanto la produzione di soldati robot che […] eliminerebbe completamente il fattore umano e, probabilmente, permetterebbe a un solo uomo schiacciando un bottone di annientare
chiunque voglia, potrebbe cambiare questa fondamentale superiorità del potere sulla
violenza. Perfino la dominazione più dispotica che conosciamo, il dominio del padrone sugli schiavi, che erano sempre numericamente superiori a lui, non si basava su
superiori mezzi di coercizione in quanto tali, ma su una superiore organizzazione del
potere, cioè sulla solidarietà organizzata dei padroni. Gli uomini soli senza appoggio
di altri non hanno mai potere a sufficienza per usare la violenza con successo» (ivi, p.
54).
34
Ivi, 54-55.
35
Cfr. ivi, 56.
36
Cfr. ibidem.
33
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 89
In sostanza, quand’anche il potere e la violenza venissero connessi l’uno all’altro, resterebbe comunque sempre il potere l’elemento
primario e predominante: dal momento che il potere è per l’appunto
un fine in sé, mentre la violenza è sempre e solo strumento, è inevitabile dedurre la preminenza dell’uno sull’altra.
L’equazione violenza-potere si basa sul fatto che «il governo è inteso come dominazione dell’uomo sull’uomo per mezzo della violenza».37 Tuttavia mentre gli strumenti della violenza possono arrivare
a distruggere ed annientare un potere, dalla violenza fine a se stessa
non potrà mai nascere il potere.38 Nello scontro frontale tra violenza
e potere l’esito non si configura per nulla incerto: l’esercizio della
violenza come forma di dominio entra in gioco solo quando si sta
perdendo il potere. Sostituendo «la violenza al potere si può ottenere
la vittoria, ma il prezzo è molto alto; in quanto viene pagato non solo
dal vinto, ma anche dal vincitore in termini di potere proprio».39 Se
la violenza talvolta prevale è soltanto perché si è logorato e consumato il consenso a sostegno del potere, permettendo così una sorta di
sovvertimento tra mezzi e fini, ovvero tra violenza e potere, con esiti
esiziali per lo stesso potere.
È da ravvisare nella debolezza, o nell’impotenza, la causa principale che alimenta la violenza dal punto di vista psicologico. Sul piano
invece politico, spesso si verifica che alla perdita di potere subentri la
tentazione di sostituire la violenza al potere, per poi verificare che la
stessa violenza sfocia nell’impotenza. Quando la violenza non è più
sostenuta e controllata dal potere, si attua un rovesciamento tale per
cui i mezzi di distruzione determinano il fine, con il risultato che il
fine distruggerà lo stesso potere.40
In conclusione, si può affermare che non solo il potere e la violenza non rappresentano lo stesso concetto, ma sono l’uno l’opposto
Ibidem.
Cfr. ivi, 57: «La violenza può sempre distruggere il potere; dalla canna del fucile nasce l’ordine più efficace, che ha come risultati l’obbedienza più immediata e
perfetta. Quello che non può uscire dalla canna di un fucile è il potere».
39
Ivi, 58.
40
Cfr. ivi, 59; inoltre Arendt ribadisce: «è stato spesso detto che l’impotenza alimenta la violenza, e da un punto di vista psicologico è piuttosto vero […].
Politicamente parlando, il punto è che la perdita di potere diventa una tentazione di
sostituire la violenza con il potere» (ibidem).
37
38
90 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
dell’altro: «dove l’una governa in modo assoluto, l’altro è assente».41
La violenza subentra quando il potere viene messo in crisi, ma lasciata a se stessa la violenza genera la dissoluzione dello stesso potere.
Non solo la violenza distrugge il potere, ma è anche assolutamente
incapace di crearlo.
Non è possibile continuare ad assecondare l’impostazione dialettica, secondo la quale il male non è altro che la temporanea manifestazione di un bene ancora nascosto.42 Il negativo, nel suo statuto
ontologico, resta costitutivamente distinto e opposto al bene, e non
può essere riassunto nel positivo. Si tratta al contrario di riconoscerne l’irriducibilità, anche allo scopo di evitare di alimentare speranze
ingannevoli. La grande fiducia nel «potere dialettico del negativo»,
secondo cui le contraddizioni e gli opposti non paralizzano, bensì
promuovono lo sviluppo, si basa su un ricorrente pregiudizio che
consiste nel ritenere il male come «un modus privativo del bene», e il
bene come possibile conseguenza del male: «queste annose convinzioni – scrive Arendt – sono diventate pericolose».43 Giustificare la
violenza in quanto elemento indispensabile per la ricostituzione di un
ordinamento politico positivo, è un ragionamento oltremodo deleterio. La violenza ha una sua ragion d’essere autonoma e non corrisponde a quel negativo che preannuncia l’origine di un disegno superiore.
Con ciò, conclude l’autrice, non si vuol sostenere che la violenza sia
uguale al male, ma semplicemente «sottolineare il fatto che la violenza non può essere derivata dal suo opposto, che è il potere, e che per
capirla per quello che è dobbiamo esaminarne le radici e la natura»,44
senza assolutizzazioni o pregiudizi di ispirazione dialettica.45
Va detto, sottolinea la Arendt, che la violenza non è affatto irrazionale. Il fatto che un uomo reagisca emotivamente attraverso la
violenza, non vuol dire che la sua reazione sia puramente di carattere
emozionale. Oltretutto curare l’uomo dalle emozioni vorrebbe dire
Ivi, 61.
Cfr. ivi, 61.
43
Ibidem.
44
Ivi, 62.
45
Per un approfondimento cfr. A.a. V.v: Filosofia e guerra nell’età dell’idealismo tedesco, Milano: Franco Angeli, 2003. Per un approfondimento sul rapporto
giudizio-esperienza in Arendt. cfr. Gaetano Rametta: “Comunicazione, giudizio ed
esperienza nel pensiero di Hannah Arendt”, in G. Duso (a cura di), Filosofia politica
e pratica del pensiero: Eric Voegelin, Leo Strauss, Hannah Arendt, 235-287.
41
42
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 91
disumanizzarlo.46 L’assenza di emozioni non genera né promuove
la razionalità, visto che molto spesso le emozioni diventano la risposta più razionale e opportuna di fronte a situazioni insopportabili e
incomprensibili. La violenza è invece molto spesso la logica e razionale conseguenza di una posizione ideologica. Essendo strumentale
di natura, la violenza è razionale nella misura in cui consegue il fine
atto a giustificata. La violenza può quindi essere usata per realizzare
uno scopo, sulla base del quale viene valorizzata.47 Il problema è che
il «pericolo della violenza, anche se essa si pone consapevolmente in
un quadro non estremistico di obiettivi a breve termine, sarà sempre
quello che i mezzi sopraffacciano il fine. Se gli obiettivi non sono
raggiunti rapidamente, il risultato non sarà la semplice sconfitta ma
l’introduzione della pratica della violenza in tutto l’insieme della politica».48 Ad ogni buon conto, la pratica della violenza, come ogni
altra azione aggressiva, può cambiare il mondo, ma il cambiamento
più probabile è quello in direzione di un mondo più violento.49
3.
L’odierna Europa appare dunque per la Arendt come un mondo dove
il potere è diventato sempre più impotente, oscurato dal progresso di
una scienza che ha reso possibile ciò che prima era impossibile, ma
che al tempo stesso ha reso incapace l’uomo di gestire il quotidiano,
senza tener conto di cosa tutto ciò comporti in termini di pericolo e
degenerazione.50
Riprendendo un passo di Valéry, la Arendt afferma che tutto ciò
che l’uomo sa, ovvero tutto quello che è nelle sue possibilità, ha fini-
Cfr. Hannah Arendt: Sulla violenza, 68.
Cfr. ivi, 86.
48
Ivi, 87.
49
Cfr. ivi, 88.
50
Per un approfondimento ulteriore cfr. Hannah Arendt, The Life of the Mind,
Harcourt New York: Brace Jovanovich, 1978; tr. it. di Giorgio Zanetti, La vita della
mente, Bologna: il Mulino, 2009; Ead.: Between Past and Future: Six Exercises in
Political Thought, New York: Viking Press, 1961; tr. it. di Tristano Gargiulo, Tra
passato e futuro, Milano: Garzanti, 1999.
46
47
92 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
to per contrapporsi con quello che veramente è.51 E conclude che se
da un lato non si sa dove potrà condurre il progresso tecnologico e
scientifico, di sicuro si dovrebbe invece avere sperimentato che ogni
contrazione del potere genera un invito aperto alla violenza.52
La violenza appare quindi la più facile alternativa al potere, e
questo vale sia per chi lo detiene, sia per chi si oppone ad esso. In
entrambi i casi, la violenza si configura come la soluzione più diretta
all’indebolimento del consenso che sorregge il potere. Anche se la
violenza possiede esclusivamente un carattere strumentale, e l’unico
esito che consegue da essa è la drammatizzazione delle tensioni e
delle ingiustizie.53
Il legame tra la vita di Arendt e gli avvenimenti terribili cui lei
stessa dovette assistere, quali la guerra, il nazismo, la persecuzione,
la shoah, l’esilio, è evidentemente molto stretto. L’autrice incarna, fin
dalla sua biografia, i contrasti di un’epoca che ha fatto dell’Europa
la fucina di sconvolgenti orrori. Se però la sua indagine riguarda in
primis la realtà storica di cui è spettatrice, sconvolta dalla violenza
e dalla guerra, si rende altresì destinataria di un’interrogazione che
trascende la singolarità di un precipuo momento per riflettere circa il
ruolo politico, oltre che morale, dell’essere umano all’interno dell’intera storia.
È chiaro che la voce di Hannah Arendt vuole parlare ad una società delusa dalla politica dove, da un lato, il potere sembra essere
diventato sinonimo unico di dominio e comando, dall’altro, l’autorità
viene sempre più identificata nella titolarità di disporre dei destini altrui, indipendentemente dal consenso o dalla negoziazione collettiva
tra individui liberi.
La dimensione della politica che disegna la Arendt non può prescindere da quella esistenziale, e in questo senso deve assumere un
ruolo preponderante ogni forma di attività e di esperienza vissuta e
condivisa nella interazione con gli altri. Il concetto di politica, o meglio di politeia, che Arendt intende allora valorizzare, nasce dall’esigenza di recuperare l’autenticità della propria condizione umana a
Cfr. Hannah Arendt: Sulla violenza, 95: non viene specificato il riferimento
bibliografico relativo a Valéry.
52
Probabilmente, sostiene la Arendt, coloro che detengono il potere, nel momento
in cui se lo sentono sfuggire di mano, trovano troppo difficile resistere alla tentazione
di sostituirlo con la violenza (cfr. ivi, 96).
53
Cfr. Giuseppina Strummiello: Il logos violato. La violenza nella filosofia, 349.
51
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 93
partire proprio dalla relazione con gli altri, nell’“essere in pubblico”.
L’“esserci” per la Arendt può infatti realizzare la propria conoscenza
solo attraverso l’ascolto, il dialogo e l’azione con l’altro e il mondo
esterno, quindi nella sfera della pluralità e della comunicazione.
La riflessione di Hannah Arendt è dunque particolarmente attenta
al ruolo dell’azione finalizzata al confronto con l’altro, nonché alla
denuncia della riduzione della sfera pratica a mero agire produttivo, quale conseguenza dell’impoverimento del valore attribuito alla
partecipazione dell’individuo nel mondo e nel rapporto con i propri
simili.54
Se è vero che nella storia dell’Europa è impresso lo stesso sigillo
già affiorato nella tradizione mitologica, il cui principio è individuato nella dimensione della guerra, è anche vero che nel contesto contemporaneo il carattere morfogenetico della guerra è stato, secondo
Arendt, completamente soppiantato da quello di olocausto, lasciando
spazio ad una violenza sempre più muta, incapace di creare un luogo
di dialogo, di azione e pensiero, incapace soprattutto di ogni possibile
concertazione politica. L’idea dunque che il potere e la violenza viaggino in coppia è un assioma che ha monopolizzato la cultura dell’Europa, da Eraclito a Platone e fino a Carl Schmitt; una cultura che,
secondo la filosofa, ha tuttavia trascurato il fatto che il potere, prima
di degenerare in guerra (in quanto espressione massima di violenza),
dovrebbe innanzitutto corrispondere alla capacità umana non solo di
agire, ma di agire di concerto. È possibile concepire un potere, disgiunto dalla violenza, ogni qualvolta vi siano individui che agiscano
insieme in uno spazio pubblico e attraverso discorsi liberi. Là dove
viene a mancare lo spazio della pluralità impera la violenza e prendono piede i regimi totalitari.55
Si dovrebbe sempre ricordare, ammonisce la Arendt, che la politica «non ha tanto a che fare con gli uomini quanto con il mondo
che si crea tra loro, e che a loro sopravvivrà»; ne consegue che più la
politica «diventa distruttiva, e provoca la fine di qualche mondo, più
distrugge e annienta se stessa».56
Cfr. Hannah Arendt: Vita Activa. La condizione umana; Laura Boella: Agire
politicamente, pensare praticamente.
55
Cfr. Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo.
56
Hannah Arendt: Was ist politik? Aus dem Nachlass, München: Piper, 1993; tr. it.
di Marina Bistolfi, Che cos’è la politica?, Torino: Einaudi, 2006, 83.
54
94 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Nella prospettiva delineata dalla Arendt, si pongono se non altro
le premesse per il superamento della schematica contrapposizione fra
l’approccio realista e quello utopico al problema della violenza. Ciò
che emerge dalle pagine del saggio arendtiano non è semplicemente
un appello emotivo, né la formulazione di una visione esigenziale, refrattaria a misurarsi con la “dura replica” dei fatti, quali emergono da
una lunga e ininterrotta storia di espressioni concrete della violenza.
L’Autrice non ignora, e anzi mostra di riattraversare con attenzione e
vigilanza critica, una tradizione culturale costruita sul riconoscimento
realistico dell’intrascendibilità della violenza. Non trascura quale sia
stata l’origine di Europa, e dunque di tutto l’Occidente, nell’intreccio
apparentemente indissolubile fra politica e guerra, fra la spinta alla
trasformazione e l’impiego di mezzi violenti finalizzati al raggiungimento di tali obbiettivi. Anche il riferimento all’olocausto, sovente
ricorrente in altri autori del Novecento come tramite per il rifiuto onnilaterale e incondizionato della violenza, non si traduce in un’impostazione meramente ottativa, ma si misura piuttosto con l’innegabilità dei conflitti quali fattori dinamici dell’evoluzione storica. D’altra
parte, pur nel quadro di una concezione perfettamente disincantata,
e pur evitando ogni concessione sentimentale, Arendt mostra in che
modo si possa immaginare di disinnescare il potenziale distruttivo
della violenza. La via da percorrere, per tentare almeno di reagire
all’appiattimento della politica sul piano della violenza “civilizzata”,
non consiste nell’annullamento della politica, ma all’opposto nella
massima valorizzazione della capacità morfogenetica di una politica a
cui venga restituito un primato scosso dall’egemonia delle guerre del
Novecento. Il percorso a cui Arendt rinvia non è certamente agevole
né rettilineo, anche per la relazione di netta discontinuità istituita con
una tradizione fondata sull’inscindibilità del binomio politica-guerra.
Ma apre al tempo stesso ad una prospettiva con la quale – oggi più che
mai – l’Europa è chiamata a confrontarsi.
Laura Sanò - Morfogenesi dell’Europa 95
Bibliografia
A.a. V.v: Geofilosofia, Sondrio: Lyasis, 1996.
Arendt, Hannah: On Violence, New York: Harcourt Brace and World, 1970,
tr. it. di Savino D’Amico, Sulla violenza, Parma: Guanda, 1996.
Arendt, Hannah: Was ist politik? Aus dem Nachlass, München: Piper, 1993;
tr. it. di Marina Bistolfi, Che cos’è la politica?, Torino: Einaudi, 2006.
Baget Bozzo, Gianni: Della guerra, Venezia: Arsenale cooperativa editrice,
1982.
Boella, Laura: Agire politicamente, pensare praticamente, Milano:
Feltrinelli, 2005.
Cacciari, Massimo: Geofilosofia dell’Europa, Milano: Adelphi, 1994.
Calasso, Roberto: Le nozze di Cadmo e Armonia, Milano: Adelphi, 1988.
Carrino, Agostino, Oltre l’Occidente: critica della Costituzione europea,
Bari: Dedalo, 2005.
Curi, Umberto: Pensare la guerra, Bari: Dedalo, 1999.
Curi, Umberto: Polemos. Filosofia come guerra, Torino: Bollati Boringhieri,
2000.
D’Agostino, Francesco: Bia, Milano: Giuffrè Editore, 1983.
Duso, Giuseppe (a cura di): Filosofia politica e pratica del pensiero: Eric
Voegelin, Leo Strauss, Hannah Arendt, Milano: FrancoAngeli, 1988.
Esposito, Roberto (a cura di): La pluralità irrappresentabile. Il pensiero politico di Hannah Arendt, Urbino: QuattroVenti, 1987.
Guaraldo, Olivia (a cura di): Il Novecento di Hannah Arendt. Un lessico
politico, Verona: Ombre Corte, 2008.
Hanson, Victor Davis: Le Modèle occidental de la guerre. La bataille d’infanterie dans la Grèce classique, Paris: Les Belles Lettres, 2004.
Jaspers, Karl: Wahrheit und Bewährung. Philosophieren für die Praxis,
München: Piper, 1983, tr. it. di Giancarlo Russo e Gaetano Rametta,
Verità e verifica. Filosofare per la prassi, Brescia: Morcelliana, 1986.
Magris, Aldo: L’idea di destino nel pensiero antico, Udine: Del Bianco
Editore, 1984.
Mattucci, Natascia: La politica esemplare. Sul pensiero di Hannah Arendt,
Milano: FrancoAngeli, 2012.
Rebughini, Paola: La violenza, Roma: Carocci, 2004, 78.
Serra, Teresa: L’autonomia del politico. Introduzione al pensiero di Hannah
Arendt, Roma: Aracne, 2005.
Strummiello, Giuseppina: Il logos violato. La violenza nella filosofia, Bari:
Dedalo, 2001.
96 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Vernant, Jean-Pierre: (a cura di), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne,
Paris-La Haye: Mouton & Co., 1968.
L’‟Europa” secondo Husserl:
l’enigmatica sfida del filosofo
Sara Pasetto
Husserl’s idea of ‛Europe’ describes a spiritual form to be human.
The human being becomes a philosopher, due to his tradition, he
doesn’t support any more all aspects of his own identity. The traditional knowledge acquires a relative validity, e. g. through a culture shock. This fact motivates the search of a universal validity: the
philosophy. Husserl describes, how historically a new idea of being
a human was developed through philosophy in Greece. The community of all these individuals, the philosophers, is called ‛Europe’.
The aim of this article is to describe the relationship between Europe
and the philosopher; not from the political point of view of Europe,
but from the ethical one of each individual philosopher. This ethical
point of view is shown as the basis of the political dimension. Thus,
being a philosopher means, according to Husserl, the first essential
step into the concrete realization of Europe.
98 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
La funzione che la filosofia deve costantemente esercitare all’interno
dell’umanità europea è una funzione arcontica per l’intera umanità1
Il 9 luglio del 1950 la sofferente cittadina di Breisach sul Reno,
distrutta per l’85 % nel 1945, votò con un assenso del 95,6 % per
un’Europa libera e unita. Fu la prima città europea a dichiararsi anche
tale. Alla luce di una volontà popolare di confine, stanca del perenne
travaglio storico consumatosi nel susseguirsi di molteplici appartenenze politiche – come dimostrano i vari stemmi che blasonano il comune (l’edificio rosa nella foto) –, l’idea di Europa eletta a Breisach
si palesa nella sua evidenza soprattutto fuori dalla sede del potere
politico cittadino. Il 9 luglio del 2000, esattamente 50 anni dopo il referendum che dichiarò Breisach “città europea”, è stata, infatti, installata dall’artista friburghese Helmut Lutz una statua commemorativa
intitolata Europa afferra le stelle. Come eruttato da flutti di terra sulla
montagna della cattedrale, nella meravigliosa piazza che sovrasta la
cittadina, nasce Zeus sotto le sembianze del mitico toro, cavalcato
da Europa, la quale, quasi danzando in perfetto equilibrio sul divino
animale, si allunga fino alle stelle. Inequivocabilmente donna, la figura di Europa è sensualmente rappresentata col cuore, ma senza testa.
L’astratto triangolo, che costituisce pancia e testa, ha, però, gambe
e braccia. Simboleggia forse una passionale razionalità, grazie alla
quale l’astrazione intellettuale possa, nonostante tutto, anche essere
concreta, muoversi e agire? Che sia questo l’enigma a cui si riferisce
anche l’“idea di Europa” nella fenomenologia di Edmund Husserl?
Il tema dell’“Europa” in Husserl mantiene, anche dopo tanto tempo, un fascino particolare. Forse proprio a causa della forza
politica che segue, paradossalmente, alla sospensione della politica
comunemente intesa, grazie a quell’epoché tanto essenziale alla fenomenologia, da identificarne il punto zero da cui partire “sempre di
nuovo” (immer wieder). Elio Franzini, nel suo libro Fenomenologia,
1
Edmund Husserl: “Die Krisis des europäischen Menschentums und die
Philosophie”, in Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Hua
VI, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1954, 314-348. La traduzione italiana del vol. VI
dell’Husserliana utilizzata in questa sede è quella di Enrico Filippini, La crisi delle
scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano: Net, 2002; tuttavia, solo
per il testo della cosiddetta ‛Conferenza di Vienna’ viene qui preferita la traduzione
italiana di Renato Cristin, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, in Crisi e rinascita della cultura europea, Venezia: Marsilio, 1999, (47-92), 77; il corsivo è mio.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 99
La piazza del comune di Breisach am Rhein.
sottolinea come Husserl dedicò all’Europa pagine importanti nel
1935, «esattamente due anni dopo l’ambiguo discorso di rettorato di
Heidegger»2, osservando come,
in questi suoi ultimi scritti, contemporanei alla crisi della Repubblica
di Weimar e alla presa di potere nazista, Husserl, occupandosi del ‟destino” della filosofia ne svincola lo sviluppo dalla superficialità germanica, parlando sempre di ‟Europa” e di ‟umanità europea”. Per comprendere il coraggio, e la portata ideologica di questa posizione, si dovrà
notare che in questi stessi anni, e particolarmente nel suo discorso di
Rettorato, Heidegger parla sempre di Germania e di filosofia tedesca3.
Questa esplicitazione di Franzini si trova in nota a un paragrafo nel capitolo intitolato L’ombra di Husserl: la fenomenologia e il
Elio Franzini: Fenomenologia. Introduzione tematica al pensiero di Husserl,
Milano: Franco Angeli, 2007, 95.
3
Ivi, 95; il corsivo è mio.
2
100 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
mondo moderno. Nel contesto fenomenologico attuale, soprattutto
in quello italiano grazie alla cosiddetta Scuola di Milano, continua
a essere notata l’importanza di Husserl per una “filosofia politica”;
tuttavia non sono a conoscenza di studi approfonditi che sviluppino
una “rigorosa fenomenologia del politico” a partire da Husserl. La
difficoltà più grande sta probabilmente nella non sistematicità della
descrizione effettuata dello stesso Husserl. L’analisi del presente articolo, quindi, tenterà, seppur in minima parte, di ricostruire alcune
di queste tematiche, come appunto quella riguardante il mestiere del
filosofo. A questo scopo verrà messa in rilievo direttamente la posizione husserliana, utilizzando esclusivamente i testi dell’autore, a
volte riportati per mezzo di lunghe citazioni.
Come considerazione introduttiva, inoltre, deve essere presa in
esame la portata stessa della sfida fenomenologica, che per essenza
tratta un sapere che si orienti, per così dire, senza bussola tra le fitte
complessità degli argomenti. Effettivamente Husserl propone di non
utilizzare concetti filosofici tradizionali, ma di verificarli proprio attraverso l’atto stesso dell’orientarsi. Affinché, dunque, il fenomenologo possa descrivere “Europa che afferra le stelle”, deve incontrare la
sua “stella polare” nel confuso mare della filosofia politica. La confusione, perciò, diviene quasi la condizione di possibilità per l’utilizzo
di nuovi strumenti, per orientarsi meglio, se tale attività viene portata
avanti con consapevolezza.
Non somigliano forse la comunità di filosofi e le generazioni di filosofi
a chi, ‟nella sua buia tempesta” – seppure attraverso molteplici errori e
confusioni –, è cosciente della ‟giusta” via? La filosofia entra in scena
nel mondo umano sempre muovendo da qualche motivazione storica,
come proposito di nuovo genere, vale a dire, come un nuovo genere di
idea operativa (di nuovo genere significa non come il tradizionale tipo
di propositi che sono già realizzati nelle opere). Essa ha una ‟fondazione originaria” in quelle personalità che, ‟nella buia tempesta”, cercano
di realizzarla nelle opere. Nella vaghezza è implicito dunque qualcosa
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 101
come un’evidenza o, meglio, come l’evidenza della possibilità di giungere veramente ad una realizzazione di fatto4.
Come il vagare, nonostante la buia tempesta, può dunque condurre alla scoperta di nuove terre da esplorare, così anche la seguente considerazione sulla politica nella fenomenologia, nonostante la
possibile confusione terminologica, può mostrare la sostanziale differenza concettuale tra “politica reale”, descritta da Husserl pressoché sempre in maniera critica, e “politica fenomenologica”. La prima
identifica la politica meramente ideologica e partitica dei «fautori della Realpolitik», per i quali
si è perduta la fede nel dominio di una ragione [… e per i quali] l’uomo
si getta in braccio all’egoismo e, politicamente, al moloch dell’idea di
potere, e abbellisce il proprio idolo (talvolta in forma nazionalistica)
con fraseologie idealistiche che, secondo la loro originaria fonte di senso, provengono dalla fucina delle idee eterne che nella loro pura forma
stanno in totale opposizione a tutte le forme di egoismo5.
La politica fenomenologica, invece, descrive proprio quest’ultima dimensione, la più basilare della “sfera del politico”, dove si ha la
partecipazione ad un’idea. Questa è, dunque, intesa quanto “principio
originario di possibilità comuni” e vista, perciò, in possibile contrasto
con l’ideologia. Ancora più pregnanti diventano oggigiorno le parole
di incipit al primo articolo di Husserl scritto per la rivista giapponese
Kaizo, datate 1923:
[r]innovamento è l’appello generale nel nostro tormentato presente, e
nell’intero ambito della cultura europea. La guerra, che dal 1914 l’ha
devastata e che dal 1918 non ha fatto che sostituire i mezzi della coercizione militare con quelli più ‟raffinati” della tortura psicologica
Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Ergänzungsband: Texte aus dem Nachlassß (1934-1937),
Hua XXIX, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1993, trad. it.
parziale di Nicoletta Ghigi, La storia della filosofia e la sua finalità, Roma: Città
Nuova, 2004, 116; il corsivo è mio.
5
Edmund Husserl: Aufsätze und Vorträge (1922-1937), Hua XXVII, Dordrecht/
Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1989, trad. it. parziale di Corrado
Sinigaglia, L'idea di Europa, Milano: Raffaello Cortina, 1999, 135.
4
102 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
e dell’indigenza economica, non meno depravanti dal punto di vista
morale, ha rivelato l’intima non verità e insensatezza di tale cultura.
Proprio questa rivelazione, però, finisce per impedire che essa dispieghi
appieno la sua autentica forza6.
L’“idea di Europa” in Husserl non si avvicina, perciò, all’ingenuo
concetto di “Europa politica”; molto più affine risulta, invece, l’enigmatica figura di Europa rappresentata a Breisach: fuori, in piazza, di
fronte alla sede politica della città una donna, mezza astratta e mezza
concreta, collega cielo e terra in una dinamica che raggiunge le stelle.
Questa statuaria Europa muove l’Europa politica decisa tra le mura
del comune; è lei che direziona, che orienta e conduce le politiche
discussioni. Secondo Husserl, infatti,
[u]na nazione, un’umanità, vive e opera nella pienezza delle forze soltanto se sorretta nel suo slancio da una fede in se stessa e nella bellezza e
bontà della vita della propria cultura; se, dunque, non si limita a vivere,
ma aspira a qualcosa che considera grande, e trova appagamento solo
quando riesce progressivamente a realizzare valori genuini e sempre più
elevati. Essere degno di appartenere a un’umanità simile, cooperare a
una tale cultura, contribuire ai suoi valori edificanti, rappresenta la felicità di ogni uomo operoso e lo solleva dalle preoccupazioni e dalle
sventure individuali7.
Al fine dello sviluppo della tematica qui proposta, ovvero l’Europa ed il filosofo secondo Husserl, risulta fondamentale il tener presente la struttura di validità, che sta alla base della fenomenologia
del politico in Husserl. Alla luce delle mie ricerche, la sfera politica
poggia su quella etica. Ciò equivale a dire, che un’impostazione fenomenologica ben fondata deve partire secondo Husserl dall’etica,
base per una politica fenomenologica, a sua volta fondamento di una
politica reale fenomenologicamente coerente. Una direzione contraria descrive una fondazione non fenomenologicamente rigorosa, sulla
6
7
Ivi, 3; il corsivo è mio.
Ivi, 3; il corsivo è mio.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 103
cui validità si deve dubitare8. Da qui parte la proposta descrittiva del
presente articolo, che vorrebbe essere non una sostituzione dell’analisi della sfera politica con quella dell’etica, quanto un esempio di
delineazione della relazione tra l’Europa e il filosofo, questa volta a
partire non dall’aspetto politico, quanto da quello più evidentemente
etico, che ne sta alla base.
Secondo Husserl «[p]er poter comprendere la confusione della “crisi” attuale [è] indispensabile elaborare il concetto Europa in
quanto teleologia storica di fini razionali infiniti; [è] indispensabile
mostrare come il “mondo” europeo sia nato da idee razionali, cioè
dallo spirito della filosofia»9. Innanzitutto, perciò, verrà riportata l’argomentazione, ricostruita attraverso citazioni da varie opere, di quello che Husserl identifica come la nascita storica dell’Europa con il
sorgere della filosofia; poi la descrizione fenomenologica del filosofo
verrà trattata sotto quattro punti di vista principali, quello del “rivoluzionario inconsapevole”, dello “scienziato in divenire”, del “richiamo
della tragicità” e di “noi europei”. Si deve inoltre tener ben presente,
che queste analisi non si riferiscono a modalità diverse dell’essere
filosofo o di essere europei, quanto ad aspetti prospettici, che appartengono tutti allo stesso fenomeno: il filosofo, che a sua volta costituisce l’Europa, intesa come la comunità dei filosofi. L’approccio etico,
che sottolineerà la figura del filosofo invece di quella dell’Europa,
non dovrà, perciò, apparire fuorviante: non è il filosofo ad essere alla
prova dell’Europa, né l’Europa alla prova del filosofo – se non altro
l’Europa secondo Husserl; a prova è la loro relazione, qui descritta
nel suo aspetto etico come un’enigmatica sfida filosofica. Non risulterà allora, quello del filosofo, proprio il primo essenziale passo nella
realizzazione concreta dell’Europa?
8
Per tutte queste tematiche, riguardanti una fenomenologia del politico – con la
differenziazione tra ‛politica reale’ e ‛politica fenomenologica’ – e la sua fondazione
fenomenologica sulla sfera dell’etico, cfr. le mie previe ricerche sintetizzate in Sara
Pasetto: “La politica dell’‛Europa’ nella fenomenologia di Edmund Husserl”, Segni e
comprensione, XXIII, 68, 2009, 7-20.
9
Husserl, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, 91.
104 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
L’universo di Babele
Nell’ingenuo immaginario collettivo il filosofo vive come in una “torre eburnea”, il suo mondo risulta diverso da quello, appunto, comune.
La domanda fenomenologica essenziale non tratta, a questo punto, la
verità o la falsità di questa immagine, quanto in che modo il filosofo
sia “straniero”. Da outsider, il filosofo è da considerarsi un “estraneo” che non conosce il “luogo comune”, o uno “strano” che, conoscendolo, ne circumnaviga i confini, aprendo varchi per nuovi spazi?
Nel manoscritto La teleologia nella storia della filosofia (Teleologie
in der Philosophiegeschichte), successivo alla stesura de La crisi,
Husserl descrive ciò che, a mio avviso, può intendersi come l’essenza
del compito del filosofo:
Doveva venire un filosofo che divenisse cosciente del fatto che il possesso del compito filosofico tramandato dalla tradizione, acquisito dalla
scuola o dall’insegnamento dei testi, non decreti ancora la possibilità
evidente del compito e neppure, eo ipso, il metodo dato soltanto insieme
a questa evidenza intellettiva; un filosofo che cioè divenisse cosciente anche del fatto che la filosofia può essere effettuata soltanto come
proposito personale, ossia come qualcosa da giustificare di persona
e mediante una personale azione responsabile. Ed ancora: un filosofo
che, da questo momento in poi, avesse motivo di elevarsi criticamente
non soltanto oltre la tradizione filosofica (e quindi, riguardo ad essa, di
esercitare in primo luogo un’epoché), bensì anche prima, cioè anche riguardo al proprio compito che guida la sua vita professionale – poiché,
anche in esso, è implicito un pregiudizio che proviene dalla tradizione,
relativo all’effettuabilità ed, eventualmente, alla metodica già esercitata,
che proviene anch’essa dalla tradizione10.
Della filosofia, quindi, la fenomenologia husserliana non sottolinea l’innovazione strettamente filosofica, intendendo come tale le
novità intellettuali legate alla disciplina, ma la “rivoluzionaria trasformazione esistenziale” avvenuta nella storia dell’umanità11.
Com’era, allora, la vita prima della filosofia? L’uomo viveva attraverso conoscenze «condizionate dalla situazione o, meglio, tradi10
11
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 108; il corsivo è mio.
Cfr. Edmund Husserl: La storia della filosofia e la sua finalità.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 105
zionalmente fondate»12, cosa che, sottolinea prontamente Husserl, «in
nessun modo deve essere un difetto o contrassegnare una manchevolezza»13. La domanda, che quindi ci si pone – oggigiorno ancora
quanto mai attuale – è la seguente: nella vita quotidiana, quella di tutti
noi al mercato della città o in farmacia, è rilevante la filosofia?
Il mercato (e, più precisamente quello di Friburgo nel nostro presente)
ha una sua verità di mercato, la farmacia una sua verità relativa alla farmacia, la vita politica in città e nello Stato (quello attuale) la sua verità
politica, ecc. Essa è comune a noi tutti, per noi tutti ben familiare, ossia
comune a tutti noi che siamo cresciuti nella stessa comunità, vale a dire,
nella stessa tradizione. ‟Ognuno” (sempre riferito ad un tale Noi) sa
come effettivamente le cose si svolgono al mercato ed allo stesso modo
in qualsiasi altra situazione familiare. Egli sa cosa bisogna decidere razionalmente in ogni situazione vera o falsa e quali sono le ragioni o le
differenze rilevanti o irrilevanti, a tale riguardo. Per una libbra ritenuta
come vera al mercato sono irrilevanti le differenze di grammi, per un
giusto cubito non è importante la misura di un pollice, la quale unità di
grandezza, invece, è decisamente essenziale in farmacia14.
Se, dunque, nella vita di tutti i giorni sono sufficienti le conoscenze situazionali supportate dalla tradizione, «si impone la questione
concernente l’utilità di questa nuova conoscenza acquisita dall’umanità»15. Come mai, infatti, l’uomo è diventato filosofo? Quale motivazione, che «rende visibile un plus ultra»16, si cela in tutto ciò?
Il fatto storico riguarda la culla della filosofia – e con essa secondo
Husserl dell’Europa –, ovvero «l’antica Grecia del VII e del VI secolo
a. C.»17 ed i suoi contatti commerciali con popoli stranieri; accadde,
infatti, che differenti nazioni condivisero degli interessi pratici. «[Ed
è appunto proprio la] forma da sempre familiare della quotidianità, in
cui ha luogo la normale vita pratica […] che è prima di tutto ridotta in
frantumi, quando l’essere umano, dal suo spazio vitale nazionale, en12
14
15
16
17
13
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 89.
Ivi, 89.
Ivi, 89; il corsivo è mio.
Ivi, 90.
Ivi, p. 91.
Husserl, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, 56.
106 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
tra in quello di una nazione straniera»18. Lo sgretolarsi della “normalità” produce una reazione a catena, che conduce alla necessità di (ri)
conoscere l’identità, innanzitutto la propria. Questa, però, non è più
possibile considerarla come assoluta; ora non può che essere ridefinita in relazione alle altre identità. Attraverso la percezione di culture
diverse, quindi, è proprio la differenza che viene posta in questione,
che assume un rilievo di spicco. E l’incontro si dà con lo scontro: tutto
inizia infatti col disprezzo ed il rifiuto. «Il greco prova disprezzo per
i barbari ed, inoltre, le mitologie a lui estranee […] valgono per lui
innanzitutto, appunto, come barbariche, come stupide, come false di
principio»19. Eppure, con il tempo, la curiosità la fa da padrona: «[i]
mparando a conoscere molti popoli stranieri ed essendo ricondotti dal
precedente interesse per la propria storia a quella dei popoli circostanti stranieri, sorge un proprio interesse per un’autocomprensione della
propria esistenza nazionale, nei confronti delle particolarità degli
stranieri»20. Anche ciò che può sembrare più intimo ed unicamente
caratterizzante, come ad esempio la religione, trova essenziali similarità negli altri popoli, un’uguaglianza di validità che, per differenziarsi, necessita della tradizione particolare dei singoli gruppi umani.
Questa, dunque, non scompare dall’orizzonte d’interesse, anzi; alla
tradizione viene aggiunta una connotazione, quella della “ricchezza
dell’alterità”. «Si tratta certamente dello stesso sole, della stessa luna,
della stessa terra, dello stesso mare, ecc., che diviene oggetto del mito
così in maniera diversa nei diversi popoli, a seconda, certamente della loro tradizione»21.
Le “invasioni barbariche”, penetrando la normalità, ovvero la vita
condotta in conformità alla tradizione, rendono possibile una vita il
cui orizzonte sia il mondo, ovvero una vita condotta in conformità
con l’universo.
Con ciò dunque si compie un’autentica rivoluzione nella costituzione
del senso del mondo. Prima il mondo era comprensibile per ognuno a
partire dalla sua tradizione nazionale come mondo circostante infinitamente aperto e, anche relativamente alle regioni sconosciute, l’essere
18
20
21
19
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 92.
Ivi, 91; il corsivo è mio.
Ivi, 89; il corsivo è mio.
Ivi, 91; il corsivo è mio.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 107
insito in esse in maniera completamente indeterminata, era comunque
anticipato nell’aderenza ad un senso della tradizione. Ora, invece, il
mondo è l’universo di tutte le cose identiche, dell’‟essente” nel nuovo
senso filosofico, il cui essere proprio è ritenuto diverso da tutte le apprensioni tradizionali22.
La tradizione, la «trasmissione ingenua»23 non parla più per il
mondo, ora è il mondo stesso che si esprime attraverso le tradizioni,
per di più utilizzando lingue differenti. Se, dunque, prima la tradizione rappresentava tutto il mondo conosciuto, ora invece è proprio la
tradizione nazionale, quella più propria, la “nostra” a mostrarsi come
la “torre d’avorio” dentro la quale si stava rinchiusi. La “torre di
Babele”, nella quale «[t]utta la terra aveva una sola lingua e le stesse
parole»24 – le “nostre”, quelle che permettevano l’ingenuo soliloquio
della tradizione del “noi” –, presenta fratture createsi senza aver scomodato la divina provvidenza; in vece sua si utilizzò l’umana filosofia.
Il risultato, infatti, di questa primissima epoché rispetto all’assoluta
validità delle conoscenze tradizionali si mostra come un’ouverture ad
una nuova impostazione esistenziale, quella della filosofia.
Implica tutto ciò anche la possibilità di un nuovo tipo di “noi”?
Secondo Husserl questa dimensione è possibile non più a partire dal
“si” impersonale della tradizione, quanto da un “io” libero di scegliere di volta in volta, sempre e di nuovo che tipo di persona essere
rispetto a se stessa e, da ciò, essere essa stessa un fondamento per la
tradizione, per il “noi”. Il filosofo, infatti, non solo scopre la dimensione dell’universale, ma scorge in essa anche una validità basilare,
che, appunto come un basamento, permette il radicamento più proprio
di tutte le possibili tradizioni; attraverso l’universale egli in prima
persona può condividere la validità di tutte le tradizioni. La filosofia
intesa da Husserl, quella che trova origine in Grecia e che dà vita
all’Europa, non prevede, quindi, un’astrazione dal mondo, quanto
un’universalizzazione che concretizza il mondo. Il mondo non si riduce più ad un’unica torre, ma diviene percepibile come un universo
22
Ivi, 93; il corsivo è mio.
Ivi, 94.
24
Conferenza Episcopale Italiana (CEI): Bibbia, Bible Gateway Online, 13-112016, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+11&version=CEI,
Gen. 11/1.
23
108 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
di torri di Babele – che siano o meno d’avorio e con più o meno crepe.
Ciò che accadde in Grecia fu un’evidenza originaria, l’origine di un
principio nuovo, il principio concreto di nuove possibilità comuni. Da
allora la vita è accompagnata da «un’evidenza effettivamente realizzata, cioè […] una evidenza della pienezza che non “dimostra” l’evidenza provvisoria, ma la rende utilizzabile, feconda per gli intenti alti
e vasti che qui sono in gioco»25.
Abbiamo così delineato nelle linee essenziali, sebbene un po’ schematicamente, quella motivazione storica che poteva far sì che un paio di greci stravaganti dessero l’avvio a una trasformazione dell’esistenza umana
e di tutta la sua vita culturale, dapprima all’interno della loro nazione e
poi di quelle vicine26.
Il rivoluzionario inconsapevole
Cosa significa, però, che quest’evidenza sia fruibile? Le fessure nella
nostra torre non sono segni inequivocabili dell’imminente crisi, un
preludio alla rovina? Come può la filosofia essere un solido basamento per una torre, i cui punti di cedimento risultino dei varchi verso
nuovi spazi, dei fecondi solchi in nuovi terreni? Se la filosofia nasce
con la messa in discussione della tradizione, come è possibile che
essa possa fungere da sostegno per la tradizione stessa?
Il problema si nasconde, a mio avviso, nella molteplicità di prospettive che si creano proprio grazie a queste fratture. Alla tradizione
– della quale, come si è visto, fanno parte tutti i saperi situazionali come quello economico, politico, istituzionale, religioso, ecc. – è
proprio solo una conoscenza di tipo pratico. L’arte degli stivali, ad
esempio, «quelli che spetta produrre al calzolaio, secondo il suo mestiere»27, viene tramandata di generazione in generazione, in modo
che il calzolaio “sa cosa deve fare”. Nel caso di uno “shock culturale”
per il quale si è a contatto con altri modi di agire, diverse maniere di
produrre stivali o di amministrare uno stato nazionale, questo sapere
25
Husserl, “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, 463;
il corsivo è mio.
26
Husserl, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, 76.
27
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 60.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 109
viene praticamente messo in discussione. La tradizione vive una situazione di contrapposizione fra diversi saperi, che, dal suo punto di
vista, non possono che essere automaticamente gli uni contro gli altri
secondo il modello dell’aut-aut. Per quanto l’atteggiamento filosofico
sia sorto storicamente proprio in risposta ad uno “shock culturale”,
alla nascita della filosofia – addirittura un nuovo tipo di sapere, quello
teorico – come avrà mai classificato la tradizione il mestiere del filosofo, di colui che solamente “sa di non sapere”? Automaticamente
come “non pratico”. «Infatti, già nel significato analitico del compito
della filosofia stessa, è implicito il fatto di essere un compito della
conoscenza [Erkenntnisaufgabe] nella forma di una contrapposizione [Frontstellung] ad ogni altra forma particolare di conoscenza che
rimane nella vita pre- ed extra-scientifica del mondo»28. Non solo,
quindi, il filosofo risulta sospetto in quanto offre una conoscenza sostitutiva a quella tradizionale, ma essa viene per di più percepita come
inutile! Effettivamente la filosofia si mostra nella sua teoresi, come
ricerca della conoscenza, la quale, non appartiene ancora al filosofo,
al ricercatore: ciò «contraddistingue il compito filosofico o, meglio, il
mestiere del ricercatore [Wissenschaftlerberuf]»29 in contrasto con gli
altri mestieri, che già posseggono una conoscenza, tramandata nella
prassi tradizionale. «Così, dunque, sorse un nuovo modello di “mestieri”, certamente inutili dal punto di vista pratico per il common
sense, sebbene legati alle loro epoche, analogamente agli altri mestieri (ad es. a quelli artigianali), proprio nella prassi»30.
Tuttavia, corrisponde questa impostazione della tradizione, del
common sense a ciò che prima è stata descritta come la fondazione
storica originaria della filosofia? Veramente la filosofia si propone di
essere contro la tradizione? Al contrario: questo non-sapere del filosofo significa che, «poiché non so, non penso nemmeno di sapere»31,
uscendo appunto dalla logica del contrasto tra conoscenze ed aprendo
alla dimensione del confronto. Se, dunque, nell’impostazione ingenua della tradizione la contrapposizione (Frontstellung) suppone il
contrasto tra due opposti, nella prospettiva filosofica invece diviene
28
Ivi, 78.
Ivi, 78.
30
Ivi, 60; il corsivo è mio.
31
Platone: “Ἀπολογία Σωκράτους”, I, in Enrico V. Maltese, cur.: Tutte le opere,
Roma: Newton, 1997, 73 (21 d).
29
110 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
il confronto fra differenze. Questo, che sia tra diverse religioni, modi
di produrre stivali, lingue straniere, ecc., è la base per percepire la
fessura della nostra torre, non come una crepa, una spaccatura della
tradizione, ma come un varco, una finestra che mostra del nuovo, che
può essere utile attuare o meno; come quando, sapendo parlare più
lingue straniere, si ha la libertà di scegliere di volta in volta con che
parole esprimersi, non cancellando una lingua a vantaggio dell’altra.
La tradizione del “noi” di provenienza, pur perdendo l’assolutezza di
validità, non viene annullata, come accade infatti per la lingua madre,
che non viene dimenticata, ma al massimo arricchita di neologismi.
Colui che è chiamato di persona a confrontare, possiede, quindi,
la libertà della scelta, appunto non già determinata in assoluto dalla tradizione. Secondo Husserl questo compito del confronto e della
scelta è ciò che identifica l’essenza dell’atteggiamento filosofico, ovvero la continua scoperta di nuove sfere di libertà.
Ci possiamo ‟liberamente” esimere da un agire-collettivo, dalla tendenza passiva dell’assumere incondizionato […] questa e, così, ogni tradizione […] Ma siamo in grado di fare ben altro. Possiamo liberamente
riflettere se dobbiamo sottrarci o meno a quella aspettativa qualora, nel
nostro orizzonte esperienziale, si presenti qualcosa di sfavorevole […]
In tale maniera, ci poniamo al di sopra della tradizione e così non ci
lasciamo più trascinare passivamente dall’aspettativa che nutriamo nei
suoi confronti e, quindi, dalla tendenza a cederle32.
Quello che non riesce più a garantire la tradizione, ad esempio
la validità assoluta dell’identità situazionale (che sia nazionale, religiosa ecc.), non è da considerarsi il segno di una sua non validità a
priori, ma l’apertura teoretica ad una rinnovata o alternativa sfruttabilità possibile. Si schiude in questo modo il campo di «quella verità
pratica che si chiama teoretica»33, nel quale «[a]ll’autonomia teoretica
succede quella pratica»34. Il filosofo, quindi, non boicotta la conoscenza pratica, anzi, attraverso la teoria le dà una rinnovata validità.
Con l’autonomia individuale rispetto alla tradizione, però, egli attua
inconsapevolmente una rivoluzione: grazie alla teoria, infatti, viene
32
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 73-74; il corsivo è mio.
Ivi, 105.
34
Husserl, “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, 37.
33
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 111
inevitabilmente inserita nella pratica la libertà personale, per cui, se
voglio, posso cambiare.
Coloro che, da un punto di vista conservatore, sono soddisfatti della tradizione entreranno in conflitto con coloro che appartengono all’ambito
filosofico, e tale lotta avverrà sicuramente anche nella sfera del politico.
La persecuzione incomincia già con gli esordi della filosofia. Gli uomini
che vivono per quelle idee sono guardati con sospetto. E tuttavia, le idee
sono più forti di qualsiasi forza empirica35.
Proprio grazie all’universalizzazione, il ‟mestiere del filosofo”
(Philosophenberuf) delineato da Husserl lega teoria e prassi, per cui
nella fenomenologia il compito di conoscenza teorico del filosofo è,
per essenza, molto pratico: una inconsapevole rivoluzionaria attività
di libertà. La filosofia è un «cambiamento totale di atteggiamento»36,
grazie al quale il filosofo non è più focalizzato alla sua momentanea
realizzazione, come ‛acquisizione umana’ «ossia come suo “possesso” [Habe]»37, quanto a ciò che viene prima (vor) dell’attualizzazione, ovvero al ‟proposito” (Vorhabe)38. Attraverso il proposito egli
progetta razionalmente la sua vita:
[a] questo voler-vivere e poter-vivere, come parte fondamentale di questo stesso vivere, serve dunque la conoscenza […] La conoscenza di per
sé è un proposito ed una operazione […] che è in grado di elevarsi, oltre
tutti i propositi pratici della vita e, appunto per ciò tramite, è funzionale
a questi propositi, ovvero al voler-vivere ed al poter-vivere39.
L’investigazione teorica del filosofo lo arricchisce delle possibilità pratiche, ovvero di ciò che ancora non è, ma può divenire. Se lui
vuole. Più egli, perciò, diviene consapevole di se stesso, più risulta
contemporaneamente inevitabile la rivoluzione di prospettiva che, inconsapevolmente attraverso se stesso, egli dona alla tradizione.
35
37
38
39
36
Husserl, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, 74.
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 70.
Ivi, 84 e cfr. seguenti.
Cfr. Edmund Husserl: La storia della filosofia e la sua finalità.
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 87; il corsivo è mio.
112 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Lo scienziato in divenire
Attraverso il “cosciente divenire di se stesso”, è l’esperienza in sé
del filosofo che assume una validità universale, in quanto «via che
per essere stata veramente praticata è sempre di nuovo praticabile»40.
Secondo Husserl, infatti, la scientificità della filosofia sta nella sua
validità come percorso “per tutti”; non intesa, però, come obbligatorietà generale, quanto come possibilità universale. «La filosofia, in
quanto teoria, non rende libero soltanto il filosofo, ma rende libero
anche qualsiasi uomo che si sia formato sulla filosofia»41. La rigorosa
essenza di quest’ultima consiste proprio nella possibilità “per tutti
e in ogni tempo” di essere rinnovata nella sua idea originaria. Nella
fenomenologia la filosofia si rivela scienza. «[L]a filosofia, in quanto
saggezza mondana, ha assunto la forma della filosofia come scienza
universale e rigorosa, in cui la ragione [Vernunft] si è plasmata e oggettivata nella figura del ‟logos”»42.
Ma come si oggettiva la ragione nel logos? Grazie all’ascolto di
questa ragione, che si esprime nelle ‟cose stesse”; in questo modo
la ragione diviene una voce, un logos che il filosofo può percepire.
Il filosofo è, dunque, colui che partecipa di questo dialogo razionale
con le cose stesse.
La gloria imperitura della nazione greca non è dovuta soltanto all’aver
fondato una filosofia nella forma di una cultura determinata da un interesse puramente teoretico, ma all’aver compiuto […] la creazione, unica
nel suo genere, dell’idea della scienza logica […] In tal modo il concetto
di logos, nel senso di una ragione autonoma e, innanzitutto, teoretica,
quale facoltà di un giudicare ‟disinteressato” che, in quanto giudicare
sulla base della pura comprensione evidente, presta ascolto unicamente
alla voce delle cose ‟stesse”, prende la sua versione originaria e al contempo la forza destinata a dar forma al mondo43.
Con ciò l’uomo (Mensch) diviene filosofo e dà vita ad una “metamorfosi logica”. Seguendo il logos della ragione l’uomo si soggetti40
42
43
41
Husserl, “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, 150.
Ivi, 37.
Husserl, “L’idea di Europa”, 66.
Ivi, 98; il corsivo è mio.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 113
vizza nel filosofo, che può formare il mondo oggettivizzandosi nello
scienziato. Si tratta qui della cosiddetta “oggettività soggettivo-relativa” analizzata da Husserl ne La crisi, secondo la quale l’oggettività
corrisponde all’auto-oggettivazione relativa ad ogni io-soggetto. Non
più passivamente pre-costituito dalla tradizione, infatti, l’io si fa soggetto nel dialogo, concretizzando attivamente se stesso e divenendo
così a sua volta un oggetto originario, visibile nel suo divenire. Non
essendo più una mera copia della tradizione, si mostra nella sua originalità, nella sua più propria libertà di scelta, quella dell’autocostituzione attiva. Emergendo dall’uniformità diviene qualcosa di percepibile e fruibile anche dagli altri: l’uomo in quanto filosofo diviene un
oggetto per il mondo, uno scienziato in divenire.
La scientificità sta nella ripetibilità di questo fenomeno, non però
in quanto sterile ritorno dell’uguale, ma come riattivazione originaria.
Quest’ultima è l’attivazione della possibilità di ascoltare in maniera
disinteressata, che dà appunto origine alla scienza fenomenologica.
Il compito del filosofo in quanto scienziato risulta, quindi, quello
di rendere questo logos razionale (vernünftig) da lui esperito, anche
un logos intellettuale (verständlich), in modo che esso possa essere
ri-compreso (Nach-Verstehen). «Solo in questo modo la conoscenza
scientifica può diventare patrimonio comune [Gemeingut], e quanto
è stato stabilito una volta può sussistere ‟oggettivamente” per chiunque, nel senso di un qualcosa che chiunque può comprendere in maniera evidente e, perciò, considerare identico»44. La ricomprensione a
sua volta offre ad altri una motivazione per la possibile scelta dell’esperienza di questo logos: vivendo in prima persona tale logos intellettuale lo si renderebbe nuovamente un logos razionale.
L’oggettività fenomenologica non è, dunque, da confondere con
quella ‟positiva” delle scienze naturali (Naturwissenschaften), per
le quali è sufficiente dedurre: «[l]’obiettivismo filosofico nella sua
forma moderna, con le sue tendenze fisicalistiche e con il suo dualismo psico-fisico, […] si sente benissimo nel ‟sonno dogmatico”»45.
Al contrario, nella fenomenologia «[n]on importa garantire le nozioni
obiettive, quello che conta è comprenderle […] Dedurre non equivale
a spiegare […] L’unica reale spiegazione è la comprensione trascen-
44
Ivi, 97.
Husserl, “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, 215.
45
114 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
dentale»46. Il filosofo secondo Husserl, cioè il fenomenologo, è chiamato per tutta la vita e attraverso la sua stessa esistenza a mostrare
(aufweisen) le proprie teorie; con ciò egli le verifica, le rende vere. Il
suo mestiere è di rendere le teorie comprensibili, non di dimostrarle
(beweisen). Questo mestiere si rivela, perciò, un compito di vita, per
il quale si vuole dover essere svegli e non dormire il “sonno della
ragione”. La razionalità dell’uomo filosofico, ovvero dello scienziato
fenomenologico, non è la «cattiva razionalità (schlechte Rationalität)
della ‟ragione pigra” (faule Vernunft)»47.
Cosa significa allora essere svegli? «Vivere desti vuol dire essere desti di fronte al mondo, essere costantemente e attualmente ‟coscienti” del mondo e di se stessi come di soggetti nel mondo, vivere
realmente, attuare realmente la certezza d’essere del mondo»48; ovvero la vita del filosofo nel suo essere uno scienziato in divenire.
[L]a filosofia scientifica […] permette di conoscere la totalità delle realtà e delle possibilità in modo ultimativo, procura la comprensione del
‟senso” del mondo e pertanto, la possibilità di una vita che ha il carattere
di una vita assoluta consapevole di sé e che vivendo realizza il senso assoluto del mondo, lo realizza nel conoscere, nel valutare [Werten], nelle
forme estetiche creative e nell’agire etico in generale49.
Il richiamo della tragicità
La situazione di vita del filosofo come “rivoluzionario inconsapevole” e “scienziato in divenire” rivela di questo mestiere (Beruf) una
certa obbligatorietà «per suo destino»50. Secondo Husserl alla filosofia appartiene per essenza un richiamo (Berufung), che muove necessariamente il filosofo «da una vocazione interiore apodittica […]
al riempimento del suo compito»51. Si tratta, infatti, di un vero e pro-
46
48
49
50
51
47
Ivi, 218.
Ivi, 45.
Ivi, 170.
Husserl, “L’idea di Europa”, 68-69; il corsivo è mio.
Husserl, “La storia della filosofia e la sua finalità”, 119.
Ivi, 119.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 115
prio “imperativo categorico volontario”: «egli è filosofo, ovvero sta
nell’apoditticità di dover volere la filosofia»52. Ciò implica, che
[i]l suo dover-essere, il dover-essere che deriva da un’autoresponsabilità
ultima, assoluta ed apodittica […] lo motiva […] ad una considerazione
[…] Prendere coscienza di me! Ecco, questo è già un nuovo inizio, il
prender coscienza di sé, in questa situazione, è la ‟possibilità” primaria
che permette <di> porre la filosofia in questione e <di> indagare sulle
sue condizioni53.
D’altra parte questo sentore (Ahnung) che «lo afferra apoditticamente»54 è comune a «tutti i filosofi, i quali vivono e debbono vivere
tutti apoditticamente»55. Questo “essere comune” tipico della filosofia
si realizza, quindi, per ogni filosofo nella personale presa di coscienza; ma ci si prende coscienza di sé con gli altri? Se il filosofo, per
essenza, è colui che “parte da sé”, deve essere di principio in solitudine: «ogni filosofo, che è il co-portatore di questo proposito [Vorhabe]
intersoggettivamente identico e apodittico, persegue le sue vie e, in
esse, ottiene la sua filosofia, quella che gli altri non sono in grado di
riconoscere come la filosofia»56.
Tutto ciò si dimostra essere proprio «la peculiarità paradossale di
una filosofia (la cui ‟possibilità” ha forse le sue difficoltà proprio in
questo aspetto)»57, il quale risulta inevitabile. Il filosofo è votato «per
suo destino»58 alla filosofia:
[e]gli è filosofo – non certo perché è una bella cosa l’essere professore
di filosofia o il poter diventare un uomo famoso; poiché se questo è il
suo vero obiettivo, non è questa affatto la filosofia. Di principio, essa
può essere obiettivo soltanto in una vocazione derivata da un imperativo
categorico, la quale né egli né chiunque altro potrebbe avergli imposto
dall’esterno ed il suo apodittico ‟devi” è il suo telos personale che gli
inerisce, come suo ‟obiettivo di vita”, già prima che egli vi volesse per52
54
55
56
57
58
53
Ivi, 120; il corsivo è mio.
Ivi, 120-121; il corsivo è mio.
Ivi, 120.
Ivi, 120.
Ivi, 122; il corsivo è mio.
Ivi, 123.
Ivi, 119.
116 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
venire (qualora vi pervenga), e già prima di formularlo come obiettivo
di vita59.
Il telos della filosofia, come idea che regge la storia della filosofia,
corrisponde, quindi, sempre e di nuovo ad un “auto-rinnovantesi io”:
[i]o, nel quale, proprio questo telos ha il luogo di un’esistenza effettiva,
ovvero di una forza direttiva pratica ed apodittica. Il telos esiste a partire
dal filosofo originariamente fondante in poi (esiste in quanto ricompreso
e apoditticamente assunto dagli uni e poi dagli altri) ed esso esplicita la
più profonda e particolare unità della comunità di tutti i filosofi, nell’unità della storia. Esso è parimenti il medesimo, la stessa idea di compito di
tutti loro, il polo ideale identico verso cui, in un’assoluta διάϑεσις, essi
sono diretti e concordi60.
Con una razionale realizzazione autonoma del suo io, il filosofo rinnova la filosofia. Quest’ultima, perciò, inizia sempre e di nuovo, mostrandosi quale principio in continuo divenire. Soltanto «con
la realizzazione di un simile nuovo inizio» il filosofo «comprende
in maniera autentica se stesso e questa certezza e supera la tragicità già consapevole [schon innegewordene Tragik] di una volontà
incondizionata che vede predelineato, solo in apparenza, un eterno
insuccesso»61. Effettivamente, quando il filosofo smette si giudicarsi
sotto la lente astratta della Filosofia e si valuta, invece, attraverso la
prospettiva vivente della propria esistenza filosofica, egli stesso vive
l’attuazione fenomenologica della Filosofia. Al fenomenologo non
appartiene l’ingenua presunzione di una completa determinazione
(Bestimmung) delle possibilità attualizzabili della Filosofia. La vuota
determinabilità della Filosofia non appare più come un nulla da riempire completamente, ma come un fenomeno di possibilità concrete
ancora da realizzare: una determinata indeterminatezza. Da un punto
di vista trascendentale la Filosofia rimane, perciò, essenzialmente indeterminata, anche quando il filosofo con la sua propria esperienza
la determina, poiché l’indeterminatezza della Filosofia si dimostra
essere proprio la necessaria condizione di possibilità (Bedingung der
59
Ivi, 120-121; il corsivo è mio.
Ivi, 120-121; il corsivo è mio.
61
Ivi, 129.
60
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 117
Möglichkeit) per la determinazione di qualsiasi filosofo. Attraverso
la sua stessa vita diviene, perciò, l’autodeterminazione del filosofo l’unica corrispondente realizzazione richiesta dall’indeterminata
Filosofia. Solo attraverso se stesso il filosofo può esperire la Filosofia
e con ciò realizzarla e contemporaneamente rinnovarla.
Husserl vede come mezzo appropriato al filosofo per la sua autodeterminazione «la critica esercitata nell’epoché»62, ovvero l’auto-critica. Nella sua costante messa in discussione il filosofo rivive e
così rinnova la «motivazione all’epoché»63. Come descritto, infatti, il
filosofo è colui che come impostazione di vita assume un «atteggiamento proprio dell’assenza di pregiudizi – nel senso, di porre fuori
azione, ovvero di rendere innocua, la tradizione»64, compresa quella
del sé. Ciò viene attuato da ogni filosofo in forma autonoma, ovvero
ogni filosofo assume il proprio io come campo fenomenologico delle
sue investigazioni. Alla critica appartiene, perciò, per essenza l’intenzione della trasformazione del proprio sé e non di quello degli altri.
Grazie ad una critica di questo genere
il senso complessivo di ‟filosofia” [è] trasformato in maniera essenziale
e, precisamente, tale che non rigetti quello antico, ma appunto lo trasformi soltanto in maniera tale che conferisce a quello il carattere relativo,
il quale può conseguire un’identità definitiva soltanto nella consapevole
considerazione della trasformazione65.
La tragicità del filosofo si dissolve quando l’evidenza dalla sua
intuizione di Filosofia «si trasforma nell’evidenza più propria dell’esperienza, di offrire di per sé soltanto ciò a cui si tende»66. E così per
tutti i filosofi:
[s]e è vero che i filosofi non assumono l’uno dall’altro i propositi,
i metodi, le filosofie fattualmente dati e che, allo stesso tempo, invece
aspirano alla filosofia nella comunanza della stessa aspirazione filosofica e nell’influenza reciproca – cosa si dà allora, se non un’unità
interna implicita in ognuno e vivente in tutte le filosofie, quand’anche
62
64
65
66
63
Ivi, 109.
Ivi, 129.
Ivi, 108.
Ivi, 125-126.
Ivi, 117.
118 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
non accolte dalla tradizione, la quale si trasmette mediante le ‟intuizioni” di quell’unica e medesima aspirazione – vale a dire quella della
filosofia?67
Noi europei
Il mestiere del filosofo si svela, perciò, essere un autonomo compito
comunitario. Il filosofo, infatti, assumendosi in maniera indipendente
il compito della sua filosofia, si lega spiritualmente ad altri filosofi: i
suoi predecessori, i suoi contemporanei, i suoi discendenti.
Qualsiasi filosofo compie le sue considerazioni in relazione con i filosofi
del passato e del presente. Egli si pronuncia su tutti i problemi che gli
si presentano, fissa, mediante queste discussioni, la propria posizione,
giunge così alla comprensione del suo proprio fare, comunque siano
sorte in lui le teorie che egli ha reso pubbliche, cosciente di ciò a cui
tendeva68.
Ogni filosofo, che vive la Filosofia in questo modo, appartiene
alla comunità filosofica. I componenti di tale comunità sono
uomini che, non nell’isolamento bensì nell’essere l’uno con l’altro e l’uno per l’altro, cioè nel lavorare in comune in modo collegato sul piano
interpersonale, perseguono ed elaborano teoria, nient’altro che teoria.
Con l’allargamento della cerchia dei collaboratori e nel succedersi delle
generazioni di ricercatori, la crescita e il costante perfezionamento di
tale teoria diventano infine una volontà, che ha il senso appunto di un
compito infinito, comune e generale69.
A questo tipo di comunità filosofica Husserl dà il nome di
“Europa”. «Il termine Europa allude evidentemente all’unità di una
[…] forma spirituale»70. La denominazione, quindi, trova le sue radici
in una mera motivazione storica:
67
69
70
68
Ivi, 116.
Husserl, “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, 101.
Husserl, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, 63; il corsivo è mio.
Ivi, 53.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 119
[l]a libera filosofia e la scienza come funzione dell’autonoma ragione
teoretica nascono nella nazione greca e determinano nel movimento
progressivo lo sviluppo di uno spirito generale di libera vita culturale fondato sull’autonoma ragione che si estende vittoriosamente oltre i
confini di questa nazione e crea l’unità di una cultura ellenica, e con ciò
lo specifico carattere europeo71.
La nascita dell’Europa in Grecia con l’entrata in scena della filosofia possiede, perciò, per Husserl un valore storico, ma relativo:
«[o]vviamente, ciò va inteso cum grano salis»72. Come per la statua
di Europa a Breisach, infatti, anche nella fenomenologia, la nomenclatura “Europa” non si riferisce al concetto meramente politico, bensì ad un’idea – «nel suo senso pregnante (platonico), un’idea-forma
[Formidee] universale di nuovo genere»73. Husserl vede nell’Europa
la comunità teoretica di sempre nuovi filosofi in costante divenire.
Cum grano salis deve, perciò, essere intesa sia la dimensione spaziale del fenomeno Europa (la Grecia, l’Unione europea, ecc.), quanto
la dimensione temporale. Quest’ultima indica sia la durata della vita
di ogni filosofo, tempo in cui la comunità filosofica viene attivamente
alimentata dalla singola filosofia del filosofo, sia l’essenziale atemporalità dello scambio filosofico generazionale. Il legame interpersonale
del filosofo con gli altri componenti della comunità filosofica si basa
sulla condivisione di un’idea filosofica. Questa compartecipazione
avviene sul piano trascendentale della teoria:
l’origine della scienza greca va cercata nel fatto che singoli uomini erano mossi dall’interesse che noi diciamo puramente teoretico, dal puro
amore per la conoscenza oggettiva, per la verità data nella comprensione evidente. La fissazione duratura della verità acquisita e la sua fondazione in forma letteraria hanno, per chi conosce, lo scopo non solo di
poterla riattualizzare in ogni momento in maniera evidente, di potersi
sempre e di nuovo allietare in essa, ma di poterne disporre quale premessa che è d’aiuto per la fondazione di nuove verità. La verità, una
volta acquisita, diviene così possesso e bene [Gut] permanente. Questa
fissazione, inoltre, serve alla trasmissione ad altri i cui interessi cono71
Husserl, “L’idea di Europa”, 81.
Ivi, 99.
73
Ivi, 99.
72
120 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
scitivi vengono così destati e permettono loro di condividere le stesse
evidenze e le stesse gioie […] il bene spirituale è di per sé patrimonio
comune [Gemeingut], la gioia gioia comune, dunque gioia raddoppiata
[…] – finché non subentrano interessi egoistici che guastano la purezza
dell’aspirazione ‟filosofica”74.
Diventando filosofo e donando la sua filosofia come scienza,
l’uomo sceglie di essere egli stesso un bene: attraverso la sua vita
scientificamente filosofica risulta un valore, che a sua volta può essere
assunto come comunitario, ovvero condiviso da un altro uomo che si
fa filosofo a sua volta. Con la Filosofia l’uomo si rivela un valore, un
bene per sé e per gli altri.
La filosofia teoretica husserliana si mostra, dunque, come una
prassi di vita quotidiana, un’impostazione di «vita razionale dell’uomo, che è eo ipso sociale»75, rendendo possibili «i valori “etici”, i
valori personali, individuali e comuni»76. Il filosofo è un mestiere autonomo, ma nell’Europa descritta da Husserl non si tramuta «in un
lavoratore dedito unicamente a un grande ingranaggio»77. Al contrario, la realizzazione del filosofo è già il porre in divenire la comunità
filosofica, l’Europa.
[C]’è una filosofia, e più precisamente una filosofia della prassi razionale di vita, che comprende una filosofia dei valori […] Al sapere autentico
segue l’azione. Al sapere autentico, vale a dire: soltanto colui che, in
prima persona, nel lavoro teoretico proprio della ragione […] possiede
quell’autentico sapere che motiva realmente la volontà. In questa svolta,
naturalmente, è in nuce innanzitutto lo sviluppo dell’etica78.
Ed ecco come, nell’Europa di Husserl, l’etica individuale vale
contemporaneamente come etica sociale.
L’Europa fenomenologica è formata dalla libera volontà di ogni
uomo che, fattosi filosofo, è autonomo. Questo tipo di volontà trova
origine direttamente da ogni iosoggetto autonomo, per cui la «comu74
76
77
78
75
Ivi, 99-100; il corsivo è mio.
Ivi, 103.
Ivi, 100.
Ivi, 127.
Ivi, 102; il corsivo è mio.
Sara Pasetto - L’‟Europa” secondo Husserl 121
nità filosofica [è], per così dire, comunistica [kommunistisch] e l’idea
guida [Leitidee] non [è] retta da alcuna volontà sociale onnicomprensiva»79, come invece accade in una comunità «imperialistica […] dominata da una volontà unitaria [einheitlichem Wille]»80. Secondo la
mia interpretazione della fenomenologia husserliana, ciò corrisponde ad «eine Ethik von unten»81, un’etica che proviene dal basso. La
portata di una tale idea è una fondazione fenomenologica, secondo
la quale è il filosofo a fare l’Europa e non l’Europa a modellare il
filosofo, o per la quale è l’Europa ad essere alla base dell’Unione europea e non viceversa. Da non confondere, dunque, con la Realpolitik
dell’Unione europea – per quanto non per forza in suo contrasto –,
la politica fenomenologica dell’Europa di Husserl poggia sull’«imperativo culturale categorico»82: «[l]a forma spirituale dell’Europa»83
è «[l]a cultura fondata sulla libera ragione [Vernunft]»84, dimensione
d’essere del filosofo.
Europa oggi
In una situazione come quella attuale, nella quale è palese la crisi
di qualsiasi “idea d’Europa”, compresa forse quella economicistica,
la rilevanza di un pensatore come Husserl è pressocchè nulla. Chi
pratica oggigiorno la tanto caldeggiata sospensione del giudizio? A
maggior ragione la descrizione etica non direttamente politica fatta
in questa sede appare come non focalizzata alla risoluzione dei problemi contingenti. Eppure Husserl mostra l’epoché come necessaria
per conseguire un autentico partire da sè, la concretissima posizione
di libertà, grazie alla quale si torna a se stessi, incarnando così la
Ivi, 106; il corsivo è mio.
Ivi, 106; il corsivo è mio.
81
Edmund Husserl: Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914, Hua
XXVIII, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1988, 414. Di
questo vol. XXVIII dell’Husserliana esiste una traduzione italiana parziale di Paola
Basso e Paolo Spinicci, Lineamenti di etica formale. Lezioni sull’etica e la teoria dei
valori del 1914, Firenze: Le Lettere, 2005; tuttavia il riferimento qui citato è tratto
dal testo Nr. 3 (1902) della sezione Ergänzende Texte, scritti che purtroppo non hanno
ancora avuto modo di essere stati tradotti in lingua italiana.
82
Husserl, “L’idea di Europa”, 121.
83
Husserl, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, 53.
84
Husserl, “L’idea di Europa”, 121.
79
80
122 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
propria idea. Fenomenologicamente, quindi, “Europa” non può indicare un ideale al quale dover adattarsi, ma un’impostazione di “vita
comunistica” non imposta dai dettami della Realpolitik. Attraverso
una fenomenologia huserliana così intesa è stata qui proposta non
una nuova idea, da sostituire a quelle che hanno ormai perso validità,
quanto una differente impostazione, grazie alla quale l’idea non funge
da astrazione intellettuale, ma da vivente razionalità.
Per quanto possa sembrare strano, questa possibilità fu storicamente attivata da «un paio di greci stravaganti»85. La filosofia non
è stata, perciò, trattata come disciplina strettamente intellettuale, ma
come mezzo che può permettere, come già avvenuto in passato, una
rivoluzionaria trasformazione esistenziale dell’uomo. Anche il filosofo non è, di conseguenza, il mero “professore di filosofia”, ma appunto l’uomo che da homo diventa humanus. Proprio il filosofo, infatti,
sulle tragiche orme socratiche, conosce i rischi derivanti da situazioni
critiche e la posizione etica del suo costante e libero divenire razionale lo rende competente nell’affrontare la “sua buia tempesta”. Ciò
si concretizza, però, non nella risoluzione dei conflitti derivati dalla
crisi, ma nell’apertura ad affrontarli “sempre e di nuovo” partendo da
sè in quanto parte integrante ed attiva del mondo. La libertà di scelta
di come vivere questi rischi è la dimensione di autonomia per la quale
la tradizione (che sia culturale, politica, ecc.) è un punto di arrivo e
non un punto di partenza. Al richiamo del proprio passato filosofico
l’attuale Europa è invitata per prima a mettere in discussione le proprie tradizioni. Ciò inizia fenomenologicamente sempre e solo dal
singolo individuo, per cui si può affermare che l’enigmatica sfida del
filosofo, consiste nell’essere l’origine, il principio dell’Europa: come
“il filosofo non può non definirsi europeo”, così l’Europa non esiste
senza filosofi.
85
Husserl, “La crisi dell’umanità europea e la filosofia”, 76.
Culture
Massimo Campanini
Sul pensiero islamico
Intervista raccolta da Alessandro Vigorelli Porro
InCircolo: Anzitutto La ringraziamo per averci concesso questa
intervista. Vorremmo cogliere questa occasione per farLe qualche
domanda su alcune caratteristiche del pensiero islamico – anche in
relazione all’odierna situazione – e sulle recenti direttive di ricerca
che sta sviluppando.
Partiamo dal punto centrale: siamo venuti a conoscenza che Lei
sta sviluppando un lavoro su Heidegger e l’idea di Dio nell’Islam.
Quali sono le ragioni per cui ha scelto di rivolgersi a un controverso
pensatore novecentesco come Heidegger per esplorare l’idea di Dio
nell’Islam?
Campanini: Su Heidegger si sta facendo un gran polverone. La questione dei Quaderni neri è stata opportunamente gonfiata per ragioni
di mercato. È lo stesso che per Carl Schmitt. Che siano stati o no per
qualche tempo compromessi col nazismo (lo furono di fatto, ma chi
non era nazista in Germania nel 1933? Si pensi a Gunther Grass. E
in Italia: Gentile? Lo stesso Croce è diventato anti-fascista col tempo. Solo 12 professori universitari si rifiutarono di giurare fedeltà a
Mussolini: erano tutti gli altri fascisti da crocifiggere postumi? Lo si è
tentato con Bobbio, un intellettuale cristallino che però in gioventù si
è adeguato all’onda dominante), Heidegger e Schmitt rimangono due
grandissimi pensatori (come lo rimangono il fascista Gentile o il comunista Gramsci – detto per coloro che demonizzano il comunismo). Ad ogni modo, il mio interesse per Heidegger è concentrato sulla critica alla metafisica. Soprattutto dopo la cosiddetta kehre, l’essere che
126 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
si ritrae ma contemporaneamente si manifesta nella “radura” degli
enti (almeno così io interpreto il suo pensiero) suona molto vicino al
Dio assente-presente dell’islam. Nell’Islam Dio è assente per quanto
la sua trascendenza lo colloca al di là e al di sopra del mondo degli
enti (per cui non può assolutamente incarnarsi in un “figlio”), mentre
è “più vicino all’uomo della sua vena giugulare” (Q. 50:16) (come
già dicevo nel mio primissimo libro, La Surah della Caverna, 1986 e
come dico, a trent’anni esatti di distanza, nel volume Philosophical
perspectives on Modern Qur’anic Exegesis, (Equinox 2016). So perfettamente che Heidegger non identificava l’essere con Dio, ma il suo
uso è teoretico non storico.
InCircolo: Heidegger muove profonde critiche alla tradizione metafisica ancorata alla filosofia greca, eppure sembra ravvisare proprio
nei primi filosofi greci la chiave di volta per uscire dagli impasse
posti dalla metafisica. Che posizione occupano, in questo quadro, i
pensatori islamici, come Avicenna, che hanno dato un impulso essenziale alla metafisica? Esistono altri studi che avvicinano Heidegger
al pensiero islamico, come, ad esempio, The phenomenological quest
between Avicenna and Heidegger, di N. El-Bizri: in che rapporto sta
il suo studio con i precedenti, e quali prospettiva mira a dischiudere?
Campanini: Il problema del rapporto dell’Islam con il pensiero greco antico è molto complesso. Provo a sfumarlo. In linea generale, di
primo acchito, i musulmani si resero subito conto che le categorie del
ragionare filosofico ellenico erano poco congruenti con quella che
potremmo chiamare la “razionalità” islamica, di tipo ortopratico, fortemente analogica, oltretutto profondamente radicata nella profezia.
Per cui, in linea di massima gli erano ostili. Tuttavia, moltissimi teologi musulmani, in primo luogo gli Ashariti e al-Ghazali (m. 1111),
apprezzavano moltissimo la logica aristotelica e la applicarono nelle
loro indagini. Addirittura, al-Ghazali, nel libro La retta bilancia (in
La Bilancia dell’azione e altri scritti, Utet 2005), individua le categorie del sillogismo aristotelico dentro il Corano! Lo stesso iper-tradizionalista hanbalita Ibn Taymiyya (m. 1328) scrisse una Confutazione
dei logici, ma adoperava tranquillamente il ragionamento deduttivo
nella sua qualità di giurista. Certo, i teologi musulmani non potevano
accettare alcune potenziali implicazioni della filosofia greca: l’eternità del mondo, la mortalità dell’anima, l’atomismo materialistico.
- Alessandro Vigorelli Porro 127
L’atomismo degli Ashariti e di al-Ghazali è occasionalistico, non
materialistico. Al-Ghazali ha scritto che i filosofi sono miscredenti
“solo” su tre punti: l’affermazione che il mondo è eterno; la negazione della conoscenza dei particolari da parte di Dio; la negazione della
resurrezione dei corpi. E qui arriviamo alla filosofia in senso stretto.
Innanzi tutto bisogna ricordare che esistono tre tipi di “filosofia”: la
falsafa, cioè la filosofia che nasce in relazione al pensiero greco e lo
dibatte (Kindi, Rhazes, al-Farabi, Avicenna, Avempace, Averroè…);
la hikma, letteralmente “saggezza”, “sophia”, che si pone problemi
analoghi alla falsafa ma con un sovrappiù di tinta religiosa e di fondamenti coranici (Kindi e Avicenna in certi loro risvolti “teologici”,
Ibn Tufayl, Suhrawardi…); e lo ‘irfan o ma’rifa, cioè la “gnosi”, una
“filosofia” intrisa di esoterismo che alla lunga si traduce in teosofia (Ibn ‘Arabi, Mulla Sadra e la scuola avicenniana di Persia, attiva
ancora oggi). Come si vede, c’è un progressivo décalage da un “razionalismo” più o meno puro (più puro quello di Rhazes, al-Farabi e
Avempace, molto meno quello di Avicenna e Averroè) a un approccio
ai problemi speculativi sempre più gnostico, anche se non irrazionale,
che finisce per cadere nel monismo con Ibn ‘Arabi e in parte Mulla
Sadra. A mio avviso, nonostante quanto ne pensino molti, musulmani
e no, la teosofia non è filosofia. Per me la filosofia si identifica col
razionalismo greco o con Cartesio. Una questione dirimente è quella
delle fonti: i filosofi musulmani conoscevano (quasi) tutto Aristotele in
maniera diretta (e parecchio dei suoi commentatori come Alessandro
di Afrodisia), poco o pochissimo Platone (in maniera diretta sempre,
ma avevano a disposizione molti sunti), conoscevano Plotino, ma lo
assimilavano ad Aristotele (vedi la cosiddetta Theologia AristotelisUthulujiyya Aristatalis, che in realtà è un sunto delle Enneadi), nulla
dei pre-socratici. Quindi subirono un forte marchio neo-platonico. Un
po’ banalizzando, si potrebbe forse dire che i filosofi musulmani erano
neo-platonici in metafisica (soprattutto erano attirati dalla gerarchia
emanatista plotiniana che utilizzavano per garantire la trascendenza
divina e contemporaneamente spiegare la “produzione” del mondo)
e aristotelici in fisica e logica. Ma naturalmente i due orientamenti
erano inestricabilmente intrecciati e si integravano a vicenda. Infine,
a parte pochissimi casi di anti-religiosità o indifferenza alla religione
(Rhazes che probabilmente era decisamente ateo e, almeno in superficie, Avempace), i filosofi musulmani erano, si sentivano e si professavano, appunto, musulmani, quindi legati al Corano e alla religione.
128 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Quanto a Nader al-Bizri e Avicenna, le riporto uno squarcio di un
mio articolo inedito:
Io credo che, in generale, la metafisica avicenniana sia essenzialmente ontologica secondo la definizione del Dâniš: «The subject-matter of philosophy is not a particolar thing; rather, it is absolute being
and thus absolute philosophy is absolute. […] All in all, the subject
matter of this one science (the first philosophy) is different from the
subject-matter of the other two sciences since its subject-matter is
the aspect of being which is being-qua-being”. Il ragionamento di
Avicenna è ben noto e si ripete in modo costante in tutte le sue opere.
Esiste un Essere assolutamente Necessario (wājib al-wujūd) in cui
l’esistenza coincide con l’essenza, e un essere contingente o possibile
che deriva la sua esistenza dal Necessario. Il possibile deve essere
obbligatoriamente tratto in esistenza dal Necessario ché altrimenti
sarebbe impossibile. Vi è dunque un principio di pienezza: tutto ciò
che può esistere esiste di fatto e ciò che non può esistere non potrà
mai esser tradotto in atto. Tutto ciò ha un’importante ricaduta teologica. Avicenna può bensì, per esempio nella Metafisica del Šifā’,
sostenere che Dio è causa efficiente (e non solo motrice) della realtà
onde salvaguardare il creazionismo coranico. Tuttavia, tale efficienza
è comunque necessitata: Dio deve far esistere in atto tutti i possibili,
pena la loro assoluta inesistenza (e dunque l’inesistenza del mondo
stesso). Il nostro è l’unico dei mondi possibili; e Dio non ha avuto alcuna facoltà di scelta nel “crearlo”, quindi non è assolutamente
(ab-solutus) onnipotente. Del resto, Avicenna non concepisce creazione ex nihilo. È bensì vero, infatti, che parla di creazione, ma egli
la intende soprattutto come passaggio dal non-essere all’essere e non
come innovazione o ibdā‘.
Inoltre, il Necessario Esistente possiede attributi positivi come
l’eternità, la volontà, la conoscenza, la stessa esistenza. Ora, la stessa
definizione di Dio come wājib al-wujūd abbassa e colloca Dio all’interno della dimensione ontologica e metafisica, cioè all’interno del
Sein. E ciò ovviamente in modo più evidente quando Avicenna scrive
in persiano (lingua indoeuropea dove esiste la copula, che non esiste
invece nelle lingue semitiche come l’arabo, con tutte le loro implicazioni ontologiche) piuttosto di quando scrive in arabo. Dio resta
comunque definibile in quanto “Essere”, sia pure come un essere particolare, l’unico Essere perfetto e Necessario tra esseri contingenti o
- Alessandro Vigorelli Porro 129
possibili. Nella terminologia di Heidegger, questo vuol dire continuare a non far differenza tra l’Essere e l’ente.
Se si aggiunge a queste motivazioni il principio di pienezza, appare chiaro come in Avicenna Dio rimanga collocato nella dimensione dell’immanenza o di una trascendenza solo imperfetta o parziale.
Nonostante Avicenna cerchi di trascendere la materia ponendo Dio al
vertice della gerarchia emanativa e frapponendo tra l’Uno e il sistema delle sfere e delle Intelligenze un “essere” intermedio secondo il
principio ex uno non fit nisi unum, Dio resta comunque connesso alla
catena emanativa e dunque dentro la realtà.
Perciò non risulta convincente, se pure stimolante, l’analisi della
metafisica avicenniana di Nader el-Bizri. Secondo el-Bizri, Avicenna
sarebbe anti-essenzialista perché sottolinea la primalità della causa
esistenziale (al-‘illa al-wujūdiyya) sull’essenza di una cosa. Questa
primalità della causa esistenziale risiede nel ruolo decisivo che essa
svolge appunto nel tradurre la cosa in esistenza (p. 99). È evidente
che questa causa che traduce il non-essere in essere, l’inesistente in
esistente (o in termini avicenniani il contingente in sé in necessario
per altro) è il Necessario Esistente, quello che in linguaggio teologico equivarrebbe a “Dio” (anche se al-Bizri evita accuratamente
di occuparsi degli aspetti teologici della dottrina avicenniana). Se
si volessero utilizzare termini aristotelici, si tratterebbe della causa
finale che, in quanto causa di completamento (cause of completion
[tamām]) è esterna al suo effetto (p. 98). Il fatto è che, secondo elBizri, la storiografia ha sempre conferito un’importanza esagerata (a
partire dal celebre, classico saggio di A.M. Goichon) alla centralità
della distinzione di essenza ed esistenza. Questa distorta prospettiva
esegetica ha sottaciuto importanti aspetti dell’ontologia avicenniana
dell’essere, ma soprattutto ha messo in ombra l’analisi ad un tempo
logica e metafisica dell’essere nei termini delle modalità di necessità,
contingenza e impossibilità (p. 129). Criticare il presunto essenzialismo di Avicenna significa, inoltre, rilevare come il pensatore persiano
riesca a superare l’ousiologia di Aristotele: «il superamento della ousiologia di Aristotele è attestato nell’indagine che Avicenna conduce
sul Necessario Esistente, il quale non è sostanza (ousia), né genere,
né specie, e neppure ha definizione, descrizione, quantità, qualità o
luogo. Il Necessario Esistente per se stesso è pura bontà e pura perfezione. E ciò perché l’esistenza/essere (wujûd) è perfezione» (pp.
144-145). Come si vede, el-Bizri ritiene che la perfezione dell’es-
130 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
sere in Avicenna consiste nell’esistenza e non nell’essenza; e inoltre
che la trascendenza e la separazione del Necessario Esistente rispetto
agli esseri contingenti, che sono gli effetti del Necessario Esistente in
quanto causa, ne fanno l’autentico essere, un essere non obliato ma
presente di fatto alla considerazione metafisica.
InCircolo: Abbiamo già toccato una delle idee fondamentali di
Heidegger la cosiddetta “differenza ontologica”: proprio questa differenza tra Essere ed ente ha attirato Heidegger verso la speculazione religiosa, come quella di Meister Eckhart per fare un esempio.
Quale ruolo gioca la differenza ontologica nella sua ricerca?
Campanini: Nella mia prospettiva, la qualità del Dio islamico che
si può trovare in Heidegger è quella dell’ipseità. Il termine arabo è
huwwiyya e vuol dire che “Dio è se stesso” (huwa huwa, una formula
che si può esprimere in questo modo perché, come detto prima, nelle
lingue semitiche non esiste la copula, qualcosa di analogo al biblico «ego sum qui sum»). Nella Lettera sull’umanismo (p. 56 dell’ed.
Adelphi 1995) Heidegger dice: «L’essere – che cos’è l’essere? Esso
è lui stesso». Un’assonanza singolare che bisognerebbe sviluppare
partendo da Parmenide. Ma sono solo all’inizio, vedremo tra qualche
anno in sha’ allah.
Conosco in maniera insufficiente, purtroppo, il pensiero di
Eckhart, per cui non azzardo collegamenti potenzialmente infondati.
La differenza tra essere ed ente, comunque, come chiarito più sopra,
è essenziale (Termine ad hoc!) per il fondamento metafisico della trascendenza islamica. Il Corano dice: «non v’ha di simile a Lui cosa
alcuna» (Q. 42:11: laysa ka-mithlihi shayy’), e ancora: «Nulla è pari
a Lui» (Q. 112:4: wa lam yakun lahu kufu’an ahad). Cioè gli enti, le
“cose”, sono irriducibili all’Essere/Dio. Qui sta uno degli equivoci
della mistica islamica - soprattutto, ed è quello che ci interessa, della
mistica filosofica tipo quella di Ibn ‘Arabi (m. 1240). Questo orientamento speculativo, infatti, traduce o “abbassa” l’essere nell’ente, o
meglio annulla l’ente nell’essere. In esistenza c’è solo l’Essere/Dio
(wahdat al-wujud). Nel migliore dei casi è monismo, nel peggiore è
panteismo: comunque, secondo me (anche se ovviamente i pensatori
di orientamento gnosticheggiante si affannano a negarlo), qualcosa
di nettamente non-islamico. Non è un caso che questo tipo di mistici
siano stati avvicinati a quelli cristiani. Al-Hallaj (m. 922) che credeva
- Alessandro Vigorelli Porro 131
che Dio si “incarnasse” in lui (nell’estasi al-Hallaj gridava: ana al-haqq, «io sono Dio»: nel senso che Hallaj non esisteva più, esisteva solo
Dio “infuso” – hulul in arabo – nel suo corpo) non per nulla è chiamato il “Cristo dell’islam” (cfr. Louis Massignon e Alberto Ventura).
Cristianesimo e Islam condividono molti presupposti sul piano storico e dell’ispirazione religiosa, ma ad un certo punto si divaricano
nettamente e irriducibilmente: i due dogmi fondamentali del cristianesimo, la Trinità e l’incarnazione, sono inaccettabili per l’islam.
InCircolo: In Heidegger l’Essere, quando pensato come movimento
di ritrazione in contrapposizione all’ente, confina con il concetto di
Nulla: al posto di una pienezza primigenia, in Heidegger veniamo
confrontati da uno spiazzamento originario, da una nascondimento e
una fuga che apre la scena per la manifestazione dell’ente. È possibile ritrovare anche questa traccia nel pensiero islamico, o su questo
punto le strade divergono?
Campanini: C’è un poeta mistico – considerato anzi il maggiore
poeta mistico dell’Islam – Jalaluddin Rumi (XIII secolo) che, nelle
parole di Alessandro Bausani concepisce «Dio come il valore assoluto, al di là del Bene e del Male. Di qui il senso vivissimo della
dialettica tra Essere e Nulla. Il Nulla è l’Essere e l’Essere è il Nulla.
Rumi usa continuamente i termini ‘creare’ e ‘creatore’ ma il suo vivo
senso della positività del Nulla implica che il creare sia un atto continuo di Dio» (Introduzione a Rumi, Poesie mistiche, Rizzoli). Anche
al-Ghazali e i teologi occasionalisti ashariti cui ho accennato prima,
in certo senso, concepiscono un Dio che lavora sul Nulla in maniera
continuativa, ma rimane in una prospettiva più “ortodossa” rispetto a
Rumi. Nel trattato sui Bei nomi di Dio, al-Ghazali spiega come segue
l’attività creativa: «Al-Khaliq, il Creatore. Al-Bari’, il Produttore. AlMusawwir, il Formatore. Si potrebbe pensare che questi nomi siano
sinonimi e che tutti si riferiscano alla creazione e all’innovazione.
Ma non necessariamente le cose stanno così. Piuttosto, ogni cosa che
viene tradotta dal nulla in esistenza ha bisogno, prima di tutto, di essere pianificata; in secondo luogo di essere originata in accordo col
piano [prefissato]; e in terzo luogo di essere formata dopo essere stata
originata. Dio – che sia lodato ed esaltato! – è creatore (khaliq) per
quanto è il determinatore (muqaddir); è produttore (bari’) per quanto
dà origine all’esistenza, ed è formatore (musawwir) per quanto ar-
132 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
rangia le forme delle cose innovate nel miglior modo possibile». La
creazione dunque consiste fondamentalmente in due tappe: trarre l’esistenza dalla non esistenza (il nulla) secondo un progetto razionale;
e quindi determinare l’esistenza secondo una forma specifica e leggi
proprie. Questo esclude assolutamente che Dio sia Nulla (il rischio
che corre Heidegger è quello di risucchiare l’Essere nel Nulla? Me lo
chiedo). Il fatto è che – e qui mi pare il discrimine fondamentale – i
teologi musulmani identificano l’Essere/Unico con Dio/uno (eredità
neoplatonica: lo fa anche s. Agostino, anche se poi Agostino parte
per la tangente trinitaria), mentre Heidegger non risolve il problema
dell’Essere: a un certo punto non sa più definirlo (il tempo? L’evento?
Il Nulla? O che so altro), per cui il suo sforzo rimane incompiuto e
l’Essere continua a sfuggire.
InCircolo: Ci conceda una domanda ispirata dall’attualità. Le correnti islamiche estremistiche, che hanno acquisito forza e riconoscimento pubblico nel corso del XX e XXI secolo, propugnano una versione “pura” dell’Islam, improntato a un ritorno alle origini e alla
corretta ortodossia tradizionale. Eppure questa tradizione, quando
la osserviamo attraverso le opere dei grandi filosofi e teologi medievali, ci appare molto più tollerante e aperta al confronto di quanto
ci si possa aspettare: si potrebbe quasi dire che il miglior antidoto
contro l’estremismo sia proprio la tradizione religiosa e filosofica. In
quest’ambito, quale pensa che sia il ruolo dello studio e dello studioso - accademico come amatoriale? Se la conoscenza delle fonti della teologia e filosofia islamica sembra squalificare ed esautorare gli
estremismi, si può parlare di un ruolo o una responsabilità “sociale”
per lo studioso e l’intellettuale?
Campanini: Nella mia più che trentennale attività di insegnante (ho
cominciato nel 1984) ho sempre sostenuto due cose: 1) che conoscere è l’unico modo per capire e convivere; 2) che la filosofia non
deve chiudersi in una torre d’avorio, ma aprirsi al mondo. Speculare
in sé è fondamentale (come diceva Averroè sulle orme di Aristotele,
si è felici solo pensando), ma la stessa riflessione su Dio deve avere
risvolti attivi. Il grande filosofo egiziano Hasan Hanafi (n. 1935), mio
maestro spirituale, ha scritto pianamente che «Dio non è un’idea, non
è Logos ma praxis» (Théologie ou anthropologie?, Gembloux 1972).
Averroè fra fiqh e filosofia
La ragione araba nel limbo
Wael Farouq
Why did Averroes’ influence on Arabo-Islamic culture stop after
his death until the 19th century? Why have attempts to recall him,
between the early 20th century and today, failed to counteract the
fundamentalists’ ascendancy on Arabo-Islamic societies? This paper
tries to find an answer to these questions, first in Averroes’ biography and his work as a judge, then in his Decisive Treatise, his most
circulated book and greatest achievement. I was able to highlight
several instances of the separation between reason and reality, the
main factor behind the failure of both Averroes’ experience in the
Arabo-Islamic cultural context of the past and of the attempts to revive his influence in modern times. This separation is still affecting the Arabo-Islamic culture today. Taking it into account can open
new perspectives on the comparison/dialogue between Western and
Arabo-Islamic philosophies.
Ibn ʻArabī (1165-1240) – il più grande sufi di tutti i tempi – ha documentato nelle Rivelazioni meccane, la più importante opera del sufismo, l’incontro avuto con Averroè, insieme al faqīh (giurista islamico) andaluso Ibn Jubayr (1145-1217). Un vero e proprio summit delle
tre componenti della cultura islamica: misticismo/sufismo; Legge
(sharia)/giurisprudenza islamica (fiqh); dimostrazione (burhān)/ filosofia. Un incontro di natura speciale, tuttavia, perché avvenuto con la
salma del filosofo andaluso.
134 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Averroè era stato sepolto mesi prima a Marrakesh, poi fu deciso
di seppellirlo nella città che gli aveva dato i natali, Cordoba. Un modo
per onorarlo o forse per fare ammenda. Cordoba, infatti, era la stessa
città che l’aveva cacciato e aveva bruciato i suoi libri. Per questo
voleva riportare indietro entrambi. La salma del filosofo fu appesa al
fianco di un cavallo, mentre all’altro, per bilanciarlo, furono appesi i
suoi libri. Ibn ʻArabī, testimone oculare, racconta la storia: “Quando
la bara nella quale giaceva il suo corpo fu posta sul cavallo, le sue
opere furono poste sull’altro lato per fare da contrappeso. Io stavo in
piedi in compagnia del faqīh Ibn Jubayr e del mio amico copista Abū
al-Ḥakam ʻAmr b. al-Sarrāj. Abū al-Ḥakam si voltò verso di noi e
disse: ‘Non vedete cosa fa da contrappeso all’imam Averroè sulla sua
cavalcatura? Quello è l’imam e quelle sono le sue opere.’ Ibn Jubayr
disse: ‘Ben visto, ragazzo mio! Che Dio ti doni eterna giovinezza!’. E
lo annotai per promemoria e monito.”1
Di fronte al corteo funebre di Averroè e dei suoi libri, rimangono
tutti silenziosi. Solo il copista parla, anche se non è nella sua natura
parlare, dato che il suo lavoro consiste nel copiare e registrare. Egli
dice: “Quello è l’imam e quelle sono le sue opere”. Forse perché, essendo un copista, vive con i libri – o nei libri – proprio come Averroè
che “dal momento in cui acquisì la facoltà di ragionare, non cessò mai
di leggere e riflettere, eccetto la notte della morte di suo padre e delle
sue nozze”.2 Nello spostamento di Averroè da una tomba all’altra, il
copista vede soltanto i suoi libri e il faqīh, che solo pochi anni prima
aveva contribuito a perseguitare Averroè, commenta le parole del copista con “ben visto”, non con “ben detto”. Cosa ha visto il copista
che gli altri non hanno visto? L’uscita dalla tomba di Averroè è una
resurrezione anticipata e ora viene giudicato. Là, su una bilancia, il
suo corpo su un piatto, le sue opere sull’altro piatto, Averroè si trova
dove l’ha messo Dante nella Divina Commedia: nel limbo, a errare
fra un sepolcro e l’altro, il suo corpo sospeso assieme ai suoi libri su
una bilancia che non pende né da una parte né dall’altra.
Oggi, passati oltre otto secoli dall’uscita di Averroè dalla tomba, come guardiamo a questa resurrezione? Lo scrittore marocchi Muḥyī al-Dīn b. ʻArabī: Al-futūḥāt al-makkiyya (Le rivelazioni meccane), a cura
di ʻUṯmān Yaḥyā, Il Cairo: Supremo Consiglio per la Cultura, 2, 1985, 373.
2
Ibn al-Abbār: Takmila li-kitāb al-ṣila (Complemento al dizionario biografico), Il
Cairo: Dār al-saʻāda, 1, 1955, 496.
1
- 135
no ʻAbd al-Fattāḥ Kilīṭū afferma che “l’esilio della salma di Averroè
avrebbe assunto, per quanto ci riguarda, un significato preciso: il rifiuto di Aristotele e la deportazione della filosofia nei Paesi latini”.3 Il
filosofo marocchino Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī, invece, sostiene che
“Averroè vive ancora, è la nostra tradizione”, perché “la tradizione
sono i morti che vivono in noi”.4 Ed ecco che Averroè si sposta in
un’altra tomba ancora, questa volta di carne e sangue, perché la frase
di al-Jābirī fa di noi delle tombe, mantenendo il filosofo nella condizione di salma: una salma che vive in noi.
Le proposte di Averroè sono scomparse sotto cumuli di confusione e substrati di storia. La ragione arabo-islamica, fino all’inizio del
ventesimo secolo, non le ha mai lette e più precisamente fino al 1903,
anno in cui lo scrittore libanese Faraḥ Anṭūn pubblicò il libro Averroè
e la sua filosofia. Anṭūn era alla ricerca di una “radice” della modernità nella tradizione islamica. Cercava un faqīh capace di promulgare
una fatwā che decretasse la legittimità della modernità. Lo trovò in
Averroè, il quale aveva formulato una fatwā che legittimava la riflessione razionale, l’essenza dell’agognata modernità. Fu così che ebbe
inizio una serie di riscoperte di Averroè, l’ultima delle quali negli anni
’90 del secolo scorso. Su di lui si sono tenuti convegni, scritti articoli
ed è persino stato prodotto un colossal cinematografico del regista
Palma d’oro al Festival di Cannes Yūsuf Šāhīn. Il titolo era estremamente significativo: Al-Maṣīr, il destino. L’élite culturale e i regimi di
governo arabi stavano combattendo una battaglia illuminista contro le
correnti religiose oscurantiste e il terrorismo che queste praticavano
in nome della religione. Ad Averroè toccò un’altra volta difendere
l’armonia fra la tradizione islamica e il razionalismo (o la modernità),
rimuovendo la contrapposizione immaginaria fra la ragione e i testi
sacri (Corano e Sunna) custoditi dalla trasmissione orale (naql), fra
filosofia e sharia, tradizione e modernità, tempo delle origini ed epoca
contemporanea.5
ʻAbd al-Fattāḥ Kilīṭū: La langue d’Adam, Casablanca: Dār Tūbqāl, 1995, tr. ar.
di ʻAbd al-Kabīr al-Šarqāwī, Lisān Ãdam, Casablanca: Dār Tūbqāl, 1996, 65.
4
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: Naḥnu wa-l-turāṯ. Qirā’āt muʻāṣira fī turāṯi-nā
al-falsafī (Noi e la tradizione. Letture contemporanee della nostra tradizione filosofica), Casablanca: Al-markaz al-ṯaqāfī al-ʻarabī, 1985, 113.
5
Cfr. ʻĀṭif al-ʻIrāqī: Ibn Rušd wa-mustaqbal al-ṯaqāfa al-ʻarabiyya (Averroè e il
futuro della cultura araba), Il Cairo: Al-hay’a al-ʻāmma li-l-kitāb, 2004.
3
136 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Tuttavia, l’Averroè del passato complica un po’ le cose per l’Averroè del presente: è l’Ibn Rušd arabo-musulmano, emarginato dalla
tradizione, il cui centro è stato invece occupato da al-Ġazālī, nella teologia, nel fiqh, nella filosofia e nel sufismo? Oppure è l’Averroè latino, uno degli ispiratori dell’illuminismo europeo? La faccenda non si
limita al dualismo temporale (passato/presente) e spaziale (occidente/
mondo arabo-islamico). C’è un altro dualismo di natura epistemologica ancora più importante, quello fra filosofia e sharia. Averroè è
stato un filosofo che ha tratto in inganno i giuristi islamici (fuqahā’)
con i suoi scritti religiosi, perché il suo vero pensiero era da ricercarsi
nei suoi commentari ad Aristotele? Oppure è stato un faqīh che si
è giovato della filosofia per rinnovare il pensiero religioso? Oppure
ancora, come sostiene lo studioso egiziano Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, è
“l’estensione di una tradizione razionalista emarginata, il cui tentativo di uscire dall’emarginazione l’ha costretta a fare concessioni che
hanno aumentato la sua emarginazione?”6
Averroè “avrebbe continuato a vivere nel nord, in Europa, dove
l’averroismo si sarebbe imposto. La sua filosofia sarebbe divenuta una delle fonti principali dell’impulso che, a Parigi, Padova e
Oxford, avrebbe investito il cuore della civiltà europea: l’università”.7
Tuttavia, l’esperienza di Averroè nel nord è stata solo una nota a margine dell’esperienza di Aristotele. L’interesse per il filosofo andaluso
non è mai stato diretto a lui stesso, ma a lui in quanto mediatore del
protrarsi di un’esperienza umana, quella di Aristotele, di cui lui ha
conservato i frutti intellettuali. La miglior prova di ciò è che nemmeno
gli studiosi europei di Averroè hanno mai prestato attenzione alla sua
vita di giudice, faqīh e essere umano, se non per sottolineare e spiegare il suo ruolo di mediatore.8 Chi è, dunque, il responsabile di questo?
A nostro avviso Averroè stesso, perché è stato il primo a marginalizzare la sua esistenza umana. Non ha lasciato nessuna autobiografia
e nient’altro che le somigli, a eccezione di due paragrafi riportati da
ʻAbd al-Wāhid al-Marrākišī nel suo libro Al-Muʻjib (L’ammiratore),
trasmessi oralmente da uno studente di Averroè. In uno di questi pa Naṣr Ḥāmid Abū Zayd: Al-ḫiṭāb wa-l-ta’wīl (Discorso e interpretazione),
Casablanca: Al-markaz al-ṯaqāfī al-ʻarabī, 2000, 57.
7
ʻAbd al-Fattāḥ Kilīṭū: Lisān Ãdam, 65.
8
Cfr. Ernest Renan: Averroès et l’averroïsme; essai historique, Parigi: Calmann
Lévy, 1882, tr. ar. di ʻĀdil Zaʻītir, Ibn Rušd wa-l-rušdiyya, Il Cairo: Dār iḥyā’ al-kutub al-‘arabiyya, 1957.
6
- 137
ragrafi, il filosofo parla del suo primo incontro con l’emiro. Nel secondo, racconta di come il filosofo Ibn Ṭufayl (1105-1185) gli abbia
suggerito di chiedere all’emiro il permesso di fare un compendio dei
libri di Aristotele. A parte questi due paragrafi, non si trova quasi nulla in cui lui parli di sé, tranne qualche frase annotata a penna fra le
pieghe di questo o quel libro, dove accenna molto succintamente alle
ricerche scientifiche che ha fatto o intende fare, ai libri che ha scritto
o intende scrivere, o al motivo che lo ha spinto a comporre questo o
quel libro. In altre annotazioni, dà informazioni sui suoi spostamenti
fra Cordoba, Siviglia e Marrakesh, appuntando fugaci osservazioni
con frasi molto concise, oppure esprimendo la propria esultanza, o
amarezza, per questioni legate alla sua posizione di filosofo. Nel complesso, tutto ciò che di personale Averroè ha raccontato o annotato
non esce mai dall’ambito del suo percorso scientifico.9
Le biografie di personaggi illustri (kutub al-tarājum) che parlano
di Averroè citano solo le tappe importanti della sua vita, non si discostano mai dalla sua genealogia, dai suoi studi, dai suoi incarichi, dai
suoi libri e dalla sua morte. Poi, compensano la mancanza di informazioni personali con frasi del tipo: “Nessuno fra coloro che sono
cresciuti in Andalusia fu dotato di maggior perfezione, conoscenza
e virtù”.10 Oppure: “Nonostante la sua nobiltà, era la più umile e misericordiosa delle persone”.11 Oppure ancora: “Fu nominato giudice
di Cordoba ed elogiato da tutti. Acquisì grande prestigio presso i sovrani, ma non ne approfittò per migliorare la sua posizione, né per
accumular ricchezze. Si limitò a usarla per il bene della sua gente e
l’utilità degli andalusi in generale”.12
Queste e altre frasi tracciano un ritratto idealizzato del filosofo-simbolo. Un’abitudine tipica della ragione araba che, fino a oggi,
non si è mai liberata delle tradizioni delle società orali, le quali, per
preservare le virtù, sono solite creare figure simboliche che le incarnano. Così, per esempio, Ḥāṭim al-Ṭā’ī è l’emblema della generosità,
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: Ibn Rušd, sīra wa-fikr (Averroè, biografia e pensiero) Beirut: Markaz dirāsāt al-wiḥda al-ʻarabiyya, 2001, 23; ʻAbd al-Fattāḥ al-Tilīlī:
Ibn Rušd fī-l-maṣādir al-ʻarabiyya (Averroè nelle fonti arabe), Il Cairo: Supremo
Consiglio per la Cultura, 2002, 73-76.
10
ʻAbd al-Fattāḥ al-Tilīlī: Ibn Rušd fī-l-maṣādir al-ʻarabiyya, 73-76.
11
Ibn al-Abbār: Takmila li-kitāb al-ṣila, 196 e seguenti.
12
Muḥammad b. ʻAbd al-Malik al-Anṣārī: Al-ḏayl wa-l-takmila (La coda e il complemento), a cura di Iḥsān ʻAbbās, Beirut: Dār al-Ṯaqāfa, 1, 1973, 22.
9
138 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
al-Samawāl quello della lealtà, Luqmān quello della saggezza. Nel
deserto, infatti, dove il movimento del tempo non conserva nulla, le
virtù hanno bisogno di figure simboliche per essere salvaguardate. La
vita di una persona ordinaria non è degna di essere ricordata, né di
dimorare nella memoria, per la quale vale la pena sacrificare persino
la realtà.13
Ciò che un ricercatore scrupoloso può sapere della vita di Averroè
dipende fondamentalmente dalla sua abilità di interpretare le frasi che
il filosofo ha sparso nei suoi libri e riempire con esse i vuoti del modello idealizzato tradizionale offertoci dalle biografie dei personaggi
illustri.14 Ciononostante, si tratterà sempre della ricostruzione della
vita del filosofo, non di quella dell’uomo.
Perché Averroè non si è preoccupato di scrivere la sua autobiografia, né se n’è occupato qualcuno dei suoi studenti o figli? Il comportamento del filosofo è atipico, sembra una rottura con le tradizioni.
I suoi predecessori e successori hanno avuto cura di documentare, o
dettare, le proprie autobiografie. L’hanno fatto al-Ġazālī e Avicenna
prima di lui, Ibn ʻArabī e Ibn Ḫaldūn dopo di lui. L’atteggiamento di
Averroè, dunque, non è solo “umiltà e negazione di sé”.15 La sua è
una presa di posizione intellettuale, un modo di riflettere sulla vita o
di riproporre un modello di relazione fra ragione e realtà tipico della
tradizione islamica. Infatti, la crisi della ragione arabo-islamica non
è imputabile soltanto alla persecuzione e all’emarginazione che essa
ha dovuto subire nella storia,16 bensì, in primo luogo, alla scelta del
suo oggetto d’indagine. La crisi non consiste, come sostengono gli
studiosi della tradizione islamica, nella mancanza di razionalismo,
bensì nella rottura della relazione fra la ragione e il suo vero oggetto
d’indagine: la realtà umana. Con ciò s’intende la vita quotidiana vissuta e praticata, la cui assenza, nella tradizione filosofica islamica, è
impressionante, potendosi osservare che “la storia della filosofia, nella civiltà arabo-islamica, presenta due aspetti: uno politico-ideologico, l’altro teorico-intellettuale. Infatti, la necessità della filosofia, così
Wael Farouq: “Alle radici della ragione araba”, in Benedetto XVI e altri: Dio
salvi la ragione, Siena: Cantagalli Edizioni, 2007, (49-92), 81.
14
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: Ibn Rušd, sīra wa-fikr, 24.
15
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: Ibn Rušd, sīra wa-fikr, 24.
16
Naṣr Ḥāmid Abū Zayd: Al-ḫiṭāb wa-l-ta’wīl, 21.
13
- 139
come la necessità di combatterla e soffocare i filosofi, è sempre stata
dettata, direttamente o indirettamente, da considerazioni politiche”.17
L’atto filosofico, nella cultura arabo-islamica, è sempre stato, fin
dalle origini, un atto politico. Di conseguenza, la sua relazione con la
realtà umana e la vita quotidiana delle persone è sempre stata contrassegnata dalla strumentalizzazione. I filosofi non sono mai partiti dalla
realtà vissuta della gente. La forza motrice dell’atto filosofico è sempre stata la lotta politica per la conquista del potere, cosa che ha impresso alla filosofia islamica il suo carattere polemico e conflittuale,
concludentesi nella scomunica altrui. L’ha fatto notare Averroè stesso
nella sua risposta ad al-Ġazālī, in cui lo accusava di mancare di “virtù
scientifica”, non occupandosi egli di scienza per amor di scienza, ma
deridendola per scopi non pertinenti. È quanto ha fatto, per esempio,
nel libro L’incoerenza dei filosofi, nel quale ha affermato che il suo
scopo era disturbare i filosofi e metterne in dubbio fondamenti e risultati. Ma questa è una cosa disdicevole per uno scienziato – secondo
Averroè – perché “in quanto tale, lo scienziato ha per obiettivo la
ricerca della verità, non seminare dubbi e confondere le menti”.18
La scienza del kalām – una delle prime manifestazioni della filosofia islamica – si sviluppò nel quadro del conflitto per il potere fra le
fazioni politiche e dottrinali in cui era diviso il mondo islamico dopo
la grande fitna, la prima guerra civile seguita all’assassinio del califfo
ʿUṯmān nel 657. Nel corso della storia, la scienza del kalām continuò
a essere oggetto di strumentalizzazioni ideologiche di vario grado da
parte dei diversi protagonisti di questo prolungato conflitto.19 Anche il
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: introduzione ad Averroè: Faṣl al-maqāl fīmā bayn
al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl (Trattato decisivo sull’accordo della religione con
la filosofia), Beirut: Markaz dirāsāt al-wiḥda al-ʻarabiyya, 2002, 13.
18
Averroè: Tahāfut al-tahāfut (L’incoerenza dell’incoerenza), a cura di Sulaymān
Jumuʻa, Il Cairo: Dār al-maʻārif, 1, 1964, 16.
19
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: introduzione ad Averroè: Faṣl al-maqāl, 16. Si veda
anche: Muṣṭafā ʿAbd al-Rāziq: Tamhīd li-tārīḫ al-falsafa al-islāmiyya (Introduzione
alla storia della filosofia islamica), il Cairo: Maṭbaʿat lajnat al-taʾlīf wa-l-tarjama
wa-l-našr, 1994, 284; Naṣr Ḥāmid Abū Zayd: Al-ittijāh al-ʿaqlī fī al-tafsīr, dirāsa fī
qadiyyat al-mijāz fī-l-Qurãn ʿinda al-muʿtazila (La corrente razionalista nell’esegesi,
uno studio della questione della metafora nel Corano secondo i Mutaziliti), Beirut:
Dār al-tanwīr, 1993, 11-42; Naṣr Ḥāmid Abū Zayd: Al-naṣṣ, al-sulṭa, al-ḥaqīqa, alfikr al-dīnī bayna irādat al-maʿrifa wa- irādat al-sulṭa (Il testo, il potere, la verità,
il pensiero religioso fra volontà di conoscenza e volontà di potere), Casablanca: Almarkaz al-ṯaqāfī al-ʿarabī, 1995, 69; Naṣr Ḥāmid Abū Zayd: Al-ḫiṭāb wa-l-ta’wīl,
17
140 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
movimento di traduzione filosofica si legò al potere. Come documenta Ibn al-Nadīm, Aristotele fu chiamato sul campo del dibattito teologico per ordine del califfo Abbaside Al-Ma’mūn (786-833), dopo che
il filosofo greco gli era apparso in sogno per spiegargli le vie migliori
che conducono alla vera conoscenza.20
Pur mutando forma di continuo, questo conflitto si protrasse nella
storia, portando tutti i grandi filosofi a schierarsi in fazioni. Basti citare l’esempio di al-Kindī, legato al califfo al-Muʻtaṣim bi-llāh (794842); di al-Farābī, legato a Sayf al-Dawla al-Ḥamdānī (916-967); di
Avicenna che fu primo ministro e fondatore della filosofia orientale;
di al-Ġazālī, legato al ministro Niẓām al-Mulk e al califfo Mustaẓhir
bi-llāh (1078-1118), per il quale scrisse il libro Faḍā’iḥ al-bāṭiniyya wa-faḍā’il al-mustaẓhiriyya (I vizi dei Bāṭinī e le virtù dei
Mustaẓhirūn), spinto, come da lui stesso confessato, dalla “ricerca di
prestigio e celebrità”.21 Altri esempi sono Ibn Ṭufayl e Averroè, legati
allo Stato Almohade in Andalusia (1147-1269). Conseguentemente,
la filosofia divenne uno strumento in mano al potere per fronteggiare
– anzi, assaltare fisicamente – i propri nemici. Come esempio bastino
i tribunali d’inquisizione mutaziliti, fra le cui vittime venne a trovarsi anche l’imam Aḥmad b. Ḥanbal, fondatore della scuola hanbalita,
una delle quattro principali scuole di giurisprudenza islamica oggi
esistenti.22
23; ʿAbd al-Majīd al-Ṣaġīr: Al-maʿrifa wa-l-sulṭa fī al-tajriba al-islāmiyya (La conoscenza e il potere nell’esperienza islamica), il Cairo: Al-hayʾa al-ʿāmma li-l-kitāb, 2010, 50; Ḥusayn Murawwa: Al-nizāʿāt al-māddiyya fī-l-falsafa al-ʿarabiyya
al-islāmiyya (I conflitti fisici nella filosofia arabo-islamica), Beirut: Dār al-Farābī, 1,
1981, 550.
20
Ibn al-Nadīm: Kitāb al-fihrist (L’indice), a cura di Gustav Flügel, Beirut:
Maktabat al-Ḫayyāṭ, s.d., 243.
21
Al-Kindī: “Kitāb al-Kindī ilā al-Muʻtaṣim bi-llāh fī-l-falsafa al-ūlā (Il libro di
al-Kindī per al-Muʻtaṣim bi-llāh sulla filosofia prima)”, in Rasā’il al-Kindī al-falsafiyya (Epistole filosofiche di al-Kindī), Il Cairo: Dār al-fikr al-ʻarabī, 1978, (32-35);
al-Farābī: Kitāb al-milla (Il libro della religione), Beirut: Dār al-Mašriq, 1986, 47;
Al-Ġazālī: Faḍā’iḥ al-bāṭiniyya wa-faḍā’il al-mustaẓhiriyya (I vizi dei Bāṭinī e le
virtù dei Mustaẓhirūn), a cura di ʻAbd al-Raḥmān Badawī, Kuwait: Dār al-kutub
al-ṯaqafiyya, 1964, 2.
22
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: Al-muṯaqqafūn fī-l-ḥaḍāra al-ʻarabiyya: miḥnat
Ibn Ḥanbal wa-nakbat Ibn Rušd (Gli intellettuali nella civiltà araba: l’ordalia di Ibn
Ḥanbal e la disfatta di Averroè), Beirut: Markaz dirāsāt al-wiḥda al-ʻarabiyya, 2014,
77.
- 141
In questo modo, la filosofia abbandonò il suo ambito di lavoro:
la vita umana. Questa fu interamente lasciata nelle mani dei fuqahā’
che, nel corso dei secoli e in ogni circostanza storica, non hanno mai
perso il controllo sulla gente comune. È stato questo controllo il motivo principale delle disfatte dei filosofi, perché i governanti hanno
sempre preferito sacrificare loro per soddisfare i fuqahā’ e, di conseguenza, il popolo. Oggi nulla è cambiato, sembra, perché la presenza
nello spazio pubblico dell’Averroè “riscoperto” è sempre dipendente
dalla volontà del potere e limitata alle sue necessità, senza spingersi
mai oltre la critica dei suoi nemici per criticare il potere stesso. Di
conseguenza, ogni tentativo di riscoperta di Averroè ha portato alla
disfatta di qualche suo discepolo.
Averroè, giudice e faqīh
Le biografie di personaggi illustri si riferiscono ad Averroè come al
nipote, per distinguerlo dal padre e dal nonno. Infatti, il nonno di
Averroè (1058-1126) fu gran giudice di Cordoba e il più grande faqīh dell’Andalusia. Anche il padre fu giudice di Cordoba (1137) ed
entrambi, verso la fine della loro vita, lasciarono la giustizia per dedicarsi all’insegnamento e alla scrittura. Averroè, dunque, è il rampollo
di una delle più venerabili famiglie andaluse che ha sempre esercitato
il fiqh, la fatwā e la leadership.23
Sappiamo, dalla storia arabo-islamica, che il fiqh era antagonista
della filosofia. Sappiamo inoltre che, nell’epoca in cui Averroè studiò
e trascorse la sua giovinezza, i fuqahā’ dell’Andalusia esercitavano la
massima autorità, non solo sul pensiero e sulla cultura, ma anche sulla
società e sulla politica. Come giunse Averroè alla filosofia? Perché
si specializzò in questo campo, contrariamente ai suoi antenati e discendenti che, come tutti i loro avi, lavorarono sempre nei palazzi dei
califfi, nel ramo della giustizia, del fiqh e della medicina?24
Averroè pare avulso dal contesto in cui è cresciuto. Sembra un
momento fugace di rottura epistemologica. Tuttavia, la sua atipicità
dipende dal fatto che in lui vediamo soltanto il filosofo – come faceva
egli stesso – ma in realtà Averroè era fondamentalmente un faqīh,
ʻAbd al-Fattāḥ al-Tilīlī: Ibn Rušd fī al-maṣādir al-ʻarabiyya, 16-18.
Ivi, 21-22.
23
24
142 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
abile quanto il padre e il nonno, che praticava la giustizia come loro.
“Si ricorreva a una sua fatwā nel fiqh come a un suo parere medico”.25
I suoi primi scritti appartengono alla sfera del fiqh, con il libro Alḍarūrī fī uṣūl al-fiqh (I fondamenti necessari del fiqh), alla cui composizione si dedicò all’età di trentadue anni.26
Senonché, quel faqīh crebbe in un contesto ostile alla scienza del
kalām che invitava ad abbandonare l’eredità delle sette islamiche
per ritornare alle radici incontestabili della religione: il Corano e la
Sunna autentica. Quest’appello rappresentava la politica ufficiale dello Stato Almohade. Il suo fondatore, Ibn Tūmart (1080-1130), aveva
per motto “l’abbandono della tradizione e il ritorno alle fonti”, cosa
in cui al-Jābirī ha visto la continuazione del progetto ẓāhirī (opposto
a bāṭinī, cioè dipendente da un significato manifesto e letterale del
testo sacro) del giurista e filosofo andaluso Ibn Ḥazm (994-1064).27
Ciò coincise con una tendenza razionalista e un ritorno ad Aristotele,
come si osserva in Avempace28 (1095-1138) e Ibn Ṭufayl. Così, “l’affrancamento dalla scienza del kalām in Andalusia liberò il discorso
filosofico, fin dalla sua comparsa con Avempace, dalla problematica
di conciliare ragione e trasmissione orale, filosofia e religione; mentre
l’affrancamento dalla filosofia religiosa ermetica liberò quello stesso
discorso dall’uso della scienza per integrare la religione nella filosofia
e la filosofia nella religione, compito che aveva tenuto occupata la filosofia in Oriente. Ciò significa che la filosofia, quando comparve nel
Maghreb e in Andalusia, comparve come una filosofia dimostrativa e
razionalista fin dall’inizio”.29
Il motto dello Stato Almohade – del quale Averroè era uno dei
rappresentanti illustri – fu la base da cui partì il filosofo per giungere
alle fasi più mature della sua filosofia e del suo fiqh. Questo in un
tempo in cui gli altri filosofi erano prigionieri della “confusione fra gli
interrogativi della scienza del kalām e della filosofia”, come dice Ibn
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: Ibn Rušd, sīra wa-fikr, 89.
Ivi, 77.
27
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: introduzione ad Averroè: Al-kašf ʻan manāhij al-adilla fī ʻaqā’id al-milla (Esposizione dei metodi di dimostrazione relativi ai dogmi
della religione), Beirut: Markaz dirāsāt al-wiḥda al-ʻarabiyya, 2001, 42.
28
Cfr. Ibn Bājja (Avempace): Šurūḥāt al-samāʻ al-ṭabīʻī li-Arisṭūṭālīs
(Commentario alla Fisica di Aristotele), a cura di Muʻn Ziyāda, Beirut: Dār al-fikr,
1981.
29
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: introduzione ad Averroè: Faṣl al-maqāl, 43.
25
26
- 143
Ḫaldūn.30 Così, per esempio, Faḫr al-Dīn al-Rāzī (1149-1209), contemporaneo di Averroè, era impegnato a rifondare la scuola asharita,
utilizzando il sillogismo aristotelico e i concetti filosofici introdotti da
Avicenna, proprio mentre Averroè stava ricostruendo l’intera filosofia
e la dottrina coranica, lavorando, da un lato, a liberare la filosofia dalle interpretazioni di Avicenna per riportarla alle fonti, in particolare
ad Aristotele; e dall’altro, a liberare la dottrina islamica dalle interpretazioni dei mutakallimūn (specialisti del kalām), in primo luogo degli
ashariti, per riportare anch’essa alle fonti.31
Per quanto riguarda, invece, gli scritti originali di Averroè – che
non sono commentari o compendi – vediamo che, oltre ad attenersi al
principio del ritorno alle fonti, essi possiedono anche un’altra radice.
Per esempio, i due libri Esposizione dei metodi di dimostrazione e il
Trattato decisivo partono entrambi dall’epistola in cui Averroè nonno risponde alla scomunica degli ashariti nei confronti di chi non si
conforma alla loro scuola, affermando: “È diritto e dovere di colui al
quale Dio ha assegnato il governo dei musulmani proibire al volgo
e ai neofiti la lettura [delle tesi] dei mutakallimūn ashariti; deve impedirglielo fermamente, per timore che la comprensione di quelli si
sviluppi dalla comprensione di questi e con tale lettura si perdano;
deve ordinar loro di limitarsi, in ciò in cui è necessario credano, al
ragionamento del Corano”.32 Averroè non si discosta molto da questo
quando dice: “Quest’interpretazione non dovrebbe essere divulgata a
chi è versato nella dialettica, figuriamoci alla moltitudine. Quando si
divulga qualcosa di queste interpretazioni a chi non è versato in esse –
soprattutto le interpretazioni dimostrative, a causa della loro distanza
dalle cose di cui c’è conoscenza condivisa – sia colui che le divulga
sia colui al quale sono divulgate sono condotti alla miscredenza. […]
Quindi, le interpretazioni non dovrebbero essere divulgate alla moltitudine, né istituite nei libri di retorica o dialettica”.33
Ibn Ḫaldūn: Al-Muqaddima (L’introduzione), Beirut: Dār al-qalam, 1978,
1048-1049.
31
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: introduzione ad Averroè: Al-kašf ʻan manāhij al-adilla, 31.
32
Averroè nonno: Al-muqaddimāt (Le introduzioni), Beirut: Al-dār al-ʻarabiyya
li-l-kutub, 1988, 423-427.
33
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl” (Trattato
decisivo sull’accordo della religione con la filosofia), in Charles E. Butterworth:
30
144 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Non intendiamo assolutamente mettere in discussione l’autenticità e la creatività dell’opera di Averroè. Desideriamo soltanto sottolineare che la sua originalità teoretica è radicata nel contesto epistemologico in cui è cresciuto. Non c’è dubbio che egli ne sia stato influenzato e l’abbia influenzato, a sua volta, in egual misura. Desideriamo,
inoltre, sottolineare come il faqīh Averroè sia stato la base sulla quale
si è costruito il filosofo Averroè. Non c’è miglior prova di questo del
metodo da lui seguito nel trattare la relazione fra sharia e filosofia.
Averroè, infatti, “non ha difeso la filosofia con la filosofia, ma con il
fiqh; perché il contesto generale in cui si muove il pensiero di Averroè
è dato dal suo status di faqīh e di giudice che parla dall’interno della sharia islamica e per mezzo delle sue regole e prescrizioni”.34 Per
questo, vediamo che Averroè esamina l’atto filosofico – e non le sue
affermazioni – dal punto di vista della sharia. La filosofia, infatti,
in quanto “atto”, cade sotto il dominio del fiqh che è l’esame delle
azioni di coloro che gli sono soggetti.35 Pertanto, Averroè difende la
liceità della riflessione razionale, ma non i risultati di tale riflessione.
Averroè, dunque, è un “faqīh filosofeggiante” o, per usare le sue parole, un mujtahid.36 È l’ijtihād unito al ritorno alle fonti che innalza
Decisive Treatise & Epistle Dedicatory, Provo, Utah; Brigham Young University
Press, 2001, (1-33), 26.
34
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: introduzione ad Averroè: Faṣl al-maqāl, 49.
35
Gli studiosi islamici hanno classificato le azioni umane in cinque categorie. Nel
mezzo stanno le azioni neutre, che non hanno, per così dire, valore etico, né avranno
peso il Giorno del Giudizio. La maggior parte delle azioni umane cade in questa
categoria. Sostanzialmente, se la Legge non ha nulla da dire su una certa azione,
essa è considerata neutra. A fianco di questa categoria ci sono poi le buone e cattive
azioni. Agli estremi di queste due categorie stanno, rispettivamente, le azioni proibite
(ḥarām) e obbligatorie (wājib). Esempi di azione wājib sono la testimonianza di fede,
le cinque preghiere quotidiane, il pellegrinaggio alla Mecca, il digiuno nel mese di
Ramaḍān e il pagamento della tassa obbligatoria (zakāt). Esempi di azioni ḥarām
sono l’omicidio, il furto, bere alcool e mangiare carne suina. Se qualcuno commette
un’azione ḥarām e non compie un’azione wājib, agisce contro il volere di Dio e
deve aspettarsi di sopportarne le conseguenze il Giorno del Giudizio. Fra le azioni
ḥarām e wājib si collocano quelle mandūb (raccomandate) e makrūh (riprovevoli).
Chi compie le azioni mandūb ed evita di compiere quelle makrūh può aspettarsi la
lode di Dio.
36
Il mujtahid (pl. mujtahidūn) è un esperto di fiqh che, secondo regole precise,
applica l’ijtihād, lo sforzo indipendente d’interpretazione del testo sacro. Il mujtahid
si oppone al muqallid (imitatore) che applica i responsi giuridico-dottrinali formulati
da giurisperiti che l’hanno preceduto.
- 145
Averroè al di sopra degli altri fuqahā’, dei quali dice: “Esiste una setta
che, da un lato, somiglia al volgo e, dall’altro, somiglia ai mujtahidūn.
In questo nostro tempo sono chiamati fuqahā’. Dovremmo considerare a quale delle due categorie è più appropriato unirci. È evidente che
il loro status è quello del volgo e che sono dei muqallidūn (imitatori)”
E sono così, perché “prendono le affermazioni dei mujtahidūn a fondamento del loro ijtihād, e questo basta quanto a eresia ed errore”.37
Il livello dell’ijtihād, dunque, è quello in cui filosofia e sharia
non si contraddicono, perché “la saggezza [la filosofia] è compagna
della sharia e sua sorella minore”38 e perché “la verità non contraddice la verità, ma concorda con essa e le rende testimonianza”39 “e
noi asseriamo con forza che allorché la dimostrazione giunge a una
contraddizione con il senso apparente della sharia, quel senso apparente ammette l’interpretazione secondo le regole dell’interpretazione dell’arabo”40. Se, invece, la riflessione dimostrativa conduce alla
conoscenza di qualcosa sulla quale la sharia tace, non vi è alcun
problema, perché “ha lo stesso status di ciò su cui la sharia è silente ed
il faqīh lo deduce con il ragionamento sillogistico basato sulla sharia
[qiyās]”.41
Averroè, dunque, non poteva vedere alcuna contraddizione fra filosofia e fiqh, perché le due cose erano unite nella sua persona. Egli
stesso era la prova vivente della loro unione e della loro armonia
concreta. Per questo, la morte di Averroè appare come la fine tragica
di questa unione. Il filosofo non ci ha lasciato alcun testo che parli
dell’applicazione di tale armonia teorica fra fiqh e filosofia, né l’ha
fatto chi ha scritto di lui in passato o in epoca moderna. Abbiamo
cercato a lungo qualche sua fatwā o sentenza, servita a dirimere una
questione fra due contendenti in carne e ossa, nel periodo in cui fu
giudice di Cordoba e Siviglia, ma invano. È stata una grande frustrazione trovare soltanto frasi succinte, in cui Averroè esprime la sua
esasperazione per quel “lavoro”. Non ha mai trovato nulla, nei casi
della gente, che meritasse la riflessione razionale? Non si soffermava
mai sulle loro tragedie o sui dettagli delle loro vite che gli venivano
Averroè: Al-ḍarūrī fī uṣūl al-fiqh (I fondamenti necessari del fiqh), a cura di
Jamāl al-Dīn al-ʻAlawī, Beirut: Dār al-Ġarb al-Islāmī, 1994, 125.
38
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 32.
39
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 9.
40
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 9.
41
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 9.
37
146 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
presentati in qualità di giudice? Il suo razionalismo influenzava le
sue sentenze? La filosofia assicurava un’applicazione più giusta della
sharia? Se sì, come? Queste e tante altre domande non troveranno mai
risposta, perché il giudice Averroè ha lasciato scivolare via la realtà,
ritenuta indegna della riflessione razionale. La gente che viveva in
quella realtà per lui non era altro che il volgo, al quale era proibito
l’accesso all’interpretazione. Per questo, Averroè non rimproverava i
fuqahā’ di forzare la realtà e la vita umana nello stampo dei testi, o
di fare del testo la radice e della realtà un ramo. Averroè non era interessato alla vita della gente tanto quanto era interessato ai testi-fonte.
Perciò, anche dopo Averroè, il razionalismo arabo ha continuato a
vivere una dolorosa separazione fra ragione e realtà.
Averroè ha posto le basi teoriche di questa separazione, quando
ha definito il campo d’azione del fiqh e della filosofia. Il faqīh “fondamentalista” Averroè, che aveva invocato la riapertura della porta
dell’ijtihād, ha finito per limitare il proprio alla sola dottrina, cercando di ripulirla dagli elementi spuri introdotti dalle interpretazioni dei
mutakallimūn e ricostruendo la sua relazione con la filosofia che tentò
di liberare in egual misura dalle contaminazioni dei mutakallimūn e
dei commentatori del Corano.42 Quello stesso faqīh, dopo quell’enorme lavoro che gli aveva portato via quasi cinque decenni della sua
vita, ha ristretto il campo d’azione della ragione alle sole cose divine,
ritenendo che il fiqh e la filosofia differissero per contenuto e metodo,
perché il fiqh è la scienza “delle azioni [umane] evidenti e corporee”.43 Materia del fiqh, dunque, sono le disposizioni pratiche della sharia, cioè le azioni di chi le è soggetto. In altre parole, la vita vera delle
persone: il lavoro, il matrimonio, il viaggio, la guerra, l’amore, l’arte
e tutte le attività che la gente compie nella sua vita. Della filosofia, invece, il cui accesso da parte del pubblico, secondo Averroè, conduceva alla miscredenza, egli dice: “L’atto filosofico non è niente più che
una riflessione sulle cose esistenti, nella misura in cui esse rivelano il
Creatore”.44 L’attività filosofica non è nella realtà, né mira a migliorare le condizioni della realtà. La “riflessione” si occupa delle cose
esistenti solo per giungere a Dio. Siamo di fronte a una situazione
tragica: prima Averroè sottrae la realtà al campo d’azione della rifles Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: introduzione ad Averroè: Faṣl al-maqāl, 75.
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 23.
44
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 1.
42
43
- 147
sione razionale, poi la riconsegna a un fiqh fondato sulla limitatezza
della ragione di fronte al testo, perché “la ragione non è un legislatore.”45 Infine, torna a difendere la legittimità dell’attività della ragione.
Ma dove dovrebbe operare, allora, la ragione e perché? Averroè dovrà
affrontare personalmente la risposta. Nel momento della sua sconfitta,
fece la più crudele delle esperienze, come lui stesso racconta: “Il momento più tragico della mia sconfitta fu quando entrammo, io e mio
figlio ʻAbdallāh, nella moschea di Cordoba. Della plebaglia si ribellò
contro di noi e ci buttò fuori”.46 Averroè aveva estromesso il volgo
dalla sua riflessione razionale e il volgo lo cacciò dalla sua vita.
La separazione fra ragione e realtà, fenomeno che si è cercato
di descrivere nell’esperienza di Averroè, è una delle ragioni più importanti che lasciano dubbiosi di fronte ai tentativi di riscoperta del
filosofo andaluso. In primo luogo, il meccanismo alla base di queste riscoperte è uno degli aspetti più problematici della cultura araba
contemporanea. L’intellettuale arabo in generale, infatti, è “prigioniero dei modelli delle origini e delle età dell’oro. In questo, il tradizionalista e il modernista sono uguali, perché entrambi ragionano in
maniera tipicamente fondamentalista. I tradizionalisti, nonostante le
differenze, pensano di riportare in vita l’epoca del Profeta, dei Califfi
ben guidati o dell’era abbaside. Oppure cercano di emulare il razionalismo di Averroè, il realismo di Ibn Ḫaldūn o il finalismo di al-Šāṭibī.
I modernisti, nonostante le differenze, pensano di riportare in vita il
Rinascimento, l’età classica o l’epoca dei lumi. Oppure cercano di
emulare il metodo cartesiano, il liberalismo di Voltaire, il razionalismo di Kant, lo storicismo di Hegel o il materialismo di Marx.”47 Di
conseguenza, “i concetti del discorso arabo moderno e contemporaneo non riflettono né esprimono la realtà araba attuale. Al contrario,
o sono presi in prestito, nella maggioranza dei casi, dal pensiero europeo, nell’ambito del quale, in Europa, si riferiscono a una realtà
realizzata o in via di realizzazione; oppure sono presi in prestito dal
pensiero arabo-islamico medievale, quando tali concetti avevano un
contenuto reale specifico, o si pensa che l’avessero. In entrambi i casi,
Abū Isḥāq al-Šāṭibī: Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-šarīʻa (Le concordanze dei fondamenti della sharia), Il Cairo: Al-maktaba al-tawfīqiyya, 1, 2003, 13.
46
Muḥammad b. ʻAbd al-Malik al-Anṣārī: Al-ḏayl wa-l-takmila, 28.
47
ʻAlī Ḥarb: Awhām al-nuḫba aw naqd al-muṯaqqaf (Le illusioni dell’élite culturale o la critica dell’intellettuale), Casablanca: al-Markaz al-Ṯaqāfī al-ʻArabī, 1996,
92.
45
148 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
questi concetti sono usati per esprimere una realtà auspicata indefinita; una realtà oscura che è la degenerazione di questa o quell’immagine idealizzata, albergante nella coscienza/memoria araba. Da qui la
rottura della relazione fra il pensiero e il suo contenuto che trasforma
il discorso che dovrebbe esprimerlo in un discorso di citazioni, non
di sostanza.”48
Pertanto, il presente acquisisce legittimità solo se gli si trova una
radice nel passato che, con gli antenati che lo abitano, è dotato di
autorevolezza assoluta sulla ragione araba.49 Averroè se ne rendeva
conto, perché nel suo Trattato decisivo allude ai filosofi greci utilizzando solo due parole: gli “antichi” e i “primi”. Questo per evitare
di suscitare il rifiuto e il disprezzo automatico nei loro confronti, in
quanto persone vissute nell’era preislamica (jāhiliyya) e non arabi
(ʻajam), due parole cariche di significato negativo.
In secondo luogo, le operazioni di riscoperta come quella di
Averroè sanciscono l’assenza della ragione critica. Il collegamento
stabilito da Averroè fra filosofia e sharia non è altro che una fatwā religiosa che legittima la riflessione razionale, dichiarata illecita da una
fatwā precedente; e ciò sulla base del fatto che è “una riflessione sulle
cose esistenti, nella misura in cui esse rivelano il Creatore”.50 Pertanto
noi, “comunità dei musulmani, sappiamo con certezza che la riflessione dimostrativa [la ragione] non contrasta con quanto stabilito dalla
Legge, perché la verità non contraddice la verità, ma concorda con
essa e le rende testimonianza”.51 La più grave conseguenza di questo
pensiero è che la ragione aristotelica e il testo religioso diventano due
riferimenti autorevoli assoluti e l’affermazione “la verità non contraddice la verità” diventa una verità precostituita.
La ragione di Averroè, dunque, non implica né un metodo né una
procedura critica. È un sistema organizzato, completo e chiuso, di
contenuto. E se “la verità non contraddice la verità”, allora tutto quel
che Aristotele afferma possiamo – “noi filosofi” – ritrovarlo nel testo, anche se fossimo costretti a interpretarlo. La ragione averroista,
fondamentalmente, non fa altro che “accordare” idee e concetti in cui
Muḥammad ʻĀbid al-Jābirī: Al-Ḫiṭāb al-ʻarabī al-muʻāṣir. Dirāsa taḥlīliyya
naqdiyya (Il discorso arabo contemporaneo. Uno studio analitico critico), Beirut:
Markaz al-dirāsāt al-wiḥda al-ʻarabiyya, 1992, 182.
49
Wael Farouq: “Alle radici della ragione araba”, 75.
50
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 1.
51
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 8-9.
48
- 149
la riflessione razionale trova la sua fine, non essendo più ammessa la
critica. Averroè non pare allontanarsi molto dal suo nemico al-Ġazālī,
il quale dice della riflessione razionale: “È la ragione che attesta la veridicità del Profeta e poi si astiene”.52 Indubbiamente, questa ragione
che si astiene non ha nulla a che vedere con la ragione illuminista che
parte sempre dalla critica di assiomi e postulati.
In terzo luogo, le operazioni di riscoperta come quella di Averroè
sanciscono l’elitarismo della ragione. Averroè assegna gradi diversi
alle persone: in cima alla piramide stanno i filosofi, poi vengono i
fuqahā’ e infine il volgo. La struttura contenutistica del testo religioso permette a ciascuno di comprendere quanto gli consente la sua
natura. Pertanto, il volgo deve essere convinto con l’arte oratoria e
l’interpretazione letterale del testo, mentre i filosofi mantengono il
“diritto” di interpretarlo per estrarne il significato recondito. Cosa accadrebbe se qualcuno del volgo infrangesse questa divisione basata
sulle diverse “nature umane” e si azzardasse a interpretare il testo?
Averroè, il grande pensatore illuminato, precursore della nostra modernità, risponde che questo porterebbe alla miscredenza; e quel che
porta alla miscredenza è miscredenza. Di conseguenza, chi non fa
parte dei sapienti deve limitarsi al significato esplicito del testo e il
sapiente che divulga le sue interpretazioni filosofiche al pubblico è un
miscredente, perché la sua azione conduce alla miscredenza. In breve,
ognuno deve attenersi alla propria “natura” e “preparazione” specifiche, senza oltrepassare i propri limiti interpretativi, perché ciò causa
confusione e disordine fra la moltitudine.53 Concordemente, Averroè
ritiene necessario prendere provvedimenti per impedire che i libri di
interpretazione filosofica giungano nelle mani del pubblico.
Si vede quindi che il legame stabilito da Averroè fra filosofia e
sharia limita la ragione. Dal punto di vista del contenuto, è limitata
alle cose divine; dal punto di vista dell’obiettivo, è limitata a confermare quanto stabilito dalla Legge; dal punto di vista di chi può farne
uso, è limitata all’élite dell’élite.
La rievocazione che oggi viene fatta di Averroè, presentato come
la radice arabo-islamica della modernità, non si può dunque attribuire al livello e al contenuto delle sue opere, perché la modernità, che
Al-Ġazālī: Al-mustaṣfā fī ʻilm al-uṣūl (L’essenziale nella scienza dei fondamenti), Il Cairo: Al-maktaba al-tawfīqiyya, 1, s.d., 6.
53
Averroes: “Faṣl al-maqāl fīmā bayn al-ḥikma wa-l-šarīʻa min al-ittiṣāl”, 29-32.
52
150 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
sacralizza l’individuo, facendone uno dei suoi riferimenti imprescindibili, non potrebbe mai accettare la frase “non date perle ai porci”
che Averroè fece sua. La modernità senza libertà e ragione critica non
trarrà mai altro, dall’esperienza di Averroè, che la sua sconfitta.
Attraverso la parete di vetro
Ricezioni del buddhismo nell’arte
e nel pensiero mitteleuropei
Federico Filippo Fagotto
Starting from the end of the 19th Century, several experiences of
links between Europe and the Far East countries have grown up together with the crisis that, from the Long Depression, was increasing
and would have led to the World Wars. It can be plausible to affirm
that mitteleuropean intellectuals and artists, particularly involved in
that situation, took almost an advantage from their naïve and not already specialized point of view towards the oriental studies, with the
aim of finding, upon the new cultural horizon, possible solutions or
occasions of escaping from the Old World’s decadence. Don Quijote in Asia
Cerco il modo di iniziare questo articolo e guardo fuori dalla finestra.
Piove. L’ideale per stare a casa e scrivere. Addosso ho un finto kimono e in sottofondo non c’è davvero Beethoven, ma una sua recente
esecuzione. Insomma, tutto è filtrato attraverso un vetro, anche e soprattutto il mio desiderio di immergermi nella cultura mitteleuropea
e, insieme, dentro quella estremo-orientale, pur restando tranquillo a
casa.
Se vivessi all’estero, forse avrei maggiori chance d’immedesimazione. Ci ho pensato seriamente l’anno scorso, quando ero a Vienna.
Poi ho letto un libro e mi sono messo in forse. Tuonava fra le pagine
la voce di Jung, fresco da un viaggio in India compiuto nel 1938, del
quale ebbe a dire di non aver visto laggiù alcun europeo che vivesse
152 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
davvero lì, cioè fuori dal proprio paese. «Sie leben alle in Europa, das
heißt in einer Flasche, gefüllt mit europäischer Luft»1, ridicolizzava
lo psicologo svizzero, forse un po’ più insanito da secoli di neutralità elvetica e di sgravio culturale. Riuscì, lui tra i primi, a mettere a
fuoco l’immagine di un Glaswand, una parete di vetro, che gli europei si sarebbero costruiti intorno grazie e a causa della loro fantasia
(Phantasie), ma oltre la quale – pur nell’impeto di evasione che urgeva dalla Crisi di fine secolo ai conflitti mondiali – non riusciranno mai
davvero a procedere (hinausbegeben).
Eppure, fu proprio in quel periodo in sella ai due secoli che, soprattutto a partire dalla Mitteleuropa appunto, nacquero i primi approcci diretti alle culture dell’Asia, dopo che si era fatto tesoro a sufficienza degli studi condotti a distanza nelle epoche immediatamente
precedenti, intervallati tutt’al più da alcuni viaggi più esplorativi che
metabolici. E nonostante l’approccio neofita, quasi dilettantesco, con
cui le prime ricerche furono intraprese, quella distorsione della fantasia snidata da Jung contribuì non solo così tanto alle arti, ma anche
al pensiero filosofico a esse retrostante, o sovrastante che fosse. Valga
simbolicamente, dunque, l’immagine che Edward Conze, uno dei primi orientalisti di lingua tedesca, diede di sé, cioè quella di un Don
Quijote che si scaglia, per bisogno e passione, verso l’immagine di
un’Asia in parte creata dalle sue stesse ambizioni.
Un prodotto della disperazione
È certo che i motivi e le curiosità che hanno portato lo sguardo attraverso la nostra parete di vetro sono stati diversi. Furono talvolta
filosofici, tal’altra storici, artistici, linguistici, e poi antropologici. Per
mettere un po’ d’ordine, un articolo – a differenza del saggio – può
chiedere aiuto anche a un esempio soltanto, che in questo caso sarà
in più un denominatore, dal momento che il buddhismo, sul quale
ricade la scelta, è quel sigillo culturale che non solo ha potuto legare
ambiti di ricerca e creatività eterogenei, ma venare tradizioni lontane,
da quella indiana, singalese, himalayana, cinese, coreana, sino a quel1
«Vivono tutti in Europa, vale a dire in una bottiglia, riempita d’aria europea»,
cfr. Carl Gustav Jung, Zivilisation im Übergang (Gesammelte Werke. Zehnter Band),
Olten und Freiburg im Breisgau, 1981, p. 567.
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 153
la giapponese e del sud-est asiatico, facilitando le prime incursioni
ingenue nel riportare in Europa una cifra culturale capace di legare
fra loro questi diversi paesi di provenienza con forse insufficiente tatto discriminatorio. A ciò si aggiunse infine l’influsso europeo. Karl
Jaspers fu tra quelli che additarono il marchio tedesco e austriaco
imposto al buddhismo durante la sua ricezione nel cuore del continente, e a un certo punto finì col chiedersi: «Was ist buddhistisch, was
östlich, was westlich?»2.
Una risposta venne da Mircea Eliade, secondo cui la riscoperta
dell’Asia cadde sotto un cattivo segno, dal momento che, a differenza
di altri rinascimenti, questo fu scoperchiato da attitudini filologiche
senza eco abbastanza profonde in arte, letteratura e nelle scienze.
Senza sforzo, immaginiamo già che qualcuno non sarà affatto d’accordo con il suo punto di vista. Fra gli scrupoli immediati dei primi
ricercatori ci fu infatti proprio quello di capire quale valore potesse
avere la scoperta dell’Oriente (chiamiamolo così, per pura comodità), e come andasse impiegato, al di là del mero interesse accademico. Max Müller, padre non solo della storia delle religioni ma anche
di questo genere di accortezza, scrisse un libro dal titolo Was kann
Indien uns lernen (1883). E, guarda caso, già la prima generazione di
studiosi piegò subito il materiale sottomano al confronto con la cultura filosofica e religiosa dell’Occidente (anche qui, semplice comodità
espressiva). Rudolph Seydel, teologo di Dresda che dal 1867 ricoprì
la cattedra di Filosofia all’Università di Lipsia, allacciò il confronto
fra il crèdo buddhista e quello cristiano. E tutto ciò avveniva malgrado le storte sopra cui tale linea spesso passava. Max Nordau, noto
sociologo ungherese, riuscì a porre a confronto le mire messianiche
del nascente sionismo, di cui fu cofondatore assieme a Herzl, con la
meta del nirvāṇa , soltanto al prezzo di una distorsione concettuale di
quest’ultima.
La stagione più recente, invece, ha rifiutato di sottrarsi al dibattito
critico pur di non lasciare nulla d’intentato, sulla via dunque del tramonto del dilettantismo. Hanno cominciato Hu Shih e il carismatico
D.T. Suzuki a dirsele senza sconti, con Philosophy East and West
(1953) e la replica a distanza di Zen: a Reply to Hu Shih, uscita nel
1978, lo stesso anno in cui venne pubblicato uno degli ultimi saggi
Karl Jaspers, Die maßgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus,
München 1964, p. 130.
2
154 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
sull’argomento ancora capace di schivare lo specialismo e diventare
quasi un best-seller. Si tratta del testo di Edward W. Saïd intitolato
Orientalism, dove la lingua dello scrittore palestinese si è affilata al
punto da dire:
Personalmente, ritengo che l’orientalismo sia più veritiero in quanto
espressione del dominio euroamericano che come discorso obiettivo
sull’Oriente (come vorrebbe l’orientalismo accademico o comunque
erudito).3
Se quindi l’orientalismo «riguarda il “nostro” mondo ancor più
di quanto riguardi l’Oriente»4, si spiega da sé, pensando alla cultura
tedesca, la fonte interpretativa che, vieppiù dalla seconda meta del
Novecento, si è accostata agli studi sull’Asia. Alcune boe di questa regata ermeneutica sono state Das Indienbild deutscher Denker (1960)
dell’indologo Helmuth von Glasenapp, German Indologists (1990) di
Stache-Rosen e Lebensbilder deutscher (1997) di Hellmuth Hecker.
Nel nuovo millennio, una voce ben impostata è quella del prof.
Volker Zotz, studioso orientalista viennese attualmente docente
all’Università del Lussemburgo, che conduce da anni una ricerca di
confronto fra il buddhismo orientale, in particolare giapponese, e la
cultura mitteleuropea. Per capire il contributo del suo testo Auf den
glückseligen Inseln ci basta il sottotitolo: Buddhismus in der deutschen Kultur. A detta di Zotz, le ultime tracce delle vedute di Eliade si
sciolgono proprio di fronte al contesto germanico di fine Ottocento, i
cui intellettuali e artisti trovarono nel nuovo pensiero orientale una risposta alle insoddisfazioni del loro momento storico. Zotz ha definito
il buddhismo tedesco come un autentico “prodotto della disperazione” (Produkt der Verzweiflung), il quale finì col dire di più della stessa
cultura tedesca che di quella asiatica.
Edward W. Saïd, Orientalismo, tr. it. Stefano Galli, Bollati Boringhieri, Torino
1991, p. 16.
4
Ibidem, p. 22.
3
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 155
Ohne Geist, ohne Gott
Questo ritorno di fiamma termina una traiettoria iniziata in realtà
nell’epoca precedente, attraverso un movimento contrario. I grandi
sistemi filosofici nati a partire dalla fine del XVIII secolo erano stati
messi alla prova in molte maniere, ma ancora inesausto era rimasto
lo sforzo di portarli verso culture lontane, magari esotiche. Ecco la
dinamica opposta: non ancora la ricerca di segni culturali esterni da
attirare verso il confronto, bensì ipotesi di pensiero da sperimentare
e lanciare più lontano possibile. Lo si fece in qualche modo già con
Kant, poiché tale sembrava uno degli approdi della sua impostazione universalista, di cui già lui si avvide al momento di concludere
uno dei suoi ultimi scritti di peso, l’Antropologia pragmatica, unendo capitoli dedicati a “Il carattere del popolo” e “Il carattere delle
razze”.
Di parallelismi non dichiarati fra il suo pensiero e le culture orientali andrà poi a caccia von Glasenapp, riuscendo a scrivere un Kant
und die Religionen des Ostens (1954), nel quale utilizza come scorta
Wilhelm von Humboldt e lo spunto kantiano dei suoi studi linguistici.
Fu questi a sottolineare le peculiarità delle lingue di alcuni popoli
asiatici, cui si vedevano connesse precise identità culturali e alla cui
sommità vi sarebbe stato sia il sanscrito che, dunque, la tradizione
a lui retrostante. Il primo giro di vite implica di conseguenza anche
il contributo di Herder, in merito al rapporto fra lingua e cultura. A
lui non rimase che ultimare il mosaico del progresso dei popoli con
una deduzione riguardo le differenze linguistiche, e attribuire ai popoli asiatici uno stadio ancora intermedio nel cammino in fieri dello
Spirito. Ed ecco trovato l’ultimo anello di congiunzione, naturalmente con il pensiero hegeliano. Incastonare il punto di vista maturato
fino a Herder nella già collaudata macchina dialettica, e negare così
ai popoli dell’Asia sia la padronanza dell’autocoscienza che un ruolo
nello sviluppo del Geist fu il compito delle Lezioni di filosofia della
storia e di alcuni passaggi di altri testi, da cui Hegel ricava persino
conclusioni geopolitiche, quali la giusta rinuncia tedesca alla corsa
del colonialismo, la cui spinta al di fuori dal tracciato della coscienza
sembrava minacciosa.
A questo punto, per sentire quasi su di sé lo stesso bisogno di
colmare un simile iato e compatire le esigenze degli autori da cui
siamo partiti e dei loro contemporanei, è in parte sufficiente leggersi
156 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
il trasporto poetico di Goethe, di Novalis e di Heine che, nel loro
vagabondare in cerca di risposte, giunsero spesso a immaginarsi l’Oriente, talvolta con infinita coerenza. La famiglia Schlegel, su tutte,
vi puntò dritto. Friedrich, dopo i suoi approfondimenti indologici e
sanscriti a Parigi, pubblicò Über die Sprache und Weisheit der Indier
(1808). August Wilhelm segue, di lì a un decennio, lo stesso percorso
di studi parigino, finendo con il tradurre Bhagavadgītā e Rāmāyaṇa.
Ma entrambi furono forse debitori al fratello più grande, il meno
noto Carl August Schlegel, cartografo e genio militare partito per
Madras (oggi Chennai) con il reggimento di fanteria dell’Elettorato
di Hannover in sostegno alle truppe britanniche di Giorgio III. Carl
non tornò mai indietro, a causa della cruenta guerra di Mysore, ma
il coraggio di intraprendere un lungo viaggio per calpestare le terre
descritte nei libri e nei racconti fu forse ciò che mancò ai due più
giovani e colti fratelli.
Per l’intanto, il pungolo degli intellettuali di evadere fisicamente,
o anche solo allargare la circonferenza del Gran Tour, non sorpassò il
bisogno di invitare in casa propria le novità filosofico-religiose delle
culture lontane per renderle partecipi del tentativo di salvataggio del
pensiero occidentale, sebbene il colpo assestato dall’hegelismo alla
dignità delle tradizioni extra o pre-spirituali rendesse cauto l’azzardo
di applicare le nuove informazioni sopra quelle vecchie categorie in
stato di malessere. I primi lavori, dunque, cominciarono con l’approfondire i testi che giungevano fino in Europa e di cui si riusciva a entrare in possesso. Queste minuziose ricerche consentirono finalmente,
a partire dai rilevamenti linguistici, di dare profilo allo scheletro di
un colosso: quello della teoria indoeuropeistica, sostenuta da Franz
Bopp e Rasmus Christian Rask. Il legame di sangue, mai dimenticato
dalla nostra bocca e custodito dagli idiomi, dopo aver ritrovato un
piedistallo culturale alla frattura hegeliana era adesso in attesa di una
rivincita filosofica.
Come risaputo, a forzare il tabù fu soprattutto Arthur Schopenhauer,
già a partire dall’esplicita dichiarazione sulla propria confessione di
fede: la fede buddhista. Come ci arrivò? L’impianto filosofico che
gravitava attorno ai concetti di Wille e noluntas sembrava combaciare con le nozioni secolari di saṃsāra (il ciclo di morti e rinascite) e
nirvāṇa. Procedendo poi nella direzione della somiglianza si poteva
forse rinvenire nella tradizione buddhista anche la soluzione ai mali
dell’esistenza e del pensiero umani, umanità intesa sì nel suo com-
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 157
plesso, ma in cui è adesso la porzione dell’ovest ad accorparsi all’altra
sua “metà”, e non già a escluderla. Certo, le sbavature di queste coincidenze culturali erano molte, ma nell’ignorarle Schopenhauer ebbe
comunque modo di attuare qualche discrimine – ad esempio sull’idea
di ciclicità del buddhismo, che supera il saṃsāra brahmanico, dove a
mutare era un’essenza concreta, per rifarsi a un più ampio processo di
trasformazioni degli esseri e delle energie spirituali – ma soprattutto
riuscì a costruire un discorso innovativo e potente sull’arte.
A spalancare del tutto l’ingresso ormai forzato da Schopenhauer
ci pensarono alcuni studiosi che, partendo dal suo sistema, indugiarono sulla via del confronto con il buddhismo, in particolare Georg
Grimm, il quale ebbe accesso ai testi originali dopo aver appreso la
lingua pāli. Il suo buddhismo “schopenhaueriano” divenne una religione razionale, in cui a cadere è il concetto di Ich (Io), in favore di
una qualità inessenziale che accompagna il Sé nel breve tempo della
sua esistenza. Ciò però che più importa è il suo bisogno di intonare
un discorso morale, ancor più del suo maestro forse, in cui infatti la
negazione della voluntas non equivale più a una nientificazione, bensì
a una posizione più alta e affermativa.
La strada morale, che tosto verrà imboccata nella retromarcia
genealogica per diventare oltre-morale, porta dritto a Nietzsche, del
quale è possibile leggere un ottimo riepilogo, a proposito dei suoi
non rari interessi per le culture orientali, nel saggio di Ryogi Okochi:
Gedanken zu Nietzsche aus östlicher Sicht (1995). A fare da lenone
fra Nietzsche e il pensiero indiano fu Paul Deussen, o forse dovremmo dire Deva-Sena, vista la sua scelta di un anabattesimo sanscrito,
incoraggiata dalla stima del carismatico guru Swami Vivekananda.
Paul Deussen, seguace del pensiero schopenhaueriano e fondatore
della Schopenhauer-Gesellschaft di Francoforte, trasferì parte degli
interessi da lui mutuati sul pensiero indiano proprio al giovane amico
Friedrich Nietzsche, il quale poi proseguì, pur in modo meno sistematico, nell’approfondire alcune questioni. Anche a Nietzsche riuscì
di trovare utili consonanze, a patto che non si attardassero sulla nullificazione della volontà di vivere, che a lui premeva invece oltrepassare. E lui stesso fece colpo, a sua volta, su alcuni pensatori a venire.
Pensiamo al filosofo e scrittore boemo Fritz Mauthner, sedotto dallo
scenario buddhista e dall’assenza, evidenziata dalla lezione nietzscheana, di un apparato teologico forte in virtù della dismissione da
parte dei suoi santi della veste olimpica ancora indossata dal brahma-
158 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
nesimo. «Buddha kam aus ohne Religion, ohne Gott, ohne Himmel»5,
scrisse Mauthner appena scoperto che Dio si poteva uccidere in molti
modi.
Dal tramonto al Sol levante
La rilettura levantina del crepuscolo degl’idoli indusse a includere il
buddhismo entro la riflessione sulla crisi europea. Rudolf Pannwitz,
altro nietzschano desideroso di superare il nichilismo, vi diede spazio nel testo Die Krisis der europäischen Kultur (1917). Il suo modo
di affrontare il problema, abile nel costruire sentieri affiliati ma indipendenti dalla filosofia, non avvicinò solo alcune soluzioni a una
cultura eterodossa come quella buddhista, ma le rivolse anche a diversi registri del discorso, in particolare quello letterario. Connubi fra
letteratura, filosofia e spiritualismo orientale, così come in Mauthner
e Pannwitz e sempre nel segno della crisi dell’Europa, sono riassunti infine nella figura di Hugo von Hofmannsthal, il cui incanto per
l’Oriente – a differenza del postmodernismo di Pannwitz, proteso
all’avvenire – prende in considerazione un ritorno all’antico. Ne nasce una posizione in bilico, fra Sehnsucht e Wirklichkeit (le due parole
chiave che Gabriella Rovagnati attribuisce nel suo saggio al rapporto fra Hofmannstal e la cultura orientale), da cui ne viene fuori una
“rivoluzione conservatrice” da proporre all’Europa. Come scrisse in
un’introduzione a Kokoro – famoso testo dello yamatologo Lafcadio
Hearn, di cui Hofmannsthal apprezzava la capacità di partecipare della «vita interiore del paese amato»6, il Giappone, che in Hearn precedeva sia gli scopi di ricerca che gli amori estetici – il buddhismo
stesso rivela e conserva questa posizione ibrida:
È filosofia, se non erro, che però non ci lascia freddi, non ci trascina nel vuoto dei concetti. Quindi è religione, una religione però che
non minaccia, che non vuole essere la sola al mondo, che non pesa
sull’anima.7
Fritz Mauthner, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. Band IV.
Stuttgart/Berlin 1923, p. 249.
6
Hugo von Hofmansthal, Lafcadio Hearn, in Lafcadio Hearn, Storie di spettri
giapponesi, tr. it. G. Rovagnati, Tranchida, Milano 2001, p. 7.
7
Ibidem, p. 10.
5
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 159
Anche Spengler dubiterà di poter chiamare il buddhismo una religione, preferendo il termine Weltstimmung. Ma, a questo riguardo, la
sua profezia sulla crisi avrà toni assai diversi: buddhismo, stoicismo
e socialismo avrebbero in comune un’indole materialistica, che disseziona l’essenza umana per chiarirla mediante concetti. Così facendo,
gli riesce il paradosso di invischiare anche il buddhismo nel tramonto
dell’Occidente.
Questo viale del tramonto portò invece alcuni dall’Untergang al
paese del Sol levante. È il caso di Carl Theodor Strauss, studioso
orientalista trasferitosi negli Stati Uniti, da cui proseguì per un viaggio nell’Estremo Oriente, fra India, Ceylon e Giappone. Ritornato
infine in Germania, vi fondò la Deutsche Gesellschaft für ethische
Kultur, con l’idea d’inoculare nella società tedesca gruppi di ricerca e
diffusione delle culture orientali. Coincisero in questo periodo tentativi analoghi, spesso collegati alla figura di Karl Seidenstücker, fondatore nel 1903 della Buddhistischen Missionverein für Deutschland
e, nel 1909, della Deutsche Pali-Gesellschaft. Sotto lo pseudonimo di
Bruno Freydank, licenziò testi di confronto fra i ruoli messianici del
Buddha e del Cristo, al cui crèdo si rivolgerà infine dichiaratamente,
nell’ambito della dottrina protestante. Degna di nota la sua decisione di rifugiarsi in un monastero buddhista giapponese di tradizione
theravāda, vero esempio di sradicamento culturale quale possibile soluzione alla crisi della società, o anche soltanto come sua plausibile
minaccia.
Siamo ormai prossimi alla stagione del caldo dialogo a distanza fra Germania e Giappone, dopo la sopravvivenza all’inverno delle diffidenze. Vi era stato infatti chi, come il gesuita missionario in
Giappone Joseph Dahlmann, forse non aveva apprezzato la cacciata
degli europei dal paese a causa dell’irrigidirsi del nazionalismo nipponico, chi poi come Friedrich Köppen che, di orientamento post-hegeliano, tacciava il buddhismo di attentato al Geistesleben, o chi
addirittura, pur orientalista e storico delle religioni come Friedrich
Heiler, nell’eleggere il sacro quale scopo ultimo di ogni confessione
di fede e nella mistica il suo naturale approdo, malvedeva la pratica
Zen temendovi una sosta fin troppo limitrofa al laicismo. In attesa
che, sul piano politico, i due paesi si allineino lungo l’asse, la riapertura proverrà proprio dal fronte intellettuale non distante dal nazionalsocialismo. Eugen Herrigel, l’autore del famoso Zen in der Kunst
des Bogenschießens (Lo Zen e il tiro con l’arco) è il nome che viene
160 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
sempre fuori in questo caso, sebbene sia meno risaputo che il maestro
da lui incontrato in Giappone in realtà non apparteneva a una scuola
Zen, e che lui in compenso fosse membro della società antisemita
Kampfbund für deutsche Kultur.
L’argomento è spesso schivato, non solo per l’inadeguatezza di
quasi tutte le teorie compromesse con il regime, ma anche per la difficoltà di far vibrare le voci fuori dal coro. Piega sulla maggioranza,
infatti, la casta di intellettuali vicini al Reich che resuscitarono i contorni, sbiaditi a dire il vero, delle antiche culture orientali nel segno
dei popoli arii. I nomi più agili da ricordare sono quelli di Wilhelm
Hauer, l’indologo fondatore della Deutsche Glaubensbewegung con
l’hobby di scrivere lettere a Himmler, Wolfgang Schumacher, che
quando scriveva del principe Asoka chissà perché veniva in mente il Führer, August Faust, docente di filosofia e studioso di culture
orientali con giovani esperienze nella Hitlerjugend, oppure Karlfired
Dürckheim, diplomatico e poi psicoterapista tedesco che durante il
lungo soggiorno in Giappone alternava meditazioni kyūdō di tiro con
l’arco insieme allo stesso maestro di Herrigel e campagne di assimilazione dei principi nazisti all’etica bushidō.
Eppure, se si rimane in ascolto, i controesempi sussurrano. Uno
è quello di Wilhelm Müller, conosciuto come Angarika Subhuti, le
cui letture di testi sacri buddhisti diede carburante alle rivendicazioni
socialiste di stampo umanista e antifascista. Dal Giappone proviene
invece il lamento di Löwith, uno dei pochi a imboccare la via dell’esilio nell’altro senso di marcia. Parliamo qui di un hegeliano temerario
al punto da spingersi al di là della linea d’ombra dello Spirito e che
in cambio ne trovò un altro, diverso e affascinante, di cui recò testimonianza nel testo Der japanische Geist. Ecco, anche la frattura con
l’hegelismo sembrava ricomporsi.
L’ultima sagoma che, in contatto con la cultura nipponica, non
può che profilarsi è quella di Heidegger, il cui ruolo è tuttora in fase
di chiarimento. Per l’equilibrio del discorso basti ricordare i suoi dialoghi filosofici con pensatori giapponesi quali Nishida Kitarō, Keiji
Nishitani e Hajime Tanabe. Quasi stupefatto dagli arrangiamenti
speculativi condotti al proprio sistema dalla Scuola di Kyōto, attraverso il suo stesso vocabolario filosofico, l’appetito del pensatore di
Meßkirch trovò soddisfazione anche in questo caso alla mensa dell’arte, di cui poté discorrere sia con Kuki Shūzō, teorizzatore dei valori
estetici dell’iki e del fūryū, ma anche con Tomio Tezuka, professore
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 161
di Letteratura tedesca all’Università imperiale di Tōkyō. Ormai, per
chiudere il cerchio o restarci dentro, si può ricordare un’asserzione
citata dallo stesso Löwith con la quale Nietzsche accomunava l’approccio alla filosofia e all’arte di tutti gli intellettuali tedeschi, arsi dal
desiderio di forzare l’evidenza e conferirle un significato più profondo di quanto sia. Chiediamoci se anche Heidegger, pensando al valore
poetico e filosofico delle immagini-di-senso, intravide questa stessa
possibilità nell’inclinazione giapponese a spingere il dato sensibile
oltre i margini del simbolo, come ammise lo stesso Tezuka in seguito
alla famosa ora di conversazione passata con l’amico tedesco:
La peculiarità del popolo giapponese […] non è il fatto di accontentarsi
della pura e semplice restituzione del dato sensibile, bensì la tendenza
a esigere che l’elemento colto dalla sensazione assuma, quanto più la
sensibilità artistica è elevata, un carattere simbolico.8
Gli Zimmermann
Siamo arrivati al midollo del discorso, nel quale il bisogno filosofico
di rivolgersi all’Oriente, in virtù dell’approccio ingenuo e della penombra di conoscenza nella quale, ricordiamoci di Pascal, ognuno
riusciva a vedere ciò che voleva, visse un exploit nelle arti e nella letteratura. Se anche solo prendessimo due romanzi come il Maha Guru
di Gutzkow, datato 1833, e l’Ekstatische Theater di Felix Emmel
(1924), è chiaro che l’abisso generazionale e stilistico sarebbe ingestibile. E proprio quando chi scrive va alla ricerca di una pallida norma per rendere conto della forse migliore risorsa di questo fenomeno,
ossia la sua eterogeneità, capita fra le mani un brevissimo scritto di
Robert Walser, autore svizzero amante delle passeggiate e del tema di
viaggio, incluso non per nulla dentro la raccolta che contiene soprattutto il racconto Der Spaziergang. La storiella, dal titolo Koffermann
und Zimmermann, parla di due scrittori che vengono contattati dall’editore della testata per la quale entrambi lavorano, in merito a dei reportage da svolgere all’estero. A Koffermann viene chiesto di preparare la valigia (der Koffer) e viaggiare verso il lontano Giappone, cosa
Tomio Tezuka, Un’ora con Heidegger. Oriente e Occidente, a cura di L.V.
Arena, Mimesis, Milano 2013, p. 14.
8
162 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
che non si fa ripetere due volte. Zimmermann invece, che dovrebbe
andare nella più vicina Turchia, rifiuta e preferisce restare nella sua
stanza (das Zimmer) a riflettere.
Chi sono i nostri Zimmermann, allora? Chi sono i letterati e gli
artisti ansiosi di condurre immersioni nelle culture orientali, anche di
notevole profondità, restando però entro le mura del vecchio continente, forse per paura di scoprire che l’Asia non corrisponde davvero alle loro aspettative? Si possono scomodare persino premi Nobel,
come Gjellerup, più interessato alla cultura tedesca che alla tradizione
del suo paese, la Danimarca, e che pur avendo inciso il fascino orientale in opere quali Offerildene (1903) e Den fuldendte Hustru (1907)
non si spinse mai più a est della stessa Turchia. Oppure lo scrittore von Doderer, che non smise di denunciare l’agonia dell’Impero
Austro-Ungarico ma che, nonostante i numerosi appelli per cercare
una sua cura tra i paesi del Levante, trascorse la maggior parte della
propria vita nella cara vecchia Vienna.
E che immagine si saranno fatta, al tempo, della vita del Buddha
e della sua agiografia, i lettori costretti a ricavarne ogni descrizione
dai romanzi depistati dall’incantesimo letterario, come quelli di von
Hornstein, Navrats, Rittmann-Ursch e anche di Hesse? Forse un volto
somigliante alle statue Gandhāra, cioè un miscuglio fra gusto indiano
e influssi dell’arte occidentale, magari però di bellezza inimitabile.
Ricordiamo che il 1920 è l’anno in cui, assieme al Siddharta, viene
pubblicato il piccolo gioiello di Stefan Zweig, il racconto Die Augen
des ewigen Bruders, in cui alla storia è sufficiente un sapore esotico
per velare i richiami alla situazione politica, di fronte al cui precipizio Zweig decise anche lui di fuggire, ma verso l’Ovest, forse per
sorprendere alle spalle il Sol Levante. Arrivato però in Brasile, uno
scoramento simile a quello di Benjamin lo fece desistere. Nella lettera
di commiato con cui annunciò il suicidio, augurò agli amici di vedere
l’alba alla fine della lunga notte. Lui, per troppa impazienza, scelse
invece di precederli.
E così, fra reazioni e rivoluzioni, frondisti e collusi col potere, i
cardini della tradizione e della metafisica buddhista vengono fatti a
brani e spartiti fra le parti. Gautama viene dipinto ora con tinte filoariane, come nel Buddha di Victor Widmann, ora come antidoto al
pangermanismo. Mentre Theodor Lessing inizia a usare il termine
brahmā al posto di Dasein e dice buddhi quando intende Geist, c’è intanto chi, come Emil Lucka, imputa alla spoliazione buddhista dell’Io
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 163
l’assenza in Oriente di una grande tradizione teatrale paragonabile a
Shakespeare o alla tragedia antica, proprio negli anni in cui Alfred
Döblin dava un volto innovativo al suo teatro e ai lavori in prosa
servendosi guarda caso di parallelismi con le culture orientali, come
quello fra l’etica taoista e il principio tolstoiano della non-violenza,
così come nel romanzo Die drei Sprünge des Wang-Lun (1915).
La cultura buddhista dové allora lottare per scendere in confidenza con l’arte nostrana, superando lei stessa qualche ritrosia. Se da una
parte, infatti, c’era chi usava l’arte come strumento di propaganda
contro la nuova religione – si guardi il dipinto di Hermann Knackfuß
commissionato dal kaiser Guglielmo II, in cui le divinità guidate da
un angelo armato di spada fiammeggiante e vegliate dal simbolo della
croce, osservano di lontano un Buddha minaccioso avvolto da fulmini
e nubi nere – alcune comunità buddhiste, emuli del regime monacale, vedevano nell’arte una fonte di distrazione e attaccamento. Nella
Buddhistisches Haus fondata dall’omeopata e promotore della pratica
buddhista Paul Dahlke era vietato il possesso di strumenti musicali,
pennelli e l’esercizio delle arti.
Il frangiflutti più autorevole fu invece Wagner, influenzato dall’amico Liszt. Dopo aver disseminato il Lohengrin, il Tannhäuser e il
Fliegende Holländer di richiami orientali e aver cominciato un’opera incentrata sull’argomento, Die Sieger (che però rimase incompiuta), a tutti parve che il rimando esotico fosse sdoganato. Già Hans
von Bülow, primo marito di Cosima Wagner e fervente ammiratore
di Richard, compose un Nirwana (1866). Due opere che ebbero in
seguito un buon successo furono, nel 1904, Der Buddha del pianista prodigio Max Vogrich e, l’anno seguente, il Maja di Adolf Vogl.
Stranamente, pur essendo la musica una delle arti più trascurate dall’estetica buddhista, orientalismo e musicologia hanno trovato spesso
un buon binomio presso vari autori occidentali di questo periodo, a
riprova del valore aggiunto della libera interpretazione. Inclinazioni
musicali erano coltivate dal teosofo Henry Steel Olcott e dall’antroposofo Hermann Bekh, capace di relare la mistica tibetana agli studi
musicali, dalla nozione di kosmische Rhythmus, fino alle ragnatele
musicali di Wagner e Bruckner.
È ovvio che, proseguendo di quest’andatura, si incontreranno
esempi sempre più rinomati di assimilazione orientale fra le restanti
arti, i cui apici sono forse la pittura di Kubin, la poesia di Rilke e il
teatro di Brecht. Anche artisti e intellettuali per nulla specializzati
164 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
e poco confidenti con l’ortodossia buddhista percepiranno in molti
dei loro aneliti quasi l’assegnazione di una nuova appartenenza, da
descriversi forse con le parole del poeta Arthur Pfungst tratte dal titolo di una sua opera uscita al culmine della crisi di fine secolo: Ein
deutscher Buddhist, del 1899.
I Koffermann
Come detto, si è parlato finora di “buddhistische Deutschen” più che
“deutsche Buddhisten”. I casi più singolari invece, purtroppo meno
noti, sono quelli di alcuni personaggi che – nell’unione di ricerca filosofica, attività artistica e pratiche spirituali all’interno degli interessi
di partenza – non indugiarono a far la valigia pur di immergersi nelle culture dell’Asia, verso cui l’ispirazione si sentiva debitrice. Gli
esempi che riportiamo sono quattro, poiché in merito a queste premesse sembrano i più rotondi.
Il primo è Anton Walter Gueth (1878-1957), giovane musicista di
Wiesbaden destinato a diventare uno dei primi bhikkhu (monaco buddhista) della storia occidentale. Nei primi anni studiò teoria musicale,
composizione e arrivò a padroneggiare violino, viola, pianoforte e clarinetto all’Hoch Conservatory di Francoforte e al Paris Conservatoire.
In seguito, si dedicò alle letture filosofiche di Platone, Cartesio, Kant
e Schopenhauer. Fu per ventura che ascoltò alcuni discorsi su argomenti teosofici, presto rinfocolati dal maestro di violino che gli regalò alcuni libri sul buddhismo. Ed ecco qui lo scarto: invogliato a
superare l’atteggiamento di studio distaccato e a prendere la decisione
di farsi ordinare monaco, intraprende un viaggio da Tessalonica al
Cairo, dove suonò il violino per racimolare i soldi necessari a proseguire fino a Bombay e, da qui, stabilirsi in Sri Lanka. Fu accolto da
un monastero theravāda e divenne prima sāmaṇera (monaco novizio)
poi svolse l’upasaṃpadā (procedura di ordinazione) assumendo il
nome di Nyanatiloka Mahathera.
Da seguire con attenzione, a questo punto, il suo ritorno in Europa
con l’intento di infondervi quanto esperito nell’apprendistato spirituale e dare alla luce un monastero buddhista occidentale. Tuttavia,
all’ennesimo tentativo fallito fra Germania, Svizzera e Italia, decide
di tornare in Asia. Si reca a Ceylon e prende possesso di un’isola vicino al villaggio di Dodanduva per fondarvi l’Island Hermitage, un
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 165
monastero che accolse non solo diversi intellettuali europei, ma anche
molti rodiya (gli “intoccabili” singalesi). La fine dell’esperimento si
ebbe allo scoppio del primo conflitto mondiale, quando Gueth, pur
sempre tedesco in una colonia britannica, fu internato nel campo di
Diyatalawa. Cessate le ostilità, dopo estradizioni in Australia, Cina
e un breve rimpatrio, si trasferì in Giappone dove insegnò tedesco
e pāli alla Taisho University. Dopo un po’ di quiete, sembra averne
abbastanza e fa il bis: torna in Sri Lanka, ritrova il vecchio monastero,
ormai semidivorato dalla giungla, e riesce a rimetterlo in sesto giusto
in tempo per lo scoppio della seconda guerra mondiale. Con l’aplomb
di una prassi collaudata, le truppe inglesi lo internano nel campo di
Dehradun. Nyanatiloka riuscirà però a cavarsela anche questa volta.
Acquisita ormai la fama di guru e forse un’aura d’immortalità, diventa il primo occidentale a presenziare al Sesto Consiglio Buddhista a
Yangon. Non chiuse mai il cerchio dei suoi pellegrinaggi e non tentò un’altra volta di strappare il successo in Europa. Rimase perciò a
Ceylon, dove morì a Colombo nel 1957.
Il secondo caso viene citato forse un po’ più spesso. Parliamo di
Karl Eugen Neumann (1865-1915), primo traduttore del Canone Pāli
e pioniere del buddhismo europeo. Il padre era tenore allo Staatsoper
di Vienna e diresse poi il teatro il Lipsia. Il giovane Karl deviò presto dalla carriera di banchiere, non appena imbattutosi nella lettura
di Schopenhauer e, da questa, nella passione per la cultura indiana.
Dedicatosi allo studio di indologia, religione e filosofia a Berlino
divenne allievo di Richard Pischel, fondatore del cosiddetto “Neobuddhismo”, che tanto influenzò Mann ed Hesse. Anche in Neumann
assistiamo alla svolta decisiva di passare dalla teoria alla messa in
opera: ultimata la traduzione del Tipitaka, in occasione dell’anniversario della morte di Schopenhauer, e del Dhammapada, sceglie di
recarsi in India e poi a Ceylon, dove conoscerà lo stesso Nyanatiloka
Mahathera. C’è da dire che, a differenza sua, a Neumann riuscì un
fortunato ritorno in patria, grazie anche al supporto del linguista
indologo Georg Bühler, di cui divenne assistente nell’Institut für
Orientalistik.
Nel segno di un fecondo dilettantismo, la sua altalena fra esterofilia e importazione all’interno del tessuto sociale mitteleuropeo
causò alcuni paradossi, quali la sua critica all’adulterazione della lezione del venerabile Shākyamuni che, a suo dire, veniva perpetrata
nel sangha dell’Island Hermitage, critica che si vide rivolta contro
166 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
appena tornato in Austria da filologi come Otto Francke, che gli attribuirono alcune imprecisioni interpretative. La sua gestione dello
scrupolo metodologico e del libero confronto rimase però fluida al
punto da permettergli una convincente applicazione dei principi buddhisti sia all’arte figurativa classica (in particolare di Salvator Rosa,
Rembrandt, Ruisdael e Luini), che alla filosofia e letteratura tedesche,
con particolare debito nei confronti di Goethe, tanto da suscitare il
plauso non solo di letterati come Mann e von Hofmannsthal e di filosofi come Max Weber ed Ernst Bloch, ma anche di maestri orientali
quali il grande Daisetzu Teitaro Suzuki, che ricavò dalla lettura della
tesi di dottorato di Neumann la necessità di un continuo confronto fra
il pensiero Zen e la mistica di Meister Eckhart.
L’audacia di azzardare un confronto con Goethe aveva adesso un
precedente. Ci riprovò Paul Carus, filosofo e teologo tedesco fra i
principali traghettatori del pensiero orientale negli Stati Uniti, dove
emigrò per sfuggire all’appesantimento culturale della politica bismarckiana. Il suo recupero del panteismo goethiano in una forma
di “panbiotismo”, che includesse tutto ciò cui spetta la dignità della
vita, lo resero «un ateo che amava Dio»9, come amava definirsi. Una
celata ironia lo mise presto sulla strada dello stesso D.T. Suzuki, dal
momento che questi avrebbe forse potuto definirsi al contrario, alla
luce della sua formazione Zen, “un credente che non amava Dio”. A
Goethe si ispirò poi il terzo personaggio chiave di questo confronto,
ovvero Bruno Petzold (1873-1949), giornalista e scrittore corrispondente in Cina per un giornale tedesco che, appassionatosi a dovere di
tradizioni estremo-orientali, proseguì il suo viaggio sino in Giappone
ed ebbe modo di convertirsi del tutto presso un monastero Tendai.
Non è soltanto l’occhio di riguardo per le arti – affinato anche dalla
moglie che a Tōkyō si esibiva come pianista e cantante – a rendere
Petzold una figura simbolica di questa panoramica, ma soprattutto il
suo bisogno di non slegare affatto le sue nuove esperienze dal proprio
retroterra culturale. All’approfondimento dei valori del buddhismo
mahāyāna assegnò anzi presto la mansione, ricoperta nei suoi scritti,
di annodare i fili conduttori del discorso filosofico occidentale, frammentato tra diverse fazioni e tradizioni speculative, che Petzold invece ammirava a prescindere da presunte antitesi, in particolare quando
«An atheist who loved God», cfr. Paul Carus, The Gospel of Buddha, Wentworth
Press 2016, p. 26.
9
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 167
si trattava dei sistemi di Nieztsche e Schopenhauer, da conciliare con
quelli di Feuerbach e Stirner.
L’ultima pedina mossa da questo confronto è quella di Ernst
Lothar Hofmann (1898-1985), conosciuto dai più con il nome di
Govinda, assunto quando a Ceylon divenne discepolo di Nyanatiloka,
il quale lo portò poi con sé in Birmania. Da giovane, avere in famiglia
un padre tedesco e una madre boliviana aiutò forse il futuro Govinda
a non sentirsi frenato nei movimenti dall’amor patrio. Dopo aver
aperto gli orizzonti mentali con gli studi di cristianesimo, buddhismo
e islamismo a Friburgo, inizia il primo dei suoi lunghi percorsi, per
studiare archeologia a Napoli. Trascorse anche molto tempo a Capri,
dove si dedicò alla pittura. Dopo aver appreso il pāli, aver approfondito i testi buddhisti ed essere entrato in contatto con la meditazione,
nacque in lui la curiosità di recarsi a Ceylon, appunto, al monastero di Nyanatiloka. Andò poi in Tibet, a cospetto del Lama Ngawang
Kalsang, e nel Kolkata, dove insegnò anche francese a Indira Gandhi.
Infine, raggiunta la notorietà, cominciò a muoversi ininterrottamente per spargere ovunque il suo insegnamento: Stati Uniti, Giappone,
Malesia, Filippine, Canada, Messico, Sudafrica e molti altri luoghi.
Non disgiunse mai quella che lui presto intese come missione
spirituale dall’attenzione mai perduta per la sensibilità artistica, anzi
maturata dall’esempio di Tagore. Quando fondò l’ordine dell’Arya
Maitreya Mandala, volle che i suoi frequentanti unissero agli studi
delle dottrine lamaiste e all’esercizio del tantrismo e del sādhanā (disciplina rituale induista), la lettura di poeti come Rilke e di testi filosofici come quelli di Klages.
Ultime riflessioni naïve
La parola “Oriente” e l’espressione “culture orientali” ormai hanno
un che di villano, la lingua ci affonda dentro come la zappa nella terra,
anziché catturare con cura, come solo lo studioso specialista armato
di bacchette sa fare, i termini corretti con cui indicare questa e quella
tradizione dei singoli paesi dell’Asia. Gli studi orientalisti si impadroniscono sempre più del rigore, e anche quanto arriva al grande pubblico – la mostra sulla scultura buddhista a Roma dello scorso agosto e
quella sull’ukiyo-e di Palazzo Reale a Milano lo confermano – vanta
ormai allestimenti dettati dallo scrupolo, in cui gli specialisti possono
168 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
ascoltare in silenzio gli altri visitatori dire a voce alta: “Oriente” e
“culture orientali”, per sorridere del gergo dei fuori casta.
Inutile, però, sorridere a nostra volta di questo sorriso. La domanda infatti resta la medesima dei primi approcci naïve di cui abbiamo
raccontato finora: di cosa c’è bisogno? Forse, oggi, c’è bisogno dello
specialismo. Senso di sicurezza teoretica? Tratto distintivo dal passato? Superomismo? Poco importa. A patto di non credere, però, che
la via maestra non sia stata, in gioventù, una “via cadetta” e non sia
andata a scuola da quello stesso dilettantismo da cui nacquero i primi
entusiasmi.
Nel caso, andiamo a rileggerci i turbamenti (Verwirrungen) di
uno di quei famosi “cadetti” (Zögling), quello narrato da Musil nel
1906 (Die Verwirrungen des Zöglings Törleß). «Il tipo d’uomo che
piace a me, sopra tutti, è più simile a un filosofo e santone indiano»10, dice il protagonista, contro il compagno d’istituto Reiting che
adora invece Napoleone. Esistono due fili, fa capire Musil nelle parole seguenti: uno rivolto all’esterno e che induce a una «compassionevole inazione» – pensiamo all’attesa quasi messianica che un
secondo Napoleone arrivasse a salvare il popolo germanico – e l’altro
che invece, facendo sprofondare nella propria anima, sa avvincere al
cosmo. I santoni indiani, esclama convinto Törleß, sono lì a dimostrare che per agguantare il secondo filo occorre spezzare il primo, cioè
compiere un sacrificio.
Vi furono disposti molti degli autori presentati in questa panoramica, si tratti del coraggio di svincolarsi dal proprio paese e dalla
propria cultura per cercare una risposta altrove, oppure di tentare la
salvezza della loro tradizione, quella europea, liberandosi però dalla speranza di poterlo fare contando unicamente sulle forze culturali
di quest’ultima. Chiediamoci quindi se avevano davvero bisogno di
eccessive accortezze filologiche. Io credo: non più di quanto un pompiere si preoccupa se dal secchio che starà per rovesciare sull’incendio cada un po’ d’acqua durante il trasporto.
«Si dice che il mondo consista in leggi meccaniche, in nulla modificabili», termina la sua tirata il giovane cadetto, «non è affatto vero,
è roba che sta solo nei libri di scuola!»11. Quando Musil era a scuola,
Robert Musil, I tormenti del giovane Törleß, tr. it. Giulio Schiavoni, Mondadori,
Milano 1987, p. 79.
11
Ibidem, p. 80.
10
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 169
ebbe la fortuna di scegliere come argomento della tesi di dottorato
un personaggio che, non contento delle leggi fenomeniche, riuscì ad
oltrepassare la barriera del suono. Era Ernst Mach. Gli interessi del
grande fisico per le culture orientali, mutuati dall’amicizia con Paul
Carus e Fritz Mauthner, avrebbero molto da dire sul rapporto odierno con il metodo scientifico. In una lettera del 1912 dichiarò che il
suo amore e l’interesse per il buddhismo fu forse un dono delle sue
deliziose «riflessioni ingenue» («durch die naivsten Überlegungen
entsanden ist»12).
Bibliografia
Baumann Martin, Deutsche Buddhisten. Geschichte und Gemeinschaften,
Marburg: Diagonal 1995.
Baumann Martin, Helmut Klar. Zeitzeuge des Buddhismus in Deutschland,
Konstanz: University of Konstanz 1995.
Beckh Hermann, Richard Wagner und das Christentum, Stuttgart: Verlag der
Christengemeinschaft 1933.
Beckh Hermann, Die Sprache der Tonart in der Musik von Bach bis Bruckner,
mit besonderer Berücksichtigung des Wagnerschen Musikdramas,
Stuttgart: Urachhaus 1937.
Bertholet Alfred, Der Buddhismus und seine Bedeutung für unser
Geistesleben, Tübingen/Leipzig: B. Mohr 1904.
Bertholet Alfred, «Buddhismus im Abendland der Gegenwart», in
Orientalische Literaturzeitung, Tübingen: Sammlung gemeinverst.
Vorträge 131 1928.
Bohn Wolfgang: «Die Einfürung des Sangho in Deutschland», in Die buddhistische Welt 1909/1911.
Buttler Paul-Gerhard, «Die buddhistische Bewegung in Deutschland», in
Asien missioniert im Abendland, Stuttgart: Kreuz Verlag 1962.
Carus Paul, Das Evangelium des Buddha, Leipzig: Übersetzt aus der englischen Auflage von Carus und Gauß 1895.
Conze Edward: «Spurious Parallels to Buddhist Philosophy», in Thirty Years
of Buddhist Studies, Oxford: Bruno Cassirer 1967.
Döblin Alfred, «Gotamo Buddha», in Unser Dasein, Olden/Freiburg im
Breisgau: Königshausen & Neumann 1932.
John Blackmoore, Mach als Außenseiter. Wien 1982, p. 48.
12
170 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Dumoulin Heinrich, «Das Buddhismusbild deutscher Philosophen des 19.
Jahrhunderts», in Zeitschrift für katholische Theologie 101, Innsbruck:
Universität Innsbruck 1979.
Eliade Mircea, Die Sehnsucht nach dem Ursprung, Wien: Europaverlag
1973.
Emmel Felix: «Die Seele Asiens», in Neue Rundschau 34, Berlin: S. Fischer
Verlag 1923.
Frauwallner Erich, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes,
Wien: Universität Wien 1939.
Gjellerup Karl, Der Pilger Kamanita, Frankfurt am Main: Rütten e Loening
1920.
Gjellerup Karl, Die Weltwanderer, Jena: Quelle & Meyer 1914 (1910).
Glasenapp Helmuth, Kant und die Religionen des Ostens, Kitzingen am
Main: Holzner Verlag 1954;
Glasenapp Helmuth, Das Indienbild deutscher Denker, Stuttgart: Koehker
Verlag 1960.
Grimm Georg, Die Lehre des Buddho, die Religion der Vernunft, Leipzig:
R. Piper 1915.
Grimm Georg, Die Wissenschaft des Buddhismus, Leipzig: W. Drugulin
1923.
Grimm Georg, Buddha und Christus, Leipzig: Neuer Geist Verlag 1928.
Han Byung-Chul, Philosophie des Zen-Buddhismus, Stuttgart: Reclam 2002.
Han Byung-Chul, Duft der Zeit: Ein philosophischer Essay zur Kunst des
Verweilens, Bielefeld: Transkript 2009.
Hecker Hellmuth, Buddhismus in Deutschland. Eine Chronik, Hamburg:
DBU 1985.
Hecker Hellmuth, Lebensbilder deutscher Buddhisten, Konstanz: Universität
Konstanz 1990-92.
Hecker Hellmuth, Buddhismus und Kunst, Konstanz: Universität Konstanz
1974.
Hecker Hellmuth, Der erste deutsche Bhikku. Das bewegte Leben des
Nyanatiloka, Konstanz: Universität Konstanz 1995.
Heiler Friedrich, Die buddhistische Versenkung, München: Reinhardt 1918.
Heim Karl, «Der Zen-Buddhismus in Japan», in Zeitschrift für Theologie
und Kirche, Tübingen: Mohr Siebeck 1923.
Herrigel Eugen, Die Ritterliche Kunst des Bogenschießens, in Nippon:
Zeitschrift für Japanologie, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1936.
Hesse Hermann, Siddhartha. Eine indische Dicthung, Frankfurt am Main:
S., Fischer Verlag 1922.
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 171
Hesse Hermann, Aus Indien. Aufzeichnungen von einer indischen Reise,
Berlin: S. Fischer Verlag 1913.
Hesse Hermann, Die Morgenlandfahrt: Eine Erzählung, Berlin: S. Fischer
Verlag, 1932.
Hoffmann Ernst Lothar, Die Grundgedanken des Buddhismus und ihr
Verhältnis zur Gottesidee, Leipzig: Altmann 1920.
Hoffmann Ernst Lothar, Kunst und Meditation, Allahabad 1936.
Hofmannsthal Hugo von, «K. E. Neumanns Übertragung der buddhistischen
heiligen Schriften» (1921), in Gesammelte Werke in Einzelausgaben.
Prosa IV, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 1955.
Hornstein Ferdinand von, Buddha. Legende in drei Akten, München: C.H.
Beck 1899.
Jaspers Karl, Die maßgebenden Menschen. Sokrates, Buddha, Konfuzius,
Jesus, München: R. Piper & Co. 1964.
Jung Carl Gustav, «Was Indien uns lehren kann» (1939), in Zivilisation
im Übergang (Gesammelte Werke. Zehnter Band), Olten/Freiburg im
Breisgau: Walter Verlag 1981.
Kaiser Georg, «Buddha», in Stücke, Erzählungen, Aufsätze, Gedichte, Köln:
Walther Huder. Kiepenheuer & Witsch Verlag 1966.
Kantowsky Detlef, «Buddhismus in Deutschland heute», in Spirita.
Zeitschrift für Religionswissenschaft 5, Marburg: Diagonal Verlag 1991.
Kassner Rudolf, «Die indische Gedanke» (1913), «Zen, Rilke und ich»
(1956), Sämtliche Werke, Zehnter Band, Pfullingen: Neske Verlag 1991.
Kubin Alfred, Aus meinem Leben, Wiesbaden: Fourier &Fertig 1870.
Lanczkowski Günter, «Richard Wagner und Indien», Indien und Deutschland,
Frankfurt/Main: H.O. Gunther 1956.
Lessing Theodor, Europa und Asien oder Der Mensch und das Wandellose.
Sechs Bücher wider Geschichte und Zeit, Hannover: Wolf Albrecht
Adam 1916.
Lucka Emil, «Buddhismus», in Neue Rundschau, Berlin: S. Fischer Verlag
1917.
Mainläder Philipp, Buddha. Ein dramatisches Fragment, München/Leipzig:
Hans Sachs Verlag 1913.
Mauthner Fritz, Der letzte Tod des Gautama Buddha, München/Leipzig:
Georg Müller Verlag 1913.
Mildenberger Michael, «Religiöser Humanismus. Zum europäischer Erbe im
deutschen Buddhismus», in Zur Religionsgeschichte der Bundesrepublik
Deutschland, München: Kösel 1980.
172 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Miura Naoji, Der ost-westliche Goethe. Deutsche Sprachkultur in Japan,
Bern: Peter Lang Verlag 2006.
Neumann Karl Eugen, «Das buddhistische Kunstwerk», in Süddeutsche
Monatshefte, München 1904, 1905, 1906.
Neumann Karl Eugen, Buddhistische Anthologie, Leiden: E.J. Brill 1892.
Nordau Max, «Buddha und der Buddhismus», in Die Gartenlaube, Leipzig:
Erst Keil Verlag 1908.
Notz Klaus-Josef, Der Buddhismus in Deutschland in seinen
Selbstdarstellungen, Frankfurt am Main/Bern/New York: Lang 1984.
Otto Rudolf, «Über eine besondere Form des japanischen Buddhismus», in
Zweites Mitteilungsblatt des Religiösen Menschheitsbundes, Tübingen:
Mohr 1922.
Osterhammel Jürgen: Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen
Reiche im 18. Jahrhundert, München: Beck 1998.
Petzold Bruno, Goethe und der Mahayana-Buddhismus, Kyoto (1936):
Octopus Verlag (Wien 1982).
Petzold Bruno, Die Quintessenz der T’ein-t’ai-(Tendai) Lehre. Eine komparative Untersuchung, Wiesbaden: Harrassowitz 1982.
Pfungst Arthur: Ein deutscher Buddhist, Stuttgart: Frommanns 1901.
Rilke Rainer Maria, «Buddha (Als ob er horchte)», «Buddha (Schon von ferne fühlt)», «Buddha in der Glorie», in Gesammelte Gedichte, Frankfurt
am Main: Insel-Verlag 1962.
Rovagnati Gabriella, Sehnsucht und Wirklichkeit: die Mythisierung
des Fernen Ostens bei Hugo von Hofmannsthal, in Zeitschrift für
Germanistik, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie 1994.
Rovagnati Gabriella, Alla ricerca di nuovi segni. Hofmannsthal e i linguaggi
non verbali d’Oriente, Studia Austriaca Vol. XI, Milano: Cuem 2013.
Ryogi Okochi, Wie man wird, was man ist. Gedanken zu Nietzsche aus östlicher Sicht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995.
Schumann Hans Wolfgang, Buddhismus und Buddhismusforschung in
Deutschland, Wien: Octopus Verlag 1974.
Schuster Ingrid, China und Japan in der deutschen Literatur 1890-1925,
Bern-München: Francke 1977.
Seidenstücker Karl: «Was bringt uns die Zukunft?» (1907), «Der Buddhismus
in Europa» (1911), Die Buddhistische Warte, Leipzig: A. Fändrich
1911/12.
Seydel Rudolf, Buddha und Christus, Breslau: Schottländer 1884.
Slepcevic Pero, Buddhismus in der deutschen Literatur, Wien: C. Gerolds
Sohn 1920.
Federico Filippo Fagotto - Attraverso la parete di vetro 173
Stache-Rosen Valentine und Stache-Weiske Agnes: Biographie of Scholars
in Indian Studies Writing in German. With a Summary on Indology in
German Speaking Countries, New Delhi: Max Müller Bhavan 1990.
Steiner Rudolf, Buddha und Christus, Dornach 1939.
Vogl Adolf: Maja (Klavierauszug), Stuttgart 1905.
Vogrich Max, Der Buddha. Große Oper (Klavierauszug und Libretto),
Leipzig 1901.
Waldschmidt Ernst, «The Influence of Buddhism on German Philosophy
and Poetry», in University of Ceylon Review, Colombo: University of
Ceylon 1963.
Wagner Richard, Die Musikdramen, Hamburg: Hoffmann & Campe 1971.
Widmann Joseph Victor, Buddha, Bern: Dalp (C. Schmid) 1912.
Zelinsky Hartmut, «Hugo von Hofmannsthal und Asien», in Fin de Siècle.
Zur Literatur und Kunst der Jahrhundertwende, Frankfurt am Main:
Roger Bauer 1977.
Zotz Volker, Zur Rezeption, Interpretation und Kritik des Buddhismus im
deutschen Sprachraum vom Fin-de-Siècle bis 1930, Wien: Phil. Diss.
1986.
Zotz Volker, «Zum Werden des Buddhismus-Bildes deutscher Philosophen
und Historiker», «Martin Baumann, Deutsche Buddhisten. Geschichte
und Gemeinschaften», in Horin. Vorgleichende Studien zur japanischen
Kultur, München: Ludicium-Verlag 1994.
Zotz Volker, «Zur Buddhismus-Rezeption in Europa», Geschichte der
Buddhistischen Philosophie, Reinbeck: Rowohlt 1996.
Zotz Volker, Auf den Glückseligen Inseln. Buddhismus in der deutschen
Kultur, Berlin: Theseus Verlag 2000.
Zweig Stefan, Die Augen des ewigen Bruders, Frankfurt am Main: InselVerlag 1922.
Zweig Stefan, Sehnsucht nach Indien. Ein Lesebuch von Goethe bis Grass,
München: C.H. Beck 1993
Zweig Stefan, Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens, Frankfurt am
Main: S. Fischer Verlag 1984.
Laboratorio
La logica del pensiero quotidiano
Riflessioni sulle “realtà multiple” di Alfred Schutz
Gianni Trimarchi
In this paper, I analyse A. Schutz' essay of 1945 On Multiple
Realities, together with two works by W. James which are often
quoted by Schutz and are a sort of basis for his essay. From his point
of view, social events should not be considered in a positivist sense,
in relation with their efficient causes. Rather, they are to be analyzed
on the basis of the meaning that they acquire as multiple realities,
in the process of being constantly re-planned. Here, internal time or
durée and external time interact. Alfred Schutz' categories have been
largely used by several anthropologists and sociologists who wish to
emphasize the dimension of possibility of life.
178 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Il sapere [dell'uomo medio] è inconsistente. Nello stesso momento egli
potrebbe considerare come ugualmente valide delle affermazioni che
sono in realtà incompatibili le une con le altre. In quanto padre, cittadino, impiegato, o membro della parrocchia, egli potrebbe avere su
diversi soggetti morali, politici, o economici le opinioni più divergenti e
meno congruenti, ma ciò che sta all'origine di questa inconsistenza non è
necessariamente un errore logico…Gli uomini non sono coscienti delle
modificazioni che devono mettere in atto per passare da un livello all’altro…Esplorare questo problema dovrebbe essere il compito di una logica del pensiero quotidiano che tutti i grandi logici, da Leibniz a Husserl
e Dewey hanno postulato, ma che non hanno mai realizzato. Fino a oggi
la scienza della logica ha trattato solo di logica della scienza.1
Alfred Schutz (1899-1959) non è certo il più conosciuto fra i fenomenologi, però la sua opera pone fondate basi teoriche per elaborare
quella che egli chiama “la logica del pensiero quotidiano”2. I suoi
testi, per quanto poco noti al grande pubblico, ebbero tuttavia un
esito notevole, in quanto costituirono le premesse per la teorizzazione e quindi per il lavoro empirico di grandi antropologi e sociologi,
a partire dagli anni Settanta.3 Come vedremo, autori come Geertz,
Goffman e altri, dichiararono il loro debito in forma molto esplicita, facendo spesso riferimento al saggio sulle realtà multiple, che qui
prendiamo in esame. Il discorso inizia tuttavia prendendo in esame
due testi di William James, che in questo testo vengono citati più
volte. Concluderemo infine con qualche cenno alla non trascurabile
fortuna postuma di Schutz.
Schutz A. The Stranger, An Essay on Psycology in American Journal of
Sociology n 49 499-507, 1944, Trad francese L’étranger ed Allia 2010, 15.
2
Ivi, 15.
3
Per questioni di brevità, qui non prendiamo in esame i testi recentemente pubblicati da alcune giovani studiose legate all’università di Pisa. Ricordiamo tuttavia:
C. Damari, La percezione della realtà in Schutz e in Goffman, Pisa University Press
2008. Va anche citato: F. Sacchetti, A. Schutz e P. Ricoeur, percorsi della soggettività
fra filosofia e ermeneutica, Roma, Bonanno, 2012.
1
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 179
La realtà come fantasia non contraddetta
Rompendo in forma categorica con il metodo positivista, ma anche
con le teorie classiche legate all’«adaequatio rei et intellectus» già
nel 1880, James afferma che “la credenza, o il senso di realtà, è una
sorta di sentimento, più affine alle emozioni che a qualsiasi altra cosa.”4 Viene percepita come reale qualunque fantasia, fintanto che non
compaia una percezione discordante con la fantasia iniziale. È quindi
“reale” un cavallo con le ali immaginato da un bambino, mentre non
può avere le ali “la mia giumenta Maggie”, perché questo sarebbe in
contraddizione con tutto l’ambiente circostante.
È poi reale tutto ciò che crea in un soggetto una grande emozione,
ponendosi decisamente in primo piano nella mia percezione, mentre
tutto il resto viene relegato nell’oscurità dello sfondo. Quelle donne
che erano “divine un tempo”5 sono destinate a diventare insignificanti, nel momento in cui l’interesse si rivolge ad altro.
Le immagini della psicologia tradizionale costituiscono una parte molto
piccola delle nostre menti. La psicologia tradizionale si esprime come
chi volesse sostenere che un fiume consiste solo in secchiate d’acqua.
Fra i secchi l’acqua libera continuerebbe ancora a scorrere. È quest’acqua libera della coscienza che gli psicologi continuano risolutamente a
trascurare. Ogni immagine definita nella mente è impregnata e colorata
dell’acqua che le scorre liberamente intorno. Il valore dell’immagine
è tutto in questo alone, o penombra, che la circonda e la accompagna.
Chiamiamo questo alone con il nome di frangia6
Abbiamo così nel soggetto umano un continuo avvicendarsi di
“sub-universi” assolutamente differenziati fra loro, che si succedono
l’uno all’altro per cause diverse, ad esempio dopo un grosso shock,
o comunque per l’apparire alla ribalta di elementi di contraddizione,
che aprono un orizzonte nuovo. In sostanza, “la realtà dilegua con
W. James 53 La percezione della realtà in W. James-A. Schutz Le realtà multiple e altri scritti, Pisa, ETS 2005, 53.
5
W. James Il flusso di coscienza in James-Schutz Le realtà multiple e altri scritti
cit,104.
6
Ivi, 111.
4
180 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
l’attenzione”7 nel corso del divenire. Si tratta, per James, di un fenomeno dinamico, che non ha la rigidità statica del “dato”.
Il modo di vedere del nostro filosofo ha anche altre valenze: mentre certe forme di pensiero tendevano ad esaltare l’επιστέμη, contro la
δόξα, James ribalta il discorso, sottolineando “l’ostinazione con cui il
mondo dei colori e degli odori resiste a quello delle vibrazioni”8 che
ne costituiscono l’espressione scientifica. Si tratta di un modo di intendere profondamente diverso dall’evoluzionismo, che invece è teso
a obliterare in forma definitiva tutto ciò che viene “superato”.
La storia della scienza è costellata da relitti e rovine di teorie a cui una
volta si aderiva appassionatamente, ma di cui si è trovato che non stavano assieme con alcun fatto sensibile.9 […] È questa una strana dipendenza circolare, in cui l’apparenza ha bisogno della realtà per esistere e
la realtà dell’apparenza per essere conosciuta.10
Quando non si tratta di conoscenza scientifica, ma di credenza,
tutto si fonda sulla “commozione corporea messa in atto dall’idea eccitante nulla che io possa sentire così può essere falso. Tutte le nostre
credenze religiose e soprannaturali sono di questo tipo.”11
Quei pellegrini che hanno visitato la Mecca o la Terra Santa sono in
seguito credenti, più fiduciosi e più zelanti di quelli che non hanno avuto
questo previlegio12…Alcune persone troverebbero difficoltà a far lezione senza una lavagna…uno dei suoi usi risiede sicuramente nel suscitare
la reazione di credenza e nel conferire alle idee una realtà più vivida […]
Quando ci raccontano una storia, se ci viene mostrato il vero coltello di
cui si servì l’assassino, tutta la cosa passa dalla fantasia alla madre terra,
così noi vediamo tutto quanto solo se ci sono dei mattoni superstiti a
raccontarci la storia.13
W. James La percezione della realtà in James-Schutz Le realtà multiple e altri
scritti cit. p 64
8
Ivi, 71.
9
Ivi, 71.
10
Ivi, 72.
11
Ivi, 78.
12
Ivi, 73.
13
Ivi, 75.
7
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 181
Non senza una certa ironia, James ci spiega che l’episteme del
discorso filosofico non può fare a meno di misurarsi con le credenze
e con gli affetti che a esse si legano. Il sottointeso sottile è che non
ha senso proclamare una verità, se questa viene rifiutata dal gruppo
rituale.
Una filosofia potrebbe essere impeccabile sotto altri punti di vista, ma
ci sono due difetti che anche isolatamente potranno essere fatali all’accettazione generale… In primo luogo il suo principio ultimo non deve
essere tale da frustrare o deludere i nostri desideri più cari e i nostri
poteri prediletti. Un secondo difetto, peggiore del contraddire le nostre
propensioni all’azione, consiste nel non dare ad esse un oggetto qualunque contro cui far forza. Una filosofia il cui principio sia così incommensurabile con i nostri poteri più intimi da negare ad essi una qualunque
rilevanza negli affari universali e da annientare i loro motivi d’un soffio
sarà sempre più impopolare del pessimismo.14
James non manca di inserire nel suo testo alcuni esempi precisi,
ricavati dalla vita quotidiana.
Un droghiere ha un credo completo quanto alla politica estera, una ragazza di campagna sarà sicura che Parigi non potrà essere presa, o che
Bismark è un miserabile, tutto perché essi hanno concepito queste cose
in qualche momento con passione.15
Gli aspetti molteplici della realtà
Nel suo saggio, Schutz convalida in sostanza le proposizioni di
James che qui abbiamo preso in esame, facendo riferimento anche a
Husserl,16 secondo il quale “nell’atteggiamento naturale, prima della
riflessione, non c’è nessuna categoria di realtà”. “Noi non siamo interessati a scoprire se questo mondo esiste davvero, o se è soltanto
Ivi, 82
Ivi, 79
16
Erfahrung und Urteil, trad. it. Esistenza e giudizio par74a (compare in JamesSchutz, Le realtà… cit, 157. (Testo non reperibile)
14
15
182 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
un sistema internamente solidale di apparenze fra loro coerenti.”17 In
questo senso:
Anche l’uomo nell’esperienza naturale adotta una specifica epoché, naturalmente tutta diversa da quella fenomenologica. Egli non sospende la
credenza nel mondo esterno, ma sospende il dubbio relativo all’esistenza del mondo esterno. Proponiamo di chiamare questa epoché l’epoché
d’atteggiamento naturale.18
Il discorso, tuttavia, presenta anche altre sfaccettature. Come abbiamo visto, in certi casi Schutz afferma che noi crediamo a un certo
tipo di realtà fino a quando non sorgono elementi di contraddizione
nell’atteggiamento naturale, causati da “un’esperienza strana”19 In altri passi, tuttavia, il discorso è molto più dinamico:
Le province di senso non sono stati separati della nostra vita mentale…
si tratta soltanto di nomi, per indicare diverse tensioni in un’unica coscienza…La mia mente può attraversare nell’arco di una sola ora l’intera gamma delle tensioni di coscienza, ora vivendo in atti lavorativi, ora
facendo un sogno a occhi aperti, ora immergendomi nel mondo pittoresco di un quadro.20
A. Schutz, Le realtà multiple cit, 148.
Ivi, 148.
19
Ivi, 147, 148, 151.
20
Ivi, 177. Qui compare un cenno molto fugace alla pittura, mentre non si fa alcun
cenno alla musica. A quest’ultima tuttavia si riferiscono i Frammenti di fenomenologia della musica, dove, ad esempio, si parla in forma compiuta dell’opera mozartiana e della sua capacità di introdurci alle province di senso in cui vivono i singoli
personaggi. Proprio la musica sembra essere la forma artistica che meglio esprime
il pensiero di Schutz, come possiamo ricavare da alcuni passi del saggio su Mozart.
“Mozart non comunica semplicemente a noi spettatori il significato oggettivo che
la situazione ha nel contesto della trama. Egli ci mostra in aggiunta i differenti significati che la stessa situazione ha per ciascuno dei personaggi in essa coinvolti.
Egli ci fa capire che per ciascuno di essi la presenza e il comportamento degli altri
sono elementi della sua stessa situazione” (A. Schutz, Fragments of Phenomenology
of Music, trad. it. Frammenti di fenomenologia della musica, a cura di N. Pedone,
Milano, Guerini e associati 1996, 135). “ L’azione della scena ha luogo davanti ai nostri occhi, nello spazio esterno e nel tempo esterno. La musica tuttavia è un processo
che si svolge nel tempo interno, nella durée. Ascoltando la musica, noi ci immergiamo nel flusso continuo della nostra coscienza. Il problema principale che un compo17
18
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 183
Qui Schutz non vuole conoscere il comportamento che l’uomo
assume nei confronti di ciò che gli accade. L’oggetto del suo interesse
riguarda “il senso soggettivo che questi attribuisce a certe esperienze
della propria vita spontanea”21 e il senso delle relazioni intersoggettive. Si tratta di processi molto più articolati di quanto i behavioristi
non potessero immaginare.
Chi comunica non fa esperienza solo di ciò che effettivamente dice.
Un complicato meccanismo di richiami e anticipazioni connette entro
il suo flusso di coscienza un singolo elemento del discorso con quanto
precedeva e con quanto seguirà nell’unità del pensiero che vuole trasmettere. Tutte queste esperienze appartengono al suo tempo interiore, [o bergsonianamente durata]… Anche io ascoltatore faccio a mia
volta esperienza delle mie azioni interpretative…da una parte vivo il
discorso dell’altro come evento nel tempo esterno, dall’altra vivo il mio
interpretare come una serie di richiami che hanno luogo nel mio tempo
interiore…Entrambi, io e l’altro, viviamo il processo comunicativo in
un vivido presente... Questo continuo rimbalzare di segnali e di richiami
nella comunicazione fra più persone finisce col creare il Noi.22
Ragionando ad altri livelli, Schutz ci spiega, invece, come esistano esperienze non facilmente comunicabili, come quella dell’immaginazione, del sogno, ma anche del pensiero teorico, le cui premesse
non sembrerebbe potessero venir condivise con l’uomo della strada.
“Il fenomenologo si pone di fronte alla difficoltà di comunicare la sua
conoscenza al dogmatico, che resta nell’atteggiamento naturale.”23
Contraddicendo in parte quanto affermato in altri passi del suo
saggio, Schutz finisce col dichiarare un certo ottimismo, fondato in
parte sull’impiego dei “tipi ideali”, che egli ritiene di poter trasmettere all’uomo comune24, ma anche fondato sulla naturalità e sull’universalità della comunicazione “mondana”25, relativa all’atteggiamento naturale:
sitore lirico deve risolvere è la traduzione di eventi del tempo e degli spazi esterni in
eventi del flusso del tempo interno” (Ivi, 136).
21
A. Schutz Le realtà multiple, in James-Schutz, Le realtà multiple cit, 128
22
A. Schutz Le realtà multiple cit, 138.
23
Ivi, 176.
24
Ivi, 174.
25
Ivi, 176.
184 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Le province di senso non sono stati separati della nostra vita mentale…
si tratta solo di nomi per indicare diverse tensioni di un’unica e medesima coscienza. Ed è alla medesima vita, la vita mondana, ininterrotta
dalla nascita alla morte che prestiamo attenzione in diversi modi…Se i
bambini giocano insieme al far finta che…se siamo collegati con altri
in un medesimo rituale, siamo ancora nel mondo del lavorare, collegati
con l’Altro mediante atti comunicativi. E tuttavia i protagonisti hanno
compiuto insieme il salto dalla provincia finita di senso del mondo della
vita quotidiana alla provincia del gioco, dell’arte, dei simboli religiosi
e via dicendo.
Allora la scienza viene di nuovo inclusa nel mondo della vita.26
Alcuni commentatori, come Possenti27 e Iacono,28 leggono questo
passo come un ritorno nella caverna platonica, intesa come il luogo in
cui le realtà singole si sfaldano in nome di un pensare e di un sentire
comune a tutti, teso a operare nuove costruzioni di senso nell’ambito dei concetti spontanei. Questi sono fondati sulla naturalità che
trascende le posizioni precostituite e anche le elaborazioni teoriche,
qui assimilate, in certo senso, al sogno29, per l’impossibilità di comunicarle in forma diretta ai non iniziati. Nel saggio su Mozart, Schutz
sembra sorridere sul “dispregio di Rousseau per i concertati e il suo
orrore per le forme contrappuntistiche…in nome del principio di naturalezza”30, qui al contrario la naturalità del linguaggio non scientifico risulta costituire il fondamento della comunicazione sociale.31
Ivi, 177-178.
I. Possenti, Introd a James-Schutz Le realtà multiple cit, 27.
28
Ivi: A. Iacono, Postfazione, 203.
29
“…Ciò implica, se si intende bene il significato delle definizioni date sopra, un
certo distacco [da parte del pensatore teorico] quanto all’interesse per la vita e un
allontanamento da quello che abbiamo chiamato “stato di completa vigilanza” (A.
Schutz, Le realtà multiple cit. 166). “Il sé che teorizza è solitario; non ha ambiente
sociale e sta al di fuori dei rapporti sociali” (Ivi, 172).
30
A. Schutz, Frammenti di fenomenologia della musica, cit, 119.
31
Non mi è dato di sapere se Schutz avesse in mente il primo capitolo di Nathan
il saggio di Lessing. Certo fra i due testi esiste un certo parallelismo, se intendiamo
come ritorno nella caverna la situazione del templare che vede messo in crisi tutto un
complesso sistema di costruzioni di senso a opera dell’urlo disarticolato di una bambina ebrea in pericolo di vita. In questo caso la primordialità (e la naturalità) dell’urlo
sembra “riempire le lacune del linguaggio”, (Diderot), rompendo lo schema preco26
27
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 185
La filosofia di Schutz davanti a un problema empirico:
lo straniero.
Schutz, austriaco, fu profugo in America a partire dal 1939 a causa
delle leggi razziali. Ciò che abbiamo fin qui preso in esame trova
un’interessante applicazione in un suo breve, ma incisivo, testo, pubblicato nello stesso anno in cui ricevette la cittadinanza americana.
Qui le sue categorie filosofiche acquistano una notevole pregnanza
nello spiegare alcuni aspetti sconcertanti del “nuovo mondo” in cui si
trovò a vivere.
L’oggetto di questo saggio consiste nello studiare la situazione in cui si
trova uno straniero, “quando si sforza di interpretare il modello culturale del nuovo gruppo sociale a cui si accosta e cerca di orientarsi al suo
interno, cercando di innescare un processo che gli permetta di rendersi
accettabile32 […] e di non essere più veramente uno straniero.33
Il nuovo gruppo sociale del nostro filosofo risultava costituito
dalla classe dirigente di New York, se non dagli austeri docenti della
New School for Social Research, presso la quale insegnava. Egli non
osa definirli in esplicito come “nativi”, benché li descriva come dediti
agli “idola tribus”34 e a tutto un modo di essere assai più fondato sulla
credenza che non sulla ragione. In sostanza “il credo completo del
droghiere”, di cui parlava James35, esiste, ma non riguarda necessariamente le classi subalterne.
Inizialmente lo straniero è una sorta di “spettatore disinteressato”36 che, con un atteggiamento in certo qual modo etnografico, cerca
di capire usi e costumi del “nuovo gruppo”, ragionando, ovviamente,
con le categorie del suo gruppo di origine. A un certo punto, però, il
nuovo modello culturale non è più un semplice oggetto di osservazione, ma diventa una parte del mondo che egli deve dominare. Egli salta, per così dire, dalla sala alla scena, cambiando provincia di senso e
stituito delle province di senso, in nome di un “Noi nel vivido presente” (Schutz, Le
realtà multiple, cit. 138, 139, 140) che trascende le convenzioni e le convinzioni.
32
A Schutz, Lo straniero, cit, 7.
33
Ivi, 39.
34
Ivi, 36.
35
W. James, La percezione della realtà cit, 79.
36
A. Schutz, Lo straniero cit, 21.
186 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
diventando un membro della troupe. Qui tutti i suoi schemi crollano:
quelli del gruppo originario risultano inadeguati, ma anche i nuovi si
mostrano nella loro inconsistenza37.
[Il nativo statunitense] non si occupa che in maniera parziale – diremo
eccezionale? – delle sue conoscenze. Gli basta avere a disposizione un
telefono funzionante, anche senza sapere come funziona. Tutto ciò che
egli reclama è un sapere verosimile e una visione chiara dei rischi che la
situazione può comportare38 […] Il sapere proprio al modello culturale
comporta la propria evidenza…in assenza dell’evidenza del contrario.
È un sapere fatto di ricette sulle quali si può contare per interpretare il
mondo sociale e per trattare gli uomini e le cose allo scopo di ottenere
in ogni situazione il miglior risultato con il minimo di sforzo […] Ogni
membro del gruppo accetta lo schema prefabbricato e standardizzato del
modello culturale che gli antenati, i professori e le autorità, gli hanno
trasmesso.39
Per lo straniero, tuttavia la regola vale al contrario, in quanto non
si tratta di dare per buono un mondo già dato in forma opaca, bensì di
giustificare le regole del nuovo mondo, in cui egli non riesce trovare
né un criterio di evidenza, né uno di razionalità. Anche qui compare,
fra le righe, l’epoché dell’atteggiamento naturale40, familiare ai “nativi”, ma non facilmente accessibile per chi viene dall’esterno.
Il meteco trova difficoltà non facilmente sormontabili, anche per
quanto riguarda la lingua, perché la si apprende solo in parte dalla
grammatica e dal vocabolario: per padroneggiarla fino in fondo ci
vuole il marchio dell’abitudine e della semi-coscienza41. Infatti, per
poter dialogare con gli Yankees, non basta conoscere la Bibbia (magari in ebraico) o Shakespeare nella traduzione tedesca: bisogna aver
letto i testi in inglese, occorre anche “aver scritto lettere d’amore,
saper pregare e maledire in lingua”42.
Proprio per la sua visione “chiara e rattristata” del contesto
in cui vive, lo straniero tuttavia può intuire meglio di altri la venuta
Ivi, 22.
Ivi, 14.
39
Ivi, 16.
40
A. Schutz Le realtà multiple, cit, 148.
41
A. Schutz Lo straniero cit, 31.
42
Ivi, 30.
37
38
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 187
prossima di una crisi43, mentre i suoi interlocutori, che riposano sulle
loro consuetudini senza cercare una autentica comprensione della realtà, rischiano di non avvertirne i sintomi.
I “nativi” rimproverano spesso allo straniero di non cercare “asilo
e protezione”44 nel nuovo modello culturale. Essi tuttavia non capiscono che nella fase di transizione quel modello non è per lo straniero
un rifugio, ma “un paese avventuroso45, un labirinto in cui egli ha
perduto il senso dell’orientamento”46
Il bisogno che ha lo straniero di “esaminare con attenzione e precisione ciò che sembra automaticamente compreso dal nuovo gruppo” ha una ragione profonda “nell’esperienza amara dei limiti del suo
pensare abituale”.47
In sostanza il gruppo dei nativi sembra ricalcare l’atteggiamento
di Don Chisciotte, “signore indisturbato del suo sub-universo”,48 al
quale riesce a dare comunque una coerenza, grazie all’espediente del
mago malvagio. L’esperienza dello straniero, invece, sembra costituirsi come una situazione di prolungato shock, o quanto meno di inquietudine, destinata a introdurlo gradatamente dallo stato di “ibrido
culturale, che vive alla frontiera fra due modelli di vita”49, a quella di
cittadino del nuovo stato.
Schutz e le scienze umane
Al paradigma di Schutz fa riferimento Clifford Geertz50, quando definisce come obsoleto il metodo “galileiano” usato nelle scienze umane
Ivi, 37.
Ivi, 38.
45
Ivi, 35.
46
Ivi, 38.
47
Ivi, 36.
48
I. Possenti, Introduzione a James-Schutz, Le realtà multiple cit, 24.
49
A. Schutz, Lo straniero, cit, 37.
50
Nel saggio La religione come sistema culturale di Geertz (in C. Geertz, The
Interpretation of cultures, New York Basic Books, Inc 1973, trad. it. Bologna il
Mulino,1987, 137-183) troviamo ben tre citazioni da Schutz, che qui riporto. “Vi
sono diverse province di significato a cui posso conferire l’accento della realtà. Sono
il trauma di piombare addormentati come se si saltasse nel mondo dei sogni, la trasformazione interiore che subiamo se il sipario del teatro si leva come transizione al
mondo del palcoscenico; il mutamento radicale del nostro atteggiamento se, davanti
43
44
188 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
e fondato sulla mera ricerca delle cause efficienti. Giustamente egli
afferma che oggi anche i fisici fruiscono di modelli diversi.
Geertz pensa weberianamente il problema epistemologico come problema di oggettivazione e di analisi delle varie procedure di costruzione
degli oggetti scientifici, interrogandosi non sui dati, ma sulle forme della
loro visibilità e conoscibilità.51
Ragionando in termini solo apparentemente semplici, Geertz afferma che un identico movimento, dal punto di vista del mero comportamento, può ugualmente risultare come effetto di un tic nervoso,
oppure di un ammiccamento.
…tuttavia la differenza fra un tic e un ammiccamento è grande, benché
non sia fotografabile, come sa chiunque è stato abbastanza sfortunato da
scambiare l’uno per l’altro. 52
a un quadro, permettiamo al nostro campo visivo di essere delimitato dentro la cornice come il passaggio nel mondo pittorico; il nostro imbarazzo che si scioglie in
una risata se, ascoltando una storiella, siamo pronti per un breve tempo ad accettare
il mondo fittizio dello scherzo come una realtà in rapporto alla quale il mondo della
nostra vita quotidiana assume il carattere della stupidaggine; il volgersi del bambino
verso il suo giocattolo come transizione nel mondo del gioco e così via. Ma anche le
esperienze religiose in tutte le loro varietà – ad esempio l’esperienza di Kierkegaard
dell’ «istante» come salto nella sfera religiosa – sono esempi di un trauma simile,
come anche la decisione dello scienziato di sostituire la partecipazione appassionata agli affari di «questo mondo» con un atteggiamento disinteressato. (C. Geertz,
Interpretazione di culture, cit, 177; citazione da A Schutz Le realtà multiple cit, 151).
“Quello che distingue il senso comune come modo di «vedere» è, come ha fatto notare Schutz, una semplice accettazione del mondo e dei sui processi come se fossero
proprio come sembrano essere, ciò che a volte si chiama “realismo ingenuo” (Ivi,
165, da A. Schutz, The Problem of Social Reality, in Collected Papers, vol 1 The
Hague, 1962). “Il mondo quotidiano degli oggetti di senso comune e delle azioni pratiche è, come dice Schutz, la realtà dominante nell’esperienza umana – suprema – nel
senso che è il mondo in cui siamo più saldamente radicati, di cui non possiamo mettere in dubbio l’intrinseca concretezza…e alle cui espressioni possiamo meno sfuggire.” (Ivi, 174-175 da A. Schutz, The Problem of Social Reality, cit, 226 e segg.))
51
R. Malighetti, Clifford Geertz, il lavoro dell’antropologo, Torino, UTET, 2008,
36
52
C. Geertz, Interpretazione di culture, cit, 42.
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 189
In sostanza, applicando il discorso alle scienze sociali, l’interesse del grande antropologo non consiste nel raccogliere dati di fatto
sull’ambiente o sulle origini storiche, che di per sé non conducono
alla comprensione di ciò che accade. Il suo impegno consiste, invece, nell’interpretare le situazioni, individuando le costruzioni di senso messe in atto dagli “attori” delle varie vicende, come risulta, ad
esempio, da una sua ricerca, in cui si tratta di una complessa vicenda
relativa a un furto di pecore, avvenuto negli altipiani del Marocco
centrale, intorno al 1912.
Reclamando il suo ‘ar, (maledizione) Cohen, [il derubato], invocava il
patto sul commercio; riconoscendone la pretesa, lo sceicco sfidava la tribù degli offensori. Accettando la responsabilità, la tribù degli offensori
pagò l’indennizzo. Ansioso di chiarire agli sceicchi e ai trafficanti chi
comandasse, il comandante francese si comportò da imperatore.53
In questo contesto, il debito del Nostro verso James e Schutz
compare con chiarezza, ad esempio nella sua famosa definizione della
religione, che egli intende come:
un insieme di simboli che agisce, stabilendo profondi e durevoli stati
d’animo, e motivazioni negli uomini, per mezzo della formulazione di
concetti di un ordine generale dell’esistenza e per mezzo del rivestimento di questi concetti con un’aura tale di concretezza, che gli stati d’animo e le motivazioni sembrano assolutamente realistici.54
Qualche pagina dopo, non a caso, Geertz cita James, quasi
a convalidare il passo di cui sopra, riportandoci, in certo senso, al “credo completo del droghiere” di James55, o all’epoché
dell’atteggiamento naturale di Schutz,56 che abbiamo già preso
in esame.
Come osservò James, noi crediamo a tutto quello che possiamo e crederemmo a ogni cosa, se solo potessimo
53
55
56
54
Ivi, 56.
Ivi, 141.
W. James, La percezione della realtà, cit, 79.
A. Schutz, Le realtà multiple, cit. 148.
190 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
La cosa che sembriamo meno in grado di sopportare è una minaccia ai
nostri poteri concettuali. L’idea anche vaga che possa venirci meno la
capacità di creare, afferrare e usare i nostri simboli, perché se questo
accadesse, noi saremmo più impotenti dei castori […] senza l’aiuto dei
modelli culturali [l’uomo] sarebbe funzionalmente incompleto […] le
nostre doti più importanti sono sempre i simboli della nostra orientation
in generale. Di conseguenza in una società primitiva viene incorporato un rituale quotidiano nelle attività comuni, nel mangiare, nel lavarsi
[…], perché si sente il bisogno di riaffermare la morale tribale e di riconoscerne le condizioni cosmiche 57
La morale tribale acquista poi un’identità specifica nel resoconto
etnografico sulla farsa di Rangda e Barong, dove gli attori e il pubblico “cadono ovunque in trance”58. Nelle nuove interpretazioni non si
tratta di un meccanismo a carattere isterico, ma dell’ingresso in una
provincia di senso diversa da quella consueta. La trance, infatti, può
essere letta come “una crisi piuttosto recitata, una fuga dalla vita quotidiana, un modo per qualcuno di realizzare un altro sé,”:59 rimanendo
in stato di vigilanza, o con il “marchio d semi-coscienza”, come indicato anche da Schutz nell’analisi dei fenomeni quotidiani60.
Interessante per altro verso il passo in cui Geertz ci parla di una
querelle fra Levy Bruhl e Malinowski61, che pone il discorso sulle
realtà multiple ben al di sopra del livello quotidiano. La reciproca
incomprensione, infatti, sembra risultare fondata sul fatto che i due
antropologi erano rigidamente arroccati su due diverse e pertanto incompatibili province di senso. L’uno infatti vedeva la realtà dei primitivi in una prospettiva specificamente religiosa, mentre l’altro ragionava sul loro senso comune. “Il punto in cui entrambi andarono fuori
strada fu la mancata spiegazione del modo in cui queste due forme di
pensiero interagiscono.”62
Nel pieno rispetto per la profondità del personaggio, sono state
fatte alcune obiezioni al metodo di Geertz, quanto meno per il fatto
che egli non pare fosse molto sensibile all’idea di considerare l’antro57
59
60
61
62
58
Ivi,151-152.
Ivi, 173.
A. Brivio, Il vodu in Africa, metamorfosi di un culto, Roma, Viella 2012 149-150.
A. Schutz, Lo straniero cit, 31; v. anche A. Schutz Le realtà multiple cit, 166.
C. Geertz, Interpretazione di culture, cit, 176.
Ivi, 176.
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 191
pologo come un elemento vivo del campo, inevitabilmente destinato
a interagire, in forma non neutrale, con quella stessa realtà di cui cercava i significati. (Borutti, Fabietti, Remotti)63 In questo senso sembrerebbe che Geertz fosse disponibile a ragionare sulle realtà multiple
che riguardano i nativi, ma dimostrasse una certa insensibilità alla
sintesi messa in atto dal “Noi nel vivido presente”64, relativa all’intervento dell’antropologo sul campo65. In tutti questi casi, la presenza
di James e Schutz nell’orizzonte di Geertz sembra risultare eminente.
Anche in ambito sociologico il nostro autore ha lasciato una traccia non trascurabile, in quanto, come scrivono Collins e Makowsky,
con le realtà multiple i sociologi escono dal mondo delle statistiche
[per affrontare direttamente] le realtà umane celate dietro i numeri e le
astrazioni…Questo metodo ha prodotto intuizioni e scoperte che hanno
cominciato a ristrutturare la teoria sociologica da capo a piedi66.
63
A proposito di Geertz, S. Borutti scrive:”Geertz persegue uno scambio dialogico
e traduttivo, ma ciò che di fatto è messo in dialogo sono degli organismi statici di
senso…I nativi sono lasciati in silenzio, o meglio sono trasformati in enunciati, loro
che sono soggetti enuncianti…Il campo è l’apertura di uno spazio artificiale…è un
fuori-testo che l’antropologia riconosce di dover richiamare nel testo come condizione
della ricerca” (S. Borutti, Filosofia delle scienze umane. Le categorie dell’Antropologia e della Sociologia. Milano, B. Mondadori 1999,172). Ugualmente critico è anche
U. Fabietti: “Benché la prospettiva interpretativa, fondata sulla metafora della cultura,
implichi una pratica antropologica basata sull’interpretazione, di soggetti a loro volta
interpretanti, cioè i nativi, in realtà essa espunge questi ultimi dallo scenario del campo,
restituendo la parola all’antropologo, che può disporre di quelle interpretazioni a suo
piacimento. Detto in altre parole, l’antropologia interpretativa, almeno nella sua versione testuale sembra essere “poco dialogica” ed è appunto questa la critica che molti
scolari e seguaci di Geertz hanno mosso a quest’ultimo” (U. Fabietti, Antropologia
culturale, l’esperienza e l’interpretazione, Bari, Laterza 2004, 238). F. Remotti, a proposito di Geertz, parla di “un pensiero che ha finito per impigliarsi e rimanere sospeso
fra le ragnatele di significati che egli stesso ha intessuto.” (F. Remotti, introduzione
a Interpretazione di culture cit, 31). In altri termini si esprime invece R. Malighetti,
sottolineando gli aspetti positivi del lavoro dell’antropologo americano: “La scienza
geertziana si identifica con la libertà di fare connessioni e separazioni fra campi di
indagine, violando linee metodologiche ritenute inviolabili” (R. Malighetti, C. Geertz,
cit, 39).
64
A. Schutz, Le realtà multiple cit, 140.
65
Per quanto riguarda la presenza dell’antropologo sul campo, cfr S. Allovio Riti
di iniziazione. Antropologi, stoici e finti immortali. Milano Cortina 2014.
66
R. Collins, M. Makowsky, The Discovery of Society 1972. Random House Inc
New York, trad. it. Storia delle teorie sociologiche, Bologna Zanichelli, 1980, 225
192 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Anche E. Goffman cita Schutz in forma molto esplicita
W James nel suo famoso saggio The perception of reality del 1890, invece di chiedersi che cos’è la realtà, diede una piega fenomenologica
e sovversiva alla questione, mettendo in corsivo la seguente domanda:
In quali circostanze pensiamo che le cose siano reali? […] Nel 1945
Schutz riprese di nuovo il tema in un saggio intitolato On Multiple
Realities. La sua posizione risultava sorprendentemente vicina a quella
di James, ma maggiore attenzione veniva rivolta alla possibilità di scoprire le condizioni che devono essere soddisfatte per generare un regno
di “realtà”, piuttosto che un altro. 67
Tutta la teoria di Goffman sulla vita quotidiana come rappresentazione teatrale68 sembra risentire in termini abbastanza espliciti dell’elaborazione di Schutz. Si tratta, in certa misura, di un ripensamento
dell’epoché dell’atteggiamento naturale, che esclude il dubbio dalla
percezione della realtà 69.
Le persone si comportano come se il loro mondo avesse un carattere
oggettivo e agiscono come se il loro ordine sociale fosse solido e duraturo, anche se di fatto è rabberciato e ambiguo…in sostanza le strutture
sociali esistono perché la gente è convinta che esistano. 70
Questa attenzione alla dimensione rituale del comportamento sociale chiaramente è riferibile a Durkheim, ma i sociologi citano anche
Schutz, ritenendo la sua ricerca strettamente pertinente al loro tema.
Questo vale anche per R. Collins e per la sua teoria della stratificazione, che dichiara origini ben definite:
…L’ondata più spettacolare è giunta con la filosofia fenomenologica,
che sorse in Germania fra il 1900 e il 1930…la figura centrale è Husserl,
il cui sforzo di eliminare l‘inconoscibile “cosa in sé” kantiana lo con E. Goffman, Frame Analysis, Cambridge Mass Harvard University Press 1974,
trad. it. L’organizzazione dell’esperienza Roma, Armando 2001, 48-49.
68
E. Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life Garden City, New York
Doubleday (1959), trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, il
Mulino 1969.
69
A. Schutz, Le realtà multiple cit. 148
70
R. Collins, M. Makovsky, Storia delle teorie sociologiche cit, 233-234
67
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 193
dusse a limitare la filosofia a un’analisi dettagliata dei contenuti della
coscienza…In sociologia la figura chiave è A. Schutz, il quale applicò la prospettiva fenomenologica a un problema sollevato dal concetto
di Verstehen di Weber…per cui scopo della sociologia è analizzare i
comportamenti dotati di senso… Schutz si assunse il compito di descrivere esattamente come appare il mondo sociale all’attore, che momento per momento agisce nella vita quotidiana. La prospettiva di Schutz
non è molto diversa da quella di Heidegger e di Sartre, anche se da
questa si differenzia per la mancanza di qualunque considerazione dei
sentimenti.71
Conclusione
Schutz si propone di ricavare dalla fenomenologia alcuni assiomi
che gli permettano di fondare un metodo di ricerca, eliminandone
gli aspetti più “metafisici”. Già Husserl nella Crisi aveva accusato
il pensiero kantiano di essere una “mitologia”, a causa della rigidità
delle forme a priori e delle categorie72. Schutz, a sua volta, è critico
nei confronti di certi aspetti della filosofia husserliana, che gli sembra
cadano in certa misura nello stesso errore. Come scrive Thierry Blin:
Schutz met néanmoins délibérément de côté les problèmes de subjectivité et d’intersubjectivité trascendentales et se situe en dehors de
cette «psychologie phénoménologique», qui, selon Husserl, est en dernière analyse une psychologie de l’intersubjectivité pure et rien d’autre
qu’une «phénoménologie constitutive du point de vue naturel». On ne
peut que le féliciter de nous épargner ainsi les nébulosités d’une philosophie en quête d’une improbable «fondation ultime» d’une prima
philosophia, ou de notions comme celle d’ «intuition des essences.» En
R. Collins, Conflict Sociology – Toward an explanatory science Academic Press
Inc, New York 1975, trad. it. Sociologia, Bologna, Zanichelli 1980, 105-106.
72
E. Husserl, Die Krisis der europȁischen Wissenchaften und die transzendentale Phȁnomenologie. L’Aia, 1959 M. Nijoff’s Boekhandel en Uitgevermaatschappij,
trad. it. La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Milano, il
Saggiatore 1961, par 30 La ragione delle costruzioni mitiche di Kant, 143.
71
194 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
un sens Schutz nous rend le service incomparable de «séculariser la
phénoménologie».73
In effetti, come abbiamo visto, il Nostro ci presenta anzitutto i
fatti sociali come fondati non sul paradigma galileiano, legato alla
causa efficiente, ma sulla costruzione di senso. All’interno di questo
modello egli oscilla fra il presentarci i processi comunicativi in due
modi diversi. Da una parte troviamo una prospettiva di chiusura totale, in cui ogni soggetto tende a dimostrare la coerenza solipsistica di
Don Chisciotte.
D’altro canto invece abbiamo un paradigma più duttile, relativo
alle relazioni faccia a faccia, caratterizzate da un complicato meccanismo di richiami e anticipazioni74, che induce a guardare al proprio
interlocutore come a “una realtà indivisa in un vivido presente […]
nella forma del Noi”75. Anche qui, tuttavia, abbiamo una chiusura: un
singolo gruppo può risultare molto compatto e coerente al suo interno, pur mantenendosi in forma donchisciottesca al di fuori della realtà
complessiva. Questo appunto costituisce la “stratificazione” sociale,
che la microsociologia può mettere in luce con molta chiarezza, ma
in parte era già stata presa in esame nel saggio sullo straniero che
abbiamo preso in esame.
In questo ambito le scienze umane, che hanno messo fra parentesi
il modello galileiano, per forza di cose si trovano ad avvicinarsi a un
paradigma legato alla narratività e allo spettacolo, ma in una forma
che non ha niente a che vedere con lo svago. Abbiamo invece una
“descrizione densa”76 a volte con risvolti drammatici, dove le variabili
della messa in scena diventano uno strumento per capire, “riempiendo le lacune” del linguaggio positivo.
Qui torniamo alla realtà, definita come un “insieme solidale di
apparenze fra loro coerenti”77. Schutz ci parla di “esperienze strane”
capaci di reinventarla, passando dallo spettacolo propriamente detto
allo scenario multiplo della vita e alla rappresentazione come categoria essenziale del quotidiano. Qui il ruolo di attore e di spettatore
T. Blin, Introduction à: A. Schutz Essais sur le monde ordinaire, Paris, Le Félin
Poche, 2010, 15.
74
A. Schutz, Le realtà multiple cit, 138.
75
Ivi, 140.
76
C. Geertz, Interpretazione di culture, cit, 27.
77
W. James, La percezione della realtà, cit 148.
73
Gianni Trimarchi - La logica del pensiero quotidiano 195
continuano a ribaltarsi l’uno nell’altro, convergendo nel mettere in
atto caleidoscopiche costruzioni di senso.
Come abbiamo visto, la sua impostazione, rigorosamente teorica,
ha avuto esiti considerevoli anche sul piano empirico.
Bibliografia
Allovio S. Riti di iniziazione. Antropologi, stoici e finti immortali, Milano
Cortina 2014
Borutti S. Teoria e interpretazione. Per un’epistemologia delle scienze umane. Milano, Guerini e associati 1991
Borutti, S. Filosofia delle scienze umane. Le categorie dell’antropologia e
della sociologia. Milano B. Mondadori 1999
Brivio A. Il vodu in Africa. Metamorfosi di un culto. Roma, Viella 2012
Collins R., Makowsky M. The Discovery of Society 1972. Random House Inc
New York, trad. it. Storia delle teorie sociologiche, Bologna, Zanichelli,
1980
Collins, R. Conflict Sociology – Toward an Explanatory Science Academic
Press Inc, New York 1975, trad. it. Sociologia, Bologna Zanichelli 1980
Damari, C. La percezione della realtà In Schutz e in Goffman, Pisa University
Press 2008
Fabietti U. Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione. Bari,
Laterza 2004
Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York Basic Books 1973, trad.
it. Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino. 1987
Goffman E. The Presentation of Self in Every Life, Garden City New York
Doubleday 1959 trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione,
Bologna il Mulino 1969
Goffman E. Frame Analysis. The Organisation of Experience, 1974, trad. it.
L’organizzazione dell’esperienza, Roma Armando 2001.
Husserl E. Die Krisis der europȁischen Wissenchaften und die transzendentale Phȁnomenologie M. Nijoff’s Boekhandel en Uitgevermaatschappij,
L’Aia 1959, trad. it. La crisi delle scienze europee e la fenomenologia
trascendentale. Milano, il Saggiatore 1961.
James W., Schutz A. Le realtà multiple e altri scritti, Introduzione e cura di
I. Possenti, postfazione di A. Iacono, Pisa ETS 2005. Contiene la traduzione italiana di
196 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
W. James The perception of Reality (1890) MacMillan and Co, Ldt,
London 1901, vol 2, cap XXI 283-322.
W. James The Stream of Consciousness (1892) in Psychology, Briefer
course 1892, Harvard University Press, Cambridge Mass. and
London, 1984, cap 11 139-158.
A. Schutz On Multiple Realities, 1945, in Collected Papers vol 1 a cura
di M. Natanson, L’Aia, Nijoff The Ague 1962, 207-259.
Malighetti R. Clifford Geertz. Il lavoro dell’antropologo Torino, UTET,
2008.
Remotti F. Introduzione a Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino
1987, 9-33.
Sacchetti F: A. Schutz e P. Ricoeur, percorsi della soggettività fra filosofia e
ermeneutica, Roma, Bonanno, 2012.
Scaramuzza G. Crisi come rinnovamento, scritti sull’estetica della scuola di
Milano, Milano, Unicopli, 2000.
Schutz A. Don Quixote and the Problem of Reality 1995 in A. Schutz
Collected Papers, vol 2 ed Martinus Nijoff, L’Aia, 1971, 135-138, trad.
it. Don Chisciotte e il problema della realtà, a cura di P. Jedlowski,
Roma, Armando 2008.
Schutz A. Essays sur le monde ordinaire, Paris, Le Félin Poche, 2010.
Introduction et traduction par Thierry Blin.
Schutz A. Fragments of the Phenomenology of Music (1944-1956). In Search
of Musical Metod. New York 1976, trad. it. Frammenti di fenomenologia della musica, a cura di N. Pedone, Milano, Guerini e associati 1996.
Schutz A. Reflections on the problem of Relevance, trad. it. a cura di G.
Riconda, Torino, Rosenberg e Sellier, 1975.
Schutz A Saggi sociologici, a cura di Alberto Izzo, Torino, UTET, 1979.
Schutz A. Der Sinnhafte der sozialen Welt,1932 Wien, Springer-Verlag 1960,
trad. it. La fenomenologia del mondo sociale, Bologna, il Mulino,1975.
Schutz A. The Stranger, An Essay on Psycology in American Journal of
Sociology n 49, 499-507 1944, trad. francese L’étranger ed Allia 2010.
Tellier F. Alfred Schutz et le projet d’une sociologie phenomenologique.
Presses Universitaires de France 2003.
La prova del filosofo: domandare
in maniera iniziale nell’epoca
della finale determinazione tecnica
Vittoria Sisca
Starting from the general question “What is philosophy?”, and trying to answer it by developing a thoughtful dialogue with Martin
Heidegger, this article proposes to reflect upon our original philosophical “gestures” and practice them. This may prove to be useful
in order to understand what are the real matters at issue for contemporary philosophers in the time of the widespread diffusion in the
whole world of the Western civilization determined by technology.
Introduzione
Com’è noto, Heidegger definisce il nostro tempo come l’epoca della
fine della filosofia. A proposito di questo evento epocale due cose vanno tenute ben salde: in primo luogo, “fine della filosofia” è sinonimo
di Weltzivilisation, ossia è da accostare all’«inizio della civilizzazione
del mondo fondata sul pensiero dell’occidente europeo»1; in secondo luogo, “fine”, non denota qui, come siamo abituati a pensare, il
mero esaurimento di qualcosa o il raggiungimento della sua massima
compiutezza. L’epoca della fine (Ende) è per Heidegger l’epoca del
compimento (Vollendung) dell’inizio del pensiero occidentale, ossia è
Martin Heidegger: Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens,
in Zur Sache des Denkens, Tübingen: Max Niemeyer, 1969, tr. it. di Eugenio
Mazzarella, Napoli: Guida, 1991, La fine della filosofia e il compito del pensiero, in
Tempo ed essere, 173.
1
198 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
quel luogo (Ort) in cui l’intera storia di ciò che chiamiamo filosofia si
raccoglie nella sua estrema e ultima possibilità.
Se la fine della filosofia, come conclusivo ri-accadere del suo
inizio, riguarda l’epoca presente, e se la questione filosofica, intesa
qui come elemento permanente dello storico dispensarsi del pensiero esperide, è non da ultimo qualcosa che riguarda profondamente,
fino a connotarlo, il nostro esserci storico, allora interrogare la nostra
identità significherà volgere il nostro sguardo a monte. Se, in altri
termini, l’inizio è qualcosa che permane pur nel suo continuo metamorfosarsi storico, allora rispondere alla domanda “chi siamo noi?”,
in vista di una rideclinazione del nostro modo di abitare all’interno di
una certa tradizione, significherà altresì tentare di porgere l’orecchio
ai nostri fondamenti teorici, ovvero chiedersi manifestamente “che
cos’è filosofia?”.
Non è qui mia intenzione recludere all’interno di un’asserzione
– ammesso che questo in generale sia possibile, naturalmente – ciò a
partire da cui diciamo “noi stessi in quanto abitatori di una certa epoca” o usiamo espressioni come “filosofia greco-europea-occidentale”.
Piuttosto, il mio tentativo sarà quello di praticare un esercizio di autoriflessione; ovvero di provare a riflettere, attraverso il semplice domandare, la nostra immagine nei tratti che assume ciò che Heidegger
aspira a delineare quando utilizza la parola “filosofia”.
1. Domandare storicamente
Nella prima parte dello scritto intitolato La fine della filosofia e il
compito del pensiero, Heidegger traccia piuttosto sinteticamente la
fisionomia dell’interrogato:
Filosofia vuol dire metafisica. […] La metafisica pensa l’essente come
essente sul modo della rappresentazione in quanto fondazione. Giacché
l’essere dell’essente dall’inizio della filosofia, e con questo stesso inizio
si è manifestato come il fondamento (Grund)2.
All’interno di tali considerazioni è possibile notare almeno due
importanti indicazioni: in primo luogo, Heidegger ravvisa la presen2
Ivi, 170-171.
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 199
za di un rapporto sinonimico tra le parole “filosofia” e “metafisica”
(«Filosofia vuol dire metafisica»); in secondo luogo, egli rileva come
la filosofia, proprio in quanto metafisica, abbia una cosa, un contenuto da pensare («la metafisica pensa l’essente in quanto essente»).
A dispetto forse delle apparenze, non vi è nulla di scontato in una
constatazione del genere, alcuna traccia d’ovvio. Un sospetto simile
scomparirebbe immediatamente, tanto per fare un esempio, qualora
si badasse al fatto che, volendo realmente farsi carico della succitata
posizione, bisognerebbe allora allontanarsi radicalmente da una posizione come quella di Kant, il quale, com’è noto, nella Critica della
ragion pura interpreta la metafisica come una «disposizione naturale»3 dell’uomo. Qualora si volesse trasporre la definizione kantiana di
metafisica in una prospettiva più vicina a quella di Heidegger, infatti,
si potrebbe certamente mantenere il termine “disposizione”, ma solo
a condizione di dover intendere la filosofia come un disporsi a qualcosa, verso qualcosa e, soprattutto, di doversi riferire sempre e necessariamente, con questo “qualcosa”, all’essente in quanto essente.
Una più generosa argomentazione è riscontrabile nel breve scritto
del 1955 dal titolo Che cos’è la filosofia?. Al suo interno, Heidegger
delinea in questi termini la tipologia di tale interrogativo: la domanda su che cos’è filosofia è «una domanda storica in cui è in gioco il
nostro destino»4. Per indicare l’aggettivo “storico” è qui utilizzata la
parola tedesca geschichtlich, diversa dal termine historisch, impiegato invece per designare l’aggettivo “storiografico”. All’interno dello stesso capoverso, infatti, è possibile leggere una frase come «Die
Frage ist auch keine historische Frage»5: letteralmente, «la domanda
non è neanche una domanda storiografica». Tale distinzione è particolarmente pregnante perché apre uno spazio di pensiero, obbliga cioè
a non far scadere ciò che presenta una connotazione autenticamente
storica a mero affaire storiografico.
L’esigenza di preservare l’ambito della storia autentica (die
Geschichte) da quello della storiografia (die Historie) è concepibile
alla luce del fatto che, a giudizio di Heidegger, la seconda altro non
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (17811; 17872), Riga: Hartknock, tr.
it. di Pietro Chiodi, Novara: UTET, 2013, Critica della ragion pura, 87-88.
4
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, Pfüllingen: Neske, 1956, tr.
it. di Carlo Angelino, Genova: Il melangolo, 1971, Che cos’è filosofia?, 19.
5
Ivi, 18.
3
200 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
è se non «una costante elusione»6 della prima. Badiamo: con ciò non
s’intende affermare che fra storia e storiografia sussista il rapporto
antitetico che intercorre fra due opposti. L’attuazione di una qualsiasi
comparazione tra queste due dimensioni è tanto poco possibile quanto
il tentativo di chi volesse cimentarsi nel confronto obiettivo di una
medesima Sonata eseguita, rispettivamente, da un pianoforte e da un
violino, due strumenti musicali appartenenti a famiglie differenti.
Storia e storiografia sono incomparabili. Lo sono, nella misura in
cui trovano origine in una dimensione vicendevolmente altra. Ma da
cosa, precisamente, è determinata tale radicale alterità? O altrimenti:
dove sta l’effettivo fattore discriminante in forza del quale ogni raffronto possibile è reso vano? Dalla maniera in cui Heidegger, ancora
in un altro luogo, afferma che il «fatto che ci si interroghi sulla determinazione della “cosa” del pensiero, e il modo in cui lo si fa, decidono […] del destino del pensiero»7, si può intuire come tale scarto sia
riconducibile proprio al modo in cui esse, cioè storia e storiografia,
determinano la loro cosa: il tempo.
La storiografia o Historie è catalogabile all’interno delle cosiddette “scienze dello spirito”. Il suo esser scienza fa sì che essa pretenda da sé, necessariamente, un ampio margine di rigore metodico.
Il carattere categorico di tale pretesa balza ancor di più agli occhi se
si pensa al fatto che, come tutte le scienze dello spirito, la disciplina
storiografica manca dell’esattezza, «la procedura stessa che calcola e
misura»8, appartenente invece a quelle che siamo abituati a chiamare
“scienze esatte”. Al fine di sopperire alla mancanza costitutiva della
propria materia di riferimento, l’Historiker è tenuto a fornire una certa stabilità all’oggetto dei suoi studi. Per l’uomo della scienza storica
il passato assume l’aspetto di una presenza avente una consistenza
superiore. Esso è già accaduto e, in ragione di ciò, presenta maggiore
sostanzialità rispetto a ciò che non è ancora e dunque passa, transita,
fluisce, in attesa di trasformarsi a sua volta, a debita distanza, nell’oggetto di una scienza possibile. I fenomeni storici sono definibili in
Martin Heidegger: Beiträge Zur Philosophie (Vom Ereignis), Frankfurt am
Main: Klostermann, 1989, tr. it. di Franco Volpi, Milano: Adelphi, 2007, Contributi
alla filosofia (dall’evento), 167.
7
Martin Heidegger: Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens,
St. Gallen: Erker-Verlag, 1984, tr. it. di Adriano Fabris, Pisa: ETS, 1988, Filosofia e
cibernetica, 30.
8
Martin Heidegger: Beiträge Zur Philosophie (Vom Ereignis), tr. it. cit., 164.
6
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 201
virtù del loro esser definiti, ordinabili in termini di successione in
virtù del loro succedersi. Se questi ci riguardano, in ultima analisi, è
perché sono conclusi: stanno alle nostre spalle.
Rispetto al moderno operare storiografico, il pensare storico comporta che si faccia esperienza del tempo in una maniera altra e più
densa. Per un pensatore della storia, quale Heidegger stesso è, il tempo «non è più la successione di un’“ora” ad un altro che sprofonda
nel passato mentre un terzo, che precedentemente doveva arrivare, diviene ora presente e così di seguito», ma «è piuttosto la contemporaneità del presente del passato e dell’avvenire»9. Pensare storicamente
significa depresentificare il presente e cioè concepirlo come l’ambito
della messa in opera, del porre in essere, di ciò che è stato tramandato
in vista di un’apertura progettuale futura10. In quest’ottica passato,
presente e futuro non si susseguono, non fluiscono, ma sono contemporanei. Non esiste un rapporto neutro col passato, in base al quale
esso possa venire ipostatizzato, trasformato in una “cosa” che, a quel
punto, sta a disposizione dello sguardo oggettivante dello storico. Ciò
che è già-stato, dal punto di vista del pensare storico, non sta alle
spalle, ma si proietta in avanti: si determina a partire dal nostro futuro,
in un ambito di decisione presente che ci coinvolge in prima persona.
Una volta chiarito ciò, è possibile guardare alla domanda “che
cos’è filosofia?” in maniera differente, entrare cioè nel cuore dell’esperienza stessa del domandare storico, il cui tratto più proprio rimane quello di non consentire all’oggetto che s’intende interrogare di
lasciarci indisturbati. Conformemente a ciò, com’è evidente, il fine
della domanda “che cos’è filosofia” non è quello di parlare sulla filosofia e al di fuori di essa ma, utilizzando le parole di Heidegger,
«di penetrare nella filosofia, di prendervi dimora e di comportarci nel
modo che le è proprio, vale a dire di filosofare»11.
Jean Beaufret e Frederic De Towarnicki: Entretiens avec Frédéric de Towarnicki,
Paris: Presses Universitaires de France, 1984, tr. it. di Stefano Esengrini, Milano:
Christian Marinotti Edizioni, 2008, In cammino con Heidegger, 74.
10
Sul punto cfr. Martin Heidegger: Logik als die Frage nach dem Wesen der
Sprache, Frankfurt am Main: Klostermann, 1998, tr. it. di Ugo Ugazio, Milano:
Christian Marinotti Edizioni, 2008, Logica e linguaggio, §24.
11
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 9.
9
202 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
2. Rispondere filosoficamente
Prima, però, di affrontare in maniera diretta la domanda su che cos’è
filosofia e tentare di rispondervi sarà necessario introdurre ancora
qualche altra indicazione metodologica. In primo luogo, quando s’intraprende un’interrogazione del genere, è auspicabile che si renda evidente anche il carattere che dovrà presentare una possibile risposta.
In base al percorso che è stato attuato finora è possibile affermare
che: a) chiedersi che cos’è filosofia equivale a porre una domanda
storica; b) la connotazione storica della domanda implica l’entrata
del domandante in una dimensione di presa in carico del domandato,
in vista di una risposta futura; c) il domandare storico esige che l’interrogante prenda dimora all’interno dell’interrogato stesso, che vi
corrisponda.
Focalizzando l’attenzione su quest’ultimo punto, un’intuizione
sovviene in maniera quasi immediata: la risposta a una domanda che
si configura come un tentativo di corrispondere al domandato non
potrà che assumere l’aspetto di una corrispondenza. Una tale ipotesi
può certamente costituire un valido slancio affinché la presente indagine si muova in una qualche direzione, nulla di più. Se l’intenzione
è di incamminarsi pazientemente sulla giusta via e non di cominciare
accidentalmente, affidandosi a una mera convinzione, essa tuttavia
non può e non deve accontentarci. Sarà necessario verificarla, vedere
quantomeno se sia possibile giungervi anche attraverso un altro punto
d’accesso.
Torniamo adesso alla prolusione del ’55. Qui Heidegger scrive
che una risposta legittima alla domanda su che cos’è filosofia «può
essere soltanto una risposta che filosofa», una risposta «che, in quanto
parola-che-fronteggia (la domanda), filosofa in sé»12. Nella sua versione originale, questa stessa frase suona: «Die Antwort kann nur eine
philosophierende Antwort sein, eine Antwort, die als Ant-wort in sich
philosophiert»13. La risposta (die Antwort) è dunque anche un’Antwort. La genuina Ant-wort, posto che ant-, seguendo le indicazioni di
Gino Zaccaria, sia sinonimo di entgegen, ossia di “incontro”, è una
dizione, un dire, che viene o va incontro ad un’altra dizione; «una parola capace d’ascolto e di rispetto, una parola che, facendosi carico di
Ivi, 33.
Ivi, 32.
12
13
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 203
ciò che l’altra chiede e pretende, le risponde in quanto ne risponde»14,
una corrispondenza.
Una volta chiarito l’aspetto che dovrà presentare la risposta alla
domanda su che cos’è filosofia, è necessario affrontare un’ultima questione metodologica: quella concernente il “come”, cioè il modo in
cui si dovrebbe procedere in questo cammino di pensiero. Posto che
sia possibile corrispondere alla filosofia solo filosofando, rimane da
chiedersi: come si filosofa? La sola esplicitazione di questa domanda
è sufficiente a far emergere quella che potremmo definire una sua impossibilità costitutiva, quantomeno rispetto alla connotazione storica
di tale indagine. Essa non può restringere il nostro campo d’azione, almeno non di molto rispetto all’interrogativo-guida del nostro
discorso, imperniato sul “che cosa”. I piani del “che cosa” (was) e
del “come” (wie), pur conservando una parvenza di diversità, conducono al medesimo punto d’arrivo: quello in cui l’uno rimanda
all’altro, costantemente, in un rapporto di circolarità viziosa più che
virtuosa. Il carattere impersonale del “che cosa s’intende per…” o
del “come si…”, smarrisce, non da ultimo, il carattere personale, disturbante, storico, che dovrebbe caratterizzare questa interrogazione.
Conformemente ad esso, la domanda dovrebbe essere semmai posta
in questi termini: stiamo filosofando?
Stiamo dialogando con Heidegger e, in particolare, con uno
dei suoi scritti. Tale dialogo, almeno finora, non ha assunto la forma del mero discorrere a vuoto. Abbiamo dialogato di qualcosa,
ossia seguendo una direttiva. Alla domanda: “quando filosofiamo?”
Heidegger risponde: «dal momento in cui dialoghiamo coi filosofi.
Questo implica che discutiamo gli uni con gli altri intorno a ciò che
sempre e di nuovo, in quanto è il Medesimo, riguarda propriamente i
filosofi»15. Rispondere filosoficamente alla domanda su che cos’è filosofia significherà allora dialogare con i filosofi, ossia corrispondere
a quel medesimo che, per Heidegger, da sempre essi hanno pensato.
Gino Zaccaria: L’inizio greco del pensiero. Heidegger e l’essenza futura della
filosofia, Milano: Christian Marinotti Edizioni, 1999, 425.
15
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 33.
14
204 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
3. φιλοσοφία
Corrispondere in parola, dialogare, parlare di qualcosa, sono attività
pressoché equivalenti. Diciamo “attività” perché ognuna di esse comporta l’esplicazione attiva di una capacità, la quale nello specifico
rimanda all’uso del linguaggio. Come abbiamo visto, per dialogare
occorre saper discorrere e ciò significa che bisogna sempre discorrere di qualcosa, in modo tale che il discorso, lungi dall’assumere
le sembianze di una sorta di monologo intersoggettivo, divenga una
corrispondenza. C’è però un’altra dimensione propria del discorrere
che fin qui non è ancora emersa.
Nel §34 di Essere e tempo, la parte dell’opera che Heidegger dedica esplicitamente al discorso (Rede), inteso come esistenziale fondamentale accanto al comprendere (Verstehen) e alla situazione emotiva
(Befindlichkeit), leggiamo: «Il sentire è costitutivo del discorrere»16. E
ancora: «Il sentire costituisce addirittura l’apertura primaria e autentica dell’Esserci al suo poter-essere più proprio, come l’ascolto della
voce dell’amico che ogni Esserci porta con sé»17. Coerentemente a
quanto dice Heidegger, il sentire e l’ascoltare sono costitutivi del discorso tanto quanto il parlare, se non in maniera ancor più decisiva.
La parola “dialogo”, come si sa, ha a che fare col discorso. Essa deriva da διάλογος che, se decidiamo di tradurre proprio con “discorso” il
termine λογος, di per sé polisemico, significa letteralmente “attraverso il discorso”. Il dialogo, dunque, proprio in forza di ciò che attraversa, è a suo modo uno stare a sentire.
L’intento qui è di dialogare con i filosofi, di filosofare. A tal fine,
si dovrà quindi discorrere di qualcosa, saper discorrere, ma anche saper sentire. Sarà dunque indispensabile cercare di porgere l’orecchio
a ciò che fino ad ora, senza troppa prudenza, è stato soltanto pronunciato. Così scrive Heidegger:
se […] ascoltiamo la parola “filosofia” a partire dalla sua origine, allora
essa suona φιλοσοφία. A questo punto la parola “filosofia” parla greco.
La parola greca, in quanto greca, è un cammino. Questo cammino, per
Martin Heidegger: Sein und Zeit (1927), Tübingen: Max Niemeyer Verlag,
2001, nuova ed. it. a cura di Franco Volpi sulla versione di Pietro Chiodi, Milano:
Longanesi, 2005, Essere e tempo, 201.
17
Ivi.
16
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 205
un verso, ci sta di fronte poiché la parola da lungo tempo si è rivolta a
noi precedendoci; ma si trova, per un altro verso, già alle nostre spalle
poiché da sempre abbiamo associato e pronunciato tale parola. La parola
greca φιλοσοφία è perciò un cammino su cui camminiamo18.
La parola φιλοσοφία è un cammino. Alla luce di quanto è stato
già detto in precedenza, l’ubiquità di questo cammino – che «ci sta
di fronte», è «già alle nostre spalle» ed è «perciò un cammino su cui
camminiamo» – non dovrebbe creare particolari preoccupazioni. È
semplice da accettare perché è altrettanto facile da comprendere: sto
scrivendo la parola “filosofia”, il lettore del presente contributo leggerà “filosofia” e avrà quindi modo di maneggiare la stessa parola alla
quale Heidegger, durante una conferenza tenuta nel 1955 a Cerisy,
dedicò uno scritto, una parola che, circa duemilatrecento anni fa,
Aristotele scriveva in greco. Non solo, dunque, la «parola φιλοσοφία
ci dice che la filosofia è anzitutto qualcosa che determina l’esistenza
del mondo greco. […] La φιλοσοφία determina anche l’intimo fondamento della nostra storia»19.
Concentriamoci per un momento sull’origine greca della parola in questione. Il termine φιλοσοφία deriva da un aggettivo:
φιλόσοφος. La parola, dice Heidegger, «venne presumibilmente coniata da Eraclito. Il che significa che, per Eraclito, non vi è ancora φιλοσοφία»20. È chiaro: solitario e diffidente come sovente viene
rappresentato, Eraclito non poteva di certo immaginare che proprio
a partire dal suo pensiero potesse essere tramandata una parola così
longeva. Egli non pensava certo di fare filosofia, almeno non nel senso che questa espressione ha assunto a partire da Platone e che è diventato decisivo per noi. Il pensiero di Eraclito sta sulla soglia: il suo
pensare, che produce l’aggettivo da cui la parola φιλοσοφία deriva, è
necessariamente pre-filosofico e proviene da una tradizione che non
è quella della filosofia. Egli senza dubbio “pensava”, ma non stava
nella tradizione della filosofia, anche se il suo pensiero giunge sino a
noi per tramite della sua storia21.
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 13.
Ivi.
20
Ivi, 23.
21
Sul punto cfr. Carlo Sini: La tradizione del pensiero, in “Archivio Carlo Sini”
(http://www.archiviocarlosini.it/materiale/manoscritti/M030.pdf).
18
19
206 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
4. Eralito e il pensiero della piega
Φιλόσοφος è parola emblematica. Heidegger sostiene che essa dica
qualcosa di fondamentalmente diverso dall’aggettivo “filosofico”.
Ciò che sottende la parola φιλεῖν, amare, nel senso di Eraclito, non è
il carattere struggente e sempre vivo di una passione rivolta a un oggetto mai del tutto raggiungibile, afferrabile. Amare significa «parlare
così come parla il Λόγος, corrispondere al Λόγος»22.
C’è una perfetta ἁρμονία fra l’uomo filosofico e il Λόγος quando
risuonano insieme. La parola parla, e si lascia ascoltare dall’uomo
che è capace di udire. Quest’ultimo la ascolta e, corrispondendole, la
dice, poiché è essa stessa a lasciarsi dire. C’è un rinvio continuo da
orecchio a bocca, un parlare e un lasciarsi parlare, un ascoltare e un
lasciare che qualcosa venga ascoltato. È questo l’autentico dialogo
di cui parlavamo in precedenza, consiste in ciò la genuina Antwort:
nel dire che va incontro a un’altra dizione, nell’ascolto che risponde corrispondendo. Ma cosa dice, esattamente, il logos? Frammento
50: «In ascolto, non di me, ma del logos, è sapiente convenire che
tutto-è-Uno»23. Consideriamo, prima di conferire a queste parole un
qualsivoglia significato, un aspetto più immediato. Focalizziamo la
nostra attenzione non sul loro contenuto, ma sulla forma, sul modo in
cui esse fluiscono.
Riflettere sulla straordinaria dimensione retorica dei frammenti
di Eraclito – dedicarsi quindi, momentaneamente, a quella che si potrebbe forse impropriamente definire la cifra estetica del suo pensiero
– non significa soltanto inoltrarsi in un esercizio volto a metterci a
riparo dall’inappagabile e pressoché costante propensione al conferimento di senso che ci caratterizza in quanto uomini. Si tratta di un’operazione rilevante per la nostra ricerca ed è auspicabile che ci aiuti a
ricavare qualche altra pregnante indicazione in merito al rapporto che
intercorre fra l’uomo filosofico e il logos.
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 23.
Pierre Jacerme: Introduction à la philosophie occidentale. Héraclite, Parménide,
Platon, Descartes, Paris: Pocket, 2008, tr. it. di Stefano Esengrini, Milano:
Christian Marinotti Edizioni, 2010, Introduzione alla filosofia occidentale. Eraclito,
Parmenide, Platone, Cartesio, 53.
22
23
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 207
A questo proposito, Pierre Jacerme osserva che
Eraclito comunemente non costruisce le sue frasi in modo sintattico,
ma in modo paratattico, ponendo le parole le une accanto alle altre,
così come si dispongono delle pennellate in pittura, in modo che non si
può veramente tradurre come si è soliti fare. Si è dunque costretti a non
padroneggiare il senso. Si è obbligati a lasciarsi dire qualcosa dal testo;
ciò significa che il movimento è inverso24.
Alla luce di quest’attenta valutazione, se guardiamo alla forma
del «tutto-è-Uno» del frammento 50 è possibile affermare che ciò che
caratterizza l’uomo filosofico nel suo rapportarsi al logos è che, nel
prestargli ascolto, nel corrispondergli, tenta il massimo congiungimento. Il piano del tutto e quello dell’Uno devono compenetrarsi,
coordinarsi, stare accanto quasi fino a connettersi. Non v’è sintassi, regola grammaticale o forma logica che possa impedire una tale
congiunzione.
La logica, com’è noto, si configura come una messa a fuoco filosofica ed è costitutiva rispetto allo spirito filosofico stesso25. Con
Eraclito non siamo ancora a questo punto. Il pensiero del sapiente
efesino, situandosi in una dimensione anteriore rispetto alla filosofia,
è effettivamente anche pre-logico. Il suo lavoro consiste in questo:
nel non disgiungere ciò che di per sé è congiunto, nel non isolare
la monotona chiarezza di un assolo da un tutto armonico orchestrale. Possiamo dire, utilizzando la trascrizione dell’Εν Πάντα eracliteo
formulata da Heidegger, che «Uno (è) Tutto»26, dove quel “è” designa
proprio ciò che unisce, che congiunge, la raccolta – il logos.
Solo adesso, una volta delineata la fisionomia del φιλόσοφος
come colui il quale, congiungendo, corrisponde al Λόγος, siamo legittimati a operare logicamente, ossia disgiungere in parti, ad analizzare il frammento 50 per comprenderne il significato, ad esibirlo, a
porcelo di fronte. Secondo l’analisi di Heidegger,
Ivi.
Sul punto cfr. Martin Heidegger: Logik als die Frage nach dem Wesen der
Sprache, tr. it. cit., 11.
26
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 23.
24
25
208 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
“Tutto” significa qui, Πάντα τὰ ὄντα, l’intero, il tutto dell’essente. “Εν”,
l’Uno, vuol dire: ciò che è uno, l’unico, ciò che tutto unisce. Ma unito è
ogni essente nell’Essere. Il σοφóν dice: ogni essente è nell’Essere. Detto
in modo ancor più pregnante: l’Essere è l’essente27.
Ci sono due piani: il piano visibile, del tutto dell’essente, e quello
dell’Uno, di ciò che tutto unisce e che non essendo, almeno non alla
maniera dell’essente, è di per sé inappariscente. Il sapiente, dicendo
che “ogni essente è nell’Essere”, pensa questi due piani come massimamente congiunti. Il suo sforzo è paragonabile a quello di Cézanne
quando dipinge la montagna Sainte-Victoire cercando di lasciar apparire non soltanto la montagna presente, che è qui, ma anche il piano
invisibile che regge la visione28. Abbiamo la piega dell’essere e quella
dell’ente insieme: è la piega dell’ente-in-essere, nel gioco che li congiunge raccogliendoli.
5. Filo-sofia: il ripiego metafisico
Il richiamo alla piega dell’ente-in-essere fa capo a una bellissima metafora utilizzata da Jean Beaufret. Egli invita a pensare il passaggio
dalla dimensione pre-filosofica, in cui abita il pensiero di Eraclito,
alla filosofia propriamente detta, come al volo di una farfalla posata
su un fiore. Dapprima questa è disposta in una maniera tale che le ali
sono così ravvicinate da sembrare una sola. Poi s’invola e queste si
distaccano, la piega si dispiega29. La filosofia è precisamente questo
movimento, questo slancio che è soprattutto un distacco.
In Che cos’è filosofia? Heidegger scrive che «Il passo in direzione
della “filosofia”, preparato dalla sofistica, fu compiuto innanzitutto
da Socrate e da Platone»30. Socrate, come si sa, non scrisse nulla.
Gli scritti di Platone sono tuttavia sufficienti a fornire una perfetta
delucidazione in merito all’atto di nascita della filosofia, al suo inizio. Estremamente illuminante, a questo riguardo, è ad esempio ciò
Ivi.
Cfr. P. Jacerme: Introduction à la philosophie occidentale. Héraclite, Parménide,
Platon, Descartes, tr. it. cit., 59.
29
Cfr. Ivi, 64.
30
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 27.
27
28
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 209
che egli scrive nel Teeteto: «È assolutamente proprio di un filosofo,
questo pathos – stupirsi; perché non vi è altra partenza che regga la
filosofia oltre a questa»31. Lo stupore regge la filosofia, e il sorreggere
di questo pathos è di natura storica. Lo è nella misura in cui si tratta
di qualcosa che concerne non solo la filosofia passata, ma anche quella presente e futura. Heidegger, infatti, traducendo il termine ἀρχή,
utilizzato da Platone proprio in riferimento allo stupore, lo caratterizza come ciò che incessantemente domina la filosofia, che la permea
dall’inizio alla fine32.
A proposito dell’esclusiva appartenenza dello stupore alla dimensione filosofica, sarebbe legittimo obiettare che esso possa aver coinvolto anche Parmenide e Eraclito, coloro i quali, in virtù dell’attestarsi su una soglia di pensiero altra e antecedente, Heidegger chiama «i
più grandi pensatori»33. Non c’è motivazione alcuna per pensare che
Eraclito non si sia sinceramente stupito dinanzi al gioco che raccoglie insieme presenza e assenza. Allo stesso modo, Parmenide avrebbe potuto provare una sensazione analoga in relazione al cammino
dell’ἀλήθεια indicato dalla dea, dell’essere, della piena presenza.
Insomma, l’ipotesi che Eraclito e Parmenide dovettero stupirsi, a loro
modo, non è del tutto inammissibile. Quello che è qui da escludere,
semmai, è che per una tale ragione possano essere considerati dei
filosofi.
Essi non compartecipano dello stesso tipo di stupore che attraversa la filosofia. La differenza fra la meraviglia tonica, intonata al
logos, di Eraclito o Parmenide, e lo stupore filosofico, è evidente se
consideriamo che, nel primo caso, ciò a cui si guarda, o meglio a cui
si presta ascolto, è la presenza nella sua più piena manifestazione,
il gioco dell’ente-in-essere attraverso il quale, come abbiamo visto,
visibile e invisibile s’intrecciano. Laddove, nel secondo caso, ciò che
fa problema e che alimenta il domandare stesso, è il manifesto, il
visibile, l’ente.
Il fatto che «l’essente resta raccolto nell’Essere, che nell’apparire
dell’Essere si manifesta l’essente»34, è questo che stupisce il filoso Cfr. Pierre Jacerme: Introduction à la philosophie occidentale. Héraclite,
Parménide, Platon, Descartes, tr. it. cit., 110. La citazione da Platone fa riferimento
a Teeteto, 155d.
32
Cfr. Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 41.
33
Ivi, 25.
34
Ivi.
31
210 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
fo. Si badi: la pro-venienza-fuori dell’ente non avrebbe mai potuto
far problema «se quest’ultimo non fosse stato già sempre compreso
come φύσις, ovvero come ciò che sorge, e che, proprio nel sorgere,
accade»35. Non stiamo dicendo che Socrate e Platone abbiano avviato
il filosofare, per così dire, fuori dal tempo, inventando una pratica di
pensiero che contemporaneamente, grazie al loro gesto, avrebbe dato
avvio anche a qualcosa come una tradizione. Stiamo dicendo semplicemente che, rispetto ai fisici, a Parmenide, a Eraclito, essi, e con
loro l’intera tradizione filosofica che giunge sino a noi, determinano
la “cosa” da pensare, l’ente-in-essere, l’«Uno-è-Tutto», in maniera
totalmente distinta, facendosi carico di un pensum, un compito di
pensiero, radicalmente differente.
Con l’inizio della filosofia, e unicamente con esso, la consonanza
alla φύσις36 diviene tensione μετά τα φυσικά – il tensivo protendere al
di là di ciò che è presente, l’ente, per rintracciare l’autentica sonorità
della presenza, i principi primi e le cause ovvero l’essere dell’ente.
Ecco come Heidegger chiarisce il punto:
Essente nell’Essere: ciò divenne per i Greci la cosa più stupefacente.
Cionondimeno i Greci stessi dovettero salvaguardare e porre a riparo
l’essere stupefacente di ciò che vi è di più stupefacente contro l’offensiva dell’intelletto sofistico che aveva pronta una spiegazione per ogni
cosa, comprensibile a tutti, e la esibiva al mercato. La salvaguardia di
ciò che vi è di più stupefacente – essente nell’Essere – avvenne grazie
a quei pochi che si posero sul cammino che porta a ciò che vi è di più
stupefacente e cioè del σοφóν. Grazie a ciò essi divennero coloro che
aspiravano al σοφóν e che, in virtù di questa loro aspirazione, risvegliavano e tenevano desta negli uomini la nostalgia del σοφóν. Il φιλεῖν τò
σοφóν, quella consonanza con il σοφóν […] divenne […] una tensione
verso il σοφóν. Il σοφóν – essente nell’Essere – viene ora espressamente cercato. Perché il φιλεῖν non è più un’originaria consonanza con il
σοφóν diviene “φιλοσοφία”. La tensione di quest’ultima è determinata
dall’Eros37.
Cfr. Gino Zaccaria: L’inizio greco del pensiero. Heidegger e l’essenza futura
della filosofia, 418.
36
Cfr. Ivi, 416.
37
Martin Heidegger: Was ist das – die Philosophie?, tr. it. cit., 25.
35
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 211
La filosofia, in quanto meta-fisica, è filo-sofia: la disgiunzione e
il distacco della piega, cui si faceva riferimento in precedenza, sono
costitutive rispetto alla sua stessa natura. La tradizione della filosofia
è costituita da una compagine di tentativi storicamente dispensati di
rispondere alla domanda: “che cos’è che fa sì che l’essente sia così e
non altrimenti?” (τι τὸ ὄν)38, di trascendere cioè, sempre nuovamente, dall’essente in direzione dell’essenza. È così che la filosofia si fa
evento: come vibrazione, ovvero come impressione in parola del lento
e interrogante movimento oscillatorio che va dall’essente al suo culmine attraverso uno sguardo di passaggio sull’essere39.
Conclusione
In sede introduttiva, sono stati menzionati due punti utili allo scopo d’iniziare a intendere qualcosa circa la caratterizzazione che
Heidegger fornisce dell’epoca presente. In via del tutto preliminare,
essi suggerivano che “filosofia” è il cammino dell’Occidente, il che
equivale a dire, prestando anche un rapido sguardo alla dilagante (o,
meglio, ormai già dilagata) occidentalizzazione del globo, che è un
cammino globale.
Adesso, al fine di valutare in che misura, nell’accadere presente,
si riflettano ancora i tratti originari di ciò che è stato tracciato nel
corso della nostra interrogazione su che cos’è filosofia, sarà necessario comprendere, in maniera più approfondita, in che senso, secondo Heidegger, la filosofia sia giunta alla propria fine. A tal riguardo, all’interno de La fine della filosofia e il compito del pensiero,
leggiamo:
La filosofia finisce (endet) nell’epoca presente. Essa ha trovato il suo
luogo (Ort) nella scientificità della scienze e nell’agire sociale dell’uoCfr. Ivi, 27.
Sul punto cfr. Jean Beaufret e Frederic De Towarnicki: Entretiens avec Frédéric
de Towarnicki, tr. it. cit., 13: «La filosofia di Platone va dall’essente al suo culmine,
che chiama agathon, sino a qualsiasi cosa di essente, grazie a uno sguardo gettato
di passaggio sull’essere come eidos. Aristotele va dall’essente al suo culmine, akrotaton, sino ai livelli minori dell’essente, e questo sino ad avvicinarsi al non-essente,
grazie a uno sguardo gettato sull’essere come energeia. Stessa cosa per Hegel: grazie
a uno sguardo gettato di passaggio sull’essere come dialettica».
38
39
212 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
mo. Il tratto fondamentale di questa scientificità è ad ogni modo il suo
carattere cibernetico, cioè tecnico. Presumibilmente il bisogno di interrogare la tecnica viene meno nell’esatta misura in cui più decisamente la
tecnica impronta e governa i fenomeni dell’universo e la posizione che
l’uomo vi occupa40.
Nell’epoca presente, la filosofia finisce perché trova il suo luogo
nella scientificità delle scienze. O altrimenti: le scienze costituiscono
l’ultima propaggine della metafisica, ciò che fornisce la risposta più
compiuta alla sua domanda-guida. Non è però attraverso il logos, la
parola pensante, che lo scienziato, come figura della sua pratica, porta
a compimento la direttiva iniziale della filosofia. Il carattere fondamentale delle scienze – quel tratto «cibernetico, cioè tecnico», di cui
parla Heidegger – consiste nel determinare iuxta propria principia
ciò che chiede il filosofo, nell’intimare da sé l’essente ad apparire
come un “mezzo per-”. Lo scienziato non ricerca il fondamento della
presenza, ma procede attraverso l’assoggettamento calcolante di ogni
singola porzione dell’intero; egli non interroga quel che c’è che da
sempre il filosofo ha interrogato, ma vi dilegua la propria potenza
misurante al fine di impiegarlo.
In conclusione, conformemente al modo di procedere delle discipline alle quali tendiamo oggi a conferire un primato conoscitivo, è
possibile affermare che quell’inedito luogo-limite che è l’epoca in cui
abitiamo rifletta sì i connotati principali di ciò che la parola “filosofia”
porta con sé, ma alla maniera dello snaturamento, ossia dello smarrimento del carattere tensivo, nostalgico, interrogativo che le è proprio.
Se è così, allora la vera prova del filosofo, nell’epoca della finale determinazione tecnica dell’essente, non consisterà nel fornire ulteriori
risposte allo scopo di determinare un tipo d’uomo “altro”, ma nel
farsi egli stesso memento della domanda, nel ri-presentare cioè, ripraticandole, quelle che con Heidegger abbiamo immaginato essere le
gestualità originali e originarie di una postura pensante e interrogante:
interrogare storico, responsabile e disturbante (1); risposta filosofante
ovvero dialogica in senso forte, senziente e ascoltante (2 e 3); incessante sforzo di lasciar essere anche ciò di cui non si padroneggia il
senso (4); salvaguardia della ricerca (5).
Martin Heidegger: Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens, tr.
it. cit., 172.
40
Vittoria Sisca - La prova del filosofo 213
Bibliografia
Beaufret, Jean e De Towarnicki, Frederic, Entretiens avec Frédéric de
Towarnicki, Paris: Presses Universitaires de France, 1984, tr. it. di
Stefano Esengrini, In cammino con Heidegger, Milano: Christian
Marinotti Edizioni, 2008.
Heidegger, Martin, Sein und Zeit (1927), Tübingen: Max Niemeyer Verlag,
2001, nuova ed. it. a cura di Franco Volpi sulla versione di Pietro Chiodi,
Essere e Tempo, Milano: Longanesi, 2005.
Heidegger, Martin, Was ist das – die Philosophie?, Pfüllingen: Neske, 1956,
tr. it. di C. Angelino, Che cos’è filosofia?, Genova: Il melangolo, 1971.
Heidegger, Martin, “Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des
Denkens“, in Zur Sache des Denkens, Tübingen: Max Niemeyer, 1969,
tr. it. di Eugenio Mazzarella, “La fine della filosofia e il compito del
pensiero“, in Tempo ed essere, Napoli: Guida editori, 1991.
Heidegger, Martin, Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens,
St. Gallen: Erker-Verlag, 1984, tr. it. di Adriano Fabris, Filosofia e cibernetica, Pisa: ETS, 1988.
Heidegger, Martin, Beiträge Zur Philosophie (Vom Ereignis), Frankfurt am
Main: Klostermann, 1989, tr. it. di Franco Volpi, Contributi alla filosofia
(dall’evento), Milano: Adelphi, 2007.
Heidegger, Martin, Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache,
Frankfurt am Main: Klostermann, 1998, tr. it. di Ugo Ugazio, Logica e
linguaggio, Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2008.
Jacerme, Pierre, Introduction à la philosophie occidentale. Héraclite,
Parménide, Platon, Descartes, Paris: Pocket, 2008, tr. it. di Stefano
Esengrini, Introduzione alla filosofia occidentale. Eraclito, Parmenide,
Platone, Cartesio, Milano: Christian Marinotti Edizioni, 2010.
Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft (17811; 17872), Riga: Hartknock,
tr. it. di Pietro Chiodi, Critica della ragion pura, Novara: UTET, 2013.
Sini, Carlo, La tradizione del pensiero, in “Archivio Carlo Sini”, http://
www.archiviocarlosini.it/materiale/manoscritti/M030.pdf.
Gino Zaccaria, L’inizio greco del pensiero. Heidegger e l’essenza futura della filosofia, Milano: Christian Marinotti Edizioni, 1999.
La figura del terrorista
nello spazio globale contemporaneo
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo
This article moves from the perceived need of a new critical approach
to the present Terrorism’s issue, which should go beyond the current
common interpretation offered by the current political and mediatic
debates. As we don’t accept to reduce the problem only to an economic and/or religious matter, we propose a different point of view,
trying to highlight some of the criticalities and contradictions of the
Western society and contemporary democracies. Therefore, the article builds on the Derrida’s proposal of a critical reinterpretation
of Carl Schmitt’s Theorie des Partisanen, suggested by the French
author during an interview in 2001, three weeks after the September
11 attacks. Moving from the problematic definition of Terrorism, the
authors try to show its arbitrary and political use. Analyzing the affinity of the contemporary terrorist to the partisan and revolutionary
figures, as Schmitt describe them, we try to connect it to the global
context and to emphasize its contemporary character.
216 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Nel 1914 i popoli e i governi europei entrarono barcollando nella Prima
guerra mondiale senza una vera inimicizia. La vera inimicizia sorse solamente dalla guerra stessa [...] Chi potrà impedire che in maniera analoga, ma in misura infinitamente più grande, sorgano nuovi e inattesi
tipi di inimicizia, il cui realizzarsi susciterà inattese forme di un nuovo
partigiano?1
Dal 2001 a oggi, il Terrorismo è diventato sempre più la costante
storica che sembra caratterizzare il presente e che determinerà il futuro. La cosiddetta “Guerra al Terrorismo” sembra essere una delle
grandi sfide che i governi occidentali saranno costretti ad affrontare
nel prossimo futuro e che sembra metterne in questione la vita stessa.
Ma chi è il terrorista? Ed è davvero possibile dichiarargli guerra? O
siamo forse di fronte a un soggetto storico e politico particolare, con
uno statuto indipendente, che merita e, anzi, obbliga a un’attenta analisi perché possa essere davvero combattuto? Attraverso una disamina
del fenomeno terroristico cercheremo di proporne una sorta di breve
fenomenologia e di offrirne una caratterizzazione che lo avvicina a un
altro soggetto storico tipico del novecento, avendo come guide due
autori in particolare: Carl Schmitt e Jacques Deridda.
Nella nostra analisi ci concentreremo in particolare sui fenomeni
terroristici degli ultimi due anni e sulle figure che li hanno prodotti in
territorio Europeo. Il 2015 e il 2016, infatti, sono stati indubbiamente
caratterizzati dai continui attacchi subiti dall’Europa e in particolar
modo dalla Francia. Più di tutti, forse, a scatenare un profondo shock
è stata la serie di attacchi armati condotti da un commando organizzato in diversi punti della città di Parigi, che hanno causato la morte di centotrenta persone, esclusi i sette terroristi rimasti uccisi negli
scontri con la polizia, il 13 Novembre 2015. A gennaio dello stesso
anno, la Francia aveva subito un attacco simile: gli attentati al giornale satirico Charlie Hebdo e al supermercato Kosher Hypercacher.
Eventi che per primi hanno portato il pericolo di IS nel cuore dell’Europa e non certo in un paese qualsiasi ma in Francia, culla dello Stato
moderno, dei diritti universali e dei valori democratici. E ancora il 14
luglio 2016 quando un camion ha travolto la folla che assisteva a uno
spettacolo pirotecnico sulla Promenade des Anglais a Nizza, provo1
Carl Schmitt, Teoria del partigiano, Milano: Adelphi, 2005, 131-2.
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 217
cando la morte di 87 persone. Una serie di eventi di enorme violenza,
incomprensibili.
La mediatizzazione come caratteristica fondamentale
del fenomeno terroristico
Già nel 2001 a poche settimane dall’attentato dell’11 settembre
Derrida, in un’intervista condotta da Giovanna Borradori,2 insisteva
su questa parola: evento, “major event”. Passati quindici anni, molto
ancora possiamo trarre da quella intervista. Derrida sottolineava che
di fronte agli attacchi alle Torri Gemelle, si avesse l’impressione che
fosse accaduto un evento importante. L’impressione, sostiene l’autore, non coincide con il fatto stesso ma è ciò che permette al fatto di
essere evento, lo costituisce come tale. Se non sono il numero di morti
(alto ma non rispetto alle frequenti stragi che avvengono in Africa e
Asia, come, per esempio quelle compiute da Boko Haram in Nigeria,
o ai morti delle due grandi guerre) e la compassione per le vittime,
ciò che davvero costituisce l’impressione è la mediatizzazione del
fatto accaduto. Esso è mediato, appunto, da un apparato interpretativo egemonico che la trasmette attraverso i suoi canali. Ed è questa
mediatizzazione ciò che sola permette al fatto di essere vissuto come
trauma insanabile e come “major event”.3 Se seguiamo la tesi del filosofo, potremmo domandarci che cosa sarebbero stati gli attentati
dell’11 settembre senza internet e senza televisione? E cosa, allora,
gli attacchi del 13 novembre 2016? Forse, guardando all’Italia, ci si
sarebbe sentiti meno partecipi e protagonisti (e meno minacciati) di
un fatto accaduto a migliaia di chilometri di distanza se non fosse stato trasportato direttamente nelle case attraverso gli schermi televisivi
in cui le immagini dell’attentato erano riprodotte costantemente. La
riproducibilità anche esasperata del fatto è consustanziale a ciò che
oggi comunemente viene definito “terrorismo” ed essa, come sottolineava sempre Derrida, è funzionale non solo ai cosiddetti “terroristi”
ma anche e forse soprattutto alle vittime: là dove a essere “vittima”,
Giovanna Borradori, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen Habermas e
Jacques Derrida, Roma-Bari: Laterza, 2003.
3
Cfr. in generale: Giovanna Borradori, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen
Habermas e Jacques Derrida, Roma-Bari: Laterza, 2003.
2
218 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
nella narrazione portata avanti dai media, non è solo chi è rimasto
ucciso negli attacchi ma soprattutto la nazione, la società, la cultura
occidentale. Quel “noi” astratto che tanto ostinatamente viene ripetuto e contrapposto a un “loro”, sebbene non sia chiaro fino in fondo che
cosa entrambi i pronomi significhino davvero. Inoltre, di ancor più
difficile comprensione sono quei riferimenti a una sorta di occidentalità, un carattere che raggrupperebbe paesi lontani e con lingue, storie
e culture diverse, nient’affatto scontato (e basta guardare all’interno
dei confini italiani per rendersi conto che già solo in una “comunità”
molto più piccola come questa vi sono divisioni continue e tentativi
di separazione culturale e geografica) e che viene riconosciuto solo
quando ci si contrappone a un comune nemico, in questo caso l’oriente islamico.
A essere sotto attacco sono “il sistema di interpretazione, l’assiomatica, la logica, la retorica [...]. Tutto il discorso che si trova
accreditato in maniera prevalente nello spazio pubblico mondiale”.4
Terrorista e terrorismo non sono concetti così chiari e definiti e non
si dimentichi che è proprio quel sistema egemonico di cui si parla sopra a stigmatizzare unilateralmente con la propria narrazione5
questa o quella persona come “terrorista” e questo o quel fatto come
“terrorismo”.
4
Ivi, 101.
È interessante notare che la retorica costruita attorno alla figura del terrorista
come mostro irrazionale ha molte analogie con la presentazione di certi personaggi
di finzione che, attraverso dei media quali film e serie televisive, popolano il nostro
immaginario. A dispetto che nella realtà, a volte, per esigenze narrative, nella fiction
può giovare cedere a un manicheismo spartano. Si pensi ai film della saga di Batman
(nei quali i criminali sono spesso dipinti semplicemente come “cattivi”, senza ragioni per le loro azioni, dai borseggiatori agli assassini). Questi antagonisti non hanno
ragioni che giustifichino le loro azioni, sono puramente malvagi e vanno fermati con
ogni mezzo. Tutto questo non è lontano da ciò che ascoltiamo da parte di politici e
giornalisti a riguardo dei terroristi islamici né da una definizione come “Axis of evil”,
utilizzata da George W. Bush per indicare l’asse di quei paesi sospettati di finanziare
e sostenere il terrorismo internazionale.
5
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 219
L’indeterminatezza del termine Terrorismo
e il suo utilizzo retorico
“Terrorismo”, dunque. Nella stessa intervista, Derrida sottolinea la
criticità di questa nozione. L’origine del termine risale alla rivoluzione francese, al periodo cosiddetto “di terrore” instaurato fra il 1793
e il 1794, in nome e in difesa dello Stato. L’origine di esso è dunque
legata al potere, al mantenimento di esso e a uno Stato che detiene,
si ricordi, il monopolio della violenza. Nella Critica della violenza di
Benjamin, ci ricorda Borradori, si distinguono due tipi di violenza:
una violenza fondatrice di diritto e una violenza conservatrice di diritto. Riprendiamo brevemente quanto descritto da Benjamin: la prima
forma è giustificabile solo retroattivamente, quando questa violenza
sia effettivamente riuscita a instaurare un ordine acquisendo legittimità.6 Il terrorismo sembra proprio essere espressione di una violenza
fondatrice. Ma se, come sostiene il filosofo tedesco, ogni diritto e
ogni istituzione sono fondati sulla violenza, niente può a priori giustificare o condannare quell’atto di violenza. Esso è giudicato solo
retrospettivamente da quel potere che impone una propria retorica e
una propria Weltanschauung. Del resto, le rivendicazioni di IS suonano non tanto come rivendicazioni d’indipendenza o di liberazione di
un territorio ma come volontà di instaurare un nuovo diritto, un nuovo
ordine sulle ceneri di quello attuale, considerato “ingiusto” e “illegittimo”. IS ha dichiarato guerra all’ordine costituito su scala globale,
quell’ordine le cui strutture sociali e culturali si sono imposte in tutto
il mondo. Contro questo potere e contro la sua invadenza si scaglia IS,
che si propone come portatrice di giustizia senza confini e universale.
Su questo torneremo dopo.
Seguendo Benjamin e Derrida, dunque, da una parte abbiamo terrorismo di Stato, prodotto cioè da uno Stato per difendersi; dall’altra,
un terrorismo che si propone come l’ultima arma possibile di fronte
alla violenza di uno Stato. In entrambi i casi, nessuna delle due tipologie si crede originaria, entrambe sono risposta, reazione a un’instabilità interna o a una violenza statale. Il primo tipo si giustifica da sé. Il
secondo, se è condannato e demonizzato dal discorso dominante, tuttavia può trovare legittimità fra quelle fasce di popolazione che effet Cfr. Walter Benjamin, Per la critica della Violenza, in Opere complete. Vol. 1:
Scritti 1906 – 1922, Torino: Giulio Einaudi Editore, 2008.
6
220 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
tivamente subiscono una violenza da parte di una potenza. Entrambi
dunque si giustificano, ma da posizioni nettamente differenti: dalla
legalità propria di un potere costituito in un caso, dalla legittimità che
si attribuisce a una rivendicazione di nuova giustizia e libertà (anche
questi sono termini del tutto oscuri e qui non si vuole dare un’accezione particolare ma intenderle per qualsiasi contenuto sia loro attribuito
in diversi contesti) nell’altro. Ciò che importa è il controllo che si ha
sul discorso mediatico e le sue narrazioni. Esso può chiamare in modi
del tutto differenti, estremizzandone o minimizzandone l’interpretazione, fatti simili, o attribuire a un fatto di poco conto e di minimo
impatto un’attenzione e una mediatizzazione massima e ridurle invece per un fatto molto più grave.
Oggi, il termine terrorismo ha assunto un’indeterminatezza forse
maggiore di quando già Derrida ne sottolineava la criticità semantica
e concettuale. Due esempi calzanti per sottolinearlo sono i due casi
della lotta No Tav in Italia e della milizia antigovernativa in Oregon,
USA, che ha occupato per diversi giorni un edificio federale.
Primo Caso: la notte fra il 13 e il 14 maggio 2013, un compressore
viene bruciato all’interno del cantiere dell’Alta velocità nella Val di
Susa dove da vent’anni gli abitanti della valle conducono una lotta
contro la costruzione della linea di alta velocità che, secondo i progetti, dovrebbe collegare Lione e Torino. Il 9 dicembre vengono arrestate quattro persone con l’accusa di terrorismo. Successivamente,
altre tre persone vengono arrestate con la stessa accusa. Nonostante la
Cassazione abbia più volte negato che di ciò potesse trattarsi, da parte
della procura vi è stata una certa ostinazione e insistenza che ha portato, dopo l’assoluzione dal reato di terrorismo in due processi differenti per tutti e sette gli imputati, a due nuovi appelli, conclusisi entrambi
nuovamente con la caduta dell’accusa.7 Colpisce quanta attenzione si
stata data a un fatto che, a ben pensarci, ha ben poco di sensazionale.
Sia da parte di una certa stampa, sia da parte delle istituzioni, vi è stato un accanimento che appare esagerato per un gesto che al massimo
può essere ricondotto al sabotaggio. È evidente che di terrorismo non
si possa parlare, ma perché allora tanta insistenza? Non sono solo
interessi economici a essere posti in questione. Del resto, già alcuni
7
Le trascrizioni dei processi sono consultabili sul sito: www.tgmaddalena.it
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 221
studi8 hanno mostrato che ormai l’impatto economico di quest’opera
sarà probabilmente sfavorevole e che essa avrebbe ormai poca utilità.
Lo stesso governo francese nel 2013 aveva dichiarato che essa non
costituiva una priorità.9 Tuttavia, da una parte, l’opposizione all’opera
ha assunto dimensioni vaste riuscendo a ottenere l’appoggio anche di
parte del mondo della cultura e della cosiddetta società civile (pensiamo allo scrittore Erri De Luca, accusato di istigazione a delinquere
per aver difeso il sabotaggio della nuova linea e poi assolto o alla condanna sancita dal Tribunale di Torino nei confronti di una studentessa
di Antropologia accusata di “concorso morale in violenza aggravata e
occupazione di terreni” per una tesi dal titolo “Ora e sempre No Tav:
identità e pratiche del movimento valsusino contro l’alta velocità”10)
e un’attenzione mediatica molto particolare; dall’altra, la sua realizzazione sembra diventata di primario interesse per lo Stato italiano
e i suoi governi, che hanno impegnato molte forze nel difenderne e
promuoverne l’utilità. In gioco forse vi sono più che altro il controllo
e la legittimità che lo Stato è in grado di esercitare ed esprimere.
Davanti a un’accusa come terrorismo, è difficile ascoltare ragioni.
Evoca violenza, follia e, chiaramente, terrore. Risulta difficile a questo punto continuare a difendere le posizioni di dissenso senza passare per terrorista o “amico dei terroristi”. Per quanto l’accusa giuridica
sia caduta, sarà difficile togliere quella macchia dal movimento No
Tav e ogni volta che se ne parlerà sarà facile ricordarla. Basta questo
per delegittimare, non serve (anche se certo sarebbe il colpo di grazia)
una vera condanna. L’articolo del codice penale utilizzato per l’accusa di terrorismo ai sette ragazzi recita:
Si vedano a tal proposito: Guido Rizzi, Angelo Tartaglia, Tav Torino-Lione. Le
bugie e la realtà, Napoli: Intra Moenia, 2005, e Luca Mercalli, Luca Giunti, Tav No
Tav, le ragioni di una scelta, Trieste: Scienza Express, 2015.
9
Si vedano: Andrea Giambartolomei, Tav, in Francia la Corte dei conti frena: “Costi alti e ricavi a rischio”, Il fatto quotidiano, 6-11-2012.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/06/tav-in-francia-corte-dei-conti-bocciaprogetto-costi-alti-e-ricavi-a-rischio/404642/ e Alberto Mattioli, Tav, la Francia
frena: “Non è una priorità”, La Stampa, 28-06-2013. http://www.lastampa.
it/2013/06/28/italia/cronache/tav-la-francia-frena-non-una-priorit-aDVB17QN6TO5yoKXVfROPP/pagina.html
10
Fonte: Andrea Giambartolomei, No Tav, Roberta Chiroli e la tesi di laurea “moralmente complice”, Il fatto quotidiano, 18-6-2016. http://www.ilfattoquotidiano.it/
premium/articoli/i-no-tav-roberta-e-la-tesi-moralmente-complice/
8
222 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro
natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la
popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,
economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale,
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di
terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.11
Come ricorda Giorgio Agamben in un articolo apparso su La
Repubblica nell’aprile del 2014,12 non solo non vi è tentativo di intimidire una popolazione ma è la popolazione stessa ad opporsi all’opera,13 ma è altrettanto difficile credere che un atto come quello in
questione possa davvero “intimidire” o “arrecare grave danno a un
paese a un’organizzazione internazionale”. Lampante è l’indeterminatezza dell’articolo del codice penale che calca le risoluzioni ONU.
Scrive Agamben nel medesimo articolo: “Chi ha qualche cultura giuridica sa bene quanto sia rischiosa l’introduzione nel diritto di clau Articolo 270 sexies del Codice penale italiano. Cfr. in parallelo, la risoluzione
ONU, successiva agli attentati dell’11 settembre che recita similmente: “ […] gli atti
criminali, particolarmente quelli diretti contro i civili con l ‟intenzione di causare la
morte o gravi ferite, la presa di ostaggi con lo scopo di seminare il terrore fra la popolazione, gruppi di persone o privati cittadini, intimidire una popolazione o costringere
un governo o un‟organizzazione internazionale a compiere un‟azione o astenersi
dal farlo, e che, come tali, sono stabiliti e stipulati come infrazioni nei protocolli e
nelle convenzioni internazionali relativi al terrorismo.”
12
Giorgio Agamben, Quell’accusa di Terrorismo, Archivio, La Repubblica, 25
aprile 2014.
13
È chiaro che qui in questione c’è un’altra ambiguità essenziale: è sempre
Agamben a ricordarcela in Giorgio Agamben, Mezzi senza fine, Torino: Bollati
Boringhieri, 1996. Il termine popolo nelle lingue europee moderne indica sia il soggetto politico costitutivo sia la classe esclusa dalla politica. Per Agamben il concetto
di popolo, nella politica occidentale, non indicherebbe dunque un soggetto unitario,
bensì “un’oscillazione dialettica fra due poli opposti: da una parte, l’insieme Popolo
come corpo politico integrale, dall’altra il sottoinsieme popolo come molteplicità
frammentaria di corpi bisognosi ed esclusi; là un’inclusione che si pretende senza
residui, qua un’esclusione che si sa senza speranze”. Il caso dei NoTav può essere
utile per pensare quest’oscillazione e lo spazio politico rimasto al cittadino al giorno
d’oggi.
11
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 223
sole generali e indeterminate (come ‘sicurezza e ordine pubblico’,
‘buon costume’ ‘stato di necessità’) che, in quanto non rimandano a
una definizione precisa, ma alla valutazione soggettiva di una situazione, finiscono, com’è stato autorevolmente osservato, col rendere
incerti tutti i concetti giuridici. La legislazione contro il terrorismo e
le cosiddette ‘ragioni di sicurezza’ hanno spinto questa indeterminazione all’estremo, tanto che si potrebbe affermare che rispetto a esse
ogni cittadino non sia ormai altro che un terrorista in potenza”.14
Non solo la parola terrorismo è oscura e di difficile interpretazione, dunque, ma nemmeno nel diritto la sua indeterminatezza viene
risolta, così che esso possa essere utilizzato in modo unilaterale per
mettere a tacere ogni dissenso.
Passando al secondo esempio, salta agli occhi come un caso ben
più grave di un compressore bruciato non sia stato stigmatizzato immediatamente con le stesse parole e la stessa retorica che si utilizzano
quando si parla di terrorismo.
Il 3 gennaio 2016, in seguito a una protesta pacifica a sostegno
di due allevatori arrestati per aver dato alle fiamme delle aree verdi
di proprietà del governo degli Stati Uniti, un gruppo armato di circa
centocinquanta persone occupa un edificio federale nel Rifugio della fauna selvatica nazionale in Oregon.15 Si chiamano “Citizens for
Constitutional Freedom” e accusano l’ingerenza del governo federale
nelle vite dei cittadini. Fanno parte della destra estrema ultra-liberale, bianca, protestante e identitaria che da sempre non vede di buon
occhio il governo di Washington, tantomeno con un afroamericano
al suo comando. Accusano il governo federale di “socialismo” e di
attentato alla proprietà privata perché avrebbe rubato le terre che ora
fanno parte di riserve naturali. La vicenda si è conclusa con uno scontro a fuoco con la polizia a un posto di blocco, l’arresto del leader
della milizia Ammon Bundy e un morto. Pochi irriducibili hanno continuato l’occupazione ancora qualche giorno, nonostante l’invito di
Bundy a deporre le armi. Senza dubbio un episodio molto più grave,
sfociato persino nella morte di una persona, rispetto al caso NoTav;
tuttavia nessun media ha menzionato la parola “terrorismo”. È diffici Agamben, Quell’accusa di Terrorismo.
Si veda: Evan Perez, Ammon Bundy, other protesters arrested in Oregon;
LaVoy Finicum killed, CNN, 27-01-2016. http://edition.cnn.com/2016/01/26/us/
oregon-wildlife-refuge-siege-arrests/
14
15
224 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
le non credere che questo accada proprio perché sono bianchi, cristiani ed estremisti liberali, e che esiste una certa destra negli Stati Uniti
che li difende e gli dà voce. Inoltre, queste persone rappresentano
ancora l’ideale dell’uomo tutto di un pezzo americano, il cowboy del
mito della frontiera, di sani e saldi principi, legato alla famiglia e a
alla religione. Insomma sembrano troppo americani per essere definiti
terroristi all’interno del registro retorico dei mass media americani.
Nonostante fossero armati, nonostante se la prendessero con il governo centrale, restano dei rappresentati tipici di una certa America e per
questo non meritano un appellativo del genere.16
Tipizzazione del Terrorista islamico:
dal partigiano al combattente rivoluzionario
I fatti sopra descritti sono due esempi eterogenei che mostrano chiaramente la vaghezza del concetto e l’arbitrarietà con cui può essere
utilizzato nel linguaggio comune; ma simili sotto una certa ottica dal
momento che in entrambi i casi è la popolazione di un territorio a essersi rivoltata contro un governo centrale sebbene animati da principi
ben diversi. Ovviamente, gli attacchi avvenuti a Parigi sono di altra
gravità rispetto ai fatti descritti sopra. Tuttavia, e proprio per questo,
possiamo più facilmente notare ora che il termine “terrorismo” sia facilmente utilizzabile in maniera unilaterale, arbitraria e politicamente
interessata per chiamare qualcosa che avviene, senza in realtà darne
una definizione vera, ma anzi confondendo ancora di più a riguardo.
Invece di cercare di capire davvero cosa abbia portato a un accadimento del genere, lo si bolla con la retorica del terrorismo e davanti
ad esso non si ascoltano ragioni: è sinonimo di male, di “assolutamente altro” rispetto a noi. Mossi dal terrore prodotto da un’alterità
assoluta non si può che reagire irrazionalmente. Il male non ascolta
ragioni e va distrutto. L’antropologo Marc Augé in Che fine ha fatto il
futuro? scriveva sempre a proposito dell’attentato alle Torri Gemelle:
16
Per una breve panoramica sulla discussione nel contesto statunitense a tal proposito, si consigliano i seguenti articoli: Janell Ross, Why aren’t we calling the Oregon
occupiers ‘terrorists’?, Washington Post, 3-1-2016. https://www.washingtonpost.
com/news/the-fix/wp/2016/01/03/why-arent-we-calling-the-oregon-militia-terrorists/ e Ibrahim Hooper, Let’s call the Oregon protesters ‘Terrorist’, 5-1-2016.
http://time.com/4166975/oregon-protesters-terrorists/
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 225
“Se invece l’evento ha una portata inaspettata e si presenta a prima
vista imprevedibile, come nel caso dell’attentato dell’11 settembre
2001, c’è un rapido cambio di strategia. La ricerca dei colpevoli diretti, morti, e dei responsabili più lontani, irrintracciabili in un futuro
prevedibile, lascia presto il posto a una nuova iniziativa temporale:
si fa dell’evento non un punto di arrivo che bisogna spiegare, ma un
punto di partenza che tutto spiegherà”.17 Allora il tutto da spiegare era
la “war on terrorism” contro la “axis of evil”, l’asse del male. Oggi
sono i bombardamenti in Siria, la stretta sulle migrazioni, lo stato
d’eccezione dichiarato in Francia, il contro-terrorismo. Tutto ciò dominato dal “terrore” diffuso di una minaccia costante e a venire che
porta a uno stato di costante allerta.
Se è forse più evidente quanto il termine “terrorismo” sia oscuro,
si pensi ora alle tante dichiarazioni di politici, giornalisti, esperti sulla
cosiddetta “guerra al terrorismo”. Da anni infatti l’opinione pubblica
si sente ripetere di “essere in guerra”, nonostante non sia ancora ben
chiaro chi sia il nemico. Per una più accurata analisi del fenomeno
del terrorismo contemporaneo, Derrida, nella già citata opera, proponeva una rilettura critica di Carl Schmitt: “da una parte per seguirlo nella distinzione tra ‘guerra classica’ e ‘guerra civile’ rispetto alla
‘guerra partigiana’. D’altra parte, dobbiamo pure riconoscere, contro
Schmitt, che la violenza scatenata in questo frangente non riguarda la
guerra (l’espressione ‘war on terrorism’ è tra la più confuse, e bisogna analizzare la confusione e gli interessi a cui tale abuso retorico fa
gioco)”.18 La questione posta da Derrida, se riletta con attenzione, può
essere molto interessante: in effetti, è difficile definire tale la cosiddetta guerra contro il terrorismo internazionale, definirla una guerra,
poiché risulta impossibile individuare un nemico chiaro e definito.
Gli attentati non sono portati a termine come operazioni militari classiche: in campo non vi sono eserciti statali contrapposti (senza tenere
conto del fatto che gli attacchi terroristici devono la propria peculiarità ed efficacia al fatto che la paura del loro ripetersi improvviso
e imprevisto ne costituisce la reale portata offensiva molto più del
numero delle vittime che possono causare. Naturalmente questo è uno
Marc Augé, Che fine ha fatto il futuro? - Dai nonluoghi al nontempo, Milano:
Elèuthera, 2009, 90.
18
Borradori, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques
Derrida, 108.
17
226 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
dei motivi per cui questa “guerra” non sarebbe immaginabile senza i
riflettori dei media, come abbiamo descritto sopra). Non solo le vittime sono civili e non militari; il terrorista stesso non può essere trattato
alla stregua di un militare e, infatti, non è quello che accade. Spesso
egli è un civile nato e cresciuto nello Stato che attacca. In effetti, il
terrorista è trattato innanzitutto come un criminale; sia attraverso i
metodi con cui viene combattuto e mediaticamente stigmatizzato sia,
di rimando, da parte dell’opinione pubblica. Il problema di un approccio del genere è che chiude la porta a una comprensione del fenomeno
che possa andare più in profondità rispetto a una semplice condanna morale e retorica. La questione che rimane aperta è se si possa o
meno attribuire carattere politico agli atti terroristici. Se il terrorista
possa essere accostato, più che al criminale, alle figure del partigiano
e del combattente rivoluzionario. La parola partigiano nel nostro paese viene usata con enfasi particolare, legata all’immagine di difesa
della democrazia contro il nazifascismo. In effetti, però, la storia di
questo termine non si esaurisce qui e del resto alcuni partigiani non
si limitarono a combattere il fascismo per ripristinare la democrazia, ma videro nella resistenza l’inizio di una possibile rivoluzione in
Italia e continuarono anche dopo la fine della guerra la loro attività.19
Un’altra cosa che occorre tenere ben presente è che molti eventi storici vengono rivalutati solo retrospettivamente: è proprio questo il caso
della Resistenza italiana, o ad esempio è il caso dell’Algeria, i cui
combattenti ottennero legittimità politica solo dopo aver reso il loro
paese indipendente dalla Francia. Si presenta nuovamente, dunque, la
polarità fra le istanze della legalità e quelle della legittimità politica;
binomio che si presenta nella distinzione fra violenza fondatrice e
violenza conservatrice di diritto, a cui accennavamo sopra: la prima
poggia sulla credenza nella propria legittimità, la seconda sul potere
costituito. Il terrorista non si muove nella sfera del diritto, e per questo “non può che richiamarsi a una legittimità superiore alla legge po-
19
Si pensi in particolare alle azioni promesse dalla “Volante Rossa”, organizzazione paramilitare attiva a Milano tra il 1945 e il 1949, che promosse una serie di
omicidi, in particolari contro ex-fascisti, “ sentimenti di una «Resistenza tradita» perché incompiuta e non sfociata in una rivoluzione politica socialista” (dalla quarta di
copertina del libro di Massimo Recchioni, Il tenente Alvaro, la volante rossa, Roma:
DeriveApprodi, 2011).
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 227
sitiva”. Come osserva Alain de Benoist,20 Carl Schmitt ritiene che la
figura del partigiano sia “essenziale, giacché costituisce una perfetta
dimostrazione del fatto che lo Stato e la politica non sono necessariamente sinonimi e, viceversa, possono disgiungersi. Il partigiano
conduce infatti una lotta eminentemente politica, che si svolge però
fuori dal controllo dello Stato, e anzi generalmente contro di esso”.
Sono quattro i caratteri che Schmitt attribuisce al partigiano in quanto
combattente: 1) irregolarità, 2) mobilità e flessibilità, 3) l’impegno
politico che lo anima, 4) il carattere tellurico, ovvero la difesa della propria patria o del proprio territorio, in genere da un occupante
straniero.21 Come osserva Franco Volpi in L’ultima sentinella della
terra22 Carl Schmitt s’interessa al partigiano perché nella sua figura si
condensano una serie di problemi inerenti all’ordine giuspolitico internazionale: “il radicalizzarsi della contrapposizione al nemico, con
la violazione delle limitazioni e delle regole della guerra, trasforma
quest’ultima in conflitto discriminatorio. Dalla guerra duello fra Stati,
circoscritta e regolamentata, si passa alla guerra senza limiti, assoluta,
totale, che implica la criminalizzazione del nemico fino a volere il suo
annientamento”23. In effetti, è questa inimicizia assoluta che segna il
confine, per Schmitt, tra il partigiano e il combattente rivoluzionario: se il partigiano, come abbiamo visto, resta legato a una logica di
difesa del territorio (Schmitt cita in tal proposito una frase attribuita
a Giovanna D’Arco: “Se dio ama gli inglesi o li odia, io non lo so;
so solo che devono essere cacciati dalla Francia”24), il combattente
rivoluzionario ha non solo un vero nemico, bensì un nemico assoluto.
Dunque, abbandonando la logica di difesa del territorio e facendosi un nemico assoluto, il partigiano perde il carattere tellurico: si
“deterritorializza”, nelle parole di Alain de Benoist, il quale osserva
che ciò è tanto più degno di attenzione in quanto noi viviamo oggi
in un’epoca in cui non c’è più spazio per logiche territoriali e in particolare la forma territoriale di dominio “diventa a sua volta obso Alain De Benoist, Dal partigiano al “terrorista globale” Riflessioni sulle forme
attuali di terrorismo, www.alaindeboist.com
21
Cfr. Schmitt, Teoria del partigiano.
22
Franco Volpi: “L’ultima sentinella della terra”, saggio introduttivo a Teoria del
Partigiano di Carl Schmitt, Milano: Adelphi, 2005.
23
Ivi, 171.
24
Episodio raccontato in Schmitt, Teoria del partigiano, 128.
20
228 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
leta”.25 È, in effetti, questo un altro dei motivi per cui risulta difficile parlare di guerra rispetto al terrorismo; oltre all’assenza di un
nemico chiaramente identificabile, manca un territorio da attaccare.
Le organizzazioni terroristiche si muovono secondo reti, proprio
come gli strumenti di dominio contemporanei: “è più redditizio, ai
nostri giorni, colonizzare le menti o controllare dei mercati, piuttosto che conquistare o annettere un territorio”.26 De Benoist prosegue
osservando che la deterritorializzazione comporta una conseguenza
importante, anch’essa legata alla questione della criminalizzazione
del nemico, ovvero “la confusione o permeabilità dei compiti militari e dei compiti di polizia” e la conseguente deflagrazione della distinzione tra affari interni e affari esteri o internazionali”. Ancora De
Benoist: “La descrizione del terrorista come un semplice ‘criminale’
si basa su una logica che mette al bando qualunque accostamento fra
omicidio e legittimità. Questa logica, tuttavia, inciampa nel fatto che
in ogni guerra l’uccisione è legittima”. Inoltre emergono altre due
problematiche importanti: la prima consiste nel fatto che il terrorismo viene affrontato con politiche di sicurezza incompatibili con il
sistema democratico e con le libertà che questo pretende di tutelare
e garantire, e la seconda riguarda invece l’utilizzo di pratiche, come
la tortura, incompatibili con questo stesso sistema. Sembra insomma
inestricabile il groviglio che si viene a creare tra delegittimazione e
criminalizzazione del nemico da una parte, e utilizzo di strategie per
combatterlo incompatibili con i modelli democratici da salvaguardare
e proteggere, dall’altra.
Lenin, secondo Schmitt, è colui che ha per primo compreso il
carattere politico del partigiano, riconoscendolo come figura centrale
della guerra rivoluzionaria.27 Il partigiano si deterritorializza: la sua
Si noti che, come osserva Paul Virilio in La bomba informatica (Milano: Cortina,
2000) e ripreso da Marc Augé in Che fine ha fatto il futuro?, l’opposizione fra globale
(in quanto “mondo in rete, un sistema definito da parametri spaziali, ma anche economici, tecnologici e politici”) e locale, nelle analisi del Pentagono (il dipartimento d
difesa degli Stati Uniti), essi vengono contrapposti come l’interno rispetto all’esterno, laddove però a essere interno è il globale e l’esterno il locale e non il contrario. È
il locale che si oppone al globale.
26
De Benoist, Dal partigiano al “terrorista globale” Riflessioni sulle forme attuali di terrorismo.
27
Cfr. in generale: Schmitt, Teoria del partigiano, e Lenin, Che fare?, Genova:
Lotta Comunista, 2004.
25
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 229
diventa la tattica propria del rivoluzionario, il quale non combatte
per difendere il territorio da un’invasione ma inserendosi in una lotta
che spezza ogni confine e ogni definizione chiara di nemico nel senso
che si era inteso fino a quel momento. Il nemico è assoluto e rappresentato dalla borghesia e dal capitalista occidentale, ovunque essi
siano. Non vi è più un nemico riconosciuto, quale potrebbe essere uno
Stato legittimo. Il nemico è la struttura stessa del mondo capitalista;
e il combattente non è più un militare, ma un civile. Il rivoluzionario
s’identifica nell’“aggressività assoluta di un’ideologia”28 o pretende
di incarnare l’ideale di una “giustizia astratta”. Suo campo d’azione
è il mondo intero e non ha remore nella scelta dei mezzi, in quanto
portatore di una nuova e vera giustizia. Il terrorista islamico contemporaneo sembra inserirsi perfettamente in questa descrizione. Come
già detto in precedenza, egli non combatte né in difesa di un territorio, né contro uno Stato in particolare. Anche il terrorista islamico
pretende di incarnare l’ideale di una “giustizia astratta” e rivendica la
propria legittimità oltre ciò che sarebbe concesso dal diritto statale.
Nemico è l’Occidente, considerato impuro nella sua stessa cultura.
Gli attentati in Francia non hanno preso di mira alcun simbolo del
potere, come ancora potevano essere considerate per esempio le Twin
Towers29, quanto piuttosto i simboli dei valori fondanti occidentali
(l’attacco alla “satira” e alla libertà di espressione nell’attentato al
giornale Charlie Hebdo) e dei suoi stili di vita (gli attacchi ai luoghi
del divertissement come il locale Bataclan o il lungo mare di Nizza).
Questi attentati simboleggiano che il nemico non è uno e definito ma
una società intera. Laddove, dunque, il nemico non è più un’entità definita ma l’Occidente in quanto tale, anche il partigiano dell’IS è deterritorializzato e assume le fattezze del combattente rivoluzionario,
che lotta contro un nemico assoluto e si fa portatore di un nuovo ideale di giustizia.30 Sebbene gli attentati di oggi possano a prima vista
risultare più efferati, nulla, o quasi nulla, separa il terrorista islamico
Cfr. Schmitt, Teoria del partigiano.
Simboli per eccellenza del primato economico degli Stati Uniti.
30
È vero che IS si è costituito come Stato ma non è riconosciuto da nessun altro
Stato. Inoltre, non vi è rivendicazione strettamente territoriale, anzi il Califfato si prospetta come grande casa di tutti i musulmani (dei musulmani che non hanno tradito
una certa interpretazione del Corano), abbattendo ogni confine. Soprattutto, quello
della costituzione dello Stato è solo una parte di un’ideologia più ampia che ha nella
lotta all’Occidente un suo cardine altrettanto importante.
28
29
230 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
dal rivoluzionario novecentesco, almeno nella sua caratterizzazione
tipologica31.
Costruzione dell’immaginario e rivendicazioni
Se non si tratta di una guerra nel senso canonico, non si tratta nemmeno di scontro fra civiltà ma anzi di uno scontro tutto interno al mondo
globalizzato. Già Derrida, nella stessa intervista, diceva a proposito
di Al-Quaeda e di Bin Laden che l’obiettivo sembrava essere quello
di “mettere tutte le forze capitalistiche e tecno-scientifiche moderne al
servizio di un’interpretazione essa stessa dogmatica della rivelazione
islamica dell’uno”32 e Borradori ci parla di un “matrimonio infelice
fra religione e rete mondiale della comunicazione”.33 Non la distruzione, quindi, di tutto l’apparato capitalistico occidentale, ma un riutilizzo. Potremmo dire: una nuova globalizzazione, completamente
diversa da quella conosciuta finora, all’insegna dell’interpretazione
estremistica della religione rivelata. Per Marc Augé34 l’integralismo,
di qualunque forma, è un tentativo di globalizzazione dell’immaginario, una nuova globalizzazione come si diceva.
Quanto questo fenomeno sia tutto interno al mondo globalizzato era già reso chiaro dal ruolo strategico che gioca lo spazio mediatico sia nella diffusione della condizione di “terrore” che si vuole
far dominare negli Stati occidentali attraverso le brutali immagini di
decapitazioni e distruzioni di città o nei video in cui si mostrano le
maggiori città europee morse dalle fiamme con la bandiera nera del
Califfato che garrisce in cima a un monumento (come San Pietro a
Roma35), sia nella propaganda rivolta a costruire l’immaginario del
31
Del resto, gli anni ’70 italiani sono stati costellati da attentati terroristici da parte
di associazioni di matrice comunista e rivoluzionaria, come le Brigate Rosse o Prima
Linea (per citarne solo due fra i più conosciuti) oppure si pensi agli attentati delle
FARC (Forze Armate Rivoluzionarie di Colombia) in Colombia.
32
Borradori, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques
Derrida, 122.
33
Ivi, 150.
34
Augé, Che fine ha fatto il futuro? - Dai nonluoghi al nontempo, 84.
35
Si veda: Giulio Olimpio, La bandiera nera di Isis su San Pietro.
Jihadisti contro ‘Roma’ e i ‘Crociati’, 12-10-14. http://www.corriere.it/esteri/14_ottobre_12/bandiera-nera-isis-san-pietro-jihadisti-contro-roma-crociati-40248cea-521e-11e4-b208-19bd12be98c1.shtml
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 231
Jihad e dello Stato Islamico rivolto ai musulmani. Da notare è che
non si parla solo arabo ma inglese, francese, tedesco e che vi sono
persino predicatori bianchi a invocare la guerra santa. Il messaggio
è trasmesso con un linguaggio evidentemente studiato per parlare a
un grande pubblico, un linguaggio più simile a quello del grande cinema americano e un pubblico che è cresciuto con quei riferimenti, come nota acutamente Silvano Cacciari, docente di sociologia e
media all’Università di Firenze, nell’articolo Crocifissioni riprese
dallo smartphone. Antropologia politica di Isis.36 L’obiettivo che si
prefigge l’utilizzo di questo tipo di linguaggio è la “massimizzazione
dell’audience”, senza distinguere se questa venga da Occidente o da
Oriente. L’aspetto però davvero interessante che Cacciari rileva è il
riutilizzo di tematiche e linguaggi appartenenti storicamente alla sinistra. Egli analizza in particolare un video, “Saluti dal Califfato (Eid
Greetings From The Land of khilafah)”,37 in cui viene mostrata la vita
quotidiana dei soldati e l’educazione impartita ai giovani nel nuovo
Stato sulla base dell’interpretazione fondamentalista del Corano. Una
terra con un ordine nuovo, in cui tutti si è davvero uguali (sebbene
sotto la legge della sharia). Come ben dice Cacciari, l’adesione a questo contesto non è più solo religiosa ma strettamente bio-politica. E
infatti non possiamo interpretare il fenomeno di IS, la sua diffusione
e la sua presa sulle persone solo come un “ritorno alla religione”.
Vi si nasconde qualcosa di più importante, una promessa di riscatto
per tutti gli esclusi del mondo globalizzato o i “dannati della globalizzazione” per dirla con Derrida. Da una parte il depauperamento e
la marginalizzazione dei paesi mediorientali avvenuti nel corso degli
ultimi due secoli, come di nuovo sottolineava Derrida, proporzionale
alla crescita della popolazione povera38; dall’altra, ed è l’aspetto forse
più interessante, i giovani delle seconde e terze generazione di immigrati in Europa, sui quali più fa presa il discorso mediatico di IS,
che si sono visti in qualche modo traditi dalle promesse delle democrazie occidentali. Non è un caso che sia proprio la Francia a essere
Silvano Cacciari, Crocifissioni riprese dallo smartphone. Antropologia
politica di Isis, apparso su www.senzasoste.it, firmato con lo pseudonimo di
“Nique la Police”, 9 settembre 2014. http://www.senzasoste.it/internazionale/
crocifissioni-riprese-dallo-smartphone-antropologia-politica-di-isis
37
Il video è stato rimosso dal canale YouTube.
38
Borradori, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques
Derrida, 131.
36
232 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
più colpita da questo fenomeno. La Francia del welfare e dei diritti,
che nasconde, e nemmeno troppo in realtà, una profonda tensione
razziale e sociale. Basti pensare alle banlieues parigine dalle quali si
muovono ciclicamente moti di rabbia sociale che sfociano anche in
violenti scontri come quelli dell’ottobre 2005, in cui per tre settimane
si diffusero una serie di rivolte su tutto il territorio francese.
La religione non è ciò che spinge queste generazioni a prendere
parte al Jihad o quantomeno non è l’unica cosa. Nati e cresciuti in
Europa, spesso non hanno nemmeno mai visto la terra di provenienza
dei propri genitori e molti prima della “conversione” prestavano ben
poca attenzione alle interpretazioni ferree del Corano. La religione
funge piuttosto da veicolo ideologico attraverso cui elaborare le reali
ragioni che producono il fenomeno. La povertà, la tensione sociale e
razziale, il bisogno di credere in un futuro differente rispetto a quello
ben grigio che si prospetta loro oggi, sono tutti moventi che possono
spingere dei giovani francesi, belgi o inglesi a offrirsi alla causa del
jihad, convinti da una propaganda che è stata in grado di offrire ben
più aspettative e speranze39. Il video “Saluti dal Califfato”, si conclude con le parole “eravamo oppressi”: “il deturnamento islamico del
successo delle rivoluzioni, e della lotta di classe, è servito sul tavolo.
La sharia non opprime qui, al contrario, libera dall’oppressione”.40 In
un altro video citato da Cacciari, il documentario di ViceNews all’interno dello Stato Islamico,41 in una scena si festeggia la caduta del
confine fra Siria e Iraq: “un abbattimento dei confini entro un nuovo
soggetto politico chiuso, ma l’effetto liberazione dalle dogane, di fine
del colonialismo nel documentario è chiarissimo”. Se una volta erano
i grandi movimenti dei lavoratori e degli studenti o i diversi gruppi
rivoluzionari a parlare alle fasce della società che più vivevano le
contraddizioni del capitalismo e della globalizzazione (che, come diceva Derrida, accade e non accade allo stesso tempo poiché, mentre
39
Si veda a tal proposito la breve video-intervista del sito online de “Il fatto quotidiano” ad alcuni specialisti dell’associazione “Entre-nous”, che si occupa dal problema della radicalizzazione religiosa, che sottolineano che l’attentatore di Nizza non
avesse nessun legame con la fede religiosa e che “il suo processo di radicalizzazione
è passato subito a un livello politico.” Link: http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/07/18/
attentanti-nizza-al-centro-anti-radicalizzazione-non-ce-islam-in-bouhlel-e-passato-allazione-senza-tappe-nel-fondamentalismo/544486/
40
Cacciari, Crocifissioni riprese dallo smartphone. Antropologia politica di Isis.
41
https://www.youtube.com/watch?v=AUjHb4C7b94
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 233
si insiste sulla apertura del mercato e delle frontiere, sull’uguaglianza
di opportunità, sulla fine del lavoro, non vi sono mai state nella storia
così tanta ineguaglianza, malnutrizione e condizioni impossibili di
lavoro42), oggi che questi movimenti sono più deboli, sono il Jihad
e il suo messaggio a essere riusciti a imporsi. I giovani che vanno a
combattere assomigliano più di quanto si creda ai combattenti rivoluzionari di allora e la tensione internazionalista, che non rivendica un
territorio o uno Stato ma la liberazione dall’oppressione, dalla povertà e dalle ingiustizie è presente in egual misura. Gli esclusi cercano di
rientrare a buon diritto nella storia; ad accoglierli però non ci sono più
i movimenti, che sembrano faticare a costruirsi uno spazio comunicativo efficace, ma il jihad e lo Stato Islamico, con tutte le sue promesse.
Non solo dunque la caratterizzazione tipologica del terrorista ricalca da vicino quella del rivoluzionario, descritto da Schmitt; ma lo
stesso immaginario e le rivendicazioni che sono portate avanti dalla
narrazione ideologica di IS assomigliano e molto a quelle tipiche della sinistra.
Conclusioni: che fare?
Riassumendo quanto detto finora, gli attacchi di Parigi hanno creato
l’impressione che fosse accaduto qualcosa di grande ma allo stesso
tempo di incomprensibile ed estraneo. Un male terribile, che coglie
impreparato chiunque e palesa una minaccia tenebrosa che grava su
tutta l’Europa e l’Occidente. I terroristi non hanno ragioni e nemmeno riescono a essere visti come esseri umani, sono mostri. Si crea,
dunque, una contrapposizione fra buoni e cattivi, “noi” e “loro”. Il
discorso mediatico comune contribuisce e anzi è il maggior responsabile di questa polarizzazione. L’IS si nutre proprio di questa estrema mediatizzazione che porta, da un lato, la paura in tutte le case e,
dall’altro, richiama a sé le fasce più critiche della popolazione, più a
rischio di finire attratte dalle promesse del Jihad perché oppresse e disilluse. La dialettica del “noi” e “loro” non fa che accentuare proprio
questo rischio. Chi si considera tagliato fuori dalla società facilmente
Borradori, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques
Derrida, pg. 131.
42
234 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
finirà per sentirsi parte del “loro” se non può o non vuole più essere
parte del “noi”.
L’utilizzo retorico e unilaterale del termine stesso “terrorismo”
non aiuta. Come si è visto, esso può essere utilizzato nei più svariati
modi, rivolto a contesti del tutto differenti e con pesi e misure ogni
volta diversi. La parola, carica di emotività, evoca solo malvagità e
follia. Ma in realtà il terrorismo non può e non deve essere assimilato
a una disumanità senza ragioni, perché, per quanto terribili siano le
sue manifestazioni, esso è un prodotto delle condizioni storiche del
presente e possiede una dimensione politica che non può non essere
considerata. Esso porta con sé delle rivendicazioni e la sua violenza
si richiama alla legittimità, presunta o meno che sia, di quest’ultime.
In un mondo globalizzato, dove ormai i confini sociali, culturali e
mediatici sono sempre più sfumati, il fenomeno terroristico prende
la sua forma proprio su questa universalità di linguaggio e contesto.
L’utilizzo dei canali d’informazione, dell’immaginario, persino delle
lingue occidentali mostra che ormai si è creato un unico grande spazio narrativo e culturale. IS è riuscita a utilizzare a pieno le forme
occidentali di comunicazione perché sono anche le sue.
Tale aspetto si manifesta anche e soprattutto nella costituzione
stessa del terrorista. La deterritorializzazione del rivoluzionario che
descriveva Schmitt è la stessa dello jihadista dell’IS. È nel mondo
globalizzato, nel mondo capitalista che essa si presenta e non poteva
crearsi se non in questa realtà unificata, oltre i confini nazionali. Il
terrorista odierno è una declinazione della figura del rivoluzionario. Il
califfato si presenta come una promessa già in atto, un ordine nuovo
che già c’è e che invita tutti in tutto il mondo a prenderne parte, nella
lotta al sistema depravato odierno. Anche se lo Stato Islamico venisse
sconfitto sul territorio (cosa sempre più probabile), non si potrà dire
altrettanto dell’ “ideale” che esso incarna e delle ragioni che portano all’estremizzazione molti giovani europei di fede islamica. Sono
soprattutto gli emarginati a esserne attratti perché sono coloro che
più soffrono le contraddizioni del mondo moderno. Essi, senza più
molto da perdere e con un futuro che si prospetta sempre più incerto
nella crisi che imperversa da quasi dieci anni, sono attratti dalla promessa. Una promessa che appare possibile, anzi reale. La differenza
che intercorre fra il terrorista e il rivoluzionario non è ontologica o
tipologica. Se non si accetta questa derivazione, si rischia di lasciare
uno spazio d’indeterminatezza in cui far finire tutto ciò con cui non
Andrea Araf, Gioacchino Orsenigo - La figura del terrorista 235
si vuol fare i conti, il male assoluto: che è proprio ciò che si è cercato
di mostrare come più dannoso a una comprensione positiva del fenomeno contemporaneo.
Eppure indubbiamente percepiamo una differenza fra il rivoluzionario e il terrorista islamico. Sorge quindi il problema di come
mantenere questa distanza e di come affrontare da un lato il terrorismo fondamentalista islamico, dall’altra quelle contraddizioni e problematiche poste dal mondo globalizzato. Abbiamo visto, infatti, che
molte delle ragioni che muovevano il rivoluzionario e che muovono i
terroristi sono le stesse. Il problema è la direzione che prendono nella
prassi politica. Il filosofo sloveno Slavoj Žižek, nell’ultimo capitolo
del suo libro Against the Double Blackmail: Refugees, Terror and
other troubles with the Neighbours,43 scrive: “The only way to break
out of this deadlock is to move beyond mere tolerance of others. Don’t
just respect others: offer them a common struggle, since our problems
today are common; propose and fight for a positive universal project
shared by all participants44.” Si tratterebbe dunque di unificare sotto
la stessa bandiera, sfruttati occidentali e migranti; costruire un piano
comune e condiviso nella lotta al nemico comune costituito dal mondo occidentale; connettere i diversi antagonismi interni ad esso, che
Žižek individua in: “the looming threat of ecological catastrophe; the
more and more palpable failure of private property to integrate into
its functioning so-called ‘intellectual property’; the socio-ethical implications of new techno-scientific developments (especially in biogenetics); and, last but not least, […] , new forms of apartheid, new
walls and slums.45”
Se la proposta di Žižek appare forse troppo confusa e romantica, almeno pone le basi per una nuova discussione sulle criticità del
mondo occidentale e sulla necessità di nuove pratiche. Sicuramente,
dobbiamo renderci conto che, se siamo in guerra oggi (e lo siamo per
quanto i bombardamenti siano silenziosi e lontani, per quanto si cerchi di allontanare il problema), non è una guerra che può essere combattuta con le modalità classiche: come speriamo di aver messo in
Slavoj Žižek, Against the Double Blackmail: Refugees, Terror and other troubles with the Neighbours, London: Penguin, 2016.
44
Slavoj Žižek, Against the Double Blackmail: Refugees, Terror and other troubles with the Neighbours, London: Penguin, 2016, pg.100.
45
Ivi, 104.
43
236 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
luce, è un fenomeno, quello cui ci troviamo davanti, nuovo e di difficile comprensione. Esso necessita, per essere afferrato e affrontato in
modo proficuo, di un ripensamento totale dei concetti di democrazia
e diritto e del capitalismo con le sue contraddizioni. La guerra cieca,
l’assimilazione dei combattenti jihadisti al male assoluto non fanno
che riprodurre e acuire le stesse condizioni che hanno provocato il
fenomeno, invece di eliminarlo. È la crisi autoimmunitaria di cui parlava Derrida: “il suicidio spontaneo dei meccanismi difensivi preposti
a proteggere un organismo dalle aggressioni esterne”.46
Bibliografia
Agamben Giorgio, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino:
Giulio Einaudi editore, 2005.
Agamben Giorgio, Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino: Bollati
Boringhieri, 1996.
Agamben Giorgio, Quell’accusa di terrorismo, Archivio LaRepubblica,
www.repubblica.it, 2014.
Augé Marc, Che fine ha fatto il futuro? - Dai nonluoghi al nontempo, Milano:
Eleuthera, 2009.
Benjamin Walter, “Per la critica della Violenza”, in Opere complete. Vol. 1:
Scritti 1906 – 1922, Torino: Giulio Einaudi Editore, 2008.
Borradori Giovanna, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen Habermas
e Jacques Derrida, Roma-Bari: Laterza, 2003.
Cacciari Silvano, Crocifissioni riprese dallo smartphone. Antropologia politica di Isis, www.senzasoste.it, 9 settembre 2014, firmato con lo pseudonimo di “Nique la Police”.
De Benoist Alain, Dal partigiano al “terrorista globale” Riflessioni sulle
forme attuali di terrorismo, www.alaindebenoist.com.
Schmitt Carl, Teoria del partigiano, Milano: Adelphi, 2005.
Žižek Slavoj, Against the Double Blackmail: Refugees, Terror and other
troubles with the Neighbours, London: Penguin, 2016.
Borradori, Filosofia del terrore - Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques
Derrida, 23.
46
Intersezioni
Robinson Crusoe Julien Sorel
Mattia Pascal
Figure letterarie alla nascita
dell’antropologia moderna
Emilio Renzi
The development of modern anthropology seen through the analysis
of the three main characters of four great novels: Robinson Crusoe
in The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe
(1719) by Daniel Defoe and Robinson Crusoe in Vendredi ou la vie
sauvage of Michel Tournier (1967), Julien Sorel in Stendhal’s Le
Rouge et le Noir (1830), and Il fu Mattia Pascal by Luigi Pirandello
(1904). Defoe’s Crusoe is the solitary man who does not surrender to
his ship’s wreck on his way to the New World and builds his salvation
through ingenuity and the Bible: he is the prototype of the birth of
the working middle class. Tournier’s Robinson (1967) is the uneasy
survivor, in search of a new relationship with Nature. Julien Sorel is
the ambitious and endowed young man whom the post-Napoleonic
Restoration forces to choose between the two professions of obedience; the final tragedy shows society’s bottlenecks. Mattia Pascal endures a fictitious existence inside the bourgeois society at the beginning of the Twentieth century. Philosophical anthropology may well
take advantage of the expressive power of a literary phenomenology.
Figlio ribelle, marinaio, naufrago, mercante,
prototipo dell’uomo britannico
Qual è la forza interiore, o i sentimenti successivi, che consentono
al marinaio Robinson Crusoe di sopravvivere a un’esperienza di solitudine per 23 anni in un’isola disabitata, dalla natura non coltivata,
240 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
fuori dalle rotte di altre navi? perché un giovane marinaio senza studi
ma con una mente dalla capacità calcolatoria che lo porteranno a finire i suoi giorni come ricco mercante londinese, diventerà nella prosa
precisa di Daniel Defoe la matrice della nascita dell’uomo moderno, nella specie dell’uomo moderno inglese? Che è sinonimo stesso
di forza di carattere, ingegno, fede nella Bibbia come fonte pulsante
quotidiana.
Robinson Crusoe è anche un romanzo di formazione. Robinson
è in quanto si fa; e si fa nonostante le parole dissuasorie del padre e
le disavventure per mare. Robinson nasce al mondo con un profilo di
ribelle tenace, non scapigliato. Rompe con la morale della famiglia
perché ha sempre pensato di voler viaggiare per mare. Lo anima il
«desiderio di vedere il mondo»1. E il mondo in quel secolo può essere
percorso in lungo e in largo, pur tra i possibili naufragi; le compagnie
marittime attuano strategie di espansione globale.
Robinson Crusoe non è di questa squadra. La sua irrequietudine
viene dal profondo. Pensa che «la ragione non vale e che incongrua
e irragionevole è l’indole dell’uomo»2. Il padre aveva cercato di dissuaderlo: «il far fortuna con iniziative avventate e acquistare fama
con imprese fuori del comune toccava a uomini disperati o che hanno
l’ambizione di raggiungere posizioni superiori alla propria». E fa l’elogio della classe che «sta in mezzo», tra la classe alta e quella bassa3.
La prima uscita in mare del giovanissimo aspirante marinaio e
futuro esploratore del mondo Robinson Crusoe è ingloriosa: un naufragio ancora sottocosta a Londra. Il ragazzo non ha dato ascolto alle
parole di saggezza del padre: «Resta nella classe di mezzo». Nella
prima tempesta si rifiuta di vedere la mano della Provvidenza.
Si imbarca per un altro viaggio verso La Guinea. Viaggio fortunato e lucroso, che fa di lui un marinaio e un mercante4. I viaggi
successivi si interrompono drammaticamente.
La cattività in Africa, la fuga fortunosa, il naufragio fatale lo precipitano nella solitudine e penuria di tutto. La cesura con la madre
Daniel Defoe, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe,
tr. it. di Riccardo Mainardi, La vita e le straordinarie sorprendenti avventure di
Robinson Crusoe, Milano: Garzanti, 1976, 55.
2
Ivi, 15.
3
Ivi, 36.
4
Ivi, 17.
1
Emilio Renzi - Robinson Crusoe Julien Sorel Mattia Pascal 241
patria, le altri navi in improbabile transito, è netta come un colpo di
rasoio. La natura gli è ignota, le circostanze ostili a giro d’orizzonte.
Robinson è l’uomo che non si dispera e non dispera. La sua è una
analitica di un lavoro insieme di mani e di testa, di fatica e di ipotesi.
A bordo del relitto della nave naufragata recupera «la cassetta del carpentiere». Esclama: «bottino utilissimo per me, molto più prezioso, in
simili circostanze, di una nave carica d’oro»5.
Non è sempre così padrone di sé: piangendo chiede alla
Provvidenza perché conduce alla rovina le proprie stesse creature.
Alla Ragione fa rispondere: considera dove sono finiti gli altri della
nave, tu ti sei salvato anche se ignudo. In una fase dolorosa delle sue
giornate compila per darsi coraggio una tabella del Dare e dell’Avere;
la somma algebrica dice che si può e deve apportare ogni giorno miglioramenti alla situazione data.
L’ingegnosità è il sentiero che percorre ogni giorno: «col tempo ogni uomo può diventare padrone di qualsiasi arte meccanica»6,
anche dei fucili: con i quali, con astuzie tattiche e con una lettura di
riscoperta della Bibbia, respinge i selvaggi, i «cannibali» che hanno
fatto irruzione nell’isola.
Più tardi un’orma resta impressa su un tratto di sabbia; a dissolvere il terrore serviranno passi della Bibbia, a sciogliere il mistero
lo sbarco di selvaggi, ai cui banchetti omicidari un giovane sfugge
perché è più veloce. Quando vede Robinson che ha sparato per proteggerlo fa atto di sottomissione; si inginocchia e pone il piede di
Robinson sul suo capo. Robinson ha trovato il compagno e il servo:
lo battezza con nome di quel giorno, Venerdì.
Un galeone spagnolo approderà e li porterà in salvo, pur nella diffidenza del calvinista Robinson per i cattolici romani, le «grinfie dei
preti» e la loro Inquisizione. In Inghilterra Robinson diventerà quello
che in realtà è sempre stato: un abile mercante, una colonna della sua
famiglia, parrocchia, comunità nazionale. Il borghese europeo è nato.
Nasce sub specie Anglorum, britannica. Il borghese inglese è nato ed
nato coriaceo: tenace nella vita, designer efficace degli strumenti per
la sopravivenza, abile negli affari e a mandar navi per il mondo. A
fare profitti. Traendo forza dalla Bibbia.
5
6
Ivi, 53.
Ivi, 71 .
242 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Con il Robinson Crusoe nasce anche, o si rafforza, un grande prosatore e innovatore della letteratura inglese, romanziere di fortuna ma
anche libellista svelto di penna, giornalista dell’incendio di Londra:
Daniel Defoe. Nasce con Robinson una figura e un prototipo dell’uomo moderno: dal calvinismo inglese alla nascita del Romanticismo
europeo l’arco di divaricazione è enorme, senza però mai perdere di
vista la centralità dell’uomo, la caduta dei dogmi e delle regole religiose. Da un altro punto di vista Defoe vale per la vivacità con cui fa
entrare nella scena della letteratura europea le donne spregiudicate,
impavide: Moll Flanders, Lady Roxana. Lucide quanto basta (anzi
per la verità ad abundantiam) per coniugare efficacemente razionalità
e proprietà7
Un naufrago nella Natura, la Natura in un uomo
In un romanzo pubblicato nel 1967, quindi poco oltre due secoli e
mezzo dopo Defoe e dal titolo analogo, il romanziere francese Michel
Tournier rivede l’avventura di Robinson Crusoe8. In un mondo che
come succede da sempre è interamente cambiato, o forse è rimasto
sostanzialmente l’identico Purgatorio o Inferno in terra di sempre,
Robinson Crusoe diventa il protagonista ed eroe eponimo della trasformazione delle relazioni tra l’uomo e la natura.
L’uomo che si salva nella natura dell’isola lontana dalle rotte della civiltà commerciale – insomma la stessa scena descritta da Defoe
– è un marinaio di forte corporatura e di animo saldo, figlio della
cultura illuministica. Anch’egli si dedica a mettere in sicurezza una
grotta, a munirsi di strumenti e di armi. Traguarda pure lui lontano
Nell’immensa fortuna che ebbe e ancora oggi accompagna Robinson Crusoe
spiccano tre nomi. – Rousseau nell’Émile lo prescrisse come primo libro per i fanciulli. Kant se ne servì per criticare «l’illusoria raffigurazione dell’età dell’oro tanto
esaltata dai poeti… un’illusione che i Robinson e i viaggi verso le isole del Sud rendono così eccitante… (Inizio congetturale della storia degli uomini, 115, in Scritti
di storia, politica e diritto, a c. di F. Gonnelli, Roma-Bari: Laterza 2007. Marx cita
Robinson in Per la critica dell’economia politica, nel Capitale e nei Grundrisse. In
Robinson Marx vede un esempio della sua tesi fondamentale della teoria del valore
del lavoro.
8
Michel Tournier, Vendredi, ou la vie sauvage, Paris: Flammarion 1984, tr. it. di
Clara Lusignoli, Venerdì o il limbo del Pacifico, Torino: Einaudi, 1968.
7
Emilio Renzi - Robinson Crusoe Julien Sorel Mattia Pascal 243
nonostante le circostanze; scrive la Costituzione dell’Isola, e i regolamenti. Inflessibili contro i nemici. C’è del Robespierre in lui, ma non
c’è solo questo; a un certo momento nella solitudine chiede la prova
dell’esistenza di Dio; la risposta è l’apparizione di un magnifico arcobaleno. Si avvicina alla natura, se ne fa prendere, la sussume. Si
animalizza. Ha visioni del suo passato infantile, della sorellina Lucy;
si convince che solo il passato esiste. Comincia a tenere regolarmente
un log-book, di fatto un diario dell’anima. Intensifica la formulazione
delle istituzioni e le difese militari contro i selvaggi; al tempo stesso
libera le pulsioni inconsce.
Cerca l’identità segreta dell’isola così come cerca la propria; si
convince di essere un «io veggente». Figure femminili appaiono con
forza soprattutto quando con animo vertiginoso si immerge nel SENO
più inaccessibile dell’isola. Lascia che il suo seme scivoli nell’alveolo9. Si stende nudo su una quillaja, la sua sensualità si avventura in
una piccola cavità muscosa; e fino alla stagione delle piogge sarà una
relazione felice. Robinson pur esitante aveva seguito la via vegetale10. Un anno dopo scorge in quei punti piccole piante che prima non
esistevano; deve prendere atto che sono le prove o conseguenze delle
sue effusioni.
L’araucano che sopravvive al fuoco con cui Robinson respinge un
attacco dei selvaggi viene adottato e chiamato Venerdì. Venerdì man
mano cresce come una forza alternativa capace di avere anch’egli un
suo proprio rapporto con la Natura. La Bibbia non basta più a suggerire a Robinson come Venerdì deve comportarsi. Non lo domina più.
Una metamorfosi prende avvio, i due uomini si identificano sempre più nelle forze primordiali della Terra: Urano, Venere. Nella mitologia classica Venerdì è il giorno di Venere. La dura replica del reale
non si fa attendere: una goletta appare all’orizzonte. Il capitano dirige
la manovra, scende a terra, «sarà il primo di tutto il consorzio umano
che avvolgendo Robinson in una rete di parole e di gesti, lo avrebbe fatto rientrare nel grande sistema»11. Ventotto anni e poco più dal
naufragio.
A bordo della nuova nave Robinson trova, o meglio ritrova, materialità, gesti brutali, discorsi di avidità. Tornerà nell’isola. Nella notte
9
Ivi, 111.
Ivi, 118.
11
Ivi, 187.
10
244 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Venerdì è scomparso; sarà visto andarsene con i suoi nuovi amici, o
compari in affari.
Ventotto anni di solitudine tornano interi sulle sue spalle, e pesanti. Deve ricominciare ma non ne ha più voglia né forze. Cercherà
nella natura una tomba che protegga la sua salma, il suo scheletro
dagli avvoltoi. La vita ha perso, la vita ha vinto se e in quanto la riconosciamo come Natura primigenia, eterna, da saper cogliere anche
nella quotidianità, e nella solitudine di un’isola deserta. La rocciosa
figura dell’ingegnoso Robinson Crusoe anglo-protestante, marinaio e
mercante, che alla fine supera e ingloba ogni ostacolo ossia «vincente» come si potrebbe dire con un lessico da fine Novecento, diventa
ora la mobile, fluttuante figura dell’uomo francese che ha alle spalle Rousseau. Il primato dell’isola, o dell’ambiente ossia dell’ecologia, avvolge il Robinson di Tournier, è a dire l’antropologia di fine
Novecento/primo Millennio.
Un giovane ambizioso e due donne innamorate
nella Francia che ha perso Napoleone
La metaforica isola in cui naufraga la giovinezza di Julien Sorel, francese di umile nascita, si chiama «Società». Una società precisa: quella
francese della Restaurazione. L’anno è il 1830, il regno dei ritornati
Borboni è prossimo alla fine e sta per cedere il potere al più borghese
regime di Luigi Filippo d’Orléans; ma questo lo sappiamo noi ora.
Julien Sorel morirà prima e non lo saprà; proverà però sino a ogni
più intima fibra le sferze di quel potere, la morale dominante, la presa
sulle anime di una restaurazione che è anche dei Gesuiti.
Il padre di Julien è un carpentiere povero e brutale del paese di
Verrières nella Franca Contea ma il figlio è determinato a una libertà
che non sa ancora bene cosa sia. In ogni caso è intelligente. In seminario apprende benissimo il latino e al tempo stesso impara la pratica
della dissimulazione per sopravvivere a un groviglio di finzioni e inganni reciproci.
Julien ha un idolo: Napoleone. Il córso che da sé si è fatto
Imperatore e che ha portato una generazione di francesi a battersi in
ogni paese d’Europa. Nascostamente Julien legge i suoi libri preferiti:
il Memoriale di Sant’Elena, la raccolta dei bollettini della Grande
Emilio Renzi - Robinson Crusoe Julien Sorel Mattia Pascal 245
Armée, le Confessioni di Rousseau. L’insieme era «il suo Corano»12
Dopo Napoleone nient’altro che corruzione e meschinità. In quei libri Julien trova la rappresentazione dell’energia vitale che costituisce l’essenza della sua concezione della vita e che assolutamente non
vede più intorno a sé. Vedrà che la società gli lascia solo il mestiere
delle armi ossia Il Rosso; oppure la vita dell’obbedienza ossia Il Nero
delle tonache, dell’ipocrisia. Da qui il titolo del romanzo di Stendhal,
sottotitolo Cronaca del XIX secolo.
Il sindaco del paese, Monsieur de Rênal, lo vuole nella sua ricca
casa come precettore dei bambini. Julien è anche bello: non l’aria
virile che ci si aspetterebbe, ma lineamenti quasi femminei, capaci di
rapidamente indurirsi. La bellezza della moglie e padrona di casa ha
il soffuso fascino di una giovane signora che non ha letto troppi libri
e non sa fare calcoli. Julien la corteggia, la seduce: ha vinto la sua
prima battaglia.
La situazione diventa insostenibile; Julien è ributtato dalla parte
del Nero. A Besançon si segnala nell’ambiente ecclesiastico e un signore della città lo assume come segretario.
In casa domina la figlia, Mathilde. I suoi molti corteggiatori vedono nell’intruso un domestico elevato a un rango superiore ma non
avvertono che il giovane segretario nell’intimo è proteso a ideali di
potenza perché sa di avere padronanza di sé. Mathilde è altera prima
ancora di essere bella: sarà lei a sedurre Julien.
Lei è incinta, il padre alla fine dà l’assenso e procura a Julien il
titolo di ufficiale e cavaliere; ma Madame di Rênal in una lettera ispirata da trame ecclesiastiche descrive il giovane come avido e sfruttatore di donne. Julien cavalca nella notte e arriva a Verrières il mattino
dopo: per prima cosa entra nella bottega dell’armaiolo.
La pistolettata non è mortale e tuttavia la ghigliottina non gli sarà
risparmiata. Nell’ultima autodifesa Julien Sorel rivendica la premeditazione, conserva e anzi eccita il proprio orgoglio e il senso storico
della sua esistenza. Alla giuria: «vedo qui uomini che vorranno punire
in me e scoraggiare per sempre quella categoria di giovani che, nati in
un ceto inferiore, e in qualche modo oppressi dalla povertà, hanno la
fortuna di procurarsi una buona istruzione, e l’audacia di mescolarsi a
quella che l’orgoglio dei ricchi chiama la buona società.
Stendhal, Il rosso e il nero. Cronaca del XX secolo, tr. it. di Margherita Botto,
Torino: Einaudi, 2014. L’opera apparve a Parigi nel 1831.
12
246 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
«Ecco il mio crimine, signori, e sarà punito ancor più severamente in quanto, di fatto, io non sono giudicato da miei pari. Non vedo
sui banchi dei giurati nessun contadino arricchito, ma solo borghesi
indignati»13.
Alle due donne è concesso di visitare in carcere Julien; Julien
sceglie l’amore-passione della di Rênal. Il Romanticismo ha vinto la
sua battaglia culturale.
Infine noi oggi sappiamo da quale parte sarebbe stato Julien Sorel
nelle barricate del 1848. La rivolta morale personale si sarà fatta rivolta sociale: della e nella società che pur tra mille ostacoli comincia
ad assaporare la nascita del liberalismo europeo14.
Tre vite fittizie. E il Caso
È sballottata invece dal Caso cui vanamente cercherà di contrapporre
la Logica, la vita smarrita di Mattia Pascal15.
Nato in un paese nel Piemonte, Mattia Pascal trova in casa e
poi eredita un relativo benessere che nei primi anni gli permette di
non lavorare. Luigi Pirandello non assegna al romanzo Il fu Mattia
Pascal (1904) un anno preciso: da qualche indizio siamo agli inizi
del Novecento o fine Ottocento. I compaesani sono piccolo-borghesi,
artigiani, possidenti locali.
In una qualche sconnessa maniera il Caso porta Mattia Pascal a
conoscere e a sposare una donna che viene da una famiglia litigiosa
e sottilmente avida. In difficoltà economiche e casualmente, diventa
bibliotecario in una piccola, storica e da tutti obliata raccolta di libri,
ricchi forse di valore bibliografico certamente di polvere.
13
Ivi, 523.
Mario Bonfantini, Stendhal e il realismo. Saggi sul romanzo ottocentesco, II
ediz. Napoli: ESI, 1968, 124. Sintetizza Bonfantini : «l’aspro sapore, il duro realismo e la linearità del Rouge et le Noir», e ricorda che Stendhal quando scriverà
il Lucien Leuwen appunterà «Tu es un réaliste. Tu ne sais jamais inventer rien. Tu
prends toujors for love Dominique et Métilde” , ivi, 125. e che a Stendhal si devono
due memorabili aforismi: «un romanzo è uno specchio trasportato lungo una strada
maestra», ivi, 388, e: «la politica mescolata all’immaginazione è un colpo di pistola
nel bel mezzo di un concerto», ivi, 410.
15
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, a c. di Giancarlo Mazzacurati, Torino:
Einaudi 1993 e 2014.
14
Emilio Renzi - Robinson Crusoe Julien Sorel Mattia Pascal 247
L’atmosfera in casa non è però serena: dopo un litigio Mattia
Pascal se ne va senza una meta precisa e con poco denaro in tasca. Il
Caso lo porta a salire sul treno per Marsiglia, pensando all’America:
scende invece a Montecarlo. Entra nel Casino: prima perde poi vince
poi perde di nuovo poi di nuovo vince; alla fine ne esce con una somma notevole. La roulette ha deciso per lui.
Quando tornando a casa legge nel giornale locale che è stato rinvenuto un suicida che per gli investigatori e il paese è Mattia Pascal,
tira le somme. Si sente superstite di se stesso: decide, lui stavolta, di
stare al gioco. Assumere un altro nome, un’altra personalità, essere
un’altra persona. Se ne andrà dal piccolo mondo odioso e odiato per
vivere libero dove vorrà. Sarà, è, Adriano Meis («suona bene»). Non
deve rispondere a nessuno né ad alcuna autorità: libertà assoluta. La
nuova città è Roma.
L’ebrietà non può però nascondergli che in un breve volger di
tempo si deve accorgere che senza l’identità conferita dalla stato civile non può fare nulla: già affittare una camera è un’impresa. Di
più: «la vita che m’ero veduta dinanzi libera», altro non era se non
«più schiava che mai, schiava delle finzioni, delle menzogne ch’era
costretto a usare, schiava del timore d’esser scoperto, pur senza aver
commesso alcun delitto»16.
Mette allora in atto il secondo suicidio, quello di Adriano Meis, e
straordinario redivivo si ripresenta nel paese e in casa. Dove scopre
che la moglie si è risposata con un altro uomo, per di più un suo maligno nemico; e che in tal caso secondo il codice il nuovo matrimonio non è valido; deve riprendersi la già moglie (e in vana ribellione
esclama: «Questa è legge turca!»17).
Dal garbuglio in cui più Casi si intrecciano anche in lunghe serate
spiritiche, si elidono e si urtano a fronte della realtà in cui la donna nel
frattempo ha avuto un’altra bambina, Mattia Pascal, tornato comunque persona,18 esce alla fine con una terza fuga in avanti: rinuncia se
non a tutto a molto e rimette piede nell’antica biblioteca. «Come già
fuori della vita» 19, scriverà le sue vicende: Pirandello gli assegna il
16
18
19
17
Ivi, 213
Ivi, 259
Ivi, 271, nota
Ivi, 11
248 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
discorso diretto in prima persona, non più la narrazione in terza persona come in quasi tutta la letteratura mondiale sino ad allora.
Al curioso che gli chiede, «si può sapere chi siete», risponde: «Io
sono il fu Mattia Pascal»20.
Pirandello esercita magistralmente l’umorismo in una prosa in cui
le contrapposizioni dialettiche si alternano sino a rasentare le sofisticherie, senza mai cadervi. È che la borghesia minuta da cui attinge
personaggi, comprimari e sfondo, non ha ideali o obiettivi di sorta che
non siano la proprietà senza gusto, sentimenti senza grandezza, animi
rosi dall’invidia, velleitarismi.
Mattia Pascal appartiene alla famiglia dei grandi «uomini senza
qualità» (alcuni, certo, più colti e più profilati di lui): inadatti alla vita,
forse inetti, dalla volontà minata dal profondo ingovernabile. È che in
maniera più o meno diretta l’Inconscio di Freud sta penetrando nella
coscienza e nella letteratura europee (nel caso di Pirandello, pare che
non conoscesse la psicoanalisi; ma era nell’aria)21.
L’uomo moderno si affaccia ed entra nel secolo XX tra spinte
di contrastati generi e drammatici esiti, sino all’Olocausto d’Europa
nella seconda guerra mondiale22.
20
Ivi, 280 – Così magistralmente Leonardo Sciascia. «Una delle poche cose, anzi
forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal….
Avrebbe potuto dire (e sono parole di Blaise Pascal): “Io non so né perché venni al
mondo né come, né cosa sia al mondo, né cosa io stesso mi sia. E s’io corro ad investigarlo, mi ritorno confuso d’una ignoranza sempre più spaventosa…”» (Leonardo
Sciascia, Alfabeto pirandelliano, Milano: Adelphi 1989, 53.
21
L’allusione, come è chiaro, è a Robert Musil, a Una vita e alla Coscienza di Zeno
di Italo Svevo; e si potrebbe continuare.
22
Il presente saggio è parte di una ricerca sul concetto di Persona. Tra le fonti
emerge il fondamentale saggio di Ernst Cassirer, Saggio sull’uomo. Introduzione a
una filosofia della cultura, a c. di M. Ghilardi, Mimesis: Milano, 2011. Scrive Ernst
Cassirer: «La principale caratteristica dell’uomo non è la sua natura fisica o metafisica, bensì la sua opera. È quest’opera, è il sistema delle attività umane a definire e
determinare la sfera della “umanità”. Così una “filosofia dell’uomo” dovrebbe essere
una filosofia che faccia conoscere a fondo la struttura fondamentale di ognuna delle
attività umane» (101). Inoltre: «La filosofia non dimentica le tensioni e gli attriti, i
forti contrasti e i profondi conflitti fra le varie facoltà dell’’uomo… ognuna dischiude un nuovo orizzonte e mostra un nuovo aspetto dell’umanità. Il dissonante è in
armonia con se stesso; i contrari non si escludono a vicenda ma dipendono l’uno
dall’altro: “armonia nel contrasto, come nell’arco e nella lira” (Eraclito, Diels, fr. 54)
(292-293)».
Il “barbaro” spartano
Identità culturale e polemica antispartana
nell’Andromaca di Euripide
Daniela Canavero
L’identità culturale di un popolo, oggi come in passato, viene a definirsi anche attraverso il confronto con il diverso; indipendentemente
dalle ragioni che suscitino la riflessione sul rapporto di somiglianza,
o di differenza, rispetto a chi e cosa viene individuato come “altro”, e
dai livelli a cui tale riflessione si svolga, l’affermazione e il riconoscimento di sé discendono dal (ri)valutare la propria, stessa, percezione
rispetto alla percezione che si ha, appunto, del diverso da sé. In linea
generale, nel mondo antico come in quello moderno, il punto di vista
di un popolo su un altro, e in particolare gli stereotipi etnici formulati
all’interno di una comunità, rivelano molto del gruppo che osserva e
definisce, assai meno contribuiscono a delineare la reale identità del
gruppo osservato e definito.
Nel corso del V secolo a.C., i crescenti interessi dell’Impero persiano verso il mondo greco ebbero, tra le altre, la conseguenza di
innalzare il livello di autocoscienza degli abitanti delle diverse poleis; ciò, più ampiamente, portò a rinsaldare e stabilire l’idea di una
polarità tra Greci e non-Greci, ovvero tra Greci e Barbari. In questo
processo di definizione del barbaro come non-greco e, quindi, opposto al greco, il teatro attico - quello tragico nello specifico - ebbe un
ruolo indubbio1. Risulta per altro una coincidenza non priva di suggestione che la più antica tragedia giunta a noi integra abbia a tema
proprio il confronto tra Greci e Barbari: i Persiani di Eschilo (472
Edith Hall: Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy,
Oxford: Oxford University Press, 1989, 1-13, per l’impostazione della prospettiva.
1
250 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
a.C.), attraverso la rievocazione della sconfitta di Serse a Salamina,
testimoniano infatti una delle prime riflessioni su tale opposizione,
celebrando la superiorità di uomini che, liberi, lottano per difendere
la propria indipendenza rispetto a sudditi che combattono asserviti
all’obbedienza di un sovrano assoluto.
La costruzione e la diffusione dell’idea del persiano-barbaro
come anti-greco si ritrova del resto anche nelle tragedie di argomento
mitico, dove si assiste all’attribuzione di comportamenti e caratteristiche contrari alla morale e all’etica greca a personaggi di origine
straniera, e in particolare troiana. Incesto, omicidi famigliari, sacrifici
umani non sono certo estranei al mito greco, ma diventano stereotipi
attribuiti al barbaro, cui si aggiungono accuse, per così dire, più tradizionalmente rivolte al mondo orientale, come quelle di corruzione,
sfrenatezza (soprattutto sessuale), codardia, disonestà, eccessivo desiderio di lusso e ricchezza, solo per limitarsi a qualche esempio2. Una
significativa eccezione ai contenuti e alle associazioni di tale polarità
è costituita dall’Andromaca di Euripide3.
Scritta molto probabilmente nei primi anni della guerra del
Peloponneso4, l’Andromaca ha una trama di invenzione euripidea, in
cui eventi e personaggi della tradizione sono intrecciati e combinati
in modo da creare una vicenda originale.
L’ambientazione è nei pressi di Ftia, dove regna Neottolemo,
il figlio di Achille, cui Andromaca, che ne è la schiava di guerra e
concubina, ha generato un figlio; Ermione è la moglie legittima di
Neottolemo, è sterile e ritiene Andromaca responsabile della sua sterilità. Neottolemo si è recato presso il santuario di Delfi per espiare la
colpa di avere in passato preteso giustizia da Apollo per l’uccisione
del padre Achille. Approfittando dell’assenza del marito e confidando nell’aiuto del padre Menelao (giunto appositamente da Sparta),
2
Su questo processo di “ingresso” del barbaro nel mito tragico, si veda Hall, cit.,
101-159.
3
Per la presenza di personaggi troiani che emergono come superiori rispetto ai
personaggi greci, evidentemente soggetti agli eccessi tipici dei barbari, si devono
ricordare anche i casi, sempre euripidei, dell’Ecuba e delle Troiane.
4
Questa l’indicazione riportata dallo scolio al v. 445; la critica moderna, sulla
base di indagini metrico-stilistiche propone una datazione tra il 428 e il 422, con
buona ragionevolezza si può pensare ad un anno intorno al 425 a.C. (così ad es. Philip
Theodore Stevens in Euripides Andromache (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1971,
15-19).
Daniela Canavero - Il “barbaro” spartano 251
Ermione ha deciso di uccidere Andromaca e il figlio che ha avuto da
Neottolemo.
La tragedia si apre con Andromaca, supplice presso l’altare di
Teti, che prova a resistere e a difendersi dalle accuse di Ermione, ma
decide di rinunciare alla propria salvezza quando scopre che Menelao
ha catturato il suo bambino e la ricatta proponendole di sacrificarsi
al posto del figlio. Lasciato il santuario, Andromaca scopre di essere
stata ingannata, poiché sarà Ermione a decidere la sorte del bambino;
giunge in suo soccorso Peleo, l’anziano padre di Achille e nonno di
Neottolemo, che riesce con la propria autorità ad allontanare Menelao.
Ermione, temendo la reazione del marito, tenta il suicidio ma è interrotta dall’arrivo di Oreste, suo antico promesso sposo, giunto a rivendicare il proprio diritto sulla donna. Oreste assicura di aver organizzato un agguato contro Neottolemo e conduce via con sé Ermione.
Arriva infatti un messaggero da Delfi che racconta a Peleo l’uccisione
di Neottolemo presso Delfi. La tragedia si chiude con l’apparizione ex
machina di Teti che predice un futuro felice per Andromaca, che sarà
sposa di Eleno, nuovo re dei Molossi, su cui regnerà anche il figlio di
Andromaca e Neottolemo, e per Peleo, che, dopo aver seppellito il nipote Neottolemo, diverrà immortale, potendo così vivere per sempre
insieme al figlio Achille e alla stessa sposa Teti.
La tragedia è dunque costruita sul contrasto tra due figure femminili, in relazione al personaggio di Neottolemo, che comparirà, cadavere, solo in chiusura: Andromaca, troiana, ne è la prigioniera di guerra e concubina, Ermione, spartana, la legittima moglie. Lo scontro
tra le due donne occupa la prima parte del dramma e l’opposizione,
oltre che dalla trama della vicenda, viene attentamente costruita da
Euripide nella presentazione e nella caratterizzazione dei personaggi5.
La prima menzione di Ermione è affidata ad Andromaca che nel
prologo, dopo aver ripercorso le proprie infelici vicende a Troia, la
definisce “la spartana” (v. 29); quando etra in scena, in apertura del
primo episodio, Ermione è riccamente vestita e ingioiellata - come
lo sarà la madre Elena, circa 10 anni dopo in un’altra tragedia di
5
Sulla natura conflittuale del rapporto tra Andromaca ed Ermione si veda la lettura di Franca Perusino: “Andromaca, l’anti-Medea?”, Dioniso, 4 (n.s.), 2014, 53-63,
in pt. 55-59.
252 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Euripide, le Troiane6 - , descrive il diadema d’oro e le vesti policrome
che indossa, che, precisa, non provengono dalla casa di Achille e di
Peleo, ma sono vesti e gioielli spartani, dono del padre Menelao, che
la autorizzano alla libertà di parola. L’attenzione posta alla ricchezza dell’abbigliamento non è di certo casuale: da una lato, a livello
drammaturgico, evidenzia visivamente la differenza tra la padrona
Ermione e la schiava Andromaca, che in effetti proprio nei primi versi
del prologo aveva ricordato la ricca dote con cui un tempo era giunta
a Troia da Tebe. L’abbigliamento sfarzoso è un tratto tipicamente associato ai barbari; che sia per così dire “traslato” e messo in evidenza
su un personaggio spartano è perciò rilevante e, vedremo, funzionale
alla messa in discussione della validità dei valori spartani7, che trovavano un importante mezzo di trasmissione dell’ideale di uguaglianza
sociale anche nei vestiti8. Sempre nel confronto tra Andromaca ed
Ermione nel primo episodio, rivolgendosi ad Andromaca, la spartana
le ricorda il suo stato di prigioniera di guerra, e indica una serie di
compiti cui dovrebbe adempiere, in quanto schiava, tra cui (oltre a
strisciarle ai piedi e a spazzarle la casa) versare acqua dalle brocche
d’oro che possiede; ricorda inoltre che Ettore e Priamo sono morti
e che anche le loro ricchezze non esistono più: ormai Andromaca si
trova in una città greca (v. 169). Fin dall’inizio del dramma, all’opposizione tra Andromaca ed Ermione, si associa dunque anche l’opposizione Troia/Sparta, con i corollari schiavitù/libertà - Andromaca
è schiava, Ermione ne è la padrona- e povertà/ricchezza - Andromaca
non ha nulla, Ermione è ricca e ostenta ricchezza9. Entrambe le donne
6
L’entrata in scena di Elena elegantemente vestita e ingioiellata (come si evince
dalle osservazioni di Ecuba ai vv. 1022-1028) è per di più in notevole e provocatorio
contrasto con la sua condizione di prigioniera di guerra; sempre nelle Troiane, Ecuba
rinfaccia ad Elena di essere rimasta affascinata dalle ricche vesti di Paride (v. 991).
7
In questo senso si vedano anche le osservazioni di Luigi Battezzato, “Dorian
Dress in Greek Tragedy”, Illinois Classical Studies, 24-25, 1999-2000, 343-362, in
pt. 355-359.
8
A puro titolo si esempio si vedano Xen. Lac. Pol. 7, 3 e Plut. Agis, 4, 2. Più in
generale sul tema Ephraim David, “Dress in Spartan Society”, Ancient World, 19,
1989, 3-13.
9
Il vanto spartano per la ricchezza è motivo tradizionale di accusa; viene, ad
esempio, ricordato indirettamente nell’epitaffio di Pericle per i caduti del primo anno
di guerra, quando sono richiamate le qualità degli Ateniesi in confronto, più o meno
esplicito, con quelle degli avversari Spartani: “Usiamo la ricchezza più come occasione per agire che per vantarcene a parole” (Tuc. II, 40).
Daniela Canavero - Il “barbaro” spartano 253
del resto si identificano e si riconoscono reciprocamente come rappresentanti della città di origine10 (o di adozione nel caso di Andromaca,
di per sé nata a Tebe d’Asia).
L’opposizione si amplia e raggiunge il culmine nel secondo episodio, quando Andromaca pronuncia una famosa invettiva contro
Sparta (vv. 445-463): lasciato l’altare di Teti, per sacrificarsi al posto
del figlio, scopre di essere stata ingannata da Menelao, che dichiara
di volerla uccidere e di lasciare comunque a Ermione la decisione se
dare la morte anche al bambino.
Voi, Spartani, la razza più odiosa del mondo, consiglieri di frode, principi di menzogna, tessitori di trame perverse, tortuosi, obliqui in ogni
pensiero, mai limpidi, e così fortunati in Grecia. Oh, le avete proprio
tutte! Pluriomicidi, avidi di denaro, dite una cosa e ne avete in mente
un’altra, sempre: i fatti lo dimostrano.
Crepate. Non mi pesa morire, come credi tu. Io sono morta tanto tempo fa quando venne espugnata l’infelice città dei Frigi e fu ucciso mio
marito, un eroe famoso, che più volte ti costrinse a cercare rifugio sulle
navi, a abbandonare il campo di battaglia. Ma ora sì che dispieghi interamente il tuo straordinario valore, di fronte a una donna: su, uccidimi,
falla finita. Non crederai che mi pieghi a adulare te e tua figlia. Sì, tu sei
grande a Sparta, ma io lo ero a Troia. Se la mia situazione è ora disperata, non vantartene: potrebbe toccare anche a te, un giorno. vv. 445-463
(trad. Albini)
Andromaca è condotta fuori e segue quindi lo stasimo.
La generalizzazione dell’attacco e il riferimento alla buona sorte
di Sparta vanno evidentemente oltre i limiti della finzione teatrale,
ed è quindi chiaro che si tratta di una riflessione metateatrale11. La
polemica antispartana prende per un breve tratto il sopravvento sul10
Già nella parodo il coro di donne di Ftia nota la sproporzione del contrasto tra
Andromaca ed Ermione: “Riconosci il destino che ti attende, valuta le tue disgrazie.
Una Troiana si misura coi re di Sparta, nati a Sparta?” (vv. 126-128).
11
In generale sulla rappresentazione di Sparta nella tragedia euripidea, anche in
relazione alla realtà storica, cfr. William Poole, “Euripides and Sparta”, in Anton
Powell – Stephen Hodkinson, cur.: The Shadow of Sparta, London – New York:
Routledge, 1994, 1-33, su questi versi in pt. 7 e 9.
254 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
la vicenda rappresentata e diviene generale; nella seconda parte del
discorso, dopo il violento “crepate”, l’accusa ritorna più pertinente
alla situazione del dramma e al caso specifico di Andromaca, che evidenzia la viltà di Menelao e rivendica la propria passata grandezza a
Troia in opposizione all’attuale superiorità del re di Sparta.
Le prime accuse di Andromaca che, come in parte si è già accennato, vanno a riprendere una serie di motivi antispartani frequenti in
autori ateniesi durante la guerra del Peloponneso, sono concentrate
essenzialmente su tre punti:
–– gli Spartani sono falsi, menzogneri, ingannatori (consiglieri di
frode, principi di menzogna, tessitori di trame perverse, tortuosi,
obliqui in ogni pensiero, mai limpidi … dite una cosa e ne avete
in mente un’altra, sempre);
–– gli Spartani sono degli assassini (Pluriomicidi);
–– gli Spartani sono avidi di guadagno (avidi di denaro)
e tuttavia ottengono una buona sorte (così ingiustamente fortunati in
Grecia).
Le accuse seguenti, che Andromaca rivolge direttamente a
Menelao, calano nella situazione tragica queste accuse, esemplificandole, ma al tempo stesso evidenziando per contrasto, e per opposizione a quella degli Spartani, la figura di Andromaca:
–– accusa di essere omicidi: Menelao sta per uccidere Andromaca
(e verosimilmente Ermione ne ucciderà anche il figlio), ma
Andromaca non ha paura di morire perché è già morta da tempo,
quando fu espugnata Troia e ucciso Ettore; la donna incita anzi
Menelao ad ucciderla (Non mi pesa morire, come credi tu. Io sono
morta tanto tempo fa quando venne espugnata l’infelice città dei
Frigi e fu ucciso mio marito … su, uccidimi, falla finita);
(parentesi sulla codardia e viltà di Menelao, argomento in seguito utilizzato anche da Peleo);
–– accusa di essere menzogneri: Andromaca non intende piegarsi ad
adulare Menelao ed Ermione, non userà dunque la sua lingua per
Daniela Canavero - Il “barbaro” spartano 255
dire cose che non pensa, per quanto potrebbe esserle utile (Non
crederai che mi pieghi a adulare te e tua figlia12).
La conclusione ribadisce infine esplicitamente l’opposizione
Troia/Sparta: Sì, tu sei grande a Sparta, ma io lo ero a Troia.
L’ampliamento della prospettiva nell’invettiva, che da accuse
più generali torna in chiusura alla dimensione drammaturgica, veicola dunque la polemica antispartana attraverso la rappresentazione
dei personaggi della tragedia, in particolare nella loro opposta caratterizzazione. Tuttavia questa opposizione tra Sparta e Troia non si
sviluppa nell’associazione che ci si potrebbe attendere: Troia-barbari
/ Sparta-greci, Troia-nemici / Sparta-amici. Sparta, nonostante i tentativi di esaltazione da parte di Ermione prima e di Menelao poi, non
rappresenta nel dramma “la città greca”, il contraltare positivo alla
negatività della terra d’Asia.
Vi è infatti una terza città, un terzo luogo, nell’Andromaca che
viene scelto come rappresentativo della Grecia, intesa come la Grecia
giusta ed onesta, ed è il luogo in cui si svolge l’azione: la patria di
Peleo e Neottolemo.
Come accennato, la prima a provare ad introdurre il tema del
barbaro in opposizione alla grecità è Ermione, la quale ricorda ad
Andromaca che si trova in una città greca, dove comportamenti barbari non sono ammessi (vv. 169-18013 e v. 244). E’ però soprattutto
Menelao ad insistere sul fatto che Andromaca sia una donna barbara,
soprattutto nel terzo episodio, durante il contrasto con Peleo che, invece, la difende e attacca piuttosto e mette in discussione i presunti
valori di Sparta, a partire da una dura accusa di viltà e debolezza
rivolta a Menelao, re spartano. Al termine del confronto da cui esce
sconfitto, infatti, Menelao se ne andrà piuttosto sbrigativamente,
dando così conferma a queste accuse di vigliaccheria. (vv. 729-739).
Nella seconda invettiva metateatrale del dramma, sempre contro
Sparta, e in questo caso pronunciata da Peleo, il punto di partenza è
una riflessione sull’infedeltà di Elena, da cui si giunge a generalizzare
12
In greco l’espressione letteralmente suona “lascerò andare via te non adulato
dalla mia lingua, e tua figlia” (v. 460) con la ripresa dello stesso termine γλῶσσα,
lingua, impiegato prima “dite una cosa con la lingua ma ne pensate un’altra” (v. 452).
13
Il riferimento in particolare è alla promiscuità di abitudini sessuali orientali per
cui i padri si accoppiano con le figlie, le madri con i figli, i fratelli con le sorelle senza
che vi siano leggi a vietarlo: Andromaca, ricorda Ermione, ha generato un bambino
al figlio di chi le ha ucciso il marito.
256 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
sull’impossibilità che le donne spartane possano essere caste: “Se ne
vanno fuori casa discinte, a cosce nude, con dei giovanotti, frequentano insieme stadi e palestre, una cosa intollerabile per me. E poi vi
stupite se non crescono oneste?” (vv. 590 segg.). Il riferimento all’attualità è indice di una osservazione che va oltre la rappresentazione
scenica14 e che, comunque, pare ribattere a distanza alle accuse sulla
licenziosità delle abitudini sessuali barbare avanzate poco prima da
Ermione contro Andromaca.
Il discorso di Menelao si sviluppa, come accennato, a partire dalla sola considerazione che Andromaca sia una barbara (v. 649), che
quindi sia inferiore e debba perciò morire insieme al figlio, per evitare
che dei barbari possano governare sui Greci: “Supponi che Ermione
non abbia figli e Andromaca sì: li installerai sul trono di Ftia? Degli
autentici barbari comanderanno sui Greci?” (vv. 663-666). E’ un
punto di vista tradizionale, per cui, nel difendere la propria stirpe,
nella figura della figlia Ermione, viene sostenuta la superiorità della
razza greca, ovvero spartana, su quella barbara. La replica di Peleo,
che in effetti si preoccupa anche della necessità che pure la propria
stirpe prosegua, parte dalla messa in discussione di questa opposizione: la prima esclamazione al termine delle parole di Menelao è
infatti “Ah, che idee sbagliate abbiamo in Grecia!” (v. 693); già in
precedenza si era appellato a valori universali per cui “molti bastardi sono superiori ai figli legittimi” (v. 638), aveva invitato Menelao
a riprendersi Ermione perché “è meglio acquisire come congiunto e
amico un individuo povero e onesto che non un essere malvagio e
ricco15” (vv. 639-641).
Particolarmente significative sono le parole con cui conclude il
contrasto con Menelao, mentre libera Andromaca e il figlio: rivolgendosi al bambino dice “Penserò io ad allevarti a Ftia come un nemico
implacabile per questa gentaglia. Spartani! Ma se vi tolgono la fama
militare e la pratica di guerra, voi non siete superiori a nessuno, in
niente. Sappiatelo bene!” (vv. 723-726). Più che la convenzionale (e
14
La polemica sull’educazione femminile a Sparta e la conseguente licenziosità
delle abitudini è peraltro tema presente in diversi autori già dal VI sec.; come osserva
Vittorio Citti: Tragedia e lotta di classe in Grecia, Napoli: Liguori editore, 1978,
148 “i motivi che ispirano questa invettiva sono interamente desunti dal modello
ideologico della donna ateniese”.
15
Si può notare inoltre il richiamo alla ricchezza come elemento negativo, associato qui alla malvagità.
Daniela Canavero - Il “barbaro” spartano 257
ancora metateatrale) discussione sull’effettivo valore della gloria militare spartana, in riferimento al contrasto Troia/Sparta barbari/greci
è interessante la promessa di Peleo di allevare il figlio di Andromaca
a Ftia come nemico degli Spartani: il figlio di una barbara, allevato a
Ftia, sarà nemico degli Spartani (e ovviamente superiore ad essi). Una
soluzione o – meglio - una nuova definizione di importanza di stirpi
che sarà poi sancita da Teti nel finale: “Non possono perire né la mia
né la tua stirpe e neppure quella di Troia” (vv. 1249-1251).
La trama di opposizioni Troia/Sparta che è possibile individuare nella tragedia e che si concretizza nelle figure di Andromaca ed
Ermione, opposte e in contrasto tra di loro, trova dunque soluzione con la scelta da parte di Peleo di inserire nella propria stirpe una
straniera barbara, invece che una donna spartana, una decisione che
decreta definitivamente la negatività e l’inferiorità di Sparta e che,
inoltre, ottiene l’approvazione divina.
Ermione è esclusa poiché manifestamente non incarna l’ideale
della donna onesta e della moglie rispettosa: non solo si presenta in
scena in abiti lussuosi e se ne vanta, “come duna barbara”, si potrebbe
dire, ma è odiata e rifiutata dal marito perché non possiede le virtù che
dovrebbe. Nel primo incontro con Andromaca, la figlia di Menelao
la accusa di volersi sostituire a lei e, per questo, di averla resa sterile
e invisa al marito, utilizzando filtri, come ogni donna asiatica è in
grado di fare (vv. 155-160)16. L’abilità nelle arti magiche è un altro
stereotipo tradizionalmente attribuito alle donne orientali17, ma, anche in questo caso, è l’evidenza della rappresentazione a dare ragione
alla replica di Andromaca che individua nell’incapacità di adattarsi
e adeguarsi allo sposo la vera sterilità di Ermione (vv. 205-212). Al
contrario, Andromaca risulta non solo l’incarnazione della moglie
ideale e devota, oltre che della madre, caratteristiche già proprie del
personaggio omerico18, ma dimostra nei fatti di essere stata capace di
16
Già nel prologo, ai vv. 32-35, Andromaca aveva riportato i termini della stessa
accusa.
17
Si tratta di una convinzione popolare piuttosto radicata; per limitarsi all’ambito
teatrale si può ricordare il caso della Medea euripidea, in cui la protagonista utilizza
le proprie conoscenze a danno della rivale; riguardo alla sterilità Medea dichiara a
Egeo di conoscere filtri in grado di farla cessare (vv. 717-718).
18
Nell’Iliade infatti Andromaca è definita sposa (di Ettore) e appare madre insieme
al figlio Astianatte. Per una analisi della caratterizzazione omerica di Andromaca, anche rispetto alla ripresa euripidea delle Troiane che, analogamente a quanto avviene
258 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
adattarsi alla nuova realtà in cui il destino la ha posta19: anche l’accusa di non rendersi conto di trovarsi in terra greca e non più barbara,
viene infatti a cadere nel momento in cui è suggellata da Teti la scelta
che sia suo figlio a proseguire la stirpe di Ftia. L’attacco e le critiche
rivolte ad Andromaca come barbara da parte dei personaggi spartani
sono, in definitiva, in così evidente contrasto con la virtù e la positività della sua figura, che sono gli stessi personaggi spartani, che a lei
si oppongono e che la accusano, ad uscirne in una luce negativa, ad
essere quindi visti come rappresentanti di valori non condivisibili: gli
Spartani, come Ermione e Menelao, sono falsi, omicidi, attaccati alla
ricchezza e in definitiva pure vili.
Il motivo anti-spartano che è stato definito, paradossalmente, per
contrasto con una donna barbara, si rinsalda nell’evidenza della superiorità dei valori da essa veicolati: non a caso, ad Andromaca, la
tragedia è intitolata.
Euripide, dunque, compie una operazione interessante e peculiare, in quanto assume il tradizionale stereotipo greco del “barbaro” che
rappresenta l’Altro, ma lo trasferisce polemicamente nei confronti di
personaggi – in primo luogo Ermione – rappresentativi della realtà di
Sparta, la storica nemica della città di Atene.
nell’Andromaca, il tragediografo accoglie e sottintende, si veda Daniela Canavero,
“Ripresa ed evoluzione: Andromaca ed Ecuba nelle Troiane di Euripide”, in Daniela
Canavero, Aandrea Capra, Alessandro Sgobbi, Giuseppe Zanetto, cur.: Momenti della ricezione omerica. Poesia arcaica e teatro, Milano: Cisalpino, 2004, 171-185, in
pt. 171-176.
19
La necessità dello straniero di adattarsi alle norme del paese che lo ospita è
riconosciuta anche da Medea nell’omonima tragedia, v. 222. Più in generale sulle
analogie e le differenze tra le figure di Medea, Ermione e Andromaca si vedano anche
le osservazioni di Franca Perusino cit. 59-62, che rileva che “Ad Ermione, e indirettamente a Medea, Andromaca insegna come deve comportarsi una buona moglie
che privilegia un rapporto coniugale amoroso”. In linea con la Perusino, cfr. n. 19
p. 60, non condivido la lettura proposta da Tristan Alonge, “Lo spettro di Medea in
Tessaglia. L’Andromaca di Euripide come riscrittura della Medea”, Maia, 60, 2008,
369-386 che ravvisa un modello medeico dietro i personaggi sia di Andromaca che
di Ermione (in pt. 380-383).
La Sfida dell’Altro
Sulla natura filosofica dell’azione terapeutica
Alessandra Zambelli
This article analyses the therapeutic action from the perspective of
an anthropological philosophy capable to set a right distance for a
point of view of empathy and epistemology, based on the author’s
daily work practice. The therapeutic setting is therefore analysed in
its possible being context structured as intimately private space at
the same time as public space, through the lived of sense of belonging or social interest/feeling – Gemeinschaftsgefühl – that the role
of therapist symbolically embodies. A framework characterized by
constitutive and dynamic oxymorons that the author makes to speak
starting with the Epistemology of Dilthey, the Logical Hermeneutic
of Misch, up to the Hermeneutic Ethic of Levinas. Central assumption is to formulate the hypothesis of an implicit curative epistemology in the therapeutic action that supports the philosophical nature as
utopian, to accept and to welcome the other in its essential challenge.
“Pardon Madame, pourrais-je aller aux toilettes avant de commencer la
séance, s’il-vous-plaît?” - “ Bien sûr, Mademoiselle. Je vous en prie.” “Ah, ce n’est pas interdit!”
Questo scambio che configurò la prima seduta con una paziente,
probabilmente borderline ad alto funzionamento cognitivo, figlia in
260 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
una famiglia pied-noir1, secondogenita di un fratello avvocato, celibe e prossima ai trent’anni, impiegata in una società di analisi delle
quotazioni borsistiche, ci permise di cogliere la costruzione evolutiva
dell’esiguo spazio che il suo corpo aveva ricevuto e occupava nella
sua vita, persino nella precedente terapia, che sembrava aver perseguito in modo caricaturale, o dogmatico, certe linee di pensiero. Ne
emerse addirittura una forma di divieto del corpo, quasi una negazione, e il conseguente quotidiano maltrattamento dei suoi bisogni, desideri e piaceri. Proprio quest’episodio, datato di più d’una decade, mi
sollecitò associazioni ad altre esperienze del mio percorso professionale e personale, in cui mi sorprendevo a sottolineare ripetutamente,
quasi come in postura da battaglia, in contrasto ai saperi acquisiti di
Istituzioni (Ospedali e Università), Associazioni (Scuole psicanalitiche e terapeutiche), e da individui (pazienti, amici e colleghi), il ruolo
del corpo, così spesso relegato al ruolo d’ombra benché non sempre
fedele, o di una macchina, particolarmente per gli sportivi e i militari,
malgrado la sua determinante apparente imponenza percettiva rispetto alla mente e alla psiche, facilmente annullata da un senso e uno
stile di vita razionalizzato e/o ipersocializzato.
E mi risuonavano nella mente, quasi come un dolce ritornello infantile, le frasi che Nietzsche declama, attraverso la voce oracolare di
Zaratustra, appartenenti alle mie “romantiche” letture liceali:
“Corpo io sono e anima”, - cosi parla il fanciullo. E perché non si dovrebbe parlare come i fanciulli? Ma il risvegliato e sapiente dice: corpo
io sono in tutto e per tutto, e null’altro, e anima non è altro che una parola per indicare qualcosa del corpo.
Il corpo è una grande ragione, una pluralità con un solo senso, una guerra e una pace, un gregge e un pastore.
Strumento del tuo corpo è anche la tua piccola ragione, fratello, che tu
chiami “spirito” (...)2
Pieds-noirs in francese era un termine per indicare familiarmente i francesi originari d’Algeria, ma che per estensione è stato usato ed è oggi d’uso prioritario per
indicare quelle famiglie di origine europea che si sono installate in Africa del Nord
sino all’indipendenza, per rientrare d’urgenza in Francia, causando sovente traumatismi transgenerazionali
2
“‘Io’ dici tu, e sei orgoglioso di questa parola. Ma la cosa ancora più grande, cui
tu non vuoi credere, – il tuo corpo e la sua grande ragione : essa non dice ‘io’, ma fa
‘io’. (...) Il tuo Sé ride del tuo io e dei suoi balzi orgogliosi. ‘Che sono mai per me
1
Alessandra Zambelli - La Sfida dell’Altro 261
L’impulso a interpretare qui questo brano di Nietzsche come
punto di partenza per comprendere la natura dell’azione terapeutica
– consegnata tradizionalmente alla parola – nella relazione duale, o
anche gruppale, è in conseguenza alla domanda spontanea sul senso
di quest’azione – che è il mio mestiere –, se essa sia da interpretare
come azione sociale di marca puramente tecnico-medica, o piuttosto
anche come prassi che è già sufficientemente corpo di una filosofia
e/o di un’antropologia, poiché produce, per riprendere l’articolo di
Papi3, una particolare verità che è già una forma intenzionale di operare nel mondo?
È evidente che il setting terapeutico lavora al livello di un’autobiografia, anche se si tratta di terapia di gruppo, e non come la filosofia che solo appartiene a un’autobiografia, come mette in evidenza
Papi per valorizzare l’aspetto pubblico e autonomo della verità della
prassi filosofica, dove nell’autobiografia l’ordine della verità è semplicemente impossibile4.
Ma non si tratta nemmeno di ‘scrivere’ o ‘inscrivere’ una prospettiva semplificata della circolarità tra vita, espressione e comprensione come un’interpretazione diltheyana degli scritti autobiografici
potrebbe suggerire. Forse piuttosto nel senso della ‘Selbstbesinnung
filosofica’ che Misch esplicita nel suo concetto di personalità come
individualità spirituale che persegue una legge interna di sviluppo
vicina al concetto di Nietzsche “divieni ciò che sei” 5. Il setting terapeutico è vita che riflette su se stessa, in particolare sulla valenza
delle categorie della vita in connessione con le implicazioni emotive
e affettive che queste veicolano, ma attraverso il riconoscimento e
questi balzi e voli del pensiero? Esso si dice. Una via traversa verso il mio scopo. Io
sono la danda dell’io e l’insufflatore dei suoi concetti’. (...) Il Sé creatore ha creato
per sé apprezzare e disprezzare, ha creato per sé il piacere e il dolore. Il corpo creatore ha creato per sé lo spirito, come una mano della sua volontà. (...) Ormai non può
più fare ciò che più di tutto vorrebbe: – creare al di sopra di sé. Questo egli vuole
più di tutto, questo è tutto quanto il suo anelito”; Friedrich Nietzsche, Così parlò
Zarathustra, “Dei Dispregiatori del Corpo”, Torino: Einaudi, 1968, 34-35.
3
Fulvio Papi, Venti tesi filosofiche, si veda il primo numero della Rivista InCircolo,
25 Maggio 2016.
4
Ivi, punto 11) dell’articolo di Papi.
5
Massimo Mezzanzanica, Georg Misch, Milano: Franco Angeli, 2001, caro amico che ringrazio per l’accompagnamento che sempre mi offre generosamente nelle
mie letture e riletture di Dilthey e Misch, oltre che di quelle fenomenologiche, ed a
cui devo il suggerimento del titolo di questo articolo
262 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
la condivisione relazionale con l’Altro, caratterizzato da uno statuto speciale polisemico e multilivello, tra cui quello di rappresentante
critico e esperto di un sapere scientifico e sociale. Essendo questo
setting terapeutico uno strumento e già una situazione sociale, che
pone enfasi sul ‘raddoppio critico’ di tutto ciò che succede al suo interno, ma in un rimando diretto e indiretto al suo esterno storicamente
determinato, tanto dal lato del paziente che da quello del terapeuta; ed
essendo questa situazione strumentale sempre e già a livello relazionale, focalizzandosi sull’intenzionalità inconscia di tutte le espressioni corporee, interne ed espressive esterne, tra cui la parola, ma anche i
gesti ed i comportamenti; quest’azione mette in rilievo la condizione
umana, benché singola e individuale, ancora una volta sia del paziente com’anche ed infine del terapeuta.
Essendo il setting tutto ciò, e qualcosa in più, esso sembra voler
e dover produrre una nuova verità che, per essere curativa, deve in
qualche modo, a un qualche livello, essere condivisa – almeno parzialmente – dai partecipanti alla relazione, e che determina una situazione di verità che, benché privata, è creata in uno spazio di pubblico
accesso e servizio, regolamentato nel suo esercizio, come anche dal
segreto professionale e dalla legge sulla privacy, e ha conseguenze
pubbliche ed è gestita e assicurata da regole pubbliche, financo i rimborsi, e impatta su persone e situazioni che vanno ben oltre la stanza
della seduta.
Infatti crea sinergia e implicazione persino nella sua evoluzione
scientifica, che si appoggia inevitabilmente sulla condivisione intersoggettiva di tanta soggettività, per promuovere quella verità di cui la
ricerca si nutre. Siamo forse ancora in quel nucleo creativo e carnale
che differenziò e oppose due secoli orsono le scienze nomotetiche
da quelle ideografiche, laboratorio vitale e nodale che manifesta nel
fare quotidiano quella circolarità delle categorie diltheyane, care alla
filosofia del periodo in cui la psicanalisi nacque e la psicoterapia ebbe
un’accelerazione egualmente considerevole benché, a oggi, non così
mediatizzata.
L’obiettivo che perseguo in questo breve scritto non è però quello
di dare uno statuto preciso alla natura dell’azione terapeutica, ancor
meno quello di azione filosofica, di setting come ‘corpo filosofico’6,
ma quello più antropologico di osservare il mio lavoro, il mio fare
6
Come lo intende Fulvio Papi, Venti tesi filosofiche.
Alessandra Zambelli - La Sfida dell’Altro 263
immanente, il contesto epistemico e pragmatico della mia prassi – che
è comune ma non equivalente a quella dei miei colleghi – tramite una
messa a distanza antropologica che sollecita la mia predisposizione e
formazione filosofica, usufruendo di uno strumento che trascenda il
setting analizzato, e che è l’impresa futile di tematizzare in una pubblicazione gli oggetti intellettuali che questo stesso contesto attua e
crea implicitamente, in particolare i limiti dinamici vissuti e teoretici
della relazione specifica che nominiamo setting, per metterne in discussione la sua struttura conoscitiva, per indagarne “l’epistemologia
curativa” che me ne risulta. E forse allora, e solo alla fine, riecheggeranno sensazioni del corpo filosofico poeticamente inteso tanto da
Nietzsche che da Merleau-Ponty.
Nella prassi terapeutica il setting è lo strumento tecnicamente più
importante degli utensili curativi, a mio avviso proprio per la sua valenza sociale di trasmissione e di appartenenza, sino a rappresentare
– “come se” – un’autorità super partes, unita alla sua fondamentale
libertà costitutiva della valenza simbolica e proiettiva che permette
la sensibile mise en scène regressiva e cosciente del transfert-controtransfert, lo psicodramma terapeutico simbolicamente gestito dai
protagonisti, malgrado e grazie alla loro asimmetria relazionale costitutiva. Proprio per questa valenza di limite tra simbolico e sociale, tra
realtà interna e verità esterna, il setting è il punto archimedeo tanto
della terapia quanto dei suoi saperi teorici di riferimento, il perno
ontologico dei conflitti tra corpus scientifici, che rischia sempre di
rendere invisibili le relazioni umane implicate, anzi ne è un assunto
di base, e che può arrivare persino a farlo in modo irreversibile e
dunque antitetico al suo scopo e alla sua natura terapeutica, quindi
teoreticamente e relazionalmente violento, come l’esempio iniziale
del “possibile divieto del terapeuta di usare le toilettes” quale conseguente divieto del corpo nel setting terapeutico specifico, frutto di
“una propria assoluta astrazione”7, ovvero di un’ipostatizzazione.
Allora possiamo vedere o intravedere come il setting di una terapia diventa tanto lo strumento di un sapere-potere quanto di un disvelamento e valorizzazione di una certa “configurazione di esistenza”
in cui certe possibilità ritornano a essere presenti per una chiara apertura di senso del mondo, apertura grazie a un quadro ben delimitato,
apparentemente rigido, ma in realtà dinamico, valorizzante l’aspetto
7
Fulvio Papi, “Venti tesi filosofiche”, punto 17.
264 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
storico-antropologico non solo degli individui in quel momento in
relazione, ma di tutti quelli implicati in quella stessa relazione, pur
restandone corporeamente fuori.
L’aspetto storico è presente non solo come narrativa tecnica, ma
come metodo aprioristico nel recupero del senso appercettivo del
mondo, in egual misura che il “senso della possibilità” dello stesso,
proprio come Veca lo intende : “la capacità di pensare tutto quello
che potrebbe egualmente essere e non essere, e di non dare maggiore
importanza a quello che è, che a quello che non è”8, poiché in seduta si sonda l’intimità per farla divenire comunicabile, condivisibile,
prim’ancora che comprensibile, e a partire da quest’azione di espressione, la soggettività assurge a un piacere corporeo di oggettivazione
infinita quanto impossibile. Potrebbe essere un modo di descrivere
il principio della “giusta distanza” in terapia, della posizione neutra
che il terapeuta deve saper cercare, pur non trovandola mai, per accompagnare il suo cliente o paziente verso la comprensione di ciò che
desidera veramente, al di là dell’accecamento della complessità del
reale come habitus immodificabile, e verso la possibilità della scelta
contro l’alienazione di una situazione ove la creatività sembra aver
perso dimora e la fatica della scelta il suo senso e la sua speranza, sotto l’abissale peso di sentimenti ed emozioni come la colpa, l’angoscia
o la collera. Come già scrissi nel mio lavoro di tesi in psicologia su
Joyce MacDougall, considero la creatività come unica chance di vita,
sposando pienamente il pensiero di Veca, recuperante Marx, che “una
società migliore resta una società che consente a tutti gli esseri umani
di fare ciò che solo gli esseri umani possono fare – creare, inventare,
immaginare altri mondi possibili”. E considero e vivo il setting terapeutico come una situazione spazio-temporale e relazionale studiata
per indurre i protagonisti ad attivare la loro creatività esistenziale a un
livello massimale ogni volta, allo scopo di aprire le menti ad ascoltare
una richiesta di nuovo senso, proveniente dal linguaggio della sofferenza e del dolore come ultima chance di creatività, che fa del “corpo
una grande ragione”, un ego in azione, un’identità sempre e già relazionale, finalizzata alla ricerca di un piacere di cui il senso della vita
è il fenomeno globale.
8
Salvatore Veca, “Il senso della possibilità”, si veda il primo numero della Rivista
InCircolo, 25 Maggio 2016
Alessandra Zambelli - La Sfida dell’Altro 265
Alfred Adler, uno dei padri fondatori della Psicologia del Profondo,
aveva ben presente la filosofia nicciana, sia direttamente sia attraverso la critica di Hans Vaihinger9, suo riferimento epistemologico, nel
considerare la psiche una compensazione organica, il prodotto creativo che il corpo ha saputo realizzare per rispondere ad un’esigenza
del reale, in presenza di una carenza organica. E lo strumento adattivo più potente è per Adler, sempre con Vaihinger, quello del sistema
teleologico finzionale, che sostituisce nella sua teoria il paradigma
pulsionale freudiano. In concreto, per Adler “tutte le manifestazioni
sessuali della nevrosi sono di natura simbolica”10, frase che implica il
concetto centrale della teoria adleriana, ovvero la finzione direttrice,
e il suo riferimento alla tesi di Vaihinger sinteticamente espressa dal
sottotitolo eloquente della sua opera principale: Il pensiero riguardato dal punto di vista di una funzione organica a carattere finalista11 .
Il filosofo ritrova nelle funzioni psichiche, come in quelle organiche
del corpo, la cosiddetta finalità empirica. Definisce quindi la ‘psiche’
non come una sostanza ma piuttosto come “la totalità organica di tutte
le azioni e reazioni dell’anima”12, che sono avvenimenti necessari,
poiché si sviluppano con regolarità dalle proprie condizioni e cause,
ma non nella stessa maniera degli avvenimenti fisici. Il finalismo si
esprime da una parte attraverso un semplice adattamento all’ambiente
e alle situazioni per la conservazione dell’organismo fisico e psichico,
dall’altra per l’acquisizione o la repulsione di nuovi elementi. Non si
tratterebbe di un semplice gioco meccanico di rappresentazioni, ma al
contrario di un flusso molto fine di rappresentazioni per la soddisfazione delle caratteristiche del finalismo psichico. A questo finalismo
partecipa il processo teoretico dell’appercezione, di cui il pensiero
scientifico fa parte, e quindi anch’esso è una funzione organica.
9
Kantiano e positivista, Hans Vaihinger pubblicò nel 1911 la sua opera fondamentale, Die Philosophie des Als-Ob, Leipzig: Meiner, 1911; tr. it. F. Voltaggio, La
Filosofia Del ‘Come Se’, Roma: Astrolabio, 1967
10
A. Adler, Über den Nervösen Charakter: Grundzüge einer vergleichen
Individual-Psychologie und Psychotherapie, Wiesbaden: Bergmann, 1912; tr. it. Il
Temperamento Nervoso, Roma: Astrolabio, 1997,198
11
La Filosofia del ‘Come Se’, 15. Questa traduzione si riferisce all’edizione popolare realizzata da Raymund Schmidt del testo originario, pubblicata dalla stessa casa
editrice F. Meiner di Leipzig (oggi Hamburg) con lo stesso titolo Die Philosophie des
Als Ob
12
Una totalità funzionale, concetto che il neurologo russo Vygotskij elabora un
decennio più tardi.
266 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
La coscienza, per Vaihinger, non può più essere un semplice specchio. Essa non riceve nessuno stimolo senza proporzionarlo immediatamente a se stessa. La psiche è nello stesso tempo sorgente di
produzione organica per l’adattamento. Non è solamente recettiva ma
anche attiva. Può elaborare e produrre da se stessa i suoi propri organi che sono le forme dell’intuizione e del pensiero. Così i concetti
e le strutture logiche, ma anche le finzioni per Vaihinger. Il pensiero logico è, di conseguenza, un’assimilazione spontanea del mondo
esteriore, cioè un’opportuna elaborazione organica del materiale delle
sensazioni.
Le categorie “non costituiscono affatto un possesso innato dell’anima”, esse sono “finzioni analogiche” tratte dall’esperienza interna,
e in quanto tali suggeriscono l’idea dell’evoluzione delle stesse, della
loro storicità13. Il pensiero logico è anch’esso una funzione organica
della psiche con l’obiettivo di trasformare le sensazioni in rappresentazioni, in connessioni di rappresentazioni e strutture concettuali
compatibili e capaci d’implicare in sé l’essere oggettivo. Vaihinger
considera centrale in questa produzione logica della psiche il linguaggio: la parola può servire tanto a fissare l’errore quanto per la comunicazione14. Errori utili perché comunicabili, ma pur sempre errori,
cioè “finzioni euristiche”, secondo il linguaggio kantiano. “Soltanto
in una cosa Kant si era sbagliato, vale a dire nel credere che ci sia un
numero prestabilito di categorie”15. Tutti i tentativi di comprensione
(teoretica) del mondo non sono altro, per il nostro filosofo, che un’illusione della psiche determinata dal suo desiderio16, dalla sua istintiva, irriflessa attività di adattamento. Nella sua definizione la finzione,
distinta dall’ipotesi, è una forma di rappresentazione che non solamente contraddice la realtà, ma è contraddittoria in se stessa. In un’esplicazione dettagliata e approfondita, il filosofo arriva ad affermare
logicamente che, anche nelle ipotesi scientifiche, si può soltanto dire
che i fenomeni obiettivi possono essere considerati come se si comportassero effettivamente così, in modo identico, cioè, al modo della
13
H. Vaihinger, ivi,161; “Originariamente la psiche possedeva una tavola categoriale più ampia di quella attualmente posseduta e come quest’ultima sia solo il
prodotto della selezione e dell’adattamento naturali”, Ivi, 160.
14
Ivi,158.
15
Ivi, 163.
16
“Comprendere è una sensazione piacevole, a noi notissima, che scaturisce dalla
trasformazione empirica delle sensazioni nelle categorie”. Ivi, 159.
Alessandra Zambelli - La Sfida dell’Altro 267
loro rappresentazione, il che non dà nondimeno il diritto, sul piano
teorico, a mutare il come se in un che17. Adler non esiterà a considerare quest’attività l’inconscio. Se la logica del pensiero ha come scopo
prioritario l’anticipazione, Adler sviluppa il concetto di finzione tendenziosa come anticipazione immaginaria o fittizia e disadattata alla
base della struttura psicopatologica.
Per Adler e per Vaihinger, infatti, non si tratta di stabilire relazioni
necessarie tra conoscenza e ontologia, tra processi mentali e realtà,
ma di far funzionare il pensiero secondo le sue proprie leggi, al punto
da arrivare a trovare una coincidenza pratica. Vaihinger, che dà alla
sola sensazione lo statuto di reale18, vuole dimostrare che le finzioni
sono una manifestazione di forza dell’anima, e non abitudini, secondo
il linguaggio di Hume, ma strutture psichiche necessarie e influenzanti l’azione, allo stesso titolo degli altri strumenti logici presi dal
metodo empirico da secoli19. Il problema di fondo della teoria della
conoscenza consisterebbe proprio nel fatto che pensiero e essere non
possono essere la stessa cosa e che “le vie del pensiero non possano essere quelle dell’essere”20. È questa la fondamentale frontiera: il
passaggio dalla sensazione al pensiero. Egli prende in considerazione la metafora dell’analisi infinitesimale per spiegare lo spettacolo
metamorfico che ci riserva il corpo in questo passaggio dall’esterno
all’interno21, e viceversa aggiungerebbe Adler.
Per Vaihinger il pensiero è un’arte, e l’attività delle finzioni dell’anima è una manifestazione della forza psichica. L’anima è creatrice,
die Seele ist erfinderisch. Essa si sviluppa nelle difficoltà, cercando di
realizzare il suo fine, attraverso l’invenzione di concetti che coincidono “praticamente” con la realtà senza rappresentarla oggettivamente.
17
Ivi, 42. Per un approfondimento, si veda il mio articolo : Alessandra Zambelli,
“La matrice kantiana della Psicologia Individuale. Dalla filosofia del ‘Come Se’ di
Hans Vaihinger, alla psicanalisi del ‘Come Se’ di Alfred Adler”, Rivista Magazzini di
filosofia, Milano: Franco Angeli Editore, 2005-2010, 63-84.
18
H. Vaihinger, La Filosofia del “Come Se”, 141.
19
Ivi, 24.
20
Ivi, 146.
21
“Assistere all’elaborazione psichica finalista a partire dal materiale fisico meccanico e atomico dei sensi, richiama metaforicamente l’immagine teorica del momento in cui l’analisi infinitesimale ha saputo perturbare il rigore dei fondamenti
della matematica e della fisica. Sistematizzata da Leibniz e Newton, l’analisi infinitesimale, introducendo degli elementi-finzione apparentemente contraddittori, ha
avuto in realtà il merito di far sviluppare queste due scienze”. Ivi, 69
268 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Sottolineando che le finzioni sono strutture psichiche, Vaihinger vuole affermare che la logica è una scienza, e dunque una disciplina di
quest’arte del pensare, che deve stabilire le sue regole tecniche per
distinguerne gli artifici. Adler intuisce la specifica efficacia di questa
concettualizzazione nella sua capacità di stabilire le linee fondamentali di una teoria dell’uomo non ipostatizzata e al di là del biologismo,
ma senza negarlo. Grazie a ciò, lo psichiatra ungaro-austriaco può
formulare la sua teoria di una clinica del come se, che sembra cogliere suggestioni anche nella filosofia dell’immanenza di Spinoza, nel
suo concetto di conatus, di desiderio come potenza d’essere, sforzo o
tendenza per sviluppare la propria esistenza d’essere come essenza,
che traduce nei termini nicciani di volontà di potenza e di sentimento
d’inferiorità. Ma in particolare l’accoppiamento tra questa volontà
e il giudizio accondiscendente nel sistema finzionale, e la classificazione dei desideri attivi e passivi, interni ed esterni, legati agli affetti
positivi di gioia e negativi di tristezza, a cui Adler aggiunge la prospettiva pragmatica del posizionare il giudizio dal lato utile o inutile
della vita. Con Spinoza (virtualmente) e Vaihinger (conretamente), e
oltre con Nietzsche, Adler pone un limite al concetto d’inconscio infinito e ineluttabile freudiano, ridando alla ragione una chance ottimista di priorità: senza patologia l’uomo può capire i suoi affetti e fare in
modo da non subirli nella forma rigida della finzione tendenziosa, ma
perseguirli nella maniera dinamica della finzione direttiva, il desiderio gioioso di esprimere la necessità della propria natura, quindi senza
alienazione ma senza egualmente il supporto di una verità assoluta,
in semplice accordo con la riflessione sulla realtà esterna ed interna,
se la sua mente può sopportare che “Dio è morto”, o forse che sia
immanente, al di là di una difensiva idealizzazione salvifica, verso
l’assunzione di un’autonomia creativa.
Per riprendere il senso della possibilità che si gioca22 in seduta,
credo che, inserito nel paradigma finzionale vaihingeriano-adleriano
della psiche, assuma un senso più strutturante, dove “l’esame socratico del sé e della varietà possibile dei suoi esperimenti”, diventa inevitabilmente, nella seduta terapeutica, un “esame del repertorio dei sé
Nel senso del Gioco che ci offre Eugen Fink nel suo Oase des Glücks. Gedanken
zu einer Ontologie des Spiels, Freiburg /München: Verlag Karl Alber, 1957, traduzione italiana di Anna Calligaris, L’oasi del gioco, Milano: Raffaello Cortina Editore,
2008.
22
Alessandra Zambelli - La Sfida dell’Altro 269
multipli”, come naturale e istintiva mutevolezza delle possibilità del
sé, sua intrinseca creatività necessaria, che il corpo conserva segretamente, disvelandone le coordinate in un progress gestuale a due, se il
contesto relazionale (setting) si manifesta e si costituisce in modalità
good enough fiduciosa. Inizia allora una danza tra i protagonisti, la
cui coreografia esprime un senso, probabilmente evidente solo a loro,
ma visibile agli altri per i suoi effetti curativi.
Ma se l’azione terapeutica è una forma di conoscenza, è anche
una forma di potere, per riprendere l’analisi della Borutti sull’antropologia? “Conoscere porta a reificare l’altro, oggettivarlo, che è una
forma di dominio, ma dominio simbolico sull’altro”23, scrive l’autrice
citando Michel de Certeau, per ricordare come l’Occidente imperialista e colonialista non sappia prendere sufficientemente le distanze
da sé per non ridurre l’alterità ad un confine svilito, come quello della
tradizione orale equiparata alla dimensione corporea inconscia, inferiore alla dimensione eccelsa della consapevolezza dei significati di
cui gode la ragione. Ma come per l’antropologia Lévi-Strauss ha ben
indicato che il ricercatore deve saper “ ‘consegnare qualcosa di sé’ per
far presa sull’altro – tanto che il viaggio antropologico può trasformarsi in confessione e viaggio alla ricerca di sé”24, a maggior ragione
per l’azione terapeutica, questa dimensione della condivisione empatica dei sé sostituisce il dominio tra esseri, per ridare alla cultura il suo
aspetto dinamico, valorizzandone la natura di processo, di possibilità,
di punto di partenza verso una creatività operante, piuttosto che quello conservatore di struttura statica, di acquisito, di oggettivo, di unico
vero e unico reale, di confronto verificatorio scientifico e normativo.
La seduta terapeutica è questa cultura in essere, un’azione nell’essere, perché nell’hic et nunc temporale sembra totalmente e pragmaticamente inutile, pur focalizzandosi sull’utilità migliore, la ricerca
del benessere nell’avere e ritrovare senso nella propria vita che porta
oltre il dolore patologico, quello che impedisce di creare, condividere, vivere con l’Altro. È un’azione che immagina possibilità nuove
nel tentativo di offrirsi e lasciarsi usare reciprocamente per scoprire
se stessi mentre si scopre l’altro, per curarlo scoprendosi, nel “rad Silvana Borutti, “Antropologia e Umanesimo”, Rivista InCircolo, 25 Maggio,
2016, n° 1.
24
Ivi, citazione di Claude Lévi-Strauss, I tre umanismi, traduzione italiana di
Sergio Moravia in Antropologia strutturale 2, Milano: Il Saggiatore, 1978, 311-314.
23
270 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
doppio critico” di saper dubitare delle verità statiche tanto del contenuto quanto del metodo, senza perdere quei limiti che soli permettono
questo gioco sacro che è la creatività dell’unità psicosomatica che
l’uomo è, nel rapporto generativo di vita e di senso con l’altro.
Gioco sacro della Selbigkeit di Dilthey, o delle Ipseità di Ricoeur,
ma in una dimensione strutturante, in una “connessione strutturale”
– Strukturzusammenhang – tra l’identità dei Sé e il mondo esterno,
che diventa una “connessione effettuale” – Wirkungszusammenhang25
– nell’ibrido che è il setting terapeutico nel suo tentativo di ri-originare l’origine, di rimetterla in scena o in essere. Questo spazio di
ordine pubblico, così intimamente privato, installa un intermezzo di
costruzione di senso che svicola e sfida persino l’ermeneutica diltheyana, a causa della predominanza dell’appartenenza – nel senso
del Gemeinschaftsgefühl26 - nell’epistemologia curativa che è giocata
nell’azione terapeutica. Ovvero, stimo che in filosofia non si sia sufficientemente vista e valorizzata la semplice importanza equilibratrice
o patologizzante che ha la condivisione della realtà con un altro soggetto, al punto che… si arriva a cedere sulla percezione della realtà
stessa pur di restare con l’Altro. Il rapporto ontologico non è in questa
prospettiva Io-Mondo, ma piuttosto Io-Altro-Mondo, in cui il Corpo,
come Nietzsche aveva capito, gioca un ruolo determinante, nel suo
essere il limite estremo della comunicazione presimbolica, quando il
pensiero non può arrivare a creare un gesto parlante. Allora la finzione sembra ritornare/restare all’origine somatica, in qualche modo più
vicina al concetto di libido freudiana, senza associarvisi.
Il setting terapeutico vuole mettere in rilievo questa “connessione
fattuale” per un’ermeneutica relazionale curativa, ma che ha le con25
Cito una comunicazione privata dell’amico filosofo Massimo Mezzanzanica:
“Wirkungszusammenhang o, al plurale, Wirkungszusammenhaenge, indica non tanto
la dimensione della soggettività, quanto il mondo storico e sociale in quanto è costituito appunto da connessioni effettuali”. Si veda inoltre, per un approfondimento
del pensiero di Dilthey, Alfredo Marini, Alle origini della filosofia contemporanea:
Wilhelm Dilthey. Antinomie dell’esperienza, fondazione temporale del mondo umano, epistemologia della connessione, Edizione riveduta e ampliata, Milano: Franco
Angeli, 2008.
26
Per un approfondimento di questo concetto si veda il mio libro Adler face à
Freud: une différence à sauvegarder, 2014, Paris, l’Harmattan; o il mio articolo “La
matrice kantiana della Psicologia Individuale. Dalla filosofia del ‘Come Se’ di Hans
Vaihinger, alla psicanalisi del ‘Come Se’ di Alfred Adler”, Rivista Magazzini di filosofia, Milano: Franco Angeli Editore, 2005-2010, 63-84.
Alessandra Zambelli - La Sfida dell’Altro 271
notazione e le implicazioni di un’epistemologia curativa, tanto come
metodo conoscitivo quanto come teoria del significato.
Infatti, seguendo liberamente l’elaborazione ed evoluzione che
Misch attua del pensiero di Dilthey, metterei l’accento su la Logica
della relazione piuttosto che sulla Logica del significato e senso, pur
valorizzandone il “carattere espressivo” degli oggetti specifici a queste logiche nella prospettiva di un’antropologia filosofica. Quando
Misch sottolinea il “procedimento evocativo” come intrinseco agli
oggetti/concetti delle scienze dello spirito perché rendono il contesto
immanente al significato, vuole metodologicamente fissare la “consapevolezza dell’impossibilità di esaurire la profondità dell’oggetto che
viene incontro nel comprendere, l’imperscrutabile profondità della
vita” e che si converte in una tensione produttiva, che io identifico
come creatività, in cui la vita coincide con “l’autenticità dell’espressione”27. Sul piano finzionale, questa creatività ha la sua autenticità in
un movimento circolare, che non si limita al rapporto soggetto-oggetto, ma al relazionale Io-Tu nella costruzione del mondo interno e del
mondo esterno, dove le connessioni rispondono a finalità, e dunque
verità, multiformi e polisemiche.
L’Unheimlich caro a Freud che l’altro ci veicola, questo familiare perturbante, perché si presenta come un’estraneità che ci riguarda intimamente, pone le basi dell’impossibilità della ragione, per il
suo essere inesorabilmente legata ad un suo inconscio, di conoscere
esaustivamente attraverso l’assimilazione della differenza. In psicanalisi, come Laplanche l’ha ben analizzato e descritto, la differenza dell’alterità non può che restare l’“inquiétant”, das Unheimliche,
l’autrement, il demoniaco. La “chose dernière” non è l’ambivalenza,
né l’ostilità, ma questa differenza dell’altro, ciò che originariamente
proviene dall’altro, nella modalità dell’altro28. Ci è dato sconoscerci
solo tramite l’altro, che assurge quindi a ruolo di riferimento confermante-disconfermante, di familiarmente straniero, di ossimoro ontologico, di paradosso esistenziale.
E la prima e più importante esperienza della differenza dell’altro
come Unheimlich è nella sessualità, nella differenza dei sessi, questa “asymétrie fonctionnelle des corps”, come la descrive Françoise
27
Massimo Mezzanzanica, Georg Misch, 172.
Laplanche, 1991, Le temps et l’autre, Paris, PUF, in Le primat de l’Autre en
psychanalyse, Paris: Flammarion, 1997, 373.
28
272 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Héritier, com’anche nella differenza tra generazioni, tra genitori e figli, che tanto produce soggettivamente come oggettivamente, e che
inscrive nel corpo la sua origine relazionale, la sua alterità originaria, la sua creatività necessaria. Il corpo è dunque in seduta il grande
assente-presente, l’Unheimlich della parola terapeutica che sempre
cerca la sua espressione, sia nel silenzio sia nel grido, sia nella passività sia nell’esplosione, sia nel gesto sia nell’azione, perché il corpo
polisemico è già e sempre nella necessità di esprimere, di esistere…
nell’appartenenza radicale all’altro (Gemeinschaftsgefühl)29, ovvero
almeno simbolica. Il corpo che sembra individuarci per eccellenza, è
anche la nostra più evidente radice nell’Altro.
Ciò comporta che il mondo – non potendo più essere considerato
filosoficamente solo quello percettivo esterno ai fini di un’epistemologia antropologica, nel senso di Dilthey, – deve essere compreso in
relazione al mondo interno, non solo percettivo, ma più intersoggettivamente emotivo e affettivo, di cui la psicanalisi e la psicoterapia
rappresentando le epistemologie e le prassi scientifiche occidentali
designate, benché non uniche, unite a quella psicologica, di cui le
neuroscienze rappresentano la punta di diamante contemporanea, e
che non a caso le tra aeree conoscitive faticano, ma oggi riuscendovi,
a parlarsi.
In qualche modo il setting terapeutico mi appare come una metafora concreta dell’Infinito di Lévinas, un Autrement qu’être ou au delà de l’essence30, un ossimoro incarnante la gloria di Dio di Levinas,
poiché l’interpreto nel senso spinoziano o nicciano; e che nell’“illeité” del “Me voici!”31, che si realizza solo nella presenza d’altro, questo Infinito non si mostra, non si svela, ma témoigne l’infinito, ovvero
esprime una verità che non è ne rappresentazione né percezione, ma
rivelazione… che non ci dà nulla – “ne nous donne rien”32 –, salvo il
Si veda su questo fondamentale concetto adleriano Gemeinschaftsgefühl – sentimento di appartenenza – il mio articolo sopra citato.
30
Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au de-là de l’essence, Paris: Livres de
Poches, 1978.
31
“Le propre, au contraire, de la relation à l’Infini, c’est qu’elle n’est pas dévoilement. Quand, en présence d’autrui, je dis ‘Me voici!’ est le lieu où l’Infini entre dans
le langage, mais sans se donner à voir.” Emmanuel Levinas, Ethique et Infini, Paris :
Fayard, 1982, 102
32
Emmanuel Levinas, Ethique et Infini, Paris : Fayard, 1982, 103.
29
Alessandra Zambelli - La Sfida dell’Altro 273
desiderio stesso33, e forse, aggiungerei, il piacere di un’empatia epistemologica e curativa, che sembra essere inscritta nella rivelazione
del contatto con le visage de l’autre, “l’espressif en autrui (et tout le
corps humain est, en ce sens, plus ou moins visage). (…) Le visage
me demande et m’ordonne”34.
Infatti il viso dell’altro per Levinas è il richiamo e il comando
(ordre) alla responsabilità come condizione d’essere, che paradossalmente assicura la suprema dignità alla propria unicità, al divenire unico della soggettività. La responsabilità ontologica risulta allora come
unica radicale possibilità di disfarsi della condizione (o incondition)
umana andando nell’Oltre attraverso la finzione filosofica35, quindi la
scelta, della responsabilità di “non essere solo un essere tra gli esseri”, garantendo così il desiderio inscritto a fuoco nell’inconscio, adleriano come freudiano, di esistere nell’unicità ontica e ontologica della
propria soggettività. Il setting terapeutico è strutturato per riattivare
questa possibilità: “le visage parle”, “je lui réponds”36.
In questa specifica descrizione, forsanche ideale del contesto o
setting terapeutico, si può escludere con certezza e necessità che l’azione terapeutica non sia in qualche modo connessa ad uno statuto
di “corpo filosofico”? O si potrebbe indagare l’idea dell’azione terapeutica come intrinsecamente un’azione filosofica utopica? Cosa ne
conseguirebbe?
Se l’epistemologia verifica i fondamenti, la validità, ed i limiti della conoscenza, in particolare la struttura logica e metodologica
della ricerca scientifica, cosa può significare il verificare i riferimenti
di una nuova verità che in quanto neo-originata e condivisa è curativa? Ovvero avrebbe senso parlare di epistemologia curativa? Un
potere curativo della procedura immaginativa relazionale che arriva a
introdurre la libertà del senso della possibilità nella percezione della
realtà affettiva ed emotiva?
Ivi, 86.
Ivi, 94-97 “Moi non interchangeable, je suis moi dans la seule mesure où je suis
responsable. Je puis me substituer à tous, mais nul ne peut se substituer à moi.”
35
“La condition ontologique se défait, ou est défaite, dans la condition ou incondition humaine. Être humain, ce signifie : vivre comme si l’on n’était pas un être
parmi les êtres. Comme si, par la spiritualité humaine, se renversaient les catégories
de l’être, e, un ‘autrement qu’être’” (Ivi, 97).
36
Ivi, 82.
33
34
274 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Poiché il contesto della seduta terapeutica cerca di recuperare la
plasticità diadica del rapporto madre-infante all’origine neurofisiologica della mente e della coscienza, ma senza farne un’equivalenza,
bensì un originale orientato allo stesso fine, quello di modellare la
mente nelle sue stratificazioni profonde, da cui permettere un’apertura di senso al mondo che potrebbe radicalizzarsi in una visione oltre,
essendo le menti in situazione già adulte, possiamo considerare questo corpo duale, corpo relazionale originante, che è il setting terapeutico un’azione carnale37 di tipo filosofico alla Merleau-Ponty?
Cfr. il mio lavoro di tesi su Maurice Merleau-Ponty: il corpo. Dal comportamento alla “chair”, 1990-1991, Tesi di Laurea in Filosofia, Università degli Studi di
Milano, sotto la direzione di Alfredo Marini.
37
Controversie
Identità e differenze temporali.
Su Heidegger e Ricoeur
Alberto Giovanni Biuso
The paper analyzes and compares two fundamental works to understand temporality: Sein und Zeit by Martin Heidegger and Paul
Ricoeur’s Temps et récit. Heidegger’s onthological analysis becomes
theoretical narrative in Ricoeur, without losing anything of the complexity of the matter, rather getting enriched with a series of strong
links to history, literature, phenomenology.
Identità e Differenza
Essere, Verità, Identità e Differenza sono le parole fondamentali della
scienza filosofica. Parole alle quali Martin Heidegger ha fornito chiarimenti utili anche a comprendere il discorde legame tra le sue analisi
e quelle di Paul Ricoeur, Sein und Zeit e Temps et récit. I titoli da soli
esprimono subito l’identità e la differenza. L’identità della questione
-il tempo-, la differenza delle intenzioni e dei modi. L’analisi ontologica di Heidegger diventa narrazione teoretica in Ricoeur1, senza
perdere nulla della complessità della questione e anzi venendone arricchita da una serie di legami profondi con la storiografia, la letteratura, la fenomenologia.
1
Troviamo una analisi critica approfondita della concezione del tempo di
Heidegger in un intero capitolo di Paul Ricoeur, Temps et récit III. Le temps raconté,
vol.3, trad. it. di Giuseppe Grampa, Tempo e racconto III, Il tempo raccontato, vol.3,
Milano: Jaca Book, 1988, 93-149.
278 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Molte filosofie tentano di rendere stabile il divenire, di fermare
l’eventuarsi dell’essere, di disconoscre l’eventuarsi che è l’essere.
Nell’evento invece -Ereignis- identità e differenza vivono ed esprimono la loro coappartenenza. Ed è esattamente questo plesso ciò
che Heidegger cerca di pensare, «in che senso la differenza derivi
dall’essenza dell’identità»: se tra Ereignis e Austrag (divergenza) regna «una consonanza»2 è perché il tempo è la differenza rispetto sia
al nulla sia all’eterno, il movimento è la differenza rispetto alla stasi.
Essere, identità, differenza, stasi, movimento sono le parole esatte
con le quali Platone ha nel Sofista segnato il progetto di pensiero della
filosofia europea.
L’assoluto come causa sui è pura identità con se stesso, la quale come pensiero si dispiega nel tempo e come divinità si dispiega
nell’eterno, rimanendo tuttavia sempre la monocorde struttura che
dall’inizio alla fine del processo nega sia l’identità dello stesso sia
la differenza dell’uguale, pervenendo così al nulla dell’essere e del
divenire.
Lo sforzo di Heidegger consiste anche nel comprendere la lunga
vicenda di questo oblio della differenza, sapendo bene che è necessario confrontarsi con la struttura linguistica del pensare e con la stratificazione storica della tradizione, poiché «soltanto quando, pensando,
ci rivolgiamo al già pensato siamo sempre impiegati per ciò che è
ancora da pensare»3. Linguaggio e tradizione sono due parole centrali anche per il dispositivo concettuale con il quale Ricoeur tenta
di pensare il tempo. Vediamo dunque come si articola l’analisi della
temporalità nelle due opere fondamentali che Heidegger e Ricoeur
hanno dedicato all’essere, al racconto, al tempo.
Sein und Zeit
In Essere e tempo i concetti vengono trasformati in problemi, le opere
(Werke) in itinerari di ricerca (Wege), l’intera filosofia diventa una
rigorosa e ripetuta analisi delle parole proprie del pensiero europeo,
poiché «è affare della filosofia preservare la forza delle parole più
2
Martin Heidegger: Identität und Differenz, Stuttgart: Klett-Cotta, 1957, trad. it.
di Giovanni Gurisatti, Identità e Differenza, Milano: Adelphi, 2009, 26.
3
Ivi, 51.
Alberto Giovanni Biuso - Identità e differenze temporali 279
elementari, in cui l’esserci si pronuncia, dal venir livellate dal senso
comune fino all’incomprensibilità» (§ 44; 625)4. In Sein und Zeit l’ontologia fondamentale, la domanda sull’essere dalla quale il pensiero
sorge, viene declinata come analitica esistenziale, come descrizione
accurata, rigorosa, ontologica della dimensione ontica in cui il fare e
l’essere quotidiano degli umani si svolge. Esserci, infatti, vuol dire
«existiert faktisch» (§ 38; 512), vuol dire abitare il mondo-tempo in
un modo collettivo e individualmente declinato nella sua struttura fenomenologica. L’ontologia è possibile come fenomenologia perché
non si tratta di due discipline tra le tante che compongono il corpo
della filosofia ma sono la filosofia stessa e il modo del suo darsi. La
filosofia è quindi
ontologia fenomenologica e universale che parte dall’ermeneutica
dell’esserci e che, come analitica dell’esistenza, ha fissato il capo del
filo conduttore di ogni domandare filosofico nel punto dal quale risulta
e sul quale torna a ribaltarsi (§ 7; 123 e § 83; 1223)
Ciò che ci è onticamente più vicino, talmente vicino da essere
noi stessi, è anche ontologicamente il più lontano, anche perché non
sembra aver bisogno di essere pensato, talmente ci è addosso e accosto. Heidegger ha voluto indagare semplicemente il darsi e il farsi
quotidiano che «da un punto di vista esistenzial-ontologico cela in sé
enigmi su enigmi» (§ 71; 1043). Se la sostanza umana precede ogni
distinzione tra anima e corpo, se «das “Wesen” des Daseins liegt in
seiner Existenz» se l’essenza dell’esserci sta nella sua esistenza (§
9; 130), l’analitica esistenziale precede logicamente e concretamente
ogni scienza umana e ogni sapere naturale (psicologia, antropologia,
biologia).
Fra le strutture dello stare al mondo – gli “esistenziali” – ci sono
l’in-essere, il con-essere, l’essere-alla-morte. Esserci e mondo non
stanno l’uno accanto all’altro ma l’esserci è un modo dell’essere insieme, perché un soggetto senza mondo è una pura astrazione, tanto
che persino «das Alleinsein ist ein defizienter Modus des Mitseins»,
Citerò da Martin Heidegger: Sein und Zeit, 1927, Tübingen, Max Niemeyer
Verlag, 2001, ed. it. a cura di Alfredo Marini, con testo tedesco a fronte, Essere e
tempo, Milano: Mondadori, 2006. Indicherò il numero del paragrafo seguìto da quello della pagina in cui si trova la traduzione italiana.
4
280 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
l’essere soli è un modo manchevole dell’essere con gli altri (§ 26;
350). La morte non è un evento biologico, il perire, ma è il costitutivo essere-alla-fine che dall’inizio accompagna l’apertura sempre incompiuta che è il futuro. Se «il fenomeno primario della temporalità
originaria e autentica è l’avvenire» (§ 65; 925-927), l’esserci è possibilità sempre aperta, tanto che la morte «è la possibilità della pura e
semplice impossibilità d’esserci» (§ 50; 709), una possibilità sempre
certa e sempre indeterminata. L’esserci quindi non ha una fine «bensì
esiste in modo finito» ed è per questo che la Cura -la quale sempre
accompagna l’umano nel tempo- è in realtà un essere alla morte (§
65; 927).
La Cura è infatti il tempo quotidiano nella sua concretezza esistenziale; la Cura è tutto ciò che serve a essere ancora: la «temporalità
si rivela come il senso dell’autentica cura» (§ 65; 917).
L’esserci come Cura si declina nelle forme del trovarsi, del comprendere, del parlare, dello scadere e «il modo d’essere quotidiano
della chiusura è caratterizzato dalla chiacchiera, dalla curiosità e
dall’equivocità. Queste, a loro volta, mostrano il moto dello scadere coi suoi essenziali caratteri della tentazione, dell’acquietamento,
dell’estraneazione e dell’inciampo» (§ 38; 515). Il modo in cui queste
e altre forme si danno anzitutto e per lo più è il Man, il Si impersonale
che evita all’esserci l’assunzione piena di ciò che è, a favore invece
di una ripetizione di tutto quanto mediamente si fa. Importante per
Heidegger è non intendere tutto questo in modo moralistico e valutativo poiché anche «il “si” è un esistenziale e appartiene come fenomeno originario alla costituzione positiva dell’esserci» (§ 27; 373).
Autenticità e inautenticità del Dasein non sono da porre in una scala
assiologica ma vanno intese in senso fenomenologico come modi diversi di abitare il mondo. Emblematica, in questa direzione, è la differenza tra paura (Furcht) e angoscia (Angst). Mentre la paura nasce
sempre da qualcosa di specifico, l’angoscia scaturisce dal solo fatto di
esser vivi. La scaturigine dell’angoscia è pertanto l’essere nel mondo
in quanto tale.
Anche per questo nessuna tonalità tipicamente umana (Stimmung)
può essere cancellata attraverso il vuoto emotivo ma solo e sempre
tramite una Gegenstimmung, una controtonalità a essa opposta (e già
Spinoza lo aveva sostenuto). La comprensione radicale, teoretica, ontologica, del mondo emotivo in cui l’esserci è immerso è uno dei
Alberto Giovanni Biuso - Identità e differenze temporali 281
contributi più importanti che Heidegger abbia offerto alla filosofia e
cioè alla vita pensata.
Una parola chiave come Geworfenheit –da Marini resa con
Dejezione e da Chiodi con Gettatezza- mostra in controluce la fonte
gnostica, fonte da Heidegger costantemente occultata. Anche se il filosofo sottolinea esplicitamente che «lo scadimento dell’esserci non
può perciò neppure essere concepito come “caduta” da un più puro
e superiore “stato originario”» del quale non avremmo né esperienza
ontica né comprensione ontologica (§ 38; 503), resta il fatto che l’esserci è come tale colpevole («Das Dasein ist als solches schuldig» [§
58; 802], Marini preferisce rendere “è in debito”); resta che il modo
fondamentale –anche se velato- dell’esser nel mondo è l’inospitalità
(Unheimlichkeit, § 57; 780) e che non è l’esser colpevoli che risulta
da una qualche colpa specifica ma, al contrario, l’indebitamento è
possibile solo sul fondamento di un «ursprünglichen Schuldigseins»,
di un esser colpevoli originario (§ 58; 799).
La caduta, il debito, la colpa, comunque la si voglia chiamare,
ha in ogni caso prodotto la sostanza temporale dell’esserci. Sta qui il
nucleo di Sein und Zeit. Il senso dell’esserci come essere nel mondo
è la Zeitlichkeit, la temporalità. L’irriducibilità dell’umano al semplice sussistere sottomano, il suo costante esistere come apertura mai
chiusa e mai compiuta, la sua “storicità”, la sua identità insomma di
specie, sono tutti fondati sul fatto che l’esserci non ha tempo ma è
temporalità vivente, vissuta, aperta, costitutiva. Preparata dalle accuratissime analisi che la precedono, la pagina chiave dell’opera è
probabilmente questa:
Non è che l’esserci riempia con le fasi delle sue realtà effettuali istantanee una pista o un segmento sottomano “della vita”, ma estende se stesso, sì che il suo esser proprio è fin dapprincipio costituito come estensione. Nell’essere dell’esserci sta già il “tra” riferito a nascita e morte. [...]
L’esserci fittizio esiste per nascita, e per nascita muore anche proprio nel
senso dell’essere-alla morte. Entrambi i “capi” e il loro “tra” sono, finché l’esserci fattiziamente esiste, ed essi sono in quel modo che unicamente è possibile sulla base dell’essere dell’esserci come cura. Nascita
e morte si “con-nettono”, nel modo che è proprio dell’esserci, nell’unità
di dejezione e sfuggente o precorrente essere-alla-morte. In quanto cura,
l’esserci è il “tra”. (§ 72; 1051)
282 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
L’eco agostiniana di questa straordinaria pagina, la distensio temporale che l’esserci è da sempre, per sempre e nel tra, il coincidere
della struttura umana con la dinamica del tempo, l’identità fra Dasein
e Zeit, confermano le considerazioni che Husserl fa a proposito della
centralità delle intuizioni di Agostino per ogni ulteriore comprensione
del tempo: «In questa materia i tempi moderni, tanto orgogliosi del
proprio sapere, non hanno eguagliato l’efficacia con cui la serietà di
questo grande pensatore aggredì il problema, né fatto progressi degni
di nota»5. Il tempo non è né oggettivo né soggettivo, né naturale né
antropologico. Simili dualismi rimangono ben al di sotto dell’enigma
semplice che il tempo è. Un enigma che si può tentare di chiarire
comprendendo che il tempo non è una cosa ma è un accadere di processi nel mondo, i quali acquistano il loro significato solo nell’esserci
umano proteso alla Cura, destinato a finire e sapiente di tale finitezza,
poiché «“si dà” verità solo nella misura e fintantoché vi è dell’esserci» (§ 44; 643). L’essere nel mondo consiste nell’abitare i significati,
nel costituire una struttura semantica che è linguistica proprio perché è una donazione di senso al mondo. La persona, infatti, «ist kein
Ding, keine Substanz, kein Gegestand», non è una cosa, una sostanza
o un oggetto ma «è data come attuatrice di atti intenzionali collegati
nell’unità di senso» (§ 10; 147).
La non cosalità dell’esserci è la radice anche del suo essere spaziale. Nonostante il fatto che numerose interpretazioni sostengano la
subordinazione della spazialità alla temporalità, il testo heideggeriano è sufficientemente chiaro nell’affermare che «l’esserci stesso, nel
suo essere-nel-mondo, è “spaziale”» (§ 22; 307) poiché «l’esserci occupa, letteralmente, lo spazio. Non è affatto soltanto sottomano nella
porzione spaziale riempita dal suo corpo» (§ 70; 1033). La spazialità
dell’esserci non consiste in un semplice occupare luoghi ma nell’apertura di senso che il corpo continuamente genera come un cuneo
che si inoltra nella materia illuminandola. Ecco perché l’esserci è
spaziale in senso originario e «la dimostrazione che questa spazialità
è esistenzialmente possibile solo grazie alla temporalità non può pre-
Edmund Husserl: Zur Phänomenologie des Inneren Zeitbewusstseins 18931917, hgg. v. Rudolf Boehm, «Husserliana», Bd. X, The Hague: Martinus Nijhoff,
1966, ed. it. a cura di Alfredo Marini, Per la fenomenologia della coscienza interna
del tempo, Milano: Franco Angeli, 1998, 43.
5
Alberto Giovanni Biuso - Identità e differenze temporali 283
figgersi di dedurre lo spazio dal tempo, o di risolverlo in puro tempo»
(§ 70; 1031).
Se l’esserci umano è una macchina semantica lo è perché è una
macchina temporale, un grumo di tempo consapevole del proprio passare: «Come senso dell’essere di quell’ente che chiamiamo esserci,
viene indicata la temporalità» (§ 5; 65). Ma –e l’ignorare tale «ma»
impedisce spesso di comprendere la radicale unitarietà del percorso
heideggeriano- «la messa in chiaro della costituzione d’essere dell’esserci resta però solo una via. La meta è l’elaborazione del problema
dell’essere in assoluto» (§ 83; 1223).
Temps et récit
Come per Heidegger ma più radicalmente di Heidegger, anche per
Ricoeur il tempo è questione anzitutto linguistica, è racconto, trama,
coglimento narrativo dell’andare dei giorni, degli eventi. Il linguaggio è scandito nel tempo, le parole vengono pronunciate l’una dopo
l’altra a formare delle frasi le quali compongono a loro volta una descrizione, un’analisi, delle narrazioni. Il carattere sequenziale del linguaggio è anche un dato tecnico, che però si fonda sulla struttura della
mente umana, la quale non è nel tempo ma è essa stessa temporalità
vivente, rammemorante, intenzionale.
Il tempo diviene tempo umano nella misura in cui è articolato in modo
narrativo; per contro il racconto è significativo nella misura in cui disegna i tratti dell’esperienza temporale. […] Che la tesi presenti un carattere circolare è innegabile. […] Il circolo tra narratività e temporalità
non è un circolo vizioso, bensì un circolo corretto (I, 15).6
È delineato così con chiarezza il tema che percorre Tempo e racconto, opera nella quale si condensano ermeneutica, fenomenologia
ed esistenza. L’obiettivo è dimostrare l’identità strutturale tra storio-
Da qui in poi mi riferisco ai tre volumi di Temps et récit, nella traduzion citata
alla nota 1. I titoli dell’edizione originale sono -rispettivamente- Temps et récit, La
configuration dans le récit de fiction, Le temps raconté. I riferimenti sono indicati
con il numero del volume in cifre romane e quello delle pagine in cifre arabe.
6
284 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
grafia e racconto di finzione sulla base dell’esigenza di verità che intride entrambi i modi narrativi.
I fondamenti sono individuati nella temporalità agostiniana e
nella mimesi aristotelica. Della prima Ricoeur conduce un’analisi
accurata e magnifica, che individua nella congiunzione di distensione e triplice presente la cifra propria di Agostino. Il tempo è dentro
l’anima, il tempo è l’anima, come per Plotino. Ma se in Plotino il
riferimento è all’anima del mondo, per Agostino il tempo siamo noi.
Nell’interiorità della mente umana -alla fine a noi stessi insondabileil tempo si costituisce e diventa un’entità nomade, fatta di transito,
misurata non nel suo essere ma nel suo passare, nel divenire. Per questo, soprattutto per questo, l’umano è un dispositivo temporale, per la
finitudine dinamica di cui è fatto.
Non sembra quindi così evidente e motivata l’opposizione che
Ricoeur individua tra il presente agostiniano e il futuro heideggeriano,
poiché entrambi sono radicati nella finitudine o come Sein-zum-tode o
in quanto relazione profonda tra l’eternità del creatore e la mortalità
delle cose create. In ogni caso e per entrambi il tempo esiste e scorre
nella sostanza umana come presente delle cose che sono state, presente delle cose che sono, presente delle cose che saranno, come Cura
rivolta al mondo a partire dalla comune finitudine che attraversa tutti
e l’intero. L’aporia della invisibilità del tempo si risolve nella corporeità che ricorda quanto ha vissuto, anche nelle forme inconsapevoli
di ciò che Antonio Damasio definisce il Sé nucleare; nella corporeità tesa a durare; nella corporeità intenzionata istante dopo istante a
prendersi cura di sé e quindi del tutto nel quale il sé accade. Poiché,
davvero, «il tempo è come circondato dal niente» (I, 48), fuori dal
tempo nulla è e se anche fosse non sarebbe pensabile.
La Poetica di Aristotele sembra non occuparsi della temporalità
e tuttavia secondo Ricoeur la costruzione dell’intrigo (mythos) e l’attività mimetica (mimesis) costituiscono le due strutture del racconto
che sono inseparabili dal tempo. Se «comporre l’intrigo vuol già dire
far nascere l’intelligibile dall’accidentale, l’universale dal singolare,
il necessario e il verosimile dall’episodico» (I, 73), raccontare significa transitare dal tempo prefigurato del mondo al tempo rifigurato della mente attraverso il tempo configurato della narrazione temporale
e linguistica, dell’intrigo. L’obiettivo consiste dunque «nel costruire
la mediazione tra tempo e racconto, dimostrando il ruolo mediatore
che la costruzione dell’intrigo svolge nel processo mimetico» (I, 93).
Alberto Giovanni Biuso - Identità e differenze temporali 285
La modalità nella quale l’indagine si articola è «una lunga e difficile
conversazione triangolare tra la storiografia, la critica letteraria e la
filosofia fenomenologica» (I, 134).
Nella comprensione del tempo storico, punto di riferimento è la
rivoluzione storiografica delle Annales -la sua apertura metodologica,
la varietà dei contenuti- e uno dei suoi testi fondamentali, il libro di
Fernand Braudel dedicato al Mediterraneo nell’epoca di Filippo II.
Les Annales rappresentano «una complessa rivoluzione storiografica»
-secondo la definizione dello stesso Braudel7- iniziata nel 1929 e che
ha consentito di cogliere, o almeno tentare di farlo, una storia globale
in grado di aggiungere ai nomi, alle date, agli eventi, la difficile completezza della vita quotidiana, i movimenti dei gruppi e delle cose,
il permanere delle mentalità, la vita materiale. Ricoeur osserva che
Bloch, Braudel, Le Goff oppongono alla discontinuità evenemenziale
«un tempo sociale le cui principali categorie -congiuntura, struttura,
tendenza, ciclo, crescita, crisi, ecc.- sono prese a prestito dall’economia, dalla demografia e dalla sociologia» (I, 158).
E tuttavia anche al fondo di questa oggettività strutturalista sta
secondo Ricoeur l’evento narrato. Da intendere, naturalmente, non
come il singolo episodio separato dal flusso della narrazione ma come
nucleo di essa. La nozione stessa di lunga durata deriverebbe dall’evento drammatico e cioè «dall’evento-messo-in-forma-di-intrigo»
(I, 307), di racconto pieno di significato e disteso nella temporalità
profonda degli spazi, delle collettività e dell’istante. Tempo storico e
tempo cosmico si coniugano nel racconto come tempo della mente,
inteso quale «spiegazione causale singola che fornisce la struttura di
transizione tra la spiegazione mediante le leggi e la comprensione
mediante l’intrigo» (I, 339).
Metodo idiografico/narrativo/comprendente e metodo nomologico/strutturale/esplicativo vengono così distinti ma non separati.
Certezza e probabilità, dati e ricostruzioni, documenti e invenzioni,
fatti discreti e lunga durata si coniugano nel racconto come imitazione mediante la scrittura di quanto accaduto e come sua interpretazione narrativa. Per Ricoeur «“la differenza reale passa non tra i fatti
storici e i fatti fisici ma tra la storiografia e la scienza fisica”. Questa
Cito da una antologia delle Annales curata da Alfredo Salsano con il titolo
Problemi di metodo storico, Roma-Bari: Laterza, 1982. La definizione di Braudel si
trova a p. V.
7
286 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
ultima sussume dei fatti sotto delle leggi, la prima li integra entro
degli intrighi» (I, 255). Entrambe sono dunque basate su dei “fatti” e
rappresentano delle forme simboliche ed ermeneutiche.
Storiografia e letteratura sono l’identico del racconto ma anche
la differenza della verità. L’elemento specifico della finzione è la sua
separazione dal vero a favore di una realtà più ampia, che Aristotele
chiama il verosimile e che per Ricoeur consiste nell’ampliamento della spiegazione sino a far scaturire da essa una comprensione più radicale rispetto a qualunque dato di fatto, legge formale, corrispondenza
tra il detto e l’empiria.
In ogni caso, cultura e racconto sono lo stesso evento, la funzione
narrativa può trasformarsi ma non può finire «e questo perché non
sappiamo che cosa sarebbe una cultura nella quale non si sappia più
che cosa significhi raccontare» (II, 54). La forma contemporanea del
racconto è il romanzo, la cui posta è il tempo: il tempo del raccontare
(Erzählzeit) e il tempo delle cose narrate (erzählte Zeit), la loro differenza, il loro convergere nell’atto concreto e universale della configurazione narrativa di finzione. Ricoeur mette alla prova l’universalità
del racconto letterario attraverso tre narratori -Virginia Woolf, Marcel
Proust, Thomas Mann- tra loro differenti ma accomunati da un nucleo
fondamentale costituito dalla relazione tra il tempo e l’eternità nel
crocevia dell’esperienza umana fatta di azione e interiorizzazione.
Mrs Dalloway distanzia e coniuga il tempo monumentale, il tempo delle figure d’Autorità -del quale quello cronologico è espressione
e conseguenza- con il tempo vivo:
È quindi in rapporto a questa frattura insuperabile aperta tra il tempo
monumentale del mondo e il tempo mortale dell’anima che si distribuiscono e mettono in ordine le esperienze temporali di ciascuno degli
altri personaggi e il loro modo di negoziare il rapporto tra i due lati della
frattura (II, 182-183).
Il tempo di Der Zauberberg è un tempo parmenideo, intriso di
immobilità e votato alla morte. La distanza spaziale dalla “pianura”
produce una distanza radicale dal divenire e dalla vita. L’eternità della
montagna incantata non è un tempo infinito o un presente costante
ma è la danza macabra ben illustrata dall’aforisma di Canetti per il
quale non è necessario scavare molto nell’umano per trarne il desiderio del nulla. Malattia, cultura e tempo sono qui l’identico. Un’altezza
Alberto Giovanni Biuso - Identità e differenze temporali 287
nella quale tutti gli attimi sono uguali. «Nell’incommensurabile,
Hans Castorp ha scoperto l’immemoriale (“Questi sei mesi lunghissimi, e che pure erano fuggiti in un batter d’occhio”)» (II, 207).
Incommensurabilità, una parola del tutto parmenidea.
Nella Recherche l’eternità, la vita per sempre, la vita “scoperta e
portata alla luce” è la parola, è la decifrazione interminabile dei segni, «segni della mondanità, segni dell’amore, segni sensibili, segni
dell’arte» (II, 216). La densità della materia, la complessa ambiguità
delle relazioni sociali, lo splendore della bellezza, l’orrore dei sentimenti -«la macchina infernale di un amore corroso dall’illusione, dal
sospetto, dalla delusione; un amore condannato a passare attraverso
l’angoscia dell’attesa, il morso della gelosia, la tristezza del declino e
l’indifferenza per la propria morte» (II, 228)- costituiscono il palinsesto da decifrare, nell’infinito lavoro ermeneutico che l’opera e la vita
sono. Il luogo spaziotemporale nel quale tutto questo, e molto altro, si
raggruma è il corpo. La Recherche tutta intera è una fenomenologia
del corpo; probabilmente la più accurata, raffinata e plausibile che
sia stata scritta. Poiché è nel corpo che sin dall’inizio e finalmente il
tempo diventa visibile: «Des poupées baignant dans les couleurs immatérielles des années, des poupées extériorisant le Temps, le Temps
qui d’habitude n’est pas visible, pour le devenir cherche des corps
et, partout où il les rencontre, s’en empare pour montrer sur eux sa
lanterne magique»8.
L’opera d’arte è il Tempo, nel duplice senso per il quale ogni
espressione artistica rappresenta un segno della struttura profonda
che tutto intride e del fatto che la realtà del tempo si fa visibile nell’opera. Spazio e tempo si congiungono nell’ultima immagine della
Recherche, nei trampoli che crescono indefinitamente a plasmare la
corporeità umana, che non può indefinitamente conservare l’equilibrio del Leib, del corpo vivente e vissuto: «Quest’ultima figura del
tempo ritrovato dice due cose: che il tempo perduto è contenuto nel
tempo ritrovato, ma anche che è in definitiva il Tempo che ci contiene» (II, 248). L’intera opera di Proust sta sotto il segno di una gnosi
radicale, quella che sa riconoscere nel geroglifico frammentato e disperso della materia e dei corpi l’unità molteplice del Tempo signore.
In tale conoscenza consiste «lo sforzo per risalire verso la luce» del
quale parla il Temps retrouvé (II, 245).
8
Marcel Proust: À la recherche du temps perdu, Paris: Gallimard, 1999, 2307.
288 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Il tempo monumentale e vitale di Virginia Woolf, il tempo mortale di Thomas Mann, il tempo segno/memoria/corpo di Marcel
Proust sono alcune delle espressioni del tempo, il cui «mistero […]
costituisce l’enigma insuperabile» -questa è la più esatta delle tesi di
Ricoeur- «precisamente per il fatto che le percezioni che si impongono a suo riguardo non si lasciano unificare» (II, 207). E quindi la
verità -storica, interiore, collettiva, estetica- della Recherche sta nella
«transizione da un significato all’altro del tempo ritrovato: ed è in
questo che essa è una favola sul tempo» (II, 238). Nel politeismo del
Tempo si dispiega non soltanto il suo enigma ma anche e soprattutto
la soluzione.
Aporie e superamenti
Le aporie della temporalità che percorrono sin qui l’indagine di
Ricoeur arrivano infine a chiarezza e a parziale superamento. La prima aporia consiste nell’inconciliabilità tra le due prospettive che tentano di pensare il tempo, quella fisico-naturalistica e l’altra coscienzialistico-fenomenologica; la seconda fa riferimento al «processo di
totalizzazione delle estasi del tempo, grazie al quale il tempo si dice
sempre al singolare» collettivo (III, 371) e tuttavia rimane distinto in
passato, presente e futuro; la terza è la più grave e consiste nell’impossibilità di rappresentare il tempo, di vederlo.
La soluzione proposta da Ricoeur, dopo un lungo e complesso
percorso, sta nella funzione mediatrice della storicità narrante, che
coniuga la verità degli eventi accaduti e quella degli eventi ricostruiti.
«Il tempo del calendario è il primo ponte gettato dalla pratica storica
tra il tempo vissuto e il tempo cosmico. Costituisce una creazione
che non dipende in modo esclusivo da una delle due prospettive sul
tempo: se partecipa di entrambe, la sua istituzione costituisce l’invenzione di un terzo-tempo» poiché il calendario «cosmologizza il tempo
vissuto, e umanizza il tempo cosmico» (III, 160 e 166).
I miti, l’epica, il dramma, il romanzo, raccontano il tempo e in
questo modo coniugano il tempo fenomenologico con quello cosmologico. Dalla narrazione storica, filosofica, di finzione scaturiscono la
distanza e insieme la profonda vicinanza tra l’ordine sovrumano degli
astri e il ciclo di nascita e morte dell’umana avventura, la gettatezza
Alberto Giovanni Biuso - Identità e differenze temporali 289
nel tempo e «il mormorio della parola mitica» che continua «a risuonare sotto il logos della filosofia» (III, 207).
Come già sapeva Aristotele, se il movimento può arrestarsi il tempo però non si ferma ed è anche per questo che «è modificando la
sua distanza rispetto al presente che un avvenimento prende posto
nel tempo» (III, 62). Le determinazioni di passato, presente e futuro
sono dunque legate alle relazioni del prima e del poi9. L’apriori universale che il tempo è si raggruma e insieme si espande nel presente
vivo della durata. Questa distensio è una delle «scoperte principali»
di Husserl, è «la costituzione del presente dilatato grazie all’aggiunta
continua delle ritenzioni e delle protensioni nel punto-sorgente del
presente vivo» (III, 383). La distensio è però sempre legata ai ritmi
del mondo -a cominciare da quelli circadiani- e da essi è inseparabile:
«Noi non produciamo affatto il tempo, ma è lui ad accerchiarci, a
circondarci e a dominarci con la sua temibile potenza» (III, 26). Non
è la coscienza umana a costituire il flusso ma flusso e coscienza sono
parte di una dinamica più ampia, che possiamo definire come la plurale unità del tempo.
Sta qui il vero superamento delle aporie indicate da Ricoeur e non
soltanto nella convergenza di racconto storico, finzione e fenomenologia, meno ancora nell’insistenza con la quale questo filosofo oppone tra di loro tempo della coscienza e tempo del mondo. Una contrapposizione di segno diverso rispetto a quelle di Bergson e di Husserl
ma con esse concorde nel frammentare l’unità profonda e plurale del
tempo vivo, del tempo vero. Di tanto in tanto, però, Ricoeur ammette
la radice unitaria di mondo e coscienza, come fa quando a conclusione del confronto tra Agostino e Aristotele afferma che «non è possibile affrontare il problema del tempo muovendo da uno solo dei due
estremi, l’anima o il movimento. La sola distensione dell’anima non
può produrre l’estensione del tempo; il solo dinamismo del movimento non può produrre la dialettica del triplice presente» (III, 35). Nei
termini heideggeriani, temporalità, storicità e intratemporalità sono
tutte necessarie alla costituzione del tempo. Ed è così che «si stringe,
tra il sole e la Cura, una sorta di patto segreto, di cui il giorno è l’intermediario» (III, 131).
9
Su questo si vedano le riflessioni di John E. McTaggart, un cui compendio si
trova in italiano ne L’irrealtà del tempo, a cura di Luigi Cimmino, Milano: Rizzoli,
2006.
290 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
La soluzione delle aporie sta nello stesso statuto ontologico del
tempo, che è gioco e dinamica di identità e differenza. Ogni ente rimane nel tempo ciò che è ma nel tempo muta a ogni istante. Passato,
presente e futuro non sono tre né uno ma costituiscono l’unitaria pluralità del divenire naturale e della sua misurazione da parte di una
coscienza. In ogni istante ciascun ente è se stesso e già non è più. Non
va però verso il non essere, in direzione del ni-ente ma si dirige verso
il non ancora implicito nell’essere stato. La memoria è l’adesso che
attende perché ricorda l’essere stato, «la ritenzione è una sfida alla
logica del medesimo e dell’altro; questa sfida è il tempo» (III, 46).
Ogni variazione nasce dentro la continuità temporale dell’ente e ogni
continuità è in divenire. Questa identità differente è il tempo.
Heidegger e Ricoeur convergono pienamente nell’affermare che
esso è costituito ogni volta e sempre da passato, presente, futuro,
prima, poi; il tempo è gewesend-gegenwärtigende Zukunft, «avvenire-essente stato-presentante. [...] La temporalità si rivela come il
senso dell’autentica cura»10. Ma non solo. Il tempo è anche lo spazio
che in esso sta come già e non ancora, per il quale vale l’osservazione di Ricoeur: «Si noterà la felice omonimia tra “esser passato”, nel
senso di esser passato in un certo luogo, e “esser passato”, nel senso
di trascorso» (III, 183).
Questa calma vertigine sta e va, permane e metamorfizza, inchioda e fugge. Se essa «resta l’inscrutabile» (III, 411), il suo enigma
«non equivale ad un interdetto che pesa sul linguaggio; suscita piuttosto l’esigenza di pensare di più e di dire altrimenti» (III, 413). Questa
esigenza è la filosofia.
Martin Heidegger, Essere e tempo, § 65; 917.
10
Viaggio al centro della sfera
Immunologia e antropotecnica
attraverso la polemica Habermas-Sloterdijk
Simone Canziani
This article goes over Sloterdijk’s works, from the late ‘90s to his
last trilogy, Sphären. In the following lines I’ll try to stress the linearity behind his texts, analyzing the concepts of anthropotechnic
and immunology and focusing on the debate he had with Habermas
– that causes him the accuses of being a fascistoid – about eugenetic
and the biologic human selection and determination he hoped for.
Nel 1983, Jürgen Habermas salutava l’opera prima di Peter Sloterdijk
– Critica della ragion cinica – come l’avvenimento filosoficamente
più importante dal 1945. Poco meno di vent’anni più tardi, nel 2001,
all’uscita della raccolta di saggi Non siamo ancora stati salvati. Saggi
dopo Heidegger, la stima di Habermas nei confronti del pensatore
di Karlsruhe è sicuramente scemata, trasformatasi nel ribrezzo e nel
sospetto che hanno portato lo Scolaro di Francoforte ad accostare il
pensiero sloterdijkiano all’eugenismo nazista e all’estremismo, generando paurosi echi del linguaggio della Germania del Terzo Reich.
Quello che al tempo venne definito da Andrew Fisher come l’affaire
Sloterdijk ha origine da alcune parole utilizzate da Sloterdijk in due
dei saggi presenti nella raccolta del 2001: La domesticazione dell’essere e Regole per il parco umano. Interrogandosi sulle differenza fra
il concetto di mondo animale e umano, sulla scia delle ricerche di von
Uexküll e delle considerazioni heideggeriane circa i concetti di Welt
e Umwelt, Sloterdijk analizza l’apertura dell’uomo nei confronti del
mondo: la possibilità di rapportarsi con infinite e nuove esperienze,
292 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
rappresenta una fonte inesauribile di conoscenza ed un arricchimento
che, però, si rivela essere una lama a doppio taglio. Infatti, l’uomo può
sì farsi carico di incommensurabili possibilità di azione, ma, al tempo
stesso, si palesa quale oggetto di altrettante innumerevoli passioni,
paure e pericoli. In questo modo, l’uomo diventa crogiolo di alta vulnerabilità, di labilità motivazionale e di irrequietezza. L’animale non
ha di queste possibilità, dal momento che si muove sempre in un’azione istintuale e non-tematizzante dell’esperienza. È da queste considerazioni che nasce il concetto di antropotecnica: essendo l’unico
essere vivente capace di distaccarsi dal proprio percorso biologico-evolutivo naturale e, quindi, di intrattenersi in una costante messa in
pericolo del sé che infesta l’essere-sapiens a causa della sua singolare
posizione biologica, l’uomo ha prodotto un inventario di procedure
di autoformazione riassumibili nel concetto di cultura. Delle tecniche
di formazione dell’uomo che agiscono a livello culturale fanno parte
le istituzioni simboliche come le lingue, le storie di fondazione, le
regole matrimoniali, le logiche della parentela, le tecniche educative,
la codificazione del ruolo per sesso e per età e, non ultimi, i preparativi per la guerra, così come i calendari e la divisione del lavoro; tutti
quegli ordinamenti, tecniche, rituali e abitudinarietà con cui i gruppi
umani hanno preso in “mano” da soli la propria formazione simbolica
e disciplinare. Questi ordinamenti e forze formative vengono indicati
da Sloterdijk con l’espressione di antropotecniche.
Il concetto di antropotecnica, dunque, deriva dal fatto che esse
- le antropotecniche, appunto - indicano il modellamento diretto
dell’uomo attraverso una messa in forma civilizzante: in altre parole, ogni attività, pensiero, inclinazione, attitudine dell’essere umano,
viene catalogata, formalizzata e disciplinata, in modo tale da creare un sistema immunitario, via via più efficiente, nei confronti della
messa in pericolo. La prassi antropotecnica, d’altra parte è presente
anche nella modernità, sotto forma di espressioni diverse, quali educazione, allevamento, disciplinamento e formazione, comprese nel
nome collettore cultura. Lo stesso utilizzo del termine antropotecnica è motivato dal fatto che è importante sottolineare la preminenza
dell’uomo in questo processo: infatti, le antropotecniche di cui si è
parlato sopra - definite da Sloterdijk antropotecniche primarie, poiché non sono mai state sufficienti a produrre gli uomini in quanto tali,
ma presuppongono un essere umano educabile, operano sull’uomo
solamente in maniera indiretta e inconscia, agendo su un essere già
Simone Canziani - Viaggio al centro della sfera 293
aperto al mondo. Sono, inoltre, antropotecniche, poiché producono
l’uomo; questo tipo di produzione si muoverà in due direzioni: modificherà l’uomo, in quanto soggetto-agente e, al contempo, oggetto
stesso della produzione. Quest’ultimo, fungerà da base stabile per le
successive azioni dell’agente che, continuamente, si muoverà verso
l’oggetto modificandolo e modificandosi, creando un circolo antropotecnico, all’interno del quale si forma una continua relazione fra
soggetto e oggetto, influenti l’uno sull’altro, ogni volta diversamente.
Se un giorno la moderna biotecnica dovesse progredire così tanto da
portare a degli interventi diretti sul “testo” genetico degli individui,
tali aggiunte saranno in ogni caso di natura antropotecnica, anche se
in un senso nuovo e più esplicito. Ciò presupporrebbe che la comunità
di ricercatori e le società tutte prendano visione delle condizioni evolutive e culturali dell’essere che fa eccezione, di cui in alcuni singoli
casi hanno intenzione di manipolare l’informazione genetica. Le antropotecniche secondarie, dunque, si fondano sulle conquiste dell’ingegneria genetica e sulla possibilità di manipolare e produrre l’uomo
non solo, come le antropotecniche primarie, in modo inconscio, ma,
e soprattutto, in modo diretto e attivo: questo offrirebbe la possibilità di intervenire, per la prima volta coscientemente, sull’evoluzione
biologica e sul patrimonio evolutivo dell’uomo. Sono queste le considerazioni di Sloterdijk che hanno dato adito alle accuse mossegli
principalmente da Habermas.
L’allievo di Francoforte, infatti, si inserisce all’interno dello scandalo suscitato dagli scritti di Sloterdijk: le tecniche zoopolitiche e le
antropotecniche secondarie accendono un campanello d’allarme in
Habermas, che non manca di ricordare come la selezione eugenetica
fu già sperimentata dai nazisti, imposta dal regime hitleriano con il
presupposto di una supremazia razziale del popolo ariano.
Il dibattito nasce fra le pagine di Die Zeit, dopo che alcuni giornali isolati avevano definito Sloterdijk come un fascistoide: Thomas
Assheuer, sulle pagine del noto giornale tedesco, accusa Sloterdijk
di auspicare ad un’elite di filosofi e genetisti che, utilizzando tecniche di allevamento e selezione, avrebbero perpetrato la creazione di
una nuova specie umana. Colpito da queste affermazioni, Sloterdijk
attribuisce questa cattiva lettura dei suoi testi non tanto al singolo
Assheuer, quanto ad un “terzo partito”, ad una figura misteriosa, un
intellettuale che, senza rivelarsi, stia muovendo le fila dei giornali un quella direzione accusatoria. La figura in questione, secondo
294 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Sloterdijk, sarebbe Habermas: egli, in possesso del testo cuore del
dibattito prima della pubblicazione, avrebbe architettato una cospirazione alle spalle dello stesso Sloterdijk, facendo circolare il testo
fra i colleghi giornalisti e professori, alimentando la sua errata interpretazione del testo, sottolineando l’importanza di una chiamata alle
armi contro Sloterdijk. Il motivo di quest’attacco, secondo Sloterdijk,
sarebbe determinato dall’impossibilità di Habermas, in quanto teorico del “dialogo democratico”, di considerare legittimo questo tipo di
argomentazioni.
La risposta di Habermas non tarda ad arrivare: in primis, egli
punzecchia Sloterdijk, per non aver risposto alle critiche mossegli da
Assheuer; in secundis, schernisce l’idea secondo la quale l’attacco
all’opera sloterdijkiana sia un archibugio da egli stesso orchestrato, definendo comica questa considerazione. Entrando nel merito,
Habermas decostruisce la denuncia di ipermoralismo e di essere parte
della “cultura del sospetto e dell’accusa” che Sloterdijk gli sporge.
A livello puramente filosofico – oltre che storico – la critica di
Habermas si fonda sulla convinzione per cui anche un’eugenetica
positiva sia da evitare: il motivo, risiede nella volontà, da parte di
Habermas, della creazione delle premesse per uno stato costituzionalmente attrezzato a formare la nostra attuale dubbia morale, in una
società così pluralistica. Sloterdijk, al contrario, vede nel genoma e
nella sua possibile malleabilità il controllo del medium del nuovo
umanesimo. Gli esseri umani, per Sloterdijk, non solo sono rinchiusi
all’interno di parchi umani, recintati dai limiti stessi che l’umanesimo pone e implica (come il linguaggio, i media), ma si pongono essi
stessi all’interno di questa struttura. Superare questi limiti, significa
entrare in contatto ed avere il controllo del medium che preannuncia
il nuovo umanesimo, ovvero il genoma.
La critica a Sloterdijk e alla sue posizioni si fa più aspra nel corso degli anni seguenti. Nel suo testo del 2001 Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenetik?, infatti,
Habermas si scaglia in modo non troppo velato contro il collega di
Karlsruhe, definendolo parte di «un pugno di intellettuali psichicamente crollati che cerca di leggere il futuro nei fondi caffè di un
“post-umanesimo” naturalisticamente declinato. Le fantasie nietzschiane di questi auto-promotori servono soltanto a soddisfare spettacoli mass-mediatici», rispondendo agli auspici di Sloterdijk per un
nuovo umanesimo lontano dai limiti del precedente.
Simone Canziani - Viaggio al centro della sfera 295
Ad onor del vero, però, nonostante Sloterdijk non abbia difeso
apertamente la sua persona da questi attacchi, è necessario leggere
attentamente Non siamo ancora stati salvati per comprendere quanto il pensatore di Karlsruhe sia egli stesso consapevole e cauto nel
parlare di eugenetica e intervento nano-bio-tecnologico. Questo tipo
di situazione possibile è definita dallo stesso Sloterdijk confusa e inquietante, e lascia il compito di affrontare la prospettiva dell’ingegneria genetica alla filosofia futura, che dovrà decidere se muoversi
in quella direzione sulla base di risultati che possano essere condivisi
localmente e universalmente.
Negli anni seguenti, la fama di Sloterdijk – dovuta alla sua indole
di filosofo pubblico, presentissimo nei media e nel dibattito contemporaneo – non ha fatto altro che accentuare le critiche di Habermas,
che in un’intervista del 2014 al web magazine Reset. Dialogues on
Civilizations, alla domanda «Che giudizio dà lei sullo stato della filosofia oggi? In Germania va sempre più di moda il filosofo da talkshow, quello che un tempo si chiamava filosofo popolare. Penso a
personaggi come Safranski, Sloterdijk, Precht. È una cosa buona oppure cattiva?» risponde: «Beh, i nomi che lei cita non sono i veri rappresentanti della filosofia tedesca», sottolineando come la filosofia,
ad oggi, sia una disciplina accademica come le altre – seppure con
delle marcate differenze, quali la mancanza di un “oggetto” e di un
“metodo” – e consti quindi di un impegno professionale che questo
tipo di attitudine (quella massmediatica assunta da molti pensatori)
non rappresenta.
Tra la bagarre del 2001 e l’intervista del 2014, non ci sono stati
nuovi scontri fra i due filosofi e anche quest’intervista non andrebbe
considerata parte del dibattito, quanto più una semplice esternazione di alcune considerazioni di Habermas che coinvolgono lo stesso
Sloterdijk.
Alla luce di questo scontro, il percorso filosofico di Sloterdijk
non ha subito grossi cambiamenti e non ha impedito al filosofo di
Karlsruhe di muovere i passi verso una sistematizzazione più o meno
tematicamente organica dei suoi scritti. Nelle righe seguenti si cercherà quindi di leggere l’opera di Sloterdijk nella sua continuità, dando risalto alle possibili connessioni fra il suo pensiero e la società e la
politica contemporanee.
Sebbene negli ultimi anni l’interesse dei testi di Sloterdijk si sia
spostato sul singolo individuo, rendendo il suo ultimo grande lavoro
296 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
– Du mußt dein Leben ändern – un’opera di stampo etico, l’attenzione
verso l’ontologia, in particolare quella sociale, ha contraddistinto il
trittico di opere per cui il pensatore di Karlsruhe ha riscosso il maggior successo, ovvero la trilogia di Sfere, edita fra il 1998 e il 2004 in
Germania. Non a caso, l’idea del parco umano, sviluppata nell’opera
del 2001, è diretta erede dei lavori sulla spazialità e sulla sferologia,
all’interno dei quali è perfettamente ascrivibile anche il discorso delle
antropotecniche.
La trilogia di Sfere rappresenta la realizzazione dell’intento di
Sloterdijk di colmare la lacuna lasciata da Heidegger con Sein und
Zeit, ovvero la mancata analisi del concetto di spazio, del dove,
dell’abitabilità. Vista l’impossibilità trovare all’interno della trilogia
una definizione univoca del concetto di sfera, diventa necessario introdurre tale concetto per sommi capi. La sfera è il nome dato allo
spazio abitato ed abitabile dagli uomini, uno spazio condiviso e utilizzato che gli esseri umani abitano proprio perché tali. Abitare significa
costruire delle sfere, dall’interno delle quali gli abitanti-uomini osservano e si rapportano con l’esterno guardando l’orizzonte. La sfera è la
dimensione all’interno della quale gli uomini possono essere contenuti ed è proprio la creazione di questo spazio che porge a Sloterdijk
la risposta alla domanda del dove. Nel concetto di sfera è insito il
continuo rapporto fra interno ed esterno, una relazione necessaria per
la condizione di creazione di spazi e di abitabilità. Dando i titoli ai tre
volumi della trilogia, Sloterdijk definisce al contempo le tipologie di
sfere presenti nel mondo umano: la prima, in ordine di grandezza e a
livello ontologico, è la microsfera, rappresentante di quella spazialità
originaria reiterabile e reiterante sempre e dovunque. Risultato del
tentativo della ricostruzione delle condizioni uterine, la microsfera
è il presupposto necessario per il passaggio alla macrosfera, rappresentante della storia dei tentativi da parte dell’uomo di sostituire la
perdita dell’unità microsferica originaria – e l’effettiva impossibilità
di riprodurla, ovvero la realtà intrauterina prenatale.
È in quest’ottica che Sloterdijk chiama in causa il concetto di immunologia e il valore immuno-sistemico della sfera: la storia della
creazione degli spazi sferologici corrisponde allo stesso tempo alla
creazione di sfere tecniche atte a funzionare come sistema immunitario, ovvero che permettano all’essere umano di avere delle condizioni
che concedano all’uomo la possibilità di sopportare la vita. Mai più
che in questo contesto diventa fondamentale e necessaria la correla-
Simone Canziani - Viaggio al centro della sfera 297
zione fra sfera e antropotecniche. Infatti, il passaggio da microsfera
a macrosfera rende visibile in modo completo quell’agglomerato di
sistemi di immunità e d’inclusività che fin dall’antichità l’uomo ha
costruito al fine di proteggersi, cercando di emulare, nel modo più
fedele possibile, la fase d’inclusione e comprensione prenatale. Ogni
macrosfera, dunque, assume i caratteri di un sistema di immunità, atto
a creare al suo interno un clima favorevole, regolato da convenzioni
(religiose, sociali, culturali, ecc) che danno la possibilità all’essere
umani di rapportarsi con l’esteriorità, grazie a questi sistemi non più
spaventosa e sconosciuta. Una forma di immunità evidente al nostro
tempo è ritrovata da Sloterdijk nel processo di globalizzazione tutt’ora in atto, avente origini ben lontane nel tempo: infatti, la globalizzazione ha contribuito in due modi alla formazione della macrosfera
contemporanea, che definisce la nostra età storica. In primis, la prima
ondata globalizzante creò nella realtà dei fatti l’attuale macrosfera.
Infatti, il carattere inclusivo ed immunitario dell’odierna macrosfera
è determinato dalla visione del mondo greca e classica mediata dal
cristianesimo, che costituisce una Weltanschauung imbrigliata da una
forza divina che al contempo rende valevole ogni singola identità ed
il posto a lei concesso. In secundis, la globalizzazione si assicura il
dominio di una macrosfera sempre maggiore grazie alle scoperte geografiche del Quattrocento e del Cinquecento, necessarie per occludere
all’interno della sfera ogni luogo fisico del pianeta Terra. È grazie
dunque ai cartografi, ai marinari, agli esploratori, che si concluse la
conquista e l’assimilazione all’interno di un’unica gigantesca sfera
del nostro pianeta nella sua effettiva totalità. La strada che porta dalla
seconda ondata globalizzante ai giorni nostri è lunga e tortuosa, tanto
da essere definita dallo stesso Sloterdijk epoca post-storica: successiva alla storia delle scoperte geografiche è infatti l’epoca storica della
routine quotidiana, dell’assenza, della nostra coscienza dell’impossibilità di cogliere l’assolutezza e l’infinità del mondo. D’altra parte,
quest’epoca racchiude in sé il corretto epigono dell’epoca storica precedente, quella delle guerre e delle crociate, delle conquiste e degli
avvenimenti storici, fondamentali ma miopi di fronte alla totalità delle loro conseguenze relazionali con l’esterno. Questo tipo di consapevolezza giunge a noi, capaci di osservare con occhio di falco la realtà
nella sua totalità sistemica. L’immobilismo storico del nostro tempo è
per Sloterdijk auspicabile, poiché non preclude il verificarsi degli avvenimenti storici, ma pone le condizioni di esistenza a giudizio degli
298 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
attori globali, che potranno di volta in volta vanificare e controllare
gli effetti, proprio alla luce del carattere sistematico della loro consapevolezza. Questo tipo di operazione è possibile grazie all’ondata
rivoluzionaria del terzo momento della globalizzazione, ovvero l’innovazione tecnologica, capace di interconnettere in modo pressoché
istantaneo ogni parte del pianeta. Per questo, il terzo volume della
trilogia di Sfere è sottotitolato Schiuma: questo termine rappresenta
l’entità interconnessa quale è il nostro mondo, soggetta a continui
mutamenti, seppur controllati, abitata da un ammasso di microindividualità interconnesse fra loro da rapporti macrosferici.
Seppur questo immobilismo sia auspicabile, secondo il pensatore
di Karlsruhe, ogni via di fuga intenta a creare un nuovo tipo di sistema
differente da quello della globalizzazione è possibile, se ascrivibile alle coordinate necessarie alla creazione di nuove sferologie. Nel
documentario Marx Reloaded, del 2011, Sloterdijk viene intervistato
insieme ad altri fra i più illustri pensatori contemporanei. La domanda che viene loro posta riguarda la possibilità di uscita dal sistema
economico-sociale del capitalismo; è possibile muoversi al di fuori
del capitalismo per giungere ad un nuovo sistema mondiale, come il
comunismo? Per Sloterdijk questo è possibile, a patto che le persone
si uniscano e che la loro unione sia regolamentata da un rapporto
di mutua sicurezza, che renda possibile la solidarietà comunitaria su
scala mondiale. Prima di giungere alla comprensione e all’attuazione
del comunismo, dunque, è necessario essere coscienti della necessità
di un immunismo, il principio di mutua assicurazione sanitaria ed economica, base propedeutica alla solidarietà. Alla provocatoria domanda di matrixiana memoria posta a tutti i pensatori intervistati: «Pillola
rossa o pillola blu?», dove la pillola rossa rappresenta la verità tanto
agognata, quel quid necessario alla conoscenza della via d’uscita dal
capitalismo, mentre la pillola blu costituisce il ritiro nella schietta
realtà capitalistica e nelle nostre fantasie di consumatori, Sloterdijk
risponde che non c’è nessuna scelta da prendere: da lungo tempo siamo avvelenati da entrambe le pillole. Per procedere, è necessario un
cambiamento strutturale, che nasce dalla creazione di una nuova unità
sferologica, basata su una concatenazione di immunità reciproche.
Simone Canziani - Viaggio al centro della sfera 299
Bibliografia di riferimento,
ovvero letture per farsi un’idea:
Peter Sloterdijk
–– Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger, Bompiani,
Milano, 2000;
–– Devi cambiare la tua vita, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010;
–– Sfere, Vol. I-III, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014;
Antonio Lucci
–– Il limite delle sfere. Saggio su Peter Sloterdijk, Bulzoni, Roma, 2011;
–– Un acrobata del pensiero. La filosofia dell’esercizio di Peter Sloterdijk,
Aracne, Roma, 2014;
Jürgen Habermas
–– Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi,
Milano, 2010;
–– Il ruolo dell’intellettuale e la causa dell’Europa. Saggi, Editori Laterza,
Roma-Bari, 2011;
Norman Schultz, Thoughts on the Sloterdijk-Habermas-Controversy,
Fahrenheit, 15 Ottobre 2016. http://fibonaccie.blogspot.it/2012/01/thoughts-on-sloterdijk-habermas.html
Mark Peacock, Philosophical Rumblings in the German Republic: Der
Philosophenstreit, Philosophy Now, 2000. https://philosophynow.org/
issues/26/Philosophical_Rumblings_in_the_German_Republic_Der_
Philosophenstreit
Filmografia:
Jason Barker, Marx Reloaded, ZDF, 2011
Corrispondenze
L’ombra di Brexit
sull’accademia inglese
Nicola Polloni
Trasferirsi in Inghilterra dopo neanche una settimana dal referendum
sulla Brexit, con un contratto di due anni cofinanziato dall’Unione
Europea in una prestigiosa università britannica. In Italia si respira
aria di imminente catastrofe, “l’Unione stessa è a rischio” si sente
ripetere, “la prossima è la Francia, poi tocca a noi”, come un mantra
o il gocciolio di un vecchio rubinetto che non si riesce più a riparare.
In Inghilterra la percezione è diversa. Nelle prime settimane dopo
il referendum, gli inglesi sembrano sotto shock, nei pub e nei corridoi
dei dipartimenti non senti parlare d’altro se non di Brexit, di un nuovo
referendum, del parlamento che non voterà a favore dell’attivazione
dell’ormai noto articolo 50. Ma c’è anche preoccupazione, tanta, almeno in una larga fetta della popolazione verso quello che in Gran
Bretagna potrebbe succedere, da un punto di vista sia geopolitico ed
economico (indipendenza della Scozia, economia britannica) che sociale. E in particolare quest’ultimo, ossia il pericolo per la tenuta della
società inglese di fronte a una frattura –spiace dirlo, ma è così– che
non è con i burocrati di Bruxelles ma con le popolazioni di altre nazioni europee. I migranti, siano essi lavoratori edili romeni, studenti
spagnoli, camerieri italiani, o docenti svedesi. La campagna elettorale
per il referendum è stata dura, reckless, e se l’orribile assassinio di Jo
Cox sembrava essere solo contestuale e quasi accidentale rispetto al
referendum: l’indomani ha mostrato che era lo stesso tessuto sociale
britannico ad essersi lacerato.
Ricevo una mail dall’ufficio ricerca, in cui mi informano che è
stato istituito uno sportello per registrare eventuali atti di razzismo e
304 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
xenofobia nei confronti dello staff continentale. Mi dico che alla fine
sono inglesi, si preoccupano sempre troppo. Poi leggo che a Harlow
un gruppo di ragazzini ha ucciso a cazzotti un lavoratore polacco perché parlava in polacco, e durante la veglia per questo folle assassinio altri due polacchi vengono malmenati. Al pub mi confido con
il pub-keeper, e gli chiedo se secondo lui debba preoccuparmi. La
risposta è agghiacciante, “non sei polacco, vai tranquillo”. Eppure
lo percepisci, quando parli con le persone, che qualcosa si è rotto, in
generale. Si è rotto perché le conversazioni casuali in treno, con un
camionista e sua moglie, entrambi scozzesi, si concludono con “ah,
lavori per l’università, quindi non sei qui per i benefits”. E non è un
caso se Martin Roth, il direttore (tedesco) dell’Albert and Victoria
Museum di Londra si dimette e lascia l’Inghilterra.
E viene da chiedersi come possa il sistema accademico britannico
reagire a tutto ciò. Il più prestigioso sistema universitario al mondo,
radicato sul territorio con una rete composta da 154 atenei (in Italia
sono meno della metà, 68) e posto in vetta ai global rankings. Un
sistema funzionale e funzionante, incardinato su valori deontologici e
morali ineccepibili, che si ritrova allo scoperto, in balia di un governo
che non vuole mostrare le sue carte, ma che quasi quotidianamente
spara a altezza uomo – proponendo limitazioni all’ingresso degli studenti universitari, liste dei dipendenti stranieri da far pubblicare alle
aziende, e negando ogni consulenza sulla Brexit-strategy agli accademici stranieri. “Brexit means Brexit”, ripete tautologicamente Theresa
May, mentre il partito laburista alterna finti sentimenti europeisti alla
sempre spendibile carta del “lavoro inglese ai lavoratori inglesi”. E
con lo Ukip in anarchia dopo l’uscita di scena (provvisoria?) di Nigel
Farage, gli unici che sembrano essere consapevoli della posta in gioco sono i Liberal-Democratici di Tim Farron.
La prima reazione del mondo universitario britannico è stata quella, tutta umana, di negare la realtà, nell’onirica convinzione che nulla
sarebbe successo. Poi, con il trascorrere della piovosa estate inglese,
l’edificio immaginato solido inizia a scricchiolare: i colleghi ‘del continente’ cominciano a porsi interrogativi sull’opportunità di presentare insieme agli inglesi progetti di ricerca a Bruxelles, nella consapevolezza che una collaborazione con le università britanniche potrebbe
compromettere il buon esito del progetto. L’incubo inizia a prendere
la forma di paesi vicini e lontani: “facciamo come la Norvegia”, “No,
saremo come la Svizzera”, peccato che la Svizzera urla il nome di
Nicola Polloni - L’ombra di Brexit sull’accademia inglese 305
Admeto mentre viene fatta fuori dai fondi di ricerca europei per colpa
del loro referendum sulla libera circolazione, ed è difficile non vedere
l’ombra di Brexit in tutto questo.
È difficile immaginare come sarà il mondo accademico britannico
fra qualche anno. Anzi, è davvero inimmaginabile, per via delle
troppe incognite che si frappongono a qualsiasi previsione. Il sistema
universitario inglese si regge su alcuni pilastri che dovranno essere
mantenuti saldi per evitare un tracollo: il cospicuo numero di studenti
stranieri, specialmente a Oxford e Cambridge; l’apertura ai ricercatori
internazionali, sia tramite la loro integrazione nel sistema che tramite
l’accesso a progetti trans-nazionali; un cospicuo finanziamento statale, tale da far andare avanti una macchina complessa e impegnativa.
Senza libertà di movimento e senza accesso al mercato europeo, con
tutte le ripercussioni a livello economico di quest’ultimo fattore, questi aspetti caratterizzanti l’università britannica potranno sopravvivere? La risposta a questa domanda sarà la chiave per comprendere il
futuro dell’istituzione accademica di questo paese.
Il governo May, comprensibilmente, non vuole esporsi pubblicamente prima di iniziare le trattative con Bruxelles. Nel frattempo
il concetto di hard Brexit prende corpo e sostanza, mentre Donald
Tusk si dice speranzoso che il Regno Unito alla fine resti in Europa.
Quattro mesi dopo il referendum. Nel contempo, il nuovo foreign secretary, Boris Johnson, risponde con il sorriso in faccia all’interrogazione parlamentare di Alberto Costa, deputato (conservatore) del
South Leicestershire, che gli chiede se gli italiani saranno benvenuti
in Gran Bretagna dopo Brexit: “Vabbè! Tutti li itali sono benvenuti
alla Londra!”, risponde Boris in ‘italiano’, e immaginiamo che lo siano anche fuori dalla capitale inglese. Il problema è che in una tale
schizofrenia della comunicazione politica – in cui i media inglesi,
famosi per il loro peculiare approccio all’informazione, grufolano e
sguazzano in allegria– più di due milioni di cittadini europei cercano
risposte sul loro futuro in questo paese.
Ma è la Gran Bretagna. Un paese che storicamente ha sempre
oscillato tra vedersi impero o isola, tra volere tutto e non volere che
se stessa. Londra da anni ormai è la capitale culturale e sociale d’Europa, dove ogni anno migliaia di giovani europei si trasferiscono e
costruiscono, fanno vacanze o progetti, lavorano e studiano. In altri
paesi e altre culture, anche solo il ruolo ‘culturale’ (per non dire economico e finanziario) che Londra ha nel contesto europeo avrebbe
306 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
dato adito a ben altri sentimenti verso il continente, dove la Gran
Bretagna avrebbe potuto giocare un ruolo egemone che adesso è indubbiamente tedesco. Ma paradossalmente, in tanti a Londra sentono
più vicino il Commonwealth che la UE.
L’università inglese sopravviverà a tutto ciò. Se ci sarà una soft
Brexit, tutto sarà come prima. Se invece sarà una hard Brexit, il sistema dovrà lottare per mantenere i suoi altissimi standard di formazione
e di ricerca, e trovare un modo per garantire l’ampio respiro internazionale dei suoi ricercatori e dei suoi studenti. È qualcosa che già
vediamo dall’altra parte dell’oceano atlantico, negli Stati Uniti, dove
un rigido sistema di salvaguardia dei confini non ha in alcun modo
compromesso lo sviluppo di un sistema accademico d’eccellenza, nel
quale ogni anno sono integrati migliaia di ricercatori e studenti stranieri, fornendo quella linfa vitale che in altri paesi, come l’Italia, è
purtroppo scarsa. Il vero pericolo per il mondo accademico inglese,
e per la Gran Bretagna in generale, è che il tessuto sociale non si
rimargini, e che le ferite aperte dal referendum non vengano finalmente sanate. Ma per fare ciò è necessaria un’azione politica mirata
ed efficace, che al momento non sembra avere attori possibili nei due
maggiori partiti britannici.
Nota sull’avvenire delle nostre scuole:
università e formazione
in Germania e in Europa
Rolando Vitali
Se è vero che allo stato attuale, posta l’impossibilità oggettiva di divenire soggetti in senso forte, l’esperienza individuale ha perduto ogni
primato, contemporaneamente, è proprio in essa che si manifesta più
che altrove tale impossibilità: è a partire da essa, dunque, che scegliamo di descrivere la miseria della triste scienza che, prima della sua
integrazione nel sistema della produzione cognitiva, ha rappresentato
l’avanguardia filosofica della tarda modernità. Mi riferisco alla teoria
critica o, più in generale, a quell’esigenza profondamente patita che
spingeva la filosofia e più in generale le scienze umane a farsi carico del presente, per afferrare il proprio tempo nel concetto e in esso
realizzarsi.
L’esperienza universitaria che ho svolto in Germania mi ha mostrato come le teorie critiche, nelle sue variegate configurazioni, siano
ormai divenute patrimonio acquisito dell’insegnamento accademico:
più ancora che gli autori di riferimento, è il sistema stesso di insegnamento, incentrato sul modulo seminariale, che sembrerebbe promuovere la coscienza critica attraverso la valorizzazione del contributo
personale all’interno del processo educativo. Dal sistema italiano si
differenzia principalmente per questi due aspetti che, come vedremo,
sono tra loro intrecciati: primato del seminario sulla lezione frontale
e maggiore integrazione delle teorie critiche all’interno del corso di
studi. Potremmo rallegrarci del fatto che finalmente l’accademia europea si stia muovendo verso l’abbandono di ogni verticalità nell’insegnamento, promuovendo lo spirito critico degli studenti attraverso
un ridimensionamento del primato autoritario della figura professora-
308 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
le e attraverso il riferimento ad autori eretici ed eccentrici rispetto alla
tradizione consolidata.
Ma in questa evoluzione si esprime anche qualcosa di problematico.
Per capire quello che sta succedendo e cosa nasconde questa “deriva antiautoritaria”, è necessario prendere preliminarmente in considerazione la posizione che la formazione universitaria occupa nel
nostro presente: da quando lo Stato ha smesso di essere l’elemento
di compensazione del sistema produttivo per diventarne l’appendice
infrastrutturale, anche la funzione della formazione universitaria ha
cambiato il proprio senso e la propria destinazione. Il patto borghese,
che faceva dello stato la macchina burocratica destinata a strutturare,
dirigere e organizzare il sistema produttivo, ha smesso di avere corso:
lo Stato da tempo ha abdicato alle sue funzioni tradizionali per assumerne altre e, in questo contesto, si è fortemente ridimensionato il suo
fabbisogno di forza lavoro intellettuale sia nella forma di un corpo
insegnante e accademico e sia di una classe dirigente culturalmente
progredita. Trasformatosi in quadro infrastrutturale del sistema produttivo, ha assunto la funzione esclusiva di fornire a quest’ultimo la
forza lavoro qualificata di cui esso abbisogna.
Che cosa ha che fare questo con la teoria critica e con l’empowerment garantito all’espressione personale e autonoma all’interno dei
seminari? Rispetto alla lezione frontale, incentrata sulla trasmissione
e sull’acquisizione di un sapere, il seminario si articola sul momento performativo favorendo l’acquisizione di competenze dinamiche.
Facendo del seminario, dove le capacità performative hanno il primato su quelle contenutistiche, il fulcro del sistema educativo, è chiaro
come la acquisizione di competenze di vario genere (argomentative,
analitiche, di scrittura ecc.) assuma progressivamente la precedenza
sulla trasmissione di un patrimonio culturale. Il sistema produttivo
al quale si rivolge l’insegnamento universitario non ha infatti bisogno di professori, più o meno competenti nelle rispettive materie,
ma di persone capaci di gestire competenze miste e indeterminate,
di manipolare contenuti culturali di vario genere, di organizzarli, di
presentarli, e di tradurli all’interno di un contesto di produzione culturale. La necessità quindi di confrontarsi con l’autorità del professore,
riconosciuto come fonte di un sapere e di un potere incarnato dallo
Stato, così come quella di acquisire la coscienza storica e culturale
del proprio passato, divengono del tutto anacronistiche: la figura del
professore è sempre più simile a quella del coordinatore del gruppo di
Rolando Vitali - Nota sull’avvenire delle nostre scuole 309
discussione, la cui tutela garantisce la trasmissione delle competenze
argomentative al resto della classe. Il rapporto con l’autorità verticale,
propria della condizione borghese, è sostituito dall’orizzontalità competitiva dell’agone performativo. In questo contesto, lo spirito critico
diviene strumento e competenza da acquisire piuttosto che risultato
della formazione. Contemporaneamente, però, viene surrettiziamente privato di ogni contenuto, nella misura in cui la coscienza viene
schiacciata sul primato del contemporaneo. Per chiarire questo punto,
potremmo richiamare l’inizio del nostro appunto: laddove vengono a
mancare le condizioni per la soggettività di essere autonoma, la sua
affermazione immediata si ribalta in oggettività eteronoma. Detto in
altri termini, la soggettività si scopre tanto più vacua quanto più crede
di esprimere immediatamente se stessa, prima di ogni rapporto con
la cosa stessa: l’invito a “esprimere la propria opinione” al di qua di
ogni rapporto con il contenuto, prima di ogni conflitto reale con l’autorità, si trasforma in riproduzione del common sense, del sentito dire,
di quella δόξα che, in quanto oggettività non mediata, rappresenta il
problema (l’ostacolo) di ogni pensiero non reificato.
La posizione delle scienze umane all’interno del sistema produttivo è specifica: da un lato, gli elementi culturali e storici che ne rappresentano il contenuto sono sempre meno necessari in quanto tali,
dall’altro il tipo di competenze miste che il loro studio può garantire
sono particolarmente adatte alla transizione del lavoro verso i nuovi
modelli di gestione del capitale umano, basati su rapporti cooperativi
e orientati alla produzione cognitiva. Alla loro inattualità sul piano
contenutistico fa da contrappeso la specifica “intersezionalità” e dinamicità del loro studio, il quale per principio rifiuta ogni acquisizione
meccanica: tale specificità si concretizza in competenze sintetiche e
gestionali che spesso lo studio delle materie scientifiche non riesce
a garantire. Per questo, tutto sommato, il loro contributo continua
ad essere richiesto dal mondo produttivo. Lo spirito critico diviene
così elemento strategico di quelle entrepreneurial skills, che vanno
implementate attraverso «new and creative ways of teaching and learning»1. Ma, sempre per questo, la promessa del pensiero critico,
1
“Rethinking Education:Investing in skills for better socio-economic outcomes”,
Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social comittee and the comittee of the regions. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389776578033&uri=CELEX:52012DC0669
310 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
deprivato di ogni contenuto, diviene menzogna: trasformatosi in strumento, separato da ogni contenuto concreto, lo spirito critico diviene
una «transversal key competence» necessaria a promuovere il proprio
capitale umano sul mercato del lavoro, piuttosto che la possibilità di
pensare la società nella sua complessità. La capacità critica, da forma
dell’autocoscienza, regredisce a trasfigurazione di quella «appropriate aggressiveness» che secondo la rivista “Time” sarebbe caratteristica propria delle persone di successo2.
In Germania, come sempre più anche nel resto d’Europa, l’insegnamento della filosofia è del tutto marginale, se non del tutto assente, all’interno del percorso scolastico obbligatorio: per questo è
stata possibile la netta distinzione delle carriere, da un lato, per coloro
che diventeranno inseganti di “Etica” o, molto raramente in alcuni
Länder, di Filosofia nelle scuole secondarie e, dall’altro, per coloro che invece saranno indirizzati nella stragrande maggioranza dei
casi all’inserimento nel mondo produttivo e, per una minima parte,
alla carriera accademica. Proprio questa divisione, questa separazione della filosofia, e più in generale delle scienze umane, dalla formazione e dall’educazione dei futuri membri della comunità rende
però la trasmissione del suo patrimonio privo di ogni senso: ad un’accademia, chiusa sia al sistema produttivo che alla formazione e in
questo modo condannata all’autofagia, corrisponde l’assimilazione
del pensiero critico alle dinamiche di mercato, sia soggettivamente,
trasformandosi in competenza individuale che, oggettivamente, assimilandosi a prodotto culturale di consumo3. Nel momento in cui
l’educazione individua il proprio paradigma nella formazione del
personale aziendale il senso e lo scopo delle scienze umane vengono
a mancare del tutto: la trasmissione della coscienza storica, politica
e culturale di una civiltà è essenzialmente orientata alla formazione
del cittadino pubblico, dell’uomo libero reso capace di esistenza politica. Viceversa, l’educazione rivolta alla persona privata non può
che avere il carattere dell’eteronomia: infatti, l’individuo che agisce
come capitale umano all’interno del mercato del lavoro si esercita nel
sistema dei bisogni, ossia a partire da una necessaria subordinazione.
Solo nel momento in cui l’educazione fa riferimento all’individuo
2
Dan Kadlec, «5 Signs You Will Become a Millionaire», March 5, 2015.
Cfr.. Barbara Carnevali, “Contro la Theory. Una provocazione”, Le parole e le
cose, 19 settembre 2016: http://www.leparoleelecose.it/?p=24320
3
Rolando Vitali - Nota sull’avvenire delle nostre scuole 311
come soggetto politico, ossia come membro della comunità, diviene
necessaria l’acquisizione di una coscienza storica e culturale capace
di permettere un’autonomia etica, autocosciente di sé e del mondo
che abita.
La rimozione dell’autorità nel mondo inconciliato diviene
menzogna.
Il mondo della formazione deve partire da queste contraddizioni
se vuole dare un futuro al progetto politico europeo: fino ad ora l’Europa non si è voluta costituire come Stato, ossia come costruzione
etica comune. Al contrario, come apparato tecnico-burocratico, si è
finora orientato alla dissoluzione di tale possibilità: l’esclusivo interesse a coprire il “fabbisogno di qualifiche” necessarie al sistema
produttivo che manifestano tutte le direttive europee in fatto di educazione, risponde all’esigenza di competitività del sistema economico
rimuovendo la dimensione etica e storica che soltanto può dare contenuto alla creazione di un progetto politico.
Letture/Eventi
Karl Jaspers, Della verità. Karl Jaspers, Von der Wahrheit.
Philosophische Logik. München, Piper, 1947. A cura di Diego
D’Angelo, Della verità. Logica filosofica. Milano, Bompiani,
2015.
Infinite le onde, nessuna onda è uguale alle altre. Sempre tutto in movimento. Da nessuna parte la stabilità […] vedere questo mare è per me,
da allora, la cosa più superba.
– Karl Jaspers, Un autoritratto1
Introduzione
Nel vangelo di Luca c’è l’episodio di quel tale che va dall’amico a
mezzanotte per chiedergli del pane. Questi, infastidito, cerca di disfarsene. Il testo greco suona: «Μή μοι κόπους πάρεχε» (Lc 11, 7)
– letteralmente: “non mi dare colpi”, quasi che l’insistenza della richiesta dell’amico sia un venir preso a pugni. Alla fine, sfinito, cede
e dà il pane.
Ecco, qualcosa del genere succede anche a leggere Della verità.
È un colosso di oltre mille pagine, ripetitivo di proposito e indigesto
alle volte, in certi passaggi piegati su di sé. Jaspers prende a colpi il
lettore. Ma non come uno Hegel, per esempio, che picchia asciutto e diritto. Jaspers colpisce sui fianchi, taglia il fiato e temporeggia
nell’oscurità.
In questa recensione dell’edizione italiana di Della verità – recensione di necessità parziale, perché parziale è la mia conoscenza di
Jaspers e immensa l’opera sua – si cercherà di far tre cose: presentare
qualche notizia storica intorno al testo, afferrarne il nocciolo teorico
(questa è la parte filosoficamente più importante) e discutere in breve
l’edizione e la traduzione italiana.
Alle citazioni dal volume fa seguito, tra parentesi tonde, il numero di pagina (in numeri romani le citazioni dal Saggio introduttivo del
curatore).
1
Il video dell’intervista è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=l7eo7Dzyuwo [ultima consultazione: 11/11/2016], traduzione mia.
316 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Storia del testo
Jaspers lavora a Della verità durante i suoi anni più difficili, mentre
è imprigionato nella sua casa di Heidelberg con la moglie Gertrud a
causa delle origini ebraiche di lei. Proprio a lei dedica il libro2, che
diventa sostanza delle loro giornate. Jaspers scrive nel suo diario:
«Solo questo lavoro giustifica la mia esistenza nel mondo» . Un altro
passaggio suona: «nel mondo non c’è per noi altro da fare […] con
l’unico presupposto, che io e Gertrud rimaniamo intimi, vicini, fedeli,
poiché il lavoro potrà essere compiuto solo da noi due assieme, oppure affatto» (XVII-XVIII).
Il libro, nel progetto dell’autore, sarebbe dovuto essere il primo
dei quattro volumi della sua logica filosofica, ma fu, nei fatti, l’unico
portato a compimento – insieme a Essere e tempo di Heidegger, quindi, Della verità è un altro grande non-finito divenuto classico della
filosofia del Novecento (XIII).
Esso venne mandato fuori nel 1947 dall’editore Piper di Monaco,
tra parecchie difficoltà: la diffusione di un libro tale, in sé già ardua, lo
fu ancor di più dopo la guerra sia per motivi logistici, sia perché altri
erano i problemi urgenti del dibattito, cui, del resto, lo stesso Jaspers
partecipa da subito, per esempio con il celebre La questione della
colpa [Die Schuldfrage] del 1946 (cfr. XIII).
Veniamo, ora, alla seconda cruciale parte: la cosa stessa.
Consideriamo che cosa si pensa in questa logica filosofica.
La cosa stessa
Cerchiamo di afferrare in pochi paragrafi, attraverso una lettura immanente, oggetto e metodo del testo, guadagnandone almeno una visione
d’insieme e facendo venire alla luce almeno alcune tesi fondamentali.
2
Sull’importanza umana e intellettuale di Gertrud per il marito mi permetto di
rinviare a un mio contributo apparso sullo scorso numero di questa rivista: La società
Karl Jaspers di Oldenburg: un resoconto. Disponibile qui: http://www.incircolorivistafilosofica.it/loffi-societa-karl-jaspers/ [ultima consultazione: 11/11/2016].
Letture 317
Oggetto
L’oggetto di Della verità, s’è detto, è la logica filosofica3. Essa non è
per Jaspers la scienza delle inferenze corrette: la logica formale o logicistica [Logistik], come l’autore la chiama. Essa è, invece, il pensiero di ciò che è primo, fondamentale – dell’essere, che Jaspers battezza
con la felice parola das Umgreifende, ben tradotta qui con l’italiano
“l’abbracciante”4.
Jaspers critica un presupposto, che è un pregiudizio, capitale
della filosofia: la riduzione della questione dell’essere alla questione
dell’oggettività [Gegenständlichkeit] e della questione della verità a
quella della correttezza (72) – tema, questo, in comune con Heidegger.
L’abbracciante non è un oggetto come gli altri – nell’abbracciante ci
sono gli oggetti e la loro dialettica. Dell’abbracciante non si può parlare allo stesso modo in cui si parla degli oggetti. «La questione filosofica a cui l’intera logica filosofica deve fornire risposta è dunque:
in che modo questo elemento insuperabile può divenire presente per
noi e procurare per la prima volta un senso e un fondamento a tutto il
nostro pensiero ulteriore e al nostro essere?» (75).
E, dunque, di questo fondo oscuro si tratta – fondo oscuro che
subito si articola in modi distinti, a seconda del rispetto da cui lo si
guardi.
I) Se si considera l’oggettività, ciò che noi non siamo, l’abbracciante può prendere l’aspetto del mondo o della trascendenza. Il mondo è l’oggettività alla mano, lo spazio in cui viviamo. La trascendenza è ciò che sfugge all’occhio e solo si annuncia nelle cifre e nelle
situazioni-limite.
II) Se si considera, poi, la soggettività, ciò che noi siamo, l’abbracciante può prendere l’aspetto dell’esserci, della coscienza in
generale, dello spirito e dell’esistenza. L’esserci è l’uomo in quanto
essere fisico, biologico, che c’è da qualche parte. La coscienza in generale è l’uomo in quanto conosce in maniera scientifica e impersonale. Lo spirito è l’uomo in quanto membro della cultura, dello stato
e di ogni consorzio umano. L’esistenza è l’uomo, da ultimo, come “io,
Molto efficace la sintesi del pensiero di Jaspers di: Bärbel Frischmann, Existenz/
Existenzphilosophie/Existenzialismus, S. 186. In: Horst D. Brandt (hrsg.), Lexicon
der Philosophie. Ein Kompendium. Hamburg, Meiner, 2014, Ss. 182-193.
4
Jaspers chiama la sua teoria dell’abbracciante anche col neologismo periecontologia (XXXIII), dal greco περιέχω, “circondo”, “abbraccio”.
3
318 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
quel singolo”, nella sua identità unica e irriducibile, nelle sue tensioni
e aspirazioni.
III) La ragione, infine, è l’ultimo modo dell’abbracciante – ma
non come l’ultimo anello di una catena, come un +1 alla fine; piuttosto, essa è la serie intera degli anelli, la catena guardata tutta intera.
La ragione è, in sostanza, la consapevolezza che l’essere si articola
in questi modi, irriducibili l’un l’altro e, insieme, in comunicazione
l’un l’altro. In ciascuno di essi, il pensare ha uno stile particolare e la
verità ha uno stile particolare. Per dirla in modo triviale: non posso
risolvere i miei problemi di esistenza singola attraverso il pensiero
della coscienza in generale, e viceversa.
Ogni abbracciante, allora, ha una sua assolutezza e, insieme, non
basta a se stesso: ogni abbracciante è un terreno coi propri metodi e
problemi e verità, ma nessuno di essi è l’essere tutto intero. La ragione, piena di vigore dialettico, tenta di trovare l’assoluto in ogni
abbracciante e va ogni volta incontro a un «fallimento peculiare»
(107). Scopre il limite e sfonda in direzione di un altro abbracciante.
Sfondare [durchbrechen] è fondare. Questa è l’operazione filosofica
fondamentale, contro ogni falsa assolutizzazione [Verabsolutierung]
e per mostrare la complessità della realtà nella sua «pluridimensionalità» [Vieldimensionalität] (57).
Jaspers riassume così la natura e il compito di questa logica in
movimento: «La logica non può essere conclusa: l’esistenza del pensatore, che cerca la propria chiarezza nella ragione, conduce, nell’esserci temporale, al fatto che la ragione è insoddisfatta di fronte ad
ogni chiusura. La ragionevolezza sistematica [Die systematische
Vernünftigkeit] non diventa mai un sistema della ragione [System der
Vernunft]» (22). Egli adopera volentieri la metafora dell’oscillazione
[Schwebe] (211) per designare questo continuo dileguare e afferrare.
Di qui segue anche che questa logica non è pura teoresi, ma anche
ethos: essa, da una parte, ha la sua realtà sempre in una situazione
concreta, nell’esistenza di chi pensa; dall’altra, una delle parole chiave del libro di Jaspes è innewerden, “prendere consapevolezza” (cfr.
XXVI): consapevolezza della complessità dell’essere e, perciò, anche
di se stessi – consapevolezza della prudenza e dell’attenzione che la
ricerca della verità richiede e della precarietà di questo cercare. Ecco
perché, nell’ultima parte del libro, si trovano temi non classicamente
facenti parte della logica, come l’autorità o il tragico.
Letture 319
Metodo
Se l’abbracciante non è oggetto fra gli oggetti, allora il discorso
sull’abbracciante non può essere discorso fra i discorsi. Quale è, dunque, il metodo di questa logica filosofica – la logica di questa logica?
Un professore di logica mi ha confidato che, quando cerca esempi di ragionamento fallace, li cerca in Jaspers. C’è della verità qui.
Sull’abbracciante non si può fare, per principio, un discorso tetico,
cioè che pone, definisce in modo netto, e deduttivo. Un’efficace
espressione di Pietro Prini può essere adoperata qui: si ha a che fare
con una metodologia dell’inverificabile.
Jaspers battezza il suo metodo di ricerca intorno all’abbracciante
erhellende Darstellung, “rappresentazione rischiarante”. La metafora
è quella del pensare come luce (70) che cerca di schiarire un poco
ciò che, per principio, non può illuminare completamente né direttamente, ma solo muovendosi «di traverso» (107). L’inoggettivabilità
dell’abbracciante è il basso ostinato metodologico del libro.
Questo metodo si serve della strategia della ripetizione
[Wiederholung5]. Jaspers, di solito, pone una domanda molto generale
– del tipo “cos’è il linguaggio?” o “quale è il rapporto tra pensiero ed
essere?” – e, quindi, enumera e descrive6 possibili punti di vista e soluzioni. Poi riformula la domanda spostando appena l’accento, o pone
un’altra domanda non troppo lontana, dove ricompaiono i temi appena trattati, ma attraversati secondo tragitti un po’ diversi. Ci si ritorna
sopra, di nuovo, e si mostra dell’altro. Passaggi come: «Dobbiamo
ricominciare ancora una volta dall’inizio, per cogliere l’esser-vero in
tutta la sua portata, almeno nella misura in cui questa può essere a noi
accessibile» (905) si incontrano di frequente.
Le stesse cose sono ripetute così spesso che, invece di diventar
chiare e fissarsi in testa, sfuggono, sfumano. La chiarificazione, scrive Jaspers, «deve rimanere equivoca e indeterminata [vieldeutig und
unbestimmt] nelle sue proposizioni» (119). E perciò egli fa largo uso
della metafora e, in generale, di significazioni non univoche: «ogni
Il tema della ripetizione è già di Kierkegaard, che pubblica nel 1843 La ripetizione. Un esperimento psicologico.
6
Nel descrivere continuo e minuzioso mi pare si possa ravvisare il piglio fenomenologico tipico di molta filosofia tedesca dell’epoca. Sul ruolo del metodo fenomenologico in Jaspers si veda, per esempio, la voce a lui dedicata nella Stanford
Encyclopedia of Philosophy – http://plato.stanford.edu/entries/jaspers/ [ultima consultazione: 11/11/2016].
5
320 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
rapporto fondamentale può essere espresso solo con una metafora»
(138).
Jaspers adopera continuamente la metafora dell’“andare in cerchio”: «La chiarificazione rimane nel tutto, si muove circolarmente
in sé [kreist in sich] e non ha alcuna conoscenza settoriale» (117).
Come accennato, il polo opposto alla chiarificazione è il conoscere
[Erkennen] che verte sul finito, «separa e non trova più, a partire da
sé, l’unico tutto, una volta che lo ha perduto» (ibid.).
Una duplicità di metodi simile si trova, del resto, già nei primi
lavori psichiatrici e psicologici di Jaspers: lì alla spiegazione causale
dei disturbi della psiche, che include anche le cause materiali e l’indagine fisiologica del cervello, viene messa accanto la comprensione
del vissuto del paziente, che è inteso, in questo senso, come esistenza
unica e mai fino in fondo afferrabile nella sua complessità7.
Ne segue anche che la filosofia viene spogliata di uno dei suo caratteri classici: la cogenza, cioè la necessità dimostrata delle sue tesi
che deve essere accettata. Il risultato della chiarificazione «non può
essere provato come un risultato. Dunque è inutile obbligare colui che
dubita al riconoscimento per mezzo di argomenti» (277). La chiarificazione dà indicazioni [Hinweise] con cui «richiamare qualcosa alla
mente [erinnern], pur non potendolo dimostrare [beweisen]» (279).
Tutto questo, naturalmente – lo si dica ancora una volta – è un
tratteggio a grandi, grandissime linee.
L’edizione italiana
Eccoci all’ultimo punto: qualche parola sull’edizione italiana di Della
verità. Il volume fa parte della collana Bompiani Il pensiero occidentale, che manda fuori libri sempre belli, con ricche introduzioni, il
testo a fronte e il glossario alla fine.
Del Saggio introduttivo menziono solamente un aspetto: mi pare
equilibrato, perché dà di Jaspers un’interpretazione non univocamente esistenzialista come spesso si trova nella letteratura secondaria8 e
Su questo è molto chiaro il libro di Giuseppe Cantillo, Introduzione a Jaspers.
Roma-Bari, Laterza, 20022.
8
È il caso, per esempio, di Jeanne Hersch (XXXVIII, nota 102), cui si possono aggiungere: Giorgio Penzo, Jaspers. Esistenza e trascendenza. Roma, Studium,
7
Letture 321
insiste giustamente sul carattere speculativo che la sua logica ha. Nel
Saggio è citato un ottimo passaggio di Enzo Paci che suona: «la sua
filosofia non tende all’irrazionalismo, ma ad una nuova logica che,
nella sua forma negativa, rende possibile la comprensione dell’irrazionale e cioè dell’esistenza […]. La vera logica filosofica è quella
che contraddice se stessa, la vera forma della logica è il circolo»9
(XXXIX, nota 105).
Questo volume, poi, contiene la prima traduzione integrale,
italiana e in assoluto, di Della verità, preceduta finora soltanto da
traduzioni parziali (IX-XI). Chi scrive – è opportuno dirlo – non è
né un germanista né un esperto in queste questioni, e pertanto, con
estrema circospezione e misuratezza, dirò solo qualche parola sulla
traduzione.
Com’è normale, ci sono lapsus calami. Ho trovato, per esempio:
“il sapere filosofico” invece del corretto “il sapere logico” (11), “costitutivamente” invece di “costruttivamente” (39), “senza soluzione
di continuità” invece di “con soluzione di continuità” (121 e
126) e così via.
Più interessante è, in ogni caso, un’altra questione: quella di traducenti che possono esser considerati tanto buoni quanto poco aderenti. Qualche esempio. Sphären (sfere) è tradotto con “ambiti” (13);
wir… ins Leere fallen (noi… cadiamo nel vuoto) con “salto nel vuoto” (65); sprechen (parlare) con “mettere a tema” (173); das Letzte
(l’ultimo) con “punto d’arrivo” (249).
Allora, la domanda (filosofica) è: quale è il metodo del tradurre?
Nella Nota editoriale si legge: «Metodologicamente si è ricercata una
traduzione il più possibile sobria e aderente al testo originale, soprattutto nelle scelte lessicali, ma che non imponesse alla lingua d’arrivo
di plasmarsi su strutture a lei aliene» (LXV). Ma, allora, fa problema
proprio lo spazio vuoto tra l’originale e la traduzione: in che modo –
con che metodo – si è tradotto sì da non imporre all’italiano le strutture del tedesco di Jaspers (che, a quel che mi sembra, non è un tedesco
impossibile, tutto sommato)?
Non posso non citare Croce, il cui lavoro di traduzione dell’Enciclopedia di Hegel mi sembra notevole per chiarezza metodologica
1985, ed Emanuele Severino, La filosofia contemporanea. Milano, Rizzoli, 1986, pp.
234-242.
9
La citazione è da Enzo Paci, L’esistenzialismo. Padova, CEDAM, 1942, p. 50.
322 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
e, quindi, per giustezza di quel metodo tanto chiaro – il metodo del
calco. Scrive Croce: «La presente traduzione è quasi letterale, essendomi studiato di conservare non solo il significato astratto, ma anche
la lettera e l’impronta dell’originale; e perciò non ho usato neppure di
questa libertà di sostituzioni terminologiche e di parafrasi interpretative, che ha adoperata il traduttore inglese. Più che un ritratto, questa
mia traduzione è, dunque, e ha voluto essere, un calco. So bene ciò
che si può addurre contro un tal metodo; ma ogni metodo di traduzione è difettoso, e, tutto considerato, credo che per un libro di filosofia,
e per un libro di Hegel, quello da me adottato sia il meno cattivo»10.
Sia come sia – e poi, certo, è facile tirare al bersaglio e criticare
questo e quello. Il lavoro di traduzione di Della verità è immenso e il
traduttore ha, prima di ogni altra cosa, il genuino merito d’aver colmato una grossa lacuna.
Infine
Se si volesse celiare (ma sarebbe una celia non falsa)11, si potrebbe
dire che Jaspers un tal libro ha scritto perché, prigioniero in casa, ne
aveva il tempo. La verità di questa celia sta qui: non si tratta di mero
tempo quantitativo, il tanto, ma di un tempo qualitativo, ampio, denso
e profondo – tre qualità che il lettore, leggendo, trova nel testo.
Non sono sicuro d’aver afferrato a pieno il senso di questo librone, ma di sicuro è un libro suggestivo. Il lettore respira l’atmosfera della ragione [Atmosphäre der Vernunft]: «Esiste per così dire
un’atmosfera della ragione. Essa si diffonde dove un occhio aperto
su tutto vede la realtà effettiva, le sue possibilità e la sua interpretabilità illimitata, dove questo occhio […] penetra in tutto ciò che è con
sincerità e giustizia, lo fa emergere, non maschera, né vela, né rende
nulla semplice ed univoco» (241).
Ne viene fuori, per dir così, una testimonianza. Anche tenendo
conto della situazione di esule in casa propria dell’autore, il libro dà
una testimonianza di serietà intellettuale e umana. Perché si vede
Benedetto Croce, prefazione a: Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, in: Hegel. Milano, Mondadori, 2008, vol 1, pag. LXXV
11
Mi sono qui preso la libertà di adoperare l’incipit con cui Croce apre il suo
Breviario di estetica (Bari, Laterza, 195813).
10
Letture 323
quanta cura ci è messa affinché nulla venga trascurato, perché è un
libro scritto nonostante tutto – nonostante le avversità e lo stato di
prostrazione spirituale che ha o avrebbe potuto toccare Jaspers (philosophia vera libertas). Perché, infine, questa filosofia non cerca la
novità ma l’essenziale: infatti, secondo Jaspers, non c’è quasi niente
di nuovo nella storia della filosofia. «Il mio pensiero fondamentale
nella sua articolazione è nuovo solo apparentemente. Non può essere
autenticamente nuovo per il fatto che io ho trascorso la mia vita nella
coscienza di non scoprire altro che una verità ancestrale. Nella filosofia la novità è contraria alla verità. Una volta sola nel corso di diversi
millenni appare qualcosa di veramente nuovo […] la mia filosofia si
nutre ad ogni passo della tradizione. Nel mio pensiero vedo la conclusione naturale e necessaria del pensiero occidentale fino ad oggi»
(387).
Oppure ancora, in un altro passaggio: «La filosofia, attraverso i
millenni, è come un unico inno alla ragione» (241).
Andrea Loffi
324 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Fabiola Falappa, Sul confine della verità. La metafisica di
Karl Jaspers e il futuro della coscienza europea, Milano:
Franco Angeli 2016.
Non è amplissima la produzione scientifica sulla filosofia di Karl
Jaspers, né entro i confini nazionali né sul panorama internazionale.
Tanto più è dunque da stimare l’intraprendenza di nuove voci che,
in un’atmosfera accademica sempre più sclerotizzata sui temi oggi
di moda che permettono di fare incetta di citazioni, si rivolgono con
onestà intellettuale ad uno studio concreto di un pensatore che ha ancora tanto da offrire. Il pensiero jaspersiano, pur nei riconosciuti limiti della sua impostazione, si presta a percorsi di ricerca inesplorati,
e proprio su uno di questi si muove lo studio di Fabiola Falappa, docente a contratto di ermeneutica filosofica all’Università di Macerata,
dal titolo Sul confine della verità. La metafisica di Karl Jaspers e il
futuro della coscienza europea. Così l’Autrice condensa lo scopo del
saggio: «il progetto del presente lavoro è […] quello di approfondire
teoreticamente la visione metafisica di Jaspers per poi attingere da
essa alcune indicazioni veramente fondamentali per dare un apporto
ad una nuova fioritura della cultura europea nel contesto problematico
di un mondo pericoloso e smarrito come quello odierno» (p. 14).
Come si vede, l’approccio dello studio in questione è ampio: temi
epistemologici (la verità) e di stampo criticista (il concetto di confine)
si legano ad un’indagine della metafisica e a questioni di filosofia
pratica come l’identità europea. Ora, non si tratta qui però, come una
facile obiezione potrebbe sostenere, di un patchwork di temi scelti
arbitrariamente o magari – peggio ancora – del tentativo di far stare
insieme singoli articoli già pubblicati altrove e trasformati solo nella
veste editoriale. Tutt’altro: il libro della Falappa segue un tema coerente, che vuole appunto dimostrare in prima linea l’indissolubilità, nell’impianto teoretico jaspersiano, tra il piano teoretico e quello
pratico. In questo senso l’Autrice conia, appunto per definire questo
impianto teoretico, la formula, forse un po’ ostica di primo acchito
ma azzeccata, di “criticismo testimoniale”: la filosofia di Jaspers è, in
altre parole, una filosofia teoretica essenzialmente critica, la quale si
radica però nell’esistenza pratica dell’individuo, che viene portata a
testimonianza appunto dalla riflessione filosofica stessa. Così l’Autrice: si tratta di un «criticismo rinnovato e integrale che, muovendo da
una matrice kantiana, si sviluppa originalmente grazie all’adesione
Letture 325
della persona intera alla ricerca filosofica […]. Al centro non c’è più
il tribunale della ragione, [ma] il viaggio del singolo nella vita […].
Con il coinvolgimento dell’esistenza nel sapere, [il criticismo testimoniale] supera i limiti della sfera logica propria dell’analisi trascendentale» (p. 29).
Il termine mira dunque ad un superamento della dicotomia tra
filosofia teoretica e filosofia pratica mostrando come, in ultima analisi, la metafisica jaspersiana sviluppata all’inizio degli anni ‘30 abbia
conseguenze decisive per la filosofia politica (e dunque per la riflessione sull’Europa) che il filosofo di Oldenburg articola a partire soprattutto dagli anni ’50. Ecco dunque che si vengono a tracciare tre
snodi principali dell’argomentazione: dapprima, l’Autrice disamina
la metafisica jaspersiana in senso lato, dedicandosi in particolare ai
temi del naufragio e della trascendenza così come questi vengono
delineati nell’opera Filosofia, uscita in tre volumi all’inizio degli anni
‘30. La filosofia di Jaspers – così ci sembra di poter riassumere la tesi
centrale di questo primo capitolo – non è una filosofia abbandonata
al nichilismo e alla negatività, come certi interpreti hanno creduto
di poter sostenere alla luce dell’importanza del tema del naufragio
come fallimento dell’essere umano, quanto piuttosto un pensiero essenzialmente positivo, che proprio nel fallimento vede il rilucere di
ciò che Jaspers chiama “trascendenza”. Si può dunque parlare di una
“esperienza metafisica”, che è l’esperienza della trascendenza stessa
per come essa si mostra nella prassi del fallimento.
Come vada compresa questa trascendenza diviene più chiaro durante la lettura del secondo capitolo di questo studio, dedicato ad
un’analisi serrata – una delle poche disponibili in lingua italiana fino
ad oggi – del capolavoro jaspersiano della maturità, ossia Della verità. Logica filosofica. In un’indagine di ampio respiro, che abbraccia
molti tra gli aspetti principali di quest’opera, l’Autrice mette in luce
come lo “sfondamento della verità” abbia qui proprio la funzione del
naufragio: far rilucere la trascendenza attraverso la trama di verità
prestabilite che, normalmente, non lasciano che si veda attraverso
(oggi, infatti, la verità è «non negata, ma semplicemente impensata,
fuori luogo», e si può dunque parlare di «irrilevanza culturale della
verità», p. 16). La verità è necessariamente molteplice, ha diverse “figure”, ma è nello sfondamento che si rende visibile anche quel senso
per cui la verità è una e unica.
326 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Che questa impostazione abbia delle conseguenze per la filosofia
politica che Jaspers sviluppa dopo la seconda guerra mondiale non
può sorprendere. La tesi secondo cui la verità è sempre prospettica
e figurale, pur essendo sempre “la” verità, evita sia, da un lato, qualunque relativismo culturale e qualunque lassismo etico, ma anche,
dall’altro lato, la possibilità di assolutizzare una qualche verità e farne
un dogma. La verità è la verità, si potrebbe dire, ma una verità (e ciò
significa: qualunque verità determinata, non “la verità” in generale e
in quanto tale) è sempre e soltanto una tra altre.
Dunque come Fabiola Falappa mostra in modo molto convincente alla fine del testo, la tesi jaspersiana dell’inscindibilità di vita e pensiero, di esistenza e teoresi, se pensata fino in fondo può portare «nuovi impulsi al pensiero metafisico europeo in una fase storica molto
problematica sia per il nostro continente che per il mondo intero»
(p. 13): la trascendenza è in primo luogo «la trascendenza del bene
comune» (p. 161). Si tratta di una tesi interpretativa di forte impatto,
che purtroppo viene giustificata, nel testo, più a livello associativo
che attraverso una rigorosa analisi testuale e concettuale. Ciò porta
a quattro “sfondamenti”: prima di tutto, ad evitare di rifugiarsi comodamente in termini negativi come “crisi” - e che si faccia un gran
parlare di crisi, soprattutto in Italia, e completamente a sproposito,
è innegabile -, riconoscendo invece il potere positivo dei naufragi e
dei fallimenti proprio per la creazione dell’identità di un popolo – nel
caso, quello europeo. Il secondo “sfondamento” del common sense
– così si potrebbero anche definire questi sfondamenti della verità
attualmente accettata – consiste nel rivendicare ai concetti di amore
e di fede (filosofica) un loro posto di diritto all’interno del pensiero,
senza essere relegati all’ambito delle facilonerie da giornaletto alla
moda. Il terzo “sfondamento” vuol superare quell’atteggiamento di
sonnolenza diffusa per cui il singolo individuo non può nulla di fronte ai grandi processi (sociali, economici, culturali...) di cui sarebbe
essenzialmente vittima. Se c’è una componente “esistenziale” nella
filosofia di Jaspers, questa va rintracciata proprio nell’accento sull’individualità, la scelta, la libertà del singolo (per altro in una direzione
che non rischia le derive più bieche di certi momenti della filosofia
heideggeriana). E il quarto sfondamento è appunto quello di ogni verità isolata, di ogni primato, sia esso razziale, locale, economico e
così via.
Letture 327
Fabiola Falappa dispiega notevoli doti ermeneutiche in questo
lavoro, celebrando l’opera di Jaspers pur tenendo la giusta distanza
critica e sviluppando il materiale in una direzione del tutto autonoma, senza avere paura a cimentarsi con grandi temi attuali che, in
una filosofia sempre più scolastica ed autoreferenziale, in molti casi
spaventano. Non in questo, appunto, e il testo contribuisce in maniera
marcata alla riscoperta di una verità che, jaspersianamente, è sfaccettata e multiforme ma rimane pur sempre la verità.
Diego D’Angelo
328 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Alberto Giovanni Biuso, Temporalità e Differenza, Firenze:
Leo S. Olschki Editore, 2013
Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio: fidenter tamen dico scire me, quod, si nihil praeteritet,
non esset praeteritum tempus, et si nihil adveniret, non esset futurum
tempus, et si nihil esset, non esset praesens tempus12.
Celeberrima citazione agostiniana che solleva un interrogativo altrettanto celebre e, da sempre, oggetto di dibattito. Cos’è il tempo?
Prospettive limitanti, tentando di inquadrare il tempo in categorie
puramente soggettive o in entità discrete fisicamente quantificabili,
hanno spesso ridotto la temporalità a semplice percezione interiore,
a realtà transeunte inferiore alla perfezione dell’eterno, al movimento inesorabile di un paio di lancette, al ticchettìo che scandisce la
quotidianità. Nessuno di questi sguardi esclusivi, tuttavia, è riuscito
a cogliere la differenza propria del tempo, pur nella costanza del suo
scorrere. Si può invece affermare che «il tempo è l’intero nel quale si
raccoglie l’infinito battito di identità e differenza»13.
È proprio questo il nucleo del pensiero di Alberto Giovanni
Biuso, il quale, in Temporalità e Differenza, affronta tale enigmatica
e affascinante questione, da un punto di vista ontofenomenologico.
Si tratta di un approccio alla temporalità «ricco e comprensivo»14,
che «accoglie le analisi e le ipotesi che le scienze dure, a partire dalla
fisica, formulano sul tempo e ne moltiplica il valore coniugandole con
la vita della mente, senza naturalmente confondere i livelli ma anche
senza disprezzare o rifiutare l’uno a favore dell’altro»15.
La concezione del tempo che emerge è frutto di un’analisi della
complessità del reale e del suo accadere:
la molteplicità dell’esistere è fatta di tempo saputo e di tempo vissuto, di
tempo cognitivo e di tempo fenomenico. La comprensione del tempo – e
Agostino d’Ippona: Confessionum Libri XIII, 396-398 d.C., trad. it. di C. Vitali,
Le Confessioni, Milano: Rizzoli, 1998, XI, 558.
13
Alberto Giovanni Biuso: Temporalità e Differenza, Firenze: Leo S. Olschki
Editore, 2013, 1.
14
Ivi, 88.
15
Ivi, 89.
12
Letture 329
non la rassegnazione all’ignorarlo – li coniuga in un sapere vivo, capace
di sentire e di vedere che il tempo è l’identità della linea generata dagli
eventi e la differenza degli eventi generati. […] Che dunque non è un
dato soltanto mentale ma non è neppure soltanto fisico. È la differenza
della materia nei diversi istanti del suo divenire ed è l’identità di questo
divenire in una coscienza che lo coglie16.
Temporalità e ontologia sono, pertanto, indissolubilmente legati.
Ogni corpomente che, come dispositivo semantico, interpreta e pensa
la temporalità, è costantemente immerso e pervaso da essa, tanto da
poter parlare di Zeitleib17. Come il tempo, nel suo flusso inesorabile
e costante, è anche discrezione degli istanti che lo compongono, così
ciascun Esserci, nel permanere della sua identità storica e finita, è tale
anche in virtù di ciò che non è, di ciò che si differenzia dal Sé che si è
costruito e che si costruisce, sempre nuovo, sempre diverso, ma anche
e sempre sul medesimo sfondo.
Questo legame, quando non identità, tra essere e tempo, in cui
«l’essere non è […] ma eventua, accade nel divenire»18, è la ragione
per cui
il tempo non si trascura impunemente: il tempo è quel non-so-che che
nessuno vede con gli occhi o tocca con le mani, di cui lo stesso orecchio
non percepisce direttamente il fluire, che non ha né forma, né colore, né
odore, che nessun pensiero concepisce, che non è né una dimensione,
né una forma, né una categoria, che è dunque, quasi-inesistente e che,
nonostante questo, è la cosa più essenziale di tutte. Se non si prende in
considerazione questo fattore invisibile e impalpabile, oltre che ineffabile, ci si espone ai più gravi disinganni19.
Disinganni profondi, reali, spesso dolorosi, che possono provocare sofferenza e instabilità psichica. Comprendere il proprio tempo nel
tempo infinito della materia è presupposto indispensabile per un’esistenza che possa dispiegarsi quanto più serenamente possibile in
16
Ivi, 111.
Cfr. ivi.
18
Ivi, 18.
19
V. Jankélévitch: La mort,1966, trad. it. di V. Zini, La morte, a cura di E. Lisciani
Petrini, Torino: Einaudi, 2009, 293, citato in A.G. Biuso, Temporalità e Differenza,
18.
17
330 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
questa spirale di passato, presente e futuro, senza lasciarsi inghiottire
da un vortice di immobilità e di negazione di ciò che è stato e di ciò
che sarà.
L’immensa tristezza degli umani affonda anche nel tentativo di negare
il tempo, il suo flusso, la morte che esso arreca istante per istante nelle
esistenze dei singoli e delle collettività. Il potere nasce anche da qui,
soprattutto da qui. Si origina dalla paura della morte. Per evitarla si crea
un paradigma di immobilità al quale consegnare la vita, un archetipo
che infinitamente ripete il medesimo ciclo, in modo che nulla sfugga
alla prevedibilità e quindi al controllo. Se lo spaziotempo costituisce l’esperienza fondamentale dell’umano e del suo stare al mondo, la radice
profonda delle psicopatologie non può che coinvolgere la percezione e
la rappresentazione del tempo. Il distacco dalla realtà, qualunque forma
esso assuma, è un distacco dal fondamento temporale della vita umana20.
Una sofferenza che non ha tempo, non ha appigli, non ha riferimenti, che si consuma senza freni e occulta qualsiasi speranza di
interruzione. Di questo dolore parlano i versi di Emily Dickinson, in
uno dei suoi componimenti, The mistery of pain:
Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.
It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain21.
Ecco perché la fenomenologia, aperta alla complessità dell’esistente, ha tanto da offrire alla psichiatria, spalancando orizzonti che
vanno ben oltre l’idea della malattia psichica come mera raccolta
sintomatologica. Alla base del disturbo vi è, spesso, infatti, una di A. G. Biuso, Temporalità e Differenza, 6.
Emily Dickinson: Favorite Poems, Mineola, New York: Dover Publications,
2001, 56.
20
21
Letture 331
storta esperienza della temporalità che, inevitabilmente, si traduce
in una «ricostruzione dell’esistenza parziale, statica, deformata sino
all’allucinazione»22.
La malattia psichica è anche una rinuncia alla dimensione fondamentale
del futuro, a quello slancio verso ‘‘l’ha da essere’’ il cui rallentamento
schiaccia la vita sotto il peso di un passato immobile. Della complessità
esistenziale e psicologica, della sua varietà,, si perdono le differenze e
rimane l’identità; si dissolve il molteplice a favore dell’uno. […]
Nell’individuo senza tempo, nel negatore del tempo, tutto lo slancio è
rivolto alla condizione nella quale non c’era differenza alcuna tra lo spazio e il tempo. Non però nel senso della loro plurale unitarietà ma nella
chiusura di entrambi dentro la placenta. […]
Se una caratteristica primaria del tempo è il divenire della struttura
sempre mobile che sta ovunque intorno e dentro all’io e che plasma incessantemente il corpo umano, i processi morbosi consistono anche nel
ridurre tale struttura a un’immobilità densa e senza futuro, nella quale i
ricordi tendono ad assumere sempre più la figura deformata della persecuzione e della tristezza23.
Il ricordo, a volte, svanisce e «nella rimemorazione di quelle che
sono state le esperienze del passato, della loro lunghezza e della loro
brevità, interferisce drasticamente la Stimmung con cui esse sono state vissute»24, sostiene Eugenio Borgna, psichiatra italiano di orientamento fenomenologico. Proprio Borgna, nel suo testo Malinconia,
descrive la stasi, la sensazione di impotenza, il dolore devastante e
apparentemente insensato, la chiusura al futuro e il rifiuto dell’alterità, tipici della Lebenswelt depressiva, attraverso il vissuto di una sua
paziente, Maria Teresa:
Mi sento tutta a pezzi. Si prova una sofferenza tremenda: come ricercare
qualcosa che non si raggiunge mai. […] Mi sento veramente monotona.
[…] Mi sento veramente morta. Mi sento con dentro niente. Mi ritrovo
senza nessun desiderio25.
22
24
25
23
A. G. Biuso, Temporalità e Differenza, 7.
Ivi, 6-7.
Eugenio Borgna: Malinconia, Milano: Feltrinelli, 1998, 138.
Ivi, 42.
332 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
«Il futuro è la struttura sempre aperta verso la quale il vivente è
diretto. Quando il futuro si chiude, è la vita che finisce»26, afferma
Biuso. E, infatti, le sensazioni che la paziente depressa riporta sono
spente, morte, sembrano fluttuare nel vuoto, nella caotica insensatezza che sfugge a ogni comprensione razionale, inghiottite da un’impalpabile brama di fuga dalla realtà.
Morivo ieri mattina. […] Il tempo: quasi un fermarsi; un tempo che si fa
eterno. La mia sofferenza è l’unica cosa che sento. […] Mi sento quasi
andare alla deriva. Mi sento svuotata di tutto. Non ho voglia di vivere
perché vivere significa morire. Mi sento una gran voglia di essere protetta, di diventare e di tornare ad essere bambina: essere accudita, essere
servita. La realtà è tremenda27.
Il primo e più semplice rifugio, in questa «vitamorte infelice»28,
è costituito dall’immobilità, dalla rinuncia all’azione, alla vita, alla
molteplicità e alla ricchezza del mondo. Un corpo, «diventato salma»29, che, nella sua lotta impari contro la potenza del flusso temporale, si abbandona già a una sorta di suicidio. Un corpomente tranciato,
snaturato nella sua costitutiva identità nomade, protesica, metamorfica, estendibile, che «lo rende sempre pronto a trasformarsi, adattarsi,
evolvere, potenziarsi»30.
Una delle differenze fondamentali tra l’organico e il macchinico è la
possibilità del primo di essere attraversato dall’alterità e dal tempo come
una fenditura, una ferita, l’apertura di una nuova via, di prospettive inedite e continuamente cangianti, dove la morte dell’ora è la condizione
per l’avvento del non ancora31.
Rifiuto e distanza dalla realtà dello spaziotempo è rifiuto e distanza dalla relazione, dall’apertura all’alterità e dal dialogo con sé stessi.
26
28
29
30
31
27
A. G. Biuso, Temporalità e Differenza. 60.
E. Borgna, Malinconia, 42.
A. G. Biuso, Temporalità e Differenza, 8.
Ibidem
Ivi, 33.
Ibidem
Letture 333
I significati e le esperienze centrali della vita umana sono lo spazio e il
tempo. Al di là delle loro pur fondamentali componenti geometriche,
matematiche e quantitative, spazio e tempo costituiscono il basso continuo della vita psichica e relazionale, a partire dal rapporto di ogni corpomente con se stesso32.
Gli accadimenti non sono solo percepiti, non vengono immagazzinati passivamente, ma impregnano l’esistenza e diventano tasselli
per costruire il nostro essere In-der-Welt, a partire dalla consapevolezza che si ha del proprio Io e della sua esistenza. Un disperato e
infantile ancoraggio al passato, alla spensieratezza perduta così come
agli eventi più dolorosi, rischia di estraniarci dall’incessante flusso del
divenire, immobilizzandoci in un eterno presente tanto ambito quanto surreale. Monadi, senza porte né finestre, arroccate nella fortezza
dell’angoscia senza fine o nascoste dietro esilaranti maschere di cera,
di trucco, di espedienti estetici che consentano – apparentemente – di
fermare il tempo, come la vecchia signora imbellettata e parata d’abiti giovanili, di pirandelliana memoria. Il riso sarà, forse, la reazione
primaria e più istintiva, ma un amaro disincanto sopraggiunge allorquando ci si rende conto della tragedia interiore a cui questa illusoria
negazione del tempo e di sé stessi rimanda.
La corporeità come Leib e come Körper costituisce un vero e proprio
confine mobile dell’io, dal cui equilibrio dipende la salute mentale. La
prima estraneità è infatti quella rivolta al sé, al sé che è il Leib ridotto
dal soggetto o dalle culture a luogo di ogni perdizione, a nemico oppure
a complice. L’Entfremdung, l’estraneità che a volte i mortali possono
provare verso lo spaziotempo, è radicata in gran parte nel sentire il corpo soltanto come differenza che si ha invece che come identità che si è,
identità la quale costituisce la persona e che si dispiega poi nello spaziotempo come differenza dei luoghi che il corpo abita e degli istanti che al
corpo accadono, sempre però all’interno della struttura identitaria della
corporeità vissuta, rammemorante il passato e diretta verso il futuro33.
La mancanza di un rapporto equilibrato, innanzitutto con il corpomente che si è, determina l’inevitabile mancanza della storicità, in
32
Ivi, 60.
Ivi, 58.
33
334 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
virtù della quale poter vivere ed esperire la bellezza e la vastità di ciò
che siamo e di ciò che ci circonda. È quello che accade allo strambo
e originale sognatore de Le notti bianche di Fëdor M. Dostoevskij, il
quale, perso in un mondo di fantasticherie, scoprirà solo grazie alla
giovane Nasten’ka il pulsare delle emozioni e della vita vera.
«Allora, che tipo di persona siete? Su, cominciate, dunque, raccontatemi
la vostra storia».
«La mia storia!», gridai io spaventato, «la mia storia! Ma chi vi ha detto
che ho una storia? Non ho una storia…».
«E come avete vissuto se non avete una storia?», interruppe lei ridendo.
«Assolutamente senza alcuna storia! Così, ho vissuto, come si dice da
noi, per conto mio, cioè assolutamente da solo, - da solo, del tutto da
solo, - capite cosa significa da solo?»
«Ma come da solo? Cioè non avete visto mai nessuno?»
«Oh no, per vedere vedo, - ma comunque sono solo»34.
Eppure, «come ha osservato Romano Guardini, la vita psichica
è un continuo morire e rinascere di relazioni con il mondo»35. Nello
scorrere della stessa materia infinita, del medesimo tempo che pervade e ci pervade, vivere e morire, creazione e dissoluzione, costanza e
cambiamento si susseguono e si intersecano senza sosta, immergendoci e presentandoci dinnanzi a una sconfinata varietà di eventi in
continuo divenire, i quali concorrono a costituire il dinamismo della
nostra identità. La chiusura in uno spaziotempo personale che neghi
l’incontro con lo spaziotempo altro – caratteristica di disturbi psichici
quali la schizofrenia e la depressione – non è che una forma patologica dell’identità, che non riconosce la pluralità che il mondo è, configurandosi come espressione di nichilismo atemporale36.
In conclusione, «di fronte a questa dolente ricchezza di ciò che
siamo»37, di fronte a una realtà che oscilla tra il tremendum e il fascinans, tra i più profondi abissi e le più alte vette, tra il diverso e
l’identico, una psichiatria che non voglia dimenticare l’essenza multi Fëdor Michajlovič Dostoevskij: Belye noči, 1848, trad. it. di Luisa De Nardis, Le
notti bianche, Roma: Newton Compton, 2013, 52.
35
A. G. Biuso, Temporalità e Differenza, 59.
36
Cfr. ivi.
37
Ivi, 59.
34
Letture 335
forme dell’umano di cui si occupa, non può limitarsi a classificazioni
nosografiche dei disturbi o a somministrazioni farmacologiche – per
quanto utili – ma «deve porsi come relazione fenomenologica con
la complessità di strati, motivi, forme della vita psichica e della sua
patologia»38, tentando di comprendere e ridonare un senso a strutture
temporali labili, distorte e sganciate dalla realtà.
La vita della coscienza e il mondo della vita sono un flusso originario
fatto di trasformazioni di contenuti e insieme di costanza della forma
[…].
Essere vivi significa non soltanto avere un futuro aperto ma vuol
dire poter riscrivere continuamente il passato a partire dall’attesa di
quanto deve ancora accadere. Nel presente vitale accade qualcosa che
oltrepassa lo slancio di ogni dualismo e l’aporia del tempo. In esso,
infatti, lo scorrere del flusso e il fermarsi dell’istante rimangono distinti e tuttavia si coappartengono39.
Katia Serena Cannata
Ibidem
Ivi, 68.
38
39
336 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Limiti e la condizione umana sospesa tra due assoluti
Chiunque abbia avuto modo di dedicarsi allo studio della filosofia
– che lo abbia fatto per obbligo, per lavoro oppure anche solo per
passione, non importa – certo si sarà inevitabilmente trovato davanti
a qualche pagina avente come tema quello della libertà. In qualsiasi
tempo e ad ogni latitudine la libertà e i suoi limiti sono stati oggetto di
dibattiti, al centro di riflessioni e di teorie. E questa raccolta di interventi, tenuti in occasione del convegno FILOSOFIADALTAQUOTA
propone un viaggio tra questi due assoluti con freschezza e originalità, chiarezza e competenza, profondità e consapevolezza di affrontare questioni tanto irrisolte quanto fondamentali per l’uomo.
Ad aprire la silloge troviamo due saggi che affrontano il tema della
libertà a partire dalla fenomenologia husserliana.
In prima battuta Diego D’Angelo aggredisce la questione in oggetto interrogandosi su I limiti della libertà fenomenologica. È proprio l’inizio dell’analisi filosofico-fenomenologica a costituire un
elemento-chiave per la riflessione circa il tema della libertà e dei suoi
limiti: “l’assoluta libertà del soggetto conoscente che decide di fare
epochè dedicandosi ad una riflessione filosofica e fenomenologica
pura è in qualche modo trascendentale a questa stessa teoresi”(p. 17),
afferma l’autore, intendendo cioè che l’inizio dell’analisi filosofica si
trova inevitabilmente ad essere esterno (e logicamente antecedente)
all’indagine filosofica stessa. Dunque, la libertà fenomenologica trova il proprio limite nella libertà assoluta. Ma è negli ultimi anni della
produzione husserliana che, come nota D’angelo, viene rilevata con
maggiore enfasi la limitatezza della libertà fenomenologica, e la si affronta in relazione alla questione dell’Urkind, ovvero dell’inizio della
soggettività trascendentale, e della Uraffektion (affezione originaria).
Questa affezione pura “non accade su una vuota tavoletta di cera, ma
è già “affezione istintuale”, già iscritta in un contesto di orizzonte che
è soprattutto orizzonte corporeo” (p.23). L’inizio di cui si parlava,
perciò, è “differito e irrecuperabile”(p.24) anche nella misura in cui
si cerchi di parlarne in una dimensione esterna a quella fenomenologica: ciò che si può fare, ritiene Husserl, è soltanto operare una
“ricostruzione”, che permetta di raggiungere il passato del bambino,
senza però mai riuscire a raggiungere quell’inizio, poiché “questo io
del bambino è sempre un io per me che ricostruisco, e io ho sempre
già esperienza del mondo”(p.24).
Letture 337
Segue l’intervento di Sara Pasetto, dal cui titolo Il ritorno di
Husserl alla caverna si comprende già la volontà dell’autrice di proporre una rilettura del Mito della caverna platonico in chiave fenomenologica e gnoseologica. La condizione originaria del filosofo, paragonata a quella dei prigionieri incatenati del dialogo platonico, può
essere vista “come necessità strutturalmente libera, nella quale, cioè,
si apre un libero spazio di possibilità” (p.35). Quindi una situazione,
quella in cui ci si trova immersi, di carattere precostituito e che, tuttavia, possiamo considerare come libera condizione di possibilità. E
la libertà del prigioniero di dubitare della verità costituita dalle ombre
degli oggetti sulla parete della caverna è legata alla figura del fenomenologo e al procedimento dell’epochè, ovvero di sospensione del
giudizio. Giunti a questo punto l’autrice si domanda: “perché dunque
continuare il viaggio? Perché la ‘troppa oscurità’ del dubitare non si
eliminerebbe col semplice ritorno al muro della caverna. La nuova
consapevolezza ha spezzato le catene e ha fatto del prigioniero un
viator” (p.38), che prosegue il proprio viaggio nel buio per raggiungere la meta, il fine, che però non è “la” fine del percorso. Una volta
raggiunto il sole egli si rende conto, da questa nuova prospettiva, del
fatto che le ombre della caverna, per sé stesse, non rappresentano né
“La verità” né “La falsità” ma “una parte della complessa catena dei
fenomeni” (p.44). Questa nuova consapevolezza fornisce al filosofo
“un buon motivo per decidersi a ridiscendere nelle tenebre” (p.46), a
causa della compassione che prova per gli ex-compagni ancora incatenati e per condividere con loro questa scoperta.
Un taglio diverso è quello dato allo scritto Aggressione al noumeno. Freud e la rivoluzione copernicana di Kant di Ivan Rotella,
il quale si propone di affrontare la questione della conoscenza a partire dall’ambito della psicanalisi. Rotella propone l’interpretazione secondo cui la psicanalisi freudiana possa essere considerata “la
prosecuzione della rettifica operata da Kant a proposito delle nostre
vedute della percezione esterna” (p.59), ovvero della rivoluzione copernicana. Tre, infatti, sono le illusioni narcisistiche dell’uomo: il
ritenere la Terra al centro dell’Universo, il considerare l’uomo una
creatura differente dalle altre e l’essere padrone dei propri desideri. Proprio quest’ultima sarebbe stata dissipata dalla psicanalisi, dal
momento che essa permetterebbe di “mortificare” l’illusione della identificazione dell’io psichico con l’io cosciente, anche se già
Kant e Schopenhauer possono esserne considerati degli anticipatori.
338 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Infatti, se Schopenhauer viene considerato come un “anticipatore non
cosciente”, Kant propone una distinzione tra un io fenomenico cosciente e un io noumenico inconscio, che anticipa la teoria freudiana
secondo cui la vita psichica non può ritenersi completamente coincidente con lo stato cosciente: è necessario ammettere l’esistenza di
un livello non-cosciente o, meglio, inconscio. Sarà poi la psicanalisi,
appunto, a compiere un passo avanti nel processo di “aggressione”
del noumeno. Ed è a questo punto che viene proposta dall’autore una
riflessione sul tema della libertà, fil rouge della raccolta: “credo che
Kant, tanto quanto Freud, abbia in mente un concetto di libertà in un
certo senso fisico-matematico” (p.72). Questa idea, presentata tramite
due metafore (quella del segmento e quella degli scacchi), poggia sul
fatto che, posti dei limiti, all’interno di questi esiste una illimitata
possibilità di scelta e di movimento: “Obiettivo dell’analisi filosofica
kantiana, così come dell’analisi psichica freudiana, a mio avviso, è
la messa a nudo e la presa di coscienza di quei limiti, in modo tale
da garantire una maggiore libertà di movimento all’interno di quegli
stessi limiti”(p.75).
Pietro Garofalo trasporta il discorso su libertà e necessità
nell’ambito delle istituzioni, caratterizzate da quella che viene chiamata “instabilità costitutiva”, la quale trova le sue radici nell’instabilità propria dell’essere umano. Il paradosso dell’animale istituzionale. Natura umana, rivolta e linguaggio si (e ci) propone di indagare
anzitutto come il binomio libertà-necessità si realizzi all’interno del
nostro apparato istituzionale, il quale avrebbe in sé un elemento di
necessità e allo stesso tempo la ragione del suo superamento: “l’istituzione si pone così come lo strumento che apre a delle possibilità a
partire, però, dal riscontro di un limite, ponendosi esso stesso come
ulteriore limite a partire da quale si aprirà un ulteriore ventaglio di
possibilità”(p.97-98). Rivolgendosi a Saussure, Garofalo espone
la teoria secondo cui la lingua costituirebbe l’istituzione-chiave a
partire dalla quale è possibile uno sviluppo delle altre e la via tramite cui accedere al “mondo della libertà” secondo due punti di vista differenti: da un lato è ciò che consente di andare oltre la mera
percezione. Dall’altro la lingua costituisce un limite, ovvero “come
struttura necessitante all’interno della quale, soltanto, si realizza e
assume senso l’atto individuale” (p.111). All’azione libera dell’individuo vengono dunque (im)posti dei vincoli, che permettono alla
lingua, pur nella sua caratteristica di non immutabilità, di non essere
Letture 339
modificabile dai singoli individui ma da quello che viene definito
“uso sociale” (p.113).
Di ambito politico è la riflessione proposta nel saggio Quando il
concetto di libertà diventa un limite: la teoria unitaria della libertà
di Stefania Lio, che propone delle considerazioni sulla teoria della libertà elaborata da Philip Pettit. Considerazioni marcatamente critiche
nei confronti della teoria unitaria proposta dall’autore che, coniugando implicazioni politiche e psicologiche della libertà, unisce libertà
politica e libero arbitrio. Alla base di questa idea sta l’identificazione “tra libertà e idoneità a essere ritenuti responsabili” (p.121), nella
quale si trova una connessione con la concezione repubblicana della
libertà, intesa come non-dominio (una ‘terza via’, alternativa rispetto alle classica dicotomia libertà positiva-negativa). La critica della
Lio è chiara: “sembra che Pettit […] finisca per confondere due piani
di questioni attinenti al problema del libero arbitrio” (p.124), ovvero
considera soltanto le sue implicazioni etico-giuridico-politiche, tralasciando completamente e in maniera impropria l’aspetto metafisico.
Due aspetti, invece, da tenersi distinti in particolar modo se connessi
al tema della responsabilità. La libertà, infatti, non può considerarsi
come idoneità a essere ritenuti responsabili.
In ambito teoretico, invece, troviamo il contributo di Valeria
Ascheri dal titolo La conoscenza e la libertà: limiti e confini in una
prospettiva realista. Ella propone di esaminare quali siano i limiti
della conoscenza in una prospettiva realista (e in particolar modo di
”realismo critico”), operando una distinzione tra limiti oggettivi e
soggettivi: nel primo caso si fa riferimento alla possibilità, da parte
del soggetto conoscente (uomo), di conoscere l’oggetto solo per come
esso si presenta (modus essendi), cosa che lo porta a “riconoscere
che non è onnipotente e che la realtà può fare resistenza alla volontà”(p.148) e imponendo, de facto, una limitazione non valicabile. Nel
secondo caso, invece, è il medesimo soggetto conoscente ad essere limitato dai propri strumenti di conoscenza (sensi e intelletto), ponendo
un’inevitabile frattura tra verità ontologica e gnoseologica. È partendo da questi limiti, che rendono la conoscenza parziale e imperfetta,
che si determina la libertà dell’uomo che è responsabile dei propri
atti e, di conseguenza, “libero” di commettere autonomamente errori.
Ecco che il limite, anche in questo caso, assume una valenza positiva:
“se la conoscenza non avesse errori, allora sarebbe una conoscenza
necessaria e l’intelletto umano forse più simile ad una macchina o
340 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
ad un computer” (p.153). Inoltre la presenza di un limite, ricorda la
Ascheri, ha storicamente rappresentato per l’uomo uno stimolo per il
suo superamento.
Proprio dalla questione dei sensi parte il saggio, scritto da Nadia
Moro, dal titolo I limiti della sensazione. La discussione sui limiti
della conoscenza nella fisiologia degli organi di senso, e in particolare dall’attendibilità (o meno) delle nostre sensazioni. Riprendendo le
riflessioni di du Bois-Reymond (risalenti alla seconda metà del XVIII
secolo), viene proposta l’idea della fisiologia come di una disciplina che funge da spartiacque tra la filosofia e le scienze naturali per
spiegare il complesso della sensazione. Questa costituirebbe il limite
della conoscenza, oltre il quale esiste un livello trascendente che non
può essere in alcun modo raggiunto. Per questo il modello esplicativo di matrice meccanicista, fondato sulla possibilità di ricondurre
i fenomeni ad un’interazione di materia e forza, presenta dei limiti
non ulteriormente valicabili. Dunque, per usare le parole dell’autrice,
“la natura specifica della sensibilità (umana) impone a sua volta forti
limiti al progresso fattuale della (nostra) conoscenza” (p.169).
Paolo Scotton riflette sul tema della libertà in ambito etico in
Creatività e necessità dell’esistenza: relazioni tra la Bestimmung
di Fichte e la Misión di Ortega. Proprio in riferimento al pensiero
del filosofo spagnolo, viene presentato la sua teoria circa la presenza, all’interno della vita di un ogni singolo uomo, di un “principio
fondante dell’agire pratico, [...] il quale guida il soggetto nel corso
della sua esistenza” (p. 186). Tale principio, chiamato “vocazionale”,
implica una sorta di “dovere” da realizzare nella propria esistenza. Un
dovere che, sottolinea l’autore, è da distinguersi radicalmente rispetto all’imperativo categorico kantiano: è preferibile, infatti, parlare di
“missione” e di “imperativo unipersonale”, che, quindi, “non vincola
in maniera necessaria l’individuo alla sua effettiva realizzazione – e
– non ha alcun valore universale poiché è tale solo per il soggetto che
lo scopre dentro di sé” (p. 188). Missione individuale che prende le
mosse da un processo di presa di coscienza di sé, del proprio carattere
e della propria identità (ensimismamiento) e che permette una nuova
concezione del rapporto tra libertà e necessità. È possibile, secondo
Scotton, pensare ad un parallelismo tra questa parte del pensiero di
Ortega e il concetto della Bestimmung fichtiana. Ma il collegamento
con Fichte, in questo caso, viene utilizzato per sottolineare un altro
aspetto importante, ovvero la tendenza a spostare questo percorso di
Letture 341
realizzazione e perfezionamento dalla dimensione del singolo individuo a quella della specie. E, accanto a questo aspetto, assume importanza la figura del dotto, il quale detiene “il compito precipuo […] di
acculturare il resto della popolazione” (p.204) e che porta al centro
della riflessione il tema dell’educazione, il cui obiettivo non rimane
solamente quelle strettamente “educativo” nei confronti dell’individuo, ma anche di fornire un contributo essenziale nel suo percorso di
auto-realizzazione.
Libertà e educazione: il caso della Philosphy for Children è il
titolo del saggio di Serena Piccirillo, che si propone di analizzare la
questione della libertà da un punto di vista educativo, anche se differente a quello di Scotton. Con una riflessione decisamente più calata
nella realtà e nella quotidianità della vita, la Piccirillo muove una
critica piuttosto dura nei confronti del sistema educativo occidentale, che spesso sottovaluta la necessità di un insegnamento non meramente nozionistico, volto a formare cittadini che siano in grado di
“esprimere il proprio pensiero in modo strutturato” (p. 219) in modo
critico e riflessivo. Una carenza che, in ultima istanza, non contribuisce allo sviluppo di individui liberi. In quest’ottica viene presentata
la Philosophy for Children, ideata da Matthew Lipman come metodo
che si propone di sostituire al paradigma standard dell’insegnamento,
di carattere che potremmo definire “verticale”, un modello fondato
sul “paradigma riflessivo” (“orizzontale”), in cui il ruolo dell’insegnante non viene assolutizzato e non deve essere percepito con quel
carattere di infallibilità nel suo compito di trasmissione delle conoscenze in senso unico e univoco, come spesso accade oggi. Questo
modello, invece, propone un’idea di educazione come “il risultato
della partecipazione ad una comunità di ricerca guidata dall’insegnante che occupa una posizione fallibile e non autoritaria” (p.223),
in cui la capacità (e la possibilità) di argomentare sono condizione
quantomeno necessaria.
Fabio Mancini torna a riflettere della libertà in ambito etico con
il suo Conflitto morale e intuizione in Nicolai Hartmann. L’interesse,
in particolare, ricade sulla teoria metaetica dell’intuizionismo, alla
quale l’obiezione principale che viene mossa è quella di non riuscire
a proporre una teoria etica di carattere oggettivistico e di ricadere,
inevitabilmente, nel relativismo della dimensione soggettiva, che gli
stessi intuizionisti avevano rifiutato e che riporta alla possibilità che
si determini un conflitto morale. È proprio Hartmann, nell’Etica, a
342 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
proporre l’idea che la scelta morale sia caratterizzata da un carattere
conflittuale, che si esplicita nella “struttura antinomica dei valori”, a
partire dalla quale emerge una “complessa struttura teorica all’interno
della quale i valori si relazionano e si ordinano secondo i […] criteri
della forza e dell’elevatezza” (p.256). In questa dinamica si inserisce
la discussione sulla libertà, intesa come condizione perché si possa
dare la legge morale in relazione al valore: prendere una decisione
per realizzare un valore coincide con la manifestazione della libertà,
la quale si sperimenta proprio davanti alle situazioni di conflitto morale. Mancini chiosa la riflessione sull’intuizionismo affermando che,
nonostante la sua imperfezione (s)oggettiva essa “è l’unica possibilità
di far coesistere l’oggettività dell’etica, libertà individuale e la complessità e la polifonia del regno di valori”(p.274).
Chiude la raccolta Franco Sarcinelli con La libertà come “indipendenza dipendente” dell’agire umano, un testo nel quale analizza
le riflessioni sulla libertà compite da tre filosofi francesi del dopoguerra e di domanda circa l’esistenza della libertà individuale. A tale
quesito Sartre risponde che “l’uomo è solo di fronte alle sue scelte
e condannato ad essere libero” (p.282), condizione che lo porta ad
“inventare” la propria morale, ma è anche vero che si può essere liberi solo le ci si assume delle responsabilità non solo a livello individuale, ovvero in una dimensione collettiva. Merleau-Ponty rimarca la
centralità del corpo nei processi di conoscenza, presupponendo una
libertà originaria (anche se non assoluta), che determina che la vita
dell’uomo si sviluppi in una condizione “aperta”, tanto che “l’io si
presenta come connotato da una duplice connotazione, psicologica
e nel contempo storica” (p.289). E, infine, Ricoeur, il quale propone
una visione sostanzialmente “neutra” della libertà, che si determina
in un “intreccio di volere/valore […] che trova un momento di sintesi
nella enunciazione dei motivi che orientano e caratterizzano la pratica
sociale”(p.291). Il momento della scelta è centrale, perché è qui che
entrano in gioco le dinamiche della libertà e della necessità, attraverso i tre momenti del decidere, agire, consentire. Termina Sarcinelli,
cercando una conclusione: “I limiti della libertà e della necessità vengono ripensati su basi filosofiche imposte dalle mutazioni in atto nella
fase storica che si sta aprendo e consumando” (p.297).
Lorenzo Musante
Letture 343
Ischia International Festival of Philosophy 2016
Nell’incantevole cornice dell’isola di Ischia si è tenuta la seconda
edizione del Festival Internazionale di Filosofia “La Filosofia, il
Castello e la Torre” dedicato quest’anno al tema delle “Relazioni
e Mediazioni”. L’inaugurazione del Festival 2016 è avvenuta ai
Giardini La Mortella di Forio d’Ischia nel tardo pomeriggio di giovedì 29 settembre. I classici saluti istituzionali di rito hanno fatto da premessa all’accattivante lectio magistralis del professor Massimo Donà
(Università Vita-Salute S. Raffaele), ospite d’onore del Festival, che
ha parlato di “Relazione e contraddizione da Hegel a Gentile”, aprendo le riflessioni di cinquanta relatori che si sono alternati nei due giorni successivi. Le sessioni prevedevano tre presentazioni parallele ed il
pubblico presente ha dovuto così scegliere il proprio percorso tematico tra due sale interne ed una esterna della Torre Guevara, conosciuta
anche come Torre di Michelangelo, con vista direttamente sulla baia
di Cartaromana. I luoghi suggestivi hanno sicuramente favorito l’esegesi filosofica e uno scambio di pensiero particolarmente proficuo,
creando un clima disteso e gioioso e permettendo così ai relatori e
al pubblico presente di amalgamarsi configurando un vero e proprio
gruppo di ricerca filosofico.
Entrando in medias res, i lavori del Festival si sono aperti il giorno 30 settembre 2016 presso la Torre Guevara, la cui storia è stata illustrata da Rosario De Laurentis del Circolo Georges Sadoul
di Ischia. Maria Elena Severini, dell’Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento di Firenze, ha dato il via alle conferenze nella sala
esterna, con una relazione dal titolo: “N. Cusano e G. Bruno: per una
filosofia della mediazione” dalla quale è emersa come preponderante
la duplicità della nozione di tempo - che contiene in sé il bene e il male
- in Bruno che riprende il pensiero di Eraclito. Lo spazio del come è
quello della libertà umana. Vi è quindi in questa teorizzazione un’unità che è intimamente connessa alla pluralità, l’alternanza dei contrari
si configura come il fondamento dell’unità. Secondo Bruno, come è
noto, l’universo è materia infinita, sostanza universale e per questo,
afferma Severini, è possibile rinvenire in lui un’adesione all’ontologia della relazione secondo la quale l’individuo e la sostanza sono
universali. Non a caso Bruno è considerato un filosofo della modernità: se all’interno del suo pensiero permane una contraddizione, essa
è sul piano mistico, non di certo su quello razionale. A differenza di
344 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
Giordano Bruno, Niccolò Cusano rimane un neoplatonico. Il dibattito
successivo ha fatto emergere il tema della composizione degli opposti: cosa muove la sostanza vitale? Secondo Severini per dare risposta
alla domanda ci si deve muovere tra aristotelismo e neoplatonismo,
non inquadrando in alcun modo la questione dialettica all’interno del
contesto hegeliano.
Presso la sala affreschi, al primo piano della Torre Guevara,
Rosario Diana dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e
scientifico moderno di Napoli, ha parlato di “Identità individuale e
incontro con l’altro”. Interessante è la nozione di cogito autobiografico emersa dalla sua relazione, concepita come un’identità che nasce
da e in una pluralità e contesto storico. Il carattere di imprevedibilità della vita è dato dalla continua costruzione e ricostruzione della
nostra identità. Dobbiamo quindi, secondo Diana, inserire l’altro nel
quadro delle mie identità possibili: se non posso prevedere e definire
le possibilità della vita, posso però cambiare il mio atteggiamento
nei confronti di queste varianti. Storicità, pluralità, alterità e identità
devono pertanto essere concepite insieme in un flusso continuo di
mediazioni e relazioni.
Salendo alla sala superiore, Clarissa Comunale, dell’Università
degli Studi di Messina, ha intrattenuto il pubblico presente su “Essere
in relazione: la koinonia ton genon platonica nell’interpretazione di
M. Heidegger”. L’analogia tra il pensiero platonico e quello heideggeriano a proposito della relazione, avviene sul piano del riconoscimento della diversità che precede l’identità in Platone, così come il
negativo dischiude e si presenta come una vera e propria aletheia
in Heidegger. In questo contesto, la questione ontologica si lega a
doppio filo con la questione antropologica ed è proprio tale legame a
costituire l’ambito della relazione filosofica.
Per quanto mi riguarda, sono intervenuta sul tema del Festival
portando l’esempio della “Aufhebung hegeliana come continua e costante mediazione razionale”. Il pensiero di Hegel è stato più volte
richiamato all’interno di diversi interventi, a partire dalla lectio magistralis di Donà, e del resto egli può sicuramente essere definito come
filosofo della mediazione. Il focus della mia relazione è stata la logica interna alla dialettica rinvenibile nella Fenomenologia dello spirito
del 1807. Tramite l’analisi delle categorie logiche hegeliane, infatti, è
possibile mostrare come si arrivi a un’unità mediata del mondo grazie
a un continuo processo fenomenologico che non si arresta, ma che
Letture 345
avanza e torna in se stesso. In questo avanzare, fondamentale è l’incontro con ciò-che-sta-di-contro (Gegenstand, oggetto, alter-ego) e
il merito del movimento dialettico hegeliano è quello di aver portato
questo altro nella sfera della coscienza, dell’io.
Una formula interessante prevista all’interno del Festival è stata
quella del panel tematico all’interno del quale si alternano diversi
relatori. “La strada verso Itaca” è stato il tema prescelto da Valeria
Ferraretto (Università di Pisa), Silvia Ferrari (Fondazione San Carlo –
Modena) e Verbena Giambastiani (Università di Pisa) per presentare
la figura di Ulisse in Adorno, Primo Levi e Levinas. La formula è stata
particolarmente efficace e le relatrici hanno saputo mantenere un’uniformità di fondo nei pur diversi autori trattati. In particolare, Verbena
Giambastiani nel suo intervento intitolato: “Etica come relazione. La
figura di Ulisse in Levinas” ha sottolineato come la metafisica all’interno della teoresi levinasiana è l’assolutamente altro. L’altro, cioè,
non ha in me la condizione di esistenza. Si parla, quindi, di un’etica
dell’alterità che consiste nella supremazia dell’etica sull’ontologia,
riconoscendo l’assolutamente altro. L’altro è straniero perché è assolutamente altro, il volto dell’altro è per Levinas l’infinito.
A seguire sul filo rosso dell’alterità è stato Luca Brovelli
(Università degli Studi di Milano), che ha presentato una relazione
dal titolo: “Il ruolo dell’alterità animale nella definizione dell’identità umana”. L’invito di Brovelli è stato quello di ragionare sulle
motivazioni di fondo per le quali noi pensiamo alla separazione tra
mondo umano e animale. Derrida postula una differenza tra il mondo
animale e l’essere umano, ma ritiene che una così rigida distinzione
crei problematiche. Quand’è che iniziamo a percepire la nostra differenza rispetto al mondo animale? Possiamo collocare questo inizio
nel Neolitico. Prima, infatti, esisteva tutta una ritualità, che prevedeva anche un certo rispetto, legata al mondo animale, si pensi ai
banchetti che le tribù allestivano dopo la caccia. Dopo il Neolitico
si passa a un’economia basata su agricoltura e allevamento. Questo
passaggio cambia moltissimo: si passa dalla violenza al dominio. I
recenti tentativi di riabilitare l’alterità animale, secondo Brovelli, incorrono nell’errore di farlo secondo categorie dell’umano. Quindi, la
sua proposta di ricerca è quella di lavorare sulle nostre domande circa
l’animalità.
Il terzo giorno del Festival è iniziato con la lectio magistralis del professor James Conant dell’Università di Chicago. Nel suo
346 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
brillante talk: “The Socratic Aspect of Wittgenstein’s Conception of
Philosophy”, Conant ha sottoposto alla platea alcuni aforismi e affermazioni di Socrate e Wittgenstein, chiedendo al pubblico di indovinare a quale dei due filosofi appartenessero. Il quiz senza premi è
stato un esperimento filosofico volto a dimostrare il fatto che anche in
base a una conoscenza specialistica di entrambi gli autori, non sia così
semplice attribuire la paternità di ciascun aforisma presentato. Ciò
dimostra anche l’analogia del pensiero di due autori apparentemente
molto distanti tra loro come Socrate e Wittgenstein.
Analogamente a quanto avvenuto il giorno precedente, anche
nella giornata di sabato è stato presentato un panel all’interno del
quale sono intervenuti Lorena Catuogno, Paola Mazzucchi, Valentina
Gaudiano e Emanuele Pili, tutti provenienti dall’Istituto universitario
Sophia. Nella sua relazione, “L’io e l’altro: le dimensioni relazionali
della persona”, Catuogno ha presentato il pensiero di Rosmini che riconosce la dimensione relazionale della persona configurandosi come
personalismo. La sua teoresi nasce dall’esigenza di dare una risposta
alternativa alla crisi della persona.
Pili, invece, ha riferito su “Non-senso e sete di relazione. Il
Taedium a partire da Tommaso D’Aquino”. La nausea esistenziale
e il non senso hanno un forte legame con le relazioni. Per Tommaso
è infatti il taedium che esprime al meglio il carattere di non senso e
di crisi dell’essere umano, è un male di vivere che si traduce con il
taedium vitae. Seneca e altri giuristi del “Codex iuris” sono concordi
nell’attribuire al taedium di vivere una tale forza annichilente da portare al suicidio. Tommaso definisce il taedium come un sentimento
che colpisce il singolo individuo nella sua solitudine, nell’assenza di
relazione con l’altro e con Dio. Una possibile via d’uscita dal taedium
è quella di uscire da se stessi, andando sempre verso altro, seguendo
il desiderio, ma è sempre un rimedio che rimane con un’accezione
negativa.
“Lo spazio interpersonale tra dono e annullamento” è la prospettiva adottata da Valentina Gaudiano nell’esplorare relazioni e mediazioni. I filosofi a cui fa riferimento nel suo discorso sono Max
Scheler, la cui parola chiave è corresponsabilità di relazionarsi o
meno all’altro; Edith Stein, che indaga le relazioni che creano traumi;
e Hildebrand che concepisce la persona in quanto aperta, ma paradossale. La persona intima per Scheler è nei e per i suoi atti, in questo
senso la Wertnehmung precede la Wahrnehmung. La datità dell’altro si
Letture 347
deve a un’intuizione immediata, ad un sentire con altri (Mit-Gefühl).
La persona umana si realizza, quindi, solo nell’amore per gli altri.
Un’altra nozione importante in questo contesto è quella di empatia:
secondo Stein si tratta della capacità di porsi al posto dell’altro ed è
la vera possibilità di conoscere se stessi che viene in risalto dall’alterità rispetto all’altro. Infine, Hildebrand concepisce la capacità di
atti intenzionali solo nell’incontro e nel rapporto con l’altro e nella
verità. L’incontro autentico è una reazione al farsi toccare dall’altro e
consiste nel voler raggiungere l’unione con l’altro. Solo attraverso la
donazione il soggetto può fare esperienza dell’altro.
L’intervento di Riccardo Finozzi (Università Statale Milano), dal
titolo: “La ricchezza del denaro oltre il valore: dalla politica monetaria all’intreccio di relazioni”, è stato pensato come seminario per
economisti. La moneta come segno del sovrano, ovvero la moneta
come segno della Banca centrale europea e della finanza è slegata
dall’intenzione politica. Oggi la moneta non è più nulla, è un segno
che rimanda a nulla e tutto ciò è la conseguenza di una visione matematizzante della natura e dei rapporti umani quantitativi.
Dall’economia si passa alla religione con il contributo di Piero
Marino (Università Federico II Napoli) intitolato: “Quando l’altro
non sei tu: prospettive di dialogo interreligioso”. Ci può essere uno
spazio comune tra credenti e non credenti? Per riflettere su questa domanda, Marino analizza il dialogo avvenuto tra Habermas e Ratzinger
nel 2004 avente per oggetto il diritto naturale. Il cammino della secolarizzazione è il cammino dei diritti della persona. Habermas chiede
al credente di dialogare col non credente che è in lui. Lo scontro tra
simboli è occultato da uno scontro tra concetti. Si avverte in tale dialogo il bisogno di esprimere pubblicamente l’esperienza religiosa. In
conclusione, si rimarca come sia possibile un incontro sotto il profilo
concettuale tra credente e non credente, ma questo incontro non elimina i motivi dello scontro.
Il professor Vito De Nardis (Liceo scientifico, Lanciano) ha tenuto un’appassionata lezione sul tema: “In principio l’incontro: un
approccio argomentativo alla mediazione”. Che cos’è la mediazione?
È compositio. De Nardis inizia da tale definizione per andare alla radice del verbo “argomentare”, che significa mettere in luce, far brillare. L’argomentazione è quindi autentica, limpida e deve essere uno
scambio utile a entrambi gli interlocutori per far valere la persuasione,
vera tecnica della compositio. Si intende mettere insieme frammenti
348 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
di mondo e la ricerca di un mondo comune è concepita come l’essere
rivolti all’altro. “Suadere” significa dire il bene all’altro, che è diverso
da “costringere”. Quando si argomenta si partecipa di entrambi gli
argomenti, non è il mondo della solitudine, ma quello del coraggio.
Prima dell’“arg-” dell’argomentare, c’è l’andare verso. Il momento di
chiarimento iniziale è quindi necessario. Perché mediare? La risposta
di De Nardis è che siamo profondamente umani nel momento in cui
incontriamo l’altro. Si argomenta per inverare noi stessi, ma l’argomentazione va regolamentata insieme, le regole si rispettano e il problema si può risolvere, anche se durante il processo argomentativo si
solleveranno sicuramente ulteriori problemi o questioni. La parola,
del resto, è per sua natura generativa.
Maria Giovanna Bevilacqua (Università della Svizzera italiana)
si muove nell’ambito dell’etica, presentando la relazione: “L’altro tra
gli altri. Lo straniero tra riconoscimento, differenza, etica della cura
e spazio comunitario/pubblico”. Le politiche di riconoscimento delle
differenze sono volte al rispetto delle diversità, per questa ragione
è utile un’etica della cura che segue il principio di ragionevolezza
che si differenzia da una razionalità formale e imposta dall’alto, non
attenta alla differenza che ci fonda e costituisce, quindi, la differenza
di tutti.
A chiudere le relazioni alla Torre Guevara, è Anita Santalucia
(Università Federico II Napoli) ideatrice e curatrice del blog “Pop
filosofia” che ha riflettuto sul tema: “Io e l’altro da me: perché seri
in movimento”. L’obiettivo del suo blog è di portare la filosofia in un
contesto molto più pratico rispetto a quello usuale in cui si esercita la
disciplina. La sua riflessione sulla relazione parte dalla constatazione del fatto che l’individuo si pone così com’è, nella sua autenticità,
nella relazione con l’altro e questo può essere mantenuto anche nel
web. La domanda che si potrebbe porre a questo impianto teorico è se
sia davvero possibile tale autenticità nella relazione con gli altri o se,
invece, non ci si nasconda consapevolmente o meno sotto alle proprie
sovrastrutture.
Al calar della sera i relatori e il pubblico interessato, si spostavano
nella suggestiva cornice del Castello Aragonese illuminato sul mare.
Andrea Le Moli (Università degli Studi di Palermo) è ritornato su
Hegel, con la sua relazione: “L’Assoluto e le mediazioni”. La prima
domanda che ha posto Le Moli è: “Ha senso parlare ancora di assoluto oggi nei riguardi della mediazione?”. Se si considera il modello
Letture 349
greco, il termine medio nel sillogismo dimostrativo ha il duplice scopo di aprire lo spazio della verità e di fornire le forme che vengono
costruite. Nella disputa giudiziaria, invece, si ha un gioco a somma
zero che deve prevedere un vinto e un vincitore. Lo spazio simbolico, in questo caso, è una forza antagonistica. Il pensiero greco non
riesce a pensare qualcosa che derivi dall’unico principio, perché dovrebbe poi pensare all’opposto, le mediazioni sono quindi necessarie.
L’arbitro si interpone tra due contendenti e neutralizza lo scontro. Lo
scopo dell’arbitrato è l’equità: la vittoria e la sconfitta devono essere
distribuite. C’è poi il contesto hegeliano, descritto all’interno della
Fenomenologia dello spirito e il rapporto religioso in cui una parte
è l’assoluto. Tutti i differenti contesti presentati da Le Moli hanno lo
scopo di farci riflettere sulle diverse accezioni di mediazione e sulla
necessità di pensare l’assoluto.
Un altro momento prezioso del II Festival Internazionale di
Filosofia di Ischia è stato la Filosofia con i bambini e coi ragazzi che
si è svolto domenica, 2 ottobre, presso la Torre Guevara. Il professor
Giuseppe Ferraro (Università Federico II Napoli) ha suscitato una forte curiosità e interesse esplorando i legami tra le parole che nascevano
spontaneamente dai protagonisti di questo incontro. La riflessione su
“Relazioni e Mediazioni” ha assunto così una veste del tutto inedita
e preziosa, quella della disarmante profondità delle parole semplici
dei ragazzi che hanno fatto riflettere tutti i presenti sull’importanza di
guardare il mondo con occhi diversi, di ascoltare la voce e i pensieri
dei ragazzi, in un flusso ininterrotto di emozioni e sguardi sul mondo
che ha portato fino alla serata conclusiva.
“D’Amore e D’Amicizia” è il titolo della relazione tenuta da
Simona Marino e Giuseppe Ferraro (Università Federico II Napoli),
compagni nella vita e nella filosofia. Il loro è stato un dialogo, iniziato
Marino che ha citato Blanchot e Rilke per illustrare i legami tra amore
e politica da una parte e relazione come messa in comune dall’altra.
La relazione è sempre tra un soggetto e l’altro, tra un io e un tu. Si
tratta quindi di deporre la posizione di essere al centro del discorso
per porsi nell’alterità, a questo proposito la teorizzazione femminista è pratica della relazione. È necessaria una critica della propria
posizione per porsi in relazione. Dal canto suo, Ferraro ha portato
l’esperienza del filosofo in carcere, che lui stesso ha provato, a cui
viene chiesto da un detenuto: “Tu che cosa fai qui?”. È possibile una
mediazione tra dentro e fuori, tra visibile e invisibile? L’intimità è il
350 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
luogo dell’utopia. Il filosofo è colui che saggia il legame più forte.
Secondo Ferraro, dobbiamo riguadagnare l’anima e perdere un po’
di coscienza. L’amore è una relazione senza rimedio: si tratta di far
diventare eterno l’attimo, ragionevole l’irragionevole.
Sara Fumagalli
Letture 351
Note sul film El abrazo de la serpiente: un approccio filosofico
El abrazo de la serpiente è un film a più livelli di lettura secondaria
– etno-antropologica, psicologica, culturale e filosofica – oltre che
quella primaria della critica cinematografica. Questo ne evidenzia la
complessità e l’interesse che può suscitare.
Il regista colombiano Carlos Guerra ha trasferito sullo schermo le
esperienze che nel corso della prima metà del ‘900, a distanza di circa
40 anni, sono state registrate nei diari di due esploratori – l’etnologo tedesco Theodor Koch-Grünberg e il botanico americano Richard
Evans Schultes – nel versante colombiano dell’Amazzonia, segnato
da foreste lussureggianti e da imponenti corsi d’acqua solcati dalle
canoe degli indigeni.
Nel film, le esperienze dei due sono assai simili per luoghi, incontri, eventi e sensazioni, e il regista lo evidenzia associando e giustapponendo le immagini della loro avventura amazzonica. Il tedesco
incontra un Karamakate, sciamano dei Cohinauo, che vive isolato
ritenendo che ormai la sua tribù si sia estinta a opera degli spietati ‘signori’ della raccolta del caucciù. In cambio dei riferimenti che
Theodor, gravemente malato, gli promette sulla esistenza di indigeni
sulla sua tribù che egli sostiene di aver incontrato, ottiene di farsi
aiutare nella ricerca della Yakruna, una rara pianta allucinogena e terapeutica, che lo potrebbe guarire, accettando le severe e rigide norme
imposte dalla cultura rappresentata dallo sciamano.
L’etnologo è supportato dall’indigeno Manduca, che gli è riconoscente per essere stato da lui riscattato presso i colombiani, cinici e
spietati sfruttatori del lattice per il caucciù degli alberi della foresta
amazzonica. Ma gli incontri che essi fanno – tra cui una missione in
cui un fanatico E SADICO frate cappuccino impone con la forza le
pratiche cattoliche a un folto gruppo di bambini indios, cancellando
ogni segno della loro cultura, e le sanguinose azioni degli sfruttatori
della foresta contro le popolazioni indigene – inducono lo sciamano a
negare l’uso della pianta, una volta avvistata, e a far morire Theodor.
La lettura del suo diario, che dopo la sua morte era stato raccolto
e spedito in Germania, spinge anni dopo ad addentrarsi negli stessi
luoghi il botanico americano Schultes, studioso citato come autore
insieme ad Albert Hofmann di un importante testo, The Botany and
Chemistry of Hallucinogens, sorretto da questa sua ampia e approfondita conoscenza scientifica delle piante e dell’ambiente caratterizzan-
352 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
te l’area amazzonica. Gli occorre di incontrare lo stesso Karamakate,
ormai invecchiato, che si dichiara un “chullachaqui”, ovvero un uomo
svuotato del suo essere, un “due-in-uno”, simulacro della identità della sua cultura, negletta e perduta.
Schultes è in grado, sulla base delle sue conoscenze, di trattare le
foglie della pianta caapi per poterne trarre effetti allucinogeni, procedura ormai dimenticata dal vecchio sciamano. Su lui Schultes può
esercitare il suo potere di scienziato dell’Occidente e ottiene affinché
insieme riescano a ritrovare la Yakruna. Nel corso del loro tragitto, si
sviluppa un processo a ruoli invertiti: lo sciamano rivedendo luoghi
e incontrando indigeni di differenti tribù recupera i tratti della sua
cultura ancestrale, mentre all’americano viene imposto di buttare nel
fiume dalla canoa come fosse una inutile e ingombrante zavorra tutti
i suoi attrezzi, taccuini e libri, per essere disponibile a immergersi ed
essere assimilato al mondo magico e sognante dei nativi.
È la condizione per il dispiegarsi di una straordinaria esperienza sensoriale ed esistenziale: l’uomo occidentale deve assumere una
purezza spirituale assoluta, abbandonarsi ai sogni e diventare capace
di captare e decifrare i messaggi di una natura smagliante e misteriosa. All’americano è concesso di trattenere con sé solo un vecchio
grammofono con il quale può ascoltare “La creazione” di Haydn, un
oratorio di musica in armonia con l’ambiente circostante.
L’iniziazione del botanico alla cultura degli indios si completa
quando lo sciamano gli traccia sulla schiena le stesse figure con cui
aveva a suo tempo adornato le pareti delle rocce della zona da lui
abitata. In prossimità della Officina degli Dei, in uno maestoso scenario di montagne prospicienti i fiumi che mescolano le loro acque,
Karamakate guarda il cielo e annuncia: “Ė a questo punto che l’anaconda scende dalla Via Lattea portando i nostri antenati”. Poco dopo
si materializza una pianta di Yakruna e tra i due personaggi si scatena
un violento scontro fisico per il possesso della pianta. Per Richard
tutelarla sarebbe un prezioso supporto dei suoi studi scientifici e, si
potrebbe supporre, per un eventuale sfruttamento commerciale futuro, per Karamakate la traccia della sua cultura originaria.
L’indigeno prevale, strappa la pianta dalle sue radici e fa addormentare il botanico. Al suo risveglio, lo sciamano è scomparso e non
riapparirà più: Karamakate ha compiuto fino alla meta il suo percorso
di riappropriazione della sua identità, tocca ora al botanico americano, esposto alla vista della Officina degli Dei, fare i conti da solo
Letture 353
con se stesso,depurarsi dalle incrostazioni della cultura occidentale,
gettare un ponte tra una mente performativa sul piano razionale e uno
spirito che ha trascurato e omesso, un analogon simmetrico dello stato di “chullachaqui” lamentato dal vecchio sciamano. Entrambi hanno dovuto compiere un sacrificio: l’uno degli strumenti della scienza,
l’altro della sacralità intoccabile della pianta allucinogena. Entrambi
hanno compiuto il percorso per superare il “due-in-uno” che li contraddistingueva, nella prospettiva di una unità, un “uno” da acquisire
insieme, camminando fianco a fianco “in due”.
Questa lettura si apre allora a un approccio tematico sul quale
la filosofia contemporanea ha mostrato un rilevante interesse teorico: il tema dell’Altro, sul quale si possono citare i nomi di Husserl,
Levinas, Ricoeur, Derrida. L’Altro è rappresentato nel film secondo
varie modulazioni: l’altro di una cultura differente per costumi, comportamenti e credenze, l’altro del pensiero magico rispetto a quello
scientifico, l’altro dei miti multiformi e mobili rispetto alla univocità
di una religione fissata nei suoi dogmi irrevocabili. Una alterità rappresentata senza cadere nei compiacimenti dell’esotismo, ma esposta
sullo schermo allo sguardo insieme rispettoso e penetrante della macchina da presa, corredata dalla efficacia immediata e pervasiva del
“bianco e nero”.
Nella tastiera delle alterità differenziali, quello che prevale nel
film è il confronto tra i personaggi, che possiede una implicita ma
significativa valenza filosofica. C’è una alterità e una mutualità, tra i
due occidentali e Karamakate, in particolare tra l’americano Richard
e lo sciamano divenuto vecchio: per entrambi è l’Altro a definire la
propria identità, ciascuno deve poi fare i conti con l’Altro mimetizzato nel proprio Io e il superamento della doppiezza richiede una
mutualità proficua a sopperire a una mancanza originaria che ne è il
connotato che da essa consegue. L’Altro è una opportunità e, nel contempo, un rischio per effetti potenzialmente dissolutivi piuttosto che
affermativi. La costruzione del Sé è un processo virtuoso faticoso,
mai definitivo e vulnerabile a istanze degenerative sia per il nativo,
sia per l’uomo bianco, fino allo stadio finale della pazzia.
Theodor Koch-Grünberg scrive nel suo diario la seguente annotazione: “Non mi è dato sapere in questo momento, caro lettore, se
già la sterminata foresta abbia iniziato in me quel processo che già in
tanti altri, tra coloro che si sono avventurati fin qui, ha condotto alla
completa e irrevocabile pazzia […] So soltanto che, come tutti coloro
354 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
che hanno visto squarciarsi il pesante velo che li accecava, quando
ritornai in me, ero diventato un altro uomo”. Se la foresta può essere
intesa in senso metaforico, esporsi a essa ed esplorarla rimanda alla
alterità che ci circonda e che è insediata nel soggetto, con la quale
confrontarsi, farsi guidare, accettare l’insidia della pazzia nel “diventare un altro”.
Ogni esplorazione esige un equipaggiamento e l’acquisizione di
sufficienti risorse e, insieme, contempla anche abbagli e derive letali. La filosofia può fornire opportuni supporti, ma non certificati assicurativi contro eventuali danni collaterali e neppure sulla validità
assoluta delle sue categorie interpretative. Parafrasando Husserl, si
potrebbe dire che l’approccio filosofico vale “così come esso si dà ed
entro i limiti nei quali si dà”. Questo vale anche per la lettura afferente le opere di creazione letteraria e artistica che sulla base di questo
approccio si può conseguire.
Va aggiunto, a livello informativo, che El abrazo de la serpiente ha avuto ragguardevoli riconoscimenti a livello internazionale.
Ha vinto il premio della “Quinzaine des Réalisateurs” al festival di
Cannes ed è entrato nel concorso come miglior film straniero nella
cinquina presentata al premio Oscar del 2015. Nonostante questi apprezzamenti così significativi, convalidati dai giudizi unanimi della
critica, in Italia il film ha avuto una circolazione assai ridotta e ha
realizzato un incasso miserevole. Anche su ciò ci sarebbe da riflettere.
Franco Sarcinelli
Gli autori
ANDREA ARAF è studente di filosofia al terzo anno all’Università
di Padova. I suoi campi di studi sono per lo più la filosofia francese
contemporanea e la filosofia politica.
ALBERTO GIOVANNI BIUSO è professore associato nel
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania,
dove insegna Filosofia teoretica, Filosofia della mente e Sociologia
della cultura. Fra i suoi libri più recenti: Temporalità e Differenza,
(Firenze: Olschki, 2013); Aión. Teoria generale del tempo, (Catania:
Villaggio Maori Edizioni, 2016); Anarchisme et Anthropologie. Pour
une politique materialiste de la limite, (Parigi: Asinamali éditions,
2016).
MASSIMO CAMPANINI, laureato in filosofia e diplomato in lingua
araba, insegna all’università di Trento ed è membro dell’Accademia
Ambrosiana di Milano. I suoi studi hanno sempre seguito i filoni paralleli della filosofia e degli studi coranici, e della storia contemporanea dei paesi arabi. Ha pubblicato 38 libri, tra cui traduzioni originali
di filosofi musulmani medioevali e: Storia del Medio Oriente contemporaneo (Bologna: il Mulino, 2014); Islam e politica (Bologna:
il Mulino, 2015); Philosophical Perspectives on Modern Qur’anic
Exegesis (Sheffield: Equinox, 2016).
356 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
DANIELA CANAVERO è laureata in Letteratura Greca presso l’Università degli Studi di Milano dove ha conseguito il titolo di dottore
di ricerca in Filologia e Letteratura del Mondo Classico e attualmente
collabora con la cattedra di Letteratura teatrale della Grecia antica.
Docente di Latino e Greco presso il Liceo Carducci di Milano, ha
pubblicato studi sull’epica arcaica, Senofonte, la tragedia attica ed
euripidea in particolare.
MATTEO CANEVARI è professore a contratto di Antropologia
Culturale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università
degli Studi di Pavia. È autore di una monografia dedicata al pensiero di Georges Bataille, La religiosità feroce (Milano: Le Monnier,
2007), di un testo introduttivo su Friedrich Nietzsche, Leggere La
genealogia della morale (Pavia: Ibis edizioni, 2008), e di uno studio
sull’epistemologia della performance in antropologia, Lo specchio infedele (Milano: Mimesis, 2015).
SIMONE CANZIANI è laureando in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi filosofici sono l’ermeneutica, la filosofia della tecnica e dell’arte e l’epistemologia.
FEDERICO FILIPPO FAGOTTO è dottore in Scienze Filosofiche
presso l’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi riguardano
l’estetica e l’orientalistica. Collabora con la cattedra di Estetica di
Milano. È direttore della rivista di arte e cultura La Tigre di Carta,
dalla quale nasce l’associazione culturale La Taiga.
WAEL FAROUQ, docente di arabo all’Università Cattolica di
Milano e, precedentemente, all’Università Americana del Cairo, è
stato Straus Fellow allo Straus Institute for the Advanced Study of
Law and Justice della New York University. Le sue ricerche spaziano nel campo della critica letteraria, degli studi di islamistica e della lingua araba. Fra le sue pubblicazioni: The Windows of Benedict
XVI in Pope Benedict XVI’s Legal Thought (Cambridge: Cambridge
University Press, 2015), Alle radici della ragione araba in Dio salvi
la ragione (Siena: Cantagalli, 2007) con Papa Benedetto XVI.
Gli autori 357
ÁGNES HELLER è stata allieva di Gyorgy Lukács ed esponente della “scuola di Budapest”, corrente critica del marxismo. Dissidente
politica, nel 1977 fu costretta a lasciare l’Ungheria. Ha insegnato alcuni anni in Australia e dal 1986 alla New School for Social Research
di New York, ricoprendo la cattedra intitolata ad Hannah Arendt. Tra
le sue opere tradotte in italiano: Etica generale (Bologna: il Mulino,
1994), Filosofia morale (Bologna: il Mulino, 1997), La bellezza della
persona buona (Parma: Diabasis, 2009).
DIEGO MARCONI, professore ordinario di Filosofia del linguaggio presso l’Università di Torino, è stato presidente della SIFA
(Società Italiana di Filosofia Analitica). Tra i suoi interessi filosofici
vi sono le ricerche sul pensiero di Wittgenstein e sulla filosofia del
linguaggio. Si possono ricordare fra i suoi libri pubblicati: Filosofia
e scienza cognitiva (Roma-Bari: Laterza, 2000); Per la verità.
Relativismo e la filosofia (Torino: Einaudi, 2007); Il mestiere di pensare (Torino: Einaudi, 2014) . GIOACCHINO ORSENIGO è studente al terzo anno del corso triennale alla facoltà di filosofia dell’Università di Pavia. I suoi interessi
riguardano in particolare la filosofia politica e teoretica.
SARA PASETTO ha studiato all’Università degli Studi di Verona e
si è laureata con una tesi intitolata “L’idea di Europa nel pensiero di
Edmund Husserl. Attualità e inattualità” con la supervisione di G.
Bosio e I. A. Bianchi. Attualmente è dottoranda alla Koblenz-Landau
Universität (Campus Landau) con la supervisione di C. Bermes.
NICOLA POLLONI è ricercatore in filosofia medievale presso l’Università di Durham (Regno Unito). Dottore di ricerca in filosofia
(Pavia) e culture del Mediterraneo (Barcellona), si occupa della trasmissione della filosofia arabo-ebraica al mondo latino, con particolare attenzione alle dinamiche di appropriazione transculturale delle
teorie metafisiche, ontologiche ed epistemologiche.
358 InCircolo n. 2 - Dicembre 2016
EMILIO RENZI si è laureato in filosofia all’Università degli Studi di
Milano con Enzo Paci. Ha lavorato alla Casa editrice il Saggiatore e
alla Olivetti. Ha pubblicato Comunità concreta. Le opere e il pensiero
di Adriano Olivetti (Napoli: Guida, 2008), Enzo Paci e Paul Ricoeur.
In un dialogo e dodici saggi (Milano: ATì editore, 2010) e Persona.
Una antropologia filosofica nell’età della globalizzazione (Milano:
ATì editore, 2015).
NATALIA RODRÍGUEZ MARTÍN è dottoranda in Filosofia alla
Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo con la supervisione di HansHelmuth Gander. La sua ricerca riguarda la teoria dell’insegnamento di Emmanuel Levinas con lo scopo di ripensare il ruolo del maestro
e della lingua nell’educazione.
LAURA SANÒ insegna Storia della filosofia contemporanea presso
l’Università di Padova. Le sue indagini si sono indirizzate all’esplorazione della tradizione del “pensiero negativo.” Tra le sue principali
pubblicazioni si ricordano: Un daimon solitario. Il pensiero di Andrea
Emo (Reggio Calabria: Città del Sole edizioni, 2001); Le ragioni
del nulla. Il pensiero tragico nella filosofia italiana tra Ottocento
e Novecento (Troina: Città Aperta, 2005); Rachel Bespaloff, Su
Heidegger (Torino: Bollati Boringhieri, 2010); Donne e violenza.
Filosofia e guerra nel pensiero del ‘900 (Milano: Mimesis, 2012).
VITTORIA SISCA è iscritta alla Università di Bologna, facoltà di
Scienze filosofiche (la laurea specialistica). Interessi di studio: filosofia contemporanea (estetica, ermeneutica filosofica, fenomenologia).
ROLANDO VITALI, dopo aver frequentato studi di filosofia nelle
università di Roma, Bologna e Berlino, si è laureato a Bologna con
una tesi su “Hegel, Adorno e il concetto di esperienza”. Attualmente è
Fellow in residence del Kolleg Friedrich Nietzsche presso l’archivio
di Weimar e dottorando all’università Friedrich Schiller di Jena. I suoi
interessi si concentrano su Adorno, la scuola di Francoforte, Hegel,
Nietzsche e il pensiero tedesco del XIX secolo.
Gli autori 359
GIANNI TRIMARCHI, laureato in filosofia alla Università degli
Studi di Milano, ha collaborato per molti anni al corso di Antropologia
dei media e attualmente collabora con la cattedra di Antropologia della religione presso l’Università di Milano Bicocca. Fra le sue pubblicazioni Lev Vygotskij e le premesse della multimedialità (Milano:
Mondadori, 2007) e Alle origini della televisione: il melodramma e
lo spettatore distratto, in Lo spazio melodrammatico (a cura di M.
Mazzocut Mis, Milano: CUEM, 2005). ALESSANDRA ZAMBELLI, psicologa clinica, psicoterapeuta e psicanalista adleriana, residente a Parigi, ha pubblicato il libro Adler face
à Freud: une différence à sauvegarder, (Paris: Harmattan, 2014) e in
italiano l’articolo “La matrice kantiana della Psicologia Individuale.
Dalla filosofia del ‘Come Se’ di Hans Vaihinger, alla psicanalisi del
‘Come Se’ di Alfred Adler”, nella rivista Magazzini di filosofia. .