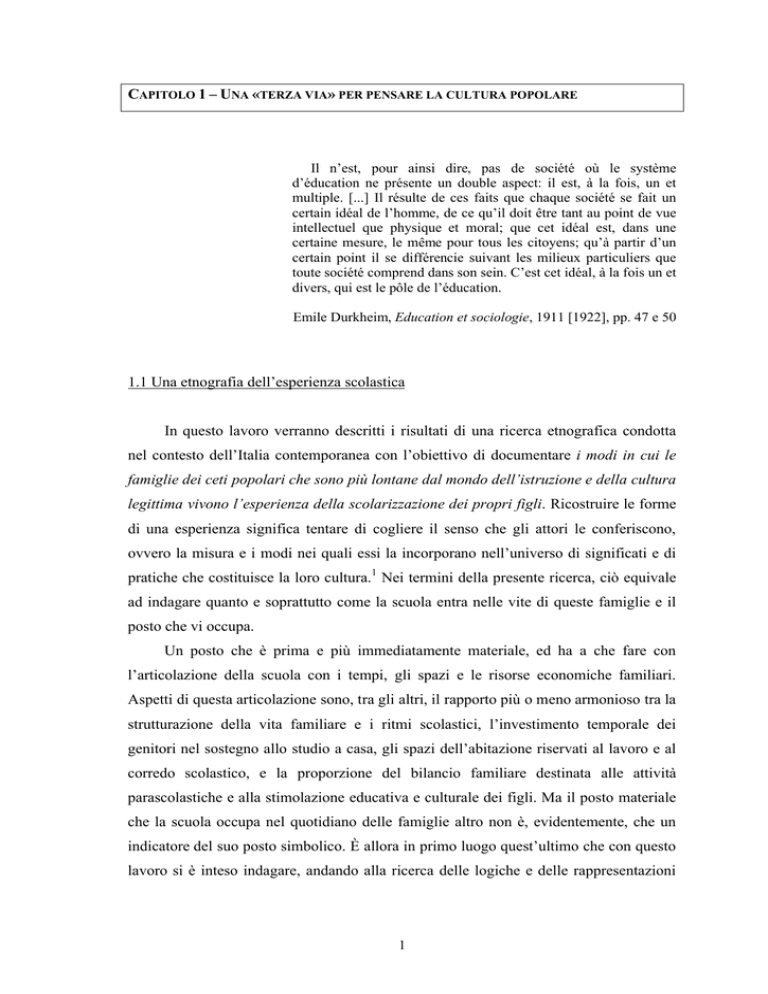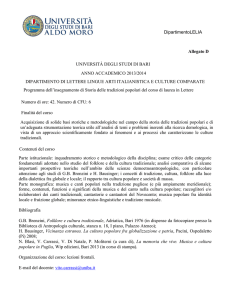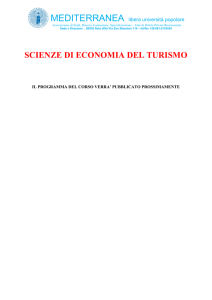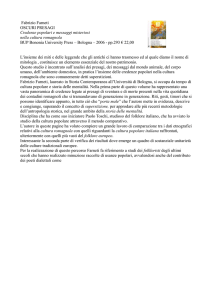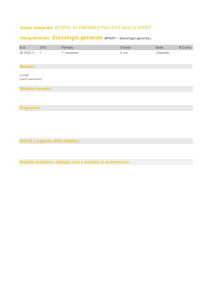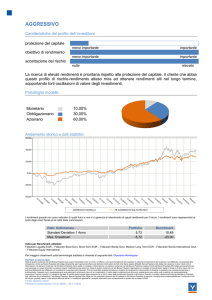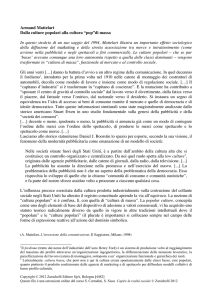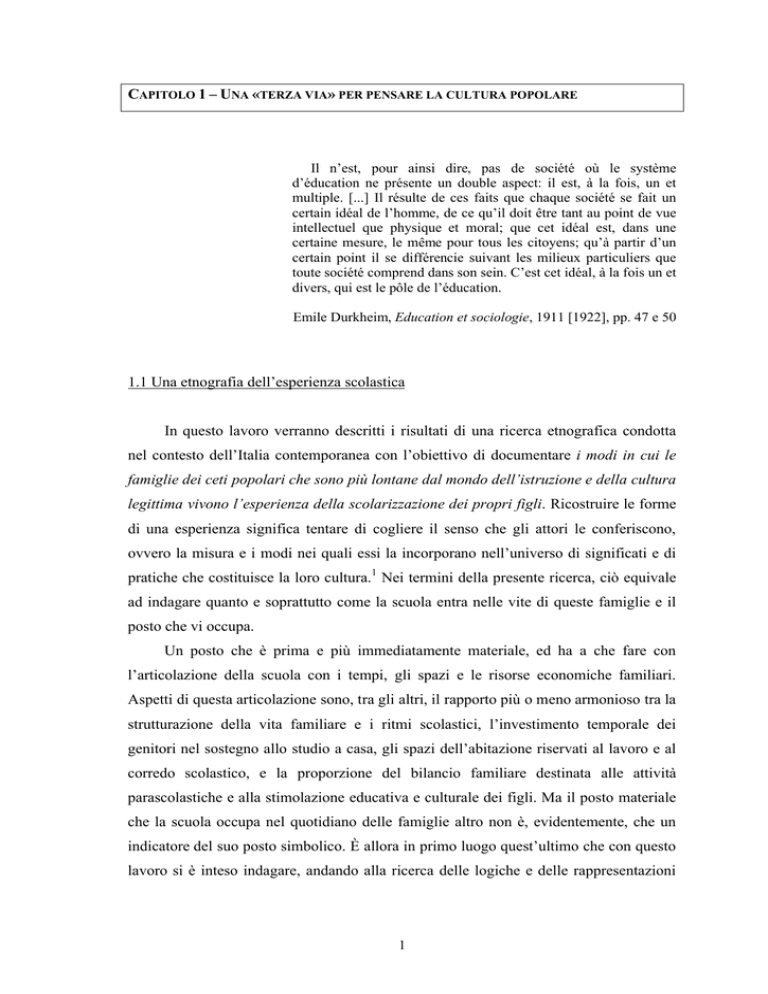
CAPITOLO 1 – UNA «TERZA VIA» PER PENSARE LA CULTURA POPOLARE
Il n’est, pour ainsi dire, pas de société où le système
d’éducation ne présente un double aspect: il est, à la fois, un et
multiple. [...] Il résulte de ces faits que chaque société se fait un
certain idéal de l’homme, de ce qu’il doit être tant au point de vue
intellectuel que physique et moral; que cet idéal est, dans une
certaine mesure, le même pour tous les citoyens; qu’à partir d’un
certain point il se différencie suivant les milieux particuliers que
toute société comprend dans son sein. C’est cet idéal, à la fois un et
divers, qui est le pôle de l’éducation.
Emile Durkheim, Education et sociologie, 1911 [1922], pp. 47 e 50
1.1 Una etnografia dell’esperienza scolastica
In questo lavoro verranno descritti i risultati di una ricerca etnografica condotta
nel contesto dell’Italia contemporanea con l’obiettivo di documentare i modi in cui le
famiglie dei ceti popolari che sono più lontane dal mondo dell’istruzione e della cultura
legittima vivono l’esperienza della scolarizzazione dei propri figli. Ricostruire le forme
di una esperienza significa tentare di cogliere il senso che gli attori le conferiscono,
ovvero la misura e i modi nei quali essi la incorporano nell’universo di significati e di
pratiche che costituisce la loro cultura.1 Nei termini della presente ricerca, ciò equivale
ad indagare quanto e soprattutto come la scuola entra nelle vite di queste famiglie e il
posto che vi occupa.
Un posto che è prima e più immediatamente materiale, ed ha a che fare con
l’articolazione della scuola con i tempi, gli spazi e le risorse economiche familiari.
Aspetti di questa articolazione sono, tra gli altri, il rapporto più o meno armonioso tra la
strutturazione della vita familiare e i ritmi scolastici, l’investimento temporale dei
genitori nel sostegno allo studio a casa, gli spazi dell’abitazione riservati al lavoro e al
corredo scolastico, e la proporzione del bilancio familiare destinata alle attività
parascolastiche e alla stimolazione educativa e culturale dei figli. Ma il posto materiale
che la scuola occupa nel quotidiano delle famiglie altro non è, evidentemente, che un
indicatore del suo posto simbolico. È allora in primo luogo quest’ultimo che con questo
lavoro si è inteso indagare, andando alla ricerca delle logiche e delle rappresentazioni
1
implicite ed esplicite con le quali gli attori danno senso a quell’insieme di pratiche
quotidiane che vanno a costituire il posto materiale che la scuola occupa nelle loro vite.
L’interesse per queste attribuzioni di senso è stato rivolto in modo particolare
all’analisi dei loro rapporti con le corrispondenti concezioni e valori educativi
«legittimi» incarnati nelle istituzioni scolastiche. In altri termini, la prospettiva generale
che ha guidato l’indagine è stata quella dell’analisi di matrice antropologica di un
incontro tra culture: delle forme, cioè, del contatto tra le rappresentazioni, le pratiche e i
valori educativi «legittimi» fatti propri, esibiti e richiesti nel sistema dell’istruzione e
quello che si può definire in modi più o meno equivalenti l’universo culturale, o la
Weltanschauung, o le logiche dell’agire, delle famiglie popolari. È in questo senso, mi
pare, che assumono tutta la loro pertinenza le parole di Education et sociologie con le
quali ho scelto di aprire la dissertazione: perché l’obiettivo di questo lavoro è proprio
quello di andare alla ricerca e poi di tracciare un ritratto il più possibile accurato di quel
certain point a partire dal quale le concezioni antropologiche ed educative implicite ed
esplicite, o, come scrive Durkheim, l’«ideale dell’uomo [e] di ciò che deve essere [...] si
differenzia a seconda degli ambienti particolari che ogni società comprende al suo
interno».
Nella ricerca, questa analisi di un incontro tra universi simbolici – o di un
rapporto tra saperi – ha preso due direzioni principali, ha riguardato cioè due tipi di
saperi. Con una metafora spaziale, si può anche dire che essa ha esplorato due aree
diverse dell’universo simbolico legato all’educazione e all’istruzione.
La prima di queste aree è anche quella che la definizione durkheimiana di «ideale
dell’uomo e di ciò che deve essere» descrive meglio, poiché riguarda proprio le
concezioni relative alla natura e allo sviluppo intellettuale, emotivo e sociale dei figli e
al ruolo dei genitori in esso. In termini essenziali, le rappresentazioni relative a come un
bambino è e deve essere (al mestiere di bambino), e a cosa devono fare i genitori per
farlo diventare quello che deve essere (al mestiere di genitore). Riguarda cioè sia quelle
che la letteratura antropologica e psicologica (in particolare, nel campo della psicologia
dello sviluppo interculturale) recente chiama le etnoteorie genitoriali, o teorie
genitoriali implicite, o naïves2 della personalità, dello sviluppo e dell’educazione, sia
quelle che la letteratura soprattutto sociologica e pedagogica ha sempre chiamato le
concezioni o i modelli dell’educazione familiare.
È evidente come questo tipo di sapere riguardi «il mondo privato degli operai»
(Schwartz 1990) prima ancora che i loro rapporti con il mondo dell’istruzione, e sia
2
radicato in modo inestricabile nella più generale concezione del mondo, o ethos, o
cultura, o modo di vita dei ceti popolari. Ma, soprattutto proprio nei ceti popolari, quella
dell’educazione familiare è anche di gran lunga la dimensione della sfera privata
riguardo alla quale è più difficile ipotizzare «l’autosufficienza simbolica» (Grignon e
Passeron 1989, p. 36), o, per dirla in termini antropologici, una chiusura dei confini
culturali.3 Nella quale, in altri termini, è più improbabile che gli attori non debbano
confrontarsi in qualche modo con i saperi educativi e pedagogici legittimi. E proprio
l’esperienza della scolarizzazione obbligatoria insieme a quella sempre più precoce e
diffusa della scolarizzazione della prima infanzia costituisce tuttora per le famiglie dei
ceti popolari il più potente e pervasivo veicolo di contatto con l’«ideale» dominante di
bambino e di genitore di bambino, ancora prima che con quello di scolaro e di genitore
di scolaro.
Le rappresentazioni e le pratiche relative al mestiere di scolaro e al mestiere di
genitore di scolaro costituiscono invece l’oggetto della seconda grande area simbolica
esplorata nella ricerca. Essa riguarda quindi i saperi legati direttamente al mondo
dell’istruzione, e in particolare il senso che gli attori conferiscono all’esperienza della
scolarizzazione, o, più esattamente, il senso contingente di questa esperienza. Per senso
contingente dell’esperienza della scolarizzazione si intende il senso dato dagli attori –
qui, i genitori dei ceti popolari – alle loro attività più o meno quotidiane legate alla
scuola. Questo senso ha molto a che fare con il rapporto di tipo epistemologico che gli
attori intrattengono con i saperi impartiti e con i processi di apprendimento di questi
saperi, cioè con le loro «sociologie spontanee» dei processi di apprendimento e, per
estensione, delle cause della riuscita scolastica. In primo luogo, quali sono i compiti dei
genitori nel sostenere giorno per giorno i propri figli nella loro scolarità, e quali sono i
rapporti che essi devono avere con l’istituzione scolastica? In che modo i bambini
apprendono le varie materie, e quali sono dunque le attività didattiche che a scuola e a
casa favoriscono questo apprendimento? Da che cosa dipendono la riuscita e il
fallimento scolastico, e, prima ancora, che cosa vuol dire veramente «andare bene a
scuola»? Sono queste alcune delle dimensioni del rapporto epistemologico delle
famiglie popolari con il sapere scolastico che l’analisi delle loro vite quotidiane alla
prese con la scuola dei figli ha permesso di cogliere.
Se in quanto segue la maggior parte dell’attenzione analitica verrà dedicata
all’esplorazione delle due aree simboliche che sono state appena presentate – e che nel
resto del lavoro saranno indicate di preferenza come i saperi relativi al mestiere di
3
bambino (e di genitore di bambino) e i saperi relativi al mestiere di scolaro (e di
genitore di scolaro) – una terza area dell’universo simbolico legato all’educazione e
all’istruzione sarà pure l’oggetto di un certo interesse analitico e di alcune riflessioni. Si
tratta dei saperi relativi a quello che, sulla scorta delle definizioni offerte per le altre due
aree, chiameremo il senso finale dell’esperienza della scolarizzazione, o anche il
mestiere della scuola.
In termini essenziali, se il senso contingente dell’esperienza scolastica ha a che
fare con la risposta alla domanda «che cosa significa studiare», o se si vuole con la
questione del «come» si deve studiare, il senso finale riguarda piuttosto la questione del
«perché» o «a che cosa serve» farlo.4 Riguarda cioè la funzione che l’attore assegna per
sé e per i propri figli alla scolarizzazione e all’istruzione. O, ancora, quello che l’attore
concepisce essere il mestiere della scuola. E poiché questo interrogativo può essere
ulteriormente ritradotto in «qual è il peso che l’esperienza scolastica ha nell’identità
personale, nella costruzione e concezione di sé», sulla scorta di Bernard Charlot (cfr. in
particolare Charlot, Bautier e Rochex 1992) il contenuto di questa terza area simbolica
può essere definito anche rapporto identitario con il sapere scolastico. In questo caso, il
sapere «legittimo» con il quale le famiglie popolari si confrontano è evidentemente
costituito da quelli che nella ricerca educativa di parecchi decenni fa era in voga definire
gli achievement values (i valori della riuscita sociale, o del successo): quei valori
veicolati in primo luogo dalle istituzioni di istruzione ma anche legittimi nella società
che in breve ingiungono a perseguire una mobilità sociale ascendente e a privilegiare
l’istruzione per farlo.
Se l’attribuzione di un senso contingente all’esperienza quotidiana della
scolarizzazione è una necessità insita nel fatto stesso di vivere tale esperienza – è cioè
genericamente il weberiano «senso soggettivo» senza il quale non si può parlare di agire
sociale – questo legame necessario appare, al contrario, tutt’altro che scontato nel caso
dell’attribuzione di un senso finale. Come vedremo, i risultati di questa ricerca
suggeriscono anzi di cercare proprio in questa direzione – nell’esplorazione della natura
del legame tra esperienza scolastica e attribuzione di un senso finale ad essa – una delle
chiavi di volta per comprendere il rapporto complesso tra le famiglie popolari e il
mondo dell’istruzione.
4
1.2 Il pungolo iniziale: Una «terza via» per pensare la cultura popolare
Nella mia frequentazione della letteratura scientifica, da lettrice ho sempre
guardato con sospetto alla tendenza degli autori ad indulgere sulle genesi intellettuali
personali dei loro lavori, sul modo in cui questi lavori avessero preso forma nelle loro
menti e posto nell’evoluzione del loro pensiero. Lo trovavo accettabile e soprattutto di
un qualche interesse pubblico solo nel caso dei veramente «grandi». Che poi erano
quasi sempre quelli che finivano per rivelarsi i più restii a questo genere di confessioni,
offrendo in tal modo un generoso banchetto a tutti quelli che, per dirla con Weber, per
lo più «vivono di» sociologia, e per lo più lo fanno attraverso le «letture di».5 In tutti gli
altri casi, lo ritenevo niente altro che un presuntuoso esercizio di solipsismo.
Poiché non ho cambiato idea, la decisione di aprire questa descrizione del
contesto teorico del mio lavoro ragguagliando in primo luogo il lettore su come è nata la
ricerca nell’ambito di quella che pomposamente definirò la mia evoluzione intellettuale
mi provoca un certo imbarazzo. Credo tuttavia che ciò sia l’unico modo per scongiurare
alcuni malintesi probabili che potrebbero nascere nell’interpretazione di un lavoro in cui
– come cercherò di spiegare in quanto segue – rispettivamente l’interrogativo teorico di
partenza, l’oggetto di studio e la prospettiva analitica con la quale si guarda a tale
oggetto non vanno «naturalmente» insieme, vale a dire provengono sia da tradizioni
disciplinari diverse sia da fasi differenti della storia interna delle discipline.
Soprattutto, si tratta di una eterogeneità non pianificata in partenza, ma costruita
involontariamente durante il percorso a tratti tortuoso tra questioni teoriche e ambiti di
ricerca che dall’idea iniziale ha portato ai risultati del lavoro. Tentare di ricondurre tale
percorso alla linearità del testo scritto è dunque un’impresa che – attraverso le ben note
virtù di strutturazione del pensiero proprie della scrittura – si rivela utile a mettere
ordine nelle idee di chi questa ricerca l’ha fatta prima ancora che a scongiurare «idee
sbagliate» in chi la legge.
La discontinuità – il tornante – più importante di questo percorso ha certamente a
che fare con l’afferenza disciplinare della ricerca. Perché se, come vedremo, il suo
prodotto finale si colloca a pieno titolo in una delle direzioni di sviluppo più recenti – e
in fieri – della sociologia dell’educazione contemporanea, il suo stimolo iniziale ha
preso le mosse da interessi e, quel che più conta, da competenze estranee a questo
ambito disciplinare e radicate piuttosto nella sociologia culturale in senso proprio.6
5
Questa ricerca nasce infatti da un interesse per lo studio delle cosiddette culture di
ceto, considerate in sé, nei loro rapporti reciproci e nei loro rapporti con la cultura
«dominante» o «legittima» nella società. O, come mi piace piuttosto affermare
ostentando un uso moderno di uno dei concetti bandiera della postmodernità, per lo
studio di quella peculiare declinazione del multiculturalismo interno alle società che è
rappresentata da differenze nei modi di vivere, di pensare e di giudicare il mondo legate
a differenze nelle condizioni socio-economiche o – sempre per riesumare il linguaggio
della modernità – di classe sociale.
Sul terreno dell’indagine empirica l’interesse per questo multiculturalismo
d’antan poteva imboccare – e nella lettura socio-antropologica ha solitamente
imboccato – almeno tre strade. La prima è la strada di derivazione più classicamente
antropologica dell’esplorazione più o meno comprensiva del territorio culturale di un
ceto che lasciasse sullo sfondo i suoi rapporti con le culture esterne ai suoi confini. Si
tratta di un approccio di studio delle culture di ceto che ha avuto una presenza sempre
piuttosto marginale ma continua lungo tutta la storia delle scienze sociali, e con il quale
le culture più studiate sono state proprio quelle del proletariato e del sottoproletariato.7
La seconda strada che poteva essere imboccata in una ricerca sulle culture di ceto
è quella della comparazione tra territori culturali, cioè tra ceti differenti, su aspetti
specifici dell’esistenza.8 Infine – ed è questa la strada che è stata imboccata in questo
lavoro – usando ancora una metafora geo-politica, o mercantile, si poteva concentrare
l’attenzione sui movimenti che avvengono nelle zone di frontiera tra territori culturali.
Dopo aver collocato un posto di osservazione all’interno di uno di questi territori ma
vicino al suo confine, si potevano cioè restare a sorvegliare – guardando in direzione
dell’esterno – gli incontri, gli scontri, gli scambi, le importazioni e le esportazioni che
sarebbero avvenuti con il territorio straniero, e – guardando verso l’interno – gli usi che
sarebbero stati fatti dei «prodotti importati».
È evidente come questo terzo approccio di studio alle culture di ceto, così come il
secondo, avrebbe potuto in linea di principio essere applicato all’analisi di qualsiasi
aspetto specifico della cultura e del modo di vita di una classe sociale.9 La scelta di
prendere come oggetto di esplorazione empirica l’ambito dei valori, delle
rappresentazioni e delle pratiche relative all’educazione e all’istruzione (ed entrare in tal
modo in una sfera di competenza della sociologia dell’educazione) è stata quindi
logicamente e cronologicamente successiva all’idea seminale della ricerca.
6
Ma essa è stata anche logicamente conseguente, perché questa particolare sfera
dell’esistenza appariva per molti versi la più «adatta» a un approccio di analisi della
cultura popolare in termini di contatti ed eventualmente, per usare un altro termine
bandiera della postmodernità, contaminazioni. Per la ragione ovvia ma a mio avviso
molto potente che nella sfera dell’educazione e dell’istruzione il contatto con la cultura
«legittima» (intesa sempre nel significato antropologico di universo simbolico
dominante nella società) non può essere evitato come invece si può fare – e di solito gli
attori fanno – con relativa facilità in altre sfere di vita, prima fra tutte quella dei consumi
culturali.
E non poter evitare il contatto in questo ambito significa sovente per i membri dei
ceti popolari più lontani dal mondo della scuola non potersi sottrarre alla dissonanza
cognitiva (o culturale, come è stata ben tradotta in termini sociologici da Bernard
Lahire: cfr. Lahire 2004 e Ravaioli 2005) che questo incontro produce in loro. Significa
soprattutto che essi cercheranno di ridurre questa dissonanza e saranno costretti a farlo
non rifuggendo il contatto con i nuovi elementi culturali ma trovando un
accomodamento, un modo di composizione con essi.
Venire a patti con elementi simbolici estranei al proprio universo culturale va
inteso qui nel significato generico di cominciare a tenere conto della loro esistenza,
trovare loro un qualche posto nella propria cultura. Non implica cioè nulla sulla forma
di questa incorporazione, che può andare dal rifiuto consapevole dei nuovi elementi
culturali (la cosiddetta resistenza culturale, o meglio la rivendicazione di gerarchie di
legittimità concorrenti) alla loro piena assimilazione.
Una variante mitigata del rifiuto è l’adattamento non convinto, l’acquiescenza
diffidente esibita «per non avere grane» in un rapporto di potere che si sa sbilanciato a
proprio sfavore, proprio come è quello tra le istituzioni scolastiche e le famiglie
popolari (sull’acquiescenza forzata come espressione della resistenza culturale delle
famiglie della ricerca all’universo scolastico, cfr. sotto il paragrafo 4.3.1).10 A sua volta,
l’assimilazione di un nuovo «pezzo» di cultura può risultare più o meno completa o più
o meno manchevole: una assimilazione a metà si verifica tipicamente quando la
dimensione valoriale del nuovo elemento culturale viene incorporata dagli attori senza
le sue dimensioni cognitiva e soprattutto prasseologica11 – nei termini di Lahire, gli
attori assimilano l’«appetenza» per qualcosa, cioè il desiderio o addirittura il gusto per
essa, senza riuscire nondimeno ad assimilare la «competenza» pratica per farla.12 È
evidente come, quando gli attori diventano consapevoli di questa loro mancanza di
7
competenza, la condivisione di un ordine di legittimità nel quale sanno di essere
condannati a occupare i gradini più bassi genera in essi un potente sentimento di
illegittimità personale.
Tra il rifiuto e l’adattamento forzato da un lato, e l’«acculturazione» o
conversione più o meno monca dall’altro, c’è una «terza via» attraverso la quale gli
attori incorporano elementi simbolici nuovi e spesso dissonanti nel proprio universo
culturale. Una modalità che non è alternativa alle altre, ma molto spesso convive con
esse. Perché mentre gli attori fanno posto, recalcitranti, nella propria cultura a un
elemento simbolico nuovo che avrebbero respinto volentieri, o, al contrario, mettono
tutto il loro impegno per assorbircelo, è molto probabile che essi stiano comunque
conferendo a questo elemento un senso – poco o tanto – diverso da quello originario che
l’elemento aveva nella sua cultura di provenienza. Soprattutto se questa cultura di
provenienza è la cultura legittima e la cultura di destinazione è la cultura popolare, si
può a giusto titolo parlare di interpretazioni o conferimenti di senso non ortodossi,
«eretici», o, come direbbe Bourdieu, «eterodossi».
Analizzare il rapporto tra la cultura dei ceti popolari e la cultura legittima
focalizzando l’attenzione su queste trasformazioni di senso che i «prestiti» culturali
subiscono nel passaggio dalla seconda alla prima implica l’adozione di una prospettiva
molto diversa da quelle delle analisi in termini di resistenza e acculturazione. Queste
ultime, infatti, anche se solo metaforicamente – cioè anche quando sono
metodologicamente a tutti gli effetti delle analisi interpretative – si può dire che abbiano
come preoccupazione ultima quello di produrre una misurazione: confrontare la
distanza tra i due territori culturali prima e dopo il transito frontaliero di pezzi di cultura
(chiedendosi, per esempio, se la resistenza prodotta dal contatto culturale abbia
aumentato questa distanza)13, o quantificare il peso dei pezzi di cultura transitati
(chiedendosi, per esempio, se siano passati solo i valori o anche le competenze pratiche
relative). Dirigere l’attenzione sulle logiche di interpretazione significa invece
preoccuparsi non tanto di quanta parte del carico culturale sia giunta a destinazione, ma
piuttosto, per continuare con la metafora mercantile, dello stato in cui esso vi è giunto.
Nelle pagine seguenti sosterrò che quella dei conferimenti e delle trasformazioni
di senso è una dimensione del contatto culturale che il dibattito teorico classico sulla
cultura popolare e sui suoi rapporti con la cultura «dominante» sviluppatosi nella
sociologia culturale ha avuto la tendenza a esplorare molto poco. Questa carenza nella
elaborazione teorica generale ha avuto ovvie ripercussioni negative sui settori di
8
indagine in cui i prodotti di tale lavoro teorico sono stati applicati all’analisi empirica
della realtà sociale, a cominciare dall’analisi culturalista delle disuguaglianze educative,
nel campo della socializzazione familiare come in quello dei rapporti con le istituzioni
di istruzione ( su questo cfr. in particolare sotto il paragrafo 2.1.2). La tesi che avanzerò
in questo lavoro è in particolare che questa sottovalutazione ha molto nuociuto alla
elaborazione di un concetto di cultura popolare che fosse di una qualche utilità a fini
euristici, e segnatamente ai fini della comprensione dei rapporti tra le i ceti popolari e
l’istruzione.
Questi rapporti sono stati costantemente al cuore delle preoccupazioni dei
sociologi dell’educazione a partire dalla seconda nascita della disciplina, negli anni
Quaranta, dopo l’eclissi durkheimiana – quando all’urgenza di fare della scuola lo
strumento d’elezione per cementare il legame sociale si sostituì definitivamente quella
di farne la strada maestra per riequilibrare le ingiustizie che troppo spesso di quel
legame modellavano la forma (cfr. sotto il paragrafo 2.1.1). Ma, come vedremo, la
possibilità della loro esplorazione – e quindi comprensione, e infine miglioramento – è
stata altrettanto costantemente limitata dal fatto di essere stata preventivamente costretta
all’interno dell’uno o dell’altro dei due quadri interpretativi della resistenza e
dell’acculturazione descritti sopra.
Mettendo a disposizione delle immagini «già pronte» e dai contorni fin troppo
netti dei rapporti tra i ceti popolari e l’universo educativo, per lungo tempo queste
prospettive analitiche hanno in realtà agito da ostacolo alla ricerca, contribuendo a
mantenere tali rapporti opachi agli occhi dei sociologi dell’educazione. Guardando ai
decenni di storia delle analisi culturaliste delle disuguaglianze educative, mi pare che la
forte frammentazione e la spesso difficile cumulatività dei risultati di queste pur
numerosissime esplorazioni, unita alla costante inconcludenza degli altrettanto numerosi
tentativi di trasformare questi risultati in azioni di policy, sia lì a testimoniarlo.
In questo lavoro sosterrò che una possibile strada per uscire da questa impasse sia
proprio quella di mettere almeno temporaneamente da una parte questi quadri
interpretativi a vantaggio di quella che ho definito la «terza via» per pensare i rapporti
tra la cultura popolare e la cultura legittima: iniziare cioè a guardare all’incontro tra i
ceti popolari e l’universo educativo in primo luogo come a un incontro tra saperi.
9
1.2.1 Il problema teorico nella sociologia della cultura: La cultura popolare tra
legittimismo e relativismo
Quello che ho appena delineato è il percorso intellettuale personale attraverso il
quale sono arrivata a dare forma al progetto di questa ricerca. L’ambito di interesse in
cui questo percorso ha avuto origine è quello dello studio del multiculturalismo di ceto
in generale e, al suo interno, dei rapporti tra la cultura dei ceti popolari e la cultura
legittima della società. La scelta dell’oggetto empirico specifico, l’universo simbolico
legato all’educazione e all’istruzione, è venuta in seguito ed stata dettata dalla
convinzione che esso costituisca un terreno d’osservazione privilegiato di questi
rapporti.
La scelta della prospettiva di analisi, infine, è stata suggerita in primo luogo
dall’insoddisfazione per i quadri e per gli strumenti interpretativi con i quali la cultura
popolare è stata tradizionalmente teorizzata nella sociologia culturale e raffigurata nelle
ricerche classiche sulle disuguaglianze educative. Nelle pagine precedenti questi quadri
interpretativi sono stati evocati solo molto brevemente, e solo nel caso dell’analisi
culturale generale, mentre niente è stato detto sulla loro applicazione alla sociologia
dell’educazione. Il resto di questa sezione sarà dedicata ad una loro illustrazione più
ampia e contestualizzata nella letteratura della sociologia culturale. La loro applicazione
all’analisi culturalista delle disuguaglianze educative sarà invece l’oggetto specifico del
prossimo capitolo.
Ho già accennato sopra al posto piuttosto consolidato ma sempre circoscritto che
gli studi sulla cultura dei ceti popolari occupano nell’analisi sociologica culturale.
Consolidato perché manifestazioni di interesse per questo ambito di ricerca puntellano
l’intera storia della sociologia (si veda per una rassegna la nota 7) – e perfino forse la
sua preistoria, se queste manifestazioni si fanno idealmente iniziare con l’opera di un
contemporaneo di Comte, il mastodontico Les ouvriers européens di Frédéric Le Play
del 1855. Circoscritto perché si tratta di un tema che non ha mai occupato il
palcoscenico della sociologia culturale – e sul quale, per questo motivo, tuttora non
sono state affatto esaurite le potenzialità di indagine (si veda la nota 9).
Naturalmente ha avuto momenti di minore e di maggiore fortuna. Questi ultimi
tuttavia non hanno coinciso – o almeno non prevalentemente – con i momenti di fortuna
generale dell’analisi culturale nelle scienze sociali, vale a dire l’auge del
parsonsianesimo prima, e, molto più tardi, il cultural turn della metà degli anni Ottanta.
10
Hanno coinciso piuttosto con gli anni a cavallo tra questi due periodi, quelli in cui la
scena era dominata dalle cosiddette sociologie del conflitto, vale a dire gli anni Sessanta
e Settanta. Un periodo che è solitamente ricordato nelle storie dell’analisi culturale in
sociologia come uno di quelli in cui l’interesse per la dimensione simbolica della vita
sociale ebbe la vita più dura, ridotto come era ad una serie di enclaves ben delimitate
come per esempio la microsociologia.
Eppure proprio in questi due decenni sorsero tre direzioni di ricerca che, seppure
in modi differenti, misero al centro l’interesse per lo studio della cultura dei ceti
popolari. La prima in ordine di tempo è quella legata al concetto di cultura della
povertà introdotto dell’antropologo statunitense Oscar Lewis (Lewis 1959, 1966, 1970).
La seconda si sviluppò in un contesto ugualmente tangenziale alla sociologia (sebbene
avrebbe esercitato in seguito una influenza notevole sullo sviluppo della «nuova»
sociologia culturale) ed è legata ai lavori prodotti nel periodo inglese dei Cultural
Studies. La terza direzione di ricerca che negli anni Sessanta e Settanta portò al centro
l’interesse per le culture di ceto venne invece dal cuore della sociologia, e anzi nella
sociologia in quegli anni detenette un quasi monopolio dell’analisi culturale: si tratta dei
lavori ispirati alla teoria della riproduzione sociale di Bourdieu e della sua scuola.
Le ricerche e il dibattito stimolati dalla teoria della cultura della povertà negli
Stati Uniti, i British Cultural Studies e la sociologia bourdieuiana in Francia non hanno
rappresentato soltanto i momenti d’oro dello studio della cultura popolare nelle scienze
sociali del Novecento. Essi sono stati anche i momenti nel corso dei quali il dibattito
teorico su questa cultura e sui suoi rapporti con la cultura «dominante» si è costituito e
soprattutto le due prospettive analitiche classiche su questi rapporti hanno preso forma.
Nelle pagine precedenti mi sono limitata a descrivere provvisoriamente e molto
imperfettamente questi due quadri interpretativi del rapporto tra i membri della cultura
popolare e la cultura «dominante» come la prospettiva del rifiuto (o resistenza, o
adattamento forzato) e la prospettiva dell’assimilazione più o meno riuscita (o
acculturazione, o conversione).
Rifiutare significa evidentemente potere e volere rivendicare una gerarchia di
legittimità culturale (relativa a qualsiasi tipo di universo simbolico, a cominciare dalle
scale dei valori) alternativa e concorrente. Laddove predisporsi all’assimilazione
significa al contrario condividere ancora prima la stessa gerarchia di legittimità
culturale.14 Tutto questo significa, a sua volta, che dietro all’ipotesi del rapporto di
resistenza e all’ipotesi del rapporto di assimilazione stanno due concezioni molto
11
diverse della cultura popolare: quella relativista – o massimalista (Cuche 2001, p. 88) –
di una cultura dotata di una piena autonomia simbolica nel primo caso, quella
legittimista – o minimalista (ivi, p. 87) – di un universo simbolico eteronomo (Grignon
e Passeron 1989) che è prodotto e funzione di un rapporto di dominio simbolico nel
secondo.
Ciascuna di queste concezioni porta soprattutto con sé un chiaro corollario
metodologico, vale a dire una raccomandazione forte su come fare analisi culturale. Se
la cultura popolare ha origini autonome vuol dire infatti che essa è anche autosufficiente
nel momento in cui si presta alla comprensione: per coglierla e descriverla non è cioè
necessario fare riferimento ad altri universi culturali, e segnatamente a quello
dominante. Se al contrario la cultura popolare ha origini eteronome, la comprensione e
la descrizione dei suoi elementi non potranno mai prescindere dai riferimenti al rapporto
di dominio simbolico rispetto al quale soltanto essi acquistano il loro significato. Ecco
come Grignon e Passeron descrivono questo dilemma metodologico generato dalle due
concezioni classiche della cultura popolare:
Per comprendere una cultura popolare nella sua coerenza simbolica,
bisogna allora trattarla come un universo di significato autonomo,
dimenticando tutto ciò che si trova al di fuori e al di sopra di essa, e in
primo luogo gli effetti simbolici del dominio che subiscono coloro che
la praticano, rischiando di tornarci solo dopo? O bisogna al contrario
partire dal dominio sociale che la costituisce come cultura dominata
per interpretare subito in rapporto a questo principio di eteronomia
tutte le sue pratiche e le sue produzioni simboliche?
(Grignon e Passeron 1989, p. 19)
Relativismo e legittimismo rappresentano dunque i due principi analitici
fondamentali attraverso i quali la cultura popolare è stata tradizionalmente pensata e
descritta nelle scienze sociali (e secondo Grignon e Passeron anche nella storia della
letteratura sui ceti popolari, nella quale essi identificano la presenza dello stesso
dualismo interpretativo). Come avremo parzialmente modo di vedere nella breve
rassegna che seguirà, tuttavia, molto diverse sono state le forme, o le varianti, che questi
due quadri interpretativi di base hanno assunto nei vari filoni di ricerca sulla cultura
popolare. Al punto che questo vero e proprio poliformismo ha molto spesso messo in
ombra la presenza di elementi ricorrenti e analogie sostanziali tra prospettive teoriche in
apparenza molto lontane o basate su presupposti inconciliabili, ma in realtà
riconducibili ad una stessa concezione della cultura popolare.
12
1.2.1.1 Le due facce del relativismo: L’Altro-stesso e l’Altro-altro
Uno dei più importanti elementi di differenziazione tra teorie della cultura
popolare che pure adottano la stessa prospettiva interpretativa di base riguarda in
particolare i giudizi di valore sull’oggetto di studio, o quanto meno – volendo
presumere una assenza di giudizi di valore – la weberiana relazione con i valori che ha
guidato i ricercatori nella scelta dell’oggetto e della prospettiva di analisi. Ovvero, per
dirla ancora più infelicemente, la sovrastruttura ideologica delle teorie stesse.
Concretamente, ciò significa che per esempio la tesi relativista – o dell’autonomia e
dell’alterità culturale – è stata ugualmente evocata sia con l’intento di «glorificare» la
cultura dei ceti popolari e rivendicarne la pari dignità rispetto alla cultura legittima, sia
come una evidenza scientifica della limitata integrabilità (ed educabilità) dei membri dei
ceti popolari nella società e nei suoi valori. E quindi, in ultima analisi, come una
spiegazione scientifica della inevitabilità della loro condizione di inferiorità sociale.
Vedremo tra poco come il primo uso della concezione relativista della cultura
popolare sia associato soprattutto alla prospettiva dei British Cultural Studies. Ma è
anche, più in generale, la visione delle culture dominate che informa tradizionalmente la
grande maggioranza delle cosiddette pedagogie critiche, e in particolare delle
pedagogie popolari moderne.15 Cioè, di quelle elaborazioni teoriche e di quelle pratiche
pedagogiche che sono state pensate specificamente per educare efficacemente «i figli
del popolo», soprattutto in occasione dei due momenti chiave che l’educazione del
popolo ha conosciuto nel Novecento, la democratizzazione dell’istruzione elementare
all’inizio del secolo e poi quella dell’istruzione secondaria di sessant’anni dopo. Dalla
pédagogie populaire di Célestin Freinet alla questione del cosiddetto multicultural
curriculum negli Stati Uniti – vale a dire la politica di trasformazione nel senso del
relativismo culturale del curriculum scolastico e universitario iniziata nell’America
degli anni Sessanta con l’introduzione dei Black Studies e continuata in tempi molto più
recenti con l’instaurazione dei programmi bilingui, e bi-culturali, per studenti ispanici –
la grande maggioranza delle riflessioni teoriche e delle sperimentazioni pedagogiche
elaborate in queste due grandi ondate di interesse per il tema delle pedagogie popolari
avevano in comune il rifiuto di quella «separazione della scuola dalla vita» che
costituisce storicamente l’essenza del modo di educazione scolastico (cfr. Durkheim
1938; Ariès 1960; Vincent 1980; Vincent (ed.) 1994).16 E l’idea che la strada per la
democratizzazione dell’istruzione passasse piuttosto per l’«apertura» della scuola alla
13
vita e alla cultura di provenienza degli allievi svantaggiati, e segnatamente per la
valorizzazione di questa cultura e dei suoi interessi e saperi all’interno del curriculum
scolastico (sul passaggio storico dal legittimismo al relativismo nella cultura scolastica,
cfr. Chartier 2003).17
Le premesse delle riflessioni sulla pedagogia popolare sono dunque una
concezione relativista della cultura popolare e una attribuzione causale proprio a questa
diversità culturale del difficile adattamento scolastico dei membri dei ceti più bassi. La
conclusione, la necessità di ridurre tale incompatibilità culturale trasformando per
quanto possibile l’universo simbolico scolastico nella direzione di un avvicinamento
alla cultura di provenienza dei suoi nuovi fruitori popolari. In altri importanti filoni di
ricerca sulle culture di ceto della sociologia del Novecento, queste stesse premesse
fortemente relativistiche sono state associate a una connotazione assai meno positiva
dell’alterità della cultura popolare ed hanno condotto a conclusioni molto meno
ottimistiche. È il caso in particolare, come vedremo meglio tra poco, della corrente di
studio sui cosiddetti valori di classe che ha dominato la sociologia e la psicologia
sociale statunitense di matrice parsonsiana negli anni a metà del secolo, e della
successiva teoria della cultura della povertà degli anni Sessanta. Questi due ambiti di
ricerca non si sono interessati tanto, come le riflessioni sulla pedagogia popolare, al
comportamento dei membri dei ceti più bassi una volta all’interno del sistema di
istruzione – banalmente, al fatto che essi non mostrassero di trarre profitto dall’accesso
a tale sistema – quanto piuttosto della loro minore propensione a entrarvi e in generale a
ricorrervi per perseguire una mobilità sociale ascendente. Ma nell’uno come nell’altro
caso è stata un spiegazione in termini di alterità culturale (prevalentemente centrata sui
valori nel secondo caso, centrata sui valori ma anche indissolubilmente sugli stili
cognitivi nel primo) originaria – cioè come un fatto primo e non derivato – quella che è
stata proposta.
Una diversità culturale che, tuttavia, nel relativismo «ottimistico» delle pedagogie
popolari e dei Cultural Studies è una risorsa ingiustamente svalorizzata (e
potenzialmente
e
auspicabilmente
valorizzabile)
dall’«arbitrario
culturale»18
dell’universo simbolico dominante. Laddove nel relativismo «pessimistico» delle
ricerche culturaliste sulla povertà e ancor più nelle ricerche classiche sui valori è
piuttosto l’eterogeneità irriducibile di due universi simbolici – «two nations», secondo
la nota definizione di Michael Harrington in The Other America (1962) (cfr. Marcus
2005, p. 36) – che, quasi come il sacro e il profano, «si escludono radicalmente»
14
(Durkheim 1912, p. 42). E in cui, analogamente, il passaggio sempre improbabile di un
individuo «da uno di questi mondi nell’altro [...] implica una vera metamorfosi» (ivi, p.
41). Una «metamorfosi» che in quest’ottica non può che procedere segnatamente da una
deculturazione e risocializzazione il più possibile precoce dei portatori della cultura
popolare – come fu per esempio nei chiari intenti ispiratori della vasta campagna di
compensatory programs rivolti a bambini svantaggiati soprattutto di età prescolare che
venne lanciata negli Stati Uniti nell’ambito della War on Poverty della seconda metà
degli anni Sessanta.
1.2.1.1.1 Il relativismo «pessimistico» della socio-antropologia statunitense: La cultura
della povertà, i valori di classe e la questione della sottoclasse
La teoria della cultura della povertà ebbe una fortuna piuttosto controversa,
circoscritta per lo più al dibattito statunitense degli anni Sessanta e Settanta.19 Questo
dibattito riguardava segnatamente la questione delle cause della persistenza della
povertà – e soprattutto degli strumenti più idonei per combatterla – e in esso si
mescolavano molto più che in altre controversie sociologiche posizioni teoriche, prese
di posizione politiche e conseguenti orientamenti di policy. I termini essenziali della
dibattito sono ben noti. Per i teorici della cultura della povertà (tra i quali vanno almeno
ricordati, oltre a Oscar Lewis, il Daniel Moynihan di The Negro Family, o l’Edward
Banfield di The Unheavenly City), la povertà si riproduce perché i poveri non hanno la
capacità di percepire e di trarre vantaggio dalle opportunità strutturali di mobilità
sociale ascendente che sono offerte loro, per esempio dall’espansione delle possibilità di
accesso all’istruzione. Soprattutto, questo accade perché essi possiedono valori diversi
da quelli dominanti nella società: non aspirano ad ascendere socialmente, o hanno
un’altra idea della riuscita sociale, o in ogni caso non apprezzano i mezzi che sono
offerti loro per ottenerla, come appunto l’istruzione. Nelle parole di un noto passo di
Lewis:
La cultura della povertà [...] non è soltanto un adattamento a una serie
di condizioni obiettive della società più vasta. Una volta venuta a
determinarsi, tende a perpetuarsi di generazione in generazione a
causa del suo effetto sui figli. I fanciulli dei quartieri poveri, una volta
giunti all’età di sei o sette anni, hanno già assorbito, di solito, i valori
fondamentali e gli atteggiamenti della loro sottocultura e non sono
psicologicamente preparati ad approfittare appieno di mutamenti di
15
condizioni o di più numerose opportunità che possono presentarsi nel
corso della loro esistenza.
(Lewis 1970, tr. it. p. 96)20
È evidente come in quest’ottica le azioni di contrasto alla povertà e alla sua
riproduzione avrebbero dovuto essere indirizzate primariamente alla sfera culturale.
Azioni di policy volte ad incidere sulle condizioni materiali di esistenza erano invece
invocate dai critici della teoria della cultura della povertà (molte delle cui posizioni sono
raccolte in Leacock (ed.) 1971 e Winter (ed.) 1971), per i quali la riproduzione della
piaga sociale della povertà aveva in primo luogo cause strutturali. Per questi studiosi, i
valori e le aspirazioni dei poveri non differivano sostanzialmente da quelli dominanti, e
se i poveri esibivano condotte di azione che non apparivano in accordo con questi
valori, questo accadeva perché tali condotte erano una forma di adattamento alle
condizioni di esistenza e ai condizionamenti imposti da esse. Condizioni di esistenza e
condizionamenti intesi nel significato di ostacoli strutturali esterni all’individuo, quali
per esempio, concretamente, la mancanza di capitale economico o il fatto di vivere in
ghetti privi di buone scuole.
I termini della controversia avevano dunque a che fare con la questione della
condivisione degli orientamenti di valore all’interno della società, e in secondo luogo
con la questione del rapporto tra gli orientamenti di valore e le logiche dell’agire. I
poveri che esibivano comportamenti «non ortodossi» rispetto alla cultura dominante
nella società erano portatori di orientamenti di valore altrettanto differenti da quelli
dominanti o questi valori condivisi lo erano anche da loro? E se gli orientamenti di
valore non differivano, come doveva essere spiegato il fatto che spesso tali valori
convivessero nei poveri con comportamenti in contrasto con essi?21
Probabilmente per il suo radicamento nell’antropologia culturale (che riguardava
molti dei sostenitori ma anche molti dei detrattori del concetto cultura della povertà, a
cominciare da quelli in prima fila come Charles Valentine), il dibattito degli anni
Sessanta e Settanta sulla teoria della cultura della povertà si sostanziava per lo più in
studi di natura etnografica sul modo di vita e sistema di valori – la cultura, appunto – di
particolari sottoclassi geograficamente localizzate, come gli abitanti di ghetti urbani. Ed
era
indubbiamente
questo
taglio
antropologico,
che
portava
con
sé
una
contestualizzazione degli orientamenti di valore all’interno di una cultura più vasta, a
conferire al tema gran parte della sua novità nel dibattito scientifico statunitense.
16
Perché in tale dibattito il tema in sé non era affatto nuovo, e il dilemma intorno
all’esistenza di un pluralismo di valori legato all’appartenenza di ceto, con particolare –
e preoccupato – riferimento ai ceti più bassi, travagliava la sociologia e soprattutto la
psicologia sociale americana già da almeno vent’anni. Le ricerche nell’ambito della
psicologia sociale finalizzate a misurare se e a che punto finissero i common values e se
e dove cominciassero i class differential values (Han 1969), soprattutto nei ceti bassi e
nei gruppi devianti (spesso accostati con disinvoltura nelle argomentazioni: cfr. per
esempio Rodman 1963), costituirono anzi dagli anni Quaranta fino a tutti gli anni
Sessanta uno dei principali campi di applicazione empirica della sociologia
parsonsiana.22
Si tratta di un filone di indagine empirica caratterizzato dalla produzione intensiva
di un gran numero di contributi (su questa letteratura cfr. più diffusamente sotto il
paragrafo 2.2.3.1), e nello stesso tempo da caratteri e contorni molto ben definiti dovuti
a una alta omogeneità della produzione stessa. Questa omogeneità è in primo luogo di
carattere metodologico ed è data dal ricorso universale a tecniche quantitative di analisi
dei dati (per una rassegna parziale, si veda Kahl 1965): surveys con domande dirette,
scale di atteggiamento con affermazioni generali esprimenti orientamenti di valore,
metodi proiettivi per cogliere i valori «inconsci», fino all’osservazione del
comportamento in situazioni sperimentali di laboratorio. In secondo luogo, e soprattutto,
in queste ricerche lo studio del pluralismo di valori legato all’appartenenza di ceto è in
realtà altrettanto universalmente circoscritto a una porzione ben delimitata del sistema
dei valori, i cosiddetti «valori della riuscita sociale» o «valori del successo». Cosicché
gli achievement values finiscono per diventare, proprio come in una sineddoche in cui la
parte è usata per esprimere il tutto, l’unico metro possibile per misurare il grado di
integrazione (e integrabilità) dei ceti più bassi nella società e nei suoi common values.
È in particolare primariamente attraverso la rilevazione di aspirazioni (non
sempre analiticamente distinte dalle aspettative: per una eccezione cfr. Caro e Pihlblad
1965) che in tali ricerche la presenza di questi «valori del successo» veniva esplorata
nei soggetti. E poiché nel sistema dei valori dominante – quello di cui si intendeva
appunto misurare l’estensione tra i ceti – l’aspirazione alla riuscita sociale per
antonomasia era quella che passava per il livello di istruzione e poi per lo status
professionale, la grande maggioranza di queste ricerche finivano concretamente per
occuparsi del tema della ambizioni educative e lavorative di genitori e di studenti
common man (Kahl 1953). Per rilevare, di nuovo nella grande maggioranza (sebbene
17
non nella totalità: sulla diversità delle conclusioni, cfr. sotto il paragrafo 2.2.3.1), che
«quello che risulta in generale è un livello più basso di aspettative e di speranze da parte
delle classi inferiori» (Hyman 1953, tr. it. p. 275), e soprattutto interpretare questo dato
con l’idea che
esiste una variabile interveniente tra la bassa posizione sociale e la
mancanza di mobilità verso l’alto, e cioè un sistema di credenze e di
valori all’interno delle classi inferiori, che riduce proprio le azioni
volontarie che potrebbero migliorare la bassa posizione di queste nella
struttura sociale. Questo sistema di valori [...] implica minor
importanza della meta tradizionale del successo, maggiore
consapevolezza della mancanza di possibilità reali di ascesa, minor
interesse per il raggiungimento di obiettivi che a loro volta
faciliterebbero il successo. In termini più semplici, l’individuo delle
classi inferiori non ha obiettivi di successo, sa che non potrebbe
affermarsi anche se lo volesse, e ancora non vuole cose che potrebbero
essergli utili nell’ottenere il successo.23 [...] Questo sistema di valori
creerebbe un ostacolo auto-imposto nel perseguimento di una ascesa
sociale.
(Hyman 1953, tr. it. pp. 267-268)24
Qualche anno più tardi, lo abbiamo visto, Oscar Lewis avrebbe cominciato a
chiamare questa «variabile interveniente» una cultura della povertà, e avrebbe così
inaugurato un nuovo periodo di auge per la tesi dell’alterità valoriale della cultura
popolare. Una questione che nella sociologia americana non ha ancora cessato di essere
discussa, se si considera la controversia recente sulla cosiddetta sottoclasse (underclass)
(cfr. Katz 1993). Si tratta di un dibattito che ricorda molto da vicino quello degli anni
Sessanta e Settanta intorno alle cause e alla cultura della povertà. In termini essenziali,
infatti, la questione sul tappeto questa volta è se abbia senso o meno parlare
dell’esistenza di un sottoproletariato come categoria sociale definita da tratti culturali
specifici, una sottoclasse, appunto. E il lato politico della controversia verte
naturalmente sull’opportunità della fornitura di servizi sociali: la differenza con il
dibattito politico degli anni Sessanta e Settanta è forse che mentre allora era in
questione la natura dei servizi sociali da erogare – di tipo soprattutto educativo o
soprattutto materiale – oggi il punto è diventato piuttosto se erogarli tout court o
lasciare al proprio destino chi di quel destino è considerato l’artefice, cioè l’undeserving
poor. Al centro del dibattito sono in particolare le tesi del più estremo sostenitore del
concetto di underclass, Charles Murray (1984), il quale ritiene che dell’esistenza di una
underclass si possa e si debba parlare, e sostiene soprattutto che ciò che definisce questo
18
gruppo sia proprio una alterità (o una «devianza») di tipo culturale. Tentare di sottrarre i
membri dell’underclass alla loro condizione attraverso interventi di welfare materiale
non solo dunque è inutile, ma può rivelarsi anche controproducente favorendo lo
sviluppo in essi di una «cultura della dipendenza» da welfare.25
Questa velocissima carrellata lungo decenni di sociologia statunitense ha avuto a
che fare con questioni quali la povertà, la guerra alla povertà e, in generale, il grado di
integrabilità materiale e simbolica nella società dei suoi membri più diseredati – fossero
essi padri e figli di «uomini della strada» (common man) come nelle ricerche sui valori
di classe, membri di una «sottoclasse», o dei semplici «poveri», meritevoli o non
meritevoli. Ha toccato quindi filoni di analisi culturalista della stratificazione sociale in
parte distinti da quello – in qualche modo meno «estremo» – nel quale si colloca
l’oggetto di questo lavoro. Il quale, si potrebbe dire con una affermazione
indubbiamente molto inesatta e infinitamente discutibile, si interessa piuttosto alla
dimensione culturale della povertà economica e di istruzione «normale», a quella
povertà cioè che sta un gradino prima del livello della marginalità sociale e del
problema sociale conclamati.26 Ovvero, a quei moderni working poors «dignitosi» e
socialmente «invisibili» a proposito dei quali qualcuno che li conosce molto bene come
la saggista statunitense Barbara Ehrenreich nella sua celebre inchiesta-shock Nickel and
Dimed osserva giustamente:
Una strana proprietà ottica della nostra società, così polarizzata e
ingiusta, fa sì che i poveri siano praticamente invisibili per chi è loro
economicamente superiore. I poveri hanno molte occasioni per vedere
i ricchi: alla televisione, per esempio, o sulla copertina delle riviste.
Ma è raro che i ricchi vedano i poveri in pubblico, oppure hanno
difficoltà a riconoscerli perchè, grazie alle rateizzazioni e ai grandi
magazzini popolari, i poveri possono travestirsi da un po’ più ricchi.
(Ehrenreich 2001, tr. it. p. 150)
Il punto da sottolineare qui è che questa sovrappresentazione di filoni di analisi
culturalista dell’alterità estrema non è imputabile tanto ad una mia selezione arbitraria,
parziale e comunque poco pertinente della letteratura statunitense sul tema della cultura
popolare. Ma è dovuta piuttosto al fatto che un impedimento ottico molto simile a quella
di cui parla Ehrenreich, e che oggi sembra rendere la working class e i suoi problemi
invisibili alla società americana (e certamente alle società di una gran parte del
cosiddetto Primo Mondo anche europeo), pare avere afflitto più o meno cronicamente
anche lo studio delle culture di ceto nella storia della socio-antropologia statunitense.
19
Nella quale, se si eccettua una certa consolidata tradizione di ricerche su comunità
operaie condotte però per lo più nell’ambito di interessi propri della sociologia del
lavoro e dell’industria,27 il termine di confronto esplicito o implicito con l’universo
simbolico legittimo incarnato dalla middle class non è stata quasi mai la cultura di una
working class intesa «all’europea» ma è stata quasi sempre la cultura di un
lumpenproletariat. È quanto osserva in un recente saggio dedicato proprio al posto della
working class nella storia delle scienze sociali e della politica statunitense anche
l’antropologo Anthony Marcus, il quale tra l’altro scrive:
Veniamo lasciati con la parte del proletariato americano che viene
recitata dal suo attore sostituto, l’«altra America»: un gruppo
scritturato per la sua impotenza economica e per la sua miseria
esotica. [...] Non esistendo due soli ricercatori che concordino su una
definizione oggettiva teorica o scientificamente replicabile
[dell’oggetto di studio], la ricerca sulla povertà in America ha
utilizzato tipicamente una unità di analisi definita dalle persone povere
che sono maggiormente visibili.
(Marcus 2005, pp. 35 e 37)
Diventa allora in realtà improprio anche qualificare, sempre «all’europea», gli ambiti di
ricerca che ho ricordato nelle pagine precedenti come degli studi sulle culture di ceto.
Perché in essi il confronto non è inteso tanto come una messa in relazione tra i modi di
vivere e pensare dei vari gruppi di cui la società si compone, ma, piuttosto, come una
contrapposizione tra la cultura della società americana (fatta coincidere con quella della
sua middle class) e la cultura di un mondo altro e ad essa irriducibile – The Other
America, appunto.
1.2.1.1.2 Il relativismo «ottimistico» dei (British) Cultural Studies
Questa idea di un multiculturalismo interno alla società è invece ben presente nei
cosiddetti Cultural Studies. Ai quali pure la definizione di «studi sulle culture di ceto» si
addice poco, se si considera che è in realtà la cultura popolare a costituire l’oggetto di
analisi unico e distintivo di questa corrente di analisi culturalista. Una corrente che,
come è ampiamente noto, nata British in una coesa famiglia multidisciplinare, alla
maggiore età è felicemente espatriata negli Stati Uniti per convolare a nozze sempre più
monogamiche con le humanities di quel Paese, spargere la propria discendenza
pressoché ovunque nel mondo, e soprattutto cambiare più o meno radicalmente vita
20
convertendosi a un radicale postmodernismo. Non è mia intenzione proporre qui una
ricostruzione della biografia di questo polimorfo campo di ricerca, i cui interessi –
soprattutto quelli attuali – cadono molto tangenzialmente nell’ambito di pertinenza di
questo lavoro. Esso rappresenta tuttavia tuttora una delle versioni più articolate e
radicali della prospettiva relativista di analisi della cultura popolare, ed è in questa veste
che alcuni dei tratti distintivi di questo approccio verranno qui evocati brevemente.
In un saggio ormai classico sull’evoluzione dei primi venticinque anni dei
Cultural Studies, Stuart Hall (1980) individua nella convivenza – e tensione – tra un
«paradigma culturalista» e un «paradigma strutturalista» il nucleo teorico di questo
approccio. Il primo paradigma, storicamente precedente, è quello delle origini di questo
campo di ricerca: è l’approccio di analisi culturale delineato tra la fine degli anni
Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta nei lavori dei «pionieri» Raymond Williams
(1958), Edward Thompson (1963) e Richard Hoggart (1957). Il secondo seguì alla
generale fortuna dello strutturalismo simbolico nell’Europa degli anni Settanta. Già il
paradigma culturalista era nato nell’area della cosiddetta New Left inglese come un
recupero dell’importanza del simbolico e soprattutto del volontarismo in reazione tanto
alla teoria culturale della Scuola di Francoforte quanto all’economicismo del marxismo
ortodosso britannico (cfr. tra gli altri Williams 1973; Johnson 1979; Dworkin 1997) –
un approccio che lo stesso Williams definì materialismo culturale. L’incontro con e
l’incorporazione di altre tradizioni, europee continentali, di marxismo culturalista nei
due paradigmi dei Cultural Studies caratterizzò poi tutta la storia successiva
dell’evoluzione teorica di questo approccio di analisi culturale. In particolare, questa
storia fu segnata, dal lato del paradigma strutturalista, dall’appropriazione della
riflessione di Althusser e del suo concetto di ideologia negli anni Settanta, e, dal lato
prevalentemente del paradigma culturalista, da quella di alcuni aspetti del pensiero di
Gramsci e in particolare del suo concetto di egemonia prevalentemente negli anni
Ottanta.
L’apertura alla teoria psicoanalitica di Lacan, alla semiotica, al post-strutturalismo
di Foucault costituirono le evoluzioni principali del coté strutturalista, evoluzioni che
prepararono a loro volta il terreno all’apertura sempre più massiccia al postmodernismo
e al successo dei Cultural Studies negli Stati Uniti. Se l’eredità del paradigma
strutturalista venne prevedibilmente raccolta da filoni di ricerca interessati soprattutto
all’analisi degli oggetti culturali, ai «testi» e ai «discorsi», quella del paradigma
culturalista arricchito dell’innesto gramsciano rivisse per lo più in approcci che davano
21
la priorità all’analisi dei contesti e delle pratiche di consumo di tali oggetti.28 Le
ricerche sulle subculture, quelle sul cosiddetto «consumo produttivo» e in generale le
teorie della resistenza culturale – o resistenza «semiotica», nella definizione di John
Fiske (cfr. tra gli altri 1989a, p. 7) – costituirono le espressioni principali della seconda
eredità.
È precisamente a quest’ultima direzione di filiazione e prima ancora al paradigma
culturalista originario dalla quale essa proviene che dobbiamo soprattutto guardare in
questa sede. Perché è certamente in questo ramo dell’albero genealogico dei Cultural
Studies, molto più che nella numerosa e variegata – e preponderante – famiglia
strutturalista, che sono stati compiuti gli sforzi maggiori e maggiormente originali per
l’elaborazione di una teoria della cultura popolare e dei suoi rapporti con la cultura
dominante. Le premesse generali di questa elaborazione, poste dai fondatori del
paradigma culturalista, sono state in primo luogo, ovviamente, la «democratizzazione»
del concetto di cultura in rottura con la tradizione umanistica – e in particolare con
quella inglese dei Matthew Arnold e dei Frank Leavis – che lo identificava con la
cultura alta. Quindi l’adesione ad una definizione ad un tempo antropologica e
fenomenologica di cultura come «un intero modo di vita, materiale, intellettuale e
spirituale» (Williams 1958, p. xvi; cfr. anche Williams 1961). E segnatamente come,
sempre nella definizione di Williams, sensuous human activity (cit. in Hall 1980, p. 61),
cioè insieme di pratiche attraverso le quali le persone esprimono la loro comprensione e
la loro esperienza del mondo (ciò che Williams definisce anche la loro structure of
feeling). In terzo luogo, una decisa enfasi posta sulla human agency rispetto ai
condizionamenti strutturali che la orientano. Una enfasi che, nel celebre incipit di The
Making of the English Working Class (1963), storia sociale della formazione politica e
culturale, o della presa di coscienza di classe, della classe operaia inglese nei
cinquant’anni a cavallo tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, Edward
Thompson descrive così: «Questo libro ha un titolo sgraziato, ma è un titolo adatto allo
scopo. Making, perché è uno studio di un processo attivo, che dipende dall’agency tanto
quanto dipende dalle condizioni strutturali. La working class non è sorta come il sole in
un momento stabilito. Era presente al suo stesso farsi» (Thompson 1963, p. 10).29
All’interno del paradigma culturalista dei Cultural Studies, queste linee di
indirizzo generali per l’analisi culturale hanno costituito in particolare le basi per
l’elaborazione di una prospettiva relativista di analisi della cultura popolare. In una
variante molto diversa, tuttavia, da quella socio-antropologia americana ricordata sopra.
22
Questa diversità ha a che fare in particolare con il modo in cui questi due differenti
«relativismi» concepiscono l’alterità simbolica della cultura popolare. Per la socioantropologia statunitense, lo abbiamo visto, essa è una proprietà essenziale e statica, una
cultura che è in realtà natura, e che in quanto tale nulla deve al rapporto che di volta in
volta intrattiene con altri universi simbolici. Per il paradigma culturalista dei Cultural
Studies, al contrario, l’alterità simbolica della cultura popolare è una proprietà
relazionale e dinamica, continuamente costruita e ricostruita in una sorta di incessante
processo di differenziazione attiva dalla cultura legittima:30
Il principio strutturante del «popolare» in questo senso sono le
tensioni e le opposizioni tra ciò che appartiene al dominio centrale
dell’élite o della cultura dominante, e la cultura della «periferia». È
questa opposizione che struttura costantemente il dominio della
cultura nel «popolare» e nel «non popolare». [...] Da un periodo
all’altro i contenuti di ciascuna categoria cambiano. [...] Il principio
strutturante non consiste nei contenuti di ciascuna categoria – che,
ripeto, si modificheranno da un periodo all’altro. Piuttosto, consiste
nelle forze e nelle relazioni che sostengono la distinzione, la
differenza. [...] Ciò che è essenziale alla definizione di cultura
popolare sono le relazioni che definiscono la «cultura popolare» in
una tensione continua (relazione, influenza e antagonismo) con la
cultura dominante.
(Hall, 1981 [2006], p. 483 e 484)
«La cultura popolare in questo uso», scrive John Storey,
non è la cultura imposta dei teorici della cultura di massa [mass
culture], né è una cultura del «popolo» che emerge dal basso e si
oppone spontaneamente [folk culture], è un terreno di scambio e
negoziazione tra le due; un terreno [...] segnato da resistenza e
incorporazione. [...] Il processo è storico (ciò che è etichettato come
cultura popolare un dato momento è etichettato come altro tipo di
cultura il momento dopo), ma è anche sincronico (l’alternarsi di
resistenza e incorporazione è presente in ogni momento storico).
(Storey 2006, p. 8)
È questa concezione relazionale e processuale della cultura dominata che è per
esempio alla base della nota distinzione di Raymond Williams tra la cultura dominante
(effective culture) da un lato e una cultura dominata che può essere alternativa o
oppositiva dall’altro, di tipo residuale ed emergente (cfr. tra gli altri Williams 1973). La
cultura alternativa, scrive Williams, è quella dei «significati e valori alternativi,
opinioni e attitudini alternative, persino conferimenti di senso al mondo alternativi, che
23
possono essere ospitati e tollerati all’interno di una particolare cultura dominante»
(Williams 1973, p. 10). «Ma la linea di confine tra alternativo e oppositivo è molto
sottile» (ivi, p. 11), egli aggiunge, perché
un significato o una pratica può essere tollerato come una deviazione,
e tuttavia essere visto ancora come semplicemente un altro particolare
modo di vivere. Ma non appena l’indispensabile area di dominio si
estende, gli stessi significati e le stesse pratiche possono essere visti
dalla cultura dominante non solo come manifestazioni di inosservanza
o disprezzo nei suoi riguardi, ma come manifestazioni di sfida.
(ibidem)
Se la cultura dominante è impegnata in un tentativo continuo di espansione e quindi
incorporazione delle forme culturali alternative, queste ultime a loro volta sono
continuamente emergenti, ovvero ne «vengono continuamente create» di nuove (ivi, p.
11).
Questa immagine del rapporto la tra la cultura legittima e la cultura popolare
come una incessante dialettica tra incorporazione e resistenza deve molto, come già
accennato, all’incontro tra il paradigma culturalista originario dei Cultural Studies e il
marxismo culturalista di Gramsci, e in particolare all’integrazione nel primo della teoria
gramsciana dell’egemonia. E segnatamente all’idea centrale di quest’ultima secondo la
quale la conservazione del dominio egemonico, ovvero «del consenso “spontaneo” dato
dalle grandi masse della popolazione all’indirizzo impresso alla vita sociale dal gruppo
fondamentale dominante» (Gramsci 1932 [2001], p. 1519), esiga un continuo lavoro di
mantenimento – un lavoro egemonico, appunto. Ovvero, il potere egemonico va
continuamente creato e ricreato. E ciò va fatto non estirpando la conflittualità sociale,
bensì tentando di incanalarla sistematicamente entro i confini simbolici del linguaggio
dell’egemonia: «il concetto di egemonia intende suggerire una società in cui il conflitto
è contenuto e convogliato in porti ideologicamente sicuri» e non «una società in cui il
conflitto sia stato rimosso» (Storey 2006, p. 64).31 Questo equivale a dire che il potere
egemonico va continuamente negoziato:
«il fatto dell’egemonia presuppone
indubbiamente che sia tenuto conto degli interessi e delle tendenze dei gruppi sui quali
l’egemonia verrà esercitata, che si formi un certo equilibrio di compromesso» (Gramsci
1932-1934 [2001], p. 1591). Anche se, aggiunge ancora Gramsci, «è anche indubbio
che» le concessioni fatte dal gruppo dominante al gruppo dominato «non possono
riguardare l’essenziale» (ibidem).
24
Se il concetto gramsciano di egemonia è in primo luogo uno strumento concepito
per l’analisi del lavoro egemonico svolto dalla classe dominante – e al di fuori della
prospettiva dei Cultural Studies è effettivamente utilizzato per lo più in questo senso –
la sua appropriazione da parte dei Cultural Studies ha portato con sé una sorta di cambio
d’uso che ne ha fatto lo strumento per eccellenza per pensare ed analizzare la cultura
popolare. Si è trattato tuttavia di un cambio d’uso, appunto, o di punto di osservazione,
e non tanto del significato del concetto, perché
se il concetto di egemonia si riferisce ai processi attraverso i quali la
classe dominante cerca di condurre negoziazioni con le culture delle
classi antagoniste su un terreno culturale e ideologico che gli fa
conquistare una posizione di potere, è altrettanto vero che [se si
guarda alle culture delle classi antagoniste] quella che in questo modo
viene resa possibile è una versione negoziata della cultura e
dell’ideologia dominante.
(Bennett 1986 [2006], p. 95)
Il concetto di egemonia permette cioè di pensare la cultura popolare né come folk
culture, la cultura «autentica» prodotta dal popolo, né come mass culture, la cultura
manipolativa prodotta per il popolo, ma come «un mix “negoziato” di ciò che è prodotto
dall’ “alto” e dal “basso”, [...] un equilibrio mutevole di forze tra resistenza e
incorporazione» (Storey 2006, p. 65). Nelle parole di Gramsci, come un sempre
precario equilibrio di compromesso.
In questa prospettiva, analizzare la cultura popolare significa allora in primo luogo
portare alla luce le strategie e le tattiche messe in pratica dai membri dei gruppi
subordinati nella loro «negoziazione» – o lotta, o «guerriglia» – quotidiana con la
cultura dominante e le sue tendenze all’incorporazione egemonica. Nel filone erede del
paradigma culturalista dei Cultural Studies, il terreno di questa negoziazione che ha di
fatto ricevuto l’attenzione quasi esclusiva dei ricercatori è stata la sfera del consumo dei
prodotti dell’industria di massa, e specialmente (anche se non solo) di quella culturale.
E la preoccupazione costante dei ricercatori nell’esplorazione delle pratiche e delle
rappresentazioni – degli usi, delle letture, delle interpretazioni, dei conferimenti di senso
– legate alla fruizione di questi prodotti è stata quella di mettere in evidenza che «le
persone fabbricano la cultura popolare a partire dal repertorio di beni messi a
disposizione dalle industrie culturali», ovvero «la cultura popolare è ciò che gli uomini
e le donne fabbricano a partire dal loro consumo attivo dei testi e delle pratiche delle
industrie culturali» (Storey 2006, p. 69 e 65). Mettere in evidenza, cioè, la natura attiva
25
e creativa dell’atto di consumo, la natura produttiva dell’uso. Dove per lo più «attivo»,
«creativo» e «produttivo» sta a significare intenzionalmente «non ortodosso» o
«deviante» rispetto alla modalità di consumo legittima o attesa inscritta nel prodotto
stesso. E dove questa sorta di insubordinazione attiva ma puramente simbolica – o
«semiotica», come è stata definita da Fiske (1989a, p. 7) – manifestata dai dominati nei
loro atti di consumo è interpretata come la forma di espressione privilegiata – o meglio
come l’unica forma di espressione – della loro resistenza alla condizione di
subordinazione sociale e strutturale in cui vivono.32
1.2.1.2 Le due facce dell’alterità: L’Altro resistente e lo Stesso rassegnato
Questi brevissimi cenni alle diverse versioni della prospettiva relativistica
avevano lo scopo di mostrare come nella storia dell’analisi sociologica delle culture di
ceto riflessioni apparentemente lontanissime sul rapporto tra l’universo simbolico
popolare e l’universo simbolico legittimo abbiano in realtà condiviso una stessa
concezione di fondo della cultura popolare. Ma quello che sopra ho definito il
polimorfismo del relativismo e del legittimismo nello studio della cultura popolare ha
dato luogo anche all’occorrenza contraria. Ha cioè fatto sì che riflessioni teoriche basate
su concezioni opposte della cultura popolare abbiano in certi casi generato immagini
molto simili, o proprio una stessa immagine, della modalità pratica di rapporto dei
membri dei ceti popolari con la cultura legittima.
Una immagine che i teorici relativisti descrivono in termini di rifiuto del contatto
culturale e i teorici legittimisti in termini di autoesclusione dal contatto stesso, ma che
in entrambi i casi si riferisce evidentemente allo stesso tipo di comportamento pratico
dei membri dei ceti popolari: l’evitamento dell’incontro (o, se si vuole,
l’«impermeabilità» rispetto ad esso) con l’universo simbolico legittimo. Nelle varie
teorie della cultura popolare questa immagine di evitamento è stata di volta in volta
proposta in relazione a sfere simboliche diverse quali i consumi (in particolare nei
Cultural Studies), le pratiche culturali (in particolare nella sociologia bourdieuiana), e
ancora una volta soprattutto il rapporto con il mondo dell’istruzione. Ed è stata
interpretata, nella prospettiva relativista, come la manifestazione di un rifiuto o di una
resistenza o di una contestazione prodotta semplicemente dall’adesione ad un ordine
simbolico e di legittimità alternativo e concorrente.
26
La spiegazione legittimista ha in qualche modo tentato di rendere l’interpretazione
relativista più complessa, aggiungendole un tassello ulteriore: l’idea che l’adesione dei
membri dei ceti popolari a un ordine simbolico alternativo a quello legittimo non fosse
in realtà un fatto «primo» ma fosse un fatto «derivato» che si potesse e si dovesse
spiegare sociologicamente. In altri termini, l’interpretazione sociologica non poteva
fermarsi alla constatazione della diversità ma doveva considerare proprio questa
diversità e le sue cause l’oggetto principale dell’analisi. Ecco allora che in quest’ottica
l’evitamento del contatto con la cultura legittima da parte dei membri dei ceti popolari
diventa non più una differenza «reale» in quanto espressione di una cultura autonoma
ma il prodotto di una imitazione impedita, e segnatamente di un adattamento, o meglio
ancora di una rassegnazione, alle limitazioni oggettive legate alle condizioni sociali di
esistenza. Diventa cioè l’esito di una interiorizzazione – più o meno irriflessiva o più o
meno conscia a seconda dei teorici e delle sfere di vita considerate – dei
condizionamenti legati alla posizione occupata nella struttura sociale.
E così, per fare riferimento al ritratto della cultura popolare che esce dalle analisi
di Bourdieu, nelle scelte di consumo dei ceti popolari, la valorizzazione della
funzionalità su ogni considerazione estetica formale e, nelle scelte alimentari, la
preferenza accordata ai cibi economici e nutrienti non sono semplici gusti propri di una
cultura popolare, come avrebbero sostenuto i teorici relativisti. In una prospettiva
legittimista, essi sono «gusti di necessità» che «esprimono, nel loro stesso adeguarsi, le
necessità delle quali sono il prodotto»: sono «amor fati, scelta del destino, ma una scelta
forzata, prodotta da condizioni di esistenza che, escludendo come puro sogno qualsiasi
altra possibilità, non lasciano altra scelta che il gusto del necessario» (Bourdieu 1979,
pp. 198 e 199). Allo stesso modo, le preferenze popolari per l’arte figurativa rispetto a
quella astratta documentate sempre da Bourdieu33 sono prodotto e funzione dell’assenza
di competenze artistiche indispensabili per decodificare e apprezzare l’arte astratta: sono
dunque «impedimenti diventati non-gusti o disgusti» (Grignon e Passeron 1989, p. 49).
Infine, last but not least, la scarsa propensione popolare a utilizzare il sistema di
istruzione. Per i teorici legittimisti, ha poca importanza il modo in cui gli attori si
rappresentano e dunque danno senso alle forme che in questa sfera di vita prende il loro
evitamento della cultura legittima, cioè ai loro abbandoni scolastici precoci e alle loro
scelte «modeste» di filiere scolastiche minori. In particolare, fa poca differenza se
questo mantenersi ai margini del sistema di istruzione sia vissuto con più o con meno
consapevolezza dei condizionamenti strutturali che pesano su di esso. Vale a dire se sia
27
percepito come una rinuncia forzata – per mancanza di denaro, capacità, sostegno
culturale familiare, o di tutte queste cose insieme – alle proprie «reali» aspirazioni, con
doloroso rimpianto o con la serena accettazione del proprio destino sociale del «fare gli
studi non è roba per gente come noi». O se, al contrario, la «scelta del destino» appaia
agli occhi di chi la compie proprio una scelta «vera», un libero atto di volontà scaturito
da quella predisposizione innata che quando si parla di istruzione si ha l’abitudine di
chiamare una vocazione – o, per i più fortunati, un dono, e per i più sfortunati un «non
esserci portato».
In una prospettiva legittimista, quella che passa tra queste due attribuzioni di
senso è solo una differenza di grado nella interiorizzazione dei condizionamenti
strutturali. Nel secondo caso questa interiorizzazione è penetrata tanto in profondità
nell’individuo da trasformare, per dirla con Lahire, le sue «competenze» in
«appetenze», la sua capacità di fare qualcosa nel suo desiderio di farla (e soprattutto la
sua incapacità di fare qualcos’altro in una provvidenziale assenza di desiderio di farlo),
e indebolire fino a far scomparire la riflessività nel suo rapporto con le proprie
disposizioni all’azione. Nel primo caso qualcosa nel meccanismo di interiorizzazione si
è inceppato34 e questa trasformazione del «posso» nel «voglio» non si è compiuta,
lasciando così l’attore nella dolorosa consapevolezza del «voglio ma non posso» e
privando di ogni «incanto» il suo rapporto con i propri condizionamenti sociali
interiorizzati.
Per l’attore, il suo benessere esistenziale e soprattutto, per dirla con Bernstein, la
sua possibilità di avere «accesso alle basi della propria socializzazione e [...] stabilire un
rapporto riflessivo con l’ordine sociale in cui è inserito» (Bernstein 1971, tr. it. p. 240),
cadere in una occorrenza o nell’altra fa evidentemente una certa differenza. Che poi
equivale proprio alla differenza che c’è tra lo stare bene con se stessi e l’avere
consapevolezza dei propri condizionamenti sociali, due disposizioni che purtroppo di
solito per questi attori si muovono in direzioni opposte. Per la teoria legittimista, invece,
ne fa poca, perché tanto il «voglio ciò che posso» quanto il «faccio ciò che posso anche
se non è ciò che voglio» sono in questa prospettiva due varianti dello stesso
meccanismo di adattamento ovvero rassegnazione alle possibilità oggettive inscritte
nella propria condizione sociale. Rassegnazione che soprattutto nel caso del rapporto di
evitamento con il sistema di istruzione conduce in particolare i membri dei ceti popolari
ad anticipare le scarse probabilità di accedere ai gradi più alti di istruzione che sono
associate alla loro posizione sociale autoescludendosi dal sistema di istruzione prima
28
ancora sia il sistema stesso ad escluderli (un meccanismo che nella sociologia
bourdieuiana ha preso il nome di causalità del probabile: cfr. sotto il paragrafo 2.2.3.1).
1.3 Alla ricerca della «terza via»: Alternanza e ambivalenza
Causalità del probabile o resistenza, rassegnazione o contestazione, differenza
reale o rinuncia e adattamento? «Come interpretare» infine l’evitamento popolare della
cultura legittima,
queste non-pratiche che, a seconda del punto di vista che si adotta
possono essere considerate sia come delle esclusioni, sia, al contrario,
come dei rifiuti (e senza dubbio non soltanto, o non sempre, come dei
rifiuti obbligati, o delle esclusioni interiorizzate, proibizioni divenute
non-gusti o disgusti)?
(Grignon e Passeron 1989, p. 49)
E, prima ancora di chiedersi quale di questi due sensi di lettura descriva meglio la logica
dell’azione dei membri dei ceti popolari nel loro rapporto con la cultura legittima, più
fondamentalmente, è davvero euristicamente utile descrivere questo rapporto con il
linguaggio dell’evitamento, come entrambe le interpretazioni concordano nel fare, pur
spiegando poi l’evitamento in modi diversi? Detto in altri termini, a me pare che la
cassetta degli attrezzi interpretativi messa a disposizione dall’insieme delle due
prospettive classiche di analisi della cultura popolare adottate nella sociologia culturale,
nelle loro diverse varianti che qui ho rapidamente evocato, si riveli poco utile allo studio
della logica dell’agire dei ceti popolari. La ragione più immediata è l’insensibilità di
questi strumenti interpretativi alle variazioni delle condizioni empiriche che dovrebbero
aiutare a leggere. O meglio, la vaghezza delle indicazioni sugli indizi e sulle piste da
seguire nell’esplorazione di queste condizioni. Lo abbiamo visto. Abbiamo visto che
una stessa pratica come l’evitamento dell’universo simbolico legittimo da parte dei
membri dei ceti popolare può essere utilizzata come evidenza di concezioni opposte
della cultura popolare. Abbiamo visto anche che per il legittimismo fa poca differenza il
modo in cui l’attore dà senso al suo agire non ortodosso rispetto alla cultura dominante,
perché la «verità» di tale agire è comunque che esso scaturisce dalla condivisione da
parte del soggetto popolare dello stesso ordine di legittimità della cultura dominante. In
entrambi i casi, tuttavia, non ci è dato sapere quali siano – e prima ancora se esistano –
gli indizi empirici che escludono una interpretazione a favore dell’altra.
29
E questo non accade per la ragione essenziale che i due concetti fondamentali di
cultura popolare con cui abbiamo a che fare sono delle prese di posizione teoriche molto
più che delle prospettive analitiche elaborate come generalizzazioni empiriche a partire
da un confronto con gli interrogativi e i problemi posti dalla ricerca sul terreno. Ciò
spiega anche la predilezione condivisa da entrambe le posizioni per l’immagine
dell’evitamento nella descrizione della logica dell’agire dei membri dei ceti popolari nel
loro rapporto con la cultura legittima. Una immagine che è a sua volta molto più un
corollario funzionale delle due concezioni della cultura popolare di quanto sia
l’evidenza empirica a partire da un confronto con la quale le due concezioni hanno
preso forma (per una riflessione analoga sull’immagine di lontananza mentale e pratica
delle famiglie popolari dall’universo dell’istruzione che domina gran parte della ricerca
educativa classica, cfr. sotto il paragrafo 2.1.2).
Si potrebbe certamente obiettare che non ci sia nulla di male nel fatto che una
posizione teorica sia stata elaborata lontano da un confronto con la realtà empirica – che
anzi per certi versi questa lontananza sia inevitabile – a patto che l’insieme di concetti di
questa teoria si riveli comunque euristicamente utile nella lettura di tale realtà. Come ho
già sostenuto nelle pagine precedenti, a me pare che le teorie socio-antropologiche della
cultura popolare non soddisfino questo secondo requisito, ed abbiano anzi storicamente
costituito un ostacolo importante sulla strada della comprensione del modo di vita,
dell’universo simbolico e delle logiche di azione dei ceti popolari. Comprensione che è
infatti ancora in larga misura ferma all’alternanza tra i due poli del quadro interpretativo
fornito dal relativismo e dal legittimismo, senza che peraltro la prova del confronto con
la realtà empirica si sia mai rivelata risolutiva nel far emergere in un modo che fosse
inequivocabile la superiorità di una delle due prospettive sull’altra, o la maggiore
plausibilità di una lettura sull’altra.
Ma allora, se nell’analisi empirica queste due concezioni della cultura popolare si
comportano ugualmente bene – o male, a seconda dei punti di vista – pare lecito
ipotizzare che ciò accada perché la questione posta in questi termini è in realtà
empiricamente indecidibile. E se la realtà empirica non è in grado di fornire una risposta
al tipo di domande che le si sta rivolgendo, l’unico modo per interrogarla
produttivamente pare quello di abbandonare le vecchie domande e provare a riformulare
i nostri interrogativi, sperando che questa volta l’interlocutore si dimostri maggiormente
reattivo e informativo. Fuor di metafora, «non si incontrano [...] delle pratiche, dei
discorsi, dei simbolismi popolari che si lasciano costruire indifferentemente, negli
30
enunciati descrittivi, come fatti di autonomia e fatti di eteronomia?» (Grignon e
Passeron 1989, p. 71). E allora non può essere che ciò accada perché tali simbolismi
sono in realtà e soprattutto nello stesso tempo fatti di autonomia e fatti di eteronomia?
Nel senso non tanto che nella cultura popolare simbolismo autonomo e simbolismo
eteronomo convivono fianco a fianco in alternanza, vale a dire dividendosi i domini e i
momenti della pratica (per esempio, con l’universo delle pratiche educative eteronomo e
l’universo delle pratiche culturali autonomo), i contesti di interazione, o anche i
sottogruppi interni al ceto (ivi, capitolo II). Ma nel senso, più forte, che autonomia ed
eteronomia convivono in ogni elemento simbolico della cultura popolare, rendendolo,
nella definizione di Grigon e Passeron, ambivalente:
La difficoltà propria di una sociologia del simbolismo dominato è che
i tratti e i comportamenti dominati non sono mai puramente autonomi
o puramente reattivi. Il concetto di ambivalenza ricorda che è raro un
tratto culturale dica tutto ciò che ha da dire in una delle due griglie
concettuali di descrizione.
(ivi, p. 93)
Fino all’enunciazione, contro la parzialità della tesi relativista e della tesi
legittimista, dell’«ipotesi di ambivalenza di ogni simbolismo e di ogni pratica di classe
dominata» (ivi, p. 71), l’argomento di Grignon e Passeron appare dunque pienamente
condivisibile. A questa pars destruens del ragionamento non corrisponde tuttavia una
successiva pars construens che sfrutti fino in fondo le potenzialità dell’intuizione
iniziale, e dunque costruisca una prospettiva di analisi della cultura popolare che sia
realmente percorribile e alternativa a quelle scartate. La costruzione compiuta di un
simile strumento analitico non rientra del resto nemmeno tra gli obiettivi dichiarati della
riflessione di Grignon e Passeron, la quale anzi si apre proprio con il caveat che
«l’esame dei lavori e dei concetti che costituisce l’oggetto di questo dibattito non mira a
proporre una teoria delle culture popolari e nemmeno a prescrivere una metodologia»,
ma solo a «esplicitare un imbarazzo che abbiamo avvertito, tanto nelle nostra inchieste
quanto nelle nostre letture, ogni volta che il Popolo appare nella letteratura» (ivi, p. 9).
È dunque a questo punto che occorre staccarsi anche da Grignon e Passeron lasciandoli
dove si sono volutamente arrestati e tentare di avventurarsi ancora oltre
nell’esplorazione della direzione indicata. Per trasformarla in un sentiero effettivamente
percorribile.
31
Perché sul modo per rendere operatoria l’ipotesi di ambivalenza del simbolismo
dominato il solo suggerimento che ci arriva dai due sociologi è quello di restare sulle
strade del relativismo e del legittimismo e cercare di percorrerle entrambe in parallelo.
Considerando cioè «ogni “tratto” popolare un palindromo a doppio senso» (ivi, p. 73) e
in quanto tale bisognoso di due direzioni di lettura: una lettura che sia attenta al senso
che tale tratto ricava dal suo rapporto con gli altri elementi interni dell’universo
simbolico popolare35 e nello stesso tempo al senso che gli deriva invece dal suo rapporto
con il tratto corrispondente dell’universo simbolico dominante. Nelle parole di Grigon e
Passeron:
L’ipotesi dell’ambivalenza significante delle realtà simboliche obbliga
[...] ad ammettere pienamente nell’analisi e nell’interpretazione i
diritti della doppia lettura. [...] Del resto non è sufficiente distinguere,
per racchiudere in universi di senso senza comunicazione, i due
significati di uno stesso comportamento che costruiscono l’analisi
culturalista [cioè, la prospettiva relativista] e l’analisi ideologica [cioè,
la prospettiva legittimista] dell’ordine simbolico. Bisogna anche
servirsi delle due descrizioni per descrivere i rapporti sociali e
simbolici attraverso i quali ciascuno dei due significati capovolge
l’altro, derivando la propria efficacia proprio da questo
capovolgimento.
(ibidem)
Ciò che Grignon e Passeron fanno non è dunque molto più che mettere in guardia
il ricercatore con una serie di considerazioni sulle quali solo gli oltranzisti del
relativismo e del legittimismo avrebbero da ridire, e in particolare ammonirlo sulla
necessità che tutte queste considerazioni insieme dovrebbero essere tenute in conto da
qualsiasi analisi della cultura popolare. In primo luogo, a fini analitici la cultura
popolare va intesa, weberianamente e con una operazione di «autonomizzazione
metodologica» (ivi, p. 21), come il risultato dell’attività di produzione simbolica
stimolata dal bisogno di senso di un certo gruppo sociale. Essa tuttavia non esiste nel
vuoto ma insieme alle culture di altri gruppi sociali. I suoi confini non sono
impermeabili. Infine, i flussi simbolici (o, in un linguaggio meno postmoderno, gli
scambi) che attraversano questi confini non impermeabili sono regolati da un rapporto
di forza tra l’interno e l’esterno che non è favorevole ai portatori della cultura popolare.
Sul come questa specie di collazione tra lettura dell’autonomia e lettura dell’eteronomia
possa essere realizzata non solo nella pratica della ricerca ma prima ancora
epistemologicamente – cioè nella sintesi di una nuova concezione della logica dell’agire
32
popolare – essi lasciano il ricercatore con nessuna indicazione metodologica e con un
concetto interessante ma troppo poco definito e per nulla operatorio di ambivalenza.
Un concetto, meglio, che i due autori pensano più nella sua accezione
psicoanalitica o comunque riferito a qualcosa di simile alla falsa coscienza marxiana
che in termini che siano utilizzabili proficuamente in una analisi sociologica
culturalista. Consapevoli essi stessi della scarsa fruibilità sociologica dell’idea di
ambivalenza simbolica della cultura popolare che hanno in mente, Grignon e Passeron
non sono tuttavia per questo indotti ad elaborare ulteriormente il concetto per farne uno
strumento utile per la ricerca sociale. Piuttosto, essi sono indotti a concludere
pessimisticamente che con gli strumenti dell’analisi sociologica la coesistenza di
autonomia ed eteronomia nell’universo simbolico popolare non potrà mai essere colta
nella sua dimensione forte dell’ambivalenza interna ad ogni elemento. Essa potrà essere
colta unicamente nella sua dimensione debole dell’alternanza tra elementi o tratti
culturali autonomi ed eteronomi a seconda dei domini, dei momenti o degli attori della
pratica. Potrà essere cioè colta in una analisi della cultura popolare che sia, per dirla con
il linguaggio della ricerca sociale, una analisi delle condizioni empiriche dell’autonomia
o dell’eteronomia della logica dell’agire popolare rispetto all’universo simbolico
dominante. Scrivono Grignon e Passeron:
Nella misura in cui [l’analisi sociologica] si aggrappa alla prospettiva
alternativista, la quale, delimitando per essa un terreno specifico, le
apre una carriera empirica e le permette di far intervenire appieno le
tecniche dell’accertamento e della misurazione, la sociologia delle
culture popolari guarda decisamente dal lato di una scienza definita in
relazione al modello delle scienze sperimentali. Nella misura in cui
essa sceglie al contrario l’ambivalenza, [...] come si fa a sapere se ciò
che si crede di rilevare abiti realmente «l’inconscio» del gusto
popolare, se i significati ai quali conduce l’analisi non sono al
contrario degli artefatti puri e semplici, il prodotto di una messa a
confronto forzata e ossessiva delle culture, o la proiezione di fantasmi
dell’interprete? Come sapere se il «contenuto latente» che ci si dà in
questo modo la possibilità di svelare è proprio la traduzione integrale,
veritiera e adeguata dei gusti e dei desideri racchiusi nelle pratiche e
nei discorsi «manifesti» dei dominati?
(Grignon e Passeron 1989, pp. 112-113)
Conoscere, attraverso la prospettiva dell’alternanza, quali sono le sfere della vita
dei ceti popolari che sono maggiormente al riparo da influenze simboliche eteronome e
quali sono in particolare le condizioni che le preservano meglio, o, al contrario, quelle
che le espongono maggiormente a queste influenze offre certamente un punto di vista
33
importante sui rapporti tra la cultura popolare e la cultura legittima. Ma un punto di
vista altrettanto prezioso è quello, preso da un’altra angolatura, che può offrire la
conoscenza di ciò che accade quando una particolare sfera di pratiche della cultura
popolare è investita da un «attacco» più o meno ufficiale – anziché, per usare il
linguaggio delle teorie della resistenza culturale, da una «guerriglia» diffusa e mai
dichiarata apertamente – da parte della cultura dominante. Ovvero nei casi in cui il
contatto culturale è obbligato e la penetrazione di elementi simbolici eteronomi
nell’universo simbolico popolare avviene più o meno d’imperio. Qui l’interrogativo di
ricerca diventa, in termini banali, in che modo i tratti simbolici legittimi invasori che
hanno sferrato l’attacco al confine tra le culture siano stati accolti nella porzione di
territorio invaso, vale a dire nel particolare dominio di pratiche e di rappresentazioni
popolari in cui sono penetrati con la forza. In questo caso, non si tratta più, come sopra,
di procedere a un censimento dei tratti culturali della cultura popolare distinguendo tra
quelli «contaminati» e quelli «puri»: si tratta invece di concentrare l’attenzione sui tratti
che si sanno già essere stati molto probabilmente «contaminati» d’imperio e studiare,
per usare una metafora organica à la Durkheim, la natura e il grado della loro
«intossicazione» e il modo i loro organismi «reagiscono» ad essa.
È evidente che in questo caso la prospettiva di analisi elettiva diventa allora quella
della coesistenza di autonomia ed eteronomia nello stesso elemento simbolico o tratto
culturale, prospettiva che con Grignon e Passeron ho definito sopra dell’ambivalenza.
Perché sia euristicamente utile ed effettivamente fruibile nell’analisi culturale, tuttavia,
questo concetto di ambivalenza simbolica va a mio avviso qui inteso primariamente in
una accezione derivata dai principi dell’analisi culturale strutturalistica. Come cioè
quell’«indeterminatezza» (Bourdieu 1977, p. 140) di significato, o polisemia, che è
propria di ogni elemento simbolico e fa sì in particolare che esso assuma significati
diversi a seconda del sistema simbolico nel quale è inserito, ovvero a seconda della
particolare configurazione di tratti culturali con la quale si trova di volta in volta a fare
senso e sistema, appunto (cfr. su questo Giglioli e Ravaioli 2004).
Che a fini analitici l’ambivalenza simbolica della cultura popolare vada intesa in
questo senso strutturalistico di base non significa che essa non possa essere studiata, per
usare le dicotomie sociologiche classiche, in una prospettiva soggettivistica e
fenomenologica, attenta cioè al senso che gli attori conferiscono alle proprie azioni.
Significa piuttosto che i cambiamenti di significato e di uso che i tratti culturali
dominanti subiscono una volta penetrati all’interno della cultura popolare non debbano
34
essere interpretati per forza con il linguaggio del volontarismo, della creatività, e, al
limite dell’insubordinazione attiva e della «resistenza» simbolica popolare. Significa, in
altri termini, che la dimensione «eretica» delle interpretazioni popolari della cultura
legittima costituisce un aspetto costitutivo e sempre presente di tali conferimenti di
senso pur non essendo nello stesso tempo necessariamente l’espressione di una azione
sacrilega intenzionale. Ma, essendo, il più delle volte, niente altro che la conseguenza
necessaria del «trasferimento» e del successivo inevitabile «riadattamento» nel senso
della coerenza di un tratto culturale da un universo simbolico a un altro. 36
La specificazione e operazionalizzazione in senso strutturalistico che ho proposto
del concetto di ambivalenza simbolica della cultura popolare non è evidentemente la
chiave di volta per superare la parzialità dei punti di vista relativista e legittimista nella
sintesi di una nuova prospettiva di analisi dell’universo simbolico popolare. E non lo è
perché si tratta di uno strumento analitico adatto all’esplorazione di un aspetto
particolare di tale universo – i suoi terreni di incontro più o meno «ufficiale» e
documentato con la cultura dominante – e non della cultura popolare tout court. Si tratta
quindi di una «soluzione» molto parziale al problema della operazionalizzazione
sociologica dell’ipotesi di ambivalenza della cultura popolare proposta da Grignon e
Passeron, che non ne esaurisce in alcun modo la portata. Quest’ultima doveva infatti
costituire la base per una sintesi analitica tra la prospettiva relativista e la prospettiva
legittimista che aiutasse a fornire una risposta finalmente plausibile all’annoso problema
del grado di autonomia o eteronomia simbolica dell’universo simbolico popolare. La
mia «terza via» allo studio della cultura popolare aggira invece del tutto questo
problema concentrando deliberatamente l’attenzione sulle sole parti sicuramente
«eteronome» di questo sistema e quindi sui soli casi documentati di incontro tra la
cultura popolare e la cultura dominante. La strada che ho scelto per il superamento dei
due quadri interpretativi classici della cultura popolare non è cioè tanto quella di un
tentativo di sintesi quanto quella di un cambio radicale di prospettiva. Una scorciatoia,
quindi, certamente. Ma anche un modo finalmente praticabile per uscire da un cul-desac teorico e cominciare a guardare almeno una parte della cultura popolare con degli
occhiali interpretativi che lascino filtrare un po’ della sua realtà empirica.
Prima di provare a indossare, nel resto di questo lavoro, questi occhiali, ci
soffermeremo ancora un po’ sulle prospettive socio-antropologiche classiche di analisi
della cultura popolare. Nel capitolo successivo cominceremo infatti ad avvicinarci
all’oggetto empirico specifico di questo lavoro analizzando le forme nelle quali queste
35
concezioni tradizionali della cultura popolare hanno trovato posto nelle analisi
culturaliste classiche delle disuguaglianze educative. Per vedere come questo posto lo
abbiano infine perso negli sviluppi più interessanti della sociologia dell’educazione
degli ultimi anni. Nella quale, va aggiunto in conclusione, una «terza via» per pensare –
e soprattutto per analizzare empiricamente – la cultura popolare appare oggi molto più
al centro degli interessi e soprattutto alla portata di mano dei ricercatori che in ogni altro
campo dell’analisi sociologica culturale contemporanea.
36
NOTE AL CAPITOLO PRIMO
1
Cultura che è intesa quindi, weberianamente, come quella «sezione finita dall’infinità priva di senso del
divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell’uomo» (Weber 1904
[1922], tr. it. p. 96).
2
Ma anche rappresentazioni, idee, credenze, concezioni: per una rassegna delle definizioni più o meno
intercambiabili che sono state utilizzate negli studi di psicologia dello sviluppo intercultuale, cfr.
utilmente Bril 1999. Le pubblicazioni a cura dei membri dell’Association pour la recherche
interculturelle (ARIC) che ha sede all’Università di Friburgo (tra le quali Bril, Dasen, Sabatier e Krewer
(eds.) 1999) offrono un utile osservatorio su questo recente settore di ricerca. Sul quale, per l’area
anglofona, cfr. anche Sigel (ed.) 1985; Harkness e Super (eds.) 1996.
3
L’ambito dell’allevamento (la puericultura) e dell’educazione familiare dei bambini è stato infatti
storicamente uno dei terreni privilegiati nei tentativi di «moralizzazione» del popolo, e in questo senso
costituisce «un oggetto privilegiato per chi voglia cogliere i caratteri specifici della diffusione delle
tecniche e dei saperi all’interno di una società stratificata» (Boltanski 1969, p. 15).
4
Con riferimento alla tradizione di analisi sociologica del sapere, mi pare possa essere forse utile pensare
la differenza tra il senso contingente e il senso finale dell’esperienza della scolarizzazione nei termini
della differenza tra gli oggetti di analisi privilegiati dai due principali filoni di questa tradizione, la
sociologia della conoscenza francese (per il senso contingente) e quella tedesca (per il senso finale). La
prima rappresentata dalla Scuola sociologica francese e dai suoi eredi (quindi Émile Durkheim, Marcel
Mauss, Robert Hertz, Marcel Granet, e poi Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Mary Douglas), la
seconda dalla corrente storicistica tedesca (quindi Karl Marx, Max Scheler, Karl Mannheim, Max
Weber). Come suggerisce Robert Merton (1972), la differenza principale tra i due approcci è bene
espressa dalle espressioni che nelle due tradizioni vengono usate per indicare la sociologia della
conoscenza: in tedesco Wissensoziologie, in francese Sociologie de la connaisance. Il verbo wissen non è
l’equivalente di connaître, ma di savoir: mentre connaître implica «la diretta familiarità con i fenomeni
che è espressa nelle rappresentazioni descrittive», wissen e savoir implicano «formulazioni più astratte
che non “assomigliano” tutte a ciò che è stato sperimentato direttamente. Quindi la sociologia della
conoscenza tedesca è la sociologia delle «formulazioni astratte», quella francese è la sociologia delle
«rappresentazioni descrittive». In altri termini, l’approccio tedesco studia la conoscenza nella forma di
sistemi complessi di idee quali teorie della storia, filosofie, dottrine politiche, ideologie. L’approccio
francese studia invece la conoscenza nella forma delle unità fondamentali delle quali sono formate le
unità complesse studiate dalla sociologia tedesca, vale a dire le categorie del pensiero e i sistemi di
classificazione. In altri termini, il polo tedesco è più vicino alla conoscenza scientifica o almeno
formalizzata, quello francese alla conoscenza ordinaria. Una delle ragioni di questa differenziazione
dell’oggetto di studio risiede, come è noto, nelle differenti radici filosofiche in contrapposizione alle quali
le due sociologie della conoscenza sorgono: quella tedesca nasce, con Marx, come una reazione
all’idealismo di Hegel (autonomia dell’Idea da ogni esperienza sociale vs. ogni sistema di pensiero è
legato a una esperienza sociale concreta); quella francese nasce come una reazione a Kant (origine innata
delle categorie fondamentali del pensiero vs. le categorie fondamentali della conoscenza sono correlate
alle divisioni della società).
5
Che è esattamente anche il modo in cui, prima di misurarmi con la ricerca empirica, io stessa ho iniziato
il mio «mestiere di sociologa». Vale a dire approfittando della riluttanza di un «grande», nel mio caso
Pierre Bourdieu, a indulgere nell’autobiografismo intellettuale, per produrre una «lettura» dell’evoluzione
della sua teoria sociale (Ravaioli 2002).
6
Quando parlo di «sociologia culturale in senso proprio» mi riferisco in particolare a quella che,
soprattutto sulla scorta delle teorizzazioni di Jeffrey Alexander, è diventanta oggi una delle suddivisioni
più accettate del campo di studio sociologico della cultura. Vale a dire la distinzione tra un filone di
sociologia della cultura e un filone di sociologia culturale. L’oggetto di studio del primo sono quelle
istituzioni alle quali all’interno della società è specificamente ed espressamente riservato il compito della
produzione simbolica (la religione, il diritto, la sfera dell’arte, dell’industria culturale di massa, dei mass
media, della scienza, ecc.). Laddove il secondo, in una concezione assai più generale, o «forte»,
dell’oggetto, si occupa dei processi di costruzione e di uso di significati condivisi (che approcci teorici
diversi hanno di volta in volta identificato nelle strutture e categorie fondamentali del pensiero, in valori e
37
norme, in sistemi complessi di idee quali le ideologie, o in una intera Weltanschauung) che hanno luogo
all’interno di una struttura di relazioni sociali e possono manifestarsi – e quindi essere studiati – in
qualsiasi tipo di «fatto sociale» (quali pratiche, eventi, istituzioni, artefatti). In altri termini, l’oggetto
della sociologia culturale non è limitato alla cultura intesa come l’insieme dei prodotti delle sfere
istituzionali specificamente riservate alla produzione simbolica ma comprende l’intera dimensione
simbolica della vita sociale. La presente ricerca rientra evidentemente in questo secondo approccio allo
studio sociologico della cultura.
7
Limitandosi alle monografie sull’intero modo di vita dei ceti popolari, tracce di questo approccio si
trovano fin quasi dalla preistoria delle scienze sociali, con Les ouvriers européens. Études sur les travaux,
la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de l’Europe (1855) di Frédéric Le
Play a fare da ideale capostipite. Nella scuola durkheimiana, nel 1913 Maurice Halbwachs dedica agli stili
di consumo delle famiglie operaie la sua tesi di abilitazione dal titolo La classe ouvrière et les niveaux de
vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines. Degli anni
Cinquanta del Novecento è la pubblicazione quasi contemporanea in Francia e in Inghilterra di altri tre
classici di questo filone: Family and Kinship in East London (1954) di Michael Young e Peter Willmott,
La vie quotidienne des familles ouvrières (1956) di Paul-Henry Chombart de Lauwe, e The Uses of
Literacy. Aspects of Working-Class life (1957) di Richard Hoggart. Gli anni Sessanta vedono il fiorire di
questo genere di letteratura, con la pubblicazione delle ricerche dell’antropologo statunitense Oscar Lewis
sul modo di vita e la cultura del sottoproletariato centroamericano, oltre che, tra gli altri, di WorkingClass Suburb: A study of Auto Workers in Suburbia (1960) di Bennett Berger negli Stati Uniti, e di
Working-Class Community (1968) di Brian Jackson in Inghilterra. Degli anni Settanta si può ricordare la
pubblicazione di The World of the Urban Working Class (1973) di Marc Fried, e del decennio successivo
quella di Le travail à-côté. Etude d’ethnographie ouvrière (1989) di Florence Weber. Del 1990 è
l’etnografia ormai classica del francese Olivier Schwartz su Le monde privé des ouvriers, e del 1999
un’altra etnografia francese, Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de SochauxMotbéliard di Stéphane Beaud e Michel Pialoux. Infine, è del decennio successivo A Phenomenology of
Working Class Experience (2000) di Simon Charlesworth. Per una storia delle monografie inglesi sulla
working class, si può vedere utilmente Johnson 1979 pp. 41-71.
8
La strada delle comparazioni interculturali su aspetti specifici dello stile di vita è stata
complessivamente meno battuta, o almeno i contributi sono più frammentati e quelli di rilievo sono
identificabili con maggiore difficoltà. La cura e l’educazione familiare dei bambini seguita dai consumi
culturali appaiono comunque le due sfere di vita sulle quali si è più concentrata l’attenzione dei
ricercatori.
9
In realtà questa possibilità non sembra essere stata finora presa seriamente nel campo degli studi sulle
culture di ceto, dove moltissimi aspetti anche rilevanti dell’esistenza restano quasi o del tutto inesplorati.
Si pensi per esempio all’ambito di ricerca del rapporto tra appartenenza di ceto e esperienza della salute e
della malattia, un tema che sembra essere quasi completamente lasciato all’interesse e ai metodi degli
studiosi di epidemiologia (mentre per esempio è da tempo esplorato nell’ambito delle analisi
multiculturali «classiche» dal filone dell’etnoscienza dell’antropologia culturale). Una felice eccezione
alla tendenza a concentrare tradizionalmente gli studi sulle culture di ceto solo su pochi aspetti
dell’esistenza è per esempio una ricerca recente che Nadine Halitim ha condotto in un quartiere popolare
di Lyon sui modi di appropriazione dello spazio attraverso le decorazioni domestiche (La vie des objets.
Décor domestique et vie quotidienne dans des familles populaires d’un quartier de Lyon, la Duchère,
1986-1993, 1996).
10
È per esempio l’accomodamento di questa madre che, in disaccordo con i principi della disciplina
scolastica (e, prima ancora, con la concezione di bambino sulla quale essa poggia), racconta così una
punizione che suo figlio ha portato a casa dalla scuola:
Dunque, la... fine dell’anno... scolastico appena passato [in terza elementare],
ha dovuto scrivere mille volte una frase.
Mille volte?!
Mille volte.
A casa o a scuola?
A casa. A casa... saltando la ricreazione a scuola... mille volte.
Con voi lo ha scritto? E come è andata?
38
Funzionava che lui era in camera, e noi «Scrivi! Avanti! Scrivi!», e lui
numerava, tutto, ogni riga, e poi partiva e scriveva tutto.
Ma ogni tanto diceva «mi sono stufato»?
Sì, ma doveva andare avanti.
Eh, ma appunto, lui diceva «mi sono stufato»?
Euh! Eccome!
E voi cosa dicevate?
«No, devi andare avanti». Anche perché la maestra ha detto... «datemi
fiducia»... [sottovoce] Non è servito a niente. Noi glielo abbiam fatto fare
anche perché la maestra è molto permalosa: se non glielo fai fare... Bisogna
andar con le pinze. Con certe maestre bisogna stare... Gli ho detto «Se lei te
le ha date, è perché era stanca, l’hai combinata grossa... »
(la madre di Tony, caso 17)
11
Una delle formulazioni più chiare della necessità di tenere distinte queste tre dimensioni nelle analisi
culturali è quella offerta da Ann Swidler (1986). Swidler utilizza l’esempio dell’analisi culturalista delle
cause della riproduzione della povertà. Come per i teorici della cultura della povertà, anche per Swidler le
cause della riproduzione della povertà sono di natura culturale più che meramente strutturale. Tuttavia, a
differenza di questi ultimi, ella ritiene che, nell’analizzare l’influenza della cultura sull’azione, si debba
distinguere nettamente la nozione di preferenze, aspirazioni, valori da quella di abilità e competenze, e
cercare l’influenza della cultura esclusivamente dal lato di queste ultime. In altri termini, per Swidler,
nelle loro aspirazioni, i poveri condividono l’idea dominante dell’ascesa sociale e dei mezzi più adatti per
raggiungerla, ma non intraprendono condotte di azione che sono in accordo con questi valori perché non
hanno le necessarie competenze culturali. Le condotte di azione dei poveri che contribuiscono alla
riproduzione del loro stato di povertà possono quindi essere definite come una forma di adattamento alle
competenza culturali che essi traggono dalle loro condizioni di esistenza, che nulla a che fare con il
desiderio che essi hanno ad agire in questo modo.
12
È così, per esempio, che nel suo celebre saggio del 1958 sul rapporto tra classe sociale e modi di
socializzazione familiare Urie Bronfenbrenner spiegava le differenze rilevate tra gli stili educativi della
prima infanzia delle famiglie di ceto medio e di ceto popolare, e loro evoluzioni nel tempo (sul quale cfr.
più diffusamente sotto il paragrafo 2.2.1). L’obiettivo del saggio era quello di fare il punto sui risultati
delle ricerche sull’educazione familiare condotte negli Stati Uniti nei tre decenni precedenti. Queste
ricerche avevano infatti prodotto una serie di risultati apparentemente contradditori la cui interpretazione
era per questo oggetto di un vivace dibattito tra gli studiosi. In particolare, le ricerche condotte fino a tutto
il periodo della Seconda Guerra Mondiale (la più nota delle quali è l’«inchiesta di Chicago» di Davis e
Havighurst del 1943) tendevano ad evidenziare una maggiore severità dello stile educativo del ceto medio
rispetto a quello più del ceto popolare, mentre le ricerche condotte successivamente (la più nota delle
quali è l’«inchiesta di Boston» di Maccoby e Gibbs del 1951-52) tendevano a ribaltare questa
conclusione. Bronfenbrenner rende conto di questa contraddizione spiegandola con l’evoluzione dei
saperi e delle norme mediche in materia di puericultura, e quindi anche di pratiche educative, e soprattutto
ipotizzando che questi nuovi saperi si fossero diffusi nelle diverse classi con una rapidità ineguale (su
questo punto, cfr. anche Boltanski 1969). I genitori di classe media avrebbero cioè adottato per primi le
nuove tecniche legittime, più permissive, laddove nello stesso tempo i genitori dei ceti popolari,
condividendo gli stessi valori educativi della classe media e proprio allo scopo di realizzarli, avrebbero
avuto la tendenza ad adottare pratiche educative diffuse nella classe media nel periodo precedente. Scrive
di questi ultimi Bronfenbrenner: «essi accettano i livelli di aspirazioni della classe media, ma non hanno
ancora interiorizzato sufficientemente i meccanismi di riposta che rendono realizzabili questi livelli per
loro e per i loro figli» (Bronfenbrenner 1958, tr. it. p. 46).
13
Come accade nei fenomeni di localismo, o di vera e propria «invenzione della tradizione», indotti dalla
globalizzazione culturale.
14
Le considerazioni che seguono sulle due concezioni classiche della cultura popolare sono debitrici a
quello che costituisce tuttora uno dei principali testi di riferimento teorico in questo ambito (e molto
probabilmente anche uno dei pochissimi libri interamente dedicati all’argomento): Le Savant et le
populaire di Claude Grignon e Jean-Claude Passeron (1989).
15
Nella storia della sociologia dell’educazione, una delle riflessioni più elaborate sul tema del rapporto
tra i contenuti e le forme dell’insegnamento scolastico e la cultura di origine dei fruitori popolari della
39
scuola è certamente quella sviluppata nella cosiddetta branca della sociologia del curriculum nell’ambito
del primo periodo della New Sociology of Education inglese (dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli
anni Settanta) (cfr. per tutti Young (ed.) 1971). Negli sviluppi subiti dalla New Sociology of Education nel
corso degli anni Ottanta, il posto occupato dalla sociologia del curriculum è diventato progressivamente
minoritario (cfr. Forquin 1983 e Trottier 1987). E l’interesse per il rapporto tra i contenuti e le forme
dell’insegnamento scolastico e le disuguaglianza scolastiche e sociali ha lasciato in gran parte l’ambito
sociologico per continuare a esistere, come già prima della parentesi della New Sociology of Education,
soprattutto nella riflessione pedagogica. In particolare, nelle varie pedagogie radicali stimolate dai
fermenti ideologici degli anni Sessanta e Settanta prima, e oggi soprattutto nella corrente di riflessione
sulla cosiddetta pedagogia critica vicina all’ambito dei Cultural Studies (della quale Henry Giroux è uno
dei teorici principali). Per uno stato dell’arte aggiornato del dibattito sulla pedagogia critica nell’area dei
Cultural Studies si può vedere utilmente il numero speciale su Popular Culture and Education che le ha
dedicato nel 2003 l’Harvard Educational Review (LXXIII, 3). Cfr. anche Giroux 1983; Giroux e
McLaren 1994; Darder, Baltodano e Torres 2002.
16
Come è noto, l’idea e la pratica della «chiusura» della scuola, della separazione materiale e simbolica
dell’universo scolastico dalla vita e dalla cultura della comunità, è nata con i collegi dei gesuiti per le
esigenze dell’educazione delle élites, e attraverso i secoli è giunta a coincidere con la «forma scolastica di
socializzazione» (Vincent (ed.) 1994) tout court.
17
Il concetto di pedagogia popolare è stato storicamente legato soprattutto a quello dell’«apertura» della
scuola alla vita e alla cultura della comunità di provenienza degli allievi. Tuttavia, non sono mancati i
sostenitori dell’idea che una educazione efficace dei figli del popolo dovesse passare necessariamente per
una scuola che fosse il più possibile «chiusa», o meglio chiaramente separata dalla vita e dalla cultura
della comunità locale. Mi pare per esempio che una delle teorizzazioni e delle realizzazioni pratiche più
chiare – ed efficaci – di questa seconda posizione si possa identificare nelle idee e nella prassi pedagogica
di Lorenzo Milani. Un altro esempio di questa seconda posizione sono i programmi di «compensazione»
sorti negli Stati Uniti degli anni Sessanta in seguito alla diffusione della teoria del deficit o dell’handicap
socio-culturale, e rivolti a bambini socialmente svantaggiati di età prevalentemente prescolare (per una
dettagliata e interessante illustrazione di uno di questi programmi di compensazione prescolari, cfr.
Bereiter e Engelmann 1966).
18
Il concetto di «arbitrario culturale» è stato introdotto da Bourdieu in La Reproduction (Bourdieu e
Passeron 1970) per indicare, in una prospettiva relativista, l’universo simbolico legittimo incarnato nelle
istituzioni educative. Sebbene Bourdieu sia solitamente considerato uno dei rappresentati principali di una
concezione legittimista della cultura popolare, la sua sociologia si caratterizza in realtà per una certa
oscillazione tra la prospettiva legittimista e quella relativista (cfr. Grignon e Passeron 1989; Ravaioli
2002). Su questo punto, si veda sotto il paragrafo 1.2.1.2.1.
19
Il concetto venne introdotto dall’antropologo statunitense Oscar Lewis per la prima volta nel 1959 in
Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. Lewis dedicò la maggior parte delle sue
ricerche – tutte pubblicate nel corso degli anni Sessanta – al modo di vita dei sottoproletari
centroamericani sia nei loro Paesi d’origine sia immigrati negli Stati Uniti. Nello stesso decennio questo
concetto venne applicato all’analisi della povertà negli Stati Uniti, tra gli altri, da Michael Harrington
nell’influente The Other America. Poverty in the United States (1962), Daniel P. Moynihan, autore di The
Negro Family (1967), e dall’antropologo Edward Banfield in The Unheavenly City (1968). Per una storia
del dibattito scientifico e politico sulla povertà negli Stati Uniti del Ventesimo secolo, si possono vedere
utilmente O’Connor 2001 e Marcus 2005.
20
La teoria della cultura della povertà è solitamente associata soprattutto al nome di Oscar Lewis. Se è
vero che Lewis fu effettivamente il primo a introdurre questo concetto, è altrettanto vero – ed è un fatto
abitualmente trascurato – che il modo in cui il concetto di cultura della povertà è stato utilizzato in seguito
da quanti lo hanno applicato alla povertà urbana degli Stati Uniti è stato poco fedele alle intenzioni
teoriche (e politiche) di Lewis. In primo luogo spesso si dimentica che Lewis aveva un orientamento
teorico e politico marxista, era un simpatizzante del Partito Comunista statunitense, e tra l’altro per
questo, in quanto «sovversivo», insieme ad altri antropologi fu uno dei sorvegliati speciali dell’FBI
durante gli anni della caccia alle streghe anticomunista maccartista (cfr. su questo il recente Price 2004).
Soprattutto, nella sua teoria Lewis non trascurò completamente il ruolo delle cause strutturali della
povertà, che identificò segnatamente nel normale funzionamento del capitalismo industriale. E ipotizzò
inoltre che una delle possibili soluzioni al problema della povertà potesse venire dall’auto-organizzazione
40
dei poveri stessi. Ma questi ultimi due aspetti di chiaro sapore marxista della sua riflessione teorica
vennero presto dimenticati, e «fu il lato class-blind del lavoro di Lewis che venne usato» da quanti
vennero dopo di lui: «nel lavoro di Lewis fu il consenso implicato dalla cultura, piuttosto che il conflitto
implicato dalla classe, che accese l’immaginazione di una generazione di scienziati sociali influenzati dal
funzionalismo di Parsons e dal volontarismo di Harrington» (Marcus 2005, p. 45).
21
Per i critici della teoria della cultura della povertà tali comportamenti non coerenti con i valori
professati andavano spiegati, come abbiamo visto, principalmente con ostacoli di natura strutturale esterni
all’individuo. Un’altra interpretazione di tale discrepanza che vale la pena di ricordare qui è quella, spesso
citata, dello «stiramento dei valori» (the lower-class value stretch) elaborata da Hyman Rodman (1963)
(sulla quale cfr. più diffusamente sotto il paragrafo 2.2.3.1). Rodman propone la tesi dello «stiramento dei
valori» proprio come terza via per risolvere il dilemma se i membri dei ceti più bassi condividano o meno
il sistema di valori dominante nella società. Questi individui, sostiene Rodman, condividono gli stessi
orientamenti di valore del resto della società, ma le loro condizioni materiali di esistenza rendono per essi
molto difficile poterli mettere in pratica ed agire in accordo con essi. Allora, per rendere i valori
compatibili con (e realizzabili in) tali condizioni, i membri dei ceti più bassi tendono a «stirarli» verso il
basso «in modo che anche livelli più bassi di successo diventino desiderabili» (Rodman 1963, p. 209).
Rodman fa l’esempio di un uomo che «senza abbandonare i valori del matrimonio e della filiazione
legittima, stira questi valori in modo che anche una unione non legale e figli legalmente illegittimi siano
desiderabili» (ibidem). Una interpretazione ugualmente culturalista della discrepanza tra valori professati
e logiche di azione che si osserva spesso alla base della scala sociale è quella offerta in tempi molto più
recenti da Ann Swidler (1986) (sulla quale si veda sopra la nota 11 di questo capitolo).
22
Nell’ambito dei parsonsiani, tra i contributi più rilevanti alla questione del relativismo dei valori vanno
certamente ricordati quelli di Clyde Kluckhohn e di sua moglie Florence Rockwood Kluckhohn. Cfr. in
particolare Florence Kluckhohn e Fred Strodtbeck, Variations in Value Orientations (1961).
23
Si noti, incidentalmente, che sia in quest’ultima frase sia nella precedente, il secondo dei tre fattori
menzionati non è affatto analiticamente equivalente agli altri due.
24
Una delle critiche più importanti che sono state mosse agli studiosi dei valori di classe è che i loro
risultati sarebbero diversi se avessero utilizzato una misura relativa, anziché assoluta, dell’ambizione (cfr.
in particolare Turner 1964; questa è anche la posizione di Boudon 1973). Se cioè l’ambizione fosse stata
misurata con il numero di «gradini» nella scala della mobilità sociale che un individuo deve salire per
raggiungere la meta che si prefigge, anziché con il prestigio sociale che nella società è attribuito a quella
meta, l’ambizione di riuscita dei membri delle classi dominate sarebbero risultato pari se non superiore a
quello dei membri delle classi più privilegiate. Nelle parole di Jean-Claude Combessie, la conclusione di
questi studi
«presuppone che il sociologo faccia astrazione proprio di quelle differenze sociali
che pretende di cogliere a livello dei valori: egli misura l’ambizione sulla base del
termine che essa si prefigge e non sulla base della distanza che separa questo
termine dal livello sociale (culturale o professionale) della famiglia»
(Combessie 1969, p. 17)
25
Una posizione autorevole e maggiormente articolata di quella di Murray nel dibattito attuale sulla
sottoclasse è quella di William Wilson (1987, 1993), il quale ha sottolineato la stretta articolazione di
fattori strutturali – tra i quali in particolare la segregazione abitativa – e culturali nella generazione delle
sacche di povertà urbana persistente.
26
Questa espressione è discutibile perché stabilire in che cosa consista la marginalità sociale (se per
esempio ai fini pratici dei rapporti con alcune istituzioni della società come le istituzioni educative essa
coincida con l’alterità culturale) e dove essa cominci a «fare problema» sociale per il gruppo studiato (se
per esempio i livelli di istruzione raggiunti dai figli dei normali «proletari» siano o meno un «problema
sociale») è proprio l’interrogativo di fondo di una analisi culturalista della stratificazione sociale.
27
Attiva già negli anni Cinquanta, con i contributi classici di Ely Chinoy (1952) e Robert Dubin (1956).
28
Il terzo momento dell’analisi culturale, quello del campo della produzione culturale (o dell’economia
della cultura), è invece tradizionalmente assente dall’approccio dei Cultural Studies. Questa mancanza
41
costituisce un bersaglio ricorrente di quanti criticano la prospettiva di analisi culturale dei Cultural
Studies, e in particolare la sua dimensione più culturalista, per l’eccessivo volontarismo e libertà
interpretativa che viene accordata ai fruitori culturali (cfr. per esempio McGuigan 1992; Garnham 1995
[2006]).
29
A proposito di questo incipit di Thompson John Storey scrive:
Thompson lavora con la famosa affermazione di Marx sul modo in cui gli uomini e
le donne fanno la storia: «Gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in
modo arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze che essi
trovano immediatamente davanti a sé, determinate dai fatti e dalla tradizione» (Marx
1852, tr. it. p. 46). Ciò che Thompson fa è enfatizzare la prima parte
dell’affermazione di Marx (l’azione umana) contro quella che ritiene una enfasi
eccessiva degli storici marxisti sulla seconda parte (le determinazioni strutturali).
(Storey 2006, p. 39)
30
Questa concezione relazionale e processuale della cultura dei dominati mi pare per esempio bene
espressa sempre nella Prefazione a The Making of the English Working Class, nella quale Thompson
scrive:
Per classe intendo un fenomeno storico, che unisce un certo numero di eventi
disparati e apparentemente non connessi tra loro, sia nel materiale grezzo
dell’esperienza sia nella coscienza. Sottolineo che è un fenomeno storico. Non
concepisco la classe come una «struttura», e nemmeno come una «categoria», ma
come qualcosa che di fatto accade (e si può dimostrare che sia accaduta) nei rapporti
umani. Inoltre, la nozione di classe implica la nozione di rapporto storico. [...] E la
classe accade quando alcuni uomini, come risultato di esperienze comuni (ereditate
o condivise), percepiscono e articolano l’identità dei propri interessi tanto tra loro
quanto contro altri uomini i cui interessi sono diversi dai loro (e di solito opposti ad
essi).
(Thompson 1963, p. 10-11)
31
Negli stessi termini Tony Bennett osserva:
La sostituzione del concetto di dominio con quello di egemonia non è, come alcuni
commentatori hanno suggerito, meramente terminologica; si porta dietro una
concezione interamente differente dei mezzi attraverso i quali le lotte culturali e
ideologiche sono condotte. Laddove, secondo la tesi dell’ideologia dominante, la
cultura e l’ideologia borghese cercano di prendere il posto della cultura e
dell’ideologia della classe operaia e diventare così direttamente operative nello
strutturare l’esperienza della classe operaia, Gramsci sostiene che la borghesia può
diventare una classe dirigente egemonica solo nella misura in cui l’ideologia
borghese sia capace di ospitare, trovare uno spazio per le culture e i valori della
classe antagonista. Una egemonia borghese è assicurata non attraverso la
cancellazione della cultura della classe operaia, ma attraverso la sua articolazione
alla cultura e all’ideologia borghese, in modo che, essendo associata a ed espressa
nelle forme di quest’ultima, in questo processo le sue affiliazioni politiche vengono
modificate.
(Bennett, 1986 [2006], p. 95)
32
È questa, per esempio, la prospettiva analitica che è stata applicata a uno degli ambiti di ricerca più noti
dei Cultural Studies degli anni Settanta, le subculture degli adolescenti inglesi di classe operaia comparse
a partire dal dopoguerra (cfr. per tutti Hall e Jefferson (eds.) 1976; Hebdige 1979), e in particolare le
subculture «spettacolari» (Hebdige), vale a dire quelle che si esprimevano principalmente negli stili
estetici e nelle scelte di consumo. Le quali sono state lette appunto come manifestazioni di una resistenza
sia alla cultura (e all’autorità) dominante sia alla cultura operaia (e all’autorità) della generazione
precedente espressa simbolicamente attraverso lo stile e il rituale, e segnatamente «attraverso la
ricollocazione e la ricontestualizzazione degli oggetti di consumo, il sovvertimento dei loro usi
convenzionali e l’invenzione di usi nuovi» (Beezer 1992, 115). Ma la versione più radicale della
concezione della cultura popolare come terreno – e prodotto – di una continua «lotta all’interno della
42
significazione» (Hebdige 1979, tr. it. p. 19), dell’interpretazione e dell’uso dei prodotti dell’industria di
massa è certamente quella elaborata a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta nelle cosiddette teorie
della resistenza, del consumo produttivo o del consumo antagonista. Una delle più note è la teoria del
consumo popolare come insieme di «tattiche» di resistenza dei dominati contro la «strategia» di
imposizione della cultura dominante elaborata da Michel de Certeau (cfr. in particolare De Certeau 1990).
All’interno dell’area istituzionale dei Cultural Studies, questa posizione è legata alla riflessione più
recente di Paul Willis (cfr. in particolare Willis 1990) e soprattutto alla riflessione di John Fiske (cfr. in
particolare Fiske 1989a e 1989b). Quest’ultima si caratterizza in particolare per un ottimismo radicale
sulla libertà di interpretazione e di uso dei beni di consumo del fruitore popolare, e quindi sulla sua
capacità di «resistenza» attraverso questa fruizione «creativa». «Una versione puramente ermeneutica dei
Cultural Studies» (Storey 2006, p. 157), in cui né il contesto e le condizioni di consumo né le
caratteristiche del prodotto consumato offrono cioè alcuna «resistenza» alla libertà interpretativa del
fruitore popolare, il quale nell’atto di consumo stesso è in grado quindi di operare una sorta di produzione
di secondo livello. Per la sua radicalità, la posizione di Fiske non ha affatto trovato consensi unanimi
nemmeno all’interno degli stessi Cultural Studies. Dove, anzi, «Fiske è generalmente considerato
l’epitome di uno scivolamento acritico nel populismo culturale» (ibidem), e la sua posizione «indicativa
del declino critico dei British Cultural Studies» (McGuigan 1992, p. 85).
33
Ma confermate molto più tardi e in riferimento al contesto statunitense anche da David Hall (cfr. Hall
1993).
34
In realtà Bourdieu presta molta poca attenzione all’eventualità e alle forme di questo «inceppamento»
nel meccanismo di interiorizzazione delle disposizioni. E anzi la sua mancanza di attenzione tanto teorica
quanto empirica alle modalità e agli effetti della socializzazione individuale lo conduce a porre come un
assunto con validità generale della sua teoria dell’azione il fatto che le disposizioni siano tanto forti (e
quindi la loro interiorizzazione sia stata tanto «perfetta») da impedire qualsiasi riflessività dell’azione. La
formulazione più seria di questa critica si deve certamente a Bernard Lahire, il quale ha dedicato una
parte importanto della sua riflessione e del suo lavoro di ricerca proprio a esplorare e cercare di
correggere questo limite della sociologia bourdieuiana dell’azione. Lahire ha più volte sottolineato come
la teoria bourdieuiana dell’habitus sia «una teoria della riproduzione “piena”, ma una teoria della
conoscenza e dei modi di socializzazione “vuota”» (Lahire 1999a, p. 131), la quale
evoca retoricamente l’«interiorizzazione dell’esteriorità» o l’«incorporazione delle
strutture oggettive» senza mai dare loro veramente corpo attraverso una descrizione
etnografica (o storiografica) e l’analisi teorica. [...] A forza di insistere sul «ciò si
riproduce», si è finito per trascurare il «che cosa si riproduce» e il «come, in quali
modi, ciò si riproduce».
(ibidem)
Sulla base di questa critica, a partire dalla metà degli anni Novanta Lahire ha iniziato ad elaborare una
revisione della teoria bourdieuiana dell’azione con il nome di sociologia psicologica. In termini
estremamente sintetici, il programma di ricerca di Lahire è nato dalla constatazione che molti degli
strumenti concettuali della sociologia bourdieuiana, nati per lo studio di unità di analisi di tipo aggregato
quali i gruppi sociali, si rivelano poco adatti per studiare l’individuo socializzato in quanto tale. Non solo
nella sociologia di Bourdieu si trova un interesse pressoché esclusivo per il sociale nella sua forma
aggregata, ma vi si trova anche l’idea che i concetti e i metodi che sono adatti allo studio del sociale nella
sua forma aggregata lo siano anche per cogliere quello che Lahire definisce il «sociale individualizzato».
«L’epistemologia molto poco weberiana di Pierre Bourdieu», scrive Lahire, «fa sì che egli non sia molto
sensibile alla questione delle variazioni di scala nella produzione delle conoscenze sociologiche» (Lahire
1999a, 123). Questo è vero soprattutto per il concetto di habitus, del cui meccanismo di funzionamento a
livello individuale la sociologia bourdieuiana offre una comprensione ben ridotta sia per quanto riguarda
la sua costituzione, il processo di socializzazione, sia per quanto riguarda le sue modalità di
attualizzazione in situazioni concrete. Ed è vero per il concetto strettamente legato di trasmissione
culturale. In particolare, se l’assunto bourdieuiano che le disposizioni che compongono l’habitus sono
tutte, allo stesso grado e in qualsiasi tipo di contesto, generalizzabili e trasferibili da un dominio di
pratiche a un altro non tiene conto della pluralità dei contesti sociali attraversati dall’individuo, l’assunto
che tali disposizioni sono tra loro coerenti e omogenee e formano un sistema non tiene conto della
pluralità interna dell’individuo, segnatamente della pluralità dei principi di socializzazione dei quali
l’individuo è il prodotto. I differenti contesti sociali attraversati possono di volta in volta produrre
nell’individuo l’attivazione di certe disposizioni e l’inibizione di altre, e questo a sua volta può accadere
43
perché ciascun individuo è portatore di un insieme di disposizioni non del tutto coerenti e omogenee tra
loro che sono il prodotto di un processo di socializzazione complesso. La mancanza di attenzione tanto
teorica quanto empirica alle modalità e agli effetti della socializzazione individuale conduce Bourdieu a
porre come un assunto con validità generale non solo l’unicità dell’individuo, ma anche il fatto che le
disposizioni siano tanto forti da impedire qualsiasi riflessività dell’azione. È questo il modello della
logica dell’agire dell’amor fati, dell’adesione immediata e completa ai propri condizionamenti sociali
incorporati e del piacere provato a praticare ciò che non si può comunque evitare. Ma questa maniera
incantata di vivere i propri condizionamenti sociali come una necessità interna, un gusto personale,
designa in realtà solo una delle modalità del rapporto che gli agenti possono intrattenere con le proprie
disposizioni, che non è l’unica e nemmeno la più frequente, poiché da un lato richiede delle condizioni di
socializzazione particolari – segnatamente, una socializzazione precoce, regolare, intensa, e priva di
fenomeni di ingiunzione contraddittoria1 – e dall’altro delle condizioni per la messa in pratica delle
disposizioni che siano socialmente gratificanti. Altre condizioni di socializzazione e di attualizzazione
delle disposizioni possono fare sì che gli individui non abbiano un desiderio particolare di mettere in
pratica le proprie disposizioni, o che addirittura desiderino liberarsene. Lahire invita quindi a distinguere,
nell’analisi del rapporto che un agente intrattiene con le proprie disposizioni, tra competenze e
appentenze, tra la capacità di fare qualcosa e il gusto o il desiderio di farla. Più in generale, egli afferma
con forza che, sebbene la tensione tra azione riflessiva e azione non riflessiva, come quella tra unicità e
pluralità dell’agente, sia una delle opposizioni maggiori lungo le quali si oppongono differenti teorie
dell’azione e del soggetto agente (cfr. Lahire 1998 e 1996b), «un simile problema non può […] essere
risolto sociologicamente nell’ordine strettamente teorico» (Lahire 1996b, p. 88), ma «il problema della
natura e dell’organizzazione del patrimonio individuale di disposizioni deve essere posto nel lavoro
empirico» (1998).
35
A proposito della imprescindibilità di questa prima dimensione della doppia lettura, Grigon e Passeron
osservano molto giustamente:
Il bilancio di una cultura popolare che si fondi sull’ipotesi della sua autonomia
simbolica può senz’altro avvalersi della tendenza di ogni gruppo sociale a
organizzare la propria esperienza in universo coerente, tendenza alla quale nessuna
condizione sociale, fosse anche la più infelice o la più dipendente, può impedire
completamente il lavoro di messa in ordine simbolico; anche dominata una cultura
funziona ancora come una cultura. Si tratta di un effetto del diritto imprescindibile
che accorda a ogni gruppo sociale la tesi weberiana secondo la quale ogni
condizione sociale è nello stesso tempo il luogo e il principio di una organizzazione
della percezione del mondo in un “cosmos di rapporti dotati di senso”.
(Grigon e Passeron 1989, p. 21)
E aggiungono anche che:
Le pratiche e i tratti culturali delle classi popolari si trovano privati del senso che
prendono dalla loro appartenenza a un sistema simbolico quando il sociologo
dichiara esclusivo il senso che essi traggono dal loro riferimento a un ordine
culturale legittimo: infrazione, errore, goffaggine, mancanza di codici, distanza,
coscienza vergognosa o infelice di questa distanza o di queste mancanze. Come le
cecità sociologiche del relativismo culturale applicato alle culture popolari
incoraggiano il populismo, per il quale il senso delle pratiche popolari si realizza
integralmente nella felicità monadica dell’autosufficienza simbolica, così la teoria
della legittimità culturale rischia sempre, per il suo integralismo enunciativo, di
condurre al legittimismo al quale, nella forma estrema del miserabilismo, non resta
che conteggiare, con un’aria dispiaciuta, tutte le differenze come mancanze, tutte le
alterità come altrettante inferiorità – sia che ciò venga fatto col tono della
declamazione elitista o con quello del paternalismo.
(ivi, pp. 36-37)
36
Un esempio di questa impostazione analitica relativo all’oggetto empirico della ricerca mi pare sia
costituito dagli studi sui valori educativi di classe condotti da Melvin Kohn. Come vedremo meglio più
avanti (cfr. sotto il paragrafo 2.2.1), le ricerche sui valori educativi di classe di Kohn si differenziano in
modo essenziale dalle numerose ricerche classiche condotte sugli stessi temi dalla generazione di studiosi
statunitensi precedente alla sua, tanto nel filone parsonsiano dei valori di classe quanto in quello
44
dell’educazione familiare. Laddove infatti questi lavori classici si limitavano tipicamente a confrontare il
grado di adesione a singoli valori educativi dei genitori delle diverse classi sociali, Kohn rende più
complessa questa impostazione analitica in due direzioni. Da un lato, si sforza di spiegare l’adesione ai
valori educativi con le condizioni di esistenza della famiglia (nello specifico, con il grado di autonomia
decisionale della posizione professionale del padre), anziché ritenerli semplicemente proprietà essenziali
della cultura della classe considerata. Dall’altro – ed è questo ciò che più ci interessa qui – presta
attenzione al senso differente che uno stesso valore può assumere per i membri delle diverse classi. E
ritiene in particolare che questo senso specifico non possa essere colto se non prendendo in
considerazione i rapporti che questo valore intrattiene con il gli altri tratti simbolici (e quindi anche con il
complessivo sistema dei valori) della cultura di classe considerata. Per una discussione dei progressi
compiuti dalla riflessione di Melvin Kohn nello studio dei valori educativi di classe nella sociologia
americana, cfr. Combessie 1969.
45
46