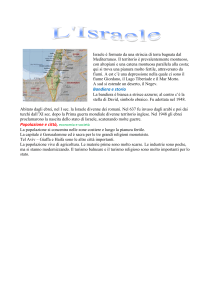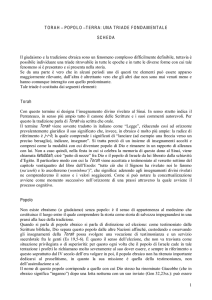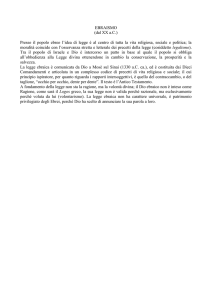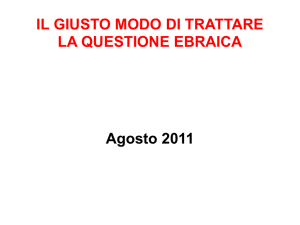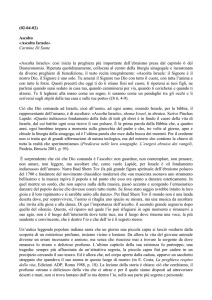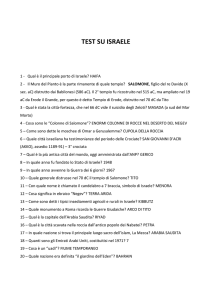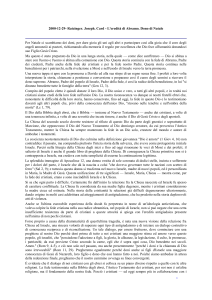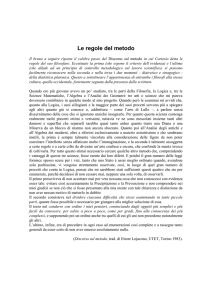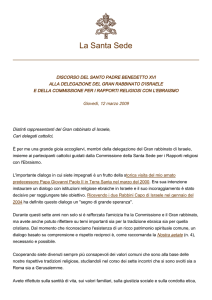REGATT 04-2010.qxd
24/02/2010
16.22
Pagina
131
E b re i : fe d e l t à e p re ce t t i
Ascolta Israele
n base a una consolidata precomprensione si è soliti sostenere sia che nell’ebraismo non ci sono
dogmi, sia che la professione di fede ebraica è costituita dall’«Ascolta Israele» (Dt 6,4). Queste due
affermazioni sono certo in larga parte condivisibili, specie se al termine «dogmi» si sostituisce l’astratto «dogmatica». Tuttavia esse, viste in una
determinata luce, peccano a un tempo, paradossalmente,
tanto per eccesso quanto per difetto. Infatti non corrisponde al vero né che l’«Ascolta Israele» si presenti come una
vera e propria «professione di fede», né che la tradizione
ebraica non abbia mai elaborato, in modo sufficientemente esplicito, degli «articoli di fede». Inoltre, anche a prescindere da queste formulazioni, per lo più legate all’epoca medievale, di norma ci si è sempre riferiti ad alcune verità il cui accoglimento fu a lungo considerato pregiudiziale alla piena appartenenza alla comunità d’Israele.
Per quanto, consapevolmente o inconsapevolmente,
ignorato da molti attuali ebrei «laici», per tutta l’epoca
premoderna quasi tutti i figli d’Israele avrebbero sottoscritto la sentenza del grande dotto alto medievale Sa‘adya
Gaon stando alla quale «siamo un popolo soltanto a motivo delle nostre dottrine religiose» (Sefer ha-’Emunot we
ha-Deot, 3,71). Va da sé che, partendo da questa convinzione, diviene indispensabile far riferimento ad alcune verità considerate vincolanti per l’intera comunità tutte riassumibili nella proposizione secondo cui la «Torah è dal
cielo» (non dagli uomini). La constatazione che queste
dottrine riguardano soprattutto la prassi più che la teoria
esclude che nell’ebraismo vi sia una formulazione del dogma simile a quella presente in alcuni simboli cristiani (ivi
compreso il Credo niceno-costantinopolitano). Ciò però
non nega che in quest’ambito ci si riferisca pur sempre ad
alcune proposizioni che fungono da presupposti irrinunciabili del «credo» ebraico.
Le osservazioni fin qui condotte potrebbero essere ritrascritte affermando che nell’ebraismo vi è, sia pure in
modo del tutto particolare, uno spazio tanto per la fides
qua quanto per la fide quae. La stessa adesione pratica ai
comandamenti implica, infatti, sia un atteggiamento di fede/fedeltà sia il riferimento a determinati contenuti.
Nella comunità d’Israele a essere fondamentale è innanzitutto l’’emunà, cioè la fedeltà che l’ebreo dimostra
nei confronti del suo Dio come risposta al vincolo di fedeltà e di amore che il Signore (JHWH) si è gratuitamente assunto nei confronti del suo popolo (cf. Dt 7,7-8). Tuttavia questa fede per dispiegarsi compiutamente come tale, deve calarsi di necessità in contenuti che attestano, nella loro attuazione, il concreto accoglimento da parte dell’ebreo dell’obbligazione derivata da quello stesso legame.
La tradizione rabbinica assegna una particolare importanza al versetto del profeta Abacuc secondo cui «il
giusto vivrà per la sua fede [fedeltà]» (Ab 2,4). Particolarmente eloquente in proposito è un brano del Talmud babilonese in cui, a conclusione di un ampio percorso, s’indi-
I
vidua proprio in questo passo il luogo dove si concentrano
tutti i significati connessi all’osservanza ebraica dei precetti. Esso inizia facendo riferimento al tradizionale computo
in base al quale i precetti della Torah ammontano a 613.
Venne dunque Mosè e diede ai figli d’Israele questo alto
numero di comandamenti; in seguito Davide, Isaia, Michea ridussero progressivamente il numero dei precetti.
Sopraggiunse infine Abacuc che ridusse il comandamento
a uno solo: «Il giusto vivrà per la sua fede» (Ab 2,4) (cf.
Talmud babilonese, Makkot, 23b-24a). Quest’ultima proposizione, è ovvio, non va intesa come se l’adesione di fede senza opere fosse in se stessa sufficiente; al contrario essa indica che il primato spetta a una fedeltà che si manifesta nell’esecuzione dei precetti.
Per comprendere meglio la prospettiva ora esposta
non vi è percorso migliore che riferirci allo Shema‘ Israel
(«Ascolta Israele») così come esso si presenta nella sua versione liturgica. Con questo nome viene indicato una sequenza di brani biblici (Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41)
preceduta e seguita dalla recita di alcune benedizioni. Il limite di considerare lo Shema‘ una vera e propria professione di fede sta nel fatto di essere privo di un carattere dottrinale astratto. Esso non ha neppure la forma di pubblica
dichiarazione davanti a Dio e agli uomini della propria fede; al contrario, pronunziandolo, il figlio d’Israele «ascolta e accetta l’invito all’obbedienza radicale che Dio gli rivolge. Non si tratta di una dichiarazione di Israele, bensì
della volontà di Dio a Israele».1
Per capire appieno il senso dello Shema‘ è fondamentale far tesoro dell’ordine in cui si succedono i brani biblici in esso contenuti. In particolare, occorre porre in rilievo
che è solo la proclamazione dell’unità e la regalità del Signore, contenuta nella prima parte, a consentire di attribuire all’accoglimento dei precetti (espresso nella seconda)
il suo più autentico significato. A questo proposito risulta
illuminante il detto di un maestro della seconda metà del
II secolo d.C., stando al quale la sezione dell’«Ascolta
Israele» (Dt 6,4-9) precede «Se [ascoltando] obbedirete»
(Dt 11,13-21), in quanto «un uomo deve prendere prima
su di sé il giogo del regno dei cieli e in seguito prendere su
di sé il giogo dei precetti» (Mishnah, Berakhot, 2,2). L’obbedienza ai precetti è, quindi, sia una conseguenza della
preliminare e gratuita scelta del popolo da parte del Signore, sia una concreta manifestazione dell’accettazione
della signoria divina da parte della comunità d’Israele. Ciò
fa comprendere come, a differenza di quanto sostenuto da
una visione stereotipata, l’osservanza è collocata non nell’orizzonte dei meriti, bensì in quello di un’obbligazione
derivata dall’aver accettato la regalità del Signore.
Già in epoca precristiana Antigono di Sokho soleva dire in nome di Shimon il Giusto: «Non siate come servi che
servono il padrone a condizione di ricevere il salario. Siate piuttosto come servi che servono il padrone non a condizione di ricevere il salario, e il timore del cielo sia su di
voi» (Mishnah, Pirqè Avot, 1,3). Sentenza che ha significato solo se, in senso formale e sostanziale, la Torah è accolta perché viene dal cielo.
Piero Stefani
1
M. PESCE, «Il centro della spiritualità ebraica alle soglie dell’era
volgare in Palestina», in La spiritualità del Nuovo Testamento, a cura
di R. Fabris, Borla, Roma 1985, 30.
IL REGNO -
AT T UA L I T À
4/2010
131