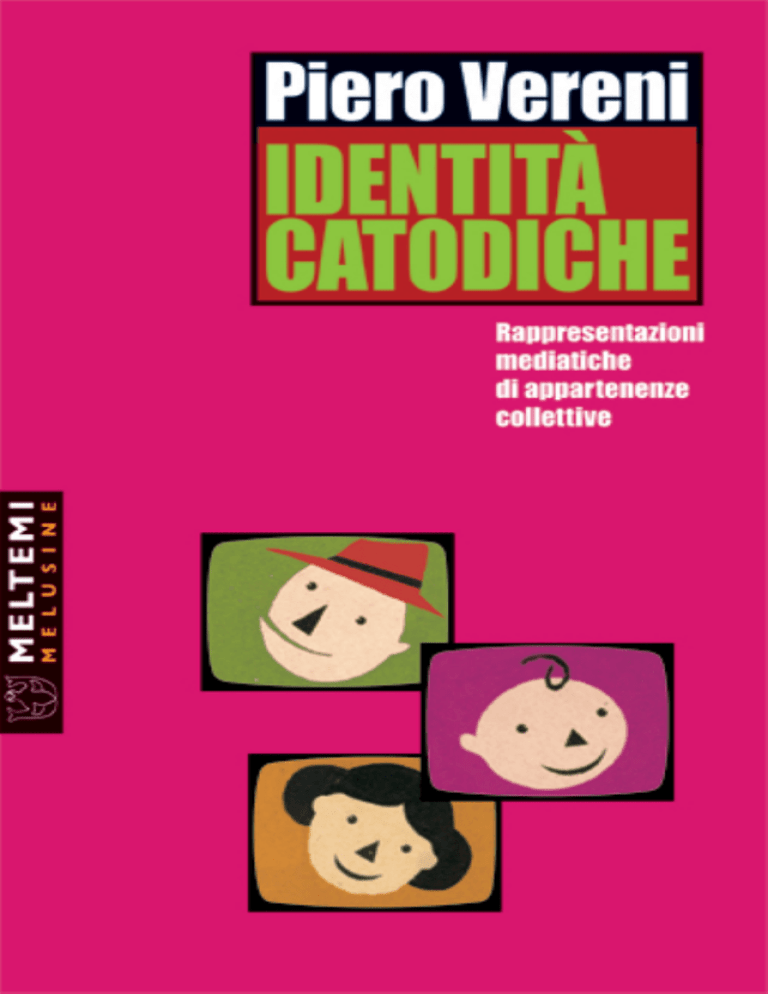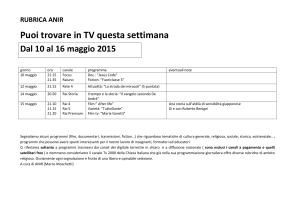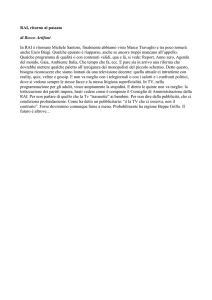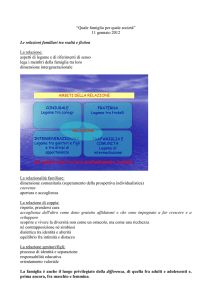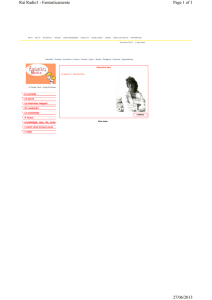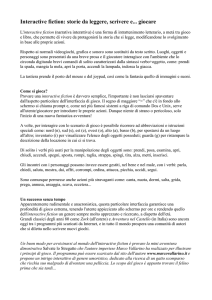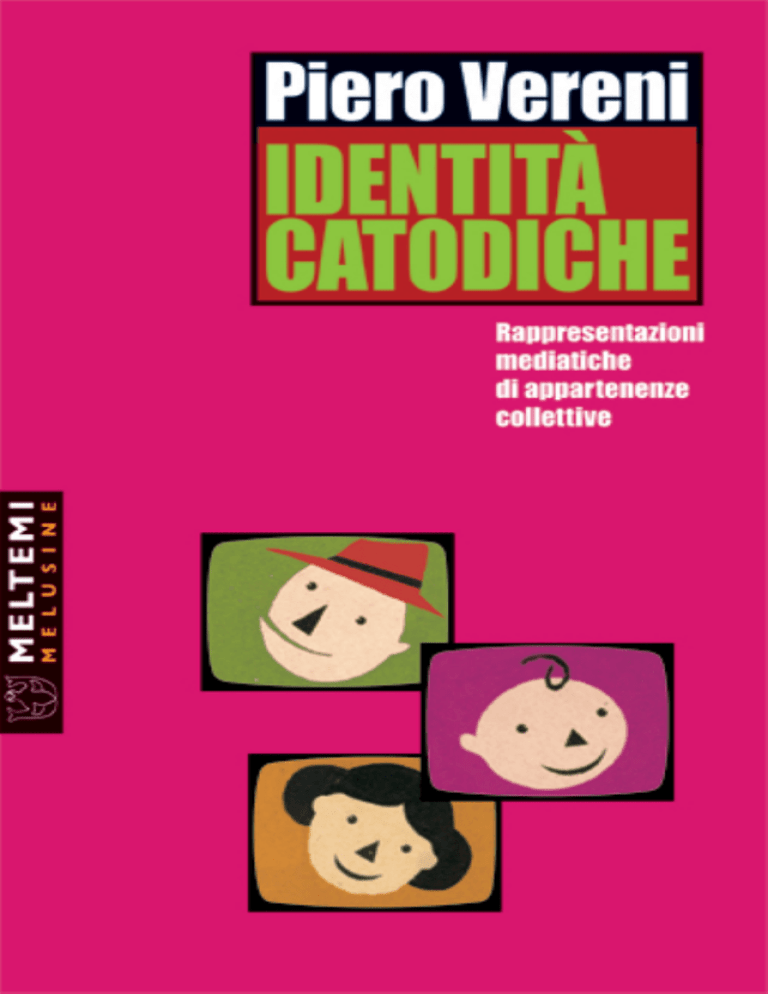
Melusine 81
antropologia / scienze sociali
Copyright © 2008 Meltemi editore srl, Roma
ISBN 978-88-8353-672-4
È vietata la riproduzione, anche parziale,
con qualsiasi mezzo effettuata compresa la fotocopia,
anche a uso interno o didattico, non autorizzata.
Meltemi editore
via Merulana, 38 – 00185 Roma
tel. 06 4741063 – fax 06 4741407
[email protected]
www.meltemieditore.it
Piero Vereni
Identità
catodiche
Rappresentazioni
mediatiche di
appartenenze collettive
MELTEMI
Indice
p.
7
Introduzione
13
Capitolo primo
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente
ossimoro
14
18
23
30
I media non esistono
Antenati e genealogie
La critica culturale e le forme mediatiche dell’appartenenza
Antropologia dei media in Italia
49
Capitolo secondo
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche
nell’epoca dei mass media
49
49
56
62
Introduzione
Il modello di Bourdieu
La distinzione, oggi
La soapizzazione dell’anima
69
Capitolo terzo
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine
degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (19972006)
69
71
77
87
Introduzione
Pastori e pinocchi
Banditi e invasori
Il carnevale delle identità
91
98
Albanesi e ballerini
Conclusioni
101
Capitolo quarto
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano
nella narrativa televisiva (1988-2007)
101
105
114
129
139
145
Introduzione
Nord/Sud e il “tipo meridionale”
L’immagine del crimine: La piovra e i suoi epigoni
La provincia e lo spazio della borghesia
La famiglia
Conclusioni: dalla fiction alla cronaca e ritorno
153
Bibliografia
163
Indice dei nomi
Introduzione
Cu l’antinna mia pignattara
lu tilivisore de la vidova Capecchia
ce se vista tutto lu munno.
Puro l’oltremunno ce se vista.
Ieri m’abbie acchiamato la vidova Capecchia,
m’abbie detto:
“Abbio vistato li morti a lu tilivisore!
Abbio vistato lu marito mio!”.
Ringraziamenti
Nel saggio Andy Warhol era un coatto, Tommaso Labranca (1994)
enuncia la formula matematica del trash, definito come lo scarto
tra un modello mediatico e il suo fallimentare tentativo di imitazione. Grazie alla complicità di Tiziano Scarpa, all’inizio degli anni
Novanta ho potuto leggere quel libro in una versione autoprodotta dall’autore – prima che lo stampasse l’editore Castelvecchi – titolata Giovani salmoni del trash. I salmoni, secondo Labranca, sono quegli individui in grado di riconoscere il trash senza temerlo,
di averne insomma una prospettiva pur non facendone veramente
parte. Il salmone risale la corrente del trash senza lasciarsene trasportare, dunque, ma anche senza uscire dal fiume della cultura
pop che quella corrente rinnova costantemente.
L’immagine, allora, mi colpì molto e oggi vi sento una forte assonanza con la recente pratica etnografica: cosa sono, in fondo, gli
antropologi se non (più o meno giovani) salmoni del trash? Certo,
tacciare di trash le culture umane studiate dagli antropologi suona offensivo, ma basta fare un giro per qualunque sagra paesana
o festival locale e si dovrà riconoscere che quel che da qualche
decennio ha preso piede come “cultura” spesso altro non è che la
rivalutazione e riproposizione (spesso fallimentare) di sedicenti
modelli passati le cui vestigia sono rinvenute grazie alla mediazione di documenti, libri, a volte fotografie. E se per decenni l’individuazione dell’autentico è stata una vera ossessione degli studi antropologici (e forse ancor più di quelli demologici),
7
Tiziano Scarpa, Groppi d’amore nella scuraglia
Piero Vereni
Identità catodiche
8
gli antropologi delle ultime generazioni, come ricordano Barbara
Kirshenblatt-Gimblett e Edward M. Bruner (1992), tendono in qualche modo a connettere l’autentico, che non può essere un concetto
astratto e slegato dai suoi usi sociali, storici o scientifici, con la
questione invece fondamentale dell’autenticazione (de Sanctis
Ricciardone 2007, p. 138).
Diciamo allora che per una porzione rilevante dei nostri studi la
questione dell’autenticità è mutata radicalmente, e sempre più
spesso l’oggetto di indagine delle ricerche antropologiche e demologiche è proprio il percorso di autenticazione, messo in atto
dagli stessi soggetti portatori secondo pratiche coscienti di culturalismo, vale a dire di utilizzo della differenza culturale con
obiettivi politici (Appadurai 1996).
La cultura, detto altrimenti, assume la sua forma “autentica” perché tra i vari discorsi che la compongono alcuni hanno il potere
di essere più plausibili, e vengono fatti circolare in quanto tali. I
capitoli inclusi in questo volume sono sondaggi che indagano
proprio la circolazione di discorsi dedicati alle forme di autenticità che assume quel particolare “oggetto” culturale che chiamiamo identità collettiva.
Gli antropologi hanno ormai consolidato la convinzione (sostenuta da una mole sterminata di dati) che i “gruppi sociali” non siano entità oggettive delimitabili dall’esterno con una serie di criteri sociologici, ma siano invece soggetti collettivi pubblici che si
sforzano di segnare la propria differenza con l’esterno tramite
una serie di marcatori semiotici, cioè di segnali della differenza e
dell’appartenenza. Dire che le appartenenze sono segni non significa ovviamente negare la politica, ma ricondurla al suo alveo
comunicativo: l’identità di un gruppo sarà la complessa risultante delle molteplici definizioni interne e delle contraddittorie classificazioni dall’esterno. Non tutti, all’interno, sono parimenti legittimati a produrre un discorso dell’appartenenza (a dire chi siano i membri “del nostro gruppo”), e dall’esterno non tutti hanno
il potere di dire come si debbano considerare “gli altri”. Tutti, comunque, devono far circolare questi discorsi attraverso i normali
canali della comunicazione umana, che oggi sono sempre di più
9
Introduzione
quelle strutture organizzate, complesse e gerarchizzate che chiamiamo mass media.
Nei capitoli che compongono questo libro il tema che costituisce
il filo conduttore è proprio il rapporto tra identità politica e mass
media. Non intendo affermare che non vi siano altre forme (per
molti certo più gratificanti o dignitose) di dichiarazione o pratica
dell’appartenenza, ma credo che l’antropologia debba riconoscere il ruolo che i mezzi di comunicazione di massa giocano nel
quadro generale della politica, intesa secondo i dettami della nostra disciplina, vale a dire le forme che regolano i rapporti tra
“noi” da un lato, e tra “noi” e “loro” dall’altro.
Nel primo capitolo, quindi, ricostruisco alcune linee di ricerca che
hanno portato all’emergere, in modo nitido solo nell’ultimo decennio, di un’“antropologia dei mass media”. Oltre che produrre
una periodizzazione almeno approssimativa per un settore di
studi in piena ebollizione, ho voluto evidenziare la rilevanza dei
media nella produzione delle identità, al fine di sottrarre definitivamente l’analisi condotta in contesti non euroamericani a uno
sguardo a volte ancora attardato su un esotismo residuale. I
mezzi di comunicazione di massa (o almeno alcuni, come il telefono cellulare e la televisione) hanno una diffusione veramente
planetaria e non ha alcun senso espungerli dalle nostre ricerche
sul campo, quando invece è evidente che la loro pervasività li
rende strumenti importanti dell’identità. Nel paragrafo finale, il
primo capitolo propone una prima sintesi degli studi italiani in
questo settore.
Come alcune forme peculiari di identità possano essere veicolate
dai mass media costituisce invece l’oggetto di interesse del secondo capitolo. Tra il didascalico e il provocatorio, il saggio si
propone come un “aggiornamento” della teoria del gusto estetico che Pierre Bourdieu (1979) ha proposto ne La distinzione. In
quel saggio fondamentale il sociologo francese dimostrava come
il capitale culturale acquisito (gli studi fatti) e il capitale economico ereditato (l’origine familiare) siano i fattori determinanti del
nostro gusto estetico. L’analisi di Bourdieu partiva dalla considerazione che la distinzione (di gusto) tra le varie classi corrispondesse di fatto alla separazione tra i membri delle medesime, che
10
Identità catodiche
Piero Vereni
occupavano spazi fisici in distribuzione complementare: le classi
dominanti, nel quadro sociologico della Francia anni Sessanta dipinta dalla sua ricerca, non entravano praticamente mai in contatto con la piccola borghesia impiegatizia e con le classi lavoratrici e questa separazione permetteva un rinforzo sistematico del
sistema della distinzione dei gusti, a sua volta garanzia della
“naturalità” della separazione fisica tra classi. Il sistema dei
mass media, in particolare la televisione, ha introdotto – è questa la mia ipotesi – una nuova forma di capitale, che denomino
capitale mediatico, che rende disponibili i sistemi ideologici (e le
forme di identità) a classi diverse da quelle che li hanno generati. Nel caso specifico, avanzo l’ipotesi che alcuni programmi di
impianto reality, come C’è posta per te di Maria De Filippi, consentano alla piccola borghesia e al proletariato di assimilare –
rapidamente e senza la necessità di accumulare lo specifico capitale culturale – il modello di identità borghese basato sull’interiorità dei sentimenti che si è sviluppato nel corso dell’Ottocento
e che per lungo tempo veniva incorporato dai suoi portatori grazie a un sistema di pratiche indotto da una “buona istruzione”.
La televisione (e proprio una televisione disprezzata dallo sguardo “distintivo” della borghesia intellettuale) rende quindi disponibile alle masse una forma di identità per lungo tempo elitaria,
e questo non può che provocare risentimento nei titolari originari di quell’appartenenza di classe, vale a dire l’intellettualità borghese, che infatti si scaglia con livore contro quel tipo di televisione che mette in crisi la sua legittimità di classe.
Nel terzo capitolo ricompare Maria De Filippi, ma in un altro contesto di produzione identitaria. Il testo analizza il mutamento
della rappresentazione dell’identità albanese nei mezzi di comunicazione italiani. Alla fine degli anni Novanta la stampa italiana
raffigurava gli albanesi come un popolo di rozzi ignoranti o di
criminali incalliti, e questa immagine egemonica, ipotizzo, si è
profondamente incardinata nella struttura identitaria degli albanesi residenti in Italia. A partire dagli inizi del nuovo millennio,
però, lo stereotipo dell’albanese pezzente o criminale ha dovuto
subire l’assalto corrosivo di una nuova immagine, proposta dal
programma Amici di Maria De Filippi. In questo programma, di
11
Introduzione
grande successo presso il pubblico più giovane, gli albanesi hanno avuto modo di riproporsi come corpi sinuosi e seducenti, lavoratori tenaci e determinati, in contrasto con un’immagine un
po’ vittimista e un po’ improvvisata di alcuni concorrenti italiani.
Lungi dal considerare “reale” questa nuova rappresentazione dell’identità albanese, il capitolo si preoccupa di evidenziarne la
presenza sul mercato delle appartenenze e di sottolineare come
essa da un lato colpisca lo stereotipo negativo degli spettatori
italiani, ma dall’altro si renda disponibile per un ripensamento
da parte degli albanesi stessi del loro ruolo come gruppo nazionale, in Italia e altrove.
Il libro si chiude con una dettagliata disamina dell’immagine del
“Meridione italiano” nella fiction di produzione italiana degli ultimi vent’anni. Un po’ insoddisfatto di alcune letture impressionistiche sul rapporto tra identità collettive e rappresentazioni nelle
fiction televisive, ho cercato di sottrarmi per quanto possibile al
rischio (sempre a portata di mano in questo tipo di analisi) di
generalizzare sulla base di una serie estremamente limitata di
dati, spesso nulla più che il ricordo della propria fruizione televisiva. Il capitolo si pone invece come un quadro “esaustivo”, dato
che è stato elaborato a partire dalla schedatura di oltre 880 titoli
di fiction italiana trasmessi tra l’autunno 1988 e l’inverno 2008.
Ne emerge, con poco stupore, una contrapposizione forte e spesso rigidissima tra ambientazioni dell’Italia Settentrionale e
Centrale, da un lato, e Meridionale dall’altro, soprattutto nella
rappresentazione della famiglia e della media borghesia. È forse
più interessante evidenziare il circolo tra rappresentazione e pratica sociale che lo sviluppo storico dell’ultimo ventennio di fiction sembra porre in chiaro: non solo la narrativa televisiva nazionale ha pescato copiosamente nel duplice bacino costituito
dal sistema degli stereotipi e dalla cronaca, ma ha rimesso in circolo personaggi e “tipologie” rendendoli disponibili per la produzione o il rinforzo di identità collettive. Sebbene quasi completamente realizzato secondo l’analisi dei contenuti delle fiction,
questo capitolo ha comunque l’ambizione di porre in evidenza,
nel finale, proprio il legame tra stereotipi e pratiche quotidiane,
cercando di superare quella rigida contrapposizione tra “vita rea-
Piero Vereni
Identità catodiche
12
le” e “rappresentazione mediatica” che sembra segnare ancora
molta della critica al sistema dei mass media.
Il volume, del resto, termina lì dove dovrebbe iniziare, se fosse
veramente un libro di “antropologia dei media” e non una serie
di riflessioni di impronta antropologica sul rapporto tra media e
identità collettive. L’antropologia del media, come racconto infatti nel primo capitolo, è tale quando si caratterizza per la pratica
della ricerca sul campo, quando cioè cerca di inseguire i percorsi
effettivi di senso del messaggio mediatico nella vita quotidiana,
e non può limitarsi al suo “contenuto” decontestualizzato.
Per essere veramente tale, quindi, l’antropologia dei media deve
quasi disinteressarsi al messaggio in sé, per ricostruirne invece i
percorsi produttivi (sia semiotici, sia economici), quelli interpretativi e, soprattutto, la sua funzione di innesco per “l’immaginazione come pratica sociale”. Si tratta di un approccio di ricerca
che necessita di un lavoro lungo e puntiglioso, di cui illustro alcuni eccellenti esempi, anche italiani, nel primo capitolo.
Sebbene quindi l’etnografia non sia presente se non in minima
parte nei saggi qui presentati, è l’obiettivo di ricerca che necessariamente scaturisce da queste pagine, e la direzione verso cui
sembra speditamente rivolgersi il meglio degli studi attuali.
Capitolo primo
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
Così avviene in genere con i mass media: li
si giudica commisurandone il meccanismo e
gli effetti a un modello di uomo rinascimentale che evidentemente (…) non esiste più.
Quando il senso comune dei non addetti ai lavori pensa all’antropologia, o vengono in mente mucchi d’ossa di ominidi da scavare, oppure villaggi nella giungla dove uomini con spezzoni
d’osso infilati nel naso e con la faccia dipinta di terra colorata ci
accoglieranno dubbiosi se adorarci come dei o mangiarci come
nemici (o mangiarci come dei, forse l’opzione più intrigante).
Come che sia, sembrerebbe una disciplina in cui ossa di vario tipo giocano un ruolo fondamentale.
Da un paio di decenni, dato il rapido decrescere dell’appeal della
dizione “tradizioni popolari” come disciplina universitaria (non
certo delle “tradizioni” in quanto tali, ovviamente), in Italia antropologia, sempre nell’accezione del senso comune, può voler
dire anche la raccolta di usi e costumi spesso desueti e quasi
sempre legati al mondo contadino.
Quale che sia il pregiudizio, esotizzante o arcaicizzante, appare a
molti comunque improponibile un’antropologia che si occupi dell’hic et nunc, tanto più di quel presente in costante accelerazione
costituito dai mezzi elettronici di comunicazione di massa. Se,
quindi, nella visione vulgata, l’antropologia coincide ancora con
lo studio dell’uomo lontano nello spazio o nel tempo, allora è
inevitabile che un’antropologia dei media suoni almeno paradossale, se non contraddittorio come ambito di ricerca, un po’ come
quei corsi universitari che Umberto Eco si divertiva a inventare
negli anni Settanta per il gusto del paradosso: architettura nomade, calligrafia dei popoli senza scrittura, fondamenti del pensiero nichilista, sociologia del solipsismo, e così via.
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
13
Umberto Eco, Apocalittici e integrati
Piero Vereni
Identità catodiche
14
Per quanto, come vedremo, le cose siano effettivamente cambiate nella ricerca e nelle sue ragioni, questo pregiudizio non è limitato ai neofiti o agli esterni alla disciplina, e non è improbabile
che alcuni antropologi considererebbero le pagine che seguono
se non proprio indecenti perlomeno del tutto irrilevanti al “vero”
sapere antropologico.
La questione, quindi, è seria: perché mai una disciplina che si è
occupata nel corso della sua storia di posti distanti e persone diverse da noi dovrebbe impegnare il suo tempo e le sue competenze ad analizzare trasmissioni televisive, telefoni cellulari e internet? Non esistono già per questo tipo di oggetti culturali specifici programmi di ricerca e discipline come la scienza delle comunicazioni o la sociologia dei mass media?
I media non esistono
Prima di iniziare a rispondere, è bene sgombrare il campo dal rischio di un equivoco. Con antropologia dei media intendiamo la
ricerca antropologica condotta sulle fonti audiovisive elettroniche, e non con le medesime1. Per quanto non vi sia una totale
separazione tra questi due ambiti di ricerca, e molti videomaker
e studiosi che utilizzano mezzi audiovisivi di ricerca si pongano
la questione del consumo di quei mezzi, resta comunque vero
che non tutti coloro che si occupano della produzione e del consumo dei media hanno una formazione specifica di “antropologia
visiva”, e spesso, come nel caso di chi scrive, hanno incrociato i
mezzi di comunicazione di massa nel corso delle loro ricerche di
antropologia politica, spesso attorno a questioni di identità etnica e nazionale. In quanto stiamo dicendo, quindi, l’attenzione
non è sull’antropologia visiva (su come usare i mezzi di comunicazione per produrre conoscenza antropologica) ma sull’antropologia dei media (come i mezzi di comunicazione sono parte delle
culture).
Per giustificare questo ramo di studi dobbiamo perciò ripercorrerne le linee di sviluppo storico, e per portare a termine questo
compito partiamo da una considerazione generale, cioè dallo
Per molti anni i mass media sono stati considerati un argomento
quasi proibito per l’antropologia, dato che puzzava troppo di modernizzazione occidentale per un settore di studi identificato con la tradizione (tipicamente non occidentale) e la vitalità della dimensione
locale (Ginsburg, Abu-Lughod, Larkin 2002, p. 3).
La ragione etnologica4 ha preferito quindi puntare su popoli senza disponibilità mediatica o, assai più di frequente, fornire del
suo oggetto una rappresentazione che occultasse proprio la dimensione di utilizzo dei media.
Uno degli esempi più clamorosi e discussi di questo atteggiamento è il film etnografico Nanook of the North di Robert
Flaherty, del 1922, in cui il protagonista è un primitivissimo
eschimese che annusa e lecca il misterioso oggetto da cui è uscita una voce (si tratta di un disco di vinile), mentre oggi sappia-
15
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
sguardo incrociato che ai mezzi di comunicazione di massa hanno offerto da un lato i massmediologi, dall’altro gli antropologi.
I primi hanno insistito (non da ultimo per ragioni di compartimentazione accademica, una delle motivazioni più rilevanti e al
contempo meno indagate della divisione sociale del lavoro scientifico) sull’esistenza autonoma di un universo mediatico da contrapporre alla “realtà reale” e che su quella realtà eserciterebbe
un suo peso diretto (molto spesso giudicato negativamente, come nelle teorie dell’imperialismo culturale, in tutte le loro varianti). Per questi studiosi, inoltre, i media costituiscono una sfera
autonoma sostanzialmente occidentale, in buona parte quindi
separata dalla “vita reale”, che si limiterebbero a riprodurre
(quando sono buoni) o a influenzare (soprattutto se malevoli)2.
Gli antropologi, dal canto loro, hanno per lunghissimo tempo fatto implicitamente propria questa versione “autonomista” della
sfera mediatica, limitandosi a ignorarla3, dall’alto del loro interesse per le culture “pure” che, per motivazioni di diversa natura,
sono ovviamente culture pre-media elettronici. Se cioè l’oggetto
ideale dell’antropologo è stato il primitivo atemporale, non si voleva certo che il suddetto navigasse in internet, o anche solo
guardasse la televisione:
16
Identità catodiche
Piero Vereni
mo che chi interpreta il personaggio di Nanook (“Capo degli
Ikivimuit”, come compare nei titoli di coda) si chiamava in realtà
Allakariallak e, con alcuni altri inuit, conosceva decisamente bene il mestiere del cinema come tecnico, operatore, sviluppatore.
Coinvolti nel traffico mondiale di pellicce (la pellicola era stata
sponsorizzata dalla Revillon Frères, la ditta di pellicce proprietaria della stazione di commercio che compare nel film), gli inuit
avevano bisogno di essere al passo con alcune tecnologie dell’epoca e quindi non erano così ignari delle tecniche di riproduzione della voce e dell’immagine come invece ci dice il “documentario” che racconta la vita di un popolo di cacciatori dell’Artico
(Rotha, Wright 1980, cit. in Ginsburg 2002, p. 53, n. 2).
Per quanto in disuso, questo atteggiamento esotizzante è ancora
evidente in una certa documentaristica divulgativa, per cui i “popoli indigeni” sono sempre ripresi nelle loro pratiche “tradizionali”, nei loro “costumi tradizionali” e in rituali più o meno misteriosi ma comunque “tradizionali”, in un’operazione di staged authenticity (MacCannell 1973) tutta a uso degli spettatori.
L’antropologia, quindi, solo da poco è disposta ad ammettere
che la tecnologia di riproduzione elettronica non è un appannaggio morale del Noi che al massimo può tracimare comicamente
(o dannosamente) sul Loro, ma che è invece una dimensione ordinaria della vita quotidiana di molti uomini in molti punti del
pianeta, e che forse oggi il vero spazio di ricerca in questo settore consiste nel considerare straniante l’uso dei media da noi e al
contempo de-occidentalizzare metodologicamente l’uso dei media altrove, ricostruendone le genealogie di indigenizzazione entro percorsi culturali autonomi. Si tratta quindi di liberare definitivamente il mondo dei mass media di un’aura di occidentalità
putativa, e di ammettere che la disponibilità dei nuovi mezzi
elettronici di archiviazione e riproduzione audiovisiva offre un
potenziale di identità e appartenenza che non è retaggio esclusivo degli “inventori” di quella tecnologia. Di fronte ai nuovi media, siamo tutti “primitivi”, dato che tutti abbiamo bisogno di
elaborare strategie d’uso e di significazione originali che abbiano
e producano un senso dentro il sistema culturale che viviamo.
In questa prospettiva, dunque, possiamo provocatoriamente dire
17
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
che “i media non esistono”: non esistono in quanto struttura autonoma slegata dalla cultura, dato che il loro ruolo è certamente
quello di mediare tra cultura come esperienza vissuta e cultura
come rappresentazione (Tomlinson 1991), ma in quanto insiemi
di oggetti e pratiche sono a pieno titolo parte della cultura come
esperienza, e come tali andrebbero trattati. Tanto meno esistono,
dunque, come sfera autonoma slegata dalla cultura, in un mondo in cui i flussi di immagini hanno raggiunto un’intensità impensabile fino a pochi decenni orsono (Appadurai 1996).
L’antropologia dei media, dunque, non distingue più necessariamente tra un “qui” mediatizzato e un “altrove” pre-mediatico, e
si occupa invece di ricostruire la relazione che intercorre, nei diversi contesti, tra l’ideologia nel messaggio e l’ideologia elaborata altrove, in altre relazioni e altri messaggi. Partendo dalla premessa che i valori del messaggio mediatico sono negoziati con
un corpus valoriale elaborato socialmente e culturalmente al di
fuori dei messaggi, l’antropologia dei media apre programmaticamente il concetto di agency a un nuovo spessore di senso. La dimensione attiva dello spettatore non si limita agli aspetti interpretativi ma si traduce in pratiche sociali: active audience significa non solo (o non tanto) che i messaggi dei media vengono attivamente interpretati dalle audience (questo dovrebbe essere
considerato un truismo dentro qualunque sistema comunicativo)
ma soprattutto che vengono a loro volta mediati socialmente, introdotti in circuiti comunicativi e operativi esterni alla fruizione
mediatica (Silverstone 1994).
Cito un passo da John Tomlinson che ben sintetizza il punto che
sto cercando di elaborare e che parte dalla ricostruzione che
Gustave Flaubert offre del sentimento amoroso di Madame
Bovary. Il modo in cui Flaubert descrive tale sentimento è estremamente sottile, e sembra in grado di rappresentare l’intimo
sommovimento del cuore della protagonista. Ma è lo stesso
scrittore a informarci che quel sentimento (che lui ha saputo descrivere così bene da farci “riconoscere”, mentre leggevamo, le
nostre stesse esperienze amorose) è il prodotto delle letture romantiche della protagonista, piene di sofferenze, dolore, passioni
ed effluvi di lacrime.
18
Identità catodiche
Piero Vereni
Quindi l’esperienza narrativa dell’amore è in effetti un prodotto di ulteriori finzioni (narrative). E quando noi leggiamo Flaubert, quest’atto
non aggiunge qualcosa al nostro senso della “realtà” dell’amore?
Non serve addentrarsi nelle complessità dell’intertestualità per rendersi conto che l’esperienza dell’amore può essere almeno in parte il
prodotto di rappresentazioni. Il che implica che ogni storia romantica
che leggiamo e ogni soap opera che guardiamo può incrementare,
conformare o mediare le nostre “reali” esperienze. Il che non significa assolutamente sostenere che queste esperienze siano, di conseguenza, meno “reali” in alcuna misura. Il punto è che la “realtà” presente deve sempre essere in parte una funzione delle nostre pregresse esperienze che in generale, nel mondo moderno, includono esperienze di testi di natura mediatica.
Ciò che questo suggerisce è che la relazione dialettica tra “esperienza vissuta” e rappresentazioni culturali (mediatiche) non consente
una semplicistica analisi nelle sue parti costitutive: certo, le persone
sono perfettamente in grado di distinguere tra la loro “vita reale” e
le cose che vedono in televisione o leggono nei libri. Ma se ci riflettiamo, ci deve essere uno scambio continuo (e una costante mediazione) tra questi livelli di esperienza. È altrettanto implausibile pensare alla vita reale come un’esperienza assolutamente immediata e
completamente separata dalle rappresentazioni culturali, quanto pensare alla televisione come fosse “il mondo reale” (Tomlinson 1991,
ora in Parks, Kumar, a cura, 2003, p. 131).
Antenati e genealogie
Se non esistono come spazio esterno al mondo sociale in cui si articolano, i mezzi di comunicazione di massa esistono dunque ben
radicati nella vita quotidiana, e lì vanno studiati se vogliamo capirne il rapporto con le strutture di potere. È questo il campo d’azione
dell’antropologia dei media, la cui storia è forse più lunga di quanto non potrebbe parere da queste prime pagine introduttive.
Già negli anni Venti del Novecento Robert Park e la scuola di
Chicago avevano prestato attenzione al ruolo dei giornali (cfr.
Wolf 1992, p. 46). Il lavoro su Middletown (Lynd, Lynd 1929) aveva evidenziato in modo chiaro il ruolo dei media nel processo di
urbanizzazione e modernizzazione. Si può anzi sostenere (Evans
19
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
1990) che la scoperta nel corso degli anni Novanta dell’etnografia dei media in realtà non sia stata altro che il recupero di una
tradizione di ricerca sul campo ben attenta alla dimensione qualitativa e molto attiva fino agli anni Quaranta. L’approccio degli
studi culturali, con la sua matrice letteraria, semplicemente non
era consapevole di questa tradizione sociologica di studi e si trovò a “scoprire” l’etnografia dei media solo quando l’analisi testuale entrò in crisi, da un lato per motivi “endogeni” e dall’altro
quando l’evidente ubiquità del mezzi di comunicazione di massa
costrinse comunque gli studiosi della differenza culturale a porsi
la domanda di come affrontare la ricerca sul campo in un’epoca
che sembrava segnata da flussi mediatici senza precedenti
(Appadurai 1991). Rimanendo più interni alla tradizione antropologica, possiamo dire che l’antropologia dei media si sia imposta
come conseguenza della crisi del modello etnografico canonico,
che ponendo al centro della riflessione teorica il senso dell’etnografia (Clifford, Marcus, a cura, 1986) non solo non ha svuotato
quella pratica di senso, ma l’ha invece recuperata anche per altri
contesti culturali, tradizionalmente trascurati come l’Europa e il
Nord America, aprendosi dunque a una nuova “antropologia del
presente” (Fox, a cura, 1991). La possibilità di restituire all’antropologia un campo di ricerca come le società industriali avanzate
ha cioè reso evidente il ruolo essenziale delle istituzioni culturali
(stampa, cinema, radio, televisione) e la necessità di indagarle a
fondo anche nei più “tradizionali” contesti di ricerca non occidentali (Ginsburg, Abu-Lughod, Larkin 2002, p. 3).
Dal canto suo, il modello etnografico della ricerca sociologica
americana, che avrebbe potuto aprire uno spazio di ricerca qualitativa duraturo e in costante espansione, venne superato metodologicamente a causa delle urgenze di ordine quantitativo delle
reti televisive commerciali, che avevano bisogno di misurare la
loro resa in forme vendibili e comprensibili agli inserzionisti, vale
a dire in termini di share e di audience assoluta. Ien Ang (1991)
ha dimostrato in modo chiaro che questo approccio quantitativo
da un lato è responsabile della creazione stessa del concetto di
audience come entità sociologicamente distinta e dall’altro, una
volta reificato il concetto, ha dato corpo alla battaglia feroce tra
20
Identità catodiche
Piero Vereni
le emittenti per la sua “conquista” esclusivamente numerica
(Spitulnik 1993, p. 299).
Se si pone comunque la questione della terminologia delle discipline e quindi si espunge dal conto la scuola “sociologica” di
Chicago, probabilmente il primo lavoro antropologico espressamente dedicato ai mass media è lo studio che Hortense
Powdermaker, allieva americana di Bronislaw Malinowski, dedicò
all’industria cinematografica di Hollywood subito dopo la seconda guerra mondiale (Powdermaker 1950). Durante una ricerca nel
profondo Sud degli Stati Uniti negli anni Trenta (Powdermaker
1939), Powdermaker si era resa conto che per la piccola comunità di afroamericani che stava studiando il cinema era la forma
principale di intrattenimento e questo la spinse a indagare in
modo sistematico il rapporto tra il mondo della produzione cinematografica e l’impatto sulle audience (Askew 2002, p. 3). Il suo
lavoro rimase sostanzialmente ignorato anche se la stessa autrice riprese il tema del ruolo dei mass media (radio e cinema) nella vita sociale quando studiò una comunità di minatori della copper belt nello Zambia (Powdermaker 1962).
Il giudizio di Powdermaker sul ruolo del cinema è categorico, e
molto vicino alle posizioni che all’incirca in quegli stessi anni
Max Horkheimer e Theodor Adorno stavano elaborando sull’industria culturale e sulla cultura di massa (Horkheimer, Adorno
1947). Si tratta di una concezione estremamente negativa, che risente sicuramente del giudizio sul ruolo della propaganda durante la seconda guerra mondiale:
Hollywood rappresenta il totalitarismo. Il suo fondamento è economico invece che politico, ma la sua filosofia è simile a quella dello stato totalitario. A Hollywood, l’idea di uomo come creatura passiva da
manipolare si estende a quanti lavorano nella produzione, ai rapporti
personali e sociali, al pubblico nelle sale e ai personaggi nei film. La
fondamentale libertà di poter scegliere tra diverse alternative è assente (Powdermaker 1950, p. 327, cit. in Askew 2002, p. 4).
Ma l’approccio etnografico di Powdermaker rimase sostanzialmente ai margini della disciplina, all’epoca ancora profondamen-
perpetuato l’attenzione sull’isolabilità dei messaggi dei media, e sulla conseguente analisi da tavolino dei testi mediatici. Per i positivisti, le unità contenutistiche consentono una facile quantificazione, e
per i fautori della teoria critica è più facile teorizzare la funzione dei
mass media come “industria culturale” monolitica e sostanzialmente
alienante se si parte dalla premessa che i messaggi siano trasmessi
e assorbiti in maniera non problematica (Spitulnik 1993, p. 296).
21
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
te intrisa del paradigma evoluzionista nella sua versione modernista, che la rendeva sostanzialmente cieca all’uso dei mass media nel contesto postcoloniale in formazione e la spingeva a
ignorare l’apporto della tecnologia anche nei contesti culturali
europei di proprio interesse, solitamente rurali e intenzionalmente ricercati per la loro “premodernità”.
Negli studi “umanistici”, un salto notevole dal punto di vista epistemologico oltre che metodologico nell’approccio ai mass media
si ebbe con l’espansione dei cosiddetti cultural studies britannici, che concentrarono l’attenzione sulla ricezione: Raymond
Williams con il suo concetto di flusso televisivo (Williams 1974),
Stuart Hall con il suo lavoro su codifica/decodifica (Hall 1980),
Ien Ang e il suo celebre studio sulla ricezione di Dallas (Ang
1985), David Morley e le sue riflessioni sul consumo televisivo
nella struttura familiare (Morley 1986).
Con l’approccio dei cultural studies, si è imposto come uno dei
temi centrali della discussione il duplice potere dei mezzi di comunicazione di rappresentare l’altro e di produrre quella coesione comunitaria che il lavoro di Anderson (1991) sul nazionalismo
aveva teorizzato come fondata proprio sul ruolo dei mezzi di comunicazione (capitalismo “a stampa”). Secondo Debra Spitulnik
(1993, pp. 295-296) questa attenzione al potere dei mass media
avrebbe prodotto un curioso effetto. Sia la teoria critica di orientamento marxista (che sostanzialmente aveva fatte sue le tesi
dei teorici della Scuola di Francoforte sulla “società di massa”)
sia gli approcci funzionalisti o “positivisti”, che si preoccupavano
di misurare la correlazione tra esposizione mediatica (soprattutto
alla televisione) e concezione del mondo (Gerbner, Gross 1976;
Gerbner et al. 1984; Gerbner 1988), hanno
22
Identità catodiche
Piero Vereni
È proprio di fronte a questo evidente limite dell’analisi testuale
che gli studiosi sempre più chiaramente hanno posto una serie
di questioni teoricamente rilevanti: l’approccio critico-letterario
sull’indeterminatezza intrinseca del senso del messaggio, quello
sociologico sulla frammentazione delle audience e quello semiotico sul processo interpretativo.
Di particolare rilevanza in questo senso è la riflessione dell’antropologia linguistica, in grado di evidenziare la centralità teoretica del contesto e della contestualizzazione come elementi fondamentali della produzione del senso (Duranti, Goodwin, a cura,
1992). Questa nuova attenzione al contesto del messaggio ha
permesso di scardinare la pietra angolare dell’analisi testuale
(“da tavolino”, come la chiama Spitulnik) che era la relazione
diadica tra utente e messaggio. Se ora il ricevente è tale solo in
un determinato contesto di ricezione, l’attenzione analitica si
sposta direttamente su quel contesto, sulla sua delimitazione,
sulla possibilità di coglierne le determinanti. La parola chiave,
quando si assume questa prospettiva, non può che essere una:
etnografia.
Il vantaggio immediato di questo approccio (che, abbiamo visto,
nasce come esigenza dettata da questioni teoriche) è la sua pretesa antiteoricità: l’etnografia dei media diventa il fondamento
empirista a cui rivolgersi in una fase in cui la riflessione teorica
rischia di piegarsi su se stessa. È più o meno a questo punto del
dibattito (quando cioè le questioni linguistiche sollevate dall’antropologia americana si incrociano con le questioni politiche dei
cultural studies britannici) che possiamo iniziare a parlare a pieno titolo di antropologia dei mass media, intesa come posizione
epistemologica (rapporto tra cultura come esperienza e cultura
come rappresentazione) e chiaro approccio metodologico (qualitativo, interpretativo e su piccola scala di interazione, etnografia,
appunto).
L’attenzione sempre più consapevole alla dimensione agentiva
dei soggetti ha prodotto diversi lavori interessati anche a contesti non occidentali, tra i quali ricordiamo come particolarmente significativi lo studio comparativo sulla ricezione di Dallas
(Liebes, Katz 1990), che ovviamente prendeva le mosse dalla
La critica culturale e le forme mediatiche dell’appartenenza
Con tutte le precisazioni finora avanzate, resta il fatto che fino
alla fine degli Ottanta antropologia socio-culturale e mass media
si sono incrociati soprattutto attorno a due questioni:
1. L’utilizzo da parte degli antropologi dei mezzi elettronici di
riproduzione audiovisiva e la discussione teorica sulla natura
politica e retorica di questo utilizzo. Si tratta, in questo caso,
del filone dell’antropologia visuale, che ha un percorso sostanzialmente autonomo rispetto a quanto stiamo dicendo in queste pagine;
2. Soprattutto negli Stati Uniti, il modo in cui l’antropologia viene “divulgata” attraverso i mezzi di comunicazione di massa, in
particolare la televisione.
23
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
già citata indagine di Ien Ang (1985), e il lavoro di Eric Michaels
sulla rappresentazione estetica degli indigeni australiani, che
includeva a pieno titolo la produzione video degli stessi
(Michaels 1994).
C’è da dire, a riguardo della dimensione etnografica, che qualcuno ha espresso serie perplessità sulla legittimità di connotare in
questo senso la nuova ricerca centrata sulla ricezione, soprattutto quando l’“etnografia” è finita per coincidere ancora una volta
con l’analisi testuale o con la pratica di intervistare gli spettatori
a casa, senza che vi fosse una vera osservazione partecipante intesa in quanto tentativo di recuperare il consumo mediatico come parte della “cultura come esperienza”. A questa etnografia
manca quindi, secondo queste critiche, la capacità di inserire il
consumo mediatico nel quadro effettivo delle pratiche sociali
(Evans 1990). Per di più, Spitulnik (1993, p. 298) fa notare come
ancora all’inizio degli anni Novanta buona parte di questa sedicente etnografia dei media non tenesse in alcun conto la posizione dell’etnografo nell’elicitazione dei dati, per cui le dichiarazioni degli intervistati venivano prese come dati di fatto, e in generale trascurasse la questione della riflessività, che tanta importanza stava assumendo in quegli anni.
Piero Vereni
Identità catodiche
24
Per quanto apparentemente secondario, questo secondo punto
ha invece costituito un ponte interessante con le tematiche che
stiamo cercando di inseguire in queste pagine. Il modo in cui la
televisione racconta l’antropologia è solo un caso particolare del
problema più generale di come i mezzi di comunicazione di massa mediano la differenza culturale, rappresentano la diversità, offrono forme di categorizzazione culturale. Spitulnik (1993, p. 300)
a questo riguardo dichiara:
Per esempio, le analisi dell’orientalismo e dello “sguardo oggettivante” nella fotografia coloniale, nella letteratura di viaggio, nel turismo,
nelle fiere mondiali e nei musei (…) si applicano altrettanto bene alla
costruzione dell’“alterità”, del “primitivo” e dell’“esotico” nei notiziari, nel fotogiornalismo, nei fumetti, nella fantascienza e nei film di
successo.
In Italia, la riflessione su questi temi è stata precoce (cfr.
Lombardi Satriani 1975) e si è di recente sedimentata in uno studio di Letizia Bindi (2005) che ricostruisce criticamente la storia
del materiale audiovisivo archiviato alle voci “folklore”, “tradizioni”, “antropologia” e “etnologia” presso le Teche Rai5.
Come quindi l’antropologia ha iniziato a “osservare il proprio
sguardo”, per così dire, così può applicare quello stesso armamentario critico alla decostruzione delle retoriche di produzione dell’identità e dell’alterità che circolano attraverso i media
ordinari, dal museo alla televisione. Studi come quelli di James
Clifford (1988; 1997) e, si parva licet, i saggi presentati in questo volume si caratterizzano proprio per essere analisi antropologiche (pur senza essere etnografie) in questo senso: decostruzioni delle forme culturali di produzione dell’identità, dell’appartenenza e dell’alterità veicolate da mezzi di comunicazione di massa.
Il limite evidente di questo tipo di analisi, tuttavia, è quello di
essere ancora profondamente radicate nell’approccio testuale e
contenutistico, offrendo poca attenzione alla circolazione sociale
e agli effetti “ordinari” di quelle rappresentazioni. La lettura interpretativa emerge avulsa dal contesto e dalle pratiche d’uso,
25
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
rendendo quindi impossibile ricostruire empiricamente la questione del processo interpretativo come pratica di potere.
Su questo tema, il dibattito è stato spesso letto come un alternarsi sistematico, quasi il movimento di un pendolo (Askew
2002, p. 8), tra posizioni teoriche che privilegiavano il potere del
produttore di imporre il suo messaggio e altre prospettive che
invece hanno insistito sul potere delle audience di interpretare
quel messaggio secondo le proprie categorie; tuttavia, oggi questa lettura ciclica tende a essere sostituita con una versione “a
compresenza”, secondo cui le diverse opzioni interpretative sugli
effetti dei media e sul ruolo agentivo delle audience sono sempre convissute (Wolf 1992, pp. 31-50).
Ma la questione degli “effetti dei media” ha un ulteriore risvolto,
più attento agli aspetti di macropolitica dei media che non alle
conseguenze sui singoli soggetti. Si tratta della dimensione
preoccupata dell’imperialismo culturale che la diffusione dei media su scala planetaria potrebbe implicare. Molti autori hanno
cioè avanzato l’ipotesi (spesso sostenuta con la certezza di una
tesi) che l’imperialismo economico abbia come suo risvolto necessario l’imperialismo culturale; questo nesso tra dipendenza
economica e dipendenza culturale sarebbe tanto più ovvio quanto più il bene in gioco è di natura semiotica6. In realtà, i dati a
nostra disposizione dimostrano che la faccenda è estremamente
più complicata: a fianco di Hollywood è cresciuta Bollywood
(Srinivas 2002; Banaji 2006) e ora anche l’africana Nollywood si
sta facendo strada, in particolare a partire dalla Nigeria (Larkin
2008). Le telenovelas del Centro e Sud America sono una realtà
produttiva consolidata e pluridecennale. Il consumo di fiction aumenta in tutto il mondo, ma non decrescono le produzioni nazionali, e tutti i dati di cui disponiamo ci segnalano una complessa
articolazione produttiva cui fa riscontro una gestione del consumo mediatico ancora più frastagliata7.
La domanda se i media sottraggano o invece offrano strumenti
di potere ai soggetti che li usano (se i media siano dunque uno
strumento di oppressione o di empowerment, per usare un termine in voga) è del tutto oziosa se non viene contestualizzata, e
un modo empirico per riformularla è quello di porla in relazione
26
Identità catodiche
Piero Vereni
al ruolo della tecnologia nella conformazione delle identità collettive. Il punto su cui riflettere diventa quindi se e in che misura
la tecnologica (e la sua innovazione) comporti forme sociologicamente innovative di aggregazione, se insomma vi sia una correlazione (e di quale natura) tra appartenenze culturali e mass media. Una volta che si sia indagata questa relazione più generale
sarà possibile stabilire chi detenga il potere di articolare questa
relazione, e a quali condizioni.
Già Arold Innis (1950) aveva posto direttamente la questione,
che McLuhan riprende nel 1964 quando inventa la formula “il
mezzo è il messaggio” (McLuhan 1964). In quel saggio McLuhan
individua con estrema precisione il nesso che lega il senso di appartenenza collettiva alla possibilità di veicolare il sentimento di
una comunità attraverso l’uso dei mass media, anticipando quindi di un ventennio il lavoro di Benedict Anderson sul ruolo del
capitalismo “a stampa” (Anderson 1991).
Anderson, a sua volta, apre lo spazio da un lato a una riflessione sistematica sul ruolo dei media nella produzione identitaria
nel contesto globale (Appadurai 1996; Hannerz 1992; Hannerz
1996; Tomlinson 1999), dall’altro a un’etnografia dei media che
sia finalmente attenta all’uso dei mass media da parte delle culture cosiddette “di interesse antropologico”.
È a questo punto che si impone negli studi antropologici una riflessione sistematica su quelli che Faye Ginsburg (1991) ha cercato di definire indigenous media. Dalla fine degli anni Settanta,
infatti, con la commercializzazione delle videocamere e dei videoregistratori a cassetta, crolla il costo di produzione di materiale video, e la diffusione dei satelliti per le telecomunicazioni
abbatte i costi di distribuzione di quelle immagini, consentendo
il downlink del segnale televisivo in aree (come il deserto australiano o la foresta amazzonica) che non erano mai state raggiunte
dalla radiodiffusione circolare (“via etere”) a causa dei costi assolutamente proibitivi di ripetizione del segnale per via terrestre.
Grazie quindi a queste innovazioni tecnologiche che consentono
produzione e distribuzione di immagini a costi estremamente ridotti, le “prime nazioni” o i “nativi” che spesso vivono ai margini
degli Stati nazionali possono elaborare nuove forme di rappre-
Quel che è veramente in gioco non è tanto la preservazione della
“cultura”, non occidentale o occidentale, ma l’acquisizione di potere
(empowerment) da parte degli attori sociali, – qualunque sia il loro
livello di “purezza” culturale, definito secondo qualunque unità di misura – per produrre le loro specifiche mediazioni culturali (Turner
2002, p. 80).
Al di là delle diverse posizioni, è notevole che nel corso degli
anni Novanta, sempre più, l’antropologia dei mass media passi
dall’essere una curiosità da sfoggiare ai convegni con l’ennesimo (e letteralmente perverso) gusto esotizzante ad ambito di-
27
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
sentazione della propria specificità culturale e nuove forme di comunicazione delle loro rivendicazioni. I lavori di Terence Turner
(1991; 1992) con i kayapo dell’Amazzonia, quelli di Eric Michaels
(1986) con gli aborigeni australiani e la teorizzazione di Faye
Ginsburg costituiscono uno dei fuochi di interesse più evidenti di
un’emergente antropologia dei media.
Possiamo soprassedere sulla discussione se sia o meno possibile
individuare in modo non equivoco lo spazio degli indigenous
media, mentre vale la pena di evidenziare una questione che si
pone immediatamente nel momento in cui gli indigeni passano
dall’altra parte della telecamera, vale a dire la questione dell’autenticità. Sia Turner che Michaels, in effetti, hanno attivamente
contribuito all’introduzione delle tecnologie di riproduzione elettronica tra le popolazioni indigene di loro interesse, e questo li
ha esposti alla critica di aver inquinato la purezza culturale di
queste popolazioni. La risposta di questi autori è particolarmente
interessante, dato che si colloca al centro di una serie di dibattiti
estremamente accesi nell’attuale panorama antropologico.
Michaels (1994) ha sostenuto che il suo compito non è quello di
stabilire cosa sia e cosa non sia autentico delle culture aborigene, ma registrare il dibattito indigeno sull’autenticità (MacCannell
1973; Bendix 1997): da strumento di analisi, l’autenticità diventa
anche attraverso l’antropologia dei media un oggetto di analisi.
La posizione di Terence Turner è invece più vicina all’approccio
engaged postcoloniale:
28
Identità catodiche
Piero Vereni
sciplinare “normale”, che si inserisce nel quadro complessivo
della riflessione antropologica sui nessi tra strutture sociali e
spazi simbolici.
Si può ripercorrere quasi passo passo questo cammino di definitivo assestamento dell’antropologia dei media nello sviluppo del
percorso di ricerca di Lila Abu-Lughod. Un percorso iniziato nel
più canonico dei modi: un lungo periodo di ricerca per il PhD tra
un gruppo particolarmente marginale, vale a dire una comunità
beduina dell’Egitto. La giovane antropologa americana (ma di padre palestinese di Giordania) si inserisce in questa comunità locale a fine anni Settanta per studiare le ghinnawa, poesie improvvisate tipiche della cultura beduina in cui vengono espressi
stati d’animo e sentimenti che il codice morale esplicito non
sembra riconoscere. Da questa ricerca Abu-Lughod trarrà un’etnografia (Abu-Lughod 1986) che da allora è diventata un piccolo
classico. Il tema tradizionale della ricerca si accompagna alla
convinzione (altrettanto canonica in molta ricerca antropologica)
di studiare un soggetto fragilmente esposto alla bufera della modernizzazione:
Avevo pensato, quando lasciai l’Egitto nel 1980 dopo il mio primo
periodo di ricerca, che il tipo di poesia tradizionale beduina che stavo studiando fosse in via di sparizione. Gli adolescenti che conoscevo non cantavano né recitavano quella forma poetica e iniziavano a
preferire, o almeno ad ascoltare, canzoni egiziane trasmesse alla radio. Gli anziani mi spiegavano che le poesie e le canzoni [tradizionali] stavano sparendo perché non vi erano più occasioni per recitarle o
cantarle. I matrimoni erano diventati celebrazioni separate per maschi e femmine, che duravano solo un paio di giorni: niente a che
vedere con le feste di una settimana durante le quali uomini e donne
si scambiavano canzoni. I giovani non le imparavano più (AbuLughod 1989, p. 9).
La prima comparsa dei media nel lavoro di Abu-Lughod, dunque,
è quella che ci si aspetterebbe da un “buon” antropologo, preoccupato della sopravvivenza della cultura che studia: la radio impone ai giovani i propri stili musicali nazionalmente uniformati e
soppianta la diversità locale, che inevitabilmente andrà a sparire.
Da quel momento, è stato inevitabile per Abu-Lughod aprire un
nuovo e proficuo filone di ricerca, che l’ha portata a indagare
con cura e profondità il rapporto tra la rappresentazione mediatica della nazione e dei suoi obiettivi e le pratiche culturali locali
di consumo di quella rappresentazione, soprattutto per quanto
riguarda la fiction televisiva, in un percorso che ha trovato di recente un compendio monografico che sintetizza quindici anni di
intensa ricerca sul campo (Abu-Lughod 2005). Ne emerge un
quadro analitico in cui l’etnografia assume una dimensione decisamente multisituata8, in cui cioè la pratica della ricerca sul campo non si confina dentro uno spazio percepito come chiuso e
isolato, ma anzi ha il coraggio di inseguire diversi campi di forze,
dal contesto produttivo (sceneggiatori e produttori nei grandi
centri urbani) a quello di fruizione, sia nella classe proletaria delle medesime grandi città, sia nei ceti contadini nella provincia.
Lo scopo della ricerca, a questo punto, diventa proprio la ricostruzione del rapporto costante tra forme della rappresentazione
e forme della vita quotidiana: non si tratta più di un’antropologia
dei media costretta a giustificare la propria esistenza, ma di
un’antropologia culturale che non ha più paura di guardare ai
media come strumenti della produzione dell’immaginario, oltre
che delle immagini.
Oggi esistono raccolte dedicate esplicitamente all’antropologia
dei media (Ginsburg, Abu-Lughod, Larkin, a cura, 2002; Askew,
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
Ma avevo sottovalutato l’impatto della diffusione dei mangianastri a
cassette. Per la metà degli anni Ottanta, una serie di cassette quasicommerciali di cantanti beduini semiprofessionisti, quasi tutti giovani
maschi, avevano iniziato a sentirsi ovunque e passavano alacremente di mano in mano. Questi divi locali avevano addirittura iniziato a
fare concerti ai matrimoni, con le loro canzoni cantate a squarciagola
in microfoni alimentati a batterie. Una simile novità ha rivitalizzato
l’interesse dei giovani beduini per queste forme culturali, e tutti hanno preso a registrare le proprie canzoni (ib.).
29
Ma è proprio quando i primi indizi sembrano confermare tutti i
timori della studiosa che lo scenario cambia:
Piero Vereni
Identità catodiche
30
Wilk, a cura, 2002), molte altre che affrontano i media studies
con un approccio metodologico e un impianto di fondo profondamente influenzati dall’antropologia (Parks, Kumar, a cura,
2003; Bailey, Georgiou, Harindranath, a cura, 2007), e a fianco
delle tradizionali riviste antropologiche le ricerche di antropologia dei media trovano buona accoglienza in riviste storiche di
media studies come «Media, Culture and Society».
Se quindi all’inizio degli anni Novanta Debra Spitulink, in quella
che probabilmente è la prima rassegna bibliografica sul tema,
poteva dire che “ancora non esiste un’antropologia dei media”
(Spitulnik 1993, p. 3) oggi la situazione è radicalmente mutata, e
sono molti gli antropologi che hanno come loro centro d’interesse il sistema delle comunicazioni e le sue implicazioni nel quadro più vasto della cultura.
Antropologia dei media in Italia
In Italia c’è di recente una notevole attenzione attorno a questo
tema. A parte l’antropologia visuale intesa come l’uso della strumentazione audiovisiva per l’indagine antropologica e la susseguente riflessione teorica, di cui, come ho ribadito, non intendo
occuparmi – dato che ha una storia ormai antica all’interno dell’antropologia italiana ma sostanzialmente autonoma dal centro
di interesse di queste pagine9 –, e senza inseguire ovviamente i
moltissimi lavori di massmediologi che oggi tengono in considerazione le tematiche e le metodologie antropologiche per studiare i mezzi di comunicazione di massa, vanno segnalati quegli
studi di analisi dei media condotti direttamente da antropologi o
quegli approcci alla comunicazione più direttamente partecipi del
progetto antropologico soprattutto per quanto riguarda la metodologia di ricerca etnografica.
Alcuni sociologi hanno ad esempio introdotto nella loro metodologia di ricerca l’etnografia, facendone un caposaldo di una rinnovata analisi dei media che sappia superare un troppo rigido testualismo (o un altrettanto rigido economicismo) in favore di una nuova
attenzione per le pratiche di ricezione e consumo (Boni 2004).
Si tratta di un desiderio che l’altro ci sia – non importa che l’altro
poi arrivi in carne e ossa, importa invece che ci sia ora, immediatamente – è questo l’impulso che spinge ad alzare la cornetta e comporre il numero. Ti voglio “ora!”, in questo preciso istante, e non voglio prolungare l’attesa (La Cecla 2006, p. 7).
Lo stimolo a questo tipo di riflessione, che dal telefonino si
estende a tutto l’universo dei mezzi di comunicazione di massa,
viene dalla convinzione che nelle analisi attuali manchi “un’analisi approfondita del loro carattere rituale, della ritualità quotidiana, della fede insomma, che i media presuppongono” (p. 14).
In realtà, non si può dire che manchi una riflessione sistematica
su questa specifica dimensione dei mezzi di comunicazione di
massa, e lo stesso La Cecla cita una raccolta di saggi di antropologia dei media (Rothenbuhler, Coman, a cura, 2005) che dà ampio spazio alla dimensione genericamente religiosa dell’universo
mediatico10.
Per quanto riguarda le pubblicazioni italiane dedicate al rapporto
tra religione e media, si deve sicuramente citare il lavoro di
Paolo Apolito (2002). Il libro ricostruisce – con dovizia di dati
raccolti in quella che possiamo definire una vera etnografia in internet, oltre che di internet – il ritorno della dimensione dello
sguardo nel mondo cristiano, in particolare in quello cattolico,
grazie alla disponibilità dei nuovi mezzi di riproduzione e trasmissione dei messaggi visivi, consentendoci così una prospetti-
31
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
Un lavoro che, pur lontano da pratiche tradizionali di
fieldwork, affronta esplicitamente la dimensione simbolica dei
mezzi di comunicazione di massa, instaurando un confronto
tra diverse forme di consumo nel mondo senza dare alcuna
priorità morale all’Occidente, è la raccolta di felici intuizioni di
Franco La Cecla (2006). Attraverso rapidi scorci etnografici sull’uso del telefono cellulare, il consumo televisivo in Vietnam o
il ruolo della pornografia nel delicato rapporto tra “realtà” e
internet, La Cecla cerca di aprire uno spazio per riflettere teoricamente sui media come macchine per realizzare la promessa
di una possibilità di presenza:
va privilegiata sullo stato attuale di quella che Apolito chiama
“cultura visionaria cattolica”
che mescola apparizioni e Internet, immagini piangenti e televisione,
stigmate sanguinanti e laboratori scientifici, soli roteanti e telecamere digitali, nubi misteriose e macchine fotografiche di telescopi avveniristici, divinazioni e fax: insomma, nello stesso tempo religiosità
miracolistica e neo-barocca e uso massiccio di apparati e attrezzature
tecnologici (p. 8).
Piero Vereni
Identità catodiche
32
Il legame tra una religiosità che potrebbe apparire “arcaica” nelle sue espressioni e le punte più avanzate dell’high tech è garantito, secondo l’autore, dalla comune attenzione alla dimensione visiva:
D’altronde, se, come si esprime Paul Virilio11, la nostra è l’epoca di
un “regime della visualizzazione generalizzata” o del “voyeurismo
universale”, come potrebbe il visionarismo religioso, che da sempre
ha fatto della vista il suo senso privilegiato, non essere attratto dalle
enormi possibilità di espansione insite nell’incontro con le risorse
tecnologiche che amplificano “lo spessore ottico delle apparenze del
mondo reale”? (p. 9).
Sull’uso “desiderante” della tecnologia – scatola magica di passioni infantili o represse più che algido strumento per rendere
più efficiente la comunicazione –, in particolare per quanto riguarda il telefono, strumento cui La Cecla presta notevole attenzione, un saggio sperimentale è contenuto nell’ultimo capitolo
di Cyberspiders di Clara Gallini, intitolato Impossibili telefonici
congiungimenti (Gallini 2004, pp. 135-163). Di questo volume si
deve citare anche il primo saggio (pp. 17-67), che dà il titolo alla raccolta, in cui l’autrice indaga a fondo il mondo delle truffe
via internet, in particolare quelle e-mail con sedicente mittente
africano che avrebbe una fortuna da esportare e che vorrebbe
condividere con il destinatario. Si tratta di un’indagine estremamente “partecipata”, in cui l’etnografa cede alla richiesta di contatto per verificare le modalità comunicative con cui la truffa
prova a realizzarsi.
33
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
La stessa autrice ha dedicato una specifica attenzione antropologica ai mass media in altri lavori, tra cui ricordiamo il saggio in
cui prende in considerazione i lungometraggi cinematografici e le
fiction mandate in onda dalle reti televisive nazionali (allora Rai,
Fininvest e Telemontecarlo) nella stagione televisiva 1992-1993 e
aventi come ambientazione “l’Oriente” nella sua accezione più
generale (Gallini 1995). L’intento è quello di ricostruire il quadro
ideologico dell’Orientalismo nostrano veicolato dalla televisione
a ridosso della prima guerra del Golfo. Il tema dell’immagine
dell’Oriente nella televisione (questa volta nell’intrattenimento
non fiction) costituisce anche il nucleo dell’analisi testuale di
Enrico Sarnelli (1995), pubblicata nella medesima raccolta. Al
ruolo della televisione nel “mediare” il Ramadan in una comunità
musulmana immigrata in Sicilia è dedicato il lavoro di Piero
Cipriano (2005), che quindi si occupa prevalentemente della ricezione e del consumo della televisione satellitare.
Altri lavori che vedono invece un incrocio profondo tra antropologia e internet sono quelli di Alessandra Guigoni, che da un lato
si preoccupa di questioni metodologiche e di documentazione
(Guigoni 2001; 2004; Guigoni, Amaducci 2002), dall’altro propone esempi di etnografia nella Rete e del rapporto tra relazioni
sociali virtuali e de visu (Guigoni 2002; 2003).
Per tornare invece al quadro teorico, che si inserisce nel filone
più vicino ai critical studies, a questo possiamo avvicinare anche
le riflessioni sul tema elaborate in diversi numeri della rivista
«Avatar» e nell’impostazione di Massimo Canevacci (1995; 1999).
Per Canevacci, che utilizza il quadro post-marxista degli -orami di
Appadurai, i mass media sono il canale attraverso cui si libera
definitivamente il rapporto tra merce e lavoro incorporato, il passo dunque che produce il salto definitivo al “feticismo delle merci”, che deve essere indagato con un corrispondente “feticismo
metodologico”. Sempre al quadro teorico generale sul “senso”
dei mass media possiamo ascrivere anche le considerazioni di
Franco Lai sul ruolo della comunicazione di massa nel processo
di globalizzazione (Lai 2006). Nelle sue riflessioni sulla creatività
e le sue condizioni sociali, Lai inserisce il discorso sui mass media in un quadro più ampio, che indaga il rapporto tra globaliz-
34
Identità catodiche
Piero Vereni
zazione e localizzazione soprattutto nel terzo capitolo,
Globalizzazione e flussi culturali (pp. 53-96).
Riprendendo gli stimoli teorici avanzati da La Cecla, un chiarimento importante sul ruolo dei mass media nel determinare le
forme della vita quotidiana si ha in una riflessione apparentemente tangenziale, ma di fatto centrale per come il tema viene
impostato. Mi riferisco al testo che Ugo Fabietti (2008) ha letto
al primo convegno nazionale dell’Anuac.
In questo denso intervento, Fabietti ci offre uno strumento importantissimo per le nostre ricerche. L’antropologia, oggi alla ricerca di una sua ennesima legittimazione, può infatti trarre beneficio dal porsi come obiettivo lo studio della contemporaneità intesa non tanto come presente o modernità, ma secondo l’accezione che ne ha dato Alfred Schütz:
una specie di simultaneità di vissuti immaginati piuttosto che un
segmento di temporalità storica. Ricordo che Schütz definì la situazione di contemporaneità come quella in cui “l’alter ego non mi è
dato in carne e ossa, quindi in una immediatezza spaziale e temporale, ma ciononostante io so della sua coesistenza con me e del decorso contemporaneo dei suoi vissuti di coscienza con i miei”; dove
“Questo so – aggiunge Schütz – è sempre mediato” da qualcosa
d’altro (Fabietti 2008).
Questa definizione di contemporaneità non si sofferma quindi
sull’adeguamento a una serie di norme o pratiche, ma sulla percezione di condivisione di orizzonti tra ego e alter in absentia e
sulle forme che può assumere storicamente questa condivisione.
Il “paradigma della contemporaneità” è quindi il modo in cui, effettivamente, per ogni sistema culturale e in ogni dato momento
storico, viene percepita, vissuta e resa significativa la coesistenza tra soggetti senza compresenza fisica. Non possono non venire in mente da un lato le comunità immaginate di Benedict
Anderson, dall’altro le comunità diasporiche di cui parla l’antropologia da tempo (Clifford 1997; Bailey, Georgiou, Harindranath,
a cura, 2007). Ma mentre in queste concezioni recenti la contemporaneità è sostanzialmente un effetto collaterale (se non una
35
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
premessa) della modernità, il punto forte della posizione assunta
da Fabietti con il riferimento alla contemporaneità di matrice
schütziana è la possibilità di separare completamente l’idea di
coesistenza in assenza da quella di modernità. Il valore euristico
di questa rielaborazione originale del concetto di contemporaneità sta proprio nella sua applicabilità pressoché universale.
Sempre e in ogni luogo le culture umane hanno dovuto risolvere
il “problema culturale” di stabilire la relazione tra i propri soggetti presenti hic et nunc e gli assenti: possono essere i morti,
gli ancora non nati, i partiti o i distanti, ma qualunque cultura,
anche di dimensioni molto esigue, ha dovuto rispondere a questa domanda di base: qual è il rapporto che intercorre tra i soggetti compresenti e i soggetti assenti ma coesistenti?
La risposta a questa domanda dipende sostanzialmente da due
fattori:
1. Dalle specifiche concezioni culturali di coesistenza. Ciò sta a
significare che ogni cultura determina cosa si debba intendere
per coesistenza in base al proprio sistema di valori e di credenze. Se ad esempio i morti sono considerati coesistenti in un altro
piano del reale, il rapporto con loro dovrà essere concepito in
questo spazio della contemporaneità come lo stiamo delineando.
2. Dalle condizioni tecnologiche di comunicazione, dato che essere in grado di comunicare a distanza muta radicalmente il rapporto tra presenti e assenti. In una società in cui non esista la
scrittura le opportunità per concepire la coesistenza sono necessariamente limitate. In questa prospettiva, i mezzi di comunicazione elettronici sono strumenti potentissimi per estendere e intensificare la contemporaneità di cui stiamo parlando.
La contemporaneità così concepita separa il concetto di “simultaneità” dalle rigidezze cui forse l’ha costretta la pur felice teorizzazione di Anderson della nuova concezione del tempo resa disponibile dalla sua frammentazione in unità astratte ed equivalenti, dal romanzo borghese e dai giornali. È vero che con la diffusione del capitalismo “a stampa” si apre una fase decisamente
originale di organizzazione sociale dei sistemi politici che può fare emotivamente leva sul senso di compartecipazione dei cittadini (soprattutto borghesi, per molti decenni) a una medesima co-
36
Identità catodiche
Piero Vereni
munità immaginata, ma questa esigenza di immaginarsi parte di
una comunità più vasta non nasce certo con il capitalismo a
stampa, come riconosce lo stesso Anderson quando insiste sul
legame che unisce le nuove comunità immaginate nazionali all’ecumene della cristianità da un lato e alla prospettiva politica
dell’Impero dall’altra.
In breve, la concezione di contemporaneità che ci propone Ugo
Fabietti consente di raffinare ulteriormente la riflessione di
William Mazzarella (2004) sui moderni mass media come una forma attuale di quell’inevitabile processo di mediazione che chiamiamo cultura.
Passando ora dal quadro più strettamente teorico ad alcuni assaggi etnografici, la rivista «Achab» (2005, n. 6) ha pubblicato
un “Dossier Antropologia e Media” in cui sono presentate diverse
ricerche, con molteplici approcci: si passa dall’analisi testuale di
prodotti cinematografici come indicatori di un discorso politico
(Martegani 2005) al ruolo dei mezzi di comunicazione nel trattenere i fili di una famiglia “diasporica” (Negro 2005); da etnografie dello spazio, mediatico o mediato (Gianoncelli 2005; Bottelli
2005), a riflessioni sul ruolo della fiction nella costruzione delle
identità nazionali e religiose (Trimarchi 2005).
Il dossier è introdotto da una nota su “Etnografia e media” redatta da Monica Fagioli e Sara Zambotti (2005), che sono anche
le curatrici di un reader (Fagioli, Zambotti, a cura, 2005) che ha
offerto ai lettori italiani la possibilità di conoscere saggi importanti e contesti etnografici poco noti nel nostro paese.
Un altro testo che consente ai lettori italiani di leggere importanti autori stranieri a cavallo tra ricerca con le immagini e antropologia delle immagini è la raccolta di saggi in traduzione
(tranne il pezzo di Roberta Altin [2004a] sulla comunità ghanese residente in Friuli) curata da Cristina Balma Tivola (2004)
che introduce i lettori italiani ad alcune recenti tematiche dell’antropologia visuale, soprattutto per quanto riguarda la relazione tra autore e soggetto rappresentato: in che misura il soggetto entra nella produzione? Quali sono le condizioni di “reciprocità” e “collaborazione” tra l’antropologo e i nativi rappresentati? Che spazio sussiste per un’antropologia visuale indige-
Si tratta, com’è evidente, di una definizione alquanto complessa,
che unisce diversi prodotti e diverse forme di produzione, il cui
tratto unificante sembra comunque essere l’estraneità ai “grandi”
circuiti produttivi e distributivi tipici del broadcasting (commerciale e di servizio pubblico) e oggi anche al narrowcasting delle
soluzioni che richiedono una qualche forma di pagamento a sottoscrizione (pay per view, abbonamento, on demand, ecc.).
Un altro filone di ricerca è quello invece che proviene dalla linguistica antropologica, che propone un nuovo approccio, profondamente contestualizzante (Duranti, Goodwin, a cura, 1992), al
“testo mediatico” e quindi ha incorporato molte delle critiche dei
cultural studies al “vecchio” modello di analisi dei media. Per
questo filone, un lavoro indicativo è quello proposto da
Vincenzo Matera (2002).
Ma oltre a questi lavori innovativi che inquadrano il rapporto
tra antropologia e media dal punto di vista teorico, con brevi
squarci etnografici o conducendo la ricerca quasi esclusivamente su internet, diversi e interessanti sono i lavori di antropologi
italiani che hanno indagato, con ricerche etnografiche più vici-
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
quelle produzioni audiovisive, estranee ai sistemi ufficiali di produzione e distribuzione videocinematografica di grandi dimensioni, che
vedono protagoniste minoranze etniche/culturali (popolazioni native,
comunità di migranti) – o comunità sociali svantaggiate identificabili
con connotazioni culturali – sia come soggetti di queste produzioni,
sia come autori/produttori (con o senza la collaborazione di ricercatori sociali e/o altri professionisti della documentazione audiovisiva)
(Balma Tivola 2004, p. 9).
37
na? In questa prospettiva, l’antropologia visuale affronta le
stesse questioni sulla rappresentazione (le retoriche) e sull’autorialità (le politiche) che l’antropologia in generale si pone ormai da un quarto di secolo.
L’introduzione della curatrice si segnala inoltre almeno per un
punto metodologico, vale a dire la definizione di small media, un
concetto che torna utile nella teorizzazione dell’antropologia dei
mezzi di comunicazione di massa. Sono dunque small media
38
Identità catodiche
Piero Vereni
ne alla tradizione metodologica, il ruolo dei media nella produzione dell’identità collettiva. In questi lavori si nota più chiaramente il passaggio di attenzione dal “testo” al consumo del
medesimo nella vita quotidiana, con un corrispondente slittamento, da parte del ricercatore, dalla posizione di “critico testuale” a quella di “etnografo” impegnato in un “esperimento
di esperienza” (Piasere 2002).
Massimo Canevacci Ribeiro (2007) dal Brasile riporta un’accurata
ricostruzione etnografica del “tradizionale” funeral bororo, e in
questa rappresentazione, che si avvale di immagini fotografiche,
include uno degli strumenti oggi impiegati dai bororo per la trasmissione intergenerazionale della loro cultura, vale a dire la videocamera. Emblematica la didascalia della foto riprodotta a pagina 155: “Il gioco degli specchi della rappresentazione: Paulinho
filma il canto [funebre] di José Carlos, Sergio filma Paulinho, io
fotografo Paulinho e Sergio”, che sintetizza un gioco complesso
di rimandi anche teorici:
In tal modo le potenzialità degli sguardi interni ed esterni si arricchiscono reciprocamente e autonomamente in un gioco di rifrazioni continue che mutano la documentazione dell’antropologia visuale classica (e monologica). Paulinho, Sergio e io incrociamo le nostre tecnologie visuali e polifoniche, documentando il senso del procedimento
rituale (pp. 154-155).
Martina Giuffrè dedica al consumo televisivo parte del suo studio
sulla narrazione della femminilità a Capo Verde (Giuffrè 2007) e
si sofferma sulla fruizione da parte delle donne capoverdiane di
una telenovela brasiliana, Terra nostra, trasmessa anche in Italia.
Particolarmente evidente risulta la lettura contestualizzante che
le spettatrici danno del racconto: benché tratti di immigrati italiani in Brasile a fine Ottocento, le donne capoverdiane hanno la
possibilità di leggere quei lontani eventi come metafore della loro condizione, in particolare per quanto riguarda i rapporti di genere e la struttura delle relazioni di coppia. Nel testo risulta inoltre evidente come il mezzo televisivo diventi parte inevitabile
dell’interazione etnografica:
Le origini del concert party riportano all’Africa e alla cultura orale
precoloniale, ma il prodotto finale è un precipitato dei vari flussi culturali che hanno in qualche modo modificato la cultura ghanese nell’ultimo secolo: gli Stati Uniti e la tratta degli schiavi, le varie potenze europee che si sono contese il predominio coloniale, e, più recentemente, tutta la cultura di diaspora. Nella vecchia colonia inglese
denominata Gold Coast negli anni ’20 iniziarono queste forme di
spettacoli di varietà comici che mescolavano diverse influenze cultu-
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
Roberta Altin rimane invece in Italia, ma per raccontare le molteplici funzioni che i mezzi di comunicazione svolgono tra i membri
della comunità ghanese del Friuli-Venezia Giulia (Altin 2004b).
Questa monografia, estremamente accurata nella descrizione etnografica, risulta particolarmente interessante perché sprovincializza rapidamente l’approccio di ricerca alla fruizione dei “media
dell’Altro”. Oltre al consumo di televisione e videocassette, videocamere e internet, la ricerca dedica infatti ampio spazio all’analisi di un medium che non ha un corrispondente immediato
nelle tradizioni di consumo cui siamo abituati, e che si chiama
concert party. Si tratta di una sorta di teatro popolare improvvisato su un canovaccio narrativo impregnato di connotazioni morali. Sebbene non particolarmente prestigioso come genere di intrattenimento, riscuote tuttavia un notevole successo di pubblico: i concert party interpretati dagli attori più famosi sono ora
trasmessi anche dalla televisione nazionale ghanese. Sul piano
teorico, la rilevanza di questo “oggetto culturale” risiede nell’essere nato proprio dall’incrocio tra storia coloniale e genealogia
culturale africana:
39
il contatto con italiani ricchi, investitori, turisti sessuali, proprietari
vestiti all’ultima moda è ben lontano dall’immagine che Terra nostra esperança dà dell’italiano, discrepante e quasi agli antipodi.
Interessante notare come Ernestina abbia cambiato atteggiamento
nei miei confronti in seguito a questa telenovela che per me è stata salvifica. Se prima pensava che io fossi ricca ma molto tirchia,
perché secondo lei tutti gli italiani erano ricchi, dopo aver visto
Terra nostra mi ha detto “anche gli italiani sono poveri!” (Giuffrè
2007, p. 192).
Piero Vereni
Identità catodiche
40
rali: dai film americani, alle canzoni latine, dagli spirituals afro-americani ai generi musicali ghanesi asafo e highlife. Dal colonialismo,
passando per l’indipendenza, fino ai giorni nostri, il concert party ha
continuato a incorporare nuovi stili, formati, valori, per adattarsi ai
vari pubblici e alle differenze culturali incontrate, raccontando storie
attraverso la performance improvvisata (pp. 37-38).
Sono ricerche come questa sul consumo dei media che consentono di togliere legittimità a qualunque sguardo esotizzante e di
superare definitivamente l’implicita convinzione che un approccio
maturo al consumo dei media sia una “nostra” prerogativa. Come
si può intuire, il concert party è un’ottima strategia comunicativa
per “giocare con la modernità” (Appadurai 1996) senza divenirne
necessariamente vittime.
Sempre in Italia si colloca l’interessante ricerca di Francesco
Marano (2005), ma con un oggetto legato agli studi di tradizioni
popolari. Si tratta infatti di una raccolta di saggi in cui si analizzano alcuni video prodotti nella provincia di Potenza da soggetti
non professionisti che si sentono parte delle culture rappresentate. Possiamo considerarlo quindi a tutti gli effetti un libro che
riflette sistematicamente ed empiricamente sulla questione degli
indigenous media e sul loro ruolo. Queste autoetnografie, come
l’autore le definisce rifacendosi a un suo precedente saggio
(Marano 1995), non hanno, diversamente dagli indigenous media studiati da Terence Turner e Faye Ginsburg, finalità di azione
politica o l’esigenza di correggere degli stereotipi razzisti, e sono invece intese dai soggetti produttori come un efficace strumento di rivitalizzazione e reintegrazione culturale di alcune
pratiche in disuso.
Nell’analisi emerge chiaramente il ruolo della televisione (in particolare del documentario televisivo) nel costituire una grammatica di riferimento delle autoetnografie, anche per quel che riguarda la dimensione nostalgica e la ricerca dell’autenticità.
Proprio questa consapevolezza della ricerca dell’autenticità da
parte dei soggetti che praticano o sollecitano autoetnografie
spinge Marano a sostenere, in particolare nell’ultimo capitolo,
una tesi interessante e forse generalizzabile oltre il contesto
La cultura materiale tradizionale – le sue attività e i suoi strumenti –
in quest’epoca di visualismo predominante finisce per essere un luogo della memoria privilegiato; fornisce simboli visivi inequivocabili,
laddove la comunità contemporanea è sempre più invisibile ed effimera (…). Così i video costituiscono un tentativo di rimaterializzare e
riterritorializzare la cultura tradizionale in contrapposizione a una
mancanza di visibilità dei confini (culturali, sociali, territoriali) della
comunità e di restituirle una sensorialità, un territorio, un paesaggio,
insomma il suo carattere locale, in alternativa tanto a descrizioni
anestetizzate e “da lontano” quanto a etnografie che invece pongono in maggiore evidenza gli aspetti della globalizzazione e del traffico locale (pp. 149-150).
Per quanto riguarda altre ricerche di oggetto demologico, segnalo inoltre un breve saggio di Giovanni Sole e Rossella Belcastro
sull’uso della televisione negli anni Cinquanta (Sole, Belcastro
2004).
Si tratta di un lavoro sulla vita “tradizionale” di San Giovanni in
Fiore, centro montano nella provincia di Cosenza, e sui sommovimenti culturali prodotti dall’introduzione di alcuni nuovi elettrodomestici, come la radio, la cucina a gas e il televisore.
Gli autori evidenziano il ruolo della radio fin dal suo primo apparire, e anche al cinema viene prestata un’adeguata attenzione nel
segnalarne l’impatto sociale fin dall’epoca fascista delle proiezio-
41
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
etnografico indagato, secondo cui l’obiettivo di questa rappresentazione della “tradizione” in forma visiva corrisponderebbe
anche all’esigenza di ancorare l’identità alla materialità della
propria condizione locale, in un momento in cui la dominanza
del sistema dei mass media (e la rappresentazione che ne offre proprio l’antropologia, con il suo insistere sulla deterritorializzazione e la dimensione globale) sta rendendo “la cultura” un oggetto sempre più sfumato, sempre meno consono a
dare sostanza all’esigenza di appartenere a qualcuno in qualche posto. I video hanno quindi la stessa funzione dei “musei
spontanei”, con in più la possibilità di giocare con la dimensione performativa della cultura e con gli aspetti “privati” della
fruizione domestica:
ni in piazza delle pellicole propagandistiche dell’Istituto Luce
(pp. 18-19); tuttavia, la ricostruzione attribuisce alla televisione il
ruolo principale nell’aver modificato il tessuto sociale del paese:
Piero Vereni
Identità catodiche
42
L’identità collettiva dei sangiovannesi, sottoposta all’influenza del
mezzo televisivo, stava subendo delle forti lacerazioni (…). La struttura etnocentrica che aveva sempre difeso il paese dal mondo esterno,
con la televisione si stava indebolendo; i meccanismi attraverso cui il
sapere appreso si trasmetteva da un individuo all’altro, da una generazione a quella successiva, si stavano definitivamente incrinando. A
San Giovanni in Fiore la memoria collettiva era intaccata dalla televisione (…) il passato veniva dimenticato, la tradizione si dissolveva e
al suo posto si faceva largo la storia (p. 26).
Questa funzione paradossalmente “demartiniana” del televisore
si accompagna a una diffusa aspirazione alla modernità di cui il
nuovo elettrodomestico diventa l’epitome. Ma nella sua prima fase di diffusione, quando è ancora talmente costoso da non essere accessibile se non a pochi, il televisore non è percepito come
causa di isolamento sociale, tutt’altro:
Con la televisione i sangiovannesi cominciarono a ritrovarsi insieme.
Già nel periodo fascista, diverse associazioni dopolavoriste avevano
favorito la fruizione di massa di certi avvenimenti culturali, ma, nell’immediato dopoguerra, c’era stato un richiudersi nella dimensione
familiare e privata. Con la televisione, invece, i paesani ritrovavano il
gusto di stare insieme nei bar, nella sezioni di partito e nelle associazioni (p. 27).
Solo nell’ultima parte del saggio, quando si analizza il sistema
delle merci pubblicizzato e reso disponibile dalla televisione,
sembra emergere nuovamente, e definitivamente, l’anomia individualista della modernità compiuta, che Giovanni Sole del resto
ha raccontato nel suo film del 1999, Fate e transistors.
Un altro caso estremamente interessante e accurato di etnografia
del consumo è quello presentato da un’antropologa americana
ma realizzato in Italia (Dick Zatta 1996). Si tratta di un saggio
molto ben riuscito che studia la ricezione di alcuni programmi te-
43
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
levisivi da parte di una comunità di roma sloveni da tempo insediatisi nell’Italia del Nord.
Utilizzando le ricerche psicologiche di studiosi come Jerome
Bruner e quelle antropologiche di Jack Goody sul ruolo della
scrittura nel produrre conformazioni peculiari di pensiero, l’autrice mette dapprima in evidenza la specificità del gruppo roma
sloveno da lei studiato: la sua cultura legata all’oralità ha una
concezione molto locale della “narrazione”, che deve essere veritiera, informare rispetto a qualche pericolo (è cioè percepita
sempre come funzionale, non “di svago”) e deve comunicare dati
importanti sull’opposizione tra roma e gage (i non zingari). È in
base a questo modello che i roma studiati da Dick Zatta decodificano i programmi della televisione italiana, ed è quindi inevitabile che vi sia uno scarto notevole tra regole di codifica del messaggio e pratiche di decodifica. L’argomento dell’autrice è che dal
largo consumo che i roma fanno di programmi televisivi italiani
non si deve dedurre automaticamente un indebolimento delle loro difese culturali.
L’analisi è condotta sul resoconto che i roma offrono di alcuni
programmi televisivi conversando con la ricercatrice. I telegiornali sono molto vicini alla concezione roma della narrazione per
il loro riferimento alla verità come testimonianza del vissuto e
visto, ma vengono prontamente adattati alle esigenze didascaliche del racconto nella cultura roma. In sostanza, la notizia viene
rielaborata secondo i fini culturali degli spettatori, e tende a dare informazioni precise su come i gage siano inclini a “rubare” e
ad ammazzarsi tra di loro. Nel caso dei film trasmessi, invece, il
concetto di fiction è privo di prestigio presso i roma, per cui il
messaggio del racconto semplicemente non passa, e tutto viene
letto come l’ennesima indicazione della tendenza dei gage a farsi del male tra loro. Quelli che nella struttura narrativa sono i
“buoni” contrapposti ai “cattivi” sono interpretati dai roma sempre come “loro”, esempio di gage che uniformemente praticano
il furto reciproco.
Un punto di contatto tra la fiction dei gage e la narrazione secondo i roma è invece costituito dai serial televisivi come
Dinasty e Falcon Crest. In questo caso, la struttura parentale che
44
Identità catodiche
Piero Vereni
regge il tessuto narrativo delle soap opera diventa un canale di
comunicazione che consente ai roma di decodificare correttamente la fabula, anche se vanno perduti i riferimenti a conflitti di natura politica o economica che non si incardinano sulla parentela.
Il punto conclusivo di questa analisi testuale condotta utilizzando le categorie “emiche” degli spettatori è l’estrema flessibilità
del messaggio mediatico alle esigenze culturali dei riceventi.
A chiusura di questa breve rassegna, è importante segnalare un
saggio che si pone, esempio rarissimo, la questione metodologica di come fare in concreto etnografia dei media (Altin,
Parmeggiani 2007).
Il testo propone l’incrocio di tre approcci per l’analisi di dati di
tipo visivo, nel caso in questione alcuni spot pubblicitari.
Partendo da una ricerca ancora in corso sull’analisi di alcuni spot
pubblicitari – ricerca che ha una forte valenza didattica dato che
coinvolge direttamente gli studenti del corso di laurea specialistica in Linguaggi e Tecnologie dei Nuovi Media dell’Università degli
Studi di Udine e che fa parte del programma DIVA (Digital
Imagine and audio Visual Analysis), che è assieme un progetto di
ricerca e un’esperienza didattica – gli autori propongono di unire
l’approccio semiotico al metodo etnografico e all’analisi qualitativa coadiuvata dal computer.
In sostanza, lo spot da analizzare è stato prima sottoposto a
un’analisi di tipo strettamente testuale (nel caso specifico utilizzando la griglia del quadrato semiotico di Algirdas Greimas).
Alcuni studenti hanno poi condotto interviste semistrutturate per
ricostruire il quadro interpretativo degli spot e per estendere per
quanto possibile il contesto del loro uso:
Le domande molto semplici che si siamo posti sono state: “Cosa vede dello (e/o nello) spot lo spettatore, come lo legge? Che tipo di
azioni determina? Come influisce nella sue pratiche quotidiane e sociali? (…) Come si mescola con la propria esperienza, il proprio vissuto, con la sfera personale di valori, di immaginazione, di azioni e
proiezioni?”. Ciascuno studente ha poi pensato e utilizzato una griglia di intervista aperta che è stata applicata in forma libera, con la
tecnica dell’osservazione partecipante per lo più nel contesto abitua-
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
Come si può notare, si tratta di domande non esattamente “molto semplici”, che cercano anzi di andare al cuore della ricerca etnografica sui media, spostando l’attenzione dal messaggio al
consumo e alla messa in circolazione dell’interpretazione che i
diversi attori ne hanno dato.
Particolarmente interessante, anche perché tema raramente dibattuto nell’antropologia dei media, l’impegno metodologico
avanzato nella proposta di utilizzare i CAQDAS, vale a dire i
Computer Assisted Qualitative Data Analyisis Software (programmi per l’analisi quantitativa coadiuvata dal computer). Al di là
delle prospettive epistemologiche della grounded analysis, che
possono invero essere discutibili, l’utilizzo di metodologie elettroniche di indicizzazione del materiale audiovisivo consente di
gestire con un certo agio moli notevoli di informazioni, rendendo
quindi più pratico il lavoro di sintesi, oltre che quello di documentazione. In sostanza, il software utilizzato in questo approccio viene impiegato in una sorta di validazione/revisione delle
ipotesi elaborate con l’analisi testuale da un lato e l’approccio
etnografico dall’altro. Potendo indicizzare il testo visivo frame
per frame, è possibile, ad esempio, verificare il valore euristico
di una specifica opposizione impiegata per produrre il quadrato
semiotico che è servito nella prima fase del lavoro, ma il software consente anche di controllare con estrema precisione le risposte degli intervistati, correlando il testo alla gestualità e alle immagini che di volta in volta vengono commentate.
Sebbene questo tipo di analisi possa risultare oltremodo dispendioso in termini di tempo, se non addirittura farraginoso, e forse
ancora incapace di proporsi come un protocollo adeguato per inseguire il messaggio mediatico nel suo percorso di inserimento
nella vita quotidiana (data la preponderanza ancora garantita al
“discorso sul medium” piuttosto che alle “pratiche con il medium”), resta tuttavia estremamente importante l’impegno a riflettere in modo sistematico su quale possa essere il percorso
conoscitivo, al di là delle petizioni di principio sull’urgenza di su-
45
le di consumo televisivo, che coincideva, nella maggior parte dei casi, con le abitazioni (p. 93).
46
Identità catodiche
Piero Vereni
perare le analisi testuali e ricostruire il senso dell’utente finale.
In questa prospettiva, si tratta di un articolo importante nel panorama degli studi italiani, che segnala il raggiungimento di un
nuovo livello di consapevolezza dell’antropologia dei media.
L’augurio è che la recente traduzione italiana dell’importante libro
di Herman Bausinger (1961) possa stimolare ulteriormente l’interesse per i mezzi di comunicazione di massa e per l’uso della tecnologia in generale da parte degli studi demologici e antropologici
italiani, che forse devono un certo relativo ritardo al loro carattere
lungamente militante, che avrebbe valorizzato “le forme popolari
più marginali e arcaiche” come “sacche di resistenza al capitalismo”, spingendo quindi l’analisi a enfatizzare più quel che “non
succedeva”. Questa impostazione ha limitato infatti per lungo tempo il campo d’azione dei nostri studi: “non è facile fare una antropologia della vita quotidiana se l’oggi è oggetto di dannazione,
non è facile aprire l’alterità alla quotidianità se questa viene circoscritta e letta come resistenza” (Clemente 2005, p. 270).
La recente riflessione sul rapporto tra cultura popolare e cultura
di massa (Dei 2002) ha aperto però lo spazio per un nuovo incontro tra antropologia culturale e studi demologici, e l’antropologia e l’etnografia dei media sembrano un campo particolarmente fruttuoso per questo incontro.
1
Estendo al parco generale dei mezzi audiovisivi la distinzione proposta da
Douglas Harper (1988) tra ricerca con le immagini e ricerca sulle immagini e così
sintetizzata da John Grady (1996, p. 495): “Harper identifica due differenti tipi di sociologia visuale: con ‘metodi visuali’ egli include ogni progetto nel quale i ricercatori ‘fanno’ fotografie (e, per estensione, film o video) per studiare i mondi sociali; al
contrario, in quel che potrebbe essere definito un approccio di ‘studi visuali’ i ricercatori ‘analizzano’ immagini prodotte dalla cultura”.
2
Per una critica sostanziale di questo approccio sociologico che separa il sistema
dei mass media dal generale sistema sociale, e insiste nel porre come suo oggetto
di studio il “rapporto” tra media e società, implicando quindi una distinzione netta
tra i due, si può vedere Tomlinson (1991), che evidenzia chiaramente le radici francofortesi di questo scollamento tra “reale” e “mediatico”, un binarismo che produrrà effetti di lungo corso nella sociologia dei media.
Non mancano alcuni controesempi che invece hanno cercato di elaborare una teoria
dei mass media non incentrata sulla produzione “occidentale”, vale a dire euroamericana. Si veda ad esempio la raccolta Sinclair, Jacka, Cunningham, a cura, 1995.
Un altro testo particolarmente attento alla critica del pregiudizio etnocentrico occidentale, anche se rimane pressante la volontà di produrre una teoria “forte” dell’influenza dei mass media sulla realtà sociale, è Curran, Park, a cura, 2000.
4
Con questa espressione si intende il sistema classificatorio della differenza delle
società umane, che pretende che ogni Altro sia incasellabile in un’appartenenza univoca, in modo da rendere univoco anche il soggetto che nomina quella differenza.
Debitrice ovviamente della riflessione dell’antropologia critica degli anni Ottanta incentrata sul testo etnografico, l’espressione si deve a Jean-Loup Amselle (1990, pp.
49-74). Cfr. ad esempio pp. 55-56: “È attorno all’idea secondo la quale le diverse
società umane sono specie o pezzi da museo che conviene classificare, comparare
o etichettare, che ancora oggi concorda la maggior parte degli antropologi”. E ancora, p. 66: “Anche quando vuole essere scientifica, l’antropologia è dunque tanto
un mezzo per definire noi stessi quanto per caratterizzare gli altri”.
5
Lavori di questo tipo si collocano a cavallo della dicotomia che abbiamo proposto
all’inizio di queste pagine (cfr. nota 1) tra ricerca con le immagini e ricerca sulle immagini, dato che sono a tutti gli effetti studi meta-antropologici il cui oggetto è il
modo in cui la divulgazione antropologica ha riprodotto l’immagine dell’Altro. Il lavoro di Letizia Bindi, in particolare, è un saggio di ricerca sulle immagini delle immagini antropologiche dell’alterità.
6
Per una chiara posizione a favore di questa lettura dell’imperialismo dei media si
veda il pezzo classico di Fred Fejes (1981). Per una critica teorica articolata si veda
il già citato Tomlinson 1991 e per una recente falsificazione empirica della tesi nel
contesto asiatico si veda Chadha, Kavoori 2000.
7
Per un recente tentativo di riarticolare l’apparente frammentarietà ingestibile dei
panorami mediatici su scala globale si veda il già citato lavoro di sintesi curato da
Antropologia dei media. Le ragioni di un apparente ossimoro
Anche qui sto cercando di delineare un certo atteggiamento generale della disciplina, più che riflettere su casi specifici, che possono invece essere particolarmente
attenti all’intreccio di fatto inestricabile tra mezzi di comunicazione di massa e senso della vita quotidiana. Anche senza citare i prodromi della Scuola di Chicago e i
lavori pionieristici di Hortense Powdermaker cui faremo riferimento più avanti in
questa breve rassegna, si pensi allo straordinario (e ben si può dire profetico per
certi versi) lavoro di Herman Bausinger (1961), che è riuscito all’inizio degli anni
Sessanta a decostruire la pregiudiziale separazione tra tecnologia e mondo popolare dimostrando come gli strati subalterni siano sempre stati particolarmente recettivi verso l’innovazione tecnologica, “indigenizzandola” molto rapidamente nella propria rete culturale. Del resto, il fatto che il testo di Bausinger sia stato tradotto in
inglese a quasi trent’anni dalla sua pubblicazione (1990) e in italiano a oltre quaranta (2005) lascia intendere che il tema di cui si è occupato questo brillante studioso non fosse esattamente in cima all’agenda di discussione dell’antropologia internazionale e nazionale.
47
3
James Curran e Myung-Jin Park (2000), che divide il pianeta (e i corrispondenti sistemi mediatici) in cinque raggruppamenti, a seconda del tipo prevalente di “società” (con il che si deve intendere il tipo di Stato), vale a dire: miste e in transizione;
neoliberali autoritarie; autoritarie regolate; neoliberali democratiche; democratiche
regolate. Resta aperto il problema, con questo tipo di approccio, di una classificazione del sistema dei mass media che utilizza come propria unità di misura ancora
e sempre lo Stato nazionale, proprio in una fase della produzione e del consumo
mediatico in cui sembra evidente che a questo soggetto predominante per decenni
si sono affiancate nuove forme produttive super- e infra-statali, e mentre si consolidano nuove modalità di identità collettiva (le cosiddette “diaspore”) in grado di
porsi in forme politicamente rilevanti anche senza fare necessariamente riferimento
a uno Stato nazionale (Bailey, Georgiou, Harindranath, a cura, 2007).
Piero Vereni
Identità catodiche
48
8
Il passaggio da un fieldwork volutamente isolato a uno multisituato è forse uno
degli effetti più evidenti del nuovo interesse per l’antropologia dei media ma anche
la premessa principale per la nascita di questo interesse. Del resto, Gupta e
Ferguson (1997) riconoscono che è proprio il modo in cui lo studio dei media mette
in discussione le idee convenzionali di comunità e località che può spiegare il lungo disinteresse dell’antropologia per i mass media. Sulle ragioni dell’etnografia
multisited si vedano Appadurai (1991), Marcus (1995) e la terza sezione di Hume e
Mulcock (2004).
9
Per una prima rassegna sui temi dell’antropologia visuale, con una particolare attenzione al contesto italiano, si possono consultare le utili sintesi di Paolo Chiozzi
(1993), Antonio Marazzi (2002) e Francesco Faeta (2003).
10 Aggiungo in nota, dato che il paragrafo si occupa delle pubblicazioni italiane, che
la dimensione rituale dei media ha da tempo una notevole attenzione da parte degli studiosi di lingua inglese, e mi limiterò a segnalare uno dei primi lavori dedicati
agli “eventi mediatici” (Dayan 1992), e uno di quelli più vicini alla prospettiva antropologica (Liebes, Curran 1998).
11
Paul Virilio, La bomba informatica, Cortina, Milano, 2000, p. 14.
Introduzione
In questo secondo capitolo propongo una versione aggiornata
del concetto di distinzione elaborato da Pierre Bourdieu (1979) e
la sua applicazione a un contesto, quello del “gusto televisivo”,
che Bourdieu non ha indagato in modo specifico, anche perché
nei periodi di raccolta dei dati della sua ricerca (1963 e 1967-68)
la televisione in Francia non aveva ancora la rilevanza sociale
che avrebbe acquisito di lì a qualche decennio.
Per rendere più esplicita la mia proposta, la faccio precedere da
una sintesi del modello di Bourdieu, così da rendere agevole la
lettura delle pagine successive anche a quei lettori che non abbiano dimestichezza con il pensiero del sociologo francese.
Il capitolo è quindi articolato in tre paragrafi: nel primo presento
il quadro teorico generale di Bourdieu, nel secondo avanzo una
serie di riflessioni generali sulla necessità di adattare ai tempi attuali il modello indagato nel primo e infine propongo, nel terzo,
una lettura di un caso specifico come esempio aggiornato del
modello.
Il modello di Bourdieu
L’analisi di Bourdieu, in generale, colloca gli attori sociali entro
“campi di forza” che anche visivamente intendono superare il
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
La natura dell’onore è di richiedere preferenze e distinzioni.
Montesquieu, Lo spirito delle leggi
49
Capitolo secondo
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca
dei mass media
50
Identità catodiche
Piero Vereni
semplicismo sociologico delle collocazioni unilineari lungo scale
monometriche.
Il suo lavoro insiste quindi nel porre i soggetti su piani cartesiani
che possono rendere in maniera più adeguata la complessità delle collocazioni (non stratificazioni) sociali e la natura non progressiva degli spostamenti sociali, che possono essere verticali
ma anche trasversali. In questo modo, acquista una dimensione
quasi visiva la natura sociale del gusto come pratica della distinzione, intesa letteralmente come procedimento attraverso cui le
frazioni di classe si dispongono nello spazio sociale per andare a
presidiare nicchie non occupate da altri.
Ogni classe, frazione di classe o soggetto detiene un capitale
complessivo che è dato dalla somma di capitale economico (inteso come disponibilità finanziaria effettiva) e capitale culturale
(espresso dai titoli di studio acquisiti). Un aspetto di cui l’analisi di Bourdieu tiene conto sistematicamente è la storia di questi capitali, se cioè il portatore sia erede o produttore dei medesimi: Bourdieu considera rilevante misurare la differenza tra
capitale complessivo individuale e capitale complessivo ereditato, per cui la classe dominante sarà definita da una quota
elevata di capitale complessivo, ma al suo interno saranno individuabili diverse frazioni di classe che corrisponderanno alle
porzioni relative di capitale (i professori universitari e i grandi
commercianti si opporranno per avere i primi elevato capitale
culturale e relativamente basso capitale economico, i secondi
elevato capitale economico e basso capitale culturale) e alle
storie ereditate di quei capitali (un laureato proveniente da genitori con istruzione elementare, che cioè ha ereditato un basso
capitale culturale e che ha dovuto costruirselo personalmente,
si collocherà socialmente in una posizione diversa da un individuo con il medesimo titolo accademico ma figlio di genitori entrambi laureati). Questa duplice ripartizione del capitale individuale (culturale e finanziario, ereditato o conquistato) produce
una complicazione delle posizioni sociali cui corrispondono diversi stili di vita.
Per la precisione, il collegamento tra posizioni sociali e stili di vita è garantito dagli habitus intesi come
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
L’habitus è quindi l’interfaccia tra posizioni sociali e pratiche sociali, consentendo alle prime di convertirsi nelle seconde.
Un aspetto non trascurabile per la nostra analisi è quella che
Bourdieu chiama l’isteresi dell’habitus. L’habitus garantisce un
modello di percezione e giudizio del reale conseguente alla posizione sociale in cui si è prodotto (per cui l’ascetismo aristocratico si sviluppa tra i professori, la pretenziosità tra la piccola borghesia, il gusto del necessario e il principio di conformità tra le
classi popolari), ma i suoi effetti di filtro sulla realtà possono
prolungarsi (isteresi in greco significa prolungamento) anche
quando il soggetto abbia mutato (soggettivamente o oggettivamente) posizione sociale, perché il suo capitale culturale è stato
rivalutato (positivamente o negativamente), perché il suo capitale finanziario si è modificato, o per una combinazione di questi
due fattori. In pratica, una volta elaborato in determinate condizioni, l’habitus tende a condizionare la percezione e il giudizio
del reale anche se le condizioni di posizionamento del soggetto
sono mutate.
Un altro aspetto dell’habitus è la sua duplice natura di generatore e classificatore. Da un lato, infatti, l’habitus produce pratiche
sociali (generando così gli stili di vita associati ai suoi portatori)
ma dall’altro consente di gerarchizzare le pratiche (generando così il gusto inteso come principio generale di categorizzazione
delle pratiche). Detto altrimenti, l’habitus garantisce la sensatezza soggettiva (“l’intelligibilità” dice Bourdieu a p. 174) del rapporto tra condizione economica e sociale e stili di vita corrispondenti. Esso consente di tradurre sui diversi domini in cui si applica (gusti estetici, scelte alimentari, ma anche posture fisiche) gli
stessi schemi di azione, di modo che la relazione tra, poniamo, i
gusti musicali e la propria classe di appartenenza è sentita come
naturale, in quanto è prodotta dall’applicazione degli stessi sche-
51
formule generatrici (per esempio, nel caso dei professori, l’ascetismo
aristocratico) che stanno alla radice di ogni classe di pratiche e di
proprietà, vale a dire della trasformazione in uno stile di vita distinto
e distintivo delle esigenze e delle disponibilità che caratterizzano una
condizione ed una posizione determinata (Bourdieu 1979, p. 131).
52
Identità catodiche
Piero Vereni
mi “insediati nei cervelli” (p. 177). In questa prospettiva l’habitus
di Bourdieu costituisce la versione “pratica” dell’operatore totemico di Lévi-Strauss, un sistema generativo in grado di porre relazioni tra i diversi domini del reale proprio perché li categorizza
in base allo stesso schema analitico di base.
Ma se questo è, in versione molto semplificata, il modello generale di Bourdieu, qual è il suo contesto di applicazione nel caso
del gusto?
Gli oggetti culturali sono raggruppati in tre ambiti di applicazione: legittimi; in via di legittimazione; liberi. Gli ambiti legittimi
sono quelli che potremmo definire parte del “canone” delle arti
maggiori: pittura, musica, letteratura, unanimemente considerate
nella loro espressione “alta”; gli ambiti in via di legittimazione
sono quelli legati alle arti minori o a forme minori dell’arte legittima: fotografia, cinema, musica leggera; gli ambiti liberi sono invece quelli che non presuppongono un apprendimento di tipo
formale: arredamento, stili di vestiario, gusti alimentari. Gli ambiti legittimi sono a loro volta suddivisi a seconda del “mercato”
(scolare o extrascolare) entro cui vengono acquisiti, per cui le
competenze musicali di un professore di chimica faranno parte
del suo capitale culturale acquisito per via extrascolare, mentre
le conoscenze letterarie di un professore di francese saranno acquisite per via scolare.
Chiarita questa generale suddivisione degli ambiti e degli oggetti
del gusto, l’analisi di Bourdieu giunge a conclusioni estremamente nette, riassunte in due “fatti fondamentali”:
da un lato, il rapporto strettissimo che lega le pratiche culturali (e le
relative opinioni) al capitale scolastico (misurato in base ai titoli di
studio ottenuti) e, in via subordinata, all’origine sociale (stabilita mediante la professione del padre); dall’altro lato, il fatto che, a parità
di capitale scolastico, nel sistema esplicativo delle pratiche e delle
preferenze, il peso dell’origine sociale aumenta quando ci si allontana dagli ambiti più legittimi (pp. 13-14).
In sintesi, il gusto è determinato dal capitale individuale e, di
questo capitale, quello scolastico è tanto più determinante quan-
l’istruzione scolastica contribuisce (…) a costituire quell’atteggiamento generale e trasferibile nei confronti della cultura legittima che, acquisito per quanto attiene alle conoscenze ed alle pratiche riconosciute dalla scuola, tende ad applicarsi al di là dei limiti dello “scolastico”, assumendo la forma di una “disinteressata” propensione ad
53
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
to più ci si avvicina all’ambito legittimo, mentre l’origine sociale
(il capitale economico) diviene sempre più determinante quanto
più da quell’ambito legittimo ci si allontana.
La musica (proprio per il suo disporsi come un continuo sull’asse
legittimo-in via di legittimazione-libero) costituisce un oggetto
privilegiato di analisi, grazie a cui Bourdieu identifica “tre universi di gusti che, grosso modo, corrispondono a tre livelli scolastici
ed a tre classi sociali” (p. 15): il gusto “legittimo”, cioè il gusto
per le opere legittime (il Clavicembalo ben temperato) cui possono eventualmente (a seconda della sicurezza dei soggetti) essere
associate anche opere in via di legittimazione (musica jazz o
canzone “d’autore”); il gusto “medio” che unisce le opere minori
delle arti legittime (come la Rapsodia in blu) e quelle maggiori
delle arti minori (Gilbert Bécaud o, potremmo aggiungere per
l’Italia, Fabrizio De André o Franco Battiato); il gusto “popolare”
legato alla musica leggera (Gigi D’Alessio, i Pooh, oppure musica
colta legata alla divulgazione, come il Danubio blu).
Queste strette correlazioni tra gusti, classi e capitali culturali non
possono essere spiegate facendo ricorso alla forza uniformante
del sistema scolastico, proprio perché la correlazione travalica
ciò che viene appreso a scuola per applicarsi a contesti extrascolastici: l’arredamento, l’abbigliamento, l’alimentazione. Insomma,
non si impara a scuola il piacere per il jazz né la passione per la
rucola, eppure, tenendo fermo il capitale economico, a parità di
capitale scolastico corrispondono gusti simili in settori molto
lontani dalla legittimità scolastica. Per comprendere le ragioni di
questa conformità, dice Bourdieu, bisogna allungare la sequenza
causale: la scuola non produce gusti uniformi, ma contribuisce a
produrre habitus, che sono le matrici di applicazione della stessa
sequenza in campi diversi, e quindi garantiscono l’uniformità dei
gusti extralegittimi:
Piero Vereni
Identità catodiche
54
accumulare esperienze e conoscenze, che, sul mercato scolare, possono anche non essere direttamente redditizie (p. 23).
In questo senso, l’istruzione scolastica assegna ai detentori dei
titoli scolastici un “titolo nobiliare”, consentendo loro di “essere”
qualcosa (i portatori di un habitus) che si può manifestare in
campi diversi da quello specifico (scolastico) entro cui quell’“essere” è stato acquisito. Mentre cioè chi non detiene un titolo dovrà sempre dimostrare attraverso il suo “fare” la propria competenza, il detentore di titolo non dovrà dimostrare alcunché, visto
che lui “è”. Proprio tale libertà dal fare come dimostrazione del
suo essere gli garantisce quella libertà “liberale” che si può
esplicare come “scelta di gusto”. In questo modo, l’assegnazione
dei titoli scolastici come assegnazione di un’essenza garantisce
due effetti fondamentali: a) essenzializza la natura del portatore,
sottraendolo all’onere della prova dei fatti; b) naturalizza il suo
gusto come “espressione naturale” della sua essenza, rendendolo quindi soggettivamente libero. Questa opposizione tra “essere” del titolo scolastico e “fare” di chi quel titolo non ce l’ha è
particolarmente importante nell’economia odierna del gusto, visto che le mutate condizioni di trasmissione degli habitus sembrano implicare una loro riconfigurazione, come vedremo nell’esempio specifico che presenteremo nel terzo paragrafo.
Per ora, limitiamoci a costatare che l’acquisizione di un titolo
scolastico si organizza concettualmente e nella pratica sociale
come il conferimento di un titolo nobiliare, come l’attribuzione di
un’essenza del soggetto che – tra l’altro – sfugge a qualsiasi definizione rigorosa, proprio perché, in quanto habitus, non può
essere definita se non come schema generale, ma i cui contesti
di applicazione sono praticamente illimitati: così com’è difficile
definire cosa sia un nobile, altrettanto difficile, da questo punto
di vista “essenzialista”, è definire cosa sia un “addottorato”, ma
l’intenzione costitutiva del titolo di studio è proprio quella di garantire questa indefinibilità dell’oggetto.
Se l’habitus conferito da capitale scolastico e origine familiare è
essenziale, conferisce cioè un “essere” al suo portatore distinto
55
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
dal suo fare, in quanto strumento categorizzante del reale quello
stesso habitus produce categorie essenziali, cioè sottratte al loro
fare (alla loro funzione). Ecco quindi che l’habitus estetico associato a (generato da) un titolo scolastico nobilitante si svilupperà
in modo “naturale” come passione per la forma sottratta alla tirannide della funzione. Provando a dirlo in modo più semplice:
l’atteggiamento estetico è quella particolare prospettiva sul reale
che (in virtù della natura essenzializzante dell’habitus che lo conforma) lo sottrae programmaticamente alla sua funzione concentrandosi in modo sistematico sulla sua forma. La produzione artistica, a sua volta, sarà produzione di forma pura, libera dalla
schiavitù della funzione. Il gusto “puro”, quindi, prende fin dalla
sua “essenza” a costituirsi in opposizione al “gusto barbarico”
inteso come passione per la funzione, gusto incapace di distaccarsi dal “fare” in quanto i suoi portatori sono privi di quei titoli
nobiliari che garantiscono l’essenzializzazione del soggetto portatore di quel gusto.
Ecco allora che il gusto estetico puro, non volgare, sarà quel gusto che più si stacca dal comune, dal facile, vale a dire dall’umano in quanto insieme di “pratiche”. La decorporazione del gusto
estetico colto va in questa medesima direzione, per cui bisogna
per quanto possibile allontanarsi dalle “funzioni” del corpo se si
vuole applicare quello schema essenzializzante nobiliare che costituisce l’habitus colto. Schematizzando: l’habitus colto si forma
in funzione differenziante attraverso l’attribuzione di titoli scolastici nobilitanti che trovano la loro espressione extrascolastica
nell’adesione alla forma in quanto tale, e nell’esplicito rifiuto
estetico della corporeità e delle sue “funzioni”.
La distinzione tra letteratura “alta” e letteratura “di genere”, ad
esempio, può essere facilmente riscritta secondo questa prospettiva decorporeizzante tipica del gusto raffinato: è arte nobile (distinguente) quell’arte che non suscita funzioni o azioni corporali,
che separa l’essere da fare, mentre la letteratura di genere è
quella che suscita reazioni fisiche: il giallo fa sudare, l’horror fa
rabbrividire, il comico fa ridere, il mélo fa piangere, l’erotico eccita sessualmente. Solo per il fatto di produrre questi effetti fisici,
questo tipo di espressione artistica non può essere arte alta.
Piero Vereni
Identità catodiche
56
La distinzione, oggi
L’analisi di Bourdieu è ovviamente molto più sottile e argomentata di quanto non sia riuscito a delineare in queste brevi note, ma
credo che alcuni punti generali si siano chiariti, soprattutto in
funzione di un loro adattamento al contesto attuale.
Gli anni trascorsi dalla raccolta dei dati sono stati caratterizzati
da una serie di sommovimenti sociali e politici che, quanto a intensità e portata, non hanno probabilmente antecedenti comparabili nella storia occidentale. È quindi inevitabile che il modello
proposto da Bourdieu per i dati a sua disposizione vada aggiornato tenendo conto almeno di quelle modifiche sociali che sono
intervenute in modo evidente a modificare le forme di strutturazione degli habitus.
Per proporre una lettura aggiornata delle tesi di Bourdieu credo
si debba partire dalla considerazione generale che la separazione
fisica e sociale tra le classi, che rende plausibile e gestibile la distinzione in base al gusto, ha subito – nei quarant’anni che separano i dati su cui si basa La distinzione dall’oggi – modificazioni sostanziali nella sua complessità e nella sua stabilità. In
pratica, possiamo dire che il mondo rappresentato nella ricerca
di Bourdieu ha visto frammentarsi e sostanzialmente complicarsi
la separazione “fisica e sociale” degli universi di vita che la “distinzione” come pratica simbolica conferma come separati, indebolendo quindi la retroazione positiva tra separazione e distinzione. Le scelte di gusto e la loro naturalizzazione producono,
come abbiamo visto, separazione tra le classi, ma questa separazione simbolica si configura concretamente – nel modello di
Bourdieu – come occupazione in distribuzione complementare di
spazi fisici, per cui un borghese e un piccolo borghese sono distinti dal gusto, ma sono separati fisicamente da pratiche sociali
che li terranno in un regime di sostanziale apartheid. Proprio
perché hanno (naturalizzato) gusti diversi e sono inseriti nella
catena produttiva a diversi livelli, l’aristocratico, il borghese e il
piccolo borghese indagati da Bourdieu tenderanno a non incontrarsi mai, o quasi mai: andranno in ristoranti diversi, occuperanno stanze o piani diversi nel mondo lavorativo, parteciperanno a
L’operaio che vede in una vetrina un orologio da polso da due milioni, o che sente dire che un chirurgo ha speso tre milioni per il fidanzamento del figlio, non prova invidia per l’orologio o per il fidanzamento, ma per i due milioni, che userebbe in tutt’altro modo; perché
non riesce a concepire il sistema di bisogni in cui, con due milioni,
non avrebbe niente di meglio da comprare, che un orologio a questo
prezzo (p. 379).
Insomma: non basta essere ricchi per fare la vita da ricchi, ma
bisogna imparare ad apprezzare il sistema simbolico (l’habitus)
associato al superamento della parsimonia come tratto distintivo. Questa analisi della vita sociale del gusto – che tiene giustamente separate la disponibilità economica dalla disposizione
(habitus) ad agire secondo canoni specifici – ha un suo fondamento materiale nella separazione “fisica” degli attori sociali, e
Bourdieu non manca di sottolinearlo in una nota a piè di pagina
che riporto di seguito:
Mille ragioni – ed in particolare la separazione fisica e sociale degli
universi di vita – fanno sì che queste due esperienze [vedere l’orologio in vetrina e venire a sapere del fidanzamento del figlio del chirurgo] siano estremamente improbabili (…). Infatti, come notava Marx,
57
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
eventi culturali e sociali diversi. Questo, secondo Bourdieu, garantisce e rafforza la retroazione positiva tra distinzione (simbolica) e separazione (sociale). Credo che l’unico modo per leggere
La distinzione oggi sia quello di fare i conti con il fatto che questa separazione non è più così nitida, dato che la diffusione dei
flussi di informazione mediatica rende, sul piano simbolico, il
rapporto tra distinzione e separazione estremamente più complicato. Un esempio credo chiarirà il senso generale di questo mio
intervento.
Nel capitolo settimo (La scelta del necessario) Bourdieu – citando un passo di Norbert Elias – individua nell’“arte di spendere
senza parsimonia” il tratto che, nel diciassettesimo secolo, marcava la distanza tra l’aristocrazia e la borghesia del risparmio.
Questo tratto definitorio segna oggi la distinzione tra borghesia
e piccola borghesia o classi popolari:
Piero Vereni
Identità catodiche
58
non senza una certa brutalità, “ciò che [l’uomo] riesce a vedere, e in
che misura, dipende non soltanto dalla situazione generale esistente,
ma anche dalla sua borsa e dalla condizione di vita toccatagli nella
divisione del lavoro, condizione che forse gli rende inaccessibili molte cose, per quanto i suoi occhi e orecchi possano essere grandi” (K.
Marx, L’ideologia tedesca…). Salvo qualche eccezione, i membri delle
classi popolari non hanno “nessuna idea” di quello che può essere il
sistema dei bisogni delle classi privilegiate, e meno ancora, quello
delle loro risorse, di cui hanno anche una conoscenza molto astratta,
e priva di qualsiasi riferimento alla realtà (pp. 379-380, n. 3).
Mi sembra che la novità sostanziale, rispetto al momento in cui
Bourdieu scrive, stia tutta nel venire meno dei limiti cui Karl
Marx fa riferimento, sul vedere e sul sentire, e nella recente acquisizione da parte delle classi popolari di una conoscenza
paradossalmente alquanto concreta dei bisogni e delle risorse
delle classi privilegiate. La spettacolarizzazione, la commercializzazione e la capillarizzazione della comunicazione mediatica
in quest’ultimo trentennio hanno reso disponibili alla piccola
borghesia e alle classi lavoratrici, soprattutto attraverso la televisione, porzioni dell’immaginario e delle pratiche sociali borghesi altrimenti separate fisicamente. Senza tanti giri di parole:
guardando la pubblicità o Verissimo, La vita in diretta o altri
programmi del medesimo genere, il piccolo borghese può oggi
avere “occhi e orecchi” ben più aguzzi di quanto non avessero
i suoi predecessori intervistati da Bourdieu e di quanto potesse
anche lontanamente immaginare Marx, e può quindi percepire
come sostanzialmente ridotta la separazione fisica che dava
credito e che si nutriva della distinzione. Non intendo sostenere che i membri delle classi popolari mutino il loro atteggiamento verso la parsimonia guardando in televisione gli sprechi
dei vip. Può accadere in effetti l’esatto contrario, come sembrano dimostrare gli studi sulla ricezione che abbiamo citato nel
primo capitolo. Quel che voglio segnalare è il mutamento di
campo che i flussi mediatici provocano: tra distinzione simbolica e separazione fisica non vi è più un rinforzo automatico o
necessario, dato che oggi la probabilità di incrociare il proprio
(...) nuove intimità a vario titolo oscene e irrispettose della persona,
che impongono alla narrazione sociale il gusto indigesto di un diffuso quanto aberrante riduzionismo psicologico, sentimentaloide e regressivo, che va per la maggiore nei media globali. L’emozione mediatica, senza dubbio vero demone del contemporaneo, ha svolto e
svolge così un ruolo spesso decisivo nella costruzione retorica del Sé
come della diversità (Pompeo 2007, p. 14).
59
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
sguardo parsimonioso su oggetti e pratiche “di spreco” è incomparabilmente cresciuta. Un conto è immaginarsi una tantum
lo spreco del chirurgo (che nella separazione fisica può ancora
essere relegato nell’eccentricità) e un altro è essere esposti in
maniera sistematica a un modello sociale raffigurato nei minimi
dettagli. Il passaggio da una società “suntuaria” (basata cioè
sulla regolamentazione ex lege o de facto dei consumi disponibili per le diverse classi sociali, per cui solo alcune classi possono accedere ad alcuni beni, indipendentemente dalla disponibilità economica) a una società del consumo (in cui tutti sono
legittimati ad acquistare tutto in base alla disponibilità economica) modifica in modo sostanziale la questione del gusto come distinzione, dato che si è realizzato attraverso una mediatizzazione dei modelli sociali che li rende estremamente permeabili allo “sguardo” altrui, soprattutto dal basso verso l’alto.
Mentre cioè è ancora probabile che le classi privilegiate sappiano poco o nulla del sistema dei bisogni e delle risorse delle
classi popolari, queste ultime sembrano essere estremamente
affamate di immaginario borghese, del quale ormai sono paradossalmente più esperte di molti borghesi stessi.
Questa permeabilità dell’identità allo sguardo dell’Altro si inserisce (senza che possiamo darne conto poco più che in un accenno) nella logica del tardo capitalismo che punta alla diversificazione per mantenere alti i livelli del consumo (Jameson
1991). Secondo questa logica, tutti devono poter esibire quando necessario una loro precisissima “identità”, sia privata e individuale, sia pubblica e collettiva, e questa duplice dittatura
dell’identità produce quella straniante compresenza di “consumo dell’etnico” e
Piero Vereni
Identità catodiche
60
Proprio l’espansione globale di un soggetto “sentimentaloide”
grazie al sistema dei media produce nuove strategie di distinzione sociale, questa volta imperniate sul consumo (o il non consumo) di quei canali mediatici.
La distinzione sembra quindi, entro il modello dell’immaginazione come pratica sociale, ridisegnarsi come struttura simbolica di
conoscenza oltre che di riconoscimento di sé: mi distinguo (e
quindi mi riconosco) perché non conosco, perché mi sottraggo
intenzionalmente alla circolazione pubblica degli immaginari di
classe. Detto altrimenti: non guardo la televisione, che è il canale attraverso cui si rendono disponibili gli immaginari altrui. Se ci
si fa caso, la risposta più chic che si possa ancora dare a qualunque domanda che riguardi un programma televisivo è la classica: “Mi spiace, non lo conosco”.
Dopo aver presentato il modello generale della Distinzione di
Bourdieu, vorrei quindi tentare un inquadramento del problema
della distinzione nel contesto attuale, che ritengo caratterizzato
in maniera determinante dall’intrusione della “cultura di massa”
nella generazione degli habitus. Lungi dall’essere una critica al libro (realizzato come ricerca e scritto come volume in una fase in
cui la prepotenza della comunicazione televisiva poteva ancora
essere legittimamente messa da parte) la mia lettura va intesa
come un omaggio a una riflessione analitica che mantiene tutta
la sua validità metodologica anche se è mutato il contesto della
sua applicazione.
Per sintetizzare anticipatamente quanto cercherò di argomentare
nel prossimo paragrafo, possiamo dire che il punto critico del
modello di Bourdieu si situa nella genesi dell’habitus.
Nell’originario modello bourdiano, il capitale che sta alla base
dell’habitus è determinato in modo praticamente esclusivo dal titolo di studio e dalla famiglia di provenienza. Scuola e famiglia,
per così dire, sono i luoghi di produzione degli habitus e soprattutto le migliori riproduttrici di se stesse. Sebbene tenga esplicitamente conto del problema della riproduzione sociale delle classi e delle loro frazioni, il modello di Bourdieu mi sembra oggi
particolarmente segnato da un mutamento strutturale delle con-
61
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
dizioni di produzione dell’habitus in cui un terzo fattore è entrato prepotentemente a modificare i rapporti specifici tra capitale
scolastico ed economico. Questo terzo fattore può essere definito come capitale mediatico, cioè come quota di “immaginazione
come pratica sociale” resa disponibile dal sistema complesso dei
flussi di immagini e informazioni che attraversano i campi precostituiti del sociale.
Alcune stimolanti riflessioni sul sistema dei mezzi di comunicazione di massa ruotano attorno all’idea di immaginazione. Per
lungo tempo l’immaginazione è stata concepita come un lusso
per le classi dominanti (letteratura, poesia), una forma di educazione sociale (mitologia) o una via di scampo individuale
dalle difficoltà della vita quotidiana. Immaginare voleva dire
scappare dalla realtà quotidiana e cercare rifugio in un’attività
negativa, caratterizzata proprio dal non-fare. Il sistema degli
immaginari era fortemente condizionato dal sistema di riferimento politico, sociale e culturale nel quale si era inseriti e direi quasi incardinati: crescere in Italia o in Francia voleva dire
partecipare a sistemi di immaginario estremamente diversi, e
altamente specifici.
Oggi i flussi mediatici rendono disponibili immaginari fortemente divergenti, conflittuali, contraddittori, che i singoli possono riconfigurare all’interno dei loro progetti di vita. In sintesi: l’immaginazione non è un modo di sottrarsi alla realtà, ma un modo per progettare forme di attività e di controllo del reale
(Appadurai 1996).
Tutte queste considerazioni (il nuovo ruolo dei media nella produzione degli habitus e nella produzione dell’immaginazione come pratica sociale) possono ancora apparire alquanto astratte,
ma intanto ci dicono che il gusto può conformarsi non solo in
base al titolo di studio acquisito e alla storia familiare, ma anche
in base a quello che vediamo in televisione o al cinema, o che
leggiamo sui giornali.
Nell’esempio che ora presenterò questi elementi vengono messi
in gioco concretamente, cercando di dimostrare come il sistema
delle appartenenze e dei gusti (il gusto come strumento della distinzione) possa trovare strani alleati e strani soggetti.
Piero Vereni
Identità catodiche
62
La soapizzazione dell’anima1
Cosa fa sì che Maria De Filippi sia così amata dal pubblico generalista e così detestata dai cosiddetti intellettuali? Prima di stracciarci le vesti e balzare popperianamente sul carro dei mosconi
detrattori del catodo, forse vale la pena di capire come funziona
un meccanismo narrativo che ha implicazioni antropologiche letteralmente sconvolgenti.
Gli sceneggiatori televisivi, gente pratica, dividono il mondo della fiction in due grandi categorie: low concept, e high concept. A
scanso di malintesi, gli aggettivi stanno a indicare più l’impegno
economico dell’eventuale investimento produttivo che il valore
intrinseco delle opere prodotte, per cui low concept fa il paio
con low budget. Comunque sia, high concept indica quel tipo di
fiction in cui i caratteri dei protagonisti sono nettamente definiti
e coincidono con un fare specifico: la caccia al colpevole, la scoperta di nuovi mondi, la ricerca di una via di fuga. Low concept
è invece quella fiction che ruota strutturalmente attorno alla definizione stessa dei personaggi, perennemente alla ricerca di una
loro collocazione sociale o affettiva. Si intuisce quindi dalle definizioni sommariamente presentate che il tipo principe di fiction
high concept è il telefilm poliziesco, mentre la fiction low concept trova la sua massima espressione nel serial (nella variante
soap opera quando il finale è dilazionato all’infinito; telenovela
se il finale, per quanto ritardato, è previsto nella sceneggiatura
di base). Low e high sono due idealtipi o caratteri estremi, che
delimitano piuttosto i margini di un continuo narrativo entro il
quale è possibile collocare le specifiche fiction. Così, per fare un
esempio a me caro, la serie Star Treck è una fiction high concept
(“alla scoperta di nuovi mondi… lì dove l’uomo non è mai stato
prima”), ma il conflitto tra la razionalità vulcaniana del Dr. Spok
e l’emotività dell’umanissimo Dr. McCoy è un tipico caso di sviluppo low concept che fa da bordone a tutta la serie.
Specularmente, il telefilm Ally McBeal è pensato come un low
concept (l’avvocatessa in perenne crisi sentimentale e identitaria)
sul quale si innestano di volta in volta plot basati su casi legali
più o meno high (ma mai alla Perry Mason).
63
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
Detto altrimenti, una narrazione è high quando punta sulle azioni
dei protagonisti (“Presto, insegua quell’auto!”) che non hanno
bisogno di definizioni dato che quello che sono sta tutto nel loro
fare (il tenente Colombo), mentre è low quando si incentra sulla
definizione dei personaggi (“Devo dirti qualcosa, Pedro: tua madre in realtà è la figlia di tuo padre, quindi tuo padre è tuo nonno, e tua madre è tua sorella”), attività che di fatto costituisce lo
scopo primario della fiction di questo tipo.
Stabilite queste coordinate, è utile ricordare che l’opposizione si
può applicare al mondo della letteratura in generale, che costituisce ovviamente il terreno dove l’opposizione si è anzi originariamente sviluppata. Ma è proprio quando viene restituita a questo campo di applicazione che l’opposizione tra high e low dimostra inaspettate implicazioni, dato che è proprio qui che le implicite connotazioni valutative che mi ero premunito di evitare all’inizio di questa discussione sembrano tornare prepotentemente
all’assalto, ma invertite di segno. Intendo dire che la letteratura
high coincide abbastanza bene con quella che si chiama “di genere” (polizieschi, fantascienza, erotici, ecc.) mentre quella low
sembra sovrapporsi con una certa precisione alla Letteratura con
la maiuscola, a quella che – beata lei – arriva a toccare le vette
dell’arte.
Anche se cioè un plot high concept può strutturare la trama di
molta Letteratura con la maiuscola, mi pare indubitabile che ciò
che ha fatto di un pezzo di “prosa letteraria” un’opera d’arte è
stato, per generazioni di critici, il tono irrimediabilmente low della struttura ideologica soggiacente. Possiamo cioè dire che senza
la ridicola crisi dell’Innominato (e gli stravizi conventuali della
monaca di Monza, e i trascorsi ribaldi di fra’ Cristoforo) i
Promessi Sposi non sarebbero entrati nel canone con il fragore
che li ha contraddistinti. Ciò che per due secoli (l’Ottocento e il
Novecento) ha costituito il fattore discriminante della Grande
Letteratura è stata proprio la capacità degli autori di comunicare
gli intimi sommovimenti dell’anima del protagonista, dimostrandone così l’esistenza in un mondo sempre più secolarizzato. La
borghesia (classe sociale di cui il romanzo è la più compiuta
espressione estetica, com’è noto) ha costruito la propria perce-
64
Identità catodiche
Piero Vereni
zione di sé attraverso la rappresentazione narrativa di un soggetto dotato canonicamente di due fondamentali caratteristiche: è
consapevole dei propri stati d’animo, più importanti per la sua
vita di qualunque condizione materiale; i suoi stati d’animo mutano nel corso del tempo a seguito di diversi motivi, non ultimo
il caso.
Non è necessario indicare in questa sede le ragioni strutturali
che hanno condotto a una simile concezione del soggetto, mentre è estremamente importante sottolineare l’aspetto distintivo di
questa identità borghese, che si oppone (tramite la sua interiorità) alla vacua esteriorità della classe nobiliare e (tramite la sua
“profonda” introspezione) alla banale e inconsapevole superficialità delle classi subalterne e strumentali. Dal Werther di Goethe
all’Agostino di Moravia, il protagonista del romanzo moderno è
un tipo noioso che non ha nulla da fare se non struggersi per
una qualche relazione (affettiva o di potere) che gli crea dei problemi di identità. Ora, imparare ad apprezzare le qualità estetiche di un simile modello narrativo è procedimento estremamente
complicato, che necessita di uno specifico e lungo addestramento: i giovani devono essere educati a identificarsi con soggetti in
crisi il cui scopo ultimo non è fare delle cose con il proprio corpo (vangare, copulare, mangiare, defecare) ma elaborare una
qualche concezione raffinata del proprio sé come espressione
desomatizzata e vagamente nevrotica di un qualche malessere di
vivere. Per poter giungere a incorporare questo modello erano
necessari – finora – rigorosi strumenti educativi e rigide pratiche
di esclusione. Pierre Bourdieu, come abbiamo visto, ha illustrato
i passaggi necessari per elaborare una concezione estetica che
garantisca un’adeguata appartenenza di classe. Nel caso della
pratica borghese dell’acquisizione di un capitale culturale, particolarmente interessante si rivela la discussione sulla natura dei
titoli scolastici, che Bourdieu identifica chiaramente come marcatori di una concezione low del soggetto, opposta alle pratiche
high dell’autodidatta:
A differenza di coloro che detengono un capitale culturale sprovvisto
di certificazione scolastica, cui si può sempre ingiungere di sottopor-
Abbiamo ormai chiarito come il saggio di Bourdieu sia stato
scritto prima di Maria De Filippi, cioè prima della soapizzazione
dell’anima. La famosa conduttrice riprende in maniera industriale, portandolo alla perfezione, il modello di Maurizio Costanzo,
che si può riassumere in uno slogan: democratizzare la crisi borghese del soggetto.
In tutti i programmi di Maria De Filippi (Amici, Saranno famosi –
poi ribattezzato Amici di Maria De Filippi per ragione di copyright
–, C’è posta per te), qualunque sia il concept (dichiaratamente
low in Amici e C’è posta per te, falsamente high in Saranno famosi, in cui si finge che i protagonisti debbano battersi per una
vittoria finale), la spina dorsale dell’audience, il detonatore dello
share, è sempre e comunque un soggetto qualunque in crisi affettiva e/o identitaria: la madre snaturata che a settant’anni vuole rivedere le figlie; il panettiere demotivato che cerca la fidanzata della sua adolescenza; l’atletico, apollineo e afasico ballerino
adolescente che deve superare la crisi che lo contrappone al padre benzinaio che l’ha ostacolato nella sua carriera (ma che a
sua volta è in crisi perché ora, pressato dalle telecamere, riconosce il “talento” del figlio ed è costretto a rivedere la sua equiparazione meccanica tra ballerini e omosessuali).
Credo che il successo di Maria De Filippi consista proprio nella
sua capacità di popolarizzare un’immagine a lungo elitaria del
soggetto occidentale, rendendola fruibile alle masse che, esposte
per troppo breve tempo alla pratica distintiva dell’educazione
formale, hanno fatto in tempo a cogliere l’allure del soggetto
65
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
si ad una prova, giacché essi sono solo quello che fanno, semplici figli delle loro opere culturali, coloro che detengono invece un titolo
di nobiltà culturale (simili in questo a coloro che detengono un titolo
nobiliare, il cui essere, definito dalla fedeltà a un sangue, ad un suolo, ad una razza, ad un passato, ad una patria, ad una tradizione, è
irriducibile ad un fare, ad un saper fare, ad una funzione) devono solo essere quello che sono, perché tutte le loro attività valgono quello
che vale il loro autore, dato che costituiscono l’affermazione e la perpetuazione di quell’essenza in virtù della quale vengono espletate
(Bourdieu 1979, pp. 23-24; tranne l’ultimo, i corsivi sono aggiunti).
66
Identità catodiche
Piero Vereni
borghese senza riuscire veramente a farlo proprio. Gli ex liceali
distratti, i geometri con il panico da compito d’italiano, i forzati
delle 150 ore e i coatti del Cepu hanno con Maria De Filippi l’opportunità irrinunciabile di prendersi una clamorosa rivincita di
classe, potendo esprimere con tutto il loro corpo quel che la
Cultura ha fatto loro solo assaggiare. Lacrime e sudore, aloni
ascellari e scarmigliature, posture goffe e voci roche da scarsa
pratica telegenica, assieme al calcolato vizio della conduttrice di
non guardare mai verso la telecamera, costituiscono lo stile “realista” della televisione di Maria De Filippi (non per nulla il genere
cui appartiene, oggi dominante nelle televisioni di tutto il mondo, è detto reality) che garantisce a chi guarda la certezza della
partecipazione e dell’identificazione. Le classi popolari, che non
hanno tempo da perdere a leggersi pallosissimi bildungsroman
senza sugo per giungere a quel raffinamento della coscienza necessario a percepirsi come “soggetto fragile”, possono attraverso
il tubo catodico fare un corso accelerato di pensiero occidentale,
e condensare in un paio d’ore la filosofia del soggetto da Hegel
a Heidegger.
Gli stessi motivi che fanno di Maria De Filippi un vero guru delle
classi subalterne stanno alla base del disprezzo che verso di lei
ostentano i colti, quelli appunto che sono in qualche modo riusciti a incorporare il modello del soggetto fragile per via letteraria o filosofica. Costoro subiscono il gravissimo dispetto di vedersi svelare il trucco sotto il naso, il trucco – si badi bene –
fondativo della loro identità. C’è posta per te (ma l’argomentazione si può estendere ai reality show in generale) costituisce infatti l’anello di congiunzione tra L’Ulisse di James Joyce e Un posto al sole, svelandone così la comune matrice low concept.
Prima del reality i sostenitori della cultura alta (che abbiamo visto essere in effetti low concept) potevano ribadire la distanza
del loro modello narrativo dal serial insistendo sulla patemizzazione esasperata di quest’ultimo, che invece non sarebbe presente nei romanzi d’Arte. A parte il fatto che l’argomentazione è
alquanto speciosa (che cos’è il flusso di coscienza di Molly se
non un effettaccio paragonabile allo slow motion in un film di
Franco Zeffirelli?), la messa in scena dei corpi proletari invasi da
67
Questioni di gusto. Identità e preferenze estetiche nell’epoca dei mass media
anime fragili dimostra senza possibilità di smentita che quel soggetto raffinato che si supponeva frutto di un incessante lavorio
interiore può esistere anche in contesti del tutto incongrui, vanificando quindi il processo di distinzione.
Maria De Filippi è dunque la profetessa della vera laicizzazione
della crisi laica del soggetto, la divulgatrice di un modello che era
nato per essere elitario. Inevitabile quindi che si attirasse gli strali
e gli anatemi di chi di quel modello è vissuto (in senso letterale).
Ma ci importa poco delle piccinerie invidiose della borghesia,
mentre ci sembra più interessante seguire gli sviluppi antropologici e politici di questo modello identitario. Cosa succede cioè
nelle pratiche sociali quando il soggetto non è più raccontabile
per il suo fare, ma solo definibile per il suo sentire? Quando il
narcisistico modello strutturalista (il soggetto è un fascio di relazioni) diviene pratica quotidiana? Cosa succede veramente quando Luisa non è più quella che fa i vestiti, ma la “madre degenere”; Lucio non è più il barbiere ubriacone, ma il “padre in crisi”;
Antonella non è più la finta verginella che fa impazzire i tardoni,
ma la “ballerina”? Il passaggio da un concetto high (basato sulla
narrazione) a uno low (basato sulla definizione) del soggetto occidentale è avvenuto circa duecento anni fa (era già compiuto
con Fichte), ma la divulgazione alle masse di questo modello sta
avvenendo ora, sotto i nostri occhi. Il revival etnico, la smania
delle radici, il culto del farro e della cucina biologica sono le ricadute ideologiche e mercantili più evidenti di questo mutamento ontologico radicale. Se io non sono più quello che sono per
quello che faccio, ma per quello che sento e per come mi rappresento di fronte agli altri, se insomma non ha più alcuna importanza raccontare chi sono, mentre diventa fondamentale definirmi (gay, skater, trans, pacifista, liberal, scrittore, artista, del
Cancro), questo modello identitario veicolato dal piccolo schermo è comunque troppo esile per darmi sicurezza, spingendomi a
barattare la mia storia personale (fatta di azioni che sul mercato
delle identità non valgono più nulla) con qualche mito collettivo
(i celti, gli antenati, le radici).
Vi è quindi un’indubitabile consonanza di fini tra reality Tv e revival etnici e localistici, dato che in entrambi i casi i soggetti so-
68
Identità catodiche
Piero Vereni
no sottratti al loro fare individuale (alienati in un modo che Marx
non aveva previsto), per essere restituiti alla macchina mediatico-produttiva nella totale convinzione che ciò che conta veramente è il “considerarsi” (mi considero un buon padre, mi considero un artista, mi considero un padano). Questa assunzione apparentemente consapevole della propria soggettività ha un effetto destabilizzante proprio in quanto sottrae al modello delle
classi la propria naturalità (critica della borghesia). Ma non è in
grado di sottrarre i soggetti all’alienazione da sé, dato che sostituisce le narrazioni individuali con una serie di definizioni (“c’ho
un trauma infantile”) pescate più o meno appropriatamente dal
mercato della patologia mentale. Se quindi sul piano ideologico
il reality show sbugiarda la borghesia e la sua distinzione fasulla,
su quello politico la deriva rischia di essere reazionaria. Appena
imparano a sentirsi “nuragici in crisi”, anche i minatori sardi perdono nerbo. In un mondo in cui le domande principali non sono
più: “Come arrivo a fine mese?” o “Come faccio a conquistarla/o?”
ma “Chi sono io, veramente?” e “Come posso superare il mio
complesso edipico?”, non rimane molto spazio per progettare
(o imporre con la forza) mutamenti strutturali delle condizioni di
produzione. La borghesia è in crisi, quindi. Ma non è che le classi subalterne stiano granché meglio. Vorrà dire che ci faremo sopra un bel talk show.
1 Una prima versione di questo paragrafo è stata pubblicata sul sito www.nazioneindiana.com e, con lo stesso titolo, in AA.VV., Best off. Il meglio delle riviste letterarie
italiane. Edizione 2005, Roma, minimum fax, 2005, pp. 99-106.
Eravamo ragazzini quando stavamo al paesino, c’era la guerra civile del 1997. L’unica cosa che ho imparato nella guerra civile è stato ascoltare i Led
Zeppelin e la musica rock. Perché noi andavamo al
mare. Avevamo questa radio e la portavamo in riva
al mare. Sentivamo radio Bari. Tra le nove e le dieci
di sera davano un programma di musica rock. “Ora
ascoltiamo una canzone, una pietra miliare del
rock, Stair Way To Heaven, loro sono i Led
Zeppelin”. Poi mettevano i Jethro Tull, i Deep
Purple. Guardavamo questo mare, le onde del mare, e intanto ascoltavamo queste canzoni sparate a
tutto volume. Io e il mio amico ascoltavamo e dicevamo: guarda il mondo come è bello di là…
(Intervista a Elton Sinani, Firenze, 16 dicembre 2006)
Introduzione
Tra il giugno 1995 e il febbraio 1997, mentre svolgevo la ricerca
sul campo in Macedonia occidentale greca per il mio dottorato,
mi sono recato diverse volte in Albania in visita a Gilles de
Rapper, un collega francese che conduceva la sua ricerca nell’area di confine tra Albania e Grecia. Durante uno di questi viaggi,
a Voskopoj ebbi modo di chiacchierare con Dhori Fallo, un professore di matematica in pensione che parlava un elegante italiano imparato durante la prigionia in Italia negli anni Quaranta.
Tenendo in braccio il nipotino di pochi mesi, Dhori mi raccontò
che aveva due figli, uno sposato che lavorava clandestinamente
in Grecia (il nipotino era figlio suo), e l’altro in Italia dal 1991, arrivato con una di quelle carrette del mare stipate di uomini che
tutti ricordiamo quell’estate. Il discorso che il padre tenne al fi-
69
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
Capitolo terzo1
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine
degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (19972006)
70
Identità catodiche
Piero Vereni
glio prima di vederlo partire fu di questo tenore: “Vai in Italia,
cercati un lavoro lì e dimenticati di essere albanese. Sposati se
puoi con una donna italiana e cresci dei figli italiani. Adesso non
è tempo di essere albanesi, non abbiamo una dignità da difendere, ma solo miseria umana e morale da sconfiggere. Tra qualche anno, quando e se l’Albania ritroverà un suo onore, potrai
dire ai tuoi figli che sono albanesi, ma non adesso, adesso dimenticati anche tu che provieni da questo paese”. Ricordo la forte impressione che mi suscitò questo imperioso comando di un
padre a scordare la patria, la terra dei padri. All’epoca, gli albanesi non godevano in Europa di buona fama: noti alle cronache
solo per i casi criminali, sembravano in generale aver fatto tesoro del consiglio di Dhori, rendendosi, perlomeno in Italia (il paese con la più alta percentuale di emigrati, assieme alla Grecia)
praticamente invisibili, anche per via delle caratteristiche somatiche “mimetiche”.
Appena rientrato in Italia, nel febbraio 1997, ebbi modo di verificare rapidamente il modo in cui gli albanesi erano visti e giudicati, dato che la crisi finanziaria che stava devastando il paese
balcanico da gennaio iniziò presto ad attrarre l’attenzione dei
mezzi di comunicazione italiani, soprattutto quando produsse
sollevazioni, incidenti e rapidi tentativi di fuga dal paese.
Ne emerse un’immagine complessa ma sostanzialmente negativa
degli albanesi, delle loro motivazioni e delle loro strategie culturali, la cui analisi costituisce la parte centrale e più consistente
di questo capitolo.
Nell’ultimo paragrafo, invece, presento un rapido caso di studio
per avanzare alcune riflessioni sul ruolo che un altro mezzo di
comunicazione di massa ha avuto nella rappresentazione dell’identità albanese, e cioè la televisione d’intrattenimento nei primi
anni del nuovo millennio.
Lungi dal voler essere una disamina sistematica sul ruolo dei
mass media nella formazione delle identità collettive, queste pagine sono piuttosto un primo resoconto di una ricerca tuttora in
corso, che cerca di riflettere sul ruolo dinamico dei mass media,
strumenti di comunicazione sempre bidirezionali, che molto dicono non solo sulla natura dell’oggetto rappresentato, ma anche
Pastori e pinocchi
Il 1997 è un anno di svolta per l’economia albanese. A partire
dalla metà di gennaio le numerose finanziarie sorte come funghi
nel biennio precedente, raccogliendo i risparmi delle famiglie e le
rimesse degli emigrati con prospettive di rendita elevatissime,
stavano collassando a ritmi incontrollabili. Il sistema piramidale
della raccolta del denaro (per cui ogni cliente, per poter iniziare
ad avere una rendita dal proprio investimento, doveva trascinare
con sé una dozzina di nuovi finanziatori) era giunto a saturazione e i soldi, confluiti nelle mani di pochissimi, si erano letteralmente volatilizzati. La crisi colpì una percentuale altissima della
popolazione residente in Albania, drenando quasi la metà del
prodotto interno lordo del paese (Jarvis 2000, p. 1); l’inerzia del
governo di Sali Berisha nell’affrontare per tempo la situazione
provocò da febbraio un periodo di sommosse, sollevazioni popolari e scontri anche violenti, periodo che oggi è ricordato come la
“guerra civile”, anche se non è mai stato chiaro quali fossero (e
se ci fossero) le parti contrapposte.
Su mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra il
15 aprile e il 12 agosto 1997 fu attivata in Albania la “missione
Alba”, condotta dalla Forza Multinazionale di Protezione per aiutare la popolazione albanese e sostenere attivamente il ritorno
della stabilità politica. Per la prima volta, una missione internazionale era a guida italiana, come italiana era la maggior parte
delle truppe coinvolte sul territorio. Si trattò quindi di un’importante occasione per fare vedere, sullo scacchiere della politica internazionale, quale potesse essere il ruolo militare dell’Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale.
L’intera vicenda ebbe un’intensa copertura mediatica globale, cui
ovviamente partecipò anche l’Italia. Nelle prossime pagine ricostruisco il modo in cui i “corsivi” di quattro quotidiani italiani
hanno raccontato la crisi dell’economia albanese tra febbraio e
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
71
sulle forme culturali del soggetto che attua l’operazione di rappresentazione.
Piero Vereni
Identità catodiche
72
marzo 1997. Ho scelto il corsivo soprattutto per la sua implicita
natura di testo “autoriale”, volendo quindi porre un parallelo tra
la scrittura giornalistica e la scrittura della saggistica antropologica. I quotidiani selezionati sono stati: «la Repubblica», il
«Corriere della Sera», «il Giornale» e «Il Gazzettino», con l’intento di fornire un quadro genericamente esaustivo del panorama
disponibile all’epoca.
Per buona parte di febbraio i giornali italiani non sembrano prestare molta attenzione a quel che accade in Albania, anche se i
crolli finanziari si susseguono a catena e non mancano le manifestazioni di protesta. Ci sono pochissimi articoli, solo nelle pagine
interne, e quasi nulla che somigli a un corsivo. Posso citare due
colonne non firmate su «la Repubblica» dell’11 febbraio, anche
perché, primo tra tutti, questo pezzo mette a fuoco il tema che
ossessionerà gli italiani di lì a qualche settimana: “E quando, come ormai pare certo, cadranno anche le company fino a ieri ritenute più solide da un punto di vista economico (…) non resterà
agli albanesi altro che tornare a imbarcarsi sui traghetti, scafi e
gommoni alla volta delle coste pugliesi”.
Quando l’interesse cresce, predomina un’immagine degli albanesi come “popolo folclorico”: “(…) noi andammo all’attacco di
quello che, allora, veniva definito ‘il nobile popolo schipetaro’.
C’era un re che si chiamava Zogu e che aveva sposato una contessina ungherese di nome Geraldine: un bel soggetto per un
musical (…) Vittorio Emanuele III diventò sovrano anche di
quelle serene popolazioni dedite alla pastorizia e che hanno
dato al mondo Madre Teresa di Calcutta e Anna Oxa da Bari”
(«Corriere della Sera», Biagi, 5 marzo). Biagi ribadirà quest’icona tra l’agreste e il comico pochi giorni dopo: “Quando stoltamente andammo ad occupare quel povero Paese (…) trovammo
un mondo arretrato e primitivo, una reggia da operetta e attorno brava gente che custodiva greggi o buttava reti” («Corriere
della Sera», 18 marzo). Normale, viste le premesse, che quelli
truffati siano descritti come “gente che aveva creduto a un sogno: la moltiplicazione della ricchezza attraverso lo scambio di
carta; parossistica rappresentazione di un capitalismo da film
73
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
di Frank Capra”, («Corriere della Sera», Cingolani, 2 marzo).
Nessuno nota che quel concetto di capitalismo è lo stesso che
pochi anni prima aveva nutrito un meccanismo finanziario del
tutto simile, e cioè il sistema dei junk-bonds, i “titoli-spazzatura” utilizzati negli anni Ottanta da squali della Borsa come
Michael Millken. Si preferisce descriverli in modo lapidario: “Gli
albanesi sono dei pinocchi che credono nel Paese dei Balocchi”
(«Il Gazzettino», Sgorlon, 15 marzo), o li si deride con una curiosa inversione di oggetto che già sposta l’attenzione da “loro” a “noi”: “quei gonzacchioni che si son fatti accalappiare da
degli pseudo finanzieri d’assalto – non poi molto diversamente
da come noi stessi negli anni Cinquanta ci lasciammo infinocchiare dai vari Virgillito and company” («il Giornale», Riva, 2
marzo).
In generale, in questa prima fase, che dura fin circa la metà di
marzo, i corsivisti parlano ancora con toni compassionevoli, con
indubbi risvolti da complesso di superiorità: “un popolo dall’animo vuoto più ancora delle tasche” («Corriere della Sera»,
Cingolani, 2 marzo). Ma è meglio chiarire subito: “Gli albanesi non
sono i nostri ‘fratelli separati’. Semmai sono i nostri cugini scalognati” («il Giornale», Riva, 2 marzo). Cugini di cui è bene fidarsi
poco, soprattutto se si pensa che sono “una popolazione che di
violenza si è sempre nutrita” («il Giornale», Caputo, 4 marzo).
Precoce è la preoccupazione che la crisi albanese possa dilagare,
anche se non sono chiari i motivi o le forme di questo potenziale contagio, paventato con un non sequitur che risente evidentemente di un radicato stereotipo della “polveriera” che così bene
si accompagna al quadro “balcanico” (Todorova 1997): in Albania
succedono sommosse, quindi c’è il rischio che si incendino i
paesi vicini.
“L’Albania non è un’eccezione, ma solo l’anello più debole di
quella catena che collega la Serbia, la Croazia, la Bulgaria, la
Romania. Paesi diversi… legati da un comune destino: l’incapacità di gestire la transizione dal comunismo al mercato” («Corriere
della Sera», Cingolani, 2 marzo).
“Ora il passato albanese sembra volersi prendere una rivincita
che nelle nuove condizioni minaccia di infiammare il Kosovo, la
74
Identità catodiche
Piero Vereni
Macedonia, e di lì tutti i Balcani”, («Corriere della Sera»,
Venturini, 4 marzo). Un esperto paventa il rischio del contagio a
tutto l’est ex comunista: “Dunque: oggi in Albania, domani in
Romania, in Bulgaria e, forse, in Russia?” («Il Gazzettino»,
Ostellino, 4 marzo) e qualcuno prevede ripercussioni su tutta
l’Europa, senza distinzioni: “(…) una crisi che destabilizza ancor
più l’area balcanica e che minaccia ripercussioni gravi per tutta
l’Europa” («Il Gazzettino», Tito, 14 marzo).
“Gli Stati Uniti (…) sanno che dopo l’Albania può esplodere il
Kosovo (…). Poi c’è la Macedonia, piena di soldati americani
mandati a circoscrivere l’incendio dei Balcani. La Grecia, intanto,
si allarma per le sorti della propria minoranza nel sud
dell’Albania” («Corriere della Sera», Cingolani, 6 marzo).
“Un’altra Somalia, un altro Libano? No, perché l’Albania è qui, è
in Europa e per massima disdetta è anche nei Balcani, nella nostra secolare e già tanto insanguinata ‘polveriera’” («Corriere della Sera», Venturini, 15 marzo).
Un altro esperto dell’area sostiene una variante di questa teoria,
per cui non si tratterebbe, per l’Albania, del caso particolare di
una regola generale, ma del contagio subito dal paese delle
Aquile, della balcanizzazione di uno Stato fino ad allora immune:
“Il nuovo regime di Tirana ha infatti realizzato dopo il ’91 una
metamorfosi del tutto balcanica del paese (…). Si è quindi sostenuta una ‘balcanizzazione’ del paese invece di contrastarla” («la
Repubblica», Cavallari, 6 marzo).
Una versione peculiare di questa teoria del “contagio balcanico”
è quella proposta da Robi Ronza, che prende le mosse dai rischi
di un intervento concertato europeo: “Coinvolgere l’Europa vuol
dire coinvolgere la Grecia, che da sempre rivendica come cosa
sua proprio quella regione dell’Albania meridionale attorno a
Valona che è attualmente in piena rivolta contro il governo di
Tirana; una regione dove tra l’altro è insediata una minoranza di
lingua greca, la cui cultura è priva di qualunque tutela e riconoscimento ufficiali. Ci sarebbe oggi in effetti da verificare in quale
misura la rivolta in corso, così violenta e nel medesimo tempo
così delimitata dal punto di vista territoriale, non trovi il suo
punto di forza nella minoranza greca, e nell’appoggio che le può
75
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
provenire dalla madrepatria, la Grecia” («il Giornale», Ronza, 9
marzo). A parte il fatto che il cosiddetto “Epiro settentrionale” –
e cioè i distretti di Saranda, Argirocastro, Tepeleni, Coriza e
Përmet, dove vive la minoranza grecofona d’Albania – è ben distante da Valona, città del tutto albanese per cultura e lingua, la
Grecia, in realtà, non “rivendica da sempre come sua” alcuna terra d’Albania. Se è vero che diversi politici greci (di destra) hanno
sfruttato la questione dei territori dell’Albania meridionale abitati
anche da popolazione di lingua greca, è anche vero che nessun
governo greco dalla fine della seconda guerra mondiale ha mai
avanzato alcuna rivendicazione ufficiale presso alcun organismo
internazionale.
In questi territori (più a sud e più a est di Valona) vive comunque una minoranza di lingua greca e religione ortodossa, riconosciuta ufficialmente dallo Stato albanese (c’è semmai contrasto
tra governo e rappresentanti della minoranza sulla consistenza
numerica della medesima), con il diritto di scuole in greco e quotidiani in lingua e alfabeto greci. Proprio nell’agosto precedente
la crisi albanese si erano aperte tre nuove scuole elementari in
greco, nei distretti di Saranda, Argirocastro e Delvina, frutto dell’accordo del marzo 1996 tra i due governi, di Tirana e Atene
(Human Rights Watch 1997). Restano questioni aperte per la minoranza greca in Albania, ma lo stesso organismo che all’epoca
monitorava in Albania il rispetto degli accordi di Helsinki ammetteva che “la minoranza greca è una parte integrante della società
albanese”. Questo tipo di giornalismo – che trasforma senza argomenti la Grecia in uno Stato pericolosamente irredentista e
l’Albania in un oppressore dei diritti delle minoranze – risente,
oltre che dei suoi oggettivi limiti, della vocazione a “balcanizzare
i Balcani”, ad attribuire cioè pregiudizialmente a tutta l’area genericamente “a sud est” istinti primordiali, siano essi di difesa
del proprio gruppo o di oppressione di quelli altrui.
Questa visione balcanizzante dell’Albania si intreccia con un’altra
dimensione dell’analisi, che indichiamo come “teoria del congelamento”. Secondo questa chiave – applicata con sistematicità durante il crollo della Iugoslavia – quel che è accaduto in Europa
orientale negli anni Novanta sarebbe la ripresa di dinamiche sto-
76
Identità catodiche
Piero Vereni
riche che i regimi socialisti e comunisti non avrebbero fatto altro
che congelare. Così, si è interpretato il presente usando manuali
di storia ed etnologia scritti prima della guerra, presentando di
solito la questione albanese come un token del type balcanico
(“Se si sfoglia un celebre libro sui Balcani, il secondo volume
delle memorie di Raymond Poincaré, intitolato appunto ‘Le
Balkans en feu’, si vedrà quanto fosse intrattabile già allora, nel
1912, la ‘questione albanese’”, «la Repubblica», Viola, 13 marzo);
e si sono spiegati gli eventi caotici e cruenti come un ritorno alle
origini, intendendo con ciò le condizioni socio-economiche precedenti all’insediamento dei regimi comunisti. In tutti i giornali
considerati per questa indagine abbondano gli articoli “storici”
che mostrano le “analogie” tra l’Albania che subì l’invasione fascista nel 1939 e quella dell’operazione Alba. “In queste ultime
due settimane è tornata in scena, infatti, dopo quasi mezzo secolo di stalinismo pastorale e qualche anno di parvenze democratiche, l’Albania dei libri di storia. Un paese arcaico, privo di un
vero cemento statuale, ancora fondato sulle divisioni regionali, il
familismo, il clan e le lealtà tribali” («la Repubblica», Viola, 13
marzo). “Il recupero del passato, del resto, è una chiave fondamentale per interpretare il caso albanese. Il ‘fis’ (clan), il ‘kanun’
(la legge consuetudinaria), la ‘besa’ (parola d’onore), la divisione
tra il Nord ‘ghego’ e il Sud ‘tosco’, le tre religioni (musulmana in
maggioranza, ortodossa nel meridione, cattolica in alcune zone
settentrionali): tutto ciò che era stato soffocato sotto la cappa
della dittatura ideologica, torna prepotentemente alla luce. La
Storia rinasce, come in gran parte dei Balcani” («Corriere della
Sera», Cingolani, 8 aprile). Questo schema interpretativo della
realtà albanese (presentata naturalmente come una “ennesima
versione della ‘poudrière balkanique’”, «la Repubblica», Viola, 13
marzo) ha la curiosa caratteristica di poter essere contraddetto
senza andare in frantumi. Lo stesso Cingolani, che ha appena
scritto che la divisione in clan del paese sarebbe stata soffocata,
congelata dal regime, aggiunge subito: “Le divisioni sono rimaste
pressoché intatte durante la dittatura di Enver Hoxha che impose
un’egemonia dei clan meridionali (era nato ad Argirocastro).
Ramiz Alia, suo successore, fu appoggiato dal Nord, che vedeva
Banditi e invasori
Quando, il 13 del mese, le manifestazioni si intensificano, gli
scontri diventano più gravi e anche il governo di Tirana ammette
che non si tratta più di “pochi facinorosi”, allora sui giornali italiani si alza il tiro. “L’Albania si è dissolta” («Corriere della Sera»,
Cingolani, 14 marzo); “In un paio di settimane la protesta dei
truffati ha cambiato natura, prima è diventata rivolta politica, poi
insurrezione, infine catastrofe umanitaria, politica, diplomatica”
(«Corriere della Sera», Cingolani, 14 marzo). A questo punto il ministro degli Interni “potenziava le frontiere e chiudeva la porta a
nuove possibili ondate di profughi” («Corriere della Sera»,
Cingolani, 14 marzo). Del resto, “L’Albania non c’è più” («Corriere
della Sera», Biagi, 18 marzo). “A Tirana è semplicemente crollato
lo Stato” («il Giornale», Ricossa, 19 marzo). E che sia crollato solo lo Stato è troppo poco per alcuni commentatori: “Ma l’insurrezione è sfuggita agli apprendisti stregoni e si sono scatenate forze ancestrali” («Corriere della Sera», Cingolani, 14 marzo).
77
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
giunto il momento di recuperare il potere perduto” («Corriere
della Sera», Cingolani, 8 aprile).
Una delle forme più compiute in cui compare questa teoria è un
articolo di Sandro Viola: “L’Albania si rivela in fin dei conti identica – almeno per un aspetto – ad ogni altro paese su cui sia
scesa la sventura del comunismo. L’aspetto cioè del congelamento, dell’eclisse solo apparente e temporanea, durante il periodo
comunista, dei suoi mali più antichi. Come in Polonia e in
Ungheria sono riemersi negli anni scorsi gli umori antisemiti, come in Jugoslavia sono esplose le avversioni etnico-religiose che
avevano sempre diviso i popoli della Federazione, così in Albania
sono tornati a galla il disordine, l’irrequietezza dei clan, la pratica del brigantaggio che erano sempre stati i fattori della sua arretratezza. (…) Quattro decenni e più di comunismo hanno lasciato sotto il ghiacciaio del sistema totalitario, sotto la repressione
dello stato di polizia, le cose come stavano. Nulla ha potuto
evolversi, maturare” («la Repubblica», Viola, 16 marzo).
78
Identità catodiche
Piero Vereni
Il climax assume toni da film horror: “In Albania tutto ciò che fa di
una massa di gente un ‘paese’ ossia l’ordine, la legalità, la convivenza, l’amor di patria, la fiducia nell’avvenire, la tradizione, l’economia, la cultura, la religione, sembra svanita [sic] nell’aria per effetto di una magia potente da Signore del Male” («Il Gazzettino»,
Sgorlon, 15 marzo). Il corsivista, che dovrebbe fornire dati essenziali alla comprensione o proporre una griglia interpretativa per dati
già noti, sembra rinunciare al suo ruolo, cedendo alle lusinghe della spiegazione “magica”: “L’Albania, a me sembra, è diventato un
caso clinico della storia e della politica. Ma stiamo attenti, noi italiani… Potremmo essere noi stessi, in un futuro non lontano, contagiati da una qualche forma di sindrome albanese” («Il Gazzettino»,
Sgorlon, 15 marzo). Gli albanesi sono dunque in preda al Male, o a
una malattia contagiosa. Questa analisi “irrazionalista” della crisi
albanese non è rara e qualche giorno dopo affiora prepotente in un
nuovo commento: “(…) ma il grande nemico, lo spirito del male, è
spesso invincibile perché poggia sull’inganno, sulla frode, sul tradimento vergognoso dell’uomo. E in Albania sembra essere sceso in
forze, con una tale violenza da farci dubitare perfino della giustizia
e della verità…” («Corriere della Sera», Bo, 20 marzo). Del resto, del
pericolo di venir infettati dagli albanesi si era appena parlato:
“Questa, come abbiamo già detto, è piuttosto un’invasione di massa, (…) una marea capace di esportare sul nostro territorio il virus
del disordine e della rivolta” («la Repubblica», Valentini, 19 marzo),
e ne accennerà ancora il decano dei giornalisti italiani: “(…)
l’Albania con i suoi virus di decomposizione e di guerra di bande”
(«Corriere della Sera», Montanelli, 30 marzo).
Il paradosso comunicativo è evidente. Nei corsivi sembra saltare
qualunque tentativo di spiegare razionalmente una sommossa
popolare in gran parte comprensibile data l’entità della crisi finanziaria, e si cede chiaramente proprio a quel richiamo “illogico” e “irrazionale” che affliggerebbe gli albanesi: di fronte al
Male non resta altro che il silenzio, o il rituale apotropaico, per
allontanarlo (dalle nostre coste, ovviamente).
I corsivisti fanno presente fin dall’inizio quale sia il vero rischio di sottovalutare la crisi albanese: “È nostro interesse ri-
79
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
portare a Tirana un dialogo corretto tra governo e opposizione
(…) Se questo non dovesse avvenire aspettiamoci nuove invasioni di profughi. Più di quelle che quotidianamente già abbiamo” («Il Gazzettino», Cerruti, 2 marzo). Non è chiaro cosa intenda Cerruti per “invasioni quotidiane”, ma l’equivalenza tra
sottovalutazione della crisi e invasione di albanesi è ribadita
anche sul «Corriere della Sera» (Venturini, 4 marzo): “L’Italia
può e deve stanziare aiuti immediati (…) ben sapendo che costerebbe assai più caro un nuovo assalto alle nostre coste come quello dell’estate ’91”.
Un’altra voce autorevole: “Adesso c’è il rischio di una invasione
alla rovescia, il terrore che la Guardia di finanza debba lanciare il
grido delle vedette della Wehrmacht sul Vallo Atlantico: ‘Sie kommen’, arrivano” («Corriere della Sera», Biagi, 5 marzo).
La minaccia dell’invasione conferma la necessità di un intervento
italiano, visto che se l’Italia non entrasse in gioco: “Quelle che
vediamo arrivare sulle nostre coste diventerebbero allora le timide avanguardie di un popolo in fuga che non potremmo né
avremmo il diritto morale di respingere” («Corriere della Sera»,
Venturini, 15 marzo).
L’escalation prospettata è terribile: “A questo punto tutto è possibile, anche l’impensabile: cioè la sparizione di uno Stato, la
disgregazione di ogni forma di convivenza. Dal caos può uscire
perfino un’orgia di rissa etnica senza confini ma non senza precedenti” («il Giornale», Pasolini Zanelli, 14 marzo). Cosa si intenda per “precedenti” è presto detto: “L’Albania potrebbe trasformare l’Europa nel ventre molle occidentale, come la trasformò la
Bosnia” («Corriere della Sera», Caretto, 17 marzo). “L’Albania, come la Bosnia, non è un fatto nostro: ma un problema dell’Europa. Può essere l’inizio di una catena di guai per tutti” («Corriere
della Sera», Biagi, 18 marzo).
Altro pericolo incombente sono le ripercussioni razziste che si
potrebbero avere in Italia: “E speriamo, questo sì, che la loro
presenza [in Italia] non inneschi da noi quei furori elettorali che
in Austria hanno fatto la fortuna di Haider, che in Francia soffiano
ancora nelle vele del Fronte nazionale” («Corriere della Sera»,
Venturini, 19 marzo).
80
Identità catodiche
Piero Vereni
Le tinte fosche con cui si raccontano l’Albania e i suoi abitanti si
incupiscono ancor più dopo la metà di marzo, quando l’Italia si
“rende conto” di dover affrontare quel che più spesso viene definito un “esodo”.
“l’esodo degli albanesi verso le coste italiane ha assunto le proporzioni di una fuga di massa” («Corriere della Sera», Venturini,
19 marzo). “(…) esodo albanese, che ha un sapore biblico” («il
Giornale», Sterpa, 21 marzo). E ormai si parla di “Puglia invasa
dagli albanesi (…). La gente [italiana] si è comportata bene, ha
mostrato di capire e compatire malgrado l’impatto tremendo dell’invasione” («Il Gazzettino», Pezzato, 19 marzo). Forse, a distanza
di anni, è utile ricordare che fino a quella data la cosiddetta invasione riguardava meno di diecimila persone.
Nonostante alcuni appelli alla calma, predomina una visione apocalittica: “Stiamo difendendo la nostra frontiera, le nostre città,
le nostre famiglie e i nostri figli” («il Giornale», Giannattasio, 28
marzo). Sono pochissimi gli esempi, in questi giorni, di corsivi
improntati alla moderazione dei toni e degli animi: “È solo che ci
saremmo aspettati che tanti anni e tanti fiumi di inchiostro spesi
in predicazioni e sermoni a favore della tolleranza (…) avrebbero
aiutato un popolo di cinquantasette milioni di benestanti a mantenere i nervi saldi e a non scambiare diecimila albanesi per l’invasione dei Visigoti” («la Repubblica», Polito, 27 marzo).
Mentre si rimodella la questione albanese (da fenomeno in fin
dei conti ancora esotico, limitato all’oltre sponda, a questione
interna italiana) si ridisegna anche l’immagine degli albanesi.
Prima di tutto quelli lì, in Albania, che tendono a incupirsi nelle descrizioni dei corsivisti: “La ‘terra delle aquile’ è in mano
agli sciacalli. Bande di uomini mascherati scorrazzano per le
città e i villaggi” («Corriere della Sera», Cingolani, 14 marzo).
Qualcuno tenta un’analisi politica e sociologica per spiegare il
mutamento di prospettiva da cui osservare gli insorti: “quella
che sembrava una rivolta popolare contro una truffa finanziaria
si è rapidamente trasformata in una guerra di bande, gestite
da loschi burattinai: ex dirigenti comunisti, mafiosi locali infiltrati dalla criminalità organizzata internazionale e soprattutto
81
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
italiana, cani sciolti della polizia segreta allenati a pescare nel
torbido e a sobillare le masse” («la Repubblica», Garimberti,
14 marzo). Qualcuno punta invece decisamente sulla fisiognomica: “Gruppi di rivoltosi presidiano i tornanti che si inerpicano sulle montagne brulle. Volti di pastori, contadini, sottoproletari urbani si mescolano alle facce sanguigne di ex ufficiali
alla ricerca di un riscatto, o alle sembianze oscure degli agenti
disseminati dalla polizia segreta” («Corriere della Sera»,
Cingolani, 14 marzo).
La natura attualmente feroce degli albanesi può essere messa in
risalto anche dal contrasto con la bontà italiana del 1991: “I pugliesi furono meravigliosi nel protendersi verso questa gente che
arrivava macilenta e stanca. Aprirono le loro case, persino i bagni, e non è mica normale. E ci siamo ritrovati, dopo pochi anni,
migliaia di prostitute e un sacco di ragazzini ai semafori schiavizzati dai loro zii. Che bella bontà” («il Giornale», Farina, 27 marzo). Oppure il contrasto si pone tra presente feroce degli albanesi e loro passato pacifico: “Un tempo avevano la religione, la tradizione, il buon senso dei contadini. Oggi non hanno più nemmeno queste cose. E meno che mai la fierezza del proprio passato” («Il Gazzettino», Sgorlon, 15 marzo).
Se questa è l’immagine sempre più fosca e insieme più vaga,
meno dettagliata, degli albanesi d’Albania, quelli che cercano di
arrivare qui sono studiati con più precisione.
Una delle descrizioni assieme più analitiche e più “fantasmatiche” di coloro che stanno arrivando (a quanto pare albanesi e
non, ma Arbasino è di proposito abbastanza ambiguo da far sì
che le accuse agli uni possano cadere anche sugli altri) è quella
proposta da un nome di grido: “Ospiti balcanici che si presentano in compagnia del kalashnikov, per la consuetudine etnica al
saccheggio che (secondo gli storici) precedeva da secoli i traumi
per la caduta del comunismo (…). Ospiti che sistemano valigie di
bustine in casa e in macchina, accompagnano gruppi di piccine
minorenni sui viali ‘del vizio’, si sistemano frotte di pupi laceri e
affamati e picchiati ogni giorno ai semafori (…). Ospiti che si battono a coltellate con bande di altri ospiti per il controllo del territorio, secondo i costumi africani descritti dagli antropologi e ri-
82
Identità catodiche
Piero Vereni
visti spesso in televisione per indurci a sensi di colpa” («la
Repubblica», Arbasino, 15 marzo). Notevole, in questo fosco quadro, il ruolo attribuito all’antropologo…
Sempre su «la Repubblica», ma qualche giorno dopo, si tenta invece l’operazione inversa, di spiegare con la giusta dose di ironia perché gli albanesi sarebbero così diversi dagli altri immigrati
(e così diversamente trattati): “gli albanesi sono alquanto refrattari a indossare i panni dei nuovi schiavi dell’Occidente. Quindi,
poco utili. Non sono cristianamente remissivi come i filippini,
non amano i bambini come le colf somale, non fanno i muratori
per quattro lire come i polacchi, non vendono cianfrusaglie come
i senegalesi. Più che essere comandati, a loro piace comandare”
(«la Repubblica», Polito, 27 marzo).
Senza essere categorici come Biagi (“Da loro riceviamo, per l’interscambio, marijuana, e anche braccianti senza diritti, ragazze
da avviare al marciapiede, e organizzatissimi criminali. Punto”
(«Corriere della Sera», Biagi, 5 marzo) tutti i commentatori puntano comunque su una questione sentita come centrale, non appena arrivano le prime navi: come distinguere il grano dal loglio?
Coloro che hanno diritto di asilo da quelli che invece dovrebbero
essere scacciati? Il quesito rivela il diritto degli italiani a sospettare, sempre, in modo sistematico. “Per intervenire efficacemente
dovremmo avere notizie sicure e sapere se chi chiede aiuto e
asilo è veramente uno che chiede la carità (oggi si chiama solidarietà) oppure uno che veste di abiti del derelitto e sfrutta, ingannandolo, chi è pronto a venirgli in soccorso” («Corriere della
Sera», Bo, 20 marzo). Come a dire che siamo di fronte a una “invasione di disperati, ma anche di delinquenti” («il Giornale»,
Giannattasio, 28 marzo).
Se per alcuni “tra mamme e bambini si nascondono gruppi di
evasi per i quali è previsto il rimpatrio automatico” («Corriere
della Sera», Venturini, 19 marzo), dando così l’impressione che
tra i molti poveracci si nasconda qualche criminale, per altri il
rapporto è inverso: “tra i boat-people dell’Adriatico ci sono più
mafiosi che fuggiaschi e accoglierli tutti, aiutandoli perfino ad arrivare in porto quando le loro carrette non ce la facevano ‘è stata una pazzia’” («il Giornale», Caputo, 22 marzo).
83
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
L’aspetto che colpisce di più in questo tipo di argomentazioni è
ciò che potremmo chiamare “la natura oggettiva e dicotomica
del male”. La distinzione tra buoni e cattivi è in questi corsivi
sempre netta e senza appello. È arduo distinguere i due gruppi
in concreto, ma nessuno mette in dubbio che di due gruppi si
stia parlando. “Quanti saranno i ‘poco di buono’ arrivati con gli
11 mila albanesi? Sta di fatto che la fuga caotica di donne, uomini, e bambini verso la Puglia, e di qui verso il resto della
Penisola, si è rivelata quello che il filtro della solidarietà non ci
aveva consentito di vedere con chiarezza: un esodo in parte cinicamente organizzato dalle mafie a un milione pro capite,
viaggio gratis per i bambini perché inteneriscono gli italiani e
ammorbidiscono i controlli” («Il Gazzettino», Pezzato, 20 marzo). È evidente la rappresentazione degli albanesi come popolo
miticamente dicotomico rispetto alla morale, senza le ovvie sfumature, ambiguità e sovrapposizioni che ci caratterizzano:
ognuno di loro può (e quindi deve) essere collocato o tra i
buoni o tra i cattivi.
Quando la divisione non si limita ad attraversare le generazioni
(bimbi buoni, adulti cattivi) passa allora anche tra i sessi:
“Capisco le donne e i bambini. Capisco i ragazzini di quindici anni, meglio qui che là a imbracciare Kalashnikov. Capisco i vecchietti, gli storpi e i ciechi. Ma non capisco quell’orda di uomini
d’età compresa fra i 20 e i 50 anni, che arrivano in massa e intervistati confessano di non avere uno straccio di documento né
di voler fornire le generalità e di non essere arrivati per accompagnare figli neonati o madri ottuagenarie. Invece sono qui per
scelta individuale, e l’ottuagenaria l’hanno lasciata in Albània
[sic] a difendere la casa (…) Sono giovani, forti. E scappano.
Disertori non solo nell’esercito e nella polizia: disertori nell’animo e nella vita” («il Giornale», Vigliero Lami, 18 marzo). Così riporta Livio Caputo una discussione cui ha assistito tra “un sindacalista della Cgil e un suo amico della stessa parrocchia”: “Essi
hanno sostenuto la tesi, tutt’altro che peregrina, che il governo
doveva ammettere sul territorio italiano soltanto le donne, i
bambini e gli anziani, spesso usati dai mafiosi come ‘schermo’ e
rimandare invece immantinente in Albania tutti gli uomini validi
84
Identità catodiche
Piero Vereni
che, anche a giudicare dai loro ceffi, non avevano davvero molto
bisogno di protezione” («il Giornale», Caputo, 22 marzo).
Sono pochi quelli che tentano una difesa “globale” degli albanesi in arrivo: “Via, presi nell’insieme sono dei poveracci e fanno
bene i nostri governanti a non avere il cuore di buttarli a mare”
(«la Repubblica», Bocca, 19 marzo). Affiora un tema che diverrà
comune tra qualche giorno, dopo una tragedia che segnerà uno
spartiacque, il tema degli albanesi come nostri antenati, come
doppio grottesco degli italiani: “Li guardi un po’ in faccia, questi
immigrati, onorevole Brighella (onorevole Arlecchino, onorevole
Pantalone), non le ricordano nessuno? Non le ricordano, per caso, suo nonno, quello che mangiava la carne una volta al mese,
quello che stava sulla groppa di un somaro? (…) Fanno paura,
evidentemente, i ragazzi che assomigliano ai nostri nonni”
(«Corriere della Sera», Zincone, 28 marzo).
Ma i giudizi cominciano a farsi pesanti e verso il 25 marzo si comincia a parlare di “battelli stracarichi di falsi profughi (ossia di
disperati che in realtà sono soltanto degli emigranti abusivi reclutati e sfruttati da bande di filibustieri locali)” («il Giornale»,
Guarini, 25 marzo). A questo punto, il dilemma morale di distinguere tra albanesi buoni e albanesi cattivi sembra inclinare verso
soluzioni radicali: “I nostri sentimenti sono confusi: adotteremmo i bambini albanesi, ma i loro padri li sbatteremmo volentieri
in galera, o addirittura in fondo al mare, visto che sparano” («il
Giornale», Farina, 27 marzo).
Il giorno dopo, infatti, Venerdì Santo, la nave albanese Kater I
Rades veniva speronata dalla nave Sibilia della marina italiana,
che cercava di bloccarne l’ingresso in acque italiane. A seguito
dell’affondamento, morirono in mare almeno 58 albanesi. Lo
choc è immediato. Sembra che si sia realizzato qualcosa di terribile, ma che tutti, in Italia, in qualche modo, in qualche anfratto impresentabile della coscienza collettiva, desideravano
che accadesse.
L’affondamento della Kater I Rades del 28 marzo segna un punto
di non ritorno nell’analisi dei corsivisti italiani. Assieme allo sgomento, si affacciano i primi seri dubbi su come sia stata raccontata, fino a quel punto, la “crisi albanese”: “In effetti, nessuno di
85
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
noi potrebbe spiegare con un minimo di precisione che cosa stia
accadendo in Albania. Tutto quel che ci è chiaro, dopo cinquanta
giorni di convulsioni, è che l’Albania è un paese sconosciuto.
Indecifrabile” («la Repubblica», Viola, 30 marzo).
Il cosiddetto problema degli albanesi viene riportato alle sue
reali dimensioni con più fermezza: “Ma noi entriamo in crisi psicologica perché dodicimila albanesi sono sbarcati (e già quasi
duemila sono stati riportati al paese di origine con metodi abbastanza spicci). Noi insceniamo ogni giorno uno psicodramma con
sindaci muniti di tanto di fascia tricolore che scavano fossati, rifiutano accoglienza…” («la Repubblica», Scalfari, 30 marzo).
Ancora: “Mi ribello all’idea che si nasconda razzismo, intolleranza, meschinità, dietro il paravento della drammatizzazione del
problema dei quindicimila albanesi arrivati in un paese di quasi
sessanta milioni di abitanti in cui già ci sono fra un milione e
due milioni di extracomunitari. In realtà si tratta di un problema
relativamente modesto trasformato in un caso nazionale” («Il
Gazzettino», Acquaviva, 3 aprile).
Nell’insieme si assiste a un ridimensionamento del linguaggio e
del tono: l’Albania è un paese in crisi, ma non più quella bolgia
infernale, quel non-luogo maledetto dagli dei raccontato solo
una settimana prima: “In Albania non esiste una guerra civile,
quelli che hanno raso al suolo università, uffici, caserme, persino
i canali di irrigazione erano mossi da una decennale carica di
rancore per un regime ormai morto e non degnamente sostituito
(…). La stragrande maggioranza degli albanesi vuole solo ritornare a una vita decente, ha come si è visto dalle trasmissioni televisive, un rispettabile nucleo di società civile, una tradizione culturale” («la Repubblica», Bocca, 12 aprile).
Ma col passare dei giorni l’Albania tende a sfumarsi in dissolvenza, per lasciare spazio sempre di più all’Italia e alle conseguenze
in Italia di un possibile intervento armato in Albania. Questo sia
sul versante interno: “Al quinto giorno [dopo l’affondamento] tutto o quasi è finito in politica interna” («la Repubblica», Fuccillo, 3
aprile); sia per l’immagine e il prestigio italiani: “Il successo
dell’Operazione Alba vale dieci ‘manovrine’ per Maastricht. Un fiasco confermerebbe i nostri partner nel già radicato pregiudizio an-
86
Identità catodiche
Piero Vereni
ti-italiano e ci lascerebbe ai margini dell’Europa per il futuro prevedibile” («la Repubblica», Caracciolo, 8 aprile). Per essere chiari:
“l’Italia si gioca più di quanto creda. Anzi, si gioca tutto. Perché
l’incrocio con la tragedia albanese strappa l’Italietta dell’Ulivo all’eterno teatrino e la pone davanti a un’alternativa grave. Se la
missione Alba avrà successo, il nostro Paese e il governo ne riceveranno enorme prestigio (…). E a quel punto, parametri o non
parametri, toccherà a Germania e Francia preoccuparsi di imbarcare l’Italia nel pullman di Maastricht, anche a prezzo di uno sconto
sulla tariffa. Al contrario, se Alba si tradurrà in un disastro (…) allora non ci saranno parametri o finanziarie o manovrine o larghe
intese che possano tenere” («la Repubblica», Maltese, 16 aprile).
Paradossalmente, l’Italia di quei giorni sembrò decidere di andare
in Albania come via più diretta per “entrare in Europa”. L’impegno
militare degli italiani veniva assunto, prima di tutto, di fronte alla
comunità internazionale e ai partner dell’Unione Europea, per far
vedere che l’Italia non era più il coacervo pavido e bizantino
uscito dalle macerie della seconda guerra mondiale. Assistiamo
quindi a una precisa inversione delle identità: non è l’Albania
che deve dimostrare di essere uno Stato e una nazione. Questo
carico simbolico ora grava sull’Italia.
Non mancano quindi le impennate di orgoglio nazionale fin da
quando un editoriale del «Times» critica la proposta di un intervento diretto italiano sul suolo albanese: “l’editoriale del Times
contro l’imminente intervento italiano in Albania (…) rispecchiava benissimo il senso di superiorità e gli stereotipi che da sempre nutrono l’atteggiamento dei sudditi di sua Maestà verso gli
italiani” («Corriere della Sera», Panebianco, 4 aprile). Lo stesso
Panebianco sottolinea poi a sua volta le conseguenze politiche
che la futura “operazione Alba” potrà avere non tanto
sull’Albania (tema questo del tutto secondario) quanto sull’immagine dell’Italia all’estero: “abbiamo forse ora la possibilità, se
sapremo comportarci correttamente sia sotto il profilo tecnico
che sotto quello politico, di assestare un colpo ai tanti pregiudizi negativi – spesso non privi di fondamento – sugli italiani, da
sempre sedimentati nelle opinioni pubbliche e nelle classi dirigenti europee (non solo del Regno Unito)” («Corriere della
Il carnevale delle identità
Il nuovo tono nel parlare dell’Albania e l’attenzione sempre maggiore prestata al ruolo che questo paese può giocare per l’Italia
possono essere visti come gli ultimi sintomi di un’inversione, di
un “carnevale” provocato dagli albanesi con la loro presenza e
che aveva iniziato a manifestarsi già prima dell’affondamento:
“durante la trasmissione di attualità Italia Radio (emittente notoriamente vicina al Pds), è intervenuta una signora romana: ‘Ho
famiglia, siamo otto persone, tutte di sinistra. Ieri sera ci siamo
riuniti per vedere Moby Dick sull’Albania. Ebbene, alla fine abbiamo convenuto tutti che aveva ragione Gasparri, il deputato di An
cui durante la campagna elettorale mi ero perfino rifiutata di
stringere la mano. E su certi punti aveva ragione perfino
Tablandini della Lega. I miei, un disastro’” («il Giornale», Caputo,
22 marzo). Caputo non è l’unico ad ascoltare Italia Radio, quei
giorni: “Provate a sentire Italia Radio, l’emittente del Pds. Ogni
mattina, al suo filo diretto, si scarica la rabbia di abituali buonisti che minacciano sfracelli se non si ferma l’invasione” («la
Repubblica», 27 marzo).
Un sintomo chiaro è la confusione tra destra e sinistra: “Qui [anche a sinistra] si registra una ostilità dura e compatta contro gli
albanesi. Una pioggia di telefonate esprime sentimenti che sembrano costole della Lega” («Corriere della Sera», Zincone, 28
marzo). “‘Buttiamoli a mare, buttiamoli a mare’. Nei giorni scorsi
l’invocazione sibilava tra le labbra di tanti, troppi italiani. La si
sentiva nei bar del Nord, ma anche nei caffè del Centro o del
87
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
Sera», Panebianco, 4 aprile). L’Albania diviene dunque il luogo
del riscatto dell’identità italiana, il pretesto per mostrare ai partner europei la qualità della nazione. La questione italo-albanese
va misurata non tanto per le possibilità che oggettivamente
l’Italia ha di migliorare la situazione politica ed economica del
paese oltre Adriatico, ma solo ed esclusivamente per quanto
l’Albania possa, nel bene e nel male, influire sull’immagine
dell’Italia all’estero.
88
Identità catodiche
Piero Vereni
Sud. I sindaci leghisti vogliono alzare le barriere per difendere la
purezza delle loro città. Ma anche quelli di sinistra chiedono al
governo di risparmiarli, per carità, dall’invasione, supplicano di
lasciare i barbari alle porte” («Corriere della Sera», Cingolani, 29
marzo). “Perché la parte più progressista della nostra opinione
pubblica sta riservando agli albanesi un trattamento che mai si
sarebbe permesso nei confronti di somali e marocchini, senegalesi e filippini?” («la Repubblica», Polito, 27 marzo). Tra le possibili risposte a questa domanda una val la pena di essere citata
perché ben si accorda con quanto stiamo dicendo sul “carnevale” albanese: “La prima ragione che ci viene in mente è che gli
albanesi hanno la colpa di essere bianchi, somaticamente non
distinguibili da un italiano qualsiasi (…). Poco diversi, troppo simili” («la Repubblica», Polito, 27 marzo).
Ci si rende subito conto, dopo l’affondamento della nave, del
ruolo attivo che hanno gli albanesi per la costruzione di noi stessi come italiani: “La vicenda degli albanesi ci ha messo a nudo
(…) davanti a noi stessi, come di fronte ad uno specchio che riflette un’immagine reale e non deformata. Nessuna illusione ottica, siamo proprio così” («Il Gazzettino», Pittalis, 1 aprile). Chi
non ama questa immagine preferisce invece attribuire agli albanesi un ruolo magico, di tricksters in grado veramente di ribaltare l’Italia: “Con il pianto, e con i soldi di Berlusconi a 34 superstiti, l’inversione dei ruoli è proprio completata: la destra si fa sinistra e viceversa” («Corriere della Sera», Merlo, 1 aprile). Lo
stesso identico concetto, lo stesso giorno, ma su un altro giornale: “la sinistra ha lasciato a Berlusconi uno spazio suo proprio,
quando il Cavaliere ha ripetuto che un Paese di 50 milioni di abitanti non può lasciarsi dominare dal panico politico per l’arrivo
di 10 mila profughi. C’è stata cioè una singolare inversione dei
linguaggi, se non delle parti” («la Repubblica», Mauro, 1 aprile).
Ma tutti – che si parli di svelamento o di ribaltamento dell’identità – sono concordi sul senso totale di straniamento: “Strani [gli
italiani], perché non si era mai visto un governo di centrosinistra,
e per di più sorretto dagli ultimi comunisti, beccarsi del fascista
persino dai giovani norvegesi. Strani perché con la stessa bocca
predichiamo la solidarietà e poi gridiamo ‘buttiamoli a mare’.
89
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
Strani perché a guardare la tv, pubblica e privata, sembra che il leader dei progressisti sia un reazionario e quello dei moderati un rivoluzionario” («Il Gazzettino», Pittalis, 1 aprile). Ancora una volta
torna la metafora del contagio: “Sembra quasi che per contagio la
disgregazione albanese abbia colpito la nostra classe politica” («Il
Gazzettino», Sensini, 2 aprile). Fatto sta che “dove finisca la maggioranza e finisca l’opposizione è difficile dire” («la Repubblica»,
Bocca, 3 aprile), e quando si parla di “un Paese governato dall’incertezza, e con una maggioranza inesistente” («il Giornale», Cervi, 4
aprile), non è più all’Albania che si fa riferimento, come due mesi
prima (“Tutti sono contro tutti. Non c’è più maggioranza, non c’è
mai stata opposizione”, «la Repubblica», 11 febbraio) ma all’Italia.
La metamorfosi, per effetto del contatto con gli albanesi, sembra estendersi dal mondo politico per coinvolgere tutti: “il nostro strano Paese assiste a troppi rigurgiti di intolleranza.
Convinto di essere cattolico e solidaristico come pochi, all’improvviso si sveglia con la voglia di gettare in mare un popolo
in fuga. E, cosa incredibile, per poco non ci riesce” («Il
Gazzettino», Pittalis, 1 aprile). “Italia: fino a ieri il paese dell’amore e del sole, tutto spaghetti, chitarre e mandolini. Oggi,
razzista, cinico e egoista” («Il Gazzettino», Acquaviva, 3 aprile).
“il ceto politico e la stampa rispecchiano gli elettori e i lettori
che in questa fase della nostra storia non sembrano più gli ‘italiani brava gente’ ma una collettività ansiosa, che non crede in
se stessa, che pensa di sopravvivere innalzando alle frontiere
‘cortine di acciaio’” («la Repubblica», Bocca, 3 aprile). “Prima
c’era un paese che, tutto sommato compatto, pensava e diceva
di trovarsi di fronte a un’immigrazione clandestina e di massa
dall’Albania. Quindi: accoglienza, controllo e rimpatrio.
Opinione pubblica, istituzioni, governo, maggioranza e opposizione stavano tutti più o meno scomodi dentro questo triangolo. Dopo i morti, gli immigrati sono ridiventati profughi e ciascuno ha mutato la sua parte in commedia (…) c’è stata quella
notte, ha sconvolto gli animi e distorto i comportamenti” («la
Repubblica», Fuccillo, 3 aprile).
Un modo interessante di guardare al problema è quello proposto
da Ernesto Galli della Loggia, in un fondo apparso sul «Corriere
90
Identità catodiche
Piero Vereni
della Sera» il primo aprile, subito dopo l’affondamento della
Kater I Rades: “Ma come è possibile che una nazione di sessanta
milioni di abitanti, che una grande e ricca nazione europea come
l’Italia si faccia spaventare da qualche migliaio di profughi albanesi a tal punto che sembra quasi non vi sia più una città, un
paese, un comune disposti ad accoglierne neppure qualche decina? (…) È possibilissimo, invece: sono il benessere e il timore di
perderlo, è la diffusione ormai senza limiti di valori e di stili di
vita ispirati al materialismo e al consumismo (…). La realtà è che
se una nazione di sessanta milioni di abitanti, se una ricca e
grande nazione come l’Italia si fa spaventare da una manciata di
profughi albanesi è precisamente perché essa non si sente affatto una nazione. (…) Gli italiani, dal canto loro, non si percepiscono come gli abitanti di questo vasto insieme nazionale quanto
piuttosto gli abitanti di una somma di comunità sparse, legate
da un debole e malcerto vincolo. Gli albanesi spaventano e inducono al rifiuto precisamente perché sono visti non già come dei
profughi che arrivano in Italia, in una grande nazione, bensì come degli intrusi non invitati in questa o quella delle tante comunità di cui sopra”. La tesi trova consensi: “Ernesto Galli della
Loggia sul «Corriere della Sera» ha analizzato bene gli umori degli italiani nella crisi albanese. Noi, dice l’autore, non siamo né
razzisti, né egoisti, né insensibili, siamo soltanto orbi della nazione e orfani dello Stato (…). Tutto questo è molto triste. Senza
nazione e senza Stato non si va lontano, si può essere sconfitti
anche in una battaglia non combattuta contro i pezzenti, nel canale d’Otranto” («il Giornale», Scarpino, 3 aprile).
È impressionante leggere, ora, degli italiani come di un popolo
“senza nazione e senza Stato”, quando per un mese erano stati gli
albanesi a essere descritti così. Marcello Veneziani riprende l’argomento di Galli della Loggia esasperando il gioco degli specchi incrociati: “Gli italiani temono ondate di immigrati albanesi non perché siano razzisti o sciovinisti, ma per due opposte ragioni. Perché
vedono gli albanesi come degli italiani affamati, li temono perché
sono la nostra versione primitiva. E temono di mettere a repentaglio il benessere, la sicurezza, la modernità: li spaventa l’arretratezza, la puzza del nostro passato. E poi li respingono non per or-
Albanesi e ballerini
Questo ripensamento di sé partito dall’Italia attraverso l’incontro/scontro con l’altro è esattamente quel che gli albanesi, nel
1997, stavano sistematicamente vivendo da oltre un decennio,
da quando cioè il cronico isolamento imposto dal regime – ricordo solo che il confine di Stato era preceduto da un confine interno che creava una fascia-cuscinetto spessa alcuni chilometri, cui
potevano accedere solo gli autorizzati – si era allentato nella seconda metà degli anni Ottanta per crollare del tutto nel 1990.
L’apertura al confronto con l’altro (è noto in questo senso il ruolo giocato dalla televisione italiana, soprattutto commerciale) ha
prodotto per anni una bassa autostima sociale.
Il più famoso intellettuale albanese, Ismail Kadarè, ha parlato all’epoca di una “psicosi pessimista che imperversa da alcuni anni
in Albania. Questa volontà di autodenigrazione, autoavvilimento
e di autodistruzione che porta a ripetere giorno e notte che questo paese è maledetto, non ha un futuro e merita di sparire è diventata una moda in alcuni ambienti” («la Repubblica», Kadarè,
13 marzo).
Non vi è dubbio che la dittatura comunista di Hoxha si sia retta,
oltre che su uno spietato Stato di polizia, anche sull’orgoglio nazionale, profuso in quantità massicce dal potere attraverso tutti i
canali della propaganda. Gli albanesi nati nel secondo dopoguerra sono cresciuti nella ferma convinzione (suffragata da continui
indizi di tipo linguistico, affermazioni, discorsi, e mai smentita da
una verifica su modelli diversi, invisibili) di appartenere a una
nazione antichissima, fiera quante altre mai e di gente industriosa e capace.
La fine della dittatura ha riportato gli albanesi di fronte alla necessità di fare i conti con il giudizio degli altri, delle altre nazioni
91
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
goglio nazionalista ma al contrario, perché temono la fragilità del
nostro sgangherato sistema Paese, con tante piccole Albanie e disoccupazione. Non si fidano dell’Italia e si sentono una comunità
nazionale spappolata” («il Giornale», 5 aprile).
92
Identità catodiche
Piero Vereni
di fronte alla propria. Gli antropologi sanno benissimo quanto
questo giudizio da parte dell’Altro sia un elemento fondamentale
per la costruzione di sé come comunità etnica e/o nazionale
(Jenkins 1997). Per ragioni esclusivamente storiche e contingenti
la nazione albanese si era costruita in quasi totale assenza del
giudizio altrui. Apparenti eccezioni hanno costituito il contatto
con l’Unione Sovietica prima e con la Cina poi, fino al 1978, ma
in entrambi i casi la possibilità di giudicare ed essere giudicati
veniva di molto limitata dall’ideologia inter-nazionalista che faceva dei sovietici e dei cinesi non un Altro da valutare e da cui essere valutati, ma piuttosto un Simile. Tanto simile da dover essere tenuto a distanza, in ogni contesto per cui il contatto non fosse strettamente necessario. In sintesi, gli albanesi avevano un’idea di sé che si basava solo su un giudizio interno, giudizio assai benevolo e indulgente. Il contatto prima mediatico e poi diretto con l’Occidente ha letteralmente spazzato via questo giudizio. Il fiero popolo albanese, cui era stato detto che stava costruendo il paese più evoluto del mondo, si è reso conto che gli
equivalenti degli scassati trattori cinesi con cui coltivava la terra
non erano più usati in Occidente da diversi decenni; che le poche fabbriche nazionali producevano pezzi di qualità peggiore di
qualsiasi concorrente dell’Ovest; che insomma la superiorità naturale del popolo albanese veniva messa in discussione dalla
realtà quotidiana che filtrava dalle televisioni e, dopo il 1990
sempre più frequentemente, dai racconti di chi tornava da viaggi
all’estero.
C’è un indizio linguistico evidentissimo di questo tentativo di ricostruire un’immagine di sé come popolo che tenga conto del
giudizio altrui. Come è noto “Albania” è un termine prima romano poi bizantino per designare una regione chiamata invece dagli abitanti “Shqipëria”. Allo stesso modo, quelli che tutto il
mondo chiama “albanesi” (con le diverse varianti, Albanians,
Alvanoi, ecc.) chiamano se stessi “Shqiptarë”.
Con due amici italiani ero alla fine del 1996 in un villaggio nel
sud-est del paese. In macchina con noi c’era un ragazzo albanese, Madin. Lo conoscevo da tempo, e normalmente comunicavo
con lui tramite il mio collega Gilles de Rapper, che però era tor-
93
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
nato in Francia. Madin fortunatamente parlava un po’ di greco,
per cui riuscivamo a comunicarci l’essenziale. I due amici italiani
volevano visitare la moschea, costruita da poco. Con la macchina
ci avviammo lungo una strada fangosa che presto si restrinse a
sentiero. Forse un chilometro prima della moschea la strada era
bloccata da una macchina in sosta nella direzione opposta alla
nostra, con l’autista al volante. Avrebbe potuto accostare alla
sua sinistra, c’era uno spiazzo libero di fronte a una casa, ma si
vedeva che aveva difficoltà a far manovra con scioltezza, e rischiava quasi di venirci addosso. Madin guardò con aria di sberleffo mista a disprezzo il maldestro autista, e lo apostrofò con
un “Albanes!” che, dal tono con cui venne pronunciato, significava con tutta evidenza: “Imbranato!”. Chiesi comunque a Madin
di ripetere quel che aveva detto, forse avevo capito male, e lui
mi spiegò in greco che quello “Odigài san alvanòs”, letteralmente: “Guida come un albanese”.
Mi spiegò poi che il termine era ormai d’uso comune, per indicare i fessi, gli incapaci, gli ignoranti. La parola che in tutto il mondo indica gli albanesi è diventata in Albania un termine spregiativo usato come un insulto. Per la Shqipëria, fare i conti con
l’Albania, con le immagini delle navi cariche verso la Puglia, degli uomini rinchiusi negli stadi, ha significato dover affrontare un
giudizio radicalmente diverso e negativo e gli shqiptarë, tanto
orgogliosi d’esserlo, fieri della loro storia e della loro cultura, capiscono che noi non li consideriamo altro che albanesi.
Ma quest’immagine sbiadita e irrimediabilmente negativa dell’identità albanese si è lentamente e parzialmente modificata, almeno in Italia. Il mutamento, che riguarda assieme la categorizzazione esterna (cioè il modo in cui gli italiani vedono gli albanesi) e l’identificazione interna (cioè il modo in cui gli albanesi
vedono se stessi) ha iniziato a prendere forma all’inizio del terzo
millennio, grazie a una serie di eventi in parte casuali.
Tra gli albanesi giunti in Italia con la prima ondata del 1991 c’è
anche un ragazzo diciassettenne di nome Kledi Kadiu. Di “buona
famiglia” (madre farmacista e padre docente universitario), Kledi è
appassionato di danza fin da bambino, e i genitori l’hanno iscritto a dieci anni all’Accademia Nazionale di Tirana, poco distante
94
Identità catodiche
Piero Vereni
dalla casa dove è cresciuto. È il 1984, Enver Hoxha sarebbe morto
l’anno successivo, e in Albania diventa sempre più facile guardare
i programmi della televisione italiana, prima per semplice debordamento hertziano, e poi tramite le parabole in grado di ricevere
il segnale satellitare. Kledi balla e guarda la televisione italiana, e
le due attività diventano parte di un solo progetto, che così oggi
viene raccontato nelle note biografiche del suo sito ufficiale
(http://www.kledi.it/Biografia.html): “Rimanevo affascinato dai
grandi artisti Italiani di quel periodo come Heather Parisi, Lorella
Cuccarini, Raffaella Carrà, Raffaele Paganini. Ricordo che mi divertivo a sognare di ballare al loro fianco, in un grande show”.
Come sappiamo, si tratta di un sognare che diventa progetto, un
caso esemplare di quel che Appadurai (1996) chiama “immaginazione come pratica sociale”. Il 12 agosto 1991, “mentre era in vacanza a Durazzo”, si imbarca su una delle navi che facevano la
spola tra l’Albania e la Puglia cariche di disperati e speranzosi,
ma viene mandato allo stadio di Bari, per essere espulso
dall’Italia quasi immediatamente. Rientrerà più di un anno dopo,
chiamato da una compagnia di danza di Mantova che aveva avuto il suo nome dall’Accademia Nazionale di Tirana. Passa rapidamente alla televisione, diventando nel 1997 primo ballerino del
programma pomeridiano Buona domenica, dove rimarrà fino al
2003. Conosce così Maria De Filippi, che dal 2002 lo vuole con
sé sia a C’è posta per te, sia ad Amici. Mentre il pubblico di
Buona Domenica e C’è posta per te è in buona parte adulto,
l’audience di Amici di Maria De Filippi è tendenzialmente giovane
e femminile, e ne decreta il definitivo successo come sex symbol.
Nel 2004 Kledi fonda a Roma la “Kledi Academy”, una scuola di
danza e musica che sta riscuotendo un buon successo e che organizza corsi annuali e stage estivi. Nel frattempo, è diventato
anche un attore di successo sia per il cinema (Passo a due, La
cura del gorilla, entrambi del 2005) sia per il piccolo schermo
(Domani è un altro giorno, 2006).
In sintesi, la figura di Kledi Kadiu è quella di un albanese “vincente”, il primo a raggiungere in Italia la notorietà per le sue
qualità artistiche. Anche senza enfatizzarne il ruolo individuale,
certamente Kledi è stato il prodromo di una nuova generazione
95
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
di albanesi, disposti a proporre agli inizi del terzo millennio una
forma alternativa di identità rispetto al modello “poveraccio o
criminale” che si era imposto negli anni Novanta e che abbiamo
visto essere particolarmente attivo durante la crisi del 1997.
Proprio la tendenza a privilegiare la televisione italiana come
veicolo di informazione, sia in Albania attraverso le antenne
paraboliche, sia una volta giunti in Italia (Mai 2005, p. 558), ha
consentito agli albanesi di fruire di una nuova immagine da articolare in modelli alternativi di appartenenza. Uno dei veicoli
principali di questo nuovo modello identitario è stato Amici di
Maria De Filippi.
Il programma (si è conclusa nella primavera 2008 la settima edizione e si prepara per l’autunno l’ottava) è concepito come un
game show in cui un gruppo di giovani partecipa a tempo pieno
a una scuola per artisti (cantanti, ballerini e attori) che prevede
una serie di sfide settimanali tra i partecipanti. Le sfide ripetute
portano all’eliminazione progressiva degli studenti/concorrenti in
base al giudizio di una commissione e ai voti telefonici del pubblico a casa, fino alla proclamazione del vincitore assoluto. Già
alla seconda edizione, tra gli studenti vi era una ragazza albanese, Anbeta Toromani, che proveniva dalla stessa scuola di Kledi e
che sarebbe giunta seconda alla finale. Oggi Anbeta è una ballerina professionista e fa parte del cast stabile del programma. La
stagione successiva (2003-2004) gli studenti albanesi della scuola di Maria De Filippi erano due: Olti Shagiri (fratello minore di
Ilir Shagiri, un altro ballerino da qualche anno nel corpo di ballo
di Maria De Filippi) e Leon Cino, ballerino molto dotato che infatti vinse quell’edizione, entrando anche lui nel corpo di ballo stabile del programma. La quarta, conclusasi a maggio del 2005, ha
visto la partecipazione di altri due ragazzi albanesi: Tili Lukas e
Klajdi Selimi. Quest’ultimo è stato sicuramente il personaggio
chiave dell’anno, anche se non ha vinto la gara: con la sua vena
polemica, la costante rivalità con Marco, un altro allievo della
scuola che non esitava a fare appelli agli “italiani” perché votassero lui invece di un “albanese”, e con il rispetto profondo mostrato verso il pubblico che numerosissimo lo votava da casa,
Klajdi ha catalizzato l’attenzione di un pubblico sempre numero-
96
Identità catodiche
Piero Vereni
so (i dati di ascolto del programma nella sua fase serale si aggirano stabilmente attorno ai sei milioni di telespettatori; per le fasi finali i voti da casa hanno sfiorato il milione a puntata, anche
se la telefonata costava un euro). Anche le successive edizioni
hanno visto la presenza di concorrenti albanesi, ma il programma ha cercato di internazionalizzarsi ammettendo nella stagione
2006/2007 anche due concorrenti romeni (entrambi ginnasti) e
un ballerino spagnolo. Non è forse casuale che la “pressione etnica” sempre più evidente sul programma abbia trovato un limite
nella stagione 2007/2008, in cui tutti i concorrenti erano italiani.
I protagonisti di Amici di Maria De Filippi sono riusciti a modificare in modo sostanziale il giudizio di molti loro coetanei italiani
sull’identità albanese. Se dieci anni fa albanese era sinonimo di
immigrato clandestino, criminale, persona pericolosa o comunque povera (in Grecia girava allora una terribile freddura: sai
qual è la barzelletta più corta del mondo? Turista albanese!) oggi
tra molti giovani italiani “albanese” significa anche spirito di sacrificio, caparbietà, orgoglio e determinazione. Per molte ragazze,
poi, è innegabile che l’uomo albanese abbia assunto connotazioni sexy del tutto impensabili fino alla comparsa di Kledi e dei
suoi connazionali sul piccolo schermo.
Questa immagine prodotta dalla televisione italiana ha iniziato a
riverberarsi sull’autorappresentazione degli albanesi, in Italia e in
Albania (dove i programmi delle reti Mediaset sono particolarmente seguiti). Gli “eroi” delle sfide di Maria De Filippi sono intervistati sui settimanali popolari albanesi e proposti come modelli per la gioventù nazionale. Klajdi Selimi che, con la bandana
in testa e perennemente a torso nudo (come spesso Kledi), dichiara di sentirsi “un gladiatore più che un ballerino” incarna un
modello appetibile per gli italiani e per gli albanesi.
La messa in scena del corpo come strumento di performance di
eccellenza ricorda altri casi famosi: i giocatori di cricket indiani
nelle squadre inglesi (Appadurai 1996) o i campioni afroamericani negli Stati Uniti (Page 1997). Corpi senz’altro naturalizzati, addomesticati dallo sguardo egemone in funzione di un godimento
estetico rassicurante. Ma corpi capaci anche di riscattare un’identità smarrita se non esplicitamente sottomessa, in grado di riap-
Kledi non riflette il cliché del divo osannato e capriccioso, ma trasmette l’idea del lavoratore scrupoloso, preparato e devoto al pubblico che lo apprezza, rispettoso di una gloria raggiunta con fatica
attraverso interminabili ore di preparazione (Seralisa Carbone, sul sito Leonardo.it).
La nuova rappresentazione dell’artista albanese si è rapidamente
imposta come role model: Anbeta Toromani, Leon Cino e gli altri
artisti albanesi sono noti per la loro laconicità – non sempre dovuta a una scarsa conoscenza della lingua italiana, ma alla esplicita contrapposizione tra dire e fare – oltre che per la loro tenacia e forza di volontà. Sono spesso giudicati, anche dai rivali, come persone “serie”, che vanno al sodo e non si perdono in
smancerie o inutili salamelecchi. Questa versione alternativa dell’essere albanese oggi sta chiaramente contaminando l’autorappresentazione degli albanesi in Italia, che hanno seguito numerosi il programma Amici di Maria De Filippi con veri gruppi di
ascolto che partecipavano attivamente al voto da casa.
Pare così plausibile ipotizzare un “ritorno” dell’identità albanese
tra gli immigrati in Italia, soprattutto tra i più giovani, che sembrano quindi aver trovato una risposta alla richiesta del vecchio
Dhori di dimenticarsi di essere albanesi. Oggi, sembrano dire i
giovani albanesi in Italia, è finalmente possibile “ricordare” la
propria identità. Come è evidente, è un ricordare spurio, che unisce in una miscela del tutto originale la tradizione balcanica del
97
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
propriarsi di una dignità personale che può diventare condivisa
dall’intera comunità di riferimento.
Un tale processo di manipolazione fisica e simbolica del corpo
passa sia attraverso la storia “occidentale” della disciplina che si
apprende, sia attraverso la genealogia delle proprie “origini”: come la “magia” indiana diventa capacità funambolica sul campo
da cricket, e come la “naturalità” africana diventa potenza esplosiva sulle piste di tartan, così l’orgoglio “balcanico” degli albanesi diventa capacità di disciplinarsi, di rimanere fedeli all’obiettivo
senza cedere alle lusinghe del facile successo. Così descrive una
giornalista italiana le ragioni del successo di Kledi:
98
Identità catodiche
Piero Vereni
ballo come espressione sociale, la scuola albanese di balletto
classico, l’espressione di una virilità estremamente fisica e poco
“ciarliera”, lo spirito competitivo e l’orgoglio di un popolo “tribale” con le esigenze del mercato televisivo, il sex appeal del body
fitness, la telegenia e la capacità di assecondare le fameliche richieste delle audience più giovani, notoriamente refrattarie al richiamo del piccolo schermo. Non vi è, in tutto questo, nulla di
chiaramente orientato al passato (un’opzione impraticabile di fatto per gran parte degli albanesi) ma piuttosto la voglia di progettare un sentire comune con i frammenti della modernità e della tradizione, senza temere il mutamento ma accettandolo come
parte inevitabile di un qualunque sano processo di identificazione collettiva che non voglia sclerotizzarsi nella nostalgia dei bei
tempi andati, che per molti giovani albanesi semplicemente non
esistono come ricordo politicamente spendibile sul mercato delle
appartenenze.
Conclusioni
L’intento di queste pagine è stato quello di spingere a riflettere
su alcune forme recenti delle appartenenze e delle identità. La
“crisi albanese” del 1997 ha costretto alcuni noti opinionisti a ripensare pubblicamente il senso e il ruolo dell’identità italiana, e
le esigenze commerciali di un programma televisivo italiano hanno contribuito al riposizionamento dell’identità albanese, per gli
attori e per gli astanti. Ancora una volta, seppure con ingredienti
insoliti, confermiamo quindi il sapere degli antropologi, che ci dice la natura necessariamente relazionale dell’identità.
Per quanto riguarda invece lo specifico rapporto tra mezzi di comunicazione di massa e identità collettive, mi sento di azzardare
il giudizio complessivo (ormai acquisito nel dibattito teorico) che
non vi è alcun rapporto causale diretto tra rappresentazione nei
media e percezione della propria identità. Non basta, cioè, vedersi descritti come sciocchi o criminali o ballerini dai grandi
mezzi di comunicazione di massa per percepirsi come tali, dato
che il discorso dei media entra nelle ordinarie spirali comunicati-
1 Questo capitolo riproduce, con alcune varianti, il saggio dallo stesso titolo pubblicato su «Achab. Rivista di antropologia», 11, 2007, pp. 47-58.
99
Pinocchi, balordi e ballerini. Il mutamento dell’immagine degli albanesi nei mezzi di comunicazione italiani (1997-2006)
ve come una delle voci in gioco. In questo senso, possiamo ribadire quanto avevamo provocatoriamente sostenuto nel primo capitolo, e cioè che i mass media “non esistono”, se per mass media intendiamo un sistema di comunicazione autonomo e tendenzialmente “persuasore”, i cui effetti sociali possano essere resecati da quelli della più vasta struttura entro cui si inscrivono
(Tomlinson 1991). Al contrario, un’analisi di taglio antropologico
sui mezzi di comunicazione di massa ci rende sempre più consapevoli della natura “mediata” della vita sociale in generale
(Mazzarella 2004).
Esistono cioè nuclei più o meno densi di comunicazione e aggregazione di significati che non possono esistere se non in forma
mediata, cioè comunicata: gli stili culturali da cui si proviene, le
aspettative sociali, gli incentivi individuali, gli habitus come archivi consolidati e generatori sperimentali di pratiche, e i capitali
culturali ed economici di cui si dispone. Dentro questo quadro,
agiscono i mezzi di comunicazione di massa. L’antropologia ha
fatto male, finora, a sottovalutare spesso il loro ruolo in nome di
un purismo dell’“autentica cultura” che non aveva ragione di essere. Farebbe altrettanto male, credo, se iniziasse ora a sopravvalutarlo, in nome di un determinismo che è altrettanto ingiustificato, teoreticamente ed empiricamente.
Michael Herzfeld, The Practice of Stereotypes
Introduzione
In un piacevole saggio volutamente polemico con la rappresentazione estremamente negativa che della televisione fornisce una
certa classe intellettuale1, Aldo Grasso (2007) equipara il consumo televisivo di fiction alla lettura delle grandi opere letterarie,
valorizzandone quindi la dignità e lo spessore intellettuale.
Sebbene la sua riflessione riguardi la fiction statunitense degli
ultimi anni e muova da considerazioni di natura primariamente
estetica, possiamo provare a generalizzare le implicazioni antropologiche della sua tesi e sostenere che le immagini e le narrazioni veicolate dal sistema dei mass media abbiano ormai un peso centrale nella costruzione dell’immaginario e che l’analisi testuale e socio-semiotica dei prodotti filmici non si possa più ridurre, come si è fatto per lungo tempo, al versante “alto” rappresentato dal cinema (magari solo nella sua variante “d’autore”). Se cioè le comunità sono “comunità immaginate” (Anderson
1991), vale a dire raggruppamenti in cui la dimensione essenziale
di esistenza è la loro natura di segni negoziati, qualunque scienza umana che studi le appartenenze collettive deve prendere seriamente in considerazione il ruolo attivo dell’immaginario nell’orizzonte politico, e approntare programmi di ricerca rivolti a studiare – per dirla con uno slogan – proprio il ruolo dell’immagine
nell’immaginazione:
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Quelli che sono interessati agli stereotipi sul
potere hanno a disposizione un luogo importante per la loro produzione: i mezzi di comunicazione di massa.
101
Capitolo quarto
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano
nella narrativa televisiva (1988-2007)
Piero Vereni
Identità catodiche
102
molte vite sono oggi inestricabilmente legate a rappresentazioni, e
(…) quindi abbiamo bisogno di incorporare nelle nostre etnografie la
complessità delle rappresentazioni espressive (film, romanzi, resoconti di viaggio), non solo come appendici tecniche, ma come fonti
primarie con cui costruire e interrogare le nostre stesse rappresentazioni (Appadurai 1996, p. 90).
Nelle pagine seguenti ci soffermeremo a indagare un’immagine
specifica in un contesto produttivo delimitato: il Sud d’Italia nella rappresentazione che ne ha dato la fiction italiana nel ventennio 1988-2007. La scelta del periodo in esame dipende da due
ragioni. In primo luogo, va detto che è solo a partire dalla metà
degli anni Novanta che l’industria della fiction italiana raggiunge
dimensioni che le consentono di superare il livello artigianale e
quindi un’analisi dell’ultimo ventennio è in grado di rappresentare adeguatamente il valore attuale della fiction anche in termini
di impatto sulle audience2. In secondo luogo, l’analisi per questo
periodo è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità della serie di volumi La fiction in Italia, l’Italia nella fiction, esito
editoriale dei rapporti annuali di ricerca che ormai da quasi un
ventennio Il Campo, l’Osservatorio sulla Fiction Italiana (OFI),
produce sotto la direzione di Milly Buonanno3. I rapporti annuali,
pubblicati da Rai-Eri, hanno costituito un insostituibile punto di
riferimento in cui reperire molte informazioni fino all’annata
2005-2006, presentata nell’ultimo rapporto pubblicato nel 2007.
Prima di iniziare la rassegna dei temi caratteristici della rappresentazione del Sud nella fiction è bene anteporre alcune considerazioni sul modello produttivo attuale.
Gli alti costi di produzione e il grave rischio di non rispettare gli impegni di share sulla base dei quali si vendono gli spazi pubblicitari
rendono estremamente arduo lo sperimentalismo nel campo della
produzione della fiction italiana. Ciò significa che questo mondo
produttivo, per ragioni strutturali, tende a essere conformista e
conservatore, dato che in una situazione di costante incertezza, in
cui il rapporto tra costi e benefici può essere molto alto, il rischio
minore consiste nel riproporre formule e temi vincenti. Qualunque
novità, infatti, può andare incontro a un grande successo ma anche
L’effetto di questo limite produttivo è il rinforzo dei modelli narrativi e dei caratteri dei personaggi, con un’inevitabile tendenza allo
stereotipo. Tale impostazione è rafforzata da un’ulteriore variabile
economica, e cioè il costo della logistica. Sembra esserci un circolo
virtuoso tra la presenza privilegiata di alcune ambientazioni e la
disponibilità delle Regioni a contribuire finanziariamente e logisticamente alla realizzazione della fiction. Detto altrimenti, in alcune
Regioni la produzione di fiction è facilitata da una serie di servizi
resi disponibili dalle Film Commission regionali o da quote di finanziamento diretto, che hanno come obiettivo la valorizzazione in termini produttivi e di richiamo turistico grazie al territorial branding.
Ora, questa operazione sembra essere stata perseguita con maggior vigore da alcune regioni rispetto ad altre, spingendo quindi ulteriormente la produzione ad accentrarsi in località predefinite.
Fig. 1. Distribuzione delle ambientazioni per aree geografiche
Sud
18%
Nord
32%
Nord
Centro
Roma
Roma
37%
Centro
13%
Fonte: elaborazione dell’autore su dati OFI.
Sud
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Questo è il punto più grave, perché poi alla fine non si ha il coraggio
di osare e si rincorrono sempre gli stessi temi. Quando un filone ha
successo si continua fin quando iniziano gli insuccessi. Attualmente
vanno le miniserie a tema, che portano in evidenza il problema della
serialità lunga (…). La sensazione forte che io ho, da anni, è che poi
ripetiamo sempre le stesse cose, stiamo riciclando gli stessi temi, e
non si riesce ad andare oltre4.
103
a insuccessi clamorosi, che costringono le emittenti a rimodulare la
programmazione o addirittura a cancellare la messa in onda se non
vengono rispettati gli obiettivi minimi della rete.
Fig. 2. Distribuzione delle ambientazioni per Regione (esclusa Roma)
120
102
100
80
60
50
45
42
48
42
40
25
23
15
Toscana
Lazio (esclusa Roma)
Marche
Umbria
Centro generico
104
Identità catodiche
Piero Vereni
12 15 12
5
4
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Nord generico
0
6
2
1
25
14
6
Campania
Puglia
Calabria
Sardegna
Sicilia
Sud generico
20
Fonte: elaborazione dell’autore su dati OFI.
Fig. 3. Percentuale di ambientazioni meridionali per anno
35
%
29,17
30
27,27
25,35
25
20
14,71
13,95
15
10
16,13 16,00 17,24 17,31
13,89
11,76
13,56
10,77
12,31
8,57
5
4,76
0
1985
15,69
1990
8,33
5,13
0,00
1995
2000
2005
2010
Fonte: elaborazione dell’autore su dati OFI.
Nella figura 1 viene riportata la distribuzione della ambientazioni
per aree geografiche, la figura 2 riporta la distribuzione per
Regioni e la 3 le percentuali di ambientazioni meridionali per anno. Si può notare come il Sud sia sottorappresentato, pur se la
Nord/Sud e il “tipo meridionale”
Quanto abbiamo detto sulla vocazione stereotipizzante della fiction
italiana segnala in realtà un’esasperazione di quella che sembra
una qualità della narrativa televisiva in generale, non solo di quella
italiana: spinta proprio dal delicato rapporto tra alti investimenti e
ricavi non di rado aleatori, la produzione di fiction tende spesso a
raffigurare i luoghi e i loro abitanti in modo convenzionale.
Nella rappresentazione televisiva statunitense, ad esempio, il
Midwest americano è sempre dipinto come una zona esclusivamente rurale, in un modello visivo che sembra espungere intenzionalmente qualunque raffigurazione delle sue invece molteplici
aree urbane (Johnson 2008). L’Egitto meridionale è sistematicamente rappresentato nella fiction egiziana come la parte arretrata del paese, legata al sistema della faida e alla rigida struttura
patriarcale delle aree rurali, nonostante sia una delle zone più
battute dai turisti e quindi risenta in modo profondo dell’impatto
culturale e sociale di questo contatto costante (Abu-Lughod
1997). Sottraendo lo spazio rappresentato al peso del divenire,
la narrazione televisiva sembra ricalcare alcuni meccanismi di
produzione dell’alterità che l’antropologia conosce bene, prima
di tutto per aver contribuito alla loro formazione relegando l’altro esotico in una porzione di spazio (l’altrove) privo di tempo e
quindi immutabile (Fabian 1983); e in tempi più recenti perché
vengono dagli antropologi alcune delle riflessioni più interessanti
sul ruolo politico degli stereotipi, che possiamo considerare delle
vere rappresentazioni culturali sottratte al divenire. Gli stereotipi
105
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
tendenza sembra attualmente indicare una decisa crescita, ma
questo dato quantitativo nulla ci dice sulle forme che assume
quella rappresentazione. Nei paragrafi che seguono vedremo dapprima alcune modalità generali della rappresentazione stereotipica del Sud in antitesi diretta al Nord, per poi concentrare l’attenzione su tre temi la cui predominanza è emersa nel corso dell’analisi: il peso del crimine; della rappresentazione della società nel
suo contesto territoriale; e della rappresentazione della famiglia.
106
Identità catodiche
Piero Vereni
sono forme essenzializzanti dell’identità che agiscono come
struttura della categorizzazione e che possono trovare spazio
nell’autorappresentazione. Ciò significa che la forza di un cliché è
duplice in quanto può operare in molteplici direzioni (non è solo
dalla condizione di egemonia che si può elaborare uno stereotipo) e può essere incorporato dall’oggetto della stereotipizzazione in un gioco articolato di potere che non si sottrae alla logica
necessitante della dialettica servo/padrone, ma che anzi su quella dialettica basa la sua forza di persuasione come strategia di
rappresentazione “credibile”. In quanto pratica sociale, l’atto di
categorizzare per grandi etichette implica quindi un costante lavorio politico di definizione e ridefinizione e merita un’adeguata
attenzione analitica perché non si tratta di una dimensione retorica esterna alla realtà sociale, ma di uno dei meccanismi di base
della sua produzione (Herzfeld 1997a).
Stiamo cercando di dire che guardare la rappresentazione del
Sud nella fiction è, ipso facto, una delle forme di produzione e
riproduzione del Sud. Questo lavorio dello stereotipo agisce direttamente sul suo oggetto ma contribuisce a consolidarne l’immagine anche distribuendo all’esterno di esso altre raffigurazioni,
in un gioco di complementarietà di cui spesso ci sfugge il quadro generale. Per esemplificare questo punto, partiamo da un caso semplice.
Una collection è una raccolta di fiction tenute assieme da un tema comune o da un quadro narrativo di riferimento. Consente
una notevole libertà in fase produttiva (per ogni episodio, infatti,
possono variare gli attori, gli sceneggiatori e i registi) ma si suppone che possa fidelizzare l’ascolto grazie alla ripresa dei temi
che la caratterizzano. Alla fine del 1990 Rai Due manda in onda
una collection titolata Altri particolari in cronaca, sette film-tv rivolti a rappresentare temi “scottanti” della cronaca e del costume. La scelta cade sui seguenti argomenti: abbandono dei neonati, razzismo contro gli immigrati, violenza sulle donne, criminalità giovanile, celibato dei religiosi, stragi del sabato sera, solitudine e povertà degli anziani. I sette film-tv sono ambientati, rispettivamente, a Roma, in Veneto, in Toscana, in Calabria, Italia
(senza caratterizzazioni), Emilia-Romagna e Torino.
107
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Il caso della criminalità giovanile è l’unico in cui il Meridione
compare esplicitamente, anche se il ruolo del contesto geografico non è chiaro, e sembra quasi dipendere dalla laconicità con
cui il film ricostruisce le motivazioni del giovane calabrese attratto nel mondo della piccola malavita. È sostanzialmente un bravo
ragazzo (il suo pentimento lo porterà alla morte) ma cede alle lusinghe del malvagio e inizia a delinquere senza che ci venga
spiegato perché. Così commenta l’estensore della scheda pubblicata nel Catalogo della fiction italiana 1988-2000 (Osservatorio
della Fiction Italiana, a cura, 2001)5: “Neanche i dialoghi, brevissimi e scarni, aggiungono elementi di maggiore chiarezza; a meno che il film non voglia alludere, altrettanto genericamente, alle
potenzialità criminogene di un contesto meridionale”.
Risulta difficile sottrarsi al gioco degli stereotipi che sembra attraversare tutta la collection: l’abbandono dei neonati si concretizza nel contesto “anomico” della metropoli; il razzismo dilaga
nel ricco Nordest; lo stupro impunito è pratica dell’alta borghesia, tipicamente fiorentina; il tema sesso/religione non può che
essere pan-italico; i giovani discotecari stanno sulla Riviera
Romagnola e due anziani che decidono di superare assieme la
solitudine sono credibili se razionalmente torinesi. Il Sud compare come matrice del crimine e, in modo complementare, rappresenta i motivi della sua assenza nelle altre tematiche sociali: una
madre meridionale non abbandona i figli nei cassonetti; i meridionali ovviamente non sono razzisti, semmai sono oggetto di
pregiudizio razziale; in quanto galantuomini non stuprano, ma in
quanto tendenzialmente fallocentrici e tradizionali non sono credibili come amanti anziani; quanto ai giovani, quelli meridionali
non hanno tempo (e vite) da perdere nelle corse in macchina all’uscita dalla discoteca (non sono cioè figli dell’effimero, del tempo superfluo) dato che sono tutti concentrati sull’alternativa bravo guaglione/picciotto in formazione.
Certo, stiamo forzando un’interpretazione che non era sicuramente nelle intenzioni degli sceneggiatori e dei produttori, ma sono
proprio gli stereotipi in quanto tali a essere interpretazioni azzardate, esagerate, “ridicole”. E funzionano narrativamente e politicamente proprio in quanto tali, come vedremo nelle conclusioni,
108
Identità catodiche
Piero Vereni
quando rifletteremo rapidamente sulla separazione tra intenzioni
dell’emittente e percorsi interpretativi degli spettatori.
Questa immagine contrastiva del Sud si misura ancor più nitidamente quando lo scontro è con un “vero” Nord. Nel 1996 Rai
Uno ha proposto con grande successo un film-tv che adattava il
romanzo d’appendice Il piccolo Lord di Frances Hodgson Burnett.
Il contrasto morale di base, che nell’originale era tra la democratica America e l’aristocratica Gran Bretagna, viene riscritto qui come l’opposizione tra un Sud povero ma solidale (l’ambientazione
principale è l’isola di Ponza) e un Nord (europeo, dato che il
nonno del piccolo protagonista è tedesco) ricco ma freddo di
sentimenti. Si tratta di un prodotto destinato anche al mercato
tedesco e quindi la stereotipizzazione del Meridione italiano è
particolarmente interessante in quanto prodotta contemporaneamente dall’autodefinizione identitaria e dallo sguardo categorizzante dell’Altro. Per gli scopi di questo lavoro, invitiamo a tenere
a mente quanto il contrasto sia contemporaneamente morale
(calore morale vs freddezza di sentimenti) ed economico (miseria
vs ricchezza), creando anzi una sorta di sovrapposizione automatica tra i due piani.
Una delle forme canoniche della rappresentazione del Sud è
quindi in antitesi ad altre rappresentazioni contestuali. E il tropos dell’antitesi è nell’andare altrove.
L’emigrazione all’estero non è un tema che abbia colpito particolarmente gli sceneggiatori di fiction italiana. A parte il caso di
Macaronì (Rai Uno, 1993), anomala e “autoriale” ricostruzione
della vita di un ragazzo figlio di immigrati italiani in Francia negli
anni Trenta, bisogna attendere gli anni recenti per trovare titoli
che parlino di emigrazione: Come l’America (Rai Uno, 2001),
Marcinelle (Rai Uno, 2003), La terra del ritorno (Canale 5, 2004),
ma la saga degli italiani emigrati è ricostruita con cura anche in
biografie di uomini famosi, come Sacco e Vanzetti (Canale 5,
2005) e soprattutto Joe Petrosino (Rai Uno, 2006).
Più articolata invece la ricostruzione dell’immagine dell’immigrato interno, che si affaccia in diversi generi di fiction. La contrapposizione può essere tra Nord come spazio malvagio contro Sud
come campo della rivalsa, come vedremo più avanti. Ma il Sud
109
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
può essere anche solo il luogo della disperazione, contrapposto
al Nord come spazio di una modernizzazione disumana o fasulla.
Come nella fiction Una lepre con la faccia da bambina (Rai Due,
1989), adattamento di un romanzo (Conti 1978), che racconta il
dramma di Seveso nel contrasto tra immigrati meridionali e i locali. Marco e Sara sono due bambini, a Seveso, ma lui è figlio di
industriali della zona, mentre Sara è figlia di immigrati siciliani.
Quando scoppia la tragedia il bimbo non si rende conto della
gravità della cosa, mentre Sara sarà costretta dalle circostanze a
prendere coscienza dell’entità dell’incidente. La sorella maggiore,
incinta, teme di dare vita a un bimbo deforme e decide di tornare in Sicilia per abortire.
In altri casi il Nord è il luogo della possibile rinascita, ma il Sud
incombe e rende il riscatto impossibile: nella miniserie Racket
(Rai Due, 1997), ambientata a Biella, Michele Placido interpreta
un ex poliziotto pugliese che per cambiare completamente vita si
è trasferito al Nord, dove lo raggiungerà un boss in soggiorno
obbligato a scatenare l’inferno del suo passato.
La salita al Nord per sfuggire al crimine o per combatterlo raramente porta alla salvezza: in Vite Blindate (Rai Uno, 1998) la famiglia di un pentito abbandona la Sicilia per seguire un programma di protezione. La figlia maggiore, Croce, torna al Sud per partecipare ai funerali della nonna uccisa con una vendetta trasversale, ma si salverà dalla furia dei boss solo grazie al caposcorta
che l’ha seguita. Non si salva invece il personaggio di Zina
Barraco, che nella fiction Non parlo più (Rai Due, 1995) incarna
la vera Rita Atria, proveniente da una famiglia massacrata dalla
guerra di mafia degli anni Ottanta. Come la cognata, Rita decide
di collaborare e troverà nel giudice Borsellino un attento interlocutore. Sconvolta dalla morte del magistrato nella strage di via
d’Amelio (19 luglio 1992), si suiciderà nella casa romana dove viveva in segreto.
Anche se non è presente il crimine organizzato, il passato di miseria sembra spesso una condanna ineluttabile per chi è salito
al Nord. Ne “L’assegno”, terzo episodio della collection La città
infinita (Rai Tre, 2002), si racconta di un’emigrata meridionale,
Santina, che ha raggiunto una certa tranquillità economica dopo
110
Identità catodiche
Piero Vereni
anni di duro lavoro e che perde tutto quando convince il marito
a vendere casa per aiutare la figlia ad aprire un negozio, ma
l’assegno viene rubato durante una rapina. In altri casi l’incontro tra Nord e Sud giunge a una soluzione pacifica quando si
tratta di affrontare un’emergenza comune. In “Rosa Furia”, secondo episodio della collection Generazioni (Rai Due, 2003)
tratto da un romanzo (Zappa Mulas 2000), si racconta la vicenda di una sedicenne che si trasferisce a Napoli da Genova e fa
amicizia, dopo un periodo di iniziale contrasto, con la figlia della portinaia, aiutandola quando questa resta incinta del patrigno, di cui si è innamorata.
Un’altra forma comune, sempre legata allo sradicamento ma con
una sfumatura peculiare, è la figura dello scugnizzo povero ma
simpatico o comunque vittima di un disagio sociale profondo
che quindi reclama solidarietà anche quando il suo comportamento è ai margini della legalità. In Felipe ha gli occhi azzurri
(Rai Uno, 1991), il protagonista è un bimbo filippino di nove anni, ma nelle sue peripezie è accompagnato da coetanei “marginali”, tra cui un spavaldo Turi (canonicamente siculo) e il napoletano Savino. Altro esempio di questo filone dedicato all’infanzia
oppressa (non solo meridionale, in questo caso) è Il ricatto 2.
Bambini nell’ombra (Canale 5, 1991). In chiave storica, lo stesso
modello delle scugnizzo vagabondo compare in Storia di guerra
e di amicizia (Rai Uno, 2002), con un gruppo di ragazzini dell’area napoletana alla ricerca dei genitori durante la seconda guerra
mondiale. Se non è protagonista, lo scugnizzo può fare da utile
contorno, come Vincenzino, figlio di un disoccupato napoletano
che, a Roma, diventa amico del figlio minore di Michele Placido,
vedovo con sei figli in Un papà quasi perfetto (Rai Uno, 2003).
Questa caratterizzazione ha la sua versione femminile nella figura della Cenerentola meridionale, una giovane donna di belle
speranze ma pochi quattrini. Nel rifacimento di Le ragazze di
piazza di Spagna (Rai Due, 1998), film di Luciano Emmer del
1952, Bianca, ragazza meridionale di carnagione scura e di modesta estrazione sociale, riuscirà a diventare modella mentre le
sue due compagne bionde e borghesi prenderanno altre strade.
Nella versione originale tutte e tre le ragazze erano modeste sar-
111
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
tine romane, mentre qui solo la ragazza del Sud (con famiglia a
carico) proviene dai ceti popolari. Una figura simile compare in
Tutti i sogni del mondo (Rai Due, 2003), una miniserie dedicata
alle vicende di aspiranti ballerine a Roma: c’è la figlia del conte,
la giovane senese e poi Cinzia, ragazza madre napoletana, che
per tenersi il figlio combinerà una matrimonio con un collega di
cui poi si innamora, facendo ovviamente trionfare la famiglia
“canonica”.
Il tipo del meridionale povero che sale al Nord pieno delle sue illusioni può condire anche contesti narrativi apparentemente incongrui. Per ricordare la vicenda de Il grande Torino (Rai Uno,
2005), la squadra di Valentino Mazzola scomparsa nella tragedia
di Superga del 1949, la vicenda è narrata dal punto di vista di un
giovane di Casoria, interpretato da Ciro Esposito, che arriva a
Torino con tutto il bagaglio di speranze e di miseria, in un contrasto tra Sud e Nord estremamente stridente (e quindi narrativamente efficace).
Anche in Marcinelle (Rai Uno, 2003), miniserie che racconta le vicende dei minatori morti nella tragedia mineraria del 1956 che
provocò 262 vittime (di cui 136 italiani), non ci si sottrae al gioco degli stereotipi regionali, per cui il toscano è un simpatico
chiacchierone che si è mangiato tutto al gioco, mentre due cugini
divisi da una faida di famiglia sono naturalmente del Sud.
Ma la raffigurazione del “carattere meridionale”, che abbiamo visto finora declinata nel suo versante drammatico, ha in realtà
uno spazio quasi fisso nella commedia, virando decisamente verso la macchietta. Se si dovesse tener conto di tutte le fiction che
contengono un buffone meridionale di contorno l’elenco sarebbe
veramente oneroso per cui ci limitiamo a indicare i casi più noti
o più marchiani.
Si può partire da un vero sottogenere, la “commedia di caratteri
regionali”, con operazioni come Classe di ferro (Italia 1, 1989) e
Classe di ferro 2 (Italia 1, 1992) serie sulla “naia” senza alcuna
pretesa se non quella di rappresentare l’archivio completo dei
cliché regionali. Per amore o per amicizia (Rai Uno, 1993) intreccia le storie di quattro giovani provinciali a Roma (dalla Toscana,
Abruzzo e Calabria). Stessa impostazione per Stiamo bene assie-
112
Identità catodiche
Piero Vereni
me (Rai Uno, 2002), una commedia che racconta le vicende di un
gruppo di studenti, con tutte le stereotipie del caso, incluso il
calabrese e la napoletana “casinara”. Ma uno dei vertici del bozzetto macchiettistico si realizza nella sitcom I-Taliani (Italia 1,
1989, I-Taliani 2, Italia 1, 1990), in cui il gruppo comico I Trettre
mette in scena diverse situazioni recitando in napoletano e dando una rappresentazione del carattere “nazionale” tipicamente
qualunquista: i protagonisti delle storie sono campioni dell’arte
di arrangiarsi e della furberia. Un’Italia quindi opportunista e arruffona che trova nel napoletano la sue epitome non solo linguistica, ma culturale.
Macchiette riuscite sono il Tonino Paparella della sitcom Stazione
di servizio (Rai Uno, 1989: il gestore è toscano, la moglie e il cognato sono romani, e lui è la classica macchietta napoletana, che
quasi profeticamente cerca di cavare benzina dall’immondizia) e
il portiere napoletano (Giobbe Covatta) con l’immarcescibile armamentario di stereotipizzazioni che compare regolarmente tra i
personaggi minori di Andy e Norman (Italia 1, 1991), un’altra sitcom ma con ambientazione milanese.
Anche ne Il giudice Mastrangelo (Canale 5, 2005), una produzione per altro non banale, l’autista del giudice, Uelino, è il tipico
“carattere meridionale”, chiacchierone, espansivo, e profondo conoscitore della sua terra e degli uomini che la abitano. Diverso,
ma sempre in funzione di alleggerimento, il personaggio “tonto e
quindi esperto di informatica” di Catarella, l’agente centralinista
delle fiction del commissario Montalbano.
Lino Banfi nel corso degli anni si è imposto come uno degli attori principali della fiction italiana, liberandosi gradualmente dallo
stereotipo regionale che lo aveva assillato come attore di cinema, ma ancora nel 1992, nella serie Un inviato molto speciale
(Rai Due, 1992), interpreta la parte di Damiano Tarantella (sic),
un giornalista barese trapiantato a Roma, che ha successo proprio grazie all’ingenuo provincialismo con cui incarna lo stereotipo del buon selvaggio meridionale.
Un altro caratterista che ha saputo trasferire nella fiction la sua
verve comica è Nino Frassica, che interpreta un personaggio molto simile a se stesso e comunque di alleggerimento rispetto alle
113
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
tensioni poliziesche in due serie di lungo corso come Don Matteo
(Rai Uno, sei stagioni tra il 2000 e il 2008), e Carabinieri (Canale
5, serie annuale dal 2002).
Il contesto canonico della stereotipizzazione caratteriale è “meridionale tra meridionali” (Uelino, Catarella) oppure, più frequente,
“meridionale al Nord” (con l’importante variante del mafioso, che
vedremo nel prossimo paragrafo dedicato proprio al “crimine meridionale”). Più raro il caso inverso, in cui sia il settentrionale a
spostarsi al Sud. Un esempio compare in Anni ’50 (Canale 5,
1998), una commedia in cui Ezio Greggio interpreta un maresciallo pieno di pregiudizi verso lo stile di vita partenopeo trasferito
a Capri dal Nord: il contesto narrativo è l’occasione per riesumare una serie di tipi tratti dalla commedia italiana del decennio
cui si riferisce la fiction. L’isola di Capri funziona in questo senso
anche nel melodrammone Capri (Rai Uno, 2007 e 2008), il cui
impianto narrativo si mette in moto proprio quando la bella milanese eredita una villa nell’isola e vi si trasferisce, venendo a
confrontarsi con un ambiente in cui domina una “mentalità” diversa dalla sua.
Ma la figura del meridionale ridicolo è ecumenica, e può essere
ficcata (attraverso la stereotipizzazione del cinema americano)
anche in una miniserie di avventura come La figlia del Maharaja
(Canale 5, 1995), oppure in una serie ambientata nella Roma antica (SPQR -2000 anni fa, Italia 1, 1998).
Se una fiction gioca sullo stereotipo contrastivo, è possibile che
nel corso delle stagioni questo venga intensificato. Un ciclone in
famiglia (Canale 5, 2005) nella prima annata prevedeva l’antitesi
tra il settentrionale nevrotico (Massimo Boldi), il romano cialtrone (Maurizio Mattioli) e le rispettive famiglie, ma nelle serie successive (Un ciclone in famiglia 2, Canale 5, 2006; Un ciclone in
famiglia 3, Canale 5, 2007) fa la sua comparsa Peppino Esposito
(Carlo Buccirosso), una sorta di contromacchietta napoletana, un
tipo estremamente meticoloso e pignolo che nel corso degli
eventi rivelerà però un animo romantico.
Non sono quindi mancati i tentativi di ribaltare il canone dello
stereotipo, come nella sitcom I vicini di casa (Italia 1, due stagioni, nel 1991 e 1992) che racconta la buffa convivenza di Teo
114
Identità catodiche
Piero Vereni
Teocoli e Silvio Orlando, fratelli per parte di padre cresciuti a distanza e ora entrambi a Milano. Nella prima stagione il milanese
è cialtrone e playboy, mentre il napoletano è sensibile e imbranato con le donne. Nella seconda serie i due fratelli imparano
uno dall’altro, in un comico ribaltamento di ruoli. L’antitesi tra
settentrionale organizzato e meridionale confusionario viene ripresa a parti invertite anche in Due imbroglioni… e mezzo!
(Canale 5, 2007): il milanese (Claudio Bisio) è fanfarone e scomposto, mentre la romana (Sabrina Ferilli) è efficiente e rigorosa.
Quel che questo carnevale degli stereotipi sembra indicare (come
qualunque carnevale, del resto) è la volontà di giocare con il sistema delle aspettative: il comico, in questi casi, deriva proprio
dal fatto che la sceneggiatura viola intenzionalmente quel che gli
spettatori potrebbero aspettarsi dalla provenienza regionale dei
personaggi, ma in effetti non mette assolutamente in discussione
il valore morale dello stereotipo, e semmai lo conferma presentando l’eccezione (che, si sa, conferma la regola).
L’immagine del crimine: La piovra e i suoi epigoni
La tendenza stereotipizzante del sistema produttivo italiano cui
abbiamo accennato all’inizio di questo capitolo può spiegare anche l’insistenza delle storie di mafia nella fiction italiana, che deriverebbero in buona sostanza dall’ultradecennale successo della
serie La piovra, iniziata nel 1984 e proseguita, sia pure con alterne vicende e con lunghi periodi di sospensione produttiva, fino
al 2000.
Per comprendere la rappresentazione della criminalità organizzata nella fiction televisiva italiana non si può quindi prescindere
dal ruolo prototipico di una delle fiction di maggior successo nella storia della televisione italiana, una delle poche in grado di
varcare con successo i confini nazionali. Al di là del seguito di
pubblico (l’audience media è sempre stata tra gli otto e i quattordici milioni di spettatori, tranne che per l’ultima miniserie in
due puntate – trasmessa su Rai Due diversamente dalle precedenti andate in onda sulla rete ammiraglia – scesa a meno di sei
115
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
milioni), La piovra deve la sua importanza alla struttura narrativa
che mette in gioco, e cioè la fusione della storia criminale con le
vicende personali e soprattutto familiari dei protagonisti.
Nell’antitesi tra high concept (e cioè fiction “d’azione”, in cui i
personaggi si caratterizzano per il loro “fare” e proprio nelle loro
qualità operative consolidano la loro identità) e low concept
(quella fiction che invece costruisce l’identità dei personaggi attorno al loro “essere”, come rappresentazione pubblica degli intimi stati d’animo e come sistema delle relazioni affettive e sociali) La piovra sembra puntare sistematicamente sulla ricerca di un
punto di equilibrio. I personaggi sono tutti intenti nel portare a
termine i loro obiettivi narrativi (far prevalere il male o il bene,
alla fine) ma lo fanno ancorando questa tensione operativa morale al loro privatissimo sistema degli affetti, per cui la lotta al
crimine diventa, per il commissario Cattani, anche una forma di
difesa della sua famiglia (si pensi al rapimento della figlia messo
in scena nella prima stagione, anticipo di una serie di atrocità
che colpiranno Cattani sul piano dei suoi affetti privati), ma anche il cattivo per antonomasia, il perfido Tano Cariddi, combatte
non solo per la conquista del potere, ma inseguendo una serie
di vendette personali. Questa commistione di sentimento privato
e spazio della contrapposizione pubblica tra bene e male costituisce un tratto caratterizzante di tutta la serie6.
Un altro aspetto notevole, probabilmente altrettanto importante
nella produzione dell’immaginario collettivo, è il tono cupamente
disforico che la caratterizza: l’eroe buono può vincere qualche
battaglia, soprattutto sul piano degli affetti familiari, ma la guerra contro il Male sembra non solo sistematicamente perduta, ma
addirittura un obiettivo che non ci si pone realisticamente. L’eroe
positivo maschile muore alla fine di ogni ciclo: ne La piovra 4
tocca al commissario Cattani (Michele Placido), ne La piovra 6
muore Dave Licata (Vittorio Mezzogiorno), mentre ne La piovra 9
toccherà al neosposo commissario Arcuti (Raoul Bova) morire
sotto i colpi della mafia. Rimane un filo di speranza con un prossimo eroe di cui si intravede la venuta, ma il successo della serie
sta anche nel suo pessimismo politico che, fondamentalmente,
circoscrive narrativamente una sorta di deresponsabilizzazione
116
Identità catodiche
Piero Vereni
collettiva: possiamo lottare, anzi dobbiamo lottare, tanto sappiamo che perderemo e quindi nessuno potrà imputarci alcuna responsabilità. Il quadro che ne emerge è quello di un’azione il cui
valore non sta nel raggiungimento di un obiettivo, ma nel perseguimento di un principio. Un’azione, quindi, tipicamente “subalterna” in quanto confinata alla testimonianza, senza una reale
capacità di modificare i rapporti di potere esistenti.
Su questa tendenza narrativa e sulle sue conseguenze avremo
modo di tornare più avanti. Concentriamoci ora sul primo aspetto evidenziato de La piovra, vale a dire l’intreccio sistematico tra
storia criminale e legami parentali, dato che prenderà rapidamente una connotazione specifica, lontana dal prototipo.
Il ricatto (Canale 5, 1989), ambientato a Napoli, si rifà a La piovra come “genere”, riproponendone le tematiche, oltre che lo
sceneggiatore (Ennio De Concini). Offre un perfetto l’incastro tra
storia criminale e storia familiare: l’omicidio del prete fratello del
protagonista sembrerebbe un atto di camorra, ma è in realtà un
delitto familiare, compiuto dallo sfaccendato figlio del protagonista per far tacere lo zio che conosceva i suoi legami poco puliti.
Anche Sospetti (Rai Due, 2000) riprende tra Roma e la Calabria
l’intreccio tra intrighi criminali e storie sentimentali drammatiche.
Ben presto, tuttavia, il filone subirà un mutamento da non trascurare: la compresenza narrativa di storia criminale e dramma
familiare verrà riscritta come contrapposizione tra fedeltà al legame familiare e fedeltà al sodalizio criminale. In termini di antropologia politica, mentre il classico plot à La piovra presenta lo
scontro tra pubblico (malvagio) e privato (positivo), quella che
sembra emergere nella mutazione di cui stiamo parlando si può
leggere come la contrapposizione tra solidarietà meccanica (basata sul legame di somiglianza e in particolare sulle strutture di
parentela) e solidarietà organica (fondata invece sulla divisione
del lavoro e sulla relazione tra i diversi gruppi sociali esterni alla
famiglia “naturale”)7. Gli esempi sono numerosi.
Nella miniserie in due puntate Uomo contro uomo (Rai Uno,
1989) fratello e sorella calabresi compiono scelte antitetiche ma
sarà proprio il legame familiare a ricongiungerli: lei si stacca dalla faida familiare grazie all’educazione (diventa insegnante) lui
È infatti il Sud il vero protagonista di questo racconto, un Sud malato che assiste immobile alla decimazione dei suoi eroi positivi (…) un
Sud rurale, avvolto in un’atmosfera cupa e luttuosa, sprofondato nella violenza, dove la criminalità non rimanda a nessun grande circuito
malavitoso, ma semplicemente alla lotta per il controllo di un territorio circoscritto che altro non è se non la propria terra di origine.
Un altro esempio è costituito da Il magistrato, miniserie trasmessa nel 1990 su Canale 5, in cui un magistrato calabrese scopre
che suo figlio da molti anni in Australia traffica in armi e droga
con la ’ndrangheta. Alla fine la sconfitta del male coincide con il
117
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
invece rimane intrappolato nel circolo del crimine fino a diventare killer della ’ndrangheta. Pagherà con la vita per non aver voluto uccidere il magistrato amico della sorella. Sono la povertà e
l’ignoranza a produrre il contesto “arretrato” che tiene in vita la
cultura mafiosa, e l’arma di riscatto è l’istruzione, come metafora
e epitome dello sviluppo.
Il tema è ripreso con particolare dettaglio qualche mese dopo, in
Un bambino in fuga (Rai Uno, 1990), una miniserie in tre puntate
di grande successo (9.268.000 spettatori di media nonostante
non avesse goduto di una particolare promozione da parte dell’emittente) e di particolare intensità narrativa. Anche in questo
caso due fratelli calabresi con destini antitetici: uno prosegue la
faida e verrà ucciso, l’altro alla fine decide di interrompere la spirale della violenza. Essenziale ancora una volta il ruolo dell’istruzione, dato che i promotori della tregua saranno l’insegnante che
si prende cura del piccolo protagonista e un giovane istruito della famiglia rivale che riusciranno a spezzare il cerchio della violenza. Tutta la fiction ruota attorno alla contrapposizione morale
tra chi ancora è “interno” al sistema culturale della faida, raffigurato come quadro rurale e premoderno, e chi invece ne è “esterno”, perché non calabrese o perché motivato a uscirne. Nel 1991
Rai Uno riprenderà la storia in Un bambino in fuga - Tre anni dopo. Il ragazzo è perseguitato dalla storia della sua famiglia e
sembra non trovare scampo. Così ne parla l’estensore della scheda sul Catalogo della fiction italiana 1988-2000:
118
Identità catodiche
Piero Vereni
ricongiungimento familiare. Molto simile la fabula de L’ispettore
anticrimine (Rai Due 1993) che racconta le vicende di un poliziotto che, partendo da Bari, insegue le rotte del crimine internazionale (traffico d’armi, droga e sangue infetto) per scoprire che è il
fratello faccendiere a reggere le fila di tutti quei traffici illeciti.
Non mancano, in questo filone, paradossi narrativi dovuti anche
all’inevitabile usura del modello. Nel secondo episodio di Scoop
(Rai Due, 1992), il giornalista romano Michele Placido scopre che
alcuni esponenti della ’ndrangheta calabrese sono stati uccisi
non, come si credeva, in un regolamento di conti, ma dai familiari di alcuni sequestrati, decisi a farsi giustizia da soli. Altro racconto paradossale è quello del film-tv Kidnapping - La sfida (Rai
Due, 1998), in cui il protagonista, imprenditore tedesco cui è stato rapito il figlioletto dall’Anonima sequestri sarda, rapisce a sua
volta il figlio del rapitore. Questi, colpito negli affetti personali,
intraprenderà un cammino di conversione che lo porterà a sacrificarsi pur di salvare il figlio dell’imprenditore.
Una delle versioni più melodrammatiche di questo intreccio tra
legami familiari e crimine si ha in La voce del sangue (Rai Uno,
2001). Un giovane bergamasco scopre di avere origini calabresi e
di essere stato dato in adozione per sfuggire a una faida. La ricerca del padre naturale lo porterà in un torbido giro di rapimenti e vendette, da cui uscirà solo grazie al padre adottivo, che gli
ricorda che non ci si può fare giustizia da sé.
Anche quando la trama e il livello produttivo lasciano trasparire
l’uso strumentale del tema mafioso, non manca la voglia di contrapporre la famiglia alla “famiglia”. In Blindati (Rete 4, 2003) ancora una volta mafia e famiglia si sovrappongono. La lotta tra
due clan, uno siculo e uno albanese, si rivela guidata da due fratelli siciliani.
Di questo filone, forse l’esempio più compiuto è la serie L’onore
e il rispetto (Canale 5, 2006), un melodramma in salsa soap ambientato tra gli anni Cinquanta e Settanta tra Torino e la Sicilia,
in cui diventa impossibile districare la famiglia dalle storie di mafia. Tonio e Santi, due fratelli siciliani di Mascalucia, si trasferiscono a Torino. Uno diventerà un boss mafioso, l’altro un magistrato antimafia. L’onore è ancora quello delle donne: per vendi-
119
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
carsi di Pippo ’o calabrese (Giancarlo Giannini) Tonio, il fratello
cattivo (Gabriel Garko), non farà altro che sedurne e metterne incinta la figlia, che verrà poi sposata da Santi. Ma alla fine, quando si tratterà di scegliere tra la famiglia e la “famiglia”, Tonio deciderà di salvare il fratello magistrato anche a costo di rimetterci
la vita. Rivolto al boss gli dirà:
– Don Calogero. Vi ricordate quando mi avete chiesto di scegliere
tra me e la mia famiglia?
– Certo. E tu hai scelto bene.
– Vi siete sbagliato – Rivolto agli sgherri del boss – Buttate le armi o lo ammazzo!
Dopo la sparatoria, ormai moribondo, Antonio fa chiamare la figlioletta Antonia (cresciuta però dal fratello) e guardandola le dice: “Sei bella”. Poi, rivolto al fratello in lacrime, lo consola con le
parole che lo reintegrano dalla parte del bene: “Santino, la mamma si è sempre sbagliata. Sei sempre stato tu il migliore”.
Un altro titolo che sfrutta in pieno il tema è Era mio fratello (Rai
Uno, 2007). Due fratelli calabresi figli di un boss sopravvivono ai
genitori e vengono separati: uno viene allevato da un capomafia,
l’altro da un comandante del GIS (Gruppo d’Intervento Speciale
dei Carabinieri), fino a quando, vent’anni dopo la separazione, il
legame di sangue tornerà a incrociare le loro vite.
Il “familismo amorale”8 della fiction italiana sembra onnipresente: in Operazione pilota (Rai Uno, 2007) una donna pilota viene
ricattata dalla mafia colombiana, e per vedersi restituito sano e
salvo il figlioletto rapito dovrà tornare dalla Colombia con l’aereo
carico di droga. Ma i carabinieri del GIS hanno scoperto il ricatto
e affiancano alla donna un loro uomo, Raffaele (Massimo
Ranieri). Ma, leggiamo sulla pagina del sito Rai dedicata alla fiction, “Raffaele [è] un uomo ferito. Sua figlia è stata uccisa anni
prima e proprio durante un’operazione antidroga. Ai narcos,
Raffaele ha giurato vendetta”9.
Per capire quanto il filone sia pervasivo, basterà ricordare che è
stato sfruttato anche da una serie di grandissimo successo
(Distretto di polizia, Canale 5, otto stagioni dal 2000). Se nella
prima stagione la protagonista saliva a Roma trasferita dalla
Sicilia dopo la morte del collega-marito, in quelle successive l’in-
120
Identità catodiche
Piero Vereni
crocio tra dimensione familiare e crimine organizzato meridionale
diventa a volte più intricato e al limite dell’assurdo. Nella seconda serie la commissaria aveva arrestato il figlio di un boss, poi
morto in carcere. Il padre giura vendetta e cerca di uccidere la
donna. Nella sesta serie Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi) diventa nuovo commissario e la linea orizzontale10 è data dalla sua
contrapposizione con un potente boss che molti anni prima,
quando Ardenzi era solo un ragazzino, non aveva saputo accusare. Nella settima stagione (2007) il nuovo commissario (Massimo
Dapporto) stava in Calabria e ha visto il suo uomo migliore finire
ammazzato per essersi fidanzato con la figlia di un boss. Questa
allora ha denunciato il padre confessando la cosa proprio al
commissario. Come si vede, la lezione de La piovra (quando si
parla di crimine organizzato funziona narrativamente l’intreccio
tra mafia story e dramma familiare) persiste, pur se in contesti
marginali delle trame.
Questo tipo di fiction sembra dotato di una struttura regolare.
Per prima cosa sono chiaramente distinte le sfere morali di appartenenza: bene e male non hanno margini di sovrapposizione.
Stabilita questa separazione tra bene e male, lo sviluppo ha tre
opzioni.
1. Se i legami parentali sono interni alla medesima sfera (vittima
e suo parente nella sfera del bene, carnefice e suo parente nella
sfera del male) allora alla fine vincerà la sfera del bene, anche
grazie alla forza del legame parentale che si nutre al suo interno:
il bene che il padre prova per la figlia rapita dai cattivi è tale che
non può non sconfiggere il male, almeno il “male locale” che ha
prodotto il danno al parente del buono. Specularmente, il padre
cattivo che vuole vendicarsi del buono che gli ha messo in galera il figlio verrà sconfitto: il bene che egli prova per il figlio incarcerato non è sufficiente a sconfiggere il bene.
2. Se invece il legame di parentela attraversa le sfere morali (un
parente dalla parte dei buoni, uno da quella dei cattivi) allora le
alternative sono due:
2a. il buono, alla fine, riesce a trascinare nella sua sfera di influenza il cattivo, cioè il legame familiare produce paradossalmente una relazione positiva sul piano della strutturazione orga-
121
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
nica della società tramite un rapporto parentale, quindi di tipo
meccanico, magari anche solo in nome della parentela stessa,
dato che può essere il cattivo stesso a decidere di sacrificare la
sua vita per salvare il parente buono in pericolo, divenendo così
egli stesso buono in quanto combatte il cattivo;
2b. oppure la tensione giungerà a un punto di rottura e il buono
deciderà che si deve superare il legame familiare in nome di una
solidarietà più alta, vale a dire quella organica che tiene in piedi
il sistema delle istituzioni extra familiari.
Comunque sia, il legame familiare non è mai dannoso per il buono, dato che o produce effetti positivi (gli dà la certezza che
sconfiggerà i cattivi nel caso 1, e nel caso 2a gli consente di tirare dalla sua parte il parente cattivo) oppure si rivela ininfluente.
A meno che gli spettatori non si identifichino con i cattivi (e non
è detto che la cosa non avvenga, come discuteremo alla fine di
queste pagine) il messaggio di una struttura narrativa di tale fatta è evidentemente sbilanciato a favore della positività del legame familiare: combattere per il bene della propria famiglia di fatto coincide col combattere per il bene generale. Questo principio
è passato forte e chiaro in una delle ultime fiction disponibili per
quest’analisi, vale a dire La vita rubata (Rai Uno, 2008), basato
su una storia vera. Beppe Fiorello è il fratello carabiniere di
Graziella Campagna, una diciassettenne uccisa nel messinese nel
1985 per aver casualmente scoperto l’identità di un pericoloso
latitante. La ricerca dei colpevoli diventa per il fratello una vera
ossessione, che non lo abbandonerà fino a quando non saranno
consegnati alla giustizia, vent’anni dopo il fatto criminoso. La fiction non ha timore di presentarci il giovane letteralmente perseguitato dalla sua missione in un crescendo di tensione patemica
sicuramente coinvolgente. Dirà a un certo punto il protagonista,
per giustificare le sue insistenze: “Qui da noi la giustizia bisogna
trovarla, non viene da sé”.
Il problema “ideologico”, con questo tipo di messaggi, consiste
nel fatto che la loro natura dissemica viene completamente trascurata nella poetica della fiction italiana. Per dissemia, sulla
scia di quanto indicato da Michael Herzfeld, indichiamo il fatto
che ogni segno ha una duplice connotazione morale e, soprat-
122
Identità catodiche
Piero Vereni
tutto, che questo dualismo morale interno ai segni “appartiene
al codice stesso” (Herzfeld 1997a). Il che significa che non possono essere gli sceneggiatori di fiction a stabilire quale debba
essere il valore morale del segno “parentela” e che la regola
che essi credono di aver stabilito (se sei dalla parte del giusto,
è giusto difendere i propri parenti con tutte le proprie forze, e
con [quasi] tutti i mezzi) apre inevitabilmente le porte alle peggiori interpretazioni, dato che tutti, più o meno, sentiamo di
essere dalla parte del giusto e quindi in determinati contesti di
ricezione anche la difesa del figlio del boss può essere letta come la scelta giusta.
Ma prima di riprendere, più avanti, le conseguenze di questo tipo di ricezione del messaggio incardinato nell’intreccio tra storia
criminale e legame parentale, vediamo le sorti dell’altro filone
generato da La piovra.
Come dicevamo, altrettanto rilevante è lo sguardo, predominante
negli anni Novanta, verso una criminalità organizzata che si sente in qualche modo invincibile o che comunque non sembra possibile vincere “del tutto”. La mafia è assieme uno spazio sociale
e un vortice morale, che attrae verso di sé anche chi prova a resistergli. La miniserie Un uomo di rispetto (Rai Due, 1993) presenta di nuovo come protagonista Michele Placido. Questa volta
interpreta un ex mafioso trapanese che viene risucchiato suo
malgrado nella spirale del crimine. La sua ribellione è puramente
individuale, dettata più da un senso finale di impotenza rassegnata che non dalla speranza. Un converso criminale del commissario Cattani: lo stesso livido pessimismo di fronte all’inamovibilità radicale del contesto mafioso. In questa fiction è molto
importante la ricostruzione del percorso sociale che ha portato il
protagonista a staccarsi dal modello del padre (lavoratore onesto
ma povero) per abbracciare il modello mafioso come vero strumento di mobilità sociale. È probabile che si debba rintracciare
in questa matrice narrativa parte del fascino morboso che il
mondo del crimine organizzato, soprattutto mafioso, sembra
esercitare su una certa tipologia di sceneggiature.
Anche nella ricostruzione italiana del mondo mafioso non mancano infatti le rappresentazioni il qualche misura “simpatetiche”
123
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
con l’universo culturale della mafia, inteso quasi come uno spazio primigenio di socializzazione elementare, basato su ipotetici
vincoli primordiali fatti di onore, parola data, rispetto e immediatezza dei vincoli familiari. Resa senso comune nell’immaginario
mediatico grazie al duplice lavoro di romanziere e sceneggiatore
di Mario Puzo (1969)11, quest’immagine dell’“onorata società” come corporazione di affetti primordiali (amore e odio, soprattutto)
più che di criminali organizzati si intreccia molto bene con il melodramma familiare di estrazione borghese, e rappresenta forse il
versante politicamente scorretto (e probabilmente il modello narrativo di riferimento) di quel legame tra famiglia e “famiglia” che
abbiamo visto presente in tutta la saga de La piovra. Un esempio particolarmente efficace di questo modo di intendere la mafia, quasi uno spazio per una “nostalgia da tavolino”12 di uno stile di vita mai veramente posseduto, si ha nell’adattamento
Donna d’onore (Canale 5, 1990), una miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Sveva Casati Modignani (1988). Più che provocare un senso di sana ripulsa per un sistema morale perverso, la
fiction sembra voler suscitare una morbosa fascinazione per la
dimensione “ancestrale” del Sud, tanto che, ad esempio, sangue
e rito sembrano legati necessariamente in questa storia di mafia
e onore: il velo della prima comunione intriso del sangue paterno diverrà un feticcio; la prima mestruazione è legata all’omicidio dello zio della protagonista, che stava tentando di violentarne la madre; il primo bacio avviene in concomitanza dell’assassinio della madre; il matrimonio della protagonista (Carol Alt) si
concluderà con la sposa che ammazza il marito, anni prima involontario omicida del padre. Più che condanna sociale sembra esserci una sorta di riconoscimento sentimentale delle motivazioni
delle pratiche mafiose della vendetta.
Ma se non è la sceneggiatura nel suo insieme a cadere vittima di
questo fascino perverso, altre volte lo sono i singoli personaggi.
In A che punto è la notte, miniserie (Rai Due, 1994) adattata dall’omonimo romanzo giallo (Fruttero, Lucentini 1979), si narra una
Torino cupa, in cui non possono mancare infiltrazioni mafiose,
cariche però di certo fascino. La figlia della bella borghese è infatti innamorata di un mafioso, e anche la madre subirà l’allure
124
Identità catodiche
Piero Vereni
del crimine. In questo caso, una Torino gelida e apparentemente
lucida nella sua razionalità nasconde un lato oscuro, e il Sud
non è altro che l’innesco per farlo esplodere all’esterno.
Ma quest’immagine del Sud come luogo di un’incontenibile pressione sensuale non si lega necessariamente al quadro malavitoso, che ne diviene anzi quasi un accessorio funzionale, un mezzo
di espressione. La letteratura nazionale è piena di raffigurazioni
appassionate e passionali del Meridione, e la fiction ne ha incorporato il sistema di valori. Assunta Spina (Rai Uno, 2006), il famoso dramma teatrale di Salvatore Di Giacomo, viene adattato
in chiave di emancipazione femminile, ma è forte la presenza del
Sud come passione incontrollabile, nella figura di Michele
Boccadifuoco e anche di Assunta, che per aiutare Michele finirà
volentieri tra le braccia del magistrato Federico Funelli.
Da forza invincibile a zona oscuramente fascinosa, l’area del crimine mafioso può divenire rapidamente lo spazio immaginario
del Male, per cui la criminalità organizzata non è rappresentata
in quanto tale, ma come semplice incarnazione di una funzione
narrativa. Si tratta per lo più di commedie o melodrammi, in cui
“il mafioso” è, senza particolari sfumature, l’ostacolo che si frappone tra il buono e il raggiungimento del suo scopo.
Non credo che si debba sottovalutare l’impatto macchiettistico, e
quindi smaccatamente costruito nella sua rappresentazione del
Sud, di questo tipo di fiction. Il problema con questo genere di
narrazione è che nel personaggio mafioso male e caratterizzazione meridionale vengono a sovrapporsi completamente, dato che
in molti casi di questo tipo il mafioso è l’unico meridionale presente sulla scena, aprendo così spazio a un’inevitabile equazione
mafia = male = Meridione.
Un esempio “innocuo” potrebbe essere Polizza droga (Canale 5,
1988), un poliziesco con Bud Spencer che si infiltra in un’organizzazione mafiosa. Un esempio invece molto più evidente nelle sue
intenzioni caratterizzanti è stato la miniserie in cinque puntate
Piazza di Spagna (Canale 5, 1992). Tra i protagonisti del bel
mondo spiccano i membri della famiglia Cascone: lui rozzo mafioso siculo, con moglie timorata di Dio, figlio scapestrato e poi
redento, e figlia tutta protesa a farsi notare sulla scena. La fic-
125
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
tion suscitò un notevole dibattito e fu accusata di razzismo per
la rappresentazione dicotomica Nord/Sud. Non è probabilmente
un caso che contenuti di questo tipo furono trasmessi tra gennaio e febbraio 1992, vale a dire in poche settimane prima delle
elezioni politiche del 5 aprile 1992, dove la Lega Nord di
Umberto Bossi (nata l’anno prima dalla fusione di diversi movimenti autonomisti del Nord Italia) ottenne oltre l’8 per cento dei
consensi su scala nazionale sia alla Camera sia al Senato, divenendo il quarto partito italiano per seguito elettorale13.
Uno degli esempi più recenti di questo modo di rappresentare il
crimine del Sud, in cui la camorra incarna il male dei sentimenti,
la malattia perversamente fascinosa del cuore più che dell’economia, è Io non dimentico (Canale 5, 2008). Manuela Arcuri è
perseguitata da un camorrista che le rovina la vita per troppo
amore, fino alla vendetta, che non giungerà però dalla sua mano, bensì da quella di un’altra donna.
Peraltro, non è assente nella raffigurazione del crimine organizzato meridionale un esplicito tentativo di rappresentarlo invece nella sua gelida brutalità, senza alcun compiacimento morboso. Il filone di questa fiction “d’impegno” è particolarmente robusto, soprattutto se associato all’intenzione di dimostrare come “le cose
possono cambiare”. Un esempio di questo atteggiamento ottimista è Il coraggio di parlare (Rai Due, 1991), tratto da un romanzo
di Gina Basso (1981). È la storia di un adolescente calabrese che
viene lentamente assorbito dalla criminalità locale ma trova la
forza di resistere. Su questa linea si colloca anche la miniserie
Dio ci ha creato gratis (Canale 5, 1998), in cui Leo Gullotta interpreta un candido prete che scoprirà che la vera terra di missione
non è l’Africa, dov’era originariamente diretto, ma l’hinterland napoletano dove la Chiesa molto può fare per contrastare il degrado
sociale e la criminalità organizzata. Un altro esempio si ha con
Ama il tuo nemico (Rai Due, 1999): un giovane camorrista si converte in carcere e prende i voti, andando a prendere il posto del
sacerdote che l’ha guidato sulla via della redenzione. Il criminale
convertito proseguirà la sua opera di recupero sociale una paio
d’anni dopo (Ama il tuo nemico 2, Rai Due, 2001), salvando una
ragazza in un quartiere a rischio di una città pugliese. In Una sola
126
Identità catodiche
Piero Vereni
debole voce (Rai Due, 1999) una donna “perbene” scopre che il
marito ha curato nella sua clinica diversi mafiosi. Dovrà lottare
duramente con la sua coscienza per ripudiare quel mondo luccicante e accettare le sue responsabilità.
Ma il filone “donne e mafia” costituisce quasi un sottogenere autonomo della fiction di impegno e di denuncia. Donne di mafia
(Rai Due, 2001), tratto dall’omonimo libro inchiesta di Liliana
Madeo (1994), racconta le donne che prendono parte a una faida, dipinte come deboli vittime o spietate partecipi. Solo la protagonista (di famiglia non mafiosa, sposata inconsapevolmente a
un mafioso) riuscirà a resistere, spingendo anche il marito verso
il pentimento, offrendo dunque una visione originale quanto a
prospettiva (dal punto di vista delle donne) ma ancora legata allo stereotipo della femmina siciliana, madre dolorosa o furia belluina. Questa contrapposizione forte tra donne vittime e donne
carnefici si ripropone in Una sola debole voce 2 (Rai Due, 2001):
sotto protezione, Nora incontra Angelica, un’altra donna testimone in un processo di mafia. Questa verrà però uccisa e Nora ne
prenderà in adozione il figlioletto. Forte la contrapposizione tra
le due donne collaboratrici e Cettina, cognata di Angelica, che la
scoprirà e la farà uccidere.
Sul versante di denuncia (con finale consolatorio) si situa anche
Il testimone (Canale 5, 2001), miniserie ispirata a fatti reali. Il
protagonista (Raoul Bova) è testimone di un delitto di mafia e
decide di collaborare con la giustizia. Esasperato dallo sradicamento da casa e dall’isolamento dovuto al programma di protezione, l’eroe normale torna al paese e solleva la comunità contro
il boss. Di denuncia è anche la miniserie A voce alta (Rai Uno,
2006), il cui protagonista (Ugo Dighero) è un buon borghese che
scopre infiltrazioni mafiose nel suo ambiente di lavoro (cantieri
navali) e non si tira indietro dal denunciare la cosa.
Proprio riflettendo sul mutamento di questo genere “di denuncia”, sembra evidente che da qualche anno comincia a delinearsi
nitidamente un modello narrativo che invoca l’impegno e la responsabilità individuale dei cittadini meridionali per liberarsi della criminalità organizzata. Mentre solitamente la descrizione del
Sud era legata a un rassegnato pessimismo o a un mutamento
127
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
che spesso sembrava provenire da fuori, sempre più evidente si
fa ora l’esigenza di ancorare il cambiamento all’interno della società meridionale. La fiction di impegno sociale rivolta al Sud,
inoltre, non si limita più alle storie di mafia, ma emergono anche
altri modelli sociali di rivalsa. Il figlio della luna (Rai Uno, 2007)
racconta la vera storia di Fulvio Frisone, nato spastico per un
trauma da parto da una famiglia siciliana di modeste condizioni.
La madre si batte per far avere al figlio una vita normale, e ci riesce. Ora Frisone è ricercatore di Fisica.
Anche il modello della biografia di italiani esemplari trova al Sud
nuovi spunti di riferimento. Giuseppe Moscati (Rai Uno, 2007)
narra la vita del napoletano “medico santo”, un dottore degli inizi del Novecento che visse la sua professione come una vera
missione, tanto da rinunciare a una promettente carriera universitaria pur di non perdere il contatto con l’ospedale e con i pazienti cui tanto teneva.
Con il passare degli anni il modello della fiction “impegnata” è
divenuto talmente diffuso da contaminare anche la classica commedia d’avventura. Bud Spencer in Padre Speranza (Rai Due,
2005) arriva come cappellano del carcere minorile di Crotone, e
con i suoi modi da burbero benefico saprà istillare fiducia tra i
giovani detenuti che inizieranno a ribellarsi alla mafia.
Ma questa disponibilità del modello non riguarda solamente l’impegno civile (che stiamo seguendo come tarda conseguenza narrativa del filone mafioso), e proprio grazie al successo generale
dei film di ambientazione criminale, ben presto la mafia può diventare poco più che un pretesto narrativo.
Solo (1989) è tratto da un racconto (Viola 1924) che già aveva
fornito il soggetto di I bambini ci guardano, un film di Vittorio
De Sica del 1943, e parla del dramma di un bimbo che vive l’abbandono della madre e la profonda tristezza del padre. Rispetto
alla trama originale, il padre del piccolo protagonista è diventato
un avvocato di processi di mafia, e il suo stato d’animo impaurito e incline alla depressione trova nella professione esercitata un
pretesto di plausibilità.
Anche una mafia story apparentemente nitida come Due vite un
destino (Canale 5, 1993) utilizza l’ambiente criminale siciliano so-
128
Identità catodiche
Piero Vereni
stanzialmente come un pretesto, in questo caso per parlare delle
vite private dei due protagonisti, un commissario profondamente
colpito nei suoi affetti e un reduce del Vietnam che accetta di diventare killer di mafia per guadagnare i soldi che gli servono per
tentare di curare la moglie in coma.
Ne Il prezzo della vita (Rai Due, 1996) la mafia è solo una scusa
per aprire lo spazio narrativo del melodramma. Parimenti, in La
signora della città (Rete 4, 1996) e Il morso del serpente (Rete 4,
2001), la mafia ha l’unico compito di produrre l’ambiente tetro
del dramma personale dei protagonisti. In Ics - L’amore ti dà un
nome (Rai Due, 2003), invece, l’effetto melodrammatico si realizza in un contesto di violenza organizzata. La protagonista
(Vittoria Belvedere) cerca vendetta dopo che le è stato ammazzato il figlio in una punizione trasversale per i traffici del padre, direttore di banca colluso.
Le linee narrative orizzontali di Distretto di Polizia cui abbiamo
accennato sopra sono un chiaro caso di uso strumentale del
racconto di mafia. Residuo ideologico-narrativo de La piovra,
la mafia in casi come questi serve a mantenere alta la tensione, stendendo un filo che aggancia lo spettatore tra un episodio e l’altro.
La mafia compare come spezia per insaporire la trama anche in
serial di lungo corso a impianto tipicamente melodrammatico,
come Incantesimo (Rai Uno, dieci stagioni tra il 1998 e il 2008).
Nella stagione 2001-2002, ad esempio, una delle protagoniste
deve cambiare identità per salvarsi dalla vendetta di Tony, un
mafioso italo-americano che la perseguita dato che il padre di lei
l’ha denunciato alla polizia. Si tratta di un modo per aumentare
il pathos del melodramma, un uso del tutto strumentale del mafioso e delle sue caratterizzazioni, che come di prammatica fa leva sull’intreccio tra trama criminale e legami parentali.
Ma per comprendere a pieno il meccanismo di produzione del
racconto mafioso e l’idea di Meridione che lo sottende almeno
fino alla fine degli anni Novanta, bisogna ripartire dalla strutturazione del territorio e dalla peculiarità della conformazione
sociale della rappresentazione del Sud. Bisogna cioè riprendere l’analisi dalla contrapposizione tra spazio urbano metropoli-
tano e provinciale da un lato, e tra spazio sociale proletario e
borghese dall’altro.
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Un tema comune nelle fiction italiane è la contrapposizione tra
metropoli, cittadina di provincia e aree rurali. Il segno morale di
questa contrapposizione non è univoco e va analizzato in dettaglio, dato che l’antitesi può essere posta sia in chiave evolutiva
(la città come luogo dell’emancipazione sociale e quindi la provincia come spazio arretrato dell’ipocrisia e delle relazioni sociali
“di facciata”) sia involutiva (la provincia come luogo del ritorno
alle origini, alla “verità” di quel che si è e al calore delle relazioni umane cooperative, contro l’anomia della vita cittadina e il
suo asettico spazio di algide relazioni professionali competitive).
Può succedere, quindi, di assistere a una storia come Ti presento un’amica (Canale 5, 1989), in cui il giornalista onesto,
disgustato dal carrierismo della collega che si concede a un dirigente televisivo, lascerà Roma, metropoli corrotta, per andarsene “in provincia”, luogo della rettitudine morale, evidentemente. In Giorni da Leone (Rai Uno, 2002) un padre del tutto
assente (Luca Barbareschi) ritroverà il rapporto coi figli quando
dalla metropoli partirà con loro per un viaggio verso la cittadina di provincia da cui era partito. Caterina e le sue figlie, una
miniserie di Canale 5 (2005; Caterina e le sue figlie 2, Canale 5,
2007) riproduce lo schema quasi invertendolo di direzione: una
madre sola nella campagna romana ha allevato tre figlie ma deve correre a Roma a salvarle dai disastri delle loro vite private,
prima di poter tornare in provincia e accettare la corte del farmacista del paese.
Il senso della provincia come spazio di un languido ricordo è
particolarmente evidente, fin dal titolo, in Un posto tranquillo
(Rai Uno, 2003), un clamoroso e inaspettato successo (oltre dieci
milioni di spettatori) che al di là dell’esile trama deve il suo risultato all’ambientazione di Borgo Treccase, una località di fantasia della Toscana su cui è facile costruire sentimenti nostalgici:
129
La provincia e lo spazio della borghesia
Piero Vereni
Identità catodiche
130
lo spettatore si trova immerso fin dalla prima inquadratura nelle immagini, nei suoni e nei rumori di quel “piccolo mondo” di ascendenze guareschiane che ha radici lunghe nella memoria del pubblico, soprattutto fra gli anziani. Il convento sperduto tra i boschi, i frati cappuccini e il paese costituiscono lo scenario che rimanda al titolo, a
quella tranquillità immaginata come un tratto distintivo del passato…
(Bechelloni 2004, p. 90).
Altre volte, invece, la provincia è il luogo del perbenismo ipocrita
e dell’incapacità di affrontare a viso aperto le debolezze umane,
spesso occultate per ragioni di decoro dietro l’apparenza di una
vita onesta e borghese. Per gli scopi di questo lavoro, è particolarmente interessante registrare i luoghi di ambientazione di queste vicende. Si tratta, infatti, quasi esclusivamente di collocazioni
geografiche dell’Italia centro-settentrionale.
Nel film-tv Dopo la tempesta (Rai Uno, 1996) l’azione si svolge a
Forte dei Marmi, e una madre combattiva dovrà affrontare l’omosessualità nascosta del figlio per salvarlo dagli esiti nefasti
di una notte brava. La tenda nera (Rai Due, 1996), una cupa
storia di sette sataniche, ha una generica collocazione provinciale, ma il protagonista è Luca Barbareschi e l’ambientazione richiama il Nord Italia. Provincia segreta (Rai Due 1998) e
Provincia segreta 2 - I delitti della casa sul fiume (Rai Due,
2000) sono ambientati al Nord (il secondo, più precisamente, in
provincia di Treviso) e raccontano entrambi degli intrighi messi
in piedi da stimati professionisti e imprenditori per coprire le
tragiche conseguenze di notti brave. La borghesia della provincia è ritratta nelle sue debolezze anche in Come quando fuori
piove (Rai Uno, 2000), una commedia che racconta le vicissitudini di un paesino veneto assalito dalla frenesia per il gioco
d’azzardo dove viene venduto il biglietto vincente di una lotteria miliardaria. Un quadro più cupo della medesima borghesia
veneta è offerto in Occhi verdi veleno (Rete 4, 2001), miniserie
ambientata a Verona. Il filone prosegue con Giochi pericolosi
(Rai Due, 2000) ambientato a Viterbo, Amanti e segreti (Rai
Uno, 2004) che si svolge a Ferrara, Assassini per caso (Rai Due,
2004), nel contesto di una generica provincia italiana, e ripren-
131
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
dendo anche classici della letteratura italiana, come nel caso de
La provinciale (Rai Uno, 2006) ambientata a Orvieto, che adatta
per il piccolo schermo il romanzo di Alberto Moravia ma ne
mantiene intatto il messaggio: la provincia è prima di tutto una
sentina del vizio, mascherato nell’ipocrisia del rispetto sociale.
Anche Il segreto di Arianna (Rai Uno, 2007) è una storia di crimini privati, e si svolge in una generica cittadina dell’Italia centrale. Io ti assolvo (Canale 5, 2008) è ancora una storia di crimine e ipocrisia della provincia borghese, ma questa volta la collocazione degli eventi è genericamente italiana.
Che sia luogo dove possono riprendere vigore gli “antichi valori”
o invece il turpe regno dell’ipocrisia (o, spesso, una compresenza di queste due dimensioni morali), fino alla fine degli anni
Novanta la cittadina di provincia italiana sembra esistere come
oggetto di rappresentazione borghese solo nel Nord e nel Centro
del paese, mentre il Sud si limita a fare da sfondo a storie in cui
predomina il crimine organizzato e il suo triste corredo di degrado morale e sociale. Si può facilmente verificare anche quantitativamente questa affermazione se si contano le ambientazioni
meridionali tra il 1988 e il 1999.
Dei 39 titoli che nel periodo indicato presentano (anche) ambientazioni meridionali solo le tre annate di Un posto al sole (Rai
Tre) raffigurano un quadro “borghese”, pur se virate secondo le
forme poco realiste della soap. Si tratta, bisogna dirlo, di un prodotto atipico che risponde anche alle esigenze di decentrare la
produzione Rai, e quindi l’ambientazione napoletana è solo parzialmente una scelta di sceneggiatura: a parte Raffaele, l’ennesimo portiere stereotipicamente napoletano, interpretato da
Patrizio Rispo, la fiction potrebbe essere ambientata ovunque. Ci
sono attori con accento milanese o altrimenti regionale, e altri
che parlano italiano standard, e la Napoli reale si vede molto poco. Anche il saltuario riferimento alla camorra, più presente nelle
prime stagioni, è solo uno dei moltissimi temi “di attualità” toccati dal serial.
Per il resto, si tratta di storie dove il crimine organizzato o il disagio sociale a questo associato hanno un ruolo predominante.
Napoli appare altre sei volte, e i temi sono la malavita, l’infanzia
132
Identità catodiche
Piero Vereni
oppressa, i bassifondi, l’emarginazione sociale e il crimine internazionale. Parziali eccezioni sono la microfiction Joe e suo nonno
(Rai Uno, 1992), che racconta Napoli attraverso le canzoni di
Edoardo Bennato (ma è più uno spot diluito per il disco del cantante che non una vera fiction) e la Napoli molto cupa descritta
nel fallimentare (in termini di ascolto, oltre che di resa artistica)
Un cambiamento d’aria (Rai Due, 1991), adattamento al contesto
partenopeo di un thriller d’ambientazione americana (Hadley
Chase, 1973). Restando in Campania, vi sono altri due titoli che
trattano di camorra ed emarginazione ma in contesto provinciale,
e infine Una storia italiana (Rai Uno, 1993) che racconta con accenti inevitabilmente didascalici i successi sportivi dei fratelli
Abbagnale come storia di riscatto sociale e di capacità di redimersi. In tre altri casi campani, Pozzuoli, in quanto sede
dell’Accademia Aeronautica, è il luogo necessario di una serie in
stile Top Gun (Aquile, Rai Due, 1990), Positano (Rai Uno, 1996),
l’ambientazione in cui una villa sulla costiera amalfitana diventa
lo spunto per una commedia di situazione, e infine Capri è solo
un pretesto scenograficamente accattivante per la commedia nostalgica di Carlo Vanzina interpretata da Ezio Greggio (Anni ’50,
Canale 5, 1998).
Venendo al resto, i conti sono presto fatti. La Calabria compare
sette volte, sempre in contesti di crimine organizzato o di profonda marginalità sociale che lì conduce o che da lì proviene. La
Puglia compare due volte con mafia e crimine internazionale; la
Sardegna una volta, con un caso di rapimento; la Sicilia, infine,
compare quindici volte, di cui tredici in contesti mafiosi, una come parziale ambientazione di un melodramma che è una curiosa
e poco riuscita trasposizione ai tempi nostri della Anna Karenina
di Lev Tolstoj (Il grande fuoco, Canale 5, 1995) e una volta infine
come luogo di ritorno di una famiglia meridionale dopo la tragedia di Seveso, in un contesto di profonda miseria ed emarginazione sociale nel già citato Una lepre con la faccia da bambina
(Rai Due, 1988).
Come si può vedere, quel che manca in questa rappresentazione
del Sud è proprio la provincia con i suoi umori e malumori borghesi. Manca insomma, fino al 1999, una rappresentazione della
133
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
“classe media” meridionale, invisibile tra mafiosi, macchiette e
miserandi in cerca di riscatto, e manca una rappresentazione della “cittadina di provincia” meridionale, oppressa tra crimine metropolitano, paesaggio agreste/insulare e nuove forme internazionali del crimine.
A parte lo sfortunato caso de Il commissario Raimondi (Canale 5,
1999), dove Marco Columbro interpreta un commissario spostatosi a Napoli a inseguire un’improbabile trafila di crimini, ad aprire
una nuova rappresentazione del Sud insieme provinciale e borghese è Il commissario Montalbano.
Salvo Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, è oggi
uno dei personaggi più famosi e amati della fiction televisiva
italiana14. Per capire il grado di novità di questa figura, che
compare in video nel maggio del 1999, bisogna ricostruire almeno per sommi capi il contesto complessivo della fiction italiana
dell’epoca che, nel genere giallo/poliziesco, consentiva di fatto
tre alternative:
1. Il giallo “astratto”, fatto di intrighi criminosi internazionali
(La ragnatela, Rai Due, 1991), di rapine del secolo (Il colpo,
Rai Uno, 1989) o di investigatori hard boiled, come Sergio
Castellitto che interpreta Un cane sciolto, con i sequel 2 e 3
(Rai Uno, rispettivamente 1990, 1991 e 1992). Possiamo definirlo lo spazio dei “duri”.
2. La mafia story in cui il poliziotto onesto combatte contro la
criminalità organizzata nel Sud dell’Italia, secondo la variante
“eroe onesto ma perdente” (che ha nel commissario Cattani il
suo archetipo) o nella più recente versione “eroe che vince”, incarnata da Ultimo (Canale 5, 1998), che aprirà un filone sostanzialmente autonomo, su cui torneremo diffusamente nel paragrafo finale, sempre più “realista” da un lato e contaminato dal modello precedente dall’altro (si veda ad esempio Operazione
Odessa, Canale 5, 2000).
3. “Bravi uomini” delle forze dell’ordine che lavorano in una
Roma strapaesana – si pensi ai bonari poliziotti incarnati da Nino
Manfredi in Un commissario a Roma (Rai Uno, 1993) e in Linda e
il brigadiere (Rai Uno, 1997) Linda e il brigadiere 2 (Rai Uno,
1998) – oppure nella Milano dei crimini “metropolitani” (bische
134
Identità catodiche
Piero Vereni
clandestine, droga, ultras calcistici: tutti temi de Il commissario
Corso, Rai Due, 1992) o sempre più spesso nella provincia del
Centro-Nord su crimini privati: il bolognese Ispettore Sarti interpretato da Gianni Cavina è del 1991 (Rai Due, la seconda serie è
del 1994); il maresciallo Rocca di Gigi Prioetti è ambientato a
Viterbo e inizia nel 1996; nel 2000 inizia anche la saga di Don
Matteo (Rai Uno), improvvisato detective in quel di Gubbio, interpretato da Terence Hill.
In questo quadro di riferimento, la regola non scritta che regge i
soggetti delle fiction italiane sembra chiara. Il crimine è raramente qualcosa di esotico, ma se è domestico si regge su una dicotomia: la città o la provincia centro-settentrionale sono lo spazio
del crimine privato, tendenzialmente piccolo-borghese in provincia e più nitidamente appannaggio delle classi alto-borghesi o
subalterne nella metropoli, mentre il Sud ha come unico spazio
di confronto con il crimine le grandi organizzazioni, i loro protagonisti luciferini e i loro nemici implacabili, il tutto su uno sfondo metropolitano (Napoli, Palermo) o privo di tratti riconoscibili.
Con il suo semplice apparire, Salvo Montalbano sovverte questa
regola, dato che nell’immaginaria Vigàta dove opera si incrociano
tre ingredienti prima tenuti sempre rigorosamente separati: la
provincia fatta di consuetudine e conoscenze; una classe borghese attiva e dinamica, ancorché vittima del suo stesso malessere
e delle sue ipocrisie; il Sud dell’Italia.
Per la prima volta, quindi, la narrazione televisiva può parlare al
Sud di crimine borghese, senza implicare necessariamente la mafia. Si tratta di una scelta intenzionale di Andrea Camilleri, che
l’ha esplicitata più volte, da ultimo in occasione della polemica
sulla messa in onda de Il capo dei capi (Canale 5, 2007), di cui
parleremo più avanti. In un’intervista rilasciata a «La Stampa» il
5 ottobre 2007, pur senza fare riferimento alla fiction che sarebbe stata trasmessa solo venti giorni dopo ma di cui già si parlava, il creatore di Montalbano esprime questo giudizio estremamente severo:
un narratore sia pure pessimo finisce col nobilitare il fenomeno mafioso. Lo abbellisce, lo rende attraente... Certo, non potevo fingere
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Questa presa di distanza è probabilmente l’evento più importante che attraversa la rappresentazione del Sud nella fiction italiana a cavallo del nuovo millennio, un evento che verrà riconosciuto immediatamente dal pubblico, che farà di Salvo Montalbano
uno dei suoi beniamini assoluti. Sicuramente il grande successo
della serie (che regge benissimo le numerosissime repliche) si
deve anche alla cura della produzione, che ha confezionato dei
veri “film per la televisione”, oltre che alle notevoli qualità di
Luca Zingaretti come interprete. Ma non vi è dubbio che nelle vicende di Montalbano il pubblico ha riconosciuto finalmente la
possibilità di parlare della Sicilia come spazio del “crimine borghese”.
Nell’episodio Il gioco delle tre carte, Simona Cavallari, nei panni
di una bella vedova, così risponde al commissario che le chiede
se la morte del marito abbia una matrice mafiosa: “Commissario,
non crederà anche lei che tutti gli omicidi che si commettono
nella nostra bella Sicilia siano opera della mafia?”. Montalbano è
la voglia di affermare una Sicilia “normale”, non certo un posto
dove non avvengono crimini, ma un posto dove i crimini avvengono per i diversi motivi “umani” che caratterizzano il crimine
ovunque.
Da quel momento, proprio grazie alla già accennata tendenza
imitativa che spinge le produzioni a replicare le formule narrative di maggior successo, la produzione italiana sembra in grado
di liberarsi progressivamente del pregiudizio che voleva la storia
criminale rappresentata al Sud necessariamente separata dalla
sua matrice sociale (provincial-borghese o metropolitano-proletaria) per esprimersi solo nella (rurale?) radice del crimine organizzato. L’anno successivo inizia La squadra (Rai Tre, sette stagioni dal 2000; nel 2008 è andata in onda La nuova squadra),
una fiction poliziesca che prosegue in questa rivisitazione del
modello meridionale: i poliziotti guidati dall’ispettore Guerra sono esseri umani a tutto tondo, con una sfera privata che non
necessariamente si incrocia con la professione (come avveniva
135
che [la mafia] non ci fosse: così l’ho introdotta come un basso continuo, un fruscio di fondo. Ma farne la protagonista, mai.
136
Identità catodiche
Piero Vereni
invece a Cattani e ai suoi epigoni) e che non hanno da combattere solo la camorra organizzata. Gli episodi intrecciano storie di
piccola criminalità urbana e tipiche vicende da crimine “borghese”, tenute assieme da uno stile narrativo caratterizzato da un
budget contenuto e quindi poco propenso a sfruttare la città come “panorama”.
A partire dal 1999, e in modo sempre più netto, emerge quindi
una nuova immagine del Sud, meno legata allo stereotipo criminale e disponibile ad articolazioni complesse della sua composizione sociale e culturale. Certo, permangono le immagini del Sud
come luogo magico, spazio dell’incanto o semplice panorama da
sfruttare come scenografia naturale, ad esempio in Capri (Rai
Uno, 2006; Rai Uno, 2008), come abbiamo visto un serial ambientato nell’isola con intenti chiaramente esotizzanti. Così come
continuano a essere presenti le rappresentazioni fortemente legate allo stereotipo “etnico”. Per citare un esempio, basta leggere il modo in cui sul sito di Codice rosso (Canale 5, 2006), una
serie dedicata ai Vigili del Fuoco, viene descritto il personaggio
di Rocco (Silvio Laviano), un catanese che guida l’autopompa:
“Mosso da passione e da un’energia vulcanica (come l’Etna della
sua terra d’origine) ha voglia di fare tutto con precisione e lealtà,
ma è così sensibile da risultare spesso timido e impacciato”.
Una cartina di tornasole particolarmente evidente di alcuni automatismi persistenti della narrativa dedicata al Meridione si è avuta con la collection Crimini (Rai Due, 2006), una raccolta di sei
gialli ognuno scritto da un famoso scrittore del genere: Cagliari
scritta da Marcello Fois, Napoli da Diego De Silva, Milano da
Sandrone Dazieri, Bologna da Carlo Lucarelli, l’isola d’Elba da
Giorgio Faletti e Palermo da Andrea Camilleri. Mentre i casi di
Milano, Bologna e dell’Elba sviluppano le tematiche del noir (intrighi, killer, omicidi borghesi) senza particolari connotazioni regionali, gli episodi dedicati al Sud toccano tutti la questione del
crimine come “problema sociale”. In Troppi equivoci, di Camilleri,
una coppia appena formatasi viene distrutta dalla mafia, che per
errore ammazza la donna, e ne Il covo di Teresa emerge anche
nettamente il contrasto tra un Nord ordinato e “civile” e un Sud
ancora “caotico”.
Sulle prime il giudice è tutt’altro che entusiasta del suo nuovo ambiente di lavoro: abituato all’efficienza milanese, Diego non riesce ad
adattarsi ai ritmi compassati dei nuovi colleghi. Impiegati svogliati,
segretarie imbranate e un rapporto conflittuale con il Procuratore
Capo (…) provocano in lui la sensazione di esser capitato nel posto
sbagliato.
Con il passare del tempo, tuttavia, Mastrangelo si accorge anche
dei pregi delle persone che lavorano con lui (…) impara a conoscere
meglio i suoi conterranei, e si rende conto che alcuni dei suoi pregiudizi erano sbagliati (…). Sul piano professionale supererà i preconcetti e le diffidenze reciproche, su quello personale imparerà ad
utilizzare il suo lato istintivo e passionale e a non aver paura dei
propri sentimenti15.
Notevole, in questa scheda, l’implicita associazione tra Sud e “lato istintivo e passionale” che si può però consolidare non più
dentro un immaginario di miseria sociale, ma lasciando la scena
a una borghesia “moralmente media” (vale a dire né pervertita
dal Male criminale né rassegnata al suo ruolo di vittima di quel
Male) finalmente in grado di preoccuparsi d’altro che non della
mafia, e finalmente in grado di esprimere un orgoglio identitario
che non sia, automaticamente, adesione belluina a un codice minimo di valori legati al sangue o all’onore delle donne. Sembra
137
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Nonostante queste evidenti resistenze, l’apertura narrativa consentita dai crimini borghesi e provinciali indagati da Montalbano
in Sicilia offre nuove opportunità di fare i conti con l’immagine
provinciale del Sud.
Il commissario Corso (Rai Due, 1992) era di origini meridionali ma
trapiantato al Nord. Lo stesso attore, Diego Abatantuono, diversi
anni dopo interpreterà un personaggio speculare, un giudice che
torna nella natia Lecce dopo aver lavorato molti anni a Milano (Il
giudice Mastrangelo, Canale 5, 2005; Il giudice Mastrangelo 2,
Canale 5, 2007). Siamo di fronte a un caso di recupero identitario: emigrante di ritorno, il protagonista deve fare i conti con un
passato e un sistema di valori dai quali si è da lungo tempo distaccato. Ma vale la pena di cedere la parola alla scheda introduttiva del sito:
138
Identità catodiche
Piero Vereni
quindi farsi avanti una rappresentazione dell’identità meridionale
sempre meno “etnica” e sempre più “civica”, per usare un’opposizione dubbia sul piano delle realtà sociali16, ma che forse può
dare conto in modo adeguato degli stili di rappresentazione utilizzati nella finzione narrativa.
La nuova immagine di un Sud come luogo della socializzazione
primaria, messa in crisi da un lato dall’etica capitalista e dall’altro dal pregiudizio contro il diverso, era già emersa qualche anno
prima – pur se implicitamente, dato che il paesello
“Casebianche” è inesistente – in Un difetto di famiglia (Rai Uno,
2002), una commedia in cui Nino Manfredi è un ex professore
gay e libertario e Lino Banfi interpreta il fratello trapiantato al
Nord a fare successo come imprenditore tutto dedito al lavoro
ma ormai inaridito nell’animo. Dopo quarant’anni si rivedono per
portare al paesello la salma della madre e potranno così riscoprirsi, superando le antiche incomprensioni.
Ma se in questa fiction il ritorno al Sud non più come destino di
sconfitta ma come recupero di un mondo positivo perduto nell’illusione di uno spazio “nordico” migliore è solo accennato, il tema diverrà esplicito l’anno dopo, con il film-tv L’inganno (Rai
Due, 2003): Nicole Grimaudo interpreta un’attrice di origini siciliane che ritrova nella sua terra i legami umani che il freddo
mondo della città e del lavoro senza sentimenti le aveva tolto.
L’inganno resta comunque un piccolo film-tv che ha conquistato
un’audience limitata, ma il concetto di fondo espresso nel cambio di atteggiamento del giudice Mastrangelo verso i suoi riscoperti compaesani troverà piena conferma nella miniserie di grande successo (oltre nove milioni di spettatori) L’uomo che sognava con le aquile (Rai Uno, 2006). Rocco (Terence Hill) è tornato
in Aspromonte, dopo anni trascorsi nel volontariato internazionale, per proseguire l’attività di produzione artigianale del formaggio, ereditata dai genitori. Si opporrà coraggiosamente all’imprenditore senza scrupoli (del Nord!) che intende fare speculazione edilizia nella zona, fino a quel momento incontaminata, e riuscirà a portare tutto il paese dalla sua parte. Per quanto discutibile per lo stile elementare con cui contrappone buoni e cattivi,
questa fiction ha tuttavia il merito di rappresentare per la prima
La famiglia
Il tema è in assoluto il più pervasivo nella fiction italiana. Si può
dire che gli esempi in cui non compaiono esplicitamente tematizzati dei rapporti familiari sono rarissimi, e solitamente riguardano format di importazione, come Camera Café (Italia 1, in onda
dal 2003) o i rari casi di fiction di avventura pura o fantasy. Dire
fiction, in Italia, vuol dire la rappresentazione di parenti e affini,
prima di tutto. Alcune fiction molto seguite hanno costruito il loro successo proprio attorno a questo prometeico oggetto sociale,
ad esempio le diverse serie di Un medico in famiglia (Rai Uno,
sei stagioni dal 1998 al 2008), e il recente successo de I
Cesaroni (Canale 5, 2006 e 2008), ma la famiglia, e i sentimenti
che la corredano, incrocia praticamente tutti i generi, divenendo
una sorta di flogisto della fiction nazionale. Che si tratti di poliziotti, medici, avvocati, psicologi, parrucchiere o di qualunque altra professione o ambiente sociale raffigurato, il legame fondamentale resta quello familiare.
Come ci si potrebbe aspettare, la rappresentazione della famiglia
nella fiction riflette i mutamenti che questa istituzione sta attraversando nella società, per cui un grande tema di riferimento a
partire dalla fine degli anni Ottanta è stata la “famiglia atipica”,
139
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
volta in modo chiaro un Sud che riesce a valorizzare la sua “tradizione” senza farla coincidere con il richiamo del sangue o la
spensieratezza dell’incoscienza. Un Sud che sembra quindi agganciarsi ai grandi filoni dell’impegno civico “europeo”, fatto di
rispetto per il territorio, salvaguardia delle tradizioni gastronomiche, valorizzazione del locale non in antitesi ma in complementarietà con una dimensione moralmente cosmopolita.
Questo passaggio abbastanza deciso verso un modello condiviso
di identità nazionale che sta attraversando la rappresentazione
del Sud per quanto riguarda la sua conformazione sociale pubblica sembra invece piuttosto tentennante quando si tratta di verificare la forma narrativa dell’istituzione sociale di gran lunga
più rappresentata nella fiction italiana, vale a dire la famiglia.
140
Identità catodiche
Piero Vereni
vale a dire tutte le forme di convivenza che non prevedano la soluzione canonica “padre, madre, figli”. Attenzione si è prestata al
ruolo dei genitori divorziati, ai vedovi e alle “famigliastre”, famiglie cioè composte da una coppia di cui almeno uno dei due
partner non è genitore naturale di uno dei figli che vivono sotto
il tetto comune. Il tema è stato trattato sotto l’angolazione leggera della commedia o la sensibilità drammatica che si deve a
un “tema sociale”, in diversi contesti socio-economici, con protagonismo ora maschile, ora femminile. Tra tutte le combinazioni
sociologiche possibili, l’unica che non trova una sua rappresentazione adeguata in termini quantitativi sembra quella meridionale:
la famiglia atipica è una prerogativa che nella fiction italiana resta confinata all’Italia centro-settentrionale. Questa assenza è
tanto più evidente (e tanto più significativa) se si misura l’entità
anche quantitativa di questa tematica nelle sceneggiature.
L’attenzione spesso è posta sulla nuova paternità, più responsabile e fatta anche di sensibilità affettiva oltre che di virile garanzia di sicurezza. Che siano divorziati o vedovi, questi nuovi padri
sensibili sono sempre dell’Italia centrale o settentrionale.
Vita coi figli (Canale 5, 1991) racconta le vicende di un padre rimasto vedovo che deve per la prima volta fare i conti con i cinque figli. Per non farsi mancare nulla in termini di nuove combinazioni parentali, alla fine il padre scoprirà addirittura che la giovane donna di cui si è innamorato è in realtà la compagna del figlio maggiore. Tutta la vicenda si svolge a Milano. A Roma è invece ambientato Un papà quasi perfetto, storia di un direttore di
supermercato (Michele Placido) vedovo e padre di sei figli.
Una variante di questo tipo è l’ex Peter Pan che riesce a riscoprire il legame coi figli, a lungo trascurati. Il già citato Giorni da
Leone (Rai Uno, 2002) e Giorni da Leone 2 (Rai Uno, 2007) si
sposta tra Roma e la Romagna per compiere questo percorso di
maturazione.
In Un milione di miliardi (Rai Uno, 1988) si ha uno dei primi
esempi di questo tipo di narrazione: Johnny Dorelli scoprirà
quanto è bello fare il padre e costruirà un rapporto profondo
con il figlio dopo anni di assenza. Da notare la connotazione
del protagonista: per quanto marcatamente settentrionale (e
141
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
anzi lombardo), nella lotta con l’ex moglie che cerca di tenerlo
lontano dal figlio – tedesca e quindi teutonicamente tetragona
nel resistere a qualunque debolezza sentimentale – incarna
l’immagine che dell’italiano spesso si ha nella raffigurazione all’estero: spensierato, sostanzialmente irresponsabile ma anche
generoso e sensibile. Una “simpatica canaglia” che vive alla
giornata. Sembra quindi che l’immagine del meridionale improvvisatore e solare che traspare nella contrapposizione con il
Nord del paese possa diventare epitome del carattere nazionale
quando la contrapposizione è con un Nord ancora più settentrionale, per così dire.
Sul taglio della commedia classica si presenta invece Pazza famiglia (Rai Uno, 1995) e Pazza famiglia 2 (Rai Uno, 1996), serie che
raccontano le vicende di un doppio divorziato romano (Enrico
Montesano) che ha avuto figli da entrambe le ex mogli e che ora
vive con l’ex suocero (Paolo Panelli).
La miniserie Ti ho adottato per simpatia (Rai Due, 1991) racconta in
tono leggero il riavvicinamento di un padre alla figlia giovane adulta, molti anni dopo il divorzio. La fiction non ha una connotazione
locale, mentre Padri (Rai Uno, 2002), che racconta di cinque uomini
alla riscoperta del loro ruolo paterno, è ambientata a Roma.
La nuova paternità è divenuta un luogo talmente comune della
fiction italiana da trovare spazio anche nel genere sitcom, solitamente poco frequentato per evidenti ragioni di carenze di sceneggiatura. Nella sitcom Il mammo (Canale 5, 2004 e 2005)
Marco Columbro gioca in leggerezza con questo nuovo ruolo sociale che, dato il protagonista, suona nitidamente nordico.
Spostandoci dai genitori ai figli, un altro macrotema è quello
delle adozioni. Ma tu mi vuoi bene? (Rai Uno, 1992), e Sì, ti voglio bene (Rai Uno, 1994) vedono Dorelli affrontare situazioni relazionali complesse. Nella prima il giudice del tribunale dei minori seguirà a Roma il caso di una piccola vietnamita, fino ad
adottarla, mentre nella seconda, spostatosi a Trieste, si innamora di una romana che a sua volta ha adottato un bambino,
unendo le due famiglie.
A volte i figli adottivi sono il pretesto per una ricongiunzione. In
Un Oscar per due (Rai Uno, 1998), ambientato nel Nord Italia,
142
Identità catodiche
Piero Vereni
una coppia in via di separazione ricuce la relazione quando ottiene l’affidamento di cui aveva fatto domanda anni prima. Non
mancano gli esempi settentrionali in cui il tema dell’adozione si
incrocia con quello mafioso: in A due passi dal cielo (Rai Uno
1999) una coppia torinese finisce per adottare un bimbo figlio di
un testimone di mafia, vittima di un attentato insieme a sua moglie. Il Sud è un bimbo da salvare, innocente non tanto perché
non abbia colpe, ma perché non ne ha coscienza. In Torniamo a
casa (Rai Due, 2000) una tribolata vicenda di adozione si svolge
tra la Romania e Pesaro, da cui proviene la coppia senza figli. Se
poi il protagonista di una complessa storia di adozione è Lino
Banfi, come in Raccontami una storia (Rai Uno, 2004), immediatamente le connotazioni meridionali dell’attore vengono attenuate, e la collocazione si fa genericamente “italiana”.
Se vi è una qualche associazione tra Sud e adozione, è perché il
Nord si offre di adottare i profughi del Sud mafioso (nell’appena
citato A due passi dal cielo), o perché la camorra ha organizzato
un giro di adozioni irregolari, come nella commedia sociale Giulia
e Marco - Inviati speciali (Rai Uno, 2001). Oppure ancora l’adozione ha luogo se la madre è morta per mano mafiosa (Una sola
debole voce 2, Rai Due, 2001) o se il bimbo viene da famiglia
mafiosa e quindi deve essere salvato (La luna e il lago, Rai Uno,
2006). Tra le molte combinazioni possibili, al Sud sembra difficile
trovare spazio per un’adozione “normale”.
Se la trama vira su tematiche sociali, uno dei temi affrontati
può essere quello dei figli contesi. In Due madri (Rai Uno,
1989) una bimba adottata da una coppia borghese di Roma
vedrà tornare la madre naturale, profuga politica argentina. Un
figlio a metà (Rai Due, 1992), miniserie che ebbe un ottimo
successo (oltre gli otto milioni di spettatori la media delle due
puntate) e ispirata a una storia vera di figli contesi, ha come
padre il romanissimo Gigi Proietti e come madre un’americana
(Kathy Connelly). Il successo portò a un sequel trasmesso nel
1994. In Storia di Chiara (Rai Due, 1995) Barbara De Rossi è
una psicologa romana che riesce ad ottenere l’affidamento della figlia che il suo defunto compagno aveva avuto dal precedente matrimonio.
143
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Oppure, sempre rimanendo a cavallo tra famiglia e fiction di taglio sociale, si affrontano le recenti questioni etiche e psicologiche legate alle nuove tecniche di fecondazione assistita. Due milanesi senza figli sono i protagonisti del film-tv Piange al mattino
il figlio del cuculo (Rai Tre, 1989). Convincono una giovane marocchina ad accettare un’inseminazione artificiale in cambio di
denaro, ma la donna porterà a termine la gravidanza con l’intenzione di tenersi il bambino. Ne Il padre di mia figlia (Rai Due,
1997) il protagonista, triestino, scopre che il seme che ha donato
dieci anni prima è stato utilizzato da una coppia romana. La madre ora è vedova e lui si avvicina alla donna e alla bimba, di cui
diverrà finalmente pater dopo essere stato genitor.
Famiglie atipiche sono anche quelle conseguenza dei nuovi single, magari con figli. In Papà prende moglie (Canale 5, 1993) un
vedovo con due figli adolescenti e una separata con due figli
piccoli uniscono le loro famiglie, il tutto a Roma. In Mamma per
caso (Rai Uno, 1997) Raffaella Carrà si trova a dover gestire i figli della sorella, intenta a salvare il suo matrimonio e la vicenda
si svolge ancora a Roma. In Prigioniere del cuore (Rai Uno,
2000) Elisabetta Gardini è una donna senza figli che per un po’
fa la vicemamma di una donna che ha perso la memoria: la storia si svolge a Pisa. Ma la famigliastra più famosa è ormai quella de I Cesaroni (Canale 5, 2007 e 2008), che unisce ancora una
volta la romanità più tipicamente colorita al clima culturale
dell’Italia del Nord.
Uno dei pochi casi di meridionale divorziato si ha in Piovuto dal
cielo (Rai Uno, 2000), una miniserie in cui Lino Banfi interpreta
un portiere meridionale di uno stabile torinese disposto ad allearsi con il nuovo marito della moglie pur di rintracciare la figlia
scomparsa con la madre. Si tratta in sostanza di una commedia
di buoni sentimenti, in cui la frattura iniziale verrà ricomposta alla fine, con tutta la famiglia nuovamente riunita.
La terra del ritorno (Canale 5, 2004) racconta di figli nati fuori
dal matrimonio in una famiglia meridionale, ma non si tratta certo di “nuova famiglia”, dato che l’epoca di ambientazione sono
gli anni che vanno dai Cinquanta ai Settanta, e si tratta quindi di
figli “illegittimi”.
144
Identità catodiche
Piero Vereni
Se non parliamo di madri e maternità nella fiction italiana la ragione è dovuta alla mole di dati disponibili, che richiederebbe
una trattazione a parte. Le donne sole con figli, nella fiction italiana, diversamente dai padri, più attivi al Nord, sono in grado di
portare a termine il loro compito educativo e di protezione a
qualunque latitudine, anche se, quando si tratta di amare i figli
oltre ogni ragionevolezza, ci vuole una madre meridionale. In
Madre come te (Rai Uno, 2004) Ida Di Benedetto è una cuoca siciliana trapiantata a Torino e deve dimostrare che suo figlio non
è un serial killer, nonostante tutto sembri provarne la colpevolezza. L’unico a crederle inizialmente è il commissario, di origini siciliane. Secondo Fabio Vassallo, “Rosaria rappresenta insomma la
legge dei sentimenti più viscerali opposta a quella dei giudici”
(Vassallo, 2005a, p. 347). Non credo sia un caso che questa parte debba essere di una “siciliana” (pur se incarnata da un’attrice
partenopea).
Come linea di tendenza, per quanto riguarda la famiglia non
sembra possibile rinvenire quel deciso mutamento di rappresentazione nella fiction che sta invece caratterizzando l’immagine
più genericamente pubblica della “società” meridionale.
Cercando di rappresentare i profondi mutamenti in corso di questa istituzione, le sceneggiature sembrano timorose di mettere
mano a una materia evidentemente sentita come difficile da gestire dal punto di vista narrativo.
Negli ultimi anni, questo scarto evidente tra immagine in movimento della famiglia italiana centrosettentrionale e staticità del
modello meridionale ha prodotto un paio di casi di riflessione,
che riguardano in particolare il ruolo dei padri meridionali nei
confronti delle scelte sessuali dei figli. In Mio figlio (Rai Uno,
2005) Lando Buzzanca, stereotipo riconosciuto dell’italico maschio di chiara impronta meridionale, interpreta un integerrimo e
tradizionalista commissario di polizia in servizio a Trieste che
scopre che il figlio (anch’egli nelle forze armate) è omosessuale,
e tutta la fiction ruota attorno al dramma di questo padre e allo
sforzo (riuscito) di comprendere il figlio nonostante tutto. L’anno
successivo il dilemma colpirà un altro campione nazionale dell’immaginario meridionale, e cioè Lino Banfi. Ne Il padre delle
Conclusioni: dalla fiction alla cronaca e ritorno
La fiction si avvale spesso della rappresentazione di eventi realmente accaduti, in una sorta di rielaborazione morale di cronache spesso criminali. Tra i primissimi esempi italiani, per l’arco
temporale interessato da questa analisi, si possono ricordare
Viaggio nel terrore - L’Achille Lauro (Rai Due, 1991) e, ambientata
in gran parte in Calabria, Liberate mio figlio (Rai Uno, 1992), filmtv che ricostruisce (pur senza citare i veri nomi dei protagonisti)
le vicende del rapimento di Cesare Casella, un diciottenne di
Pavia rimasto oltre due anni nella mani della ’ndrangheta e rilasciato il 30 gennaio 1990. La ricostruzione narrativa insiste sulla
“mamma coraggio” del rapito, che arriverà a incatenarsi nelle
piazze delle cittadine della Locride dove si suppone il figlio sia
tenuto prigioniero.
A questo filone finge di rifarsi anche Per odio o per amore
(Canale 5, 1992), film-tv che però stravolge completamente il caso di cronaca cui si ispirerebbe. Presentato nel ciclo “Film
Dossier”, il film racconta la vicenda di una giovane romagnola
145
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
spose (Rai Uno, 2006) Banfi è un uomo del Sud coltivatore di
olivi, che scopre che la figlia a Barcellona è sposata con una
donna. Ci vorrà qualche tempo, e qualche peripezia, ma alla fine
il sentimento paterno prevarrà sul pregiudizio omofobico.
Nonostante le evidenti buone intenzioni, l’accento posto sulle
origini meridionali dei due padri rischia paradossalmente di produrre l’effetto opposto a quello voluto, sottolineando la resistenza “meridionale” a forme alternative di sessualità.
Lo sforzo di inseguire la realtà sociale è comunque riconoscibile,
e fa parte di un chiaro movimento di tutta la fiction italiana, che
sempre più tende a spostarsi dagli stilemi della narrativa per acquisire non solo i temi, ma anche il passo discorsivo del racconto di cronaca. In questa rilettura della fiction come mezzo di
espressione collettiva di temi di cronaca l’immagine del
Meridione ne risulta particolarmente influenzata e modificata.
Vediamo infine come.
146
Identità catodiche
Piero Vereni
migrata in Sicilia per sposarsi con un uomo che lei non sa essere
coinvolto in crimini mafiosi. Rimasta vedova, con la cugina/amante del marito scoprirà l’assassino e le due donne si faranno giustizia da sé. La fiction dovrebbe ispirarsi alla cronaca di una giovane vedova siciliana che, divenuta l’amante dell’assassino del
marito, lo aveva poi denunciato alla magistratura, ed è stata trasmessa, con scarsa coerenza, all’interno di un dibattito su “donne del Sud che si ribellano alla mafia”. Dalla scelta della protagonista (la prosperosa Serena Grandi) al tripudio di carretti siciliani e scoppole, se ne deduce un uso evidentemente “folkloristico” del repertorio e del simbolismo siculo-mafioso, il cui scopo è
produrre quell’immagine di “fascino dell’altro” di cui abbiamo
discusso più sopra.
Molto più aderente alla realtà dei fatti, purtroppo, è invece la ricostruzione di Non parlo più (Rai Due, 1995), basata sulla vera
storia di Rita Atria, che abbiamo già incontrato come esempio
del fallimento del Sud disposto a cercare salvezza al Nord.
Sempre al filone basato sulla cronaca appartiene Il dono di
Nicholas (Canale 5, 1998), ricostruzione della vicenda del piccolo
Nicholas Green, vittima nel 1994 di un agguato lungo la SalernoReggio Calabria e poi donatore di organi grazie ai genitori.
Un punto di svolta nella produzione di questo tipo di fiction si è
avuto probabilmente nel 2001, con la messa in onda di Uno
bianca (Canale 5, 2001), la fiction di Taodue che ricostruisce una
delle pagine più efferate della cronaca criminale degli anni
Novanta e che ha lanciato poi ulteriori produzioni dedicate a fatti
criminosi o di attualità come Il sequestro Soffiantini (Canale 5,
2002), Soldati di pace (Rai Uno, 2003) sulla missione italiana in
Kosovo, Ultima pallottola (Canale 5, 2003) sugli omicidi di donne
compiuti tra Liguria e basso Piemonte dal serial killer Donato
Bilancia nel 1997 e 1998, Vite a perdere (Rai Due, 2004) sulla
banda della Magliana, Attacco allo Stato (Canale 5, 2006) che ricostruisce il terrorismo politico dopo l’omicidio D’Antona, Caccia
Segreta (Rai Uno, 2007) sulla morte di Andrea Calipari a Kabul,
Nassiriya - Per non dimenticare (Canale 5, 2007).
Questo nuovo modello italiano di aderenza alla realtà della cronaca (che sostanzialmente tra forza morale dell’esempio e verosi-
147
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
miglianza punta decisamente su quest’ultima) presto si incrocia
(anche per via del comune produttore originario, vale a dire la
Taodue di Pietro Valsecchi) con una nuova modalità narrativa del
racconto di mafia, che già dalla fine degli anni Novanta stava facendosi spazio con nuovi personaggi post-Cattani che ambivano
a un taglio più realista. Dalla cronaca proviene infatti anche un
personaggio che ha influenzato in modo significativo il corso della produzione di fiction dedicata alla mafia dell’ultimo decennio.
Si tratta del tenente colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio,
noto come Capitano Ultimo, l’ufficiale responsabile dell’arresto di
Salvatore Riina il 15 gennaio 1993. La sua vicenda è stata trasposta in una miniserie di grande successo, Ultimo (Canale 5, 1998),
prodotta appunto dalla Taodue, casa di produzione che da quel
momento è diventata la leader indiscussa di un nuovo modo di
rappresentare le vicende criminali, assieme più aderente alla
realtà e più incline a recuperare per i personaggi l’alone di eroismo dei protagonisti de La piovra. Rispetto a quelli, però, i prodotti Taodue segnano spesso storie di riscatto vincente dello
Stato. Il grande successo di Ultimo ha dato vita a due sequel
(Ultimo - La sfida, Canale 5, 1999; Ultimo 3 - L’infiltrato, Canale
5, 2004) che marcano ulteriormente la volontà di riscatto del
Bene sul Male e, soprattutto, la nuova convinzione che la vittoria
finale, per quanto costosa, sia possibile. In generale, mentre La
piovra è sostanzialmente un “melodramma sociale” (Vassallo
2005b, p. 251), Ultimo (e molta della fiction prodotta da Taodue)
regge con più saldezza i canoni del poliziesco. Ha quindi meno
bisogno di caricarsi esplicitamente di connotazioni simboliche
per attrarre gli spettatori, e può limitarsi a rappresentare lo scontro “reale” tra individui “reali”. Riportare quindi il Male entro i
confini della sua “banalità” è un’importante operazione ideologica, demandata a intaccarne lo spessore simbolico.
Applicata al contesto del crimine organizzato nel Sud dell’Italia,
l’operazione “realista” della nuova fiction di cronaca ha dato vita a numerosi prodotti di largo seguito e buona qualità media.
L’attentatuni - Il grande attentato (Rai Due, 2001), parte dalla
strage di Capaci, ma racconta come una tenace squadra di poliziotti, carabinieri e finanzieri riesca a individuare i colpevoli as-
148
Identità catodiche
Piero Vereni
sicurandoli alla giustizia. Evidente l’influsso del “modello
Ultimo” in questo tipo di ricostruzione. Più classicamente legato
alla ricostruzione biografica dell’eroe solitario è Brancaccio (Rai
Uno, 2001), che racconta la vita e la morte di don Pino Puglisi,
prete coraggio che nel quartiere di Brancaccio si oppone alla
cultura mafiosa fino alla morte. Con il passare degli anni, si fa
più evidente la competizione tra le due grandi reti generaliste
per impegnare questo settore narrativo, con una serie di titoli in
rapida crescita: Paolo Borsellino (Canale 5, 2004), Giovanni
Falcone, l’uomo che sfidò Cosa Nostra (Rai Uno, 2006), Il
Generale Dalla Chiesa (Rai Uno, 2007) L’ultimo dei Corleonesi
(Rai Uno, 2007), Il capo dei capi (Canale 5, 2007), L’ultimo padrino (Canale 5, 2008).
L’influsso di questa impostazione, che come formato nasce con
la miniserie in due puntate, arriva a colpire anche la lunga serialità, come si può notare ne La nuova squadra (Rai Tre, 2008),
che accentua la già evidente vocazione realista del serial poliziesco di ambientazione napoletana puntando su caratteri estremamente duri anche tra i poliziotti e offrendo una rappresentazione
spesso cruda anche in termini visivi delle vicende che tratta.
Questo impegno “realista” della fiction dedicata alla cronaca criminale rischia, purtroppo, di ottenere l’effetto contrario, investendo proprio i maggiori criminali mafiosi di quell’aura di “eroica normalità” che nelle intenzioni iniziali era appannaggio riservato dei “buoni”. Questo in effetti è quel che è successo tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, con la messa in onda di due fiction dedicate a importanti figure di boss mafiosi. Ne Il capo dei
capi (Canale 5, 2007) si racconta con dovizia di dettaglio la vita
di Salvatore Riina, interpretato da Claudio Gioè. La fiction ha sollevato un intenso dibattito proprio sulla legittimità narrativa dell’oggetto, che descritto minuziosamente nelle sue determinanti
sociali e nella sua intima storia personale rischia di diventare
quasi un role model. In L’ultimo padrino (Canale 5, 2008) l’ennesimo Michele Placido incarna un Bernardo Provenzano sicuramente affascinante nell’intreccio di meticolosità maniacale e
flemma apparentemente inossidabile. Così l’attore descrive il suo
personaggio nel video promozionale:
Il regista Marco Risi, nel medesimo video, riconosce il rischio
dell’operazione, ma insiste su una lettura realista e, sostanzialmente, demitizzante:
Naturalmente il rischio in queste situazioni è che ci si possa affezionare, diciamo così, al personaggio negativo. Però vederlo in una
chiave non soltanto negativa è la cosa che mi interessa di più:
quanto il male sia contaminato dal bene.
Riportando i dati d’ascolto per L’ultimo padrino, Aldo Grasso
(2008) ha notato che anche in questo caso, come era già avvenuto nell’ottobre del 2007 per Il capo dei capi, gli spettatori più
fedeli di questa fiction sono stati i giovani, ultimamente tra le fasce d’utenza meno disposte a sedersi di fronte al televisore:
“Nella fascia di pubblico compresa fra i 15 e 24 anni, la fiction
con Michele Placido balza improvvisamente in testa alla classifica
degli ascolti della settimana, con uno share che tocca il 34%”.
Particolare impressione suscita il fatto che gli ascolti maggiori
vengano registrati al Sud, non al Nord “con una differenza di oltre trenta punti di share tra la Sicilia e la Calabria (46% di share)
e la Lombardia (15%)”.
Come sempre quando si tratta di capire le ragioni delle audience, la domanda rimane aperta: il grande seguito di questo tipo
di fiction dipende dal fatto che l’argomento è sentito come socialmente rilevante (un problema) oppure individualmente affascinante?
Con i dati disponibili, non è certo possibile rispondere a un domanda che richiederebbe di spostare decisamente l’attenzione
dal piano della produzione di immaginario a quello del consumo,
ma possiamo tuttavia indicare la strada che dovrebbe percorrere
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
149
C’è qualcosa di misterioso nella natura di certi uomini. Ci sono certi
uomini che hanno un carisma tale che loro riescono a trasmettere fiducia in tutto ciò che fanno. Lo sappiamo bene che è un mafioso, un
criminale. Ma è qualcosa di più sicuramente. È uno che aveva il rispetto di tante... centinaia e centinaia, se non migliaia di persone...
E allora è piuttosto capire vedendo il film, io per primo, capire che
cos’era tutto quello che succedeva intorno a lui.
Piero Vereni
Identità catodiche
150
la ricerca futura su questo tema. Si tratta di ricostruire i sentieri
che dalla fiction portano alle pratiche della vita quotidiana, verificando quindi quanto della cronaca passi nella fiction, ma anche
se e quanto della fiction passi negli usi e nelle pratiche quotidiane. Per il mondo criminale ha iniziato a fare questo lavoro
Roberto Saviano. Nel capitolo Hollywood di Gomorra racconta
come negli ambienti della camorra sempre più “Non è il cinema
a scrutare il mondo criminale per raccoglierne i comportamenti
più interessanti. Accade esattamente il contrario” (Saviano 2006,
pp. 272-273). Grazie ai numerosi esempi riportati in questo libro
– che ha a sua volta segnato profondamente l’immagine che il
Sud dà e ha di se stesso –, dobbiamo prendere atto di un fenomeno non meno vero perché terribilmente grottesco:
Come i giovani spartani andavano in guerra con in mente le gesta di
Achille ed Ettore, in queste terre si va ad ammazzare e farsi ammazzare con in mente Scarface, Quei bravi ragazzi, Donnie Brasco, Il
Padrino (p. 279).
Questo tipo di immaginario, reso disponibile dal cinema e oggi
anche dalla televisione, non riguarda solo i protagonisti in negativo delle gesta criminali. Anche i comuni cittadini possono filtrare la realtà cui partecipano con gli strumenti dell’immaginario
messi in circolazione dai “mediorami”, i flussi delle immagini che
circolano attraverso i mezzi di comunicazione di massa:
Ogni volta che torno a Corigliano Calabro non posso fare a meno di
pensare al porto e alle pescherie che sono punti di approdo e di distribuzione della droga in tutta la zona della Sibaritide; ai lidi e ai locali notturni, in gran parte proprietà dei mafiosi locali, che gremiscono il lungomare della costa; al ricordo dei frammenti della vetrina
sfondata dal rimbalzo del corpo colpito dalle pallottole d’una pistola,
al centro dello scalo; alla visione di una Lancia Y crivellata dai colpi
delle mitragliatrici sulla SS 106. Ogni volta che intraprendo la strada
di casa mia riaffiorano nei pensieri le immagini di un paese combattuto e stravolto dalla sottomissione alle cosche mafiose (…) a volte
pare di rivivere alcune scene da film stile Damiano Damiani, in cui le
comparse impersonano le folle spaventate e quasi fiancheggiatrici
1
Già nel titolo, l’obiettivo della critica è soprattutto il pessimismo di Popper (1994).
2
Sullo sviluppo dell’industria della fiction italiana si vedano Buonanno 2007 e
Lucherini 2007.
3
Colgo l’occasione per ringraziare, oltre al direttore dell’OFI, anche Fabrizio
Lucherini, vicedirettore, e Tiziana Russo, segretario generale, per la loro disponibilità a rendere più completo questo capitolo, le cui manchevolezze sono mia esclusiva responsabilità.
4
Intervista a Graziella Giacometti, sceneggiatrice professionista, registrata a Roma il
24 novembre 2007.
5
Il rimando non riporta il numero di pagina perché la citazione è tratta dalla scheda reperibile ad vocem nell’Archivio elettronico in CD allegato al volume.
6
Sulle sorti di questa fiction si veda Buonanno 1996.
7
La distinzione tra solidarietà meccanica e organica si deve originariamente a
Durkheim (1893).
8
Onde evitare malintesi interpretativi, riportiamo la definizione data originariamente
dall’autore: “L’ipotesi è che i montegranesi agiscono come se seguissero questa regola generale: ‘massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare;
supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo’” (Banfield 1958, p. 105).
Senza bisogno di condividere l’impianto teorico che sostiene la sua ipotesi, si può
accettare la definizione come tipologia comportamentale: in questo senso, possiamo
dire che molta della fiction di cui stiamo parlando è improntata al “familismo amorale”, dato che i protagonisti tendono a comportarsi in modo da massimizzare i benefici per la loro famiglia nucleare, per la quale spesso si battono aspramente.
9
Http://www.raifiction.rai.it/raifiction2006fiction/0,11357,2023,00.html [ultimo accesso 31 marzo 2008].
A Sud della fiction. L’immagine del Meridione italiano nella narrativa televisiva (1988-2007)
Tutto questo, come dire, salta all’occhio, si impone con la forza
della sua pressione violenta sul visibile. Resta invece ancora da
svolgere un lavoro più sottile, perché fatto di una materia prima
forse meno appariscente, un lavoro che documenti come altre
immagini del Meridione, rese disponibili anche dalla fiction domestica, circolino nelle pratiche quotidiane per divenire parte
dell’autorappresentazione e del sistema di categorizzazione degli spettatori.
151
dei sicari che corrono in sella alla moto dopo aver appena ucciso il
disgraziato della situazione17.
10 Nello sviluppo delle sceneggiature, la serialità lunga italiana non ha quasi mai
perseguito il modello detto “a eroe ricorrente”, in cui cioè la trama “ricomincia da
zero” a ogni nuovo episodio, consentendo quindi una riproducibilità tendenzialmente infinita, e ha invece costruito le sue fortune incrociando una trama di puntata
(detta anche linea verticale) che si conclude autonomamente con una trama di serie
(detta appunto linea orizzontale) che invece si sviluppa da una puntata all’altra,
giungendo a sciogliersi solo alla fine della stagione di trasmissione. Sugli aspetti
tecnici e le conseguenze produttive di questo modello cfr. le “analisi della stagione”
elaborate da Fabrizio Lucherini per le diverse annate de La fiction italiana, l’Italia
nella fiction, dove il problema delle forme della serialità e dei suoi mutamenti è tenuto sempre sotto stretta osservazione.
Piero Vereni
Identità catodiche
152
11 Quasi inutile ricordare che l’enorme successo, nel 1972, dell’adattamento cinematografico del suo romanzo Il padrino (Puzo 1969) lanciò due romanzi-sequel (a loro
volta prontamente tradotti in pellicola) e una fila sterminata di epigoni tuttora vitali.
12 “(...) oggi gli spettatori si limitano semplicemente a far aderire la loro disposizione per la nostalgia ad un’immagine che fornirà il ricordo di una perdita che essi non hanno mai subito. Possiamo chiamare questa relazione ‘nostalgia da tavolino’, nostalgia senza esperienza vissuta o memoria collettiva storica” (Appadurai
1996, p. 108).
13 Sulla storia della Lega Nord e la coincidenza della sua nascita con la crisi politica
nazionale si veda Biorcio 1999.
14 Sul personaggio letterario, soprattutto dopo il successo delle trasposizioni televisive, si è prodotta una discreta bibliografia. Segnaliamo come particolarmente accurati i lavori di Pistelli (2003) e Marrone (2003).
15
Http://www.fiction.mediaset.it/fiction/mastrangelo/index.htm.
16
Sulla natura di questa opposizione e sul suo senso attuale vale la pena di leggere Geertz 1999, pp. 56.
17
Testimonianza di Giuseppe Tobia Flora, un giovane di Corigliano, raccolta dall’autore ad Arcavacata di Rende (Cs), il 9 febbraio 2008.
Bibliografia
Bibliografia
Abu-Lughod, L., 1986, Veiled Sentiments. Honor and Poetry in a Bedouin
Society, Berkeley (Ca.), University of California Press; trad. it. 2007,
Sentimenti velati. Oralità e poesia in una società beduina, a cura di
Vanessa Maher, Torino, Le Nuove Muse.
Abu-Lughod, L., 1989, Bedouins, Cassettes and Technologies of Public Culture,
«Middle East Report», 159, 4, pp. 7-11.
Abu-Lughod, L., 1997, The Interpretation of Culture(s) after Television,
«Representations», 59, Special Issue: The Fate of “Culture”: Geertz and
Beyond (Summer), pp. 109-134.
Abu-Lughod, L., 2005, Dramas of Nationhood: The Politics of Television in
Egypt, Chicago, University of Chicago Press.
Altin, R., 2004a, “Comunità di diaspora ghanese. Visuale e visioni ”, in Balma
Tivola, a cura, 2004, pp. 119-138.
Altin, R., 2004b, L’identità mediata. Etnografia delle comunicazioni di diaspora: i ghanesi del Friuli Venezia Giulia, Udine, Forum Editrice Universitaria
Udinese.
Altin, R., Parmeggiani, P., 2007, “Incroci di sguardi. Analizzare la ricezione dell’immagine con diversi approcci metodologici”, in R. Altin, P. Parmeggiani,
a cura, Nuove frontiere della rappresentazione digitale, Milano, Lampi di
stampa, pp. 83-110.
Amselle, J.-L., 1990, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique
et ailleurs, Paris, Payot; trad. it. parziale 1999, Logiche meticce.
Antropologia dell’identità in Africa e altrove, Torino, Bollati Boringhieri.
Anderson, B., 19912, Imagined Communities. Reflections on the Origins of
Nationalism. Revised and Extended Edition, London, Verso; trad. it. 1996,
Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi, Roma, manifestolibri.
Ang, I., 1985, Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination,
London, Methuen.
153
Nel testo, l’anno che accompagna i rinvii bibliografici secondo il sistema autore-data è sempre quello dell’edizione in lingua originale, mentre i rimandi ai numeri di
pagina si riferiscono sempre alla traduzione italiana, qualora negli estremi bibliografici qui sotto riportati vi si faccia esplicito riferimento.
154
Identità catodiche
Piero Vereni
Ang, I., 1991, Desperately Seeking the Audience, London, Routledge.
Ang, I., 1996, Living Room Wars: Rethinking Media Audiences for a
Postmodern World, London, Routledge.
Apolito, P., 2002, Internet e la Madonna: sul visionarismo religioso in Rete,
Milano, Feltrinelli.
Appadurai, A., 1991, “Global Ethnoscapes. Notes and Queries for a
Transnational Anthropology”, in Fox, a cura, 1991, pp. 191-210; trad. it.
1996, “Etnorami globali: appunti e questioni per un’antropologia transnazionale”, in Appadurai 1996, pp. 71-92.
Appadurai, A., 1996, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization,
Minneapolis (Minn.), University of Minnesota Press; trad. it. 2001, Modernità
in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, Roma, Meltemi.
Askew, K. M., 2002, “Introduction”, in Askew, Wilk, a cura, 2002, pp. 1-13.
Askew, K. M., Wilk, R. R., a cura, 2002, The Anthropology of Media. A Reader,
Malden (Mass.) - Oxford (U.K.) - Carlton (Vic., Australia), Blackwell.
Bailey, O. G., Georgiou, M., Harindranath, R., a cura, 2007, Transnational Lives
and the Media. Re-Imagining Diasporas, Houndmills-Basingstoke
(Hampshire), Palgrave Macmillan.
Balma Tivola, C., 2004, “Introduzione. Rappresentazioni ‘altre’, sguardi reciproci, mediazioni culturali ”, in Balma Tivola, a cura, 2004, pp. 9-22.
Balma Tivola, C., a cura, 2004, Visioni del mondo. Rappresentazioni dell’altro,
autodocumentazione di minoranze, produzioni collaborative, Bagnaria
Arsa (UD), Edizioni goliardiche.
Banaji, S., 2006, Reading “Bollywood”: The Young Audience and Hindi Films,
Houndmills-Basingstoke (Hampshire), Palgrave Macmillan.
Banfield, E. C., 1958, The Moral Basis of a Backward Society, Glencoe, Free
Press; trad. it. 1976, Le basi morali di una società arretrata, Bologna, il
Mulino.
Basso, G., 1981, Il coraggio di parlare: un ragazzo, la mafia, l’omertà. Un
romanzo tratto dalla cronaca drammatica dei nostri giorni, Milano,
Fabbri.
Bausinger, H., 1961, Volkskultur in der technischen Welt, Frankfurt am Main;
trad. it. 2005, Cultura popolare e mondo tecnologico, a cura di Luca
Renzi, Napoli, Guida.
Bechelloni, G., 2004, “Il programma dell’anno. Un posto tranquillo. Un ‘simpatico’ eroe italiano”, in Buonanno, a cura, 2004, pp. 89-99.
Bendix, R., 1997, In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies,
Madison, University of Wisconsin Press.
Bindi, L., 2005, Bandiere antenne campanili. Comunità immaginate nello specchio dei media, Roma, Meltemi.
Biorcio, R., 1999, La Lega Nord e la transizione italiana, «Rivista italiana di
scienza politica», 29, 1, pp. 55-88.
155
Bibliografia
Boni, F., 2004, Etnografia dei media, Roma, Editori Laterza.
Bottelli, S., 2005, 10 corso Como, Milano. Luogo come discorso e media,
«Achab. Rivista di antropologia», 6, pp. 38-41.
Bourdieu, P., 1979, La distinction, Paris, Les éditions de Minuit; trad. it.
1983, La distinzione. Critica sociale del gusto, Bologna, il Mulino.
Buonanno, M., 1996, La Piovra. La carriera politica di una fiction popolare,
Genova, Costa & Nolan.
Buonanno, M., 2007, “Un decennio di successi. La Golden age della fiction
italiana”, in Buonanno, a cura, 2007, pp. 73-98.
Buonanno, M., a cura, 2004, Il ritorno del già noto. La fiction italiana, l’Italia
nella fiction. Anno quindicesimo, Roma, Rai-Eri.
Buonanno, M., a cura, 2005, Lontano nel tempo. La fiction italiana, l’Italia
nella fiction. Anno sedicesimo, Roma, Rai-Eri.
Buonanno, M., a cura, 2007, La bella stagione. La fiction in Italia, l’Italia nella fiction. Anno diciottesimo, Roma, Rai-Eri.
Canevacci Ribeiro, M., 1995, Antropologia della comunicazione visuale. Per
un feticismo metodologico, Genova, Costa & Nolan.
Canevacci Ribeiro, M., 1999, “Il feticcio e il visuale”, in P. Faccioli, D. Harper,
a cura, Mondi da vedere. Verso una sociologia più visuale, Milano,
Franco Angeli, pp. 340-356.
Canevacci Ribeiro, M., 2007, La linea di polvere. I miei tropici tra mutamento e autorappresentazione, Roma, Meltemi.
Casati Modignani, S., 1988, Donna d’onore, Milano, Sperling & Kupfer.
Chadha, K., Kavoori, A., 2000, Media imperialism revisited: some findings
from the Asian case, «Media, Culture & Society», 22, 4, pp. 415-426.
Chiozzi, P., 1993, Manuale di antropologia visuale, Milano, Unicopli.
Cipriano, P., 2005, Il Ramadan in tv. Analisi di un rito televisivo in contesto
d’emigrazione, «Meridiana», 52, pp. 41-64.
Clemente, P., 2005, “Oltre l’orizzonte”, in H. Bausinger, Cultura popolare e
mondo tecnologico, a cura di Luca Renzi, Napoli, Guida, pp. 235-270.
Clifford, J., 1988, The Predicament of Culture. Twentieth-Century
Ethnography, Literature, and Art, Cambridge, Harvard University Press;
trad. it. 1993, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel
XX secolo, Torino, Bollati Boringhieri.
Clifford, J., 1997, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth
Century, Cambridge, Harvard University Press; trad. it. 1999, Strade.
Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri.
Clifford, J., Marcus, G. E., a cura, 1986, Writing Culture. The Poetics and
Politics of Ethnography: A School of American Research Advanced
Seminar, Berkeley, University of California Press; trad. it. 20013, Scrivere
le culture. Poetiche e politiche in etnografia, Roma, Meltemi.
Conti, L., 1978, Una lepre con la faccia da bambina, Roma, Editori Riuniti.
156
Identità catodiche
Piero Vereni
Curran, J., Gurevitch, M., Woolacott, J., a cura, 1977, Mass Communication and
Society, London, Edward Arnold.
Curran, J., Park, M.-J., a cura, 2000, De-Westernizing Media Studies, London,
Routledge.
Dayan, D., 1992, Media Events. The Live Broadcasting of History, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press.
Dei, F., 2002, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma,
Meltemi.
de Sanctis Ricciardone, P., 2007, “Festa: mercato e usi dell’autenticità”, in
Ultracorpi. Figure di cultura materiale e antropologia, Napoli, Liguori, pp.
132-155.
Devereaux, L., Hillman, R., a cura, 1995, Fields of Vision. Essays in Film
Studies, Visual Anthropology and Photography, Berkeley, University of
California Press.
Dick Zatta, J., 1996, “Tradizione orale e contesto sociale: i Roma sloveni e la
televisione”, in L. Piasere, a cura, Italia Romanì. Volume primo, Roma,
Cisu, pp. 179-203.
Duranti, A., Goodwin, C., a cura, 1992, Rethinking Context. Language as an
Interactive Phenomenon, Cambridge, Cambridge University Press.
Durkheim, É., 1893, De la Division du travail social, thèse présentée à la
Faculté des lettres de Paris, par Émile Durkheim, Paris, F. Alcan; trad. it.
1977, La divisione del lavoro sociale, Milano, Edizioni di Comunità.
Edwards, E., 1992, Anthropology and Photography, 1860-1920, New Haven,
Yale University Press - London, Royal Anthropological Institute.
Evans, W. A., 1990, The Interpretive Turn in Media Research: Innovation, Iteration,
or Illusion?, «Critical Studies in Mass Communication», 7, 2, pp. 147-168.
Fabian, J., 1983, Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object,
New York, Columbia University Press; trad. it. 2000, Il tempo e gli altri. La
politica del tempo in antropologia, Napoli, L’ancora del Mediterraneo.
Fabietti, U., 2008, L’antropologia e il paradigma della modernità, intervento
presentato al Primo convegno nazionale dell’ANUAC, Matera, 29 maggio.
Faeta, F., 2003, Strategie dell’occhio. Saggi di etnografia visiva, nuova edizione rivista e ampliata, Milano, Franco Angeli.
Fagioli, M., Zambotti, S., 2005, Etnografia e media, «Achab. Rivista di antropologia», 6, pp. 14-16.
Fagioli, M., Zambotti, S., a cura, 2005, Antropologia e media. Tecnologie, etnografie e critica culturale, Como-Pavia, Ibis.
Fejes, F., 1981, Media imperialism: an assessment, «Media, Culture & Society»,
3, 3, pp. 281-289.
Fox, R. G., a cura, 1991, Recapturing Anthropology: Working in the Present.
School of American research advanced seminar series, Santa Fe, School
of American Research Press.
157
Bibliografia
Fruttero, C., Lucentini, F., 1979, A che punto è la notte, Milano, Mondadori.
Gallini, C., 1995, “I film e la fiction: Aladino non abita più qui. L’Oriente tra
vecchie stereotipie e nuovi presunti realismi ”, in Marletti, a cura, 1995, pp.
163-220.
Gallini, C., 2004, Cyberspiders. Un’etnologa della rete, Roma, manifestolibri.
Geertz, C., 1999, “Che cos’è un paese, se non è una nazione? ”, in Mondo globale, mondi locali, Bologna, il Mulino, pp. 33-56.
Gerbner, G., 1988, Violence and Terror in the Mass Media, Reports and papers
on mass communication, Paris, Unesco.
Gerbner, G., Gross, L., 1976, Living With Television: The Violence Profile, «The
Journal of Communication», 26, 2, pp. 172-194.
Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., Signorielli, N., 1984, Political Correlates of
Television Viewing, «Public Opinion Quarterly», 48, 1, pp. 283-300.
Gianoncelli, T., 2005, Ma cosa ascolti in un non-luogo? Un esperimento di etnografia in un paesaggio sonoro caratterizzato dai media, «Achab. Rivista di
antropologia», 6, pp. 30-37.
Ginsburg, F. D., 1991, Indigenous Media: Faustian Contract or Global Village?,
«Cultural Anthropology», 6, 1, pp. 92-112.
Ginsburg, F. D., 1995, “Mediating Culture: Indigenous Media, Ethnographic Film,
and the Production of Identity”, in Devereaux, Hillman, a cura, 1995, pp.
256-290; nuova ed. 2002, in Askew, Wilk, a cura, 2002, pp. 210-235.
Ginsburg, F. D., 2002, “Screen Memories. Resignifying the Traditional in
Indigenous Media”, in Ginsburg, Abu-Lughod, Larkin, a cura, 2002, pp. 39-57.
Ginsburg, F. D., Abu-Lughod, L., Larkin, B., 2002, “Introduction”, in Ginsburg,
Abu-Lughod, Larkin, a cura, 2002, pp. 1-36.
Ginsburg, F. D., Abu-Lughod, L., Larkin, B., a cura, 2002, Media Worlds.
Anthropology on New Terrain, Berkeley, University of California Press.
Giuffré, M., 2007, Donne di Capo Verde. Esperienze di antropologia dialogica a
Ponta do Sol, Roma, Cisu.
Grady, J., 1996, The Scope of Visual Sociology, «Visual Sociology», 11, 2, pp.
10-24.
Grasso, A., 2007, Buona maestra. Perché i telefilm sono diventati più importanti del cinema e dei libri, Milano, Mondadori.
Grasso, A., 2008, La mafia in tv affascina i giovani, «Corriere della Sera», 21
gennaio, p. 53.
Guigoni, A., 2001, Internet per l’antropologia. Risorse e strumenti per la ricerca
etnografica nel cyberspazio, Genova, Name.
Guigoni, A., 2002, Comportamenti e relazioni tra i membri di comunità virtuali:
il caso delle scienze sociali, «Memoria e ricerca», 10, pp. 135-142.
Guigoni, A., 2003, I bookcrossers. Una comunità (virtuale) di donatori, «Rivista
elettronica di scienze umane e sociali», 1, 3, http://www.analisiqualitativa.com/magma/0103/articolo_05.htm.
158
Identità catodiche
Piero Vereni
Guigoni, A., 2004, “Il cibo e la Rete, un catalogo ragionato delle risorse”, in
Foodscapes. Stili, mode e culture del cibo oggi, Monza, Polimetrica, pp.
73-80.
Guigoni, A., Amaducci, G., 2002, Internet per umanisti, Milano, Alpha Test.
Gupta, A., Ferguson, J., a cura, 1997, Culture, Power, Place. Explorations in
Critical Anthropology, Durham, Duke University Press.
Hadley Chase, J., 1973, Have a Change of scene, London, Hale; trad. it. 1975,
Cambia aria Larry Carr!, Milano, Mondadori.
Hall, S., 1977, “Culture, the Media and the ‘Ideological Effect’”, in Curran,
Gurevitch, Woolacott, a cura, 1977, pp. 315-348.
Hall, S., 1980, “Encoding/Decoding”, in Hall, Hobson, Lowe, Willis, a cura,
1980, pp. 11-23; trad. it. 2006, “Codifica e decodifica nel discorso televisivo”, in S. Hall, Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli
studi culturali e postcoloniali, a cura di Miguel Mellino, Roma, Meltemi,
pp. 33-50.
Hall, S., Hobson, D., Lowe, A., Willis, P., a cura, 1980, Culture, Media,
Language. Working Papers in Cultural Studies, 1972-79, London,
Hutchinson.
Hannerz, U., 1992, Cultural Complexity. Studies in the Social Organization
of Meaning, New York, Columbia University Press; trad. it. 1998, La
complessità culturale. L’organizzazione sociale del significato, Bologna,
il Mulino.
Hannerz, U., 1996, Transnational Connections. Culture, People, Places,
London-New York, Routledge; trad. it. parziale 2001, La diversità culturale,
Bologna, il Mulino.
Harper, D., 1988, Visual Sociology. Expanding Sociological Vision, «The
American Sociologist», Spring, pp. 54-70; trad. it. 1993, Orizzonti sociologici. Saggio di sociologia visuale, «Sociologia della Comunicazione», X,
19, pp. 15-31.
Herzfeld, M., 1997a, Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State, New
York, Routledge.
Herzfeld, M., 1997b, “The practice of stereotypes”, in Herzfeld 1997a, pp. 156164.
Horkheimer, M., Adorno, T. W., 1947, Dialektik der Aufklarung: philosophische
Fragmente, Amsterdam, Querido; trad. it. 1966, Dialettica dell’Illuminismo,
Torino, Einaudi.
Human Rights Watch, 1997, “Albania”, in Human Rights Watch. World Report,
testo reperibile online all’indirizzo: http://www.hrw.org/1997/WR97.
Hume, L., Mulcock, J., 2004, Anthropologists in the Field: Cases in Participant
Observation, New York, Columbia University Press.
Innis, H. A., 1950, Empire and Communications, Oxford, Clarendon Press; trad.
it. 2001, Impero e comunicazioni, Roma, Meltemi.
159
Bibliografia
Jameson, F., 1991, Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism,
Durham, Duke University Press; trad. it. 2007, Postmodernismo, ovvero la
logica culturale del tardo capitalismo, Roma, Fazi.
Jarvis, C., 2000, The Rise and Fall of the Pyramid Schemes in Albania, «IMF
Staff Papers», 47, 1, pp. 1-29.
Jenkins, R., 1997, Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations, London,
Sage.
Johnson, V. E., 2008, Heartland TV. Prime Time Television and the Struggle for
U.S. Identity, New York, New York University Press.
Kirshenblatt-Gimblett, B., Bruner, E. M., 1992, “Tourism”, in R. Bauman, a cura, Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments, Oxford,
Oxford University Press.
Labranca, T., 1994, Andy Warhol era un coatto. Vivere e capire il trash, Roma,
Castelvecchi.
La Cecla, F., 2006, Surrogati di presenza. Media e vita quotidiana, Milano,
Bruno Mondadori.
Lai, F., 2006, “Globalizzazione e flussi culturali ”, in La creatività sociale,
Roma, Carocci, pp. 53-96.
Larkin, B., 2008, Signal and Noise. Media, Infrastructure, and Urban Culture in
Nigeria, Durham (N.C.), Duke University Press.
Liebes, T., Curran, J., a cura, 1998, Media, Ritual, and Identity, London,
Routledge.
Liebes, T., Katz, E., 1990, The Export of Meaning. Cross-Cultural Readings of
Dallas, New York, Oxford University Press.
Lombardi Satriani, L. M., 1975, Telefolklore e videocrazia cristiana, «La Musica
popolare. Rivista trimestrale dell’Amicizia musicale italiana», 1, 1, pp. 24-29.
Lucherini, F., 2007, “Tradizioni vecchie e nuove. L’evoluzione delle politiche
editoriali Rai e Mediaset nella stagione del rilancio produttivo”, in
Buonanno, a cura, 2007, pp. 99-117.
Lynd, R. S., Lynd, H. M., 1929, Middletown, a Study in Contemporary American
Culture, New York, Harcourt, Brace and Company; trad. it. 1970,
Middletown, Milano, Edizioni di Comunità.
MacCannell, D., 1973, Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in
Tourist Settings, «American Journal of Sociology», 79, 3, pp. 589-603.
Madeo, L., 1994, Donne di mafia. Vittime, complici, protagoniste, Milano,
Mondadori.
Mai, N., 2005, The Albanian Diaspora-in-the-Making: Media, Migration and
Social Exclusion, «Journal of Ethnic and Migration Studies», 31, 3, pp.
543-561.
Mankekar, P., 1999, Screening Culture, Viewing Politics. An Ethnography of
Television, Womanhood, and Nation in Postcolonial India, Durham (N.C.),
Duke University Press.
160
Identità catodiche
Piero Vereni
Marano, F., 1995, Autoetnografie. Autorappresentazioni della cultura tradizionale, «Ossimori», 7, pp. 24-32.
Marano, F., 2005, Anni Cinquanta e coccinelle che volano. Video e poetiche
della memoria etnografica, Nardò (LE), Besa.
Marazzi, A., 2002, Antropologia della visione, Roma, Carocci.
Marcus, G. E., 1995, Ethnography in/of the World System: The Emergence of
Multi-Sited Ethnography, «Annual Review of Anthropology», 24, 1, pp. 95117.
Marletti, C., a cura, 1995, Televisione e Islam. Immagini e stereotipi dell’Islam
nella comunicazione italiana, Roma, Rai-Eri.
Marrone, G., 2003, Montalbano. Affermazioni e trasformazioni di un eroe mediatico, Roma, Rai-Eri.
Martegani, F., 2005, La rappresentazione del conflitto del Vietnam attraverso
Hollywood. Analisi comparativa di Apocalypse Now di Coppola e di Full
Metal Jacket di Kubrick, «Achab. Rivista di antropologia», 6, pp. 17-25.
Matera, V., 2002, Etnografia della comunicazione. Teorie e pratiche dell’interazione sociale, Roma, Carocci.
Mazzarella, W., 2004, Culture, Globalization, Mediation, «Annual Review of
Anthropology», 33, 1, pp. 345-367.
McLuhan, M., 1964, Understanding Media; the Extensions of Man, New York,
McGraw-Hill; trad. it. 1967, Gli strumenti del comunicare, Milano, il
Saggiatore.
Michaels, E., 1986, The Aborigenal Invention of Television in Central Australia
1982-1986, Canberra, Australian Institute of Aborigenal Studies.
Michaels, E., 1994, Bad Aborigenal Art. Tradition, Media, and Technological
Horizons, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Morley, D., 1986, Family Television. Cultural Power and Domestic Leisure,
London, Comedia Pub. Group.
Negro, S., 2005, Lo Tsunami del 26 dicembre 2004 e le comunicazioni mediali
di una famiglia srilankese, «Achab. Rivista di antropologia», 6, pp. 26-29.
Osservatorio della Fiction Italiana, a cura, 2001, Catalogo della fiction italiana
1988-2000, Roma, Rai-Eri.
Page, H. E., 1997, “Black Male” Imagery and Media Containment of African
American Men, «American Anthropologist», New Series, 99, 1, pp. 99-111.
Parks, L., Kumar, S., a cura, 2003, Planet TV. A Global Television Reader, New
York, New York University Press.
Peéristiany, J. G., 1966, Honour and Shame. The Values of Mediterranean
Society, London, Weidenfeld and Nicolson.
Piasere, L., 2002, L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, Roma-Bari, Laterza.
Pistelli, M., 2003, Montalbano sono. Sulle tracce del più famoso commissario
di polizia italiano, Firenze, Le Càriti.
161
Bibliografia
Pompeo, F., 2007, “Multiculturalismo: società di tutti o di ciascuno? ”, in F.
Pompeo, a cura, La società di tutti. Multiculturalismo e politiche dell’identità, Roma, Meltemi, pp. 9-77.
Popper, K. R., 1994, Cattiva maestra televisione, Introduzione di G. Bosetti, a
cura di F. Erbani, Milano, Reset.
Powdermaker, H., 1939, After Freedom. A Cultural Study in the Deep South,
New York, Viking Press.
Powdermaker, H., 1950, Hollywood, the Dream Factory. An Anthropologist
Looks at the Movie-Makers, Boston, Little, Brown.
Powdermaker, H., 1962, Copper Town. Changing Africa; the Human Situation
on the Rhodesian Copperbelt, New York, Harper & Row.
Puzo, M., 1969, The Godfather, New York, Putnam; trad. it. 1970, Il padrino,
Milano, Club degli editori.
Rotha, P., Wright, B., 1980, Nanook and the North, «Studies in Visual
Communication», 6, 2, pp. 33-60.
Rothenbuhler, E. W., Coman, M., a cura, 2005, Media Anthropology, Thousand
Oaks (Ca.), Sage.
Sarnelli, E., 1995, “Pubblicità, talk show e varietà: contenitori di Oriente”, in
Marletti, a cura, 1995, pp. 221-244.
Saviano, R., 2006, Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di
dominio della camorra, Milano, Mondadori.
Silverstone, R., 1994, Television and Everyday Life, London, Routledge; trad.
it. 2000, Televisione e vita quotidiana, Bologna, il Mulino.
Sinclair, J., Jacka, E., Cunningham, S., a cura, 1995, New Patterns in Global
Television. Peripheral Vision, New York, Oxford University Press.
Sole, G., Belcastro, R., 2004, Sulle bombole del gas a guardare la Tv. La televisione in un paese calabrese alla fine degli anni cinquanta, Rende,
Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria.
Spitulnik, D., 1993, Anthropology and Mass Media, «Annual Review of
Anthropology», 22, 1, pp. 293-315.
Srinivas, L., 2002, The active audience: spectatorship, social relations and
the experience of cinema in India, «Media, Culture & Society», 24, 2,
pp. 155.
Todorova, M. N., 1997, Imagining the Balkans, Oxford, Oxford University Press.
Tomlinson, J., 1991, “Media Imperialism”, in Cultural Imperialism: A Critical
Introduction, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 34-67; nuova
ed. 2003, in Parks, Kumar, a cura, 2003, pp. 113-134 [non comprende il
paragrafo “Laughing at Chaplin: problems with audience research”, pp.
50-56 dell’originale].
Tomlinson, J., 1999, Globalization and Culture, Cambridge, Polity Press; trad.
it. 2001, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene globale,
Milano, Feltrinelli.
162
Identità catodiche
Piero Vereni
Trimarchi, G., 2005, Il pubblico televisivo e la negoziazione del senso (note su
una telenovela indiana), «Achab. Rivista di antropologia», 6, pp. 42-46.
Turner, T., 1991, The Social Dynamics of Video Media in an Indigenous Society:
The Cultural Meaning and the Personal Politics of Video-making in
Kayapo Communities, «Visual Anthropology Review», 7, 2, pp. 68-76.
Turner, T., 1992, Defiant Images: The Kayapo Appropriation of Video,
«Anthropology Today», 8, 6, pp. 5-16.
Turner, T., 2002, “Representation, Politics, and Cultural Imagination in
Indigenous Video. General Points and Kayapo Examples”, in Ginsburg,
Abu-Lughod, Larkin, a cura, 2002, pp. 75-89; trad. it. 2004,
“Rappresentazione, politica e immaginario culturale nella produzione video indigena. Questioni generali ed esempi kayapo”, in Balma Tivola, a
cura, 2004, pp. 139-154.
Vassallo, F., 2005a, “Madre come te”, in Buonanno, a cura, 2005, p. 347.
Vassallo, F., 2005b, “Ultimo 3 - L’infiltrato”, in Buonanno, a cura, 2005, p. 251.
Viola, C. G., 1924, Pricò, Milano-Roma, Mondadori.
Williams, R., 1974, Television. Technology and Cultural Form, London,
Fontana; trad. it. 2000, Televisione. Tecnologia e forma culturale e altri
scritti sulla tv, a cura di Enrico Menduni, Roma, Editori Riuniti.
Wolf, M., 1992, Gli effetti sociali dei media, Milano, Bompiani.
Worth, S., Adair, J., 1972, Through Navajo Eyes. An Exploration in Film
Communication and Anthropology, Bloomington, Indiana University Press.
Zappa Mulas, P., 2000, Rosa Furia, Milano, La tartaruga.
Bailey, Olga G., 30, 34, 48
Balma Tivola, Cristina, 36-37
Banaji, Shakuntala, 25
Banfi, Lino, 112, 138, 142-143, 144-145
Banfield, Edward C., 151
Barbareschi, Luca, 129-130
Basso, Gina, 125
Battiato, Franco, 53
Bausinger, Hermann, 46-47
Bécaud, Gilbert, 53
Bechelloni, Giovanni, 130
Belcastro, Rossella, 41
Belvedere, Vittoria, 128
Bendix, Regina, 27
Bennato, Edoardo, 132
Berisha, Sali, 71
Berlusconi, Silvio, 88
Biagi, Enzo, 72, 77, 79, 82
Bilancia, Donato, 146
Bindi, Letizia, 24, 47
Biorcio, Roberto, 152
Bisio, Claudio, 114
Bo, Carlo, 78, 82
Bocca, Giorgio, 84-85, 89
Boldi, Massimo, 113
Boni, Federico, 30
Borsellino, Paolo, 109, 148
Bossi, Umberto, 125
Bottelli, Serena, 36
Bourdieu, Pierre, 9, 49-53, 56-58,
60, 64-65
Bova, Raoul, 115, 126
Bruner, Edward M., 8
Bruner, Jerome, 43
Buccirosso, Carlo, 113
Indice dei nomi
Abatantuono, Diego, 137
Abbagnale, Carmine, 132
Abbagnale, Giuseppe, 132
Abu-Lughod, Lila, 15, 19, 28-29, 105
Acquaviva, Sabino, 85, 89
Adorno, Theodor W., 20
Alia, Ramiz, 76
Allakariallak, 16
Alt, Carol, 123
Altin, Roberta, 36, 39, 44
Amaducci, Gaia, 33
Amselle, Jean-Loup, 47
Anderson, Benedict, 21, 26, 34-36,
101
Ang, Ien, 19, 21, 23
Apolito, Paolo, 31-32
Appadurai, Arjun, 8, 17, 19, 26, 33,
40, 48, 61, 94, 96, 102, 152
Arbasino, Alberto, 81-82
Arcuri, Manuela, 125
Askew, Kelly Michelle, 20, 25, 29
Atria, Rita, 109, 146
163
Indice dei nomi
Piero Vereni
Identità catodiche
164
Buonanno, Milly, 102, 151
Buzzanca, Lando, 144
Calipari, Andrea, 146
Camilleri, Andrea, 133-134, 136
Campagna, Graziella, 121
Canevacci (Ribeiro), Massimo, 33, 38
Capra, Frank, 73
Caputo, Livio, 73, 82-84, 87
Caracciolo, Lucio, 86
Carbone, Seralisa, 97
Caretto, Ennio, 79
Carrà Raffaella, 94, 143
Casati Modignani, Sveva, 123
Casella, Cesare, 145
Castellitto, Sergio, 133
Cavallari, Alberto, 74
Cavallari, Simona, 135
Cavina, Gianni, 134
Cerruti, Maurizio, 79
Cervi, Mario, 89
Chadha, Kalyani, 47
Chiozzi, Paolo, 48
Cingolani, Stefano, 73-74, 76-77, 8081, 88
Cino, Leon, 95, 97
Cipriano, Piero, 33
Clemente, Pietro, 46
Clifford, James, 19, 24, 34
Columbro, Marco, 133, 141
Coman, Mihai, 31
Connelly, Kathy, 142
Conti, Laura, 109
Costanzo, Maurizio, 65
Covatta, Giobbe, 112
Cuccarini, Lorella, 94
Cunningham, Stuart, 47
Curran, James, 47-48
Dalla Chiesa, Carlo Alberto, 148
D’Alessio, Gigi, 53
D’Antona, Massimo, 146
Damiani, Damiano, 150
Dapporto, Massimo, 120
Dayan, Daniel, 48
Dazieri, Sandrone, 136
de André, Fabrizio, 53
De Caprio, Sergio, 147
De Concini, Enrico, 116
Deep Purple, 69
De Filippi, Maria, 10, 62, 65-67, 9497
Dei, Fabio, 46
de Rapper, Gilles, 69, 93
De Rossi, Barbara, 142
de Sanctis Ricciardone, Paola, 8
De Sica, Vittorio, 127
De Silva, Diego, 136
Di Benedetto, Ida, 144
Dick Zatta, Jane, 42-43
Dighero, Ugo, 126
Di Giacomo, Salvatore, 124
Dorelli, Johnny, 140-141
Duranti, Alessandro, 22, 37
Durkheim, Émile, 151
Eco, Umberto, 13
Elias, Norbert, 57
Emmer, Luciano, 110
Esposito, Ciro, 111
Evans, William A., 18, 23
Fabian, Johannes, 105
Fabietti, Ugo, 34-36
Faeta, Francesco, 48
Fagioli, Monica, 36
Falcone, Giovanni, 148
Faletti, Giorgio, 136
Fallo, Dhori, 69-70, 97
Farina, Renato, 81, 84
Fejes, Fred, 47
Ferguson, James, 48
Ferilli, Sabrina, 114
Fichte, Johann Gottlieb, 67
Hadley Chase, James, 132
Haider, Jörg, 79
Hall, Stuart, 21
Hannerz, Ulf, 26
Harindranath, Ramaswami, 30, 34,
48
Harper, Douglas, 46
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 66
Heidegger, Martin, 66
Herzfeld, Michael, 101, 106, 121-122
Hill, Terence, 134, 138
Hodgson Burnett, Frances, 108
Horkheimer, Max, 20
Hoxha, Enver, 76, 91, 94
Hume, Lynne, 48
165
Galli della Loggia, Ernesto, 90
Gallini, Chiara, 32-33
Gardini, Elisabetta, 143
Garimberti, Paolo, 81
Garko, Gabriel, 119
Gasparri, Maurizio, 87
Geertz, Clifford, 152
Georgiou, Myria, 30, 34, 48
Geraldine Margit Virginia Olga Mária
Apponyi de Nagy-Appony, 72
Gerbner, George, 21
Giacometti, Graziella, 151
Giannattasio, Maurizio, 80, 82
Giannini, Giancarlo, 119
Gianoncelli, Tullia, 36
Ginsburg, Faye D., 15-16, 19, 26-27,
29, 40
Giuffrè, Martina, 38-39
Goethe, Johann Wolfgang von, 64
Goodwin, Charles, 22, 37
Goody, Jack, 43
Grady, John, 46
Grandi, Serena, 146
Grasso, Aldo, 101, 149
Green, Nicholas, 146
Greggio, Ezio, 113, 132
Greimas, Algirdas, 44
Grimaudo, Nicole, 138
Gross, Larry, 21
Guarini, Ruggero, 84
Guigoni, Alessandra, 33
Gullotta, Leo, 125
Gupta, Akhil, 48
Innis, Harold Adams, 26
Jacka, Elizabeth, 47
Jameson, Fredric, 59
Jarvis, Chris, 71
Jenkins, Richard, 92
Jethro Tull, 69
Johnson, Victoria E., 105
Joyce, James, 66
Kadarè, Ismail, 91
Kadiu, Kledi, 93-94
Katz, Elihu, 22
Kavoori, Anandam, 47
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara, 8
Kumar, Shanti, 18, 30
Labranca, Tommaso, 7
La Cecla, Franco, 31-32, 34
Lai, Franco, 33
Larkin, Brian, 15, 19, 25, 29
Laviano, Silvio, 136
Led Zeppelin, 69
Indice dei nomi
Fiorello, Beppe, 121
Flaherty, Robert, 15
Flaubert, Gustave, 17-18
Flora, Giuseppe Tobia, 152
Fois, Marcello, 136
Fox, Richard Gabriel, 19
Frassica, Nino, 112
Frisone, Fulvio, 127
Fruttero, Carlo, 123
Fuccillo, Mino, 85, 89
Piero Vereni
Identità catodiche
166
Lévi-Strauss, Claude, 52
Liebes, Tamar, 22, 48
Lombardi Satriani, Luigi Maria, 24
Lucarelli, Carlo, 136
Lucentini, Franco, 123
Lucherini, Fabrizio, 151-152
Lukas, Tili, 95
Lynd, Helen Merrell, 18
Lynd, Robert Staughton, 18
MacCannell, Dean, 16, 27
Madeo, Liliana, 126
Madre Teresa (Agnes Gonxha
Bojaxhiu), 72
Mai, Nicola, 95
Malinowski, Bronislaw, 20
Maltese, Curzio, 86
Manfredi, Nino, 133, 138
Marano, Francesco, 40
Marazzi, Antonio, 48
Marcus, George E., 19, 48
Marrone, Gianfranco, 152
Martegani, Fiammetta, 36
Marx, Karl, 57-58, 68
Matera, Vincenzo, 37
Mattioli, Maurizio, 113
Mauro, Ezio, 88
Mazzarella, William, 36, 99
Mazzola, Valentino, 111
McLuhan, Marshall, 26
Merlo, Sandro, 88
Mezzogiorno, Vittorio, 115
Michaels, Eric, 23, 27
Millken, Michael, 73
Montanelli, Indro, 78
Montesano, Enrico, 141
Montesquieu, Charles-Louis de
Secondat, baron de La Brède et
de, 49
Moravia, Alberto, 64, 131
Morgan, Michael, 21
Morley, David, 21
Moscati, Giuseppe, 127
Mulcock, Jane, 48
Negro, Silvana, 36
Orlando, Silvio, 114
Ostellino, Piero, 74
Oxa, Anna, 72
Paganini, Raffaele, 94
Page, Helán E., 96
Panebianco, Angelo, 86-87
Panelli, Paolo, 141
Parisi, Heather, 94
Park Myung-Jin, 47-48
Park, Robert, 18
Parks Lisa, 18, 30
Parmeggiani, Paolo, 44
Pasolini Zanelli, Alberto, 79
Piasere, Leonardo, 38
Pistelli, Maurizio, 152
Pittalis, Edoardo, 88-89
Placido, Michele, 109-110, 115, 118,
122, 140, 148-149
Poincaré, Raymond, 76
Polito, Antonio, 80, 82, 88
Pompeo, Francesco, 59
Pooh, 53
Popper, Karl R., 151
Powdermaker, Hortense, 20, 47
Proietti, Gigi, 142
Provenzano, Bernardo, 148
Puglisi, Pino, 148
Puzo, Mario, 123, 152
Ranieri, Massimo, 119
Ricossa, Sergio, 77
Riina, Salvatore, 147-148
Risi, Marco, 149
Rispo, Patrizio, 131
Ronza, Robi, 74-75
Rotha, Paul, 16
Teocoli, Teo, 114
Tirabassi, Giorgio, 120
Todorova, Maria N., 73
Tolstoj, Lev, 132
Tomlinson, John, 17-18, 26, 46-47,
99
Valentini, Giovanni, 78
Valsecchi, Pietro, 147
Vanzina, Carlo, 132
Vassallo, Fabio, 144, 147
Veneziani, Marcello, 90
Venturini, Franco, 74, 79-80, 82
Vigliero Lami, Mitì, 83
Viola, Cesare Giulio, 127
Viola, Sandro, 76-77, 85
Virgillito, Michelangelo, 73
Virilio, Paul, 32, 48
Vittorio Emanuele III, 72
Wilk, Richard R., 30
Williams, Raymond, 21
Wolf, Mauro, 18, 25
Wright, Basil, 16
Zambotti, Sara, 36
Zappa Mulas, Patrizia, 110
Zeffirelli, Franco, 66
Zincone, Giuliano, 84, 87
Zingaretti, Luca, 135
Zog I, Skanderbeg III (Ahmet
Zogolli), 72
167
Sarnelli, Enrico, 33
Saviano, Roberto, 150
Scalfari, Eugenio, 85
Scarpa, Tiziano, 7
Scarpino, Salvatore, 90
Schütz, Alfred, 34
Selimi, Klajdi, 95-96
Sensini, Mario, 89
Sgorlon, Carlo, 73, 78, 81
Shagiri, Ilir, 95
Shagiri, Olti, 95
Signorielli, Nancy, 21
Silverstone, Roger, 17
Sinani, Elton, 69
Sinclair, John, 47
Sole, Giovanni, 41-42
Spencer, Bud, 124, 127
Spitulnik, Debra, 20-24, 30
Srinivas, Lakshmi, 25
Sterpa, Egidio, 80
Toromani, Anbeta, 95, 97
Trettre, 112
Trimarchi, Gianni, 36
Turner, Terence, 27, 40
Indice dei nomi
Rothenbuhler, Eric W., 31
Russo, Tiziana, 151
Stampato per conto della casa editrice Meltemi
nel mese di settembre 2008
presso Arti Grafiche La Moderna, Roma
Impaginazione: www.studiograficoagostini.com