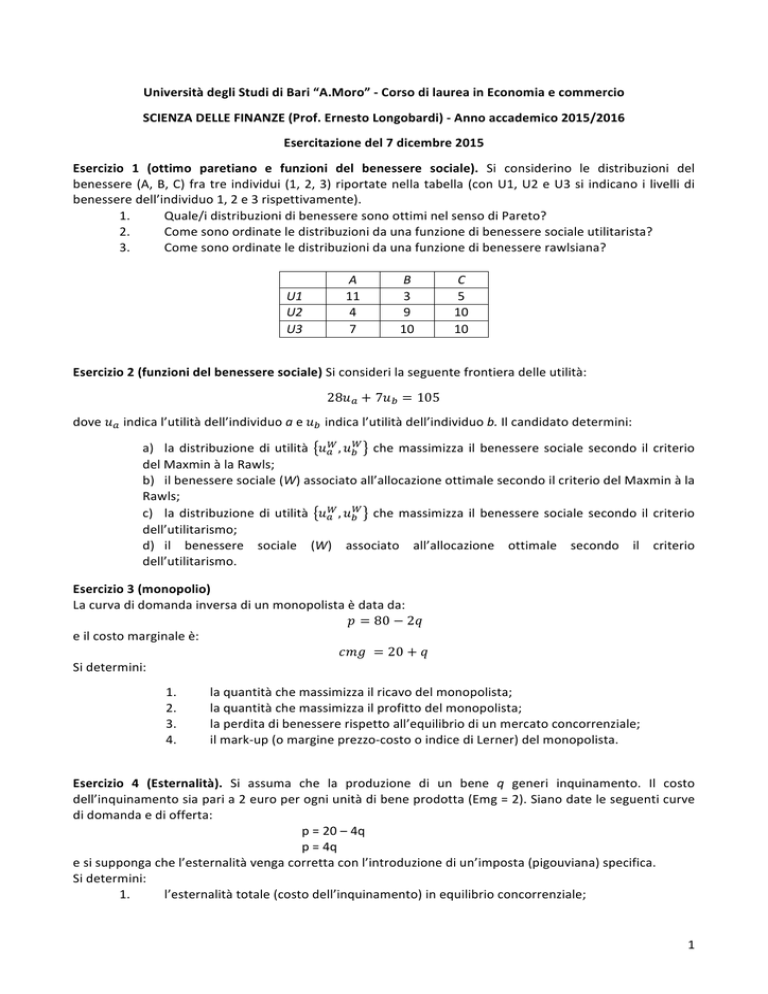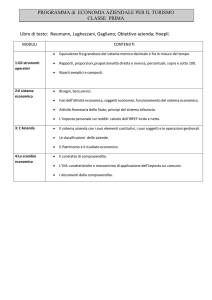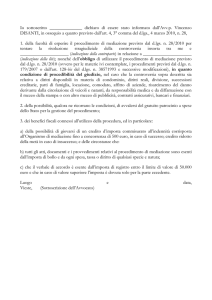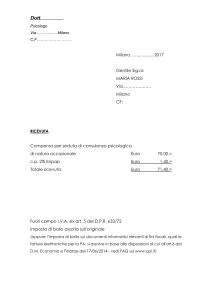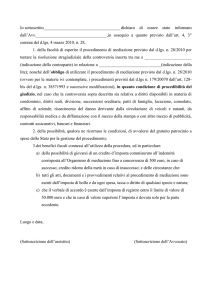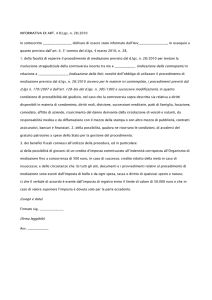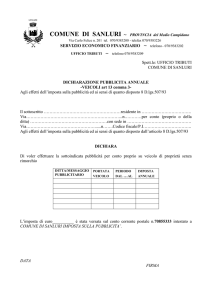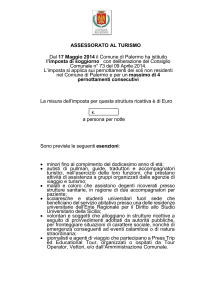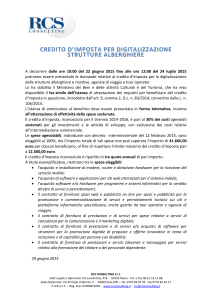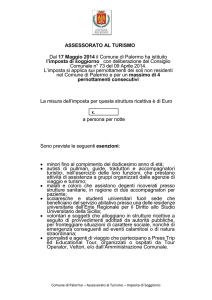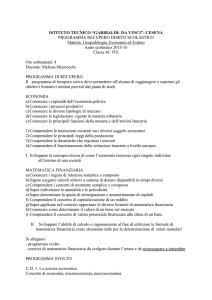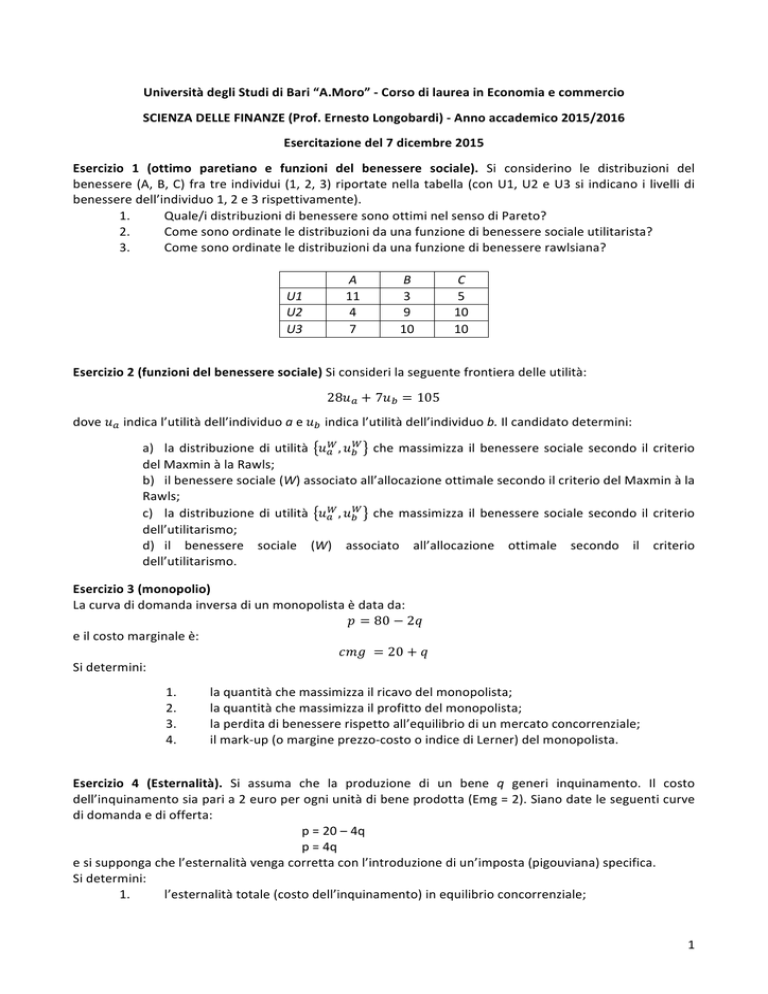
UniversitàdegliStudidiBari“A.Moro”-CorsodilaureainEconomiaecommercio
SCIENZADELLEFINANZE(Prof.ErnestoLongobardi)-Annoaccademico2015/2016
Esercitazionedel7dicembre2015
Esercizio 1 (ottimo paretiano e funzioni del benessere sociale). Si considerino le distribuzioni del
benessere(A,B,C)fratreindividui(1,2,3)riportatenellatabella(conU1,U2eU3siindicanoilivellidi
benesseredell’individuo1,2e3rispettivamente).
1.
Quale/idistribuzionidibenesseresonoottiminelsensodiPareto?
2.
Comesonoordinateledistribuzionidaunafunzionedibenesseresocialeutilitarista?
3.
Comesonoordinateledistribuzionidaunafunzionedibenessererawlsiana?
A
B
C
U1
11
3
5
U2
4
9
10
U3
7
10
10
Esercizio2(funzionidelbenesseresociale)Siconsiderilaseguentefrontieradelleutilità:
28𝑢! + 7𝑢! = 105
dove𝑢! indical’utilitàdell’individuoae𝑢! indical’utilitàdell’individuob.Ilcandidatodetermini:
a) la distribuzione di utilità 𝑢!! , 𝑢!! che massimizza il benessere sociale secondo il criterio
delMaxminàlaRawls;
b) ilbenesseresociale(W)associatoall’allocazioneottimalesecondoilcriteriodelMaxminàla
Rawls;
c) la distribuzione di utilità 𝑢!! , 𝑢!! che massimizza il benessere sociale secondo il criterio
dell’utilitarismo;
d) il benessere sociale (W) associato all’allocazione ottimale secondo il criterio
dell’utilitarismo.
Esercizio3(monopolio)
Lacurvadidomandainversadiunmonopolistaèdatada:
𝑝 = 80 − 2𝑞
eilcostomarginaleè:
𝑐𝑚𝑔 = 20 + 𝑞
Sidetermini:
1.
2.
3.
4.
laquantitàchemassimizzailricavodelmonopolista;
laquantitàchemassimizzailprofittodelmonopolista;
laperditadibenessererispettoall’equilibriodiunmercatoconcorrenziale;
ilmark-up(omargineprezzo-costooindicediLerner)delmonopolista.
Esercizio 4 (Esternalità). Si assuma che la produzione di un bene q generi inquinamento. Il costo
dell’inquinamentosiaparia2europerogniunitàdibeneprodotta(Emg=2).Sianodateleseguenticurve
didomandaediofferta:
p=20–4q
p=4q
esisuppongachel’esternalitàvengacorrettaconl’introduzionediun’imposta(pigouviana)specifica.
Sidetermini:
1.
l’esternalitàtotale(costodell’inquinamento)inequilibrioconcorrenziale;
1
2.
l’esternalitàtotale(costodell’inquinamento)incorrispondenzadellaquantitàsocialmente
ottima;
3.
ilgettitodell’imposta;
4.
ilguadagnointerminidibenessereassicuratodallacorrezionedell’esternalità.
Esercizio5(criteridistribuzionedelcaricotributario)
Ibeneficimarginaliprivatigeneratidaunserviziopubblicosiano:
Bmgpr=6–q
Ilserviziogeneraancheun’esternalitàmarginalepositivadatada:
ESmg=2–q/3
Ilcostomarginale(emedio)delservizioè:
Cmg=2
Calcolare:
1.
laquantitàdiserviziorichiestadagliutentiquandol’interocostoèpostoalorocarico;
2.
laquantitàottimadiservizio;
3.
qualepercentualedelcostovapostaacaricodell’interacollettivitàtramiteleimposte
perchégliutentirichiedanolaquantitàottima.
Esercizio6(incidenzadelleimposte)
Il governo decide di aumentare l’accisa sulla benzina di 10 centesimi di euro per litro. Sapendo che
l’elasticità dell’offerta è ηs= 1,2 e che, in seguito all’aumento dell’accisa, il prezzo della benzina al
consumatore aumenta di 8 centesimi di euro per litro, si determini il valore assoluto dell’elasticità della
domanda(ηd).
Esercizio7(Progressivitàlocaleeglobale).
Siassumaunasocietàcompostaditreindividui,laseguentedistribuzionediredditi:y=(600,1.000,2200)e
duefunzionid’impostaprogressive:
1.
funzioned’imposta(A)T=0,25(Y–200)
2.
funzioned’imposta(B)T=0,25Y-50
Calcolare:
1.
lapressionefiscalecomplessivanelcasodall’imposta(A);
2.
l’elasticitàdeldebitodiimpostanelcasodell’imposta(B)perl’individuopiùpovero;
3.
l’elasticitàdelredditonettoconl’imposta(A)perl’individuopiùricco;
4.
l’aliquotamarginaledellafunzionediimposta(A);
5.
lacurvadiLorenzdelgettitoperl’imposta(A).
2
Esercizio8(grandezzeeconomichedell’impresa)
Siconsideriilseguentecontoeconomicodiun’impresaindividuale:
Costi
Ricavi
Rimanenzeinizialidiprodottifiniti100 Venditadiprodottifiniti1500
Rimanenzeinizialidibeniintermedi50 Rimanenzefinalidiprodottifiniti200
Acquistidibeniintermedi300 Rimanenzefinalidibeniintermedi100
Stipendiesalari600 Ammortamenti300
Onerifinanziari40
Sicalcoli:
1.
2.
3.
Ilvaloreaggiunto
L’utileoperativo,omargineoperativolordo
Ilprofittosupponendoche:
a. ilcapitaleinvestitonell’aziendasiaparia2.400,dicui2/3diproprietàdell’imprenditore,
b. iltassod’interessesiail5%;
c. l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa, quando, se lavorasse come lavoratore
dipendentepressoun’altraazienda,percepirebbeunostipendiodi300.
4.
Il debito (-) o il credito (+) IVA considerando un’aliquota ordinaria del 20% e supponendo
chel’impresaabbiaeffettuatouninvestimentoper500.
Esercizio9(incidenza)
Inrelazioneall’esercizioprecedentesisuppongachevengaintrodottaun’impostadel25%sulredditodi
impresa(utili),un’impostadel10%suiredditidaattivitàfinanziarie(interessi)eun’impostadel30%sui
redditidalavorodipendente.
Sicalcoli:
1.
2.
3.
l’utilealnettodell’impostasulredditodiimpresa;
inuovicostifigurativi;
ilprofitto(positivo+onegativo-)alnettodell’impostasulredditodiimpresa.
Esercizio10(unitàimpositiva)
SiconsiderilaseguentescaladiequivalenzaISEperlefamigliemonoreddito:
Nucleofamiliare
1
2
3
4
5
ISE(monoreddito)
1,00 1,57 2,04 2,46 2,85
3
Un nucleo familiare monoreddito (famiglia A) è composto da 4 persone (il capofamiglia, due figli e il
coniugeacarico)epercepisceunredditoequivalente,interminidibenessere,aunredditodi10.000nel
casodiunindividuosingle(famigliaB).
Siassumalaseguentefunzioned’impostaprogressivaperdeduzione𝑇 = 𝑌 − 100 ∗ 0,25 eleseguenti
ipotesiditrattamentodelredditofamiliare:
1. tassazioneseparatacondetrazioniperfamiliariacarico
a. detrazioneperconiugeacarico:500
b. detrazioniperfigliacarico:100perciascunfiglio
2. quozientefamiliare:
a. coefficienteconiugi:1
b. coefficientefigli:0,5perciascunfiglio
Sidetermini:
a) ilredditonettodellafamigliaAnell’ipotesiditassazioneseparatadeiredditi
b) ilredditonettodellafamigliaAnell’ipotesidelquozientefamiliare
Esercizio11(aritmeticadeldebitopubblico)
Inundeterminatoeserciziofinanziario,inunpaesechenonpuòfarericorsoalfinanziamentomonetario
del disavanzo, il rapporto tra il debito pubblico e il Pil è pari al 120%. Il tasso di interessecorrisposto sul
debitopubblico(r)èparial5%.Iltassodicrescitamonetario(x)delPilèil2%.Determinareilvaloredel
saldoprimariorispettoalPilnecessarioperchéilrapportodebito/Pilnoncresca.
Esercizio12(contoconsuntivo)
Inrelazioneallaseguentetabella,relativaalcontoconsuntivodiunentepubblico,sicalcolino:
1.
2.
leeconomiedispesa(residuidistanziamento)
iresiduiallafinedell'esercizio
Rendiconto di un ente pubblico - Spese
Residui all'inizio dell'esercizio
Previsioni di competenza (stanziamenti)
Impegni
Pagamenti in conto competenza
Pagamenti in conto residui
105
500
430
325
79
4
Esercizio13(contoeconomicoconsolidatodelleamministrazionipubbliche)
Sicompleti,inserendoivalorimancanti,laseguentetabella,relativaaicontieconomicideitresotto-settori
delleamministrazionipubblicheealcontoconsolidato.
Ipotetici conti economici delle amministrazioni pubbliche - anno xxxx (miliardi di euro)
[a]
[b]
[c]
Amm. centrali Amm. locali E. di prev. Consolidato
Uscite
Totale uscite correnti
di cui:
Interessi passivi
Trasferimenti ad enti pubblici
Totale uscite in conto capitale
di cui:
Trasferimenti ad enti pubblici
Totale uscite
Entrate
Totale entrate correnti
di cui:
Trasferimenti da enti pubblici
Totale entrate in conto capitale
di cui:
Trasferimenti da enti pubblici
Totale entrate
Saldo di parte corrente (risparmio pubblico)
Indebitamento (-) o accreditamento(+)
Saldo primario
450
200
325
75
200
40
5
3
30
0
6
0
20
10
0
430
220
330
8
10
84
15
114
0
4
10
0
70
VEROOFALSO
Indicareseleseguentiaffermazionisonovereofalse.
1. L’IVAèun’impostaadvaloremtaxexclusive
2. Un’impostaproporzionalesulpatrimoniorisultaprogressivarispettoalreddito,seil
rapportotrapatrimonioeredditocrescealcresceredelreddito
3. Secondoilprincipiodelbeneficio,l’oneredellacoperturadelcostodellaspesa
pubblicaèpostointuttooinparteacaricodeibeneficiari
4. Inpresenzadiesternalitàpositivel’equilibriodimercatoconcorrenzialeè
caratterizzatodalloscambiodiquantitàminoririspettoaquelleottimeinsenso
paretiano
5. L’indicediKakwanimisural’effettoredistributivodell’imposta
6. Ladomandacomplessivadiunbeneprivatosiottienesommandoverticalmentele
domandedeisingoliindividui
7. Conunacurvadidomandaperfettamenterigida,l’impostarisultaperinteroa
caricodeicompratori
8. L’impostaPigouvianaazzeraleesternalitànegative
9. ConunaFBSallaRawlsilbenesseresocialeèdatodallamediatral’utilità
dell’individuoconutilitàmaggioreeutilitàdell’individuoconutilitàminore
10. Perilprincipiodiequitàverticale,leimposterealinondevonoessereprogressive.
5
11. L’elasticitàdeldebitod’impostaèdatadalrapportotralavariazionedeldebito
d’impostaelavariazionedellabaseimponibile
12. Un’impostaèregressivasel’aliquotamarginaleèinferioreall’aliquotamedia
13. IlsettoredelleAmministrazionipubblicheèsuddivisoinduesotto-settori:
AmministrazionicentralieAmministrazionilocali.
14. Neicontipubblicilaspesaperinteressièdatadalprodottotrailtassodiinteressee
l’indebitamentonetto.
15. SeilPILnominaleècostanteeilsaldoprimarioèpariazero,l’aumentodel
rapportodebito/Pilèdatodalprodottotrailtassodiinteresseeilrapportodebito
/Pil.
16. Wikipedia è un bene pubblico.
17. Si ha un’allocazione Pareto efficiente quando non è possibile migliorare la
condizione di alcun individuo.
18. Il teorema di Coase dice che in caso di esternalità la contrattazione tra privati porta a
un’allocazione Pareto efficiente, a condizione che diritti di proprietà siano assegnati
in modo appropriato.
19. Il prezzo di Lindahl è unico per tutti gli individui, come il prezzo di mercato di un
bene privato.
20. Si ha il paradosso del voto quando l’ordinamento di preferenze di almeno un
partecipante al voto non è transitivo.
21. Lo scambio dei voti può migliorare l’esito di una votazione dal punto di vista
dell’efficienza.
22. Il trattato di Maastricht prevede che il saldo di bilancio in termini strutturali non
superi il 3% del Pil.
23. Il Six-pack prevede che i paesi con un rapporto debito/Pil superiore al 60% riducano
l’eccedenza di 1/20 l’anno.
24. In Italia il Programma di stabilità (PS) e il Piano nazionale di riforme (PNR) sono
contenuti nel Documento di economia e finanza (DEF).
25. Indebitamento netto e fabbisogno sono la stessa cosa.
26. Saldo netto da finanziare e fabbisogno sono la stessa cosa.
27. Un’imposta è progressiva se l’aliquota marginale cresce al crescere del reddito.
28. Le esportazioni sono operazioni esenti dall’IVA.
29. Date le curve di domanda e di offerta, e data l’imposta unitaria nel punto di
equilibrio, la ripartizione del carico fiscale tra venditori e compratori è indipendente
dal fatto che il tributo sia formalmente a carico degli uni oppure degli altri.
30. L’imposta sul valore aggiunto è insensibile al grado d’integrazione verticale degli
scambi.
31. Secondo il principio della capacità contributiva l’onere della copertura del costo
delle spese pubbliche è posto, in tutto o in parte, a carico dei beneficiari.
32. L’indice di Reynolds-Smolensky è pari alla differenza tra l’indice di Gini dei redditi
lordi e l’indice di Gini dei redditi netti.
33. Con l’IVA a ogni stadio l’imposta gravante sul valore del bene corrisponde alla
somma dell’imposta che ha gravato sugli stadi precedenti.
34. Se un monopolista ha come obiettivo la massimizzazione del valore delle vendite,
dato un vincolo di profitto minimo, un’imposta proporzionale sui profitti può
trasferirsi.
35. Date due distribuzioni di reddito X e Y, Y domina X nel senso di Lorenz se e solo se
Y domina X secondo il criterio utilitaristico.
36. Le curve di indifferenza della funzione del benessere sociale utilitarista sono rette
inclinate negativamente a 45 gradi.
37. Il valore aggiunto è dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi
6
variabili.
38. Il piano di consumo ottimo per un individuo è quello per il quale il tasso soggettivo
di interesse eguaglia il saggio marginale di sostituzione intertemporale.
39. All’interno della scatola di Edgeworth, la curva dei contratti è il luogo geometrico
dei miglioramenti paretiani.
40. La quantità ottima di bene pubblico è quella in corrispondenza della quale il costo
marginale è eguale alla somma dei benefici marginali degli individui.
41. Il secondo teorema fondamentale dell’economia del benessere stabilisce che esiste
sempre un vettore di prezzi tale che ciascuna allocazione Pareto-efficiente è un
equilibrio di mercato concorrenziale, una volta assegnate le opportune dotazioni
iniziali.
42. L’IVA è un’imposta generale sulle vendite al consumo.
43. La progressività dell’imposta è condizione necessaria e sufficiente perché il prelievo
riduca la disuguaglianza, quale che sia la distribuzione dei redditi lordi.
44. La tassazione del reddito entrata equivale alla tassazione del consumo potenziale.
45. Con il principio della fonte i redditi sono tassati dal paese esportatore.
46. L’escludibilità di un bene è condizione necessaria perché possa applicarsi il principio
della controprestazione.
47. Il teorema dell’elettore mediano dice che, dato uno spazio politico unidimensionale e
un profilo di preferenze unimodali, la politica vincente con la regola della
maggioranza è la politica mediana.
48. Data una distribuzione dei redditi X e due funzioni d’imposta t1 e t2; l’imposta t1
eserciterà un maggiore effetto redistributivo se e solo se, in corrispondenza di ogni
livello di reddito, l’imposta t1 risulta più progressiva dell’imposta t2 in base
all’elasticità del reddito netto.
49. Con un’imposta progressiva per scaglioni, nell’ambito di ciascuno scaglione
l’aliquota marginale è costante.
50. Un’imposta è progressiva se l’elasticità del gettito è superiore a zero.
7