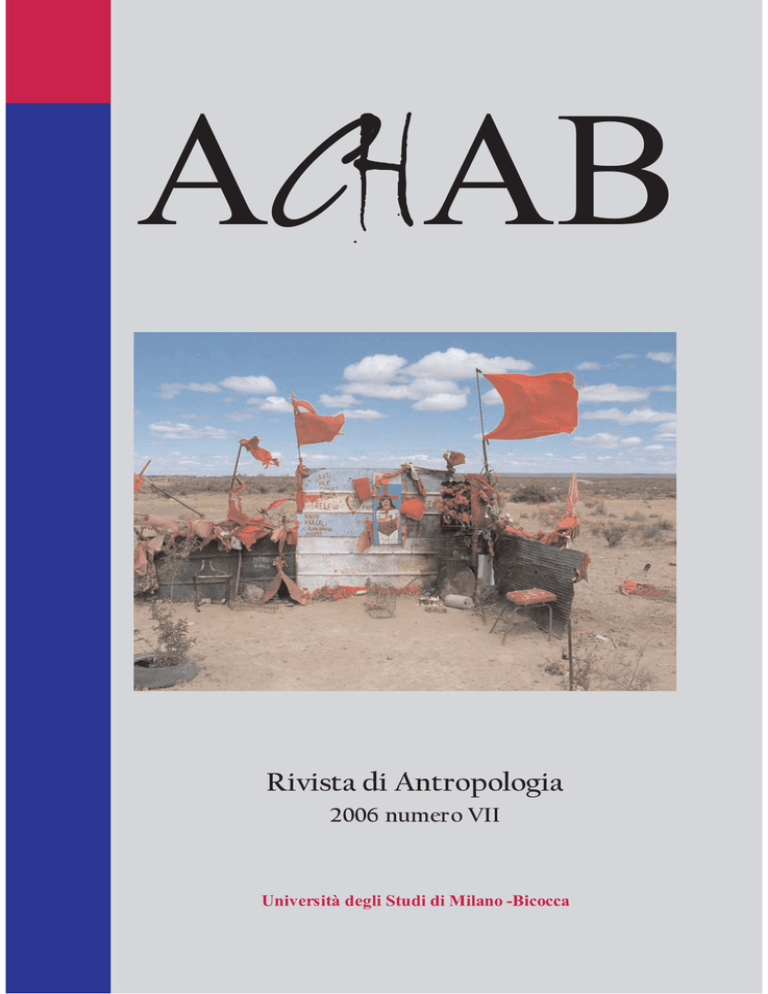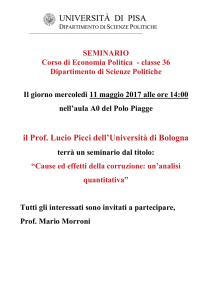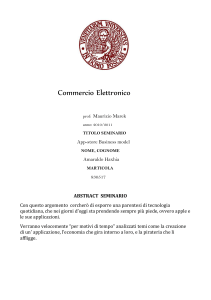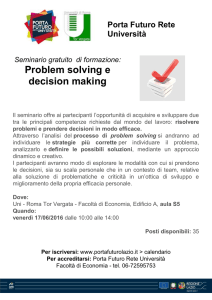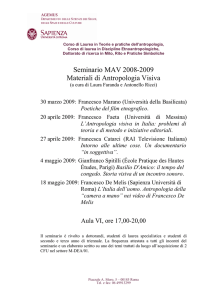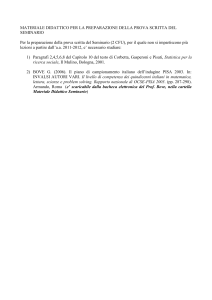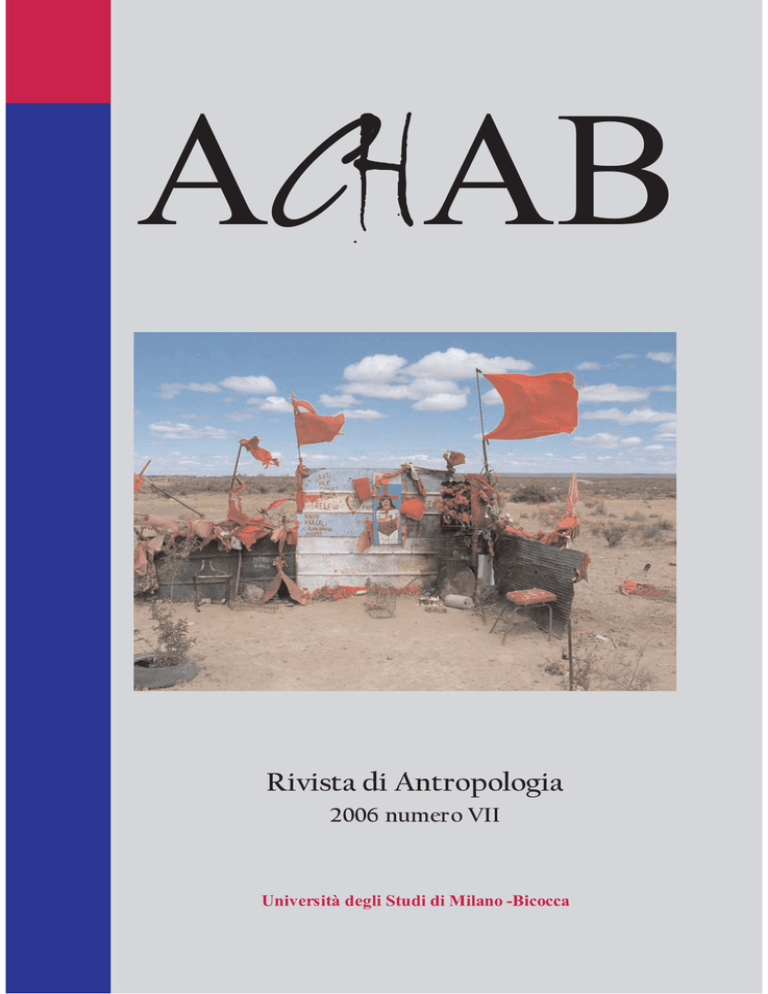
ACHAB
Rivista di Antropologia
2006 numero VII
Università degli Studi di Milano -Bicocca
AChAB - Rivista di Antropologia
Numero VII - febbraio 2006
Direttore Responsabile
Matteo Scanni
Direzione editoriale
Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi
Redazione
Paolo Borghi, Lorenzo D'Angelo, Antonio De Lauri, Michele Parodi, Fabio Vicini
Progetto Grafico
Lorenzo D'Angelo
Referente del sito
Antonio De Lauri
Tiratura: 500 copie
Pubblicazione realizzata con il finanziamento del Bando "1000 lire", Università degli Studi di Milano
Bicocca
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 697 - 27 settembre 2005
Non siamo riusciti a rintracciare i titolari del dominio di alcune immagini qui pubblicate. Gli autori sono
invitati a contattarci.
* Immagine in copertina di Paolo Borghi: altare commemorativo in onore di Gauchito Antonio Gil,
santo popolare (Trelew, Patagonia Argentina, dicembre 2005).
Se volete collaborare con la rivista inviando vostri articoli o contattare gli autori,
scrivete a: [email protected]
In questo numero...
3
Intervista a Michael Herzfeld
a cura della Redazione
9
Transazioni della politica e declinazioni di "nazione"
Mafia siciliana e yakusa giapponese tra società tradizionale e stato moderno
di Rossana Di Silvio
21
Sarajevo e il passato che non passa
La memoria, il paesaggio e l'identità come fermo-immagine
di Claudio Todisco
29
Identità mobili tra emigrazione, immigrazione, accoglienza
di Paolo Benini
36
I fenomeni migratori
Metodo e prospettiva critica di Abdelmalek Sayad
di Paolo Borghi
Dossier Università e Sapere
42
Premessa
43
Un seminario… è come un vocabolario fatto di parole senza definizioni
di Paola Di Cori
47
Che cos'è un seminario?
di Michel de Certeau
51
“Un’utopia?”
di Franca Balsamo
53
Facoltà in conflitto
di Matteo Bonazzi
55
Riflessioni sulle riforme universitarie (1989-2005)
di Stefano Boni
1
56
"Il risveglio delle metafore"
di Davide Borrelli
57
Il seminario: spazio di confine tra il "centro" di produzione del sapere e l' "erranza"
intellettuale
di Barbara Caputo
59
Quei discorsi 'inconcludenti'
di Elena Gagliasso Luoni
61
A proposito di giocatori
di Alberto Giasanti
62
L'Università, l'istituzione e i suoi margini
di Michele Parodi
64
Costruire insieme la conoscenza per formarsi
di Clotilde Pontecorvo
66
Transiti e Contraddizioni
Riprendere il seminario di Michel de Certeau perché l'università non si metta in sosta
di Chiara Rabbiosi
68
Totò, il Jazz e la Scienza: un Metalogo
di Francesco Ronzon
Altrevoci
71
Bomalang-ombe, Tanzania
di Edoardo Occa
2
Intervista a Michael Herzfeld
*
I - Vorremmo iniziare con una nota biografica e chiederle
quindi come si è sviluppato il suo percorso di antropologo.
H - Ogni persona ha qualcosa nel suo passato che la spinge a porsi
determinate domande. Io, ad esempio, essendo nato e cresciuto in
Inghilterra, ma non sentendomi mai veramente inglese, perché di
origine straniera, sono sempre stato molto interessato alle
situazioni che si sviluppavano a scuola tra amici, molti dei quali
figli di profughi come me o studenti stranieri. Molti ragazzi si
consideravano inglesi senza sentirsi obbligati a rifletterci e questa
cosa, che per loro sembrava naturale, mi spingeva a riflettere e a
pormi certe domande. Fin da giovane ero molto interessato a
questo tipo di questioni e, inoltre, il fatto di aver viaggiato molto
insieme ai miei genitori ha suscitato in me l'interesse rispetto alle
differenze culturali, insegnandomi ad apprezzare le piccole cose
come, per esempio, essere aperti a nuovi tipi di cucina. Per cui
penso che fossi in qualche maniera già orientato all'antropologia
molti anni prima di diventare un antropologo.
Ho incominciato al liceo con gli studi classici di cultura greca
antica e latina, ma un viaggio in Grecia mi ha convinto di essere
ben più interessato alla cultura dei greci contemporanei. Ho
imparato il greco moderno da solo (come del resto avevo già fatto
con l'italiano un paio d'anni prima), e questo fatto mi è servito da
base forte quando, deluso dall'archeologia come si insegnava
all'epoca, ho incominciato a rivolgermi da solo allo studio della
cultura greca moderna. Un primo salto a Creta nel 1967 per
registrare con due coetanei delle canzoni rurali è stato forse il
definitivo punto di svolta che mi ha portato verso l'antropologia
sociale, la quale già faceva parte dei miei studi di primo anno
all'università di Cambridge. Così, l'anno dopo la laurea, ho
iniziato a studiare il folklore greco all'Università di Atene. Questo
argomento, legatissimo alle esigenze politiche del nazionalismo
greco (sviluppato al diapason sotto i colonelli), mi è servito anche
per un Master all'Università di Birmingham, dove ho studiato con
la professoressa Margaret B. Alexiou. In seguito, questo percorso
un po' complesso mi ha portato ad Oxford, dove, dopo un primo
anno e mezzo passato sotto la tutela dei professori Ravindra K.
Jain (indiano d'origine ed un'eccellente insegnante), e il famoso
sinologo Maurice Freedman, ho finalmente cominciato a lavorare
presso il "decano" degli specialisti della Grecia moderna J. K.
Campbell. Quest'ultimo, che per me è stato il punto d'attrazione
principale ad Oxford e che a mio parere è lo studioso che ha
creato il modello ideale per trasferire lo sguardo etnografico di
Evans-Pritchard dall'Africa ad una società emarginata in Europa,
è stato uno delle presenze più importanti nella mia vita. Se da un
lato, la sua prospettiva mi è servita da modello in tanti aspetti del
mio percorso intellettuale, egli è anche sempre stato aperto alle
modifiche che proposi, modifiche a volte inevitabili nello
sviluppo della forma e del contenuto degli scritti etnografici. È
stato un vero amico: tollerante, critico, generoso.
I - Il metodo comparativo è un elemento centrale dei suoi lavori
etnografici, vorrebbe approfondire questo aspetto?
H - Per molti anni sono stato dell'opinione che difficilmente un
antropologo potesse fare ricerca in diversi paesi, in primo luogo
per la difficoltà di poter padroneggiare due, tre, o più lingue
differenti. Ma non solo, vi è inoltre la difficoltà di tenere in
considerazione una bibliografia sempre più ampia e di acquisire
quel tipo di intimità con la gente, che per me è il presupposto di
un etnografia degna di questo nome. Questa combinazione di
fattori permette, in un certo senso, di evitare un pericolo
abbastanza comune, quello della superficialità. Ma alle volte,
impedisce all'antropologo di aprirsi a nuove esperienze e dunque
lo costringe ad evitare l'esperienza diretta della comparazione
vissuta. Quello che ho scoperto negli ultimi anni è che il rischio
di superficialità non è superiore a quello della chiusura
intellettuale, per cui ho iniziato ad espormi a nuove esperienze di
terreno e, per buona fortuna, sono riuscito a trovare certi punti
interessanti di comparazione in questo senso. Il percorso
comunque non è mai stato ovvio o facile, e, infatti, credo che un
antropologo debba essere sempre aperto all'imprevedibilità del
proprio mestiere, che è davvero una delle sue caratteristiche più
eclatanti. La mia esperienza personale fornisce un esempio
chiaro. Uno dei motivi per cui sono diventato antropologo era il
mio interesse per la Grecia e per molti anni ho pensato di
continuare a lavorare esclusivamente su quel campo, affrontando
diverse questioni. Tuttavia, essendomi formato in una scuola
molto comparativa, quella di Oxford, avevo avuto la possibilità di
leggere molte etnografie di altre culture (ho studiato ad esempio
l'etnografia indiana con Jain), e, ad un certo punto, ho voluto
provare a cambiare terreno di ricerca, sempre in una prospettiva
comparativa. In qualche maniera, il salto più facile era quello di
venire in Italia, innanzitutto perché conoscevo già la lingua
italiana, ed inoltre, perché così sarei stato in grado di paragonare
due grandi paesi dell'antica Europa (e specificamente quelli che si
vantavano di essere i paesi di cultura detta "classica"). Ero già
interessato agli effetti dell'ideologia neoclassica in Grecia, grazie
a quell'esperienza all'Università di Atene che ho appena
menzionata, e volevo studiare come era vissuto, in Italia, il
legame con il passato classico per osservare quali erano gli effetti
sulla vita quotidiana e comparare tali aspetti alla realtà greca. Ho
scoperto, non direi inaspettatamente, che tali effetti erano in realtà
molto diversi nei due paesi, in parte, perché il nazionalismo in
*L’intervista, a cura della redazione, è stata condotta in italiano nel luglio 2005. Il dialogo col prof. Herzfeld è continuato anche nei mesi seguenti
3
Grecia e in Italia ha sempre giocato un ruolo diverso. La Grecia è
un paese molto unito dove, per esempio, l'idea che si possa parlare
un dialetto nella capitale appare come una cosa strana, mentre a
Roma si parla "romanesco", che rimanda ad un senso di identità
locale, regionale che a volte sembra più forte di quello nazionale.
Quindi, ero interessato a rintracciare l'origine e gli effetti sociali
di questa differenza tra le due popolazioni e questo rappresentava
per me il primo "salto". Essendo stato addestrato ad un
comparativismo molto strutturale, per cui cercavo sempre gli
aspetti formali che consentivano di paragonare un gruppo ristretto
di casi (come ad esempio tre paesi rurali greci dove le "regole"
dell'eredità
seguivano principi strutturalmente comuni),
cominciavo a vedere che il metodo comparativo poteva divenire
anche uno strumento per riflettere sul nostro coinvolgimento
come rappresentanti di una certa cultura, o di un gruppo di
culture, nell'ambito di quella studiata, per poi analizzare le
reazioni culturali provocate da tale coinvolgimento diretto.
Quando ero studente non si parlava ancora di riflessività come si
fa ora, il comparativismo era da considerarsi, più o meno, un
modello scientifico in senso stretto. In passato molti ritenevano
che il comparativismo fosse assolutamente e per definizione
incompatibile con la riflessività. Il comparativismo era il prodotto
della scuola strutturale-funzionalista, mentre la riflessività
rimandava alle elaborazioni teoriche post-moderne; io le ho
sempre considerate due facce della stessa medaglia. Quando
paragoniamo una cultura ad un'altra dobbiamo considerare che in
tale comparazione entrano in gioco anche certi presupposti che
risalgono alla nostra formazione culturale; c'è sempre, in maniera
più o meno esplicita, una base di comparazione che risale alla
propria esperienza. Fare etnografia in Italia era quindi anche un
modo per utilizzare il metodo comparativo secondo una
prospettiva diversa, in un certo senso più aperta. Devo dire che
all'inizio avevo abbastanza paura di lavorare in Italia. Come ho
già detto, conoscevo già la lingua italiana, ma fino a quel
momento l'avevo sempre associata ad esperienze personali quali
l'amicizia, il turismo, e l'opera (sono un verdiano pazzo!), ma non
al lavoro sul campo, che fino ad allora avevo sempre associato
alla Grecia. Una volta giunto alla conclusione che lavorare su più
campi fosse non solo possibile ma molto stimolante, divenne
realizzabile anche l'idea di andare ancora più "lontano", sia
geograficamente che culturalmente. Nel 1997 mi trovavo ad un
convegno ad Hong Kong e decisi di visitare un vecchio amico in
Thailandia, anche lui un professore, un politologo. Una volta là,
ho cominciato a parlare con vari colleghi ed ho iniziato ad
elaborare l'idea di poter fare ricerca anche in quel paese. Sapevo
che nella mia università vi era un corso di lingua thailandese e al
mio ritorno negli U.S.A. iniziai a studiarla. L'esperienza
thailandese è stata un'avventura intellettuale e personale molto
interessante e preziosa.
tipo di comparazione in un certo senso "convenzionale",
confrontando, per esempio, differenze tra sistemi di parentela,
trasmissioni di nomi e trasmissioni di beni tra vari paesi rurali in
Grecia, come ho già accennato. In un secondo momento,
spostando l'attenzione su questioni di ideologia, e sull'identità
greca, mi sono reso conto delle implicazioni legate all'influenza
occidentale ed ho cominciato a cercare di comprendere gli effetti
di quel rapporto ineguale tra la Grecia e i suoi cosiddetti
"protettori occidentali". Ho anche comparato la prospettiva di un
antropologo rispetto a quella di uno scrittore di romanzi come il
cretese Andreas Nenedakis, - figlio di un commerciante i cui
parenti erano pastori di un paese di montagna; lui era cresciuto a
Rethemnos, dove ho fatto delle ricerche etnografiche estese, e poi
vissuto in altre città che conobbi anch'io - di cui ho pubblicato una
"biografia etnografica" nel 1997, proprio per mettere in
discussione comparativa il rapporto tra i due tipi di scrittura.
Queste prime mosse mi hanno portato ad essere forse più
sensibile ai problemi di una Thailandia che mentre si vanta di
essere sempre stata indipendente e di non essere mai stata
colonizzata, nella realtà storica ha sempre subito il controllo dei
vari poteri occidentali sia a livello culturale che a livello
economico e politico. Infatti la Thailandia non è mai stata invasa
militarmente, ma ha dovuto, per esempio, cedere molti territori ai
britannici e ai francesi. L'aspetto che forse mi interessava di più
era il fatto che, come anche in Grecia, l'esigenza di dover creare
un senso di identità nazionale avesse seguito linee molto precise;
l'idea di stato nazionale ha un passato ben preciso, una
storiografia nota. Penso che sia la Grecia che la Thailandia siano
esempi di paesi costretti ad accettare un determinato modello di
stato nazionale, che ho chiamato "crypto-coloniale".
Naturalmente, come antropologo, sono sempre stato interessato a
vedere quali fossero gli effetti di questa situazione nella vita
quotidiana. Lasciamo ai politologi ed agli storici gli aspetti
formali e strutturali di questo tipo di dipendenza; noi analizziamo
gli effetti sulla vita quotidiana per poi vedere come potrebbero
avere nuove conseguenze, di seguito, sul percorso della cultura e
della politica nazionale.
I - L'attenzione verso i piccoli gesti, le parole, le
microinterazioni della quotidianità, che riteniamo uno degli
aspetti più interessanti del suo lavoro, può comportare il rischio
di perdersi nella frammentarietà delle realtà sociali. Qual è la
sua opinione in merito?
H - Mah, senta, penso che gli altri scienziati sociali (politologi,
sociologi, ecc.) facciano sondaggi e indagini a livello molto
generale. Questi ci forniscono anche dati e modelli che possiamo
confrontare con i nostri, ma il grande vantaggio dell'antropologia
è la sua capacità di entrare nell'intimità della vita quotidiana. E
non vi si entra se non si riesce prima a dominare la lingua e a
capire le piccole sfumature che sono i segni di un'appartenenza
parzialmente realizzata anche dall'antropologo. Detto ciò, sono
consapevole dell'insofferenza di molti nel leggere i nostri libri,
perché spesso ritenuti troppo dettagliati; non hanno la pazienza di
applicarsi ad una lettura attenta di questi dettagli. Anche questo
I - Esiste, a suo avviso, un limite alla comparazione?
H - Penso che la comparazione risalga sempre ad interessi
preesistenti. Io per esempio ero interessato alla Grecia per diverse
ragioni ed ho cominciato a fare ricerca. Inizialmente facevo un
4
fatto può servire da punto di provocazione, per chiedere perché la
gente accetti di essere talmente conforme e passiva. Le nostre
indagini potrebbero aiutare a rompere quest'egemonia della
cosiddetta "semplicità", che, al fondo, è tutt'altro che semplice
poiché rinchiude l'immaginazione pubblica in forme determinate
e determinanti. Io personalmente preferisco i dettagli di vita
quotidiana a quei listini di cifre infinite e non penso che siano
meno "scientifici". Per la maggior parte le nostre testimonianze
non sono statistiche, non sono sondaggi di grandi proporzioni. La
loro profondità risale al fatto che conosciamo la gente in tutti i
piccoli gesti, come dice lei giustamente. Per cui, secondo me,
un'etnografia priva di questo tipo di informazioni non vale la pena
di essere letta, perché il lettore non ha altri appigli per poter
cogliere il senso di appartenenza degli individui alla comunità. Il
lettore ha bisogno di essere rassicurato che l'antropologo sappia
certe cose. Questi dettagli sono l'unica garanzia che l'antropologo
può dargli, ma a prescindere dall'importanza di convincere il
lettore, c'è anche un aspetto scientifico da considerare. Io, come
ben sa, ho parlato molto spesso di quella che definisco "intimità
culturale"; quando cominciamo ad indagare su una cultura diversa
dalla nostra c'è sempre qualcuno che non vuole che entriamo nei
"luoghi segreti" di quella cultura, o che ci accetta solo se siamo in
grado di dimostrare una certa competenza culturale. E quella
competenza, secondo me, risiede esattamente nei dettagli.
società. E non è che il ritratto ufficiale è meno reale di quello
scoperto dall'antropologo. E le dico un altra cosa. Sono due realtà
che entrano sempre in tensione tra di loro e il compito
dell'antropologo è di dimostrare il ruolo della rappresentazione
ufficiale nella vita quotidiana e in quale maniera e per quali
motivi viene contrastata, respinta oppure sostituita da
un'immagine radicalmente diversa a questo livello vissuto.
I - In "Intimità culturale" lei usa il concetto di disemia1…
H - Per certi versi ho preferito mettere da parte il concetto di
disemia. A me non piacciono i modelli formali. In Grecia il
modello della disemia era utile perché la presenza di dualità
formali era riconosciuta dai greci stessi e io volevo solo ribadire
il fatto che questa coesistenza di due sistemi simbolici di
appartenenza non era solo linguistica, ma faceva parte di un
sistema molto più totalizzante, che si rivelava in diversi ambiti di
quella stessa cultura.
I - Oltre all'aspetto dell'ideologia dominante e dell'intimità
culturale, l'etnografo dovrebbe secondo lei indagare anche la
dimensione individuale?
H - Guardi, non sono uno psicologo e non sono intenzionato a
diventarlo. Rispetto questo ambito scientifico, ma ciò che
realmente mi interessa è vedere come la cultura si fa e si rifà
tramite la vita quotidiana e non penso che un antropologo sia in
grado di entrare nel pensiero individuale. Ovviamente, il
comportamento degli individui non è assolutamente coerente ed è
interessante vedere in che misura una persona può porsi in certe
condizioni della sua cultura. Per questo motivo, mentre respingo
i modelli deterministici - non sono interessato per esempio a
dimostrare che una certa società segue rigorosamente un sistema
di parentela nella quale non ci sono mai eccezioni, perché non
penso che oggi ci siano molte società di questo genere (non sono
nemmeno convinto che ce ne fossero nel passato, ma questa è
ovviamente una questione empirica alla quale ogni risposta
dovrebbe essere sempre provvisoria, visto che le testimonianze
storiche non sono sempre molto ampie) - penso che comunque,
entrare nel pensiero di una persona è forse un'ambizione troppo
grande per noi. Io, per esempio, ho scritto su soggetti individuali,
penso sopratutto alla biografia etnografica che ho scritto sullo
scrittore cretese già menzionato. In quel lavoro però non parlo
della sua "mentalità", infatti, come tanti altri antropologi, io
respingo l'uso di questa parola: "mentalità". Perché penso che non
serva. E invece penso che quello che l'antropologo può e deve fare
sia di indagare sul modo in cui i modelli individuali vengono
descritti nella società. Non cerco di entrare nella mente di una
persona, che inoltre potrebbe anche essere una persona non troppo
rappresentativa della sua società, ma sono interessato a vedere la
reazione degli altri al suo comportamento, che mi consente di
comprendere anche il livello di tolleranza nei confronti delle
eccezioni. In questo senso, ad esempio, le risposte critiche al
lavoro di uno scrittore ci danno la possibilità di parlare non solo
di rappresentazioni collettive nel senso durkheimiano ma anche
delle variazioni tramite le quali si svolgono le trasformazioni
I - Secondo lei il lavoro dell'etnografo può contribuire alla
costruzione di una storia comune?
H - Penso di si. Perché secondo me, l'etnografia è sempre il frutto
di un negoziato tra l'etnografo e il popolo che studia e quindi fa
parte di una conversazione continua. Devo dire che non sosterrei
mai che un mio libro etnografico possa essere la "parola finale" su
una società. È in qualche maniera una fotografia di quella società
che deve rendere molto chiari i presupposti che mi hanno portato
a concepirla in una certa maniera, per esempio i miei interessi
precedenti, le circostanze del mio arrivo nel paese o nella zona, i
miei atteggiamenti politici, ecc. Un antropologo non è mai neutro
e secondo me pretendere una neutralità inesistente sarebbe
tutt'altro che scientifico. E qui il problema è che molti osservatori
di altre scienze sociali ci rimproverano per il fatto che, in
generale, non facciamo ricerche statisticamente molto raffinate.
Ci sono ovviamente eccezioni. Quello che comunque noi
tentiamo di contrapporre al peso delle prove statistiche è questa
intimità realizzata tramite un lunghissimo soggiorno e tramite
contatti molto intimi con la gente che studiamo. Secondo me, è
possibile fare etnografia in un periodo breve. Non sono
assolutamente convinto che un antropologo abbia bisogno sempre
di fare quell'anno rituale che in qualche maniera è diventato
tradizionale. Però oggi è un po' di moda, anche in altre scienze,
dichiarare che uno studioso sta facendo etnografia, ma quando
vediamo il loro lavoro scopriamo che molto spesso è svolto in
maniera molto superficiale. Per me il criterio più importante della
qualità di uno studio etnografico o del tempo percorso per
completare l'indagine è proprio questa capacità di testimoniare un
intimità che porta il lettore oltre il ritratto convenzionale di quella
5
culturali e per reazione alle quali si può individuare ugualmente le
tendenze conservatrici.
Ma questo non è diverso,
sostanzialmente, dal metodo per cui osserviamo, in un piccolo
paese rurale, il comportamento individuale e le reazioni che
provoca per poi arrivare allo stesso senso flessibile della cultura
locale. L'importante, secondo me, non è di mantenere l'enfasi
tradizionale dell'antropologia sui posti isolati ed esotici. Al
contrario, per certi versi, quell'approccio non serve più, perché
staccato da gran parte della realtà del mondo in cui viviamo.
Dobbiamo piuttosto provare a trasferire tutto quello che consente
metodologicamente all'antropologo di entrare nella vita intima dei
nuovi contesti di vita sociale, perché, altrimenti, finiamo per
lasciare tutto il campo ad un livello di generalizzazione che non
svela nulla dell'esperienza vissuta.
E loro secondo me erano molto felici di questa risposta perché
avevo dimostrato di non essere un ipocrita, uno che prometteva
senza poter capire ciò che diceva. E, in breve tempo, sono arrivato
al punto di volerli aiutare. Oggi, ad esempio, ho spedito una
lettera alle autorità di Bangkok perché c'è una nuova minaccia da
parte delle autorità e mi sento obbligato a dare una risposta, una
risposta che vuole aiutare tutte e due le parti a risolvere il
problema3. Penso che sia anche nell'interesse delle autorità
lasciare questa comunità sul posto. Io, per carità, non voglio
prendere una posizione ostile nei confronti delle autorità, al
contrario. Penso, comunque, che un osservatore straniero possa
offrire una prospettiva che, magari, aiuta a capire meglio qual è il
problema. Secondo me è nell'interesse dello Stato e del Comune
lasciare la gente sul posto, perché questa comunità, che si è molto
compattata durante gli ultimi anni in cui ha lottato per il diritto a
rimanere, ha anche un senso molto forte di obbligo civile, per
esempio, nei confronti del problema della droga che, come lei sa,
in Thailandia è molto serio. Infatti, all'interno della comunità il
problema è stato più o meno risolto. Nel caso che vengano
allontanati, il Comune dovrà affrontare un problema molto serio,
visto che il posto si trova tra le vecchie mura della città e un
canale, un luogo ideale per gli spacciatori. Secondo me,
dovrebbero invece sfruttare la volontà degli abitanti di proteggere
la loro comunità per proteggere anche gli interessi del Comune.
Queste cose, per varie ragioni, sono molto complesse. Io vorrei
sentire anche le ragioni delle autorità. Ovviamente, da cittadino
straniero, non ho il diritto di prendere alcuna iniziativa personale
oltre un certo livello. Penso comunque di poter offrire una
prospettiva aperta e costruttiva per quanto riguarda il rapporto tra
questa comunità e le istituzioni. Secondo certi burocrati, il cui
atteggiamento risale a considerazioni sia ideologiche che
personali, non si tratta di una vera comunità nel senso tradizionale
del termine, sia perché non è nata intorno ad una sola professione,
come accade in certi luoghi in Thailandia, sia perché la gente,
negli ultimi quarant'anni, per lo più, è venuta da varie parti del
paese. Quindi, per certi elementi all'interno del comune, questa
gente non costituisce una comunità vera. Io, invece, provo a far
capire che è una comunità nel senso antropologico e, cioè, che c'è
la volontà di un'esistenza comune; c'è l'esperienza di una lotta
condivisa per il diritto per la casa; c'è anche un desiderio di
rappresentare, nel loro essere uniti, tutta la loro diversità diversità che, infatti, è molto caratteristica della Thailandia come
paese. Ci sono per esempio due case di musulmani in questa
comunità, ci sono persone di origine cinese, ci sono persone le cui
origini risalgono al Nord-Est del paese. Questo lo dico non per
contrastare l'idea che sia una vera comunità, ma al contrario, per
dire che loro hanno costruito un senso comune e un luogo comune
dove abitano, che amano e che vogliono proteggere. Questo
potrebbe essere veramente un punto forte anche nell'interesse
della città. Per cui spero che ci ascolteranno. Non so, non so dire
in questo momento4. Ecco un esempio del tipo di impegno di cui
mi stava chiedendo, delle ragioni e del perché uno fa delle scelte.
Per me la scelta non era la violenza, non era un modo di
manifestare contrario a tutto quello che è legale. Io rispetto le
I - L'antropologo si trova spesso a dover prendere posizioni che
lo costringono ad uscire dalla torre d'avorio nella quale,
secondo alcuni, ha la tentazione di rifugiarsi. Quale è secondo
lei il confine tra ricerca e impegno politico? In che misura
l'advocacy è compatibile con l'antropologia?
H - La ringrazio per la domanda perché mi offre l'occasione di
dichiarare quanto più chiaramente possibile che, per me,
l'antropologia è sempre un impegno politico. Politico non nel
senso di "partitico" ma nel senso di un impegno ad analizzare in
modo critico quello che chiamiamo il "potere". E, visto che
l'antropologo, così come le persone che studia, ha una propria
storia, un proprio percorso che, nel tempo, lo ha portato, in un
certo momento storico, ad incontrare uno specifico problema,
sarebbe secondo me un'ipocrisia non riconoscere il desiderio di
prendere una posizione chiara. Ora, ci saranno anche delle
situazioni in cui non sappiamo come reagire o in cui abbiamo dei
dubbi. Ci sono anche situazioni, però, in cui sentiamo il bisogno
di riconoscere l'importanza della reciprocità. Noi dobbiamo tutto
ai nostri informatori, i quali, se vuole, sono più amici che
informatori. Io ho tanti amici nei posti in cui ho fatto ricerca. Per
cui, quando uno di loro si trova nei guai ritengo che il mio
compito sia anche di aiutarlo quanto più possibile. Secondo me
ognuno deve fare le proprie scelte. Le posso fare un esempio.
Quando ho cominciato a lavorare a Bangkok sulla comunità di cui
ho parlato all'Università di Milano-Bicocca2 , onestamente, non
ero intenzionato a farmi coinvolgere concretamente nei loro
problemi. Ad un certo punto, però, durante un primo incontro, una
signora mi chiese se potevo aiutare la sua comunità. E io ho
risposto quanto più onestamente possibile: "Non voglio darvi una
risposta adesso perché è la prima giornata. In generale, sono
convinto che la gente abbia il diritto di rimanere nelle proprie
case. Sono contrario agli sfratti se non esistono motivi
assolutamente convincenti che li impongono. Pur non essendo un
politico non voglio promettervi un impegno che in questo
momento non so se sarò in grado di mantenere. Però se voi mi
aiutate a raccogliere i dati di cui ho bisogno, per capire meglio il
caso, e se trovo che sono d'accordo con voi, poi vi aiuto molto
volentieri. Tenuto conto delle mie possibilità limitate, in relazione
anche al fatto che sono un cittadino straniero".
6
leggi di un paese, però, allo stesso tempo, il rispetto non vuol dire
accettare tutto quello che ti dicono persone il cui impegno è,
precisamente, quello di proteggere tutto ciò che si trova all'interno
dello stato nazionale e che deve essere sempre nascosto agli occhi
degli stranieri, tutto ciò che costituisce l'intimità culturale nel
senso che ho già accennato. Anzi, quando mi trovo nelle comunità
o nei diversi paesi dove ho fatto delle ricerche, se non sono
d'accordo, il rispetto reciproco implica che io lo dica. E questo si
trasferisce anche nel livello dell'azione politica. Se non sono
d'accordo con la politica del Comune, sapendo pure che l'attuale
governatore di Bangkok è una persona molto in gamba e molto
simpatica, preferisco esprimere il mio parere nella speranza che,
magari, possa essere utile anche per lui.
impegnato non dovrebbe fare l'antropologo. Perché è
un'ingerenza nella vita della gente che studiamo. Per lo più ci
tollerano e alle volte si divertono anche con noi, però se non
prendiamo sul serio l'aspetto politico, l'aspetto dell'impegno,
l'obbligo morale di una reciprocità il più completa possibile,
penso che il lavoro dell'antropologo sia solo tempo perso. E forse
anche una pratica invadente. Invece, uno che è impegnato, uno
che rispetta la gente che studia e usa le sue conoscenze per
riflettere sui problemi del mondo attuale, per tante cose va a
contribuire alla loro soluzione, senza che ciò ci inganni sul fatto
che una soluzione definitiva sia veramente attingibile.
L'antropologia è sempre stata in prima linea contro il razzismo,
contro l'intolleranza culturale e secondo me questo impegno
rimane centrale. Penso che il fatto di aver lavorato, in passato, per
lo più in Occidente, e di lavorare adesso in un paese orientale che
ha subito una grande influenza da quei paesi, mi da una
prospettiva dalla quale posso anche criticare quello che si chiama
"Occidente". E per me, anche questo è importante. Sono molto
grato ai colleghi italiani, agli studenti a cui ho insegnato in Italia,
perché c'è sempre stato uno scambio di idee per me ricchissimo
che mi ha consentito di ripensare anche tutto quello che davo per
epistemologicamente scontato. Quindi, in fin dei conti,
l'antropologo può riflettere antropologicamente anche
sull'antropologia stessa. Questi incontri non sono importanti nel
definire delle prospettive puramente didattiche, ma per riflettere
sulle motivazioni soggiacenti al nostro impegno. Se siamo seri nel
dire che l'antropologia è un impegno politico e morale dobbiamo
sempre cercare di sapere quali sono i motivi per cui siamo
impegnati, provare anche a convincere i nostri interlocutori, in
qualsiasi paese lavoriamo, ad entrare con noi in uno scambio del
genere. Io non vedo una differenza tra intellettuale e gente
comune in questo senso. E posso dire anche che ho imparato forse
più teoria dai pastori poco istruiti che ho studiato a Creta che da
certi professori famosi di antropologia. E non dico questo per
esprimere un qualche disprezzo verso i miei colleghi, al contrario,
penso che forse il compito più importante dell'antropologo sia di
riconoscere tutto quello che abbiamo in comune con gli altri esseri
umani. La capacità di analizzare, di ragionare e di riflettere:
queste capacità sono cose che condividiamo con i nostri
interlocutori. Per cui dobbiamo provare ad aiutarli quando ce lo
chiedono, solo quando ce lo chiedono, senza interferire ad ogni
costo con i loro progetti. Questo è importante.
I - L'antropologo non può essere quella figura di intellettuale
che scardina la rigida separazione tra "persone comuni" e
mondo accademico?
H - Penso di si. Noi siamo coinvolti nella vita delle società che
studiamo. Non le studiamo ad una grande distanza, però,
dobbiamo mantenere una distanza intellettuale. Certo non
abitiamo sempre in una "torre di avorio". Siamo lì, siamo
coinvolti. Poi, in antropologia, nel mondo anglosassone almeno,
c'è la tradizione di scrivere sempre in prima persona - cosa che
agli storici, per esempio, appare ancora oggi abbastanza strano.
Ma è un fatto che rivela chiaramente l'impegno personale di ogni
antropologo. D'altro canto, devo dire, c'è molta teoria anche in
antropologia, gran parte della quale si esprime in una
terminologia piuttosto difficile da capire. Il nostro compito è di
spiegare perché dovrebbero interessarsi all'antropologia. E questo
non è sempre facile. Il fatto che noi studiamo il senso comune di
ogni società vuol dire che noi studiamo le cose che loro danno per
scontate e la cui importanza non sembra quindi sempre ovvia. E
per questo motivo spesso è difficile spiegare ad un non
antropologo perché la nostra ricerca potrebbe avere un interesse al
di là della descrizione di tutto quello che è ovvio. Infatti, quello
che analizziamo è ciò che l'antropologa italiana Silvana Miceli
chiama "l'ovvietà". In un mio libro ho scritto che l'antropologia,
in qualche maniera, può definirsi come lo studio comparativo del
senso comune. Quindi il nostro vantaggio intellettuale è anche il
nostro svantaggio nel senso pratico della politica del significato.
I - In conclusione, vuole aggiungere qualcosa?
H - Senta, sono molto contento di avere avuto questa occasione,
di parlare su cose che per me sono assolutamente centrali. Per me
la cosa più importante è che l'antropologia è una passione, è un
impegno. Secondo me uno che non si sente appassionato e
I - Grazie professor Herzfeld.
H - Grazie a voi e buon lavoro...
7
Principali pubblicazioni di Michael Herzfeld:
Ours Once More: Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece, Austin: University of Texas Press, 1982.
The Poetics of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Mountain Village, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1985.
Anthropology Through the Looking-Glass: Critical Ethnography in the Margins of Europe, Cambridge: Cambridge University Press,
1987.
A Place in History: Monumental and Social Time in a Cretan Town, Princeton: Princeton University Press, 1991.
The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy, Oxford: Berg,.1992.
(Paperback reprint, The University of Chicago Press, 1993).
Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State, New York: Routledge,.1997.
(trad it. Intimità culturale. Antropologia e nazionalismo, L'ancora del mediterraneo, Napoli, 2002.
Portrait of a Greek Imagination: An Ethnographic Biography of Andreas Nenedakis, Chicago: The University of Chicago Press,
1997.
Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society, Oxford: Blackwell; Paris: UNESCO, 2001.
The Body Impolitic: Artisans and Artifice in the Global Hierarchy of Value, Chicago: University of Chicago Press, 2004.
Pagina web
http://www.fas.harvard.edu/~anthro/social_pages_herzfeld.html
8
Transazioni della politica e declinazioni di "nazione"
Mafia siciliana e yakusa giapponese tra società tradizionale e stato moderno
di Rossana Di Silvio
"…Perché è necessario dire che non esiste né può esistere
una mafia individuale; la mafia traduce un istinto sociale,
è essa stessa organismo sociale. E la sua forza risiede tutta
qua: che non c'è il mafioso come individuo, ma il mafioso,
come dice il gergo, amico degli amici."
Pietro Mignosi (1895 - 1937), 1925
Di mafia si è scritto molto e detto ancor di più e questo fiume di
parole sembra, in alcune circostanze, aver oscurato
l'oggettivazione del fenomeno stesso.
L'immagine comune, sapientemente costruita nel tempo dal
discorso mediatico - ma non solo - di un organismo tentacolare,
una "Piovra", che avviluppa nelle sue spire malefiche il corpo
"sano" della comunità civile e dello Stato, ha spesso ottenuto, per
contro, l'effetto di confondere la visuale dell'oggetto, rendendolo
sempre più un'"entità" dai contorni imprecisi.
Tra i tanti aspetti trattati nella letteratura di settore, il binomio
mafia-politica è certamente quello che ricorre più di frequente,
ma anche qui i punti di vista sono talmente abbondanti e variegati
da rendere estremamente difficoltoso individuare una specificità.
Infatti l'intreccio tra mafia e politica si sovrappone e confonde
con l'analisi sociologica dell'ambiente di vita, con l'economia, lo
sviluppo e l'alta finanza, l'amministrazione giuridica e il governo
istituzionale delle aree e dei paesi interessati, e per ognuno di
questi settori è stato analizzato un presunto o documentato
"inquinamento mafioso", riproponendo nel complesso, forse con
un linguaggio più adatto ai tempi, la medesima immagine
pervasiva di una mafia onnipresente ma, proprio per questo,
sfuggente ed imprecisa.
Non è stato facile, dunque, all'interno di una vasta mole di
documentazioni e testi, identificare un "filo del discorso" che
permettesse una riflessione più marcatamente antropologica sulla
natura e sul significato della relazione tra mafia e politica.
In questa ricerca del "bandolo", e dovendo per necessità di spazio
e di finalità tralasciare moltissime argomentazioni sul tema, mi
sono concentrata, come punto di partenza della riflessione, sul
contenuto del testo di Jeremy Boissevan "Friends of friends"
(1973). Il testo, seguendo l'inclinazione etnografica degli anni
'70, maggiormente orientata verso contesti socio-politici
complessi quale quello delle società mediterranee, approfondisce
la logica del rapporto clientelare: una forma di relazione sociale e
politica che, in molti contesti, si presenta come alternativa alla
logica dello Stato razionale di Weber, una logica parallela e
spesso in competizione con lo stesso Stato.
In modo particolare ho trovato interessante, per la riflessione che
intendevo avviare, l'accento posto sulle transazioni tra coalizioni
che l'autore interpreta come risposta di base degli attori sociali
alle spinte dialettiche e processuali che iscrivono la società in un
continuo divenire.
Seguendo l'idea di cercare un riscontro alle sue riflessioni, che
potesse peraltro fornire un qualche abbozzo di risposta al quesito
sulla relazione tra mafia e politica, mi sono trovata a dover
quantomeno delimitare un preciso segmento storico, ma ho anche
ritenuto interessante tentare una sorta di valutazione comparativa
tra due realtà molto distanti geograficamente, storicamente e
culturalmente, come l'Italia, ed in particolare la Sicilia postrisorgimentale e il Giappone a cavallo tra l'Era Tokugawa e la
Restaurazione Meji.
La collocazione storica, dunque, è tra la fine dell'800 e il primo
'900 quando, in entrambi i Paesi, la prospettiva che si va
delineando è il processo di costruzione della nazione.
Tanto distanti per moltissimi aspetti, questi due Paesi sembrano
condividere, nel periodo preso in esame, molti degli elementi che
caratterizzano il percorso di trasformazione dei rispettivi assetti
sociali tradizionali, una trasformazione tanto profonda quanto
repentina.
A partire da un medesimo contesto economico di tipo rurale e da
un'organizzazione socio-politica di tipo "feudale", entrambi si
troveranno a fronteggiare le pressioni della modernità incarnate
dalle spinte egemoniche che provengono dall'esterno, i
piemontesi e gli americani. In entrambi i casi queste spinte
provocheranno cambiamenti sostanziali nei tradizionali assetti
sociali e di potere, ed ogni organizzazione sociale cercherà al suo
interno, nelle proprie risorse culturali, rituali e simboliche, il
modo per avviarsi a questa trasformazione senza essere del tutto
stravolta.
Una di queste strategie è rappresentata da quel particolare
"organismo sociale" chiamato mafia.
Nel suo libro "Friends of friends", Jeremy Boissevan sottolinea
9
come il comportamento sociale quotidiano non possa essere
spiegato esclusivamente in termini di rigido meccanismo dello
scambio reciproco di diritti e obbligazioni moralmente sanzionati,
come vorrebbe la teoria struttural-funzionalista ma che, viceversa,
gran parte delle interazioni sociali vanno viste come transazioni
dinamiche tra coalizioni temporanee. A tal proposito Boissevan
afferma: "Molte interazioni sono transazioni, che non sono la
stessa cosa degli scambi reciproci di diritti e doveri moralmente
sanzionati di cui scrive lo struttural-funzionalismo. Le relazioni
di ruolo appaiono in un continuo fluire, le aspettative di ogni
attore variano a seconda della situazione e delle altre relazioni
che ha in essere. (…) Gli individui in conflitto con altri non
vincono tanto perché sono nel "giusto", (…) ma perché hanno
accesso ad alleanze influenti che possono fare pressione sui rivali
e sui loro alleati. (…) certe persone sembrano ricavare un enorme
potere non dai loro ruoli formali ma grazie a una serie di contatti
accuratamente coltivati e costantemente modificati. (…) le
alleanze sono temporanee, non sono i gruppi "corporativi"
duraturi la chiave della struttura sociale (…). Piuttosto, queste
coalizioni temporanee sembrano giocare una parte
straordinariamente importante non solo nelle attività politiche ed
economiche, ma anche nel quadro delle relazioni sociali
quotidiane."
Possiamo riconoscere nelle azioni interattive degli attori sociali di
cui parla Boissevan un sistema di azione politica.
Secondo Smith (cit. da Balandier, 2000), che ha approfondito il
concetto del politico nelle società segmentarie, la vita politica è
un aspetto della vita sociale, non un semplice prodotto di strutture
specifiche, e l'azione sociale diventa azione politica quando cerca
di controllare o influenzare le decisioni collettive concernenti gli
affari pubblici. I contenuti di queste decisioni variano a seconda
dei contesti culturali e delle unità sociali di riferimento, ma i
processi di cui sono il risultato si situano comunque nel quadro
della competizione tra individui e tra gruppi, e dunque, tutte le
unità sociali coinvolte nella competizione hanno carattere
politico.
In tutte le società, sostiene Boissevan, vi è una competizione per
le risorse, le quali sono spesso sotto il controllo di poche persone
influenti e di potere che formano l'establishment locale. Gli altri
gruppi sociali, che non hanno accesso diretto alle risorse, sono
costretti ad assoggettarsi al/ai gruppi dominanti per ricavarne
benefici ed acquisire maggior potere sulla scena della
competizione, che si presenta comunque asimmetrica e non
paritaria. Infine, la maggioranza delle persone - i poveri, i malati,
spesso i giovani - è esclusa dalla transazione competitiva ma
rappresenta il bacino di reclutamento delle coalizioni tra loro in
conflitto.
In questo quadro, la diversità degli interessi perseguiti e di
utilizzo delle risorse rende l'insieme delle interazioni
estremamente fluido sia nel tempo che nello spazio.
Ciò che emerge in modo chiaro dalla ricerca etnografica di
Boissevan è come gli individui siano imprenditori sociali di sé
stessi attraverso un determinato modo di strutturare ed influenzare
le relazioni interpersonali, come le persone ovunque competano
l'uno con l'altro e cerchino alleanze che li possano aiutare a
raggiungere i propri obiettivi, come le persone siano ovunque
coinvolte in senso politico, attraverso un sistema di amici-degliamici che fa di ognuno il membro di una rete di relazioni
dinamiche che li collega - in modi diversi ma entro i significati
sociali, culturali ed ecologici di appartenenza - a gruppi,
coalizioni, classi ed istituzioni.
All'interno di questo discorso il potere appare come una
particolare categoria dei rapporti sociali.
Per Weber il potere è la possibilità data ad un attore, all'interno di
un certo rapporto sociale, di dirigerla secondo le proprie esigenze;
allo stesso modo, per Beattie (1985) rappresenta la possibilità di
costringere gli altri all'interno di un certo sistema di rapporti tra
individui e tra gruppi, mentre per Smith (cit. in Balandier, 2000)
il potere è la capacità di agire con efficacia sulle persone e sulle
cose, che si ottiene ricorrendo ad una gamma di mezzi, dalla
persuasione alla coercizione. In ogni caso l'esercizio del potere
implica necessariamente una legittimazione pubblica che si
fonderà su un sistema di valori condivisi.
Il potere, ci dice Balandier (2000), è riconosciuto in tutte le
società umane, anche le più semplici e tra i suoi attributi
fondamentali vi è quello di essere sempre al servizio di una
struttura sociale che non potrebbe mantenersi con il solo
intervento della "consuetudine" o della legge. Il potere va dunque
visto come un "meccanismo di difesa" della struttura sociale dalle
sue stesse debolezze, dal momento che esso promuove la
conservazione dello status quo e, se necessario, gestisce quegli
adattamenti che non sono in aperta contraddizione con i principi
fondamentali della struttura stessa.
In particolare il potere politico appare come un prodotto della
competizione, più o meno evidente, tra gruppi, in cui ciascuno
mira ad orientare le decisioni collettive in ragione dei propri
interessi personali, tuttavia è anche un mezzo per contenere la
competizione in modo tale che non assuma proporzioni distruttive
per la struttura sociale.
Dunque, secondo Balandier (2000), il potere politico è "inerente"
ad ogni società, ed "(…) è il risultato della necessità, per ogni
società, di lottare contro l'entropia che la minaccia di disordine".
Per assolvere a questa necessità, ovvero la stabilità sociale, il
potere non sempre ricorre alla coercizione, anzi più di frequente
sono i rituali, le cerimonie, le procedure, ovvero un adeguato
sistema simbolico, a diventare strumento di un'azione politica e
che assicura un periodico od occasionale rinnovamento della
società.
Oltre alle necessità interne, continua Balandier, il potere appare
anche la risultante di una necessità esterna dovuta, in particolare,
al senso di minaccia proveniente dai rapporti con altre società
considerate estranee e ostili. Per fronteggiare questa minaccia,
non solo si tessono alleanze, ma si deve anche esaltare l'unità, la
coesione e i tratti distintivi della società stessa. Sotto questa
minaccia, che può essere reale o presunta, il potere si rafforza
ancor di più: per suo tramite e per tramite dei simboli ad esso
collegati, la società dispone di un mezzo per affermare la sua
coesione interna ed esprimere la sua "personalità".
10
Il potere si presenta dunque con un doppio sistema di relazioni,
l'uno orientato verso l'interno, l'altro verso l'esterno.
Infine, conclude Balandier, una condizione essenziale del suo
manifestarsi è che comunque il potere implica sempre e
comunque una dissimmetria nei rapporti sociali: esso si rafforza
con l'accentuarsi delle disuguaglianze, la cui presenza è
condizione del suo manifestarsi e del loro mantenimento.
seconda metà dell'800, in una Sicilia post-risorgimentale. E' un
termine, oggi come ieri, polisemico, di cui - come dice Giovanni
Falcone (1990) - si è persino abusato in termini descrittivi
nell'indicare contesti, fenomeni, intenzioni del tutto disomogenei
per latitudine e campi d'azione.
In Sicilia, soprattutto negli anni '50-'60 del novecento, il termine
è stato abbondantemente utilizzato, spesso in riferimento a
personaggi particolari, concorrenti o avversari politici, oppure
riferito ad esponenti diversi dell'autorità pubblica. Ma già a partire
da fine '800, ogni operazione di rinnovamento o di semplice
opposizione condotta nell'isola fu veicolata dallo slogan della
lotta alla mafia, il quale divenne
presto una resistente metafora delle
competizioni
politiche
nella
regione, sia da parte del sistema di
governo che dell'opposizione, sino
ad indicare l'immagine di un
mezzogiorno
parassitario
e
corrotto. In definitiva "la lotta
politica ha piegato ai propri fini
uno strumento concettuale già di
per sé molto impreciso" (Lupo,
1996) e l'abuso della parola ha in un
certo qual modo ucciso i fatti: se
tutto è mafia, niente è mafia
(Falcone, 1990).
Quando in Sicilia si comincia a
parlare di mafiosi il termine è, se
possibile, ancora più impreciso, e nei documenti dell'epoca viene
solitamente attribuito sia all'area rurale che a quella urbana. La
mafia appare di fatto una realtà composita in cui s'incontrano
soggetti provenienti da varie classi sociali, dalle più infime alle
più alte, che opera in base a scelte razionali la cui direzione
strategica è nelle mani dei soggetti della classe dominante.
La mafia siciliana
Allievo di Boissevan, che ne curò il dottorato, Anton Block
presenta una ricerca etnografica (1986) in un piccolo villaggio
della Sicilia degli anni '60, i cui
risultati sono raggiunti attraverso
l'osservazione
partecipante
e
l'analisi qualitativa delle interazioni
e delle interpretazioni degli attori
sociali, nonché da diverse fonti
documentarie. L'autore prende le
mosse
dagli
importanti
cambiamenti nei rapporti di potere
tra i diversi gruppi sociali, osservati
nel corso del processo che ha
condotto alla formazione dello Stato
nazionale ed analizza il modello
dinamico processuale, ovvero i
modelli di trasformazione e di
sviluppo nel tempo della struttura
sociale del villaggio e della mafia
nel periodo compreso tra il 1860 e il 1960, a partire cioè dal
momento in cui la Sicilia venne ricompresa entro i confini
nazionali del neo Stato italiano.
Block si concentra in modo particolare sulle condizioni che
permisero ad alcuni individui collocati in specifiche posizioni
dell'organizzazione sociale, successivamente denominati mafiosi,
di inserirsi nei vuoti politici lasciati dallo Stato e dalle istituzioni
e nei vuoti economici createsi tra proprietari del latifondo e
contadini.
L'impostazione e i risultati della ricerca mettono in evidenza
come questa operazione di "imprenditoria sociale" avessero
consentito ai mafiosi di proporsi e comportarsi come una sorta di
mediatori del potere, come intermediari politici, sotto il cui
controllo erano posti tutti i canali di comunicazione del villaggio,
interni ma soprattutto con l'esterno, e come, attestandosi su questa
posizione, essi incrementassero il prestigio e il potere personali.
"Essi si trovano nei punti chiave o di giuntura delle relazioni che
collegano il sistema sociale con l'insieme più vasto. La loro
funzione essenziale è quella di (mettere in contatto) gli individui
che nell'ambito comunitario vogliono consolidare e migliorare le
loro opportunità (…)" (E. Wolf, 1956 cit. in Block, 1986). "…Essi
acquistano potere grazie alla straordinaria facilità con cui
accedono alle informazioni e a potenti personalità che stanno
all'esterno (…)" (C. Tilly, 1967).
Una questione di costume. Leopoldo Franchetti (1993) nella sua
notissima indagine datata 1876, evidenziava come nella
percezione del siciliano medio l'autorità pubblica fosse
inesistente, tanto da ritenere che bisognasse cercare al di fuori i
mezzi per difendere i propri diritti: "(…) poichè l'opinion
pubblica è informata a questo sistema sociale extra-legale, la
massa delle popolazioni ammette, riconosce e giustifica
l'esistenza di quelle forze che altrove sarebbero giudicate
illegittime (…)". Non solo, "(…) questi malfattori, pur sempre
pronti a servire altrui, lavorano per conto proprio (…)" e "(…)
l'organizzazione della violenza, diventata per tal modo più
democratica, è adesso accessibile a molti piccoli interessi (…)
quasi ad ogni ceto e ad ogni classe (…) e si può quasi dire di essa
che è addirittura un'istituzione sociale che, oltre ad essere
istrumento al servizio di forze esistenti ab antiquo, essa è
diventata, per le condizioni speciali portate dal nuovo ordine di
cose, una classe con industria ed interessi suoi propri, una forza
sociale a sé stante (…)". Franchetti parla esplicitamente di
"facinorosi della classe media", da considerarsi una "classe
Una questione di termini. La parola "mafia" compare nella
11
indipendente" che, a seguito dell'abolizione del sistema feudale e
della democratizzazione dell'uso della violenza si era venuta a
trovare nella nuova condizione di assurgere addirittura ad
"istituzione sociale".
fanno riferimento ad una società meridionale semi-feudale, tutta
agraria e latifondista, economicamente e socialmente immobile,
percorsa dal solo fremito di rinnovamento dato dal movimento dei
contadini, dove sembra logico pensare che la mafia valga ad
assicurare la subordinazione dei contadini alla classe dirigente.
Una questione socio-economica. Lo scenario che Block ci In realtà, a cavallo tra l'800 e il '900, i mafiosi più rappresentativi
prospetta nella sua ricerca è proprio quello di una evoluzione, una del modello tradizionale non sono solo ciechi strumenti del potere
transizione storica, sociale e di poteri, a partire dalla realtà del agrario, ma sono già organizzatori di cooperative, mediano i
latifondo feudale siciliano.
trasferimenti di terre dai grandi proprietari ai contadini: non
La terra, nell'economia agricola della Sicilia dell'epoca, era intesa appaiono guardiani, ma "becchini" del feudo. Allora, si domanda
come bene fondamentale, mezzo di produzione e di conseguenza Lupo come mai il contesto universalmente richiamato è quello del
principale risorsa politica e fonte di potere. Il prevalere del latifondo quando si può facilmente osservare, all'origine, la
capitalismo della rendita, ovvero la trasformazione in senso compatibilità tra mafia e frantumazione del possesso fondiario, tra
commerciale e di profitto delle originarie pretese feudali sul mafia e grado elevato di integrazione con i ricchi mercanti
reddito prodotto da contadini ed artigiani, scoraggiava gli nazionali ed internazionali nella Sicilia mineraria dello zolfo e
investimenti a lungo termine, ma le numerose riforme agrarie, nelle aree costiere del palermitano e del trapanese, settori di
avviate dai Borboni e proseguite fino agli anni '50 del novecento, grande dinamismo economico? Sembra, afferma Lupo, che gli
avevano lasciato il latifondo sostanzialmente inalterato (Santino, studiosi siano affascinati dall'esotismo dei contesti rurali e
2004). I proprietari, spesso residenti in città anche molto lontane, primitivi, dimenticando la capitale dell'isola e la sua campagna
reclutavano tra i contadini figure "che sapevano farsi rispettare", urbanizzata: la Conca d'Oro palermitana, vero centro di residenza
per amministrare le terre,
della mafia, quella leggendaria
proteggerle dai briganti, punire i
del primato criminale (Cutrera,
ladri e gli sfaccendati e riscuotere
1900).
i profitti. Questi arruolati
In questa area palermocentrica a
divennero così "imprenditori
cavallo tra città e campagna, ma
contadini": gestivano le tenute
anche nelle borgate e nei paesi
del padrone ma manipolavano
periferici, si riscontrerà infatti
anche persone, nella fattispecie i
una sconcertante continuità dei
contadini, e risorse alla ricerca
gruppi, dei luoghi, delle
del
profitto
personale,
esperienze
e
dei
settori
sottoponendo i riottosi con l'uso
d'intervento mafiosi (Lupo,
della violenza.
1996). Qui i gruppi mafiosi
Ancora Franchetti sottolineava la
daranno luogo ad un sistema di
sostanziale differenza tra mafia e
controllo del territorio che, a
L’entroterra palermitano
brigantaggio o delinquenza
partire dalla fitta rete delle
comune che, date le condizioni economiche e la confusione socio- guardanìe, arriveranno a filtrare i traffici leciti ed illeciti
politica dell'epoca, erano molto diffuse. La mafia, sosteneva, non dell'intera zona.
può che essere nelle mani di persone della classe media e La spiegazione del fenomeno fondata sull'arcaismo sociocomunque dotate di capacità non comuni, "(...) a quelle deve la economico, ovvero l'equazione mafia = latifondo, come peraltro
sua organizzazione superiore, l'unità dei suoi concetti, la sul suo corrispettivo socio-culturale, ovvero comportamento
costanza dei suoi modi d'agire, la profonda abilità colla quale sa mafioso = antropologia dei siciliani/meridionali (secondo i
voltare a suo profitto perfino le leggi e l'organizzazione classici e diffusi stereotipi), non informa né sulla diffusione del
governativa dirette contro il delitto, (…) la costanza con la quale fenomeno mafioso nel passato, né sulla sua pervasività in tempi
osserva quelle regole di condotta che sono necessarie alla sua più recenti, peraltro proprio in coincidenza con la
esistenza. (…) è il capo-mafia che dà alla mafia la sua apparenza modernizzazione del Paese.
di forza ineluttabile e implacabile, regola la divisione del lavoro
e delle funzioni, la disciplina tra gli operai di questa industria, Una questione politica. Forse, suggerisce ancora Lupo,
disciplina indispensabile in questa come in ogni altra per ottenere bisognerebbe provare a distinguere il fenomeno dal suo contesto,
abbondanza e costanza di guadagno." (Franchetti, 1993). Così, indagando il modo con cui l'organizzazione mafiosa si appropria
rispetto ai "facinorosi di classe infima", il capo mafia svolge, dei codici culturali, li strumentalizza, li modifica, ne fa un
nell'industria della violenza, la parte del capitalista, collante per la propria tenuta. Si pensi ad esempio al rifiuto del
dell'impresario e del direttore (Santino, 2004).
concetto dell'impersonalità della legge, al disprezzo per gli
Tuttavia, Salvatore Lupo (1996) critica l'intera prospettiva di "sbirri" e per chi con essi collabora, tratti certamente molto diffusi
contributi, compresi quelli di scuola socio-antropologica, che tra gli appartenenti ad ogni ceto nella Sicilia otto-novecentesca,
12
ma che dalla mafia vengono riutilizzati secondo proprie finalità.
L'utilizzo di relazioni personali a fini particolaristici è tipico della
Anche in tempi moderni e pur in contesti diversi, la mafia ha relazione tra patrono, che detiene un controllo più o meno lecito
sempre fornito di sé una sola immagine: non delinquenza, ma su una determinata risorsa, e uno o più clienti che si rivolgono a
rispetto della legge dell'onore, difesa di ogni diritto, protezione lui per ottenerne un utilizzo a proprio vantaggio, obbligandosi
dei deboli, grandezza d'animo. Dunque è innanzitutto la mafia a verso il patrono a ricambiare, in vario modo, il favore ricevuto. Il
descrivere sé stessa come costume e come comportamento, come rapporto clientelare sarebbe tipico di una situazione pre-moderna,
espressione della società tradizionale, fornendo un mito, ed infatti denuncia, di per sé, l'assenza o la debolezza del capitale
costruito, in contrapposizione (ma opportunisticamente sociale come bene pubblico.
dialogante) ad un ordine statuale invadente ed alieno. Ogni Tuttavia, questa considerazione sembra contraddetta
mafioso ci tiene a presentarsi nella veste del mediatore e del dall'esperienza giapponese e dallo sviluppo delle società asiatiche
pacificatore di controversie, ostentando una "giustizia" rapida ed in genere, dove elementi anche sostanziali di familismo e
esemplare.
particolarismo hanno convissuto con una modernizzazione
Un gruppo di potere, dunque, che esprime una propria ideologia accelerata.
anche attraverso aspetti simbolici e rituali, e con la quale intende
creare consenso all'esterno e compattezza all'interno; un gruppo, Tra governo e Stato. Pietro Mignosi (1925), poeta ed illustre
seppur non centralizzato, che fa forza sul medesimo capitale letterato della Sicilia del primo '900, nel tratteggiare in modo
sociale, quello della reputazione e della rete di
acuto e quasi doloroso le condizioni più
relazioni (Gambetta, 1992).
profonde dell'essere e del sentire politico del
Secondo Coleman (1990), "il capitale sociale
siciliano di inizio novecento, afferma che
è definito dalla sua funzione (…), il capitale
l'aver individuato la mafia come organismo
sociale è produttivo, e rende quindi possibile il
tipicamente sociale, "(…) ha creato l'altro
conseguimento di obiettivi che altrimenti non
mito, della mafia come associazione a
sarebbero raggiungibili (…), il capitale
delinquere", un equivoco estremamente
sociale non è completamente fungibile, ma lo
pericoloso, a parere suo, dal momento che le
è rispetto a determinate attività (…), il
misure di contrasto e di risoluzione sono state
capitale sociale è contenuto nella struttura
affidate alla "(…) intelligenza, perizia e
delle relazioni tra le persone".
solerzia del funzionario (…)" senza che la
Il mafioso fin dalle origini vende un "bene"
mafia perdesse alcunchè della sua potenza.
specifico, la protezione, in un contesto storico,
Ma la mafia, sottolinea Mignosi, "(…) non è
quello siciliano (o meridionale in genere) in
né una forma animi, né un'associazione a
cui difetta la fiducia (Gambetta, 1992).
delinquere: essa è l'innuclearsi e
Ma tanto nella Sicilia post-risorgimentale
l'organizzarsi spontaneo di quello stato
quanto in situazioni più recenti, la mafia
refrattario della popolazione siciliana,
Luciano Liggio
"d'ordine" presuppone sempre un disordine da
refrattario ad intendere le profonde ragioni
organizzare e da tenere sotto controllo, anzi è proprio la mafia a dell'unità e della centralità dello Stato". Di questo Stato come
creare l'insicurezza di cui usufruisce, sicché si può dire che la sua confluenza dei valori etici e giuridici, continua Mignosi, vi è tra
unica funzione sia quella che essa stessa determina (Lupo, 1996). tutti i siciliani una nozione "oscura ed approssimativa", che non
In una situazione di legalità debole, ovvero quando norme e riesce ad adeguarsi allo Stato in atto. Il borghese o il contadino
politiche pubbliche sono ritenute già in partenza inefficaci, siciliano "(…) non intendono né possono intendere lo Stato se non
distorte, eludibili, oppure rivolte a coalizioni ristrette, la creazione nell'appariscente e mutevole prassi di governo", un governo nella
o il mantenimento del capitale sociale come bene pubblico non è sua "sovrana ed irrazionale mobilità continua", di cui il siciliano
favorito mentre, viceversa, la carenza di bene pubblico favorisce ha un'atavica esperienza, un governo che sente non come
il mantenimento di una legalità debole (La Spina, 2005).
espressione di una logica razionale ma come volontà di una
E' in questi casi che si rafforzano gli investimenti verso persona, che tuttavia non è la legge, in cui comunque non avrebbe
l'accumulazione di capitale sociale di tipo particolaristico che dà fede perché non ha fiducia nelle persone. Il siciliano "(…) non
luogo ad una struttura sociale dominata da sfiducia orizzontale e intende lo Stato perché sente il governo", sostiene Mignosi, e
sfruttamento/dipendenza verticale (Putnam, 1996).
"(…) di contro al doloroso scorrere delle dominazioni
Lo stesso Block (1986) illustra la formazione e la dissoluzione governative in Sicilia (romani, barbari, greci, arabi, normanni,
delle potenti famiglie mafiose come un continuo processo tedeschi, francesi, spagnoli, austriaci, borboni, italiani) si è
conflittuale per l'accaparramento delle risorse (gabelle), da cui spontaneamente costituito un nucleo organizzativo di Statoemerge una rete caratteristica con forti accenti sulle relazioni tra morale. Non ha assunto mai forme chiare definitive, ma ha
cognati, affini, amici, patroni e clienti, dove una particolare mantenuto sempre una efficienza reale ed un reale dominio. La
amicizia, funzionale, strumentale ed asimmetrica, interseca le mafia è l'istinto dello Stato ed è, naturalmente, una oscura pratica
divisioni tra classi e sfocia nel clientelismo del patronage.
di governo (…)". Il governo esterno, "lu cuvernu", è per il mafioso
13
siciliano il massimo termine di arbitrio; ecco perché l'uomo
d'onore, in cui Mignosi sembra ravvisare l'animale politico in
senso aristotelico, "(…) così scrupoloso nell'adempimento di
quelli che crede i suoi doveri, non piglia mai sul serio le funzioni
dell'amministrazione e del controllo statale, ma ama eluderle,
neutralizzarle, renderle, per quanto è possibile, inefficaci". E' per
questo, continua Mignosi, che il mafioso va alla conquista delle
cariche politiche e delle istituzioni, non perché crede nello Stato,
che anzi sente pesare sulle spalle, quanto per neutralizzarne la
potenza in modo da sentirsi più libero "(…) nell'esplicazione del
suo mandato reale". In questo senso il mafioso è apolitico, ed
"(...) è nella apoliticità della mafia che va ricercato il significato
stesso della mafia".
nel tempo, all'incirca nella seconda metà del '600, in piena Era
Tokugawa, quando le principali e frequentate vie di
comunicazione del Giappone avevano visto nascere numerose
stazioni di posta in cui svolgevano la loro attività illegale, seppur
incontrastata, i bakudo, giocatori d'azzardo che "ripulivano" i
numerosi viaggiatori.
Il termine sembra sia da attribuire ad un particolare gioco delle
carte, la cui mano perdente era appunto detta ya-ku-sa. Il
significato, come spesso accade, travalicò i confini specifici della
sua origine fino ad indicare, per estensione, i biscazzieri stessi, o
più in generale "cosa di poco valore, indegna, persone inutili alla
società" (Flore, 2001). Nel tempo, la parola finì per indicare sia i
bakudo che i tekiya, i venditori ambulati, anch'essi personaggi
socialmente marginali, tendenzialmente girovaghi di territorio in
territorio a seconda del calendario delle fiere, dediti al raggiro
commerciale.
La yakusa giapponese
La yakusa o mafia giapponese entra in scena nel mondo
occidentale alla fine degli anni '70 a seguito di un casuale
resoconto di polizia al Dipartimento di Giustizia americano alle
Hawaii. Prima di allora la situazione e la natura della criminalità
organizzata in Giappone era del tutto sconosciuta e di scarso
interesse per l'informazione mediatica dell'occidente.
Tuttavia, nel corso degli anni '80 le informazioni si fanno più
precise e risulta immediatamente evidente che il fenomeno
criminale si presenta in termini complessi e del tutto nuovi.
Ciò che sorprende gli occidentali sono soprattutto due elementi: la
straordinaria politicizzazione della yakusa e la sua
istituzionalizzazione nel corpo della società giapponese in
generale, e nei suoi apparati politici in particolare.
La storia moderna della yakusa è strettamente legata alla storia
dell'estrema destra giapponese, un gruppo di attivisti fanatici
dell'imperatore che fu la forza motrice dell'ascesa del fascismo
nazionale e dell'espansionismo militare pre-bellico.
Sebbene oggi questa componente sia meno potente di un tempo,
il suo peso è ancora consistente e la coalizione composta da
attivisti e yakusa, spesso indistinguibili tra loro, ha operato come
forza paramilitare al servizio del partito liberal-democratico
giapponese, che ha esercitato un dominio pressoché ininterrotto
sulla politica nazionale del dopoguerra.
L'attività politica della yakusa ha influenzato nel corso degli anni
numerosi eventi critici del Paese, veicolata da un sistema
clientelare profondamente radicato nella società giapponese.
Da queste sintetiche notizie iniziali sembra che yakusa e mafia
siciliana abbiano veramente ben poco in comune riguardo al ruolo
sociale e all'azione politica giocati all'interno delle rispettive
organizzazioni sociali, tuttavia ad un'analisi processuale, seppure
circoscritta entro uno specifico spazio storico, si noterà come
molti elementi riconducano alla medesima matrice delle
transazioni tra coalizioni temporanee.
Una questione di costume. La società giapponese è considerata
una società "collettivista" ed al suo interno è di fondamentale
importanza che ogni individuo occupi il posto appropriato, sia nel
gruppo sociale che nell'istituzione cui è assegnato. Ciò serve ad
identificare sé stessi, una frazione individuale, in rapporto all'altro
e al gruppo inteso come "un tutto organico" (Lebra, 1976). Questa
peculiarità è dovuta principalmente alla diffusione nel Paese
dell'etica confuciana che, a partire dal VII sec., andò fondendosi e
adattandosi alla cultura autoctona di tradizione scintoista.
L'ideologia confuciana assunse un tale peso nella vita e nei
rapporti quotidiani da permeare l'intera vita sociale e le istituzioni
del Paese. Inoltre, con la sua adozione ufficiale da parte dei
Tokugawa, furono fissate le basi di una organizzazione sociale in
cui le relazioni personali erano ampliate e rafforzate,
consolidando una struttura sociale di tipo familistico e dando
luogo ad una rigida stratificazione sociale che perdurò per secoli
(Goode, 1982).
Di fatto, il significato del termine società, così come noi lo
conosciamo, è rimasto oscuro in Giappone fino alla fine dell'800,
quando, con la cosiddetta Restaurazione Meiji e la
contaminazione occidentale, venne adattato allo scopo il termine
"shakai" (Fukutake, 1989).
Nella lingua giapponese, la posizione sociale individuale viene
indicata dal suffisso "bun", che significa "parte", porzione",
"frazione", e potrebbe essere tradotto dal punto di vista
antropologico con il termine "status" e dal punto di vista
sociologico con il termine "ruolo".
Sugiyama Lebra (1976) distingue "status" e "ruolo"
rispettivamente in termini di diritti e prerogative da una parte e
obbligazioni e responsabilità dall'altra.
In tal senso "status" si riferisce ad una posizione entro una
struttura gerarchica, mentre "ruolo" implica una funzione ma non
necessariamente una gerarchia.
"Status" e "ruolo" possono essere interpretati secondo due
prospettive: innanzitutto come concetti relazionali, dove uno
status o un ruolo esistono solo in relazione ad un altro status o
ruolo, oppure possono essere concettualizzati indipendentemente,
Una questione di termini. Quando si parla delle organizzazioni
criminali giapponesi, accade che il fenomeno venga identificato
con l'utilizzo di termini diversi, tra cui il più conosciuto in
occidente è "yakusa". La versione maggiormente accreditata circa
l'etimologia del termine rimanda ad un periodo piuttosto lontano
14
ad esempio in relazione al sesso, all'età, all'occupazione, ecc.
(Lebra, 1976).
Nella società giapponese, generalmente identificata come una
"società verticale", l'orientamento di status, o meglio la sensibilità
all'ordine gerarchico (rango), caratterizza gran parte dei
comportamenti degli individui tanto che, utilizzando i concetti
delle teorie di Bateson (1971) sulla comunicazione interpersonale,
possiamo dire che questa organizzazione sociale ha sviluppato al
suo interno un carattere relazionale fortemente complementare
piuttosto che un carattere simmetrico, tra pari.
Ogni individuo viene educato sin da piccolo ai comportamenti e
allo stile di vita appropriati allo "status" di appartenenza. Un
comportamento, un atteggiamento o una performance ritenuta
incongruente con lo status di appartenenza è fonte di grande
vergogna.
Ruth Benedict, nel suo famoso libro "La spada e il crisantemo",
definì il Giappone la "cultura della vergogna". A questo proposito
Lebra (1976) sostiene che la vergogna è strettamente correlata alla
condizione di "status": da un lato perché i giapponesi tendono
molto ad identificarsi con la propria posizione sociale e ad
ostentarla, dall'altro perché i comportamenti incongruenti
risultano maggiormente visibili nelle posizioni sociali più elevate.
La società giapponese si presenta dunque con una struttura
componenti sono vincolati da solidi legami di interdipendenza,
secondo il tradizionale concetto feudale di "gruppo allargato". La
"feudalizzazione dei rapporti familiari" (Goode, 1982) emerge in
modo evidente nel rapporto oyabun/kobun, tradotto come
rapporto genitore/figlio, ma che in realtà si riferisce al rapporto
protettore/protetto o signore/vassallo: il protetto deve lealtà al suo
protettore il quale, a sua volta, deve protezione e sostegno al suo
protetto.
Parenti e non parenti, ovvero l'intero gruppo di protetti sotto un
protettore, costituiva tradizionalmente il dozoku, il gruppo
familiare, all'interno del quale ogni membro doveva lealtà al capo
della famiglia ceppo, che dispensava loro sostegno e protezione,
e il suo potere e prestigio sociale si misurava dal numero di
protetti o vassalli su cui poteva contare.
Radicato soprattutto tra le casate del latifondo, la IE si configurò
come un gruppo nella cui casa erano accolti un numero
imprecisato di vassalli che in cambio della benevolenza ricevuta
e del conseguente accesso allo "status" del gruppo familiare,
assicuravano al capofamiglia una fedeltà incondizionata. La IE
era un luogo organizzato secondo una rigida gerarchia, dove la
rilevanza dei rapporti personali spesso mettevano in ombra gli
stessi legami biologici, dal momento che tutti i membri erano tesi
al raggiungimento del bene e dell'interesse del gruppo (dozoku)
nel suo insieme.
L'ideologia confuciana fu fatta propria già dai primi gruppi di
bakudo e tekiya che, seguendo il modello della IE, assicuravano
uno status sociale a coloro che ne erano privi, formando
corporazioni compatte e gerarchicamente strutturate, governate
da severe norme comportamentali e dominate da solidi rapporti e
da una forte coscienza di gruppo.
Nel tempo il concetto di IE fu tradotto nel modello della ikka.
Una questione politica. Scorrendo la letteratura sulla comparsa
e il radicamento della yakusa come organismo sociale, non
sfugge la concomitanza con i periodi di grande trasformazione
della società giapponese.
Nel XVII sec. l'ascesa della dinastia Tokugawa diede inizio ad
una serie di cambiamenti politico- sociali di cui risentirono
soprattutto i samurai (dal verbo samurau: servire) che, fino ad
allora, avevano occupato una posizione di prestigio.
Infatti, fin dal VII sec. ed in particolare con l'ascesa della classe
militare e del successivo periodo Sengoku, il periodo degli stati
belligeranti, i samurai venivano reclutati con il compito di
difendere e vigilare i possedimenti dei loro signori, dei quali
diventavano vassalli in cambio di concessioni di terre. Questo
legittimò sempre più il loro potere dando origine a vere e proprie
casate di nobili-guerrieri, i bushi, con un preciso codice di
condotta, il bushido, retto da principi di coraggio, rettitudine,
onore e radicato senso di giustizia e autocontrollo.
Quando il samurai era accolto al servizio dello shogun, il
riconoscimento dello status di "familio" avveniva attraverso il rito
del dono della spada. L'arma, preparata secondo particolari
procedure tradizionali, era carica di simbolismi magici, religiosi e
sociali: era considerata un potente deterrente contro gli spiriti
Rara foto di una cerimonia yakuza
verticale molto rigida e performativa, dalle caratteristiche più
accentuate negli strati sociali di "rango" elevato, dove i concetti di
vergogna, onore e "faccia" sono valori profondamente
incorporati.
In questa società è la famiglia, o meglio la casa, a fornire ad ogni
individuo la posizione sociale appropriata, e colui che, per diversi
motivi, ne fosse escluso, verrebbe automaticamente a trovarsi ai
margini della società, coperto di vergogna, privato dell'onore e
svuotato della sua identità personale.
La IE, termine traducibile in "famiglia" ed identificato con una
"casa", è il modello sociale tradizionale più diffuso e radicato del
Paese, e definisce un gruppo corporativo che risponde ad una
struttura gerarchica molto precisa, all'interno della quale i
15
maligni, in essa era contenuta l'anima e l'onore del valoroso dell'ordine, suscitarono l'apprezzamento dei Tokugawa.
guerriero, identificava immediatamente lo status di appartenenza Caratterizzati anch'essi da forti valori tradizionali, finirono con
e il ruolo sociale ricoperto dal possessore.
l'"accogliere gran parte degli emarginati, dei samurai sbandati e
La forzata pacificazione del paese condotta dai Tokugawa, se da dei disoccupati che popolavano la città" (Flore, 2001), dei quali
una parte aveva parcellizzato gran parte delle terre nobiliari, il capogruppo si prendeva personalmente cura, suscitando la loro
dall'altra aveva precipitato molti samurai, soprattutto coloro che incondizionata fedeltà. Il forte legame tra le parti fece sì che il
non erano stati in grado di trasformarsi in burocrati di prestigio, gruppo assumesse sempre più le connotazioni di una IE, con il
ad una esistenza di precario vassallaggio e di vagabondaggio. tipico rapporto oyabun-kobun tra capo e membri e di fratellanza,
Nacquero così gruppi di hatamoto, gli uomini della bandiera, che secondo l'ordine gerarchico della primogenitura, tra i protetti. Va
si ponevano al servizio dello shogun, verso il quale stabilivano un ricordato che nella società feudale del Giappone del '700, il
legame indissolubile di fedele vassallaggio ricevendone in sistema oyabun-kobun costituiva spesso la base dei rapporti tra
cambio un riconoscimento di status, e gruppi di ronin, samurai maestro e apprendista, tra signore e vassallo e lo stesso avvenne,
senza padrone, che vagavano per il paese
nella nascente malavita organizzata, tra
in veste di mercenari o terrorizzando la
capo e gregario.
gente comune.
Grazie all'appoggio governativo, i
La successiva confisca delle armi e delle
machiyakko estesero la loro influenza su
spade, conseguenza della politica di
territori sempre più vasti, non solo per la
pacificazione dei Tokugawa tesa alla
difesa contro i banditi, ma anche per il
prevenzione di possibili azioni eversive,
reclutamento di manodopera da
non ebbe soltanto conseguenze dal punto
assegnare temporaneamente allo shogun
di vista sociale ma furono soprattutto di
e, nell'immaginario collettivo, il
tipo psicologico. Inoltre la presenza di
machiyakko
diventò
l'eroe
per
una stratificazione sociale congelata, per
eccellenza, la cui fama persiste ancor
cui a nessun individuo era concesso
oggi in numerose leggende del teatro
cambiare la sua posizione sociale di
kabuki che ne esaltano le qualità morali
I sette Samurai (A. Kurosawa)
appartenenza, privò gli hatamoto sia
e le gesta eroiche.
delle terre, anch'esse confiscate, che di qualunque possibilità di L'eredità degli hatamotoyakko e dei machiyakko fu raccolta in
ricollocazione onorevole.
particolare da due nuove coalizioni, dei tekiya e dei bakudo,
entrambe strutturate gerarchicamente e regolate da rapporti
Una questione socio-economica. Gli hatamoto di basso rango e fondati su lealtà e fedeltà incondizionata al capo "famiglia".
i contadini, pressati da imposizioni fiscali sempre più alte, si I tekiya cominciarono ad unirsi in gruppi compatti e ben
riversarono nei nuovi agglomerati urbani all'epoca in forte organizzati nel tentativo di aggirare i divieti imposti dai
espansione, cui si aggiunsero i ronin ed altri sventurati senza Togukawa sull'esercizio del commercio. Il potere esclusivo era
padrone. Tutti questi individui, costretti in un mondo in cui avere nelle mani dell'oyabun e si estendeva sulla zona territoriale di
una posizione sociale riconosciuta era di vitale importanza, si influenza, la cui espansione inevitabilmente conduceva ad un
raccolsero ai margini della società vivendo di espedienti e molti conflitto con il gruppo confinante.
si dedicarono al brigantaggio e al saccheggio. In particolare i figli Attorno alla metà del '700, al fine di contenere sia i conflitti che i
degli hatamoto, senza alcuna possibilità di riconquistare la disordini che li accompagnavano, il governo riconobbe agli
posizione originaria, si ritrovarono in gruppi compatti e oyabun una sorta di legittimazione del loro operato territoriale.
vagabondi, le ikka, dediti al brigantaggio o, in alcuni casi, Tale riconoscimento ufficiale consentiva loro l'attribuzione di un
ponendosi a difesa di poveri contadini che li assoldava contro i nome di famiglia e il privilegio di portare la spada che, in quanto
medesimi banditi.
simbolo di status sociale, li collocava di poco al di sotto dei
Akira Kurosawa, il grande cineasta nipponico, ne ha samurai. Allo oyabun fu affidato il controllo sui mercati e sulla
mirabilmente tratteggiato le figure nel suo "I sette samurai".
raccolta delle tasse, dalle quali tratteneva una percentuale come
Questi samurai itineranti erano conosciuti in tutto il paese come compenso dell'impegno svolto; inoltre era chiamato a svolgere
kabuki-mono, personaggi eccentrici con aspetto, abbigliamento e funzioni di vigilanza e di mantenimento dell'ordine nel proprio
linguaggio caratteristici, che percorrevano le strade in piccoli territorio.
gruppi in cerca di malcapitati da depredare, sentendosi tuttavia Col tempo i tekiya abbandonarono l'itineranza e diversificarono
custodi dei valori tradizionali del rango di appartenenza.
gli affari: commerci criminali celati dietro attività legali,
I cittadini, stanchi delle loro angherie, si unirono in solidi gruppi protezione in cambio di denaro e detenzione di armi.
di difesa. Di estrazione sociale completamente diversa, in Anche i bakudo accoglievano individui socialmente emarginati ed
prevalenza impiegati, commercianti e artigiani, adottarono il erano organizzati in gruppi molto coesi, ma pur in presenza di
nome di machiyakko, servitori della città, e le loro imprese competizione per il territorio presentavano un grado maggiore di
"cavalleresche", ma soprattutto il loro contributo al mantenimento collaborazione o di mutuo soccorso rispetto ai tekiya.
16
Così, verso la fine dell'Era Tokugawa, nella seconda metà
dell'800, le strade del Giappone erano percorse da bande di
yakusa al cui interno avevano trovato un ruolo ed uno status
biscazzieri, venditori itineranti, gruppi di machiyakko, cui
l'appartenenza "di famiglia" conferiva un'appropriata
collocazione. Le attività tradizionali riguardavano il gioco
d'azzardo, la frode commerciale e il reclutamento familistico di
manodopera affidabile e a basso costo pronta per essere utilizzata
nel processo di modernizzazione del paese che all'epoca muoveva
i primi passi.
I gruppi yakusa erano a quel punto perfettamente radicati nel
tessuto sociale come portatori e difensori dei valori tradizionali, in
una società che i più percepivano confusa e in profonda
trasformazione.
Tra governo e stato. I Tokugawa adottarono una serie di misure
che portarono alla costruzione di un apparato regolato da rigide
norme di comportamento che ne assicurarono la stabilità per più
di due secoli.
La riorganizzazione del territorio fu accompagnata da un
complesso sistema di controlli volti a d arginare qualsiasi
tendenza destabilizzante. Tuttavia il dilagante malessere popolare
diede vita a frequenti ribellioni che non era possibile fronteggiare
con l'esiguo esercito di cui il governo si era dotato a seguito della
smilitarizzazione e della pacificazione del paese. Cominciò così a
delinearsi la necessità di ricorrere ad una stretta collaborazione tra
istituzioni e gruppi di fuorilegge, gli unici che avevano mantenuto
l'arte delle armi.
Come dicevamo, già alla metà del '700, ai gruppi tekiya era stato
riconosciuto e legittimato l'esercizio della funzione esattoriale e di
vigilanza e polizia nei rispettivi territori.
Le disposizioni introdotte nel 1806 dal nuovo Codice Penale
istituirono un gruppo itinerante di ufficiali di polizia governativa
che strinsero accordi con i bakudo per avere informazioni sui
ribelli ed appoggio sul territorio, in cambio di una non ingerenza
nei traffici illeciti, opportunità di cui i gruppi approfittarono per
rafforzarsi sia sul piano economico che politico.
Tra il XVII e XIX sec. la società giapponese presentava molte
condizioni favorevoli allo sviluppo di una coscienza nazionalista.
La netta conformazione dei confini, la struttura sociale
rigidamente ordinata e il secolare isolamento favorirono una forte
ostilità nei confronti dell'"alterità". Inoltre la riscoperta della
tradizione scintoista, con la divinizzazione della famiglia
imperiale, fu una leva importante contro il potere Tokugawa, che
i più ritenevano illegittimo.
In particolare, nella seconda metà del XVII sec., il pensiero di
Motoori Norinaga contribuì per primo a dare voce ad una
ideologia nazionalista. Nel suo "Kokugaku", Scienza della
Nazione, egli affermava che "la superiorità del cuore giapponese
e la sua purezza poteva essere ritrovato solo estirpando le
influenze straniere, confuciana e buddista, che lo
contaminavano" (Borsa, 1998). Tra il 1740 e il 1800, il suo
discepolo Aizawa Yasushi fornì le basi ideologiche per il
rovesciamento del governo Tokugawa. Il kokutai (nazionalismo)
pensato da Yasushi cambiava la direzione della devozione, non
più diretta al signore feudale, concetto tipico dei samurai, ma
all'imperatore, "genitore di tutti i sudditi" (Flore, 2001). I
Tokugawa cercarono in tutti i modi di impedirne la diffusione, ma
con scarso successo: l'ideologia rinnovatrice ebbe sempre
maggiori seguaci, soprattutto negli strati più bassi della
popolazione.
La questione si aggravò, nella prima metà dell'800, con la
richiesta da parte americana di aprire scali marittimi lungo le
coste giapponesi. Il paese si divise tra modernisti governativi, che
vedevano in questo contatto il definitivo decollo verso la
modernizzazione, e tradizionalisti, sostenuti infine anche
dall'imperatore, che volevano preservare il Giappone dalla
contaminazione esterna. Ma le forti pressioni occidentali
costrinsero all'apertura dei porti, nella autoconsapevolezza
nipponica di una significativa inferiorità militare. Queste
concessioni alimentarono, se possibile, ancor più l'ostilità verso il
governo, dando vita ad una corrente popolare molto agguerrita
che riteneva ineludibile il conflitto con la potenza straniera: un
modo per trovare una soluzione alla secolare frustrazione derivata
da una mobilità sociale inibita, ma anche un'occasione per
defenestrare lo stesso governo.
Riconoscendosi perfettamente negli ideali del kokutai, la yakusa
diede un contributo decisivo alla disfatta dei Tokugawa: fu la
stessa corte imperiale che, in assenza di un esercito preparato,
chiese l'intervento di uomini capaci nelle armi per fronteggiare i
ribelli e ricacciare chiunque fosse favorevole ad una politica di
apertura.
Nel 1867 il quindicesimo ed ultimo shogun Tokugawa si dimise
dando luogo alla cosiddetta Restaurazione o, più precisamente, al
Rinnovamento Meiji, che restituì alla corte imperiale il legittimo
esercizio del potere e che fece "esplodere tutte le energie pratiche
ed intellettuali del paese represse per secoli"(Kaplan-Dubro,
1986).
Tuttavia, come sottolinea Fukutake (1989), la struttura feudale
giapponese era ancora fondamentalmente integra ed il modello
familiare samurai profondamente radicato, continuando a
permeare l'intero corpo sociale.
L'organizzazione sociale, infatti, non aveva ancora del tutto
raggiunto quel punto di rottura con il passato che potesse portare
naturalmente alla nascita di una società capitalistica moderna.
Anzi, la modernizzazione giapponese fu una modernizzazione di
difesa e la Restaurazione Meiji, di fatto condotta sotto il comando
degli ultimi samurai, si palesò come il prodotto di un secolo di
scollamento tra la storia giapponese e quella del resto del mondo,
distorcendo l'essenza dello stesso percorso di modernizzazione.
Infatti, nel tentativo di inserirsi in questa società in veloce
trasformazione, molti bushi sfruttarono l'alto grado d'istruzione e
le capacità organizzative, diventando funzionari statali o uomini
d'affari, altri, i più conservatori, si armarono nel tentativo di
riconquistare i privilegi perduti, tutti si schierarono al servizio
dell'imperialismo, visto al momento come unico argine alla
contaminazione straniera.
I nuovi leader politici, profondamente consapevoli
17
dell'umiliazione di essere stati forzati ad aprire il paese, uomini di mano per i caporalati locali, avevano tutti una
concentrarono i loro sforzi nel preservare l'indipendenza contro il occupazione "legale" di operai specializzati, spesso riuniti in
pericolo del colonialismo e nel costruire una nazione tanto forte e "Sindacati".
moderna da contrapporsi alle potenze straniere. Il loro obiettivo fu Se fuori dai confini, nelle aree occupate militarmente, gli uomini
in definitiva di passare dal feudalesimo all'imperialismo di Toyama erano utilizzati come spie governative a sostegno delle
(Fukutake, 1989). Si assistette allora ad una serie di iniziative mire imperialiste, in Giappone venivano utilizzati in molte
contrastanti: da una parte interventi tesi a minare la rigida attività: dall'aizzare o reprimere il malcontento popolare ,
stratificazione sociale che impediva la modernizzazione del all'intimidazione di candidati ed elettori, alla punizione o
paese, dall'altro la conservazione della struttura familistica eliminazione di lavoratori variamente dissidenti, in definitiva a
tradizionale, che per alcuni versi fu anche rafforzata, all'interno sostegno della produzione industriale e dunque della prosperità
della società moderna.
del paese.
Il più importante e significativo gruppo di nostalgici samurai, il La Società di Toyama e le sue alleate minori venivano chiamate
"Kyoshisha" o Società dell'Oceano Tenebroso, fu quello fondato dalle stesse società industriali, soprattutto minerarie e
da Mitsuru Toyama. La figura di Toyama è significativa per capire manifatturiere, non solo per soffocare gli scioperi e reprimere le
il profondo radicamento tra yakusa e società giapponese, ed in rivendicazioni dei lavoratori che in quegli anni avevano formato i
modo particolare la stretta connessione con l'azione politica ed primi sindacati, ma anche come "(…) braccio violento per
istituzionale del tempo.
promuovere o affossare le carriere dei politici" (Kaplan- Dubro,
Tra il 1890 e il 1914 la produzione industriale del paese raddoppiò 1986).
e triplicò il numero delle fabbriche. Anche sul piano politico, il Inizialmente i gruppi più tradizionalisti degli yakusa non avevano
Paese cambiava in fretta:
una vera e propria ideologia
nacquero e maturarono il primo
politica, né questa sembrava
parlamento, i partiti politici ed
suscitare in loro un interesse che
una casta militare, autonoma e
andasse al di là dell'opportunipotente, che di lì a breve sarebbe
smo affaristico, e si tenevano ad
entrata in azione in Cina e Corea.
una certa distanza dalla società
Mentre il paese si modernizzava,
di Toyama. Ciononostante erano
le yakusa estendevano la loro
evidenti i molti punti in comune
attività di pari passo con la
tra le yakusa e le forze
crescita
dell'economia,
in
ultranazionalistiche, nonché la
particolare organizzando la
perfetta integrazione delle
manovalanza avventizia per le
rispettive ideologie di base:
costruzioni nelle grandi città e
accomunati dalla venerazione
reclutando gli scaricatori dei
per un passato romantico e
porti, sui cui traffici vantavano
dall'ostilità per lo straniero, il
ampi poteri. Il gioco d'azzardo
loro legame fu rafforzato, dal
Tatuaggi di alcuni membri di una gang yakuza
continuò ad essere il fulcro delle
punto di vista strutturale, dal
bande bakudo, ma molti capi avviarono aziende legittime di comune sistema organizzativo fondato sul rapporto oyabunfacciata e le bande tekiya ampliarono il loro territorio. Tutti kobun.
continuarono ad occuparsi di politica stringendo legami con Questi modelli sociali finirono con il produrre una sostanziale
funzionari importanti: la chiave di volta per continuare identità politica tra molti oyabun yakusa ed esponenti politici di
indisturbati l'attività illecita.
destra.
Dal canto suo il governo aveva inizialmente utilizzato i servigi All'affermarsi di un forte movimento operaio all'inizio del secolo
delle bande in modo occasionale, tuttavia con l'ascesa e alla diffusione prebellica del pensiero liberale, la yakusa rispose
dell'ultranazionalismo e la svolta a destra del Paese i legami, da con la creazione di una federazione nazionale, il "Dai Nippon
semplicemente opportunistici, si fecero più profondi e Kokusui-kai", la Società dell'Essenza Nazionale del Grande
politicamente connotati.
Giappone, nata dalla stretta collaborazione di azione e pensiero
Toyama fu il primo a formare e a prevedere un nuovo organismo tra Toyama e l'allora Ministro degli Interni Tokunami.
sociale patriottico da usare come forza paramilitare nel quadro Il programma della società utilizzava il discorso retorico
della contesa politica. Con una studiata ed efficiente campagna di dell'onore, della dedizione all'imperatore, il rispetto dello "spirito
assassinii, la Società di Toyama, esercitò la sua influenza di cavalleria" e degli antichi valori giapponesi, ma nella pratica
soprattutto sugli ufficiali e sulla burocrazia governativa, fino ad essa serviva come massiccia forza d'urto contro gli scioperi e
assumere un ruolo determinante nell'invasione dell'Asia Orientale l'avanzamento del processo di democratizzazione del paese.
prima e degli Stati Uniti poi. I membri della Società, che Capeggiata dallo stesso Ministro Tokunami, che aveva in Toyama
fungevano da guardie del corpo di esponenti del governo o da il suo principale consigliere, l'organizzazione era strutturata in
18
processo di centralizzazione del potere statual-nazionale e della
riorganizzazione del territorio, costrinse i nuovi gruppi di potere
a cercare alleanze locali orientandosi verso chi nella marginalità
aveva acquisito, per posizione e ruolo, la possibilità di mediare tra
il centro e la periferia, dando conto di quella dinamicità delle
relazioni tra gruppi sociali di cui parla Boissevan (1973).
In questa situazione di transizione, la mafia come organismo
sociale, sembra colmare i vuoti di potere - politico, economico,
culturale - che si creano nelle condizioni di "disordine", adottando
una sorta di riconversione degli "eccessi". Infatti sia i samurai
giapponesi che i gabellotti siciliani, sebbene appaiano nel nuovo
contesto sociale e politico delle figure anacronistiche e marginali,
riescono a mettere a frutto con successo il patrimonio di
reputazione, anche simbolica, accumulata nel tempo.
Collocandosi sul confine delle relazioni tra l'apparato statale e il
neo cittadino, in una situazione in cui lo Stato non si è ancora
"appropriato" della società, la mafia trae il suo potere dalla
capacità e dalla possibilità di veicolare le informazioni tra il
gruppo egemone e la gente comune, un'attività che, per la sua
funzione, si connota apertamente come azione politica.
La mafia si fa in tal senso strumento del potere, ma a sua volta
attua essa stessa, certamente sul proprio territorio, una
strumentalizzazione del potere di governo dello stato, un potere
mafioso altresì legittimato, non solo dall'uso della coercizione più
o meno avallato dallo Stato, ma soprattutto dalla capacità di
appropriarsi dei codici della tradizione, di cui manipola a suo
beneficio termini e significati, costruendo attraverso di essi il
mito su cui fondare la propria immagine sociale.
In tal senso la mafia si pone in concorrenza, nel caso della Sicilia,
o affianca, nel caso del Giappone, il potere governativo nel
processo di costruzione dei miti nazionali, presentandosi alla
pubblica opinione come chi ha preservato e traghettato nel tempo
i valori della tradizione.
La presenza di una legalità debole, come nel caso della Sicilia, o
la presenza di una forte struttura di patronage nel tessuto sociale
e nelle istituzioni, come nel caso del Giappone, in definitiva la
personalizzazione dei rapporti sociali e politici, hanno permesso
alla mafia l'esercizio di poteri che normalmente sono assolti in via
esclusiva dall'autorità centrale dello Stato, come ad esempio l'uso
della violenza per fini personali e il controllo del territorio. Infatti,
come ricorda Beattie (1985), "uno Stato centralizzato, se è
abbastanza potente, non consentirà il ricorso alla violenza per
motivi personali", ma è il governo che rivendica il monopolio
della forza entro i suoi confini. Tuttavia molte società
centralizzate sembrano coesistere con modelli che si richiamano
ad un'organizzazione segmentata dove sono comuni le faide tra
gruppi di potere concorrenti per l'accesso alle risorse oppure con
modelli ereditati da una precedente struttura di tipo "feudale".
La struttura clientelare, su cui regge ogni spazio ed azione politica
mafiosa, che nel caso siciliano si manifesta nel rapporto friendsof-friends e nel caso nipponico nel rapporto oyabun-kobun,
configura un network di relazioni che rappresenta in definitiva il
vero capitale sociale della mafia. Ma perché questo capitale possa
fruttare il meglio possibile è necessario che l'esistenza
modo piuttosto simile alle "camicie nere" di mussoliniana
memoria e godeva dell'appoggio oltre che del ministero, anche
della polizia e di numerosi ufficiali di grado superiore. Non era
impiegata solo contro gli scioperanti, dove era fianco a fianco
della polizia, ma anche contro tutti gli individui considerati
sommariamente sovversivi.
Il kokusui-kai di Tokunami crebbe sino a diventare il braccio
paramilitare del Seiyu-kai uno dei due partiti politici dominanti
dell'epoca. Non molti anni più tardi, anche il partito avverso, il
Minseito, ne seguì l'esempio organizzando un proprio esercito cui
aderirono numerosissimi yakusa provenienti dalle fila degli
operai edili, ed alcuni oyabun finirono con il candidarsi
personalmente a cariche nazionali, riscuotendo un particolare
successo.
La politica espansionistica aveva dato vita ad un duraturo
binomio tra yakusa e governo. Fornendo gran parte della
manovalanza, soprattutto nel settore edile e portuale, la yakusa, e
Toyama in particolare, contribuì in modo decisivo allo sviluppo e
al consolidamento dell'imperialismo nipponico, senza tralasciare
gli interessi economici personali che, in un'economia in pieno
sviluppo, gli procurò un potere impressionante.
Infine, la diffusione delle sue idee fornì la base ideologica su cui
si costruirono le future organizzazioni dell'estrema destra, nelle
quali molti gruppi yakusa poterono soddisfare il loro spirito
patriottico e di potere.
Conclusioni.
Come abbiamo già ricordato, nel periodo storico preso in
considerazione sia la Sicilia che il Giappone dovettero
fronteggiare i profondi mutamenti sociali che accompagnarono il
processo di nazionalizzazione dei rispettivi Paesi e la
riorganizzazione del territorio, anche se, come afferma Beattie
(1985), vi sono profonde differenze strutturali tra gli Stati nati a
seguito dell'ingerenza egemonica e dal dominio di un gruppo
territorialmente esterno su di un altro, socialmente e
culturalmente diverso, e gli Stati nati da una propria evoluzione
interna, seppur forzata dall'esterno. Nel primo caso, infatti,
vengono spesso a configurarsi due società i cui rapporti
istituzionali sono relativamente scarsi, mentre nel secondo caso
prevalgono le spinte alla coesione attorno a determinati valori
identitari riconosciuti e condivisi, che segnano nettamente il
confine con l'Altro.
In Sicilia il latifondo, in Giappone l'organizzazione feudale,
avevano prodotto secoli di stratificazione sociale e di
legittimazione del potere che si erano ormai cristallizzati, dando
vita ad un assetto tradizionale profondamente radicato,
incorporato nelle pratiche sociali dei singoli attori e dei gruppi.
Ma, come afferma Balandier, "tutte le società sono, con gradi
diversi, eterogenee, e la storia le carica di nuovi apporti senza
eliminare quelli vecchi: la diversificazione delle funzioni
moltiplica i gruppi che le assumono o impone a uno stesso gruppo
di presentarsi sotto "aspetti" differenti a seconda delle situazioni"
(Balandier, 2000). Così la necessità di governare il "disordine"
sociale prodotto dalle spinte egemoniche straniere e l'avvio del
19
dell'organizzazione mafiosa, il suo linguaggio e i suoi simboli,
siano in qualche modo divulgati; soprattutto ne deve circolare la
reputazione all'interno del territorio controllato, ma anche oltre .
In tal senso la questione della segretezza è strettamente correlata
alla posizione dello Stato nei confronti dell'organizzazione: esso
può mostrarsi apertamente avverso e dunque contrastarne
l'esistenza e le azioni, oppure può in qualche modo riconoscere,
se non legittimare, la sua presenza nel tessuto sociale.
La mafia, dunque, non si configura tanto come fenomeno
tradizionale, quanto come modello di comportamento derivante
da una combinazione del tutto peculiare tra vecchio e nuovo. Essa
si definisce in base ad alcuni obiettivi che consistono
essenzialmente nel perseguimento di posizioni di monopolio sul
mercato economico e sul piano politico.
Per usare le parole di Boissevan (1973), i mafiosi sono
"imprenditori sociali", nel senso di "manipolatori di norme allo
scopo di collegare gruppi ed individui, consentire lo svolgimento
di attività economiche e politiche, garantire il controllo sociale
nell'interesse della classe dominante (…)" (La Spina, 2005) e in
quanto tali si configurano in modo evidente nel ruolo di attori
politici.
Bibliografia
Balandier, G. (2000), Antropologia politica, Armando, Roma.
Bateson G. (1971), Verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano.
Beattie, J. (1985), Uomini diversi da noi. Lineamenti di antropologia sociale, Laterza, Roma.
Block, A. (1986), La mafia di un villaggio siciliano, Einaudi, Torino.
Boissevan, J. (1973), Friends of Friends, Basil Blackwell, Oxford.
Borsa, G. (1998), Le origini del nazionalismo in Asia Orientale, Ed.Università di Pavia, cit. in Flore, M. (2001).
Coleman, J. (1990), Foundation of Social Theory, Harvard University Press, cit. in La Spina, A. (2005).
Cutrera, A. (1900), La mafia e i mafiosi. Saggio di sociologia criminale, Palermo, cit. in Lupo, S (1996).
Falcone, G.(1990), Una nuova fase della lotta alla mafia, in "Segno" 116, cit. in Lupo, S. (1996).
Flore, M. (2001), Yakuza: tra politica e affari, Tesi di Laurea, Cà Foscari, Venezia (com. pers.).
Franchetti, L. (1993), Condizioni politiche ed amministrative della Sicilia, (ed. or. 1876), Donzelli, Roma, cit. in La Spina, A.
(2005).
Fukutake, T. (1989), The Japanese social structure, University of Tokio Press.
Gambetta, Diego (1992), La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata, Einaudi, Torino.
Goode, W. (1982), Famiglia e trasformazioni sociali. Il Giappone, Zanichelli, Bologna.
La Spina, A. (2005), Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna.
Lupo, S. (1996), Storia della mafia, Donzelli, Roma.
Lebra, T. Sugiyama (1976), Japanese patterns of behaviour, EastWest Center Book, Honolulu.
Mignosi, Pietro (1925), La Mafia, in "La rivoluzione liberale" n. 38/4.
Putnam, Robert D. (1996), La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano, cit. in La Spina, A. (2005).
Santino, Umberto (2004), Borghesia mafiosa, Centro Siciliano di Documentazione "Giuseppe Impastato", Palermo.
Tilly, Charles (1986), Prefazione, in Block, A. 2^ ed.
20
Sarajevo e il passato che non passa
La memoria, il paesaggio e l'identità come fermo-immagine
di Claudio Todisco
Un paesaggio della mente - Quando, armato di macchina
fotografica1, ho iniziato la mia ricerca in Bosnia-Erzegovina in
seno all'approccio teorico della Critical Geopolitics, non ero mai
stato a Sarajevo; tutto ciò che sapevo di inerente a questa città
meravigliosa erano solo alcuni tra i peggiori aspetti della sua
storia: l'attentato del 1914, spesso annoverato tra le cause
principali dello scoppio della Grande Guerra e il conflitto degli
anni Novanta, del quale ricordavo alcune immagini rimastemi
impresse, tra quelle ampiamente diffuse dai telegiornali quando
avevo tra i tredici e i sedici anni. In particolare rammentavo i
corpi straziati delle vittime nella strage del mercato; per il resto
una gran confusione. In realtà un certo grado di preconoscenze
l'avevo acquisito durante il corso sui "luoghi e paesaggi
simbolici" alla Facoltà di Sociologia, del quale quello di Sarajevo
era stato un argomento approfondito. Tuttavia ritenevo di potermi
considerare essenzialmente ancora vergine di fronte al consumo
del paesaggio di questa città, cosa della quale ero lieto, poiché
speravo che il mio intento conoscitivo potesse avvicinarsi il più
possibile (entro i limiti dei quali ero conscio, certamente)
all'essere incontaminato. Oggi so con certezza che mi sbagliavo.
È stato un preciso episodio a farmi ravvedere presto su tale
speranza: Giunto a Sarajevo ho cominciato a perlustrarne le varie
zone in lungo e in largo cercando di prendere confidenza con i
monumenti, i palazzi, le chiese più importanti, e ovviamente le
moschee, ma oltre a ciò inizialmente mi sforzavo soprattutto di
imparare le fermate del tram, i nomi delle vie. Il mio primo
obiettivo in altre parole era sapermi orientare, avere un'idea
superficiale ma totalizzante dell'area urbana. È stato facile,
nonostante il mio scarso senso dell'orientamento. Se mi perdevo
era sufficiente riaffacciarmi sul fiume Miljacka, la colonna
vertebrale della città, e ripartire da lì. Niente a che vedere con
Milano insomma. Ma quando mi sono sentito padrone di una
discreta dimestichezza con i luoghi, gli incroci e i ponti principali,
ho deciso che dovevo fare un passo ulteriore e che per farlo mi
serviva una guida, nel vero senso della parola. Mi sono rivolto
ad un tourist information point nel quale mi hanno dato
delucidazioni e mi hanno riempito di opuscoli e volantini scritti in
lingue diverse, un po' a stele di Rosetta per intendersi, quindi sotto
cospicuo pagamento (preferendo non aggregarmi a una comitiva
non potevo dividere la spesa con nessuno) mi è stata assegnata
una guida. Sembrava preparata e sicura di sé, ma dopo breve mi
ero già reso conto che non poteva spiegarmi niente che non
sapessi già. Il fatto è che sebbene fossi partito quasi da un giorno
all'altro, prima di lasciare l'Italia mi ero ampiamente documentato
su riviste, guide turistiche, persino l'atlante e soprattutto internet,
non tanto con qualsivoglia intenzione di tipo epistemologico,
Claudio Todisco, La moschea wahabita di re Fahd, periferia Ovest di Sarajevo, agosto 2004
quanto per non trovarmi allo sbaraglio una volta sceso dall'aereo.
Così ogni volta che la mia guida iniziava a descrivermi la storia
di un edificio o lo stile col quale era stato costruito oppure una
leggenda o un racconto pittoresco che lo riguardasse io la
interrompevo e terminavo il discorso al suo posto, tanto che ad un
certo punto ho notato il suo estremo imbarazzo mentre si
scervellava per mostrarmi qualcosa che non potessi conoscere.
Alla fine il giro si è dilungato fino sulle prime alture della città,
occupando tutto il pomeriggio. Per fortuna la situazione si è
trasformata in un gioco divertente, una specie di quiz nel quale lei
mi sfidava e io prontamente rispondevo, ma non era esattamente
ciò di cui avevo bisogno ai fini del mio interesse. Così vista la sua
disponibilità mi sono risolto a dirle direttamente quali fossero i
posti di cui avevo letto e che volevo vedere perché mi ci
accompagnasse. In seguito mi sono rivolto ad accompagnatori
21
essenzializzati ed esasperati e fondano la propria legittimità nella
continuità con il passato, anche quando lo fanno in modo del tutto
nuovo. Va detto però che, prendendo l' 'oggi' come riferimento
puntuale è molto difficile dire chi sia il vero detentore del potere.
In prima istanza verrebbe da pronunciarsi a riguardo dei partiti
nazionalisti e in particolare dell'SDA (Partito d'Azione
Democratica) e certo non a torto, ma pensandoci bene a garanzia
del sistema democratico in seno al quale quei partiti sono eletti si
erge una forza militare straniera (oggi nella forma dell'EUFOR)
che appoggia sicuramente e partecipa a rafforzare quel sistema
democratico, ma che di fatto non ne è l'espressione. Poi va
considerato l'interesse di alcuni paesi islamici che oltre a portare
la propria solidarietà in Bosnia e a Sarajevo non disdegnano di
fare del proselitismo. Per non parlare della spartizione del
territorio tra Republika Srpska e Federazione croato-musulmana.
È all'interno di questa situazione di passaggio (di questo si tratta)
che va individuata una spiegazione dell'accentuata complessità
delle rappresentazioni del paesaggio. Focalizzando l'attenzione su
una città popolata prevalentemente da musulmani, è facile che ci
si concentri esclusivamente sul tema dell'islamizzazione, quando
in vero Sarajevo oltre che come città dei bošnjaki può essere
considerata quale città dell'assedio, o come capitale della BosniaErzegovina (specie in vista dell'avvicinamento a Bruxelles),
capitale della Federazione croato-musulmana, o ancora come città
dell'arte e del multiculturalismo. E' bene inoltre ricordare che
l'SDA collabora al governo del paese in un sistema istituzionale a
rotazione periodica tra serbi, bošnjaki e croati (il che vale anche
per la carica presidenziale) e dunque non esercita il monopolio del
potere. Ciò concorre a rendere il panorama politico e sociale
ancora più molteplice e variegato e il senso di transitorietà che ne
deriva ha l'effetto per cui invece di essere forgiati nuovi simboli,
in mancanza di punti di riferimento si propende a recuperarne di
vecchi, salvo poi adattarli alle esigenze specifiche del presente.
meno convenzionali, ma in fin dei conti anche con la prima guida
non penso di aver buttato via i miei soldi, perché ho capito fino a
che punto il paesaggio di Sarajevo fosse già un idea ben articolata
nella mia testa. E tuttavia sapevo che non potevo averne colto la
realtà in un pomeriggio; quello che possedevo era un 'paesaggio
della mente', una rappresentazione. Nella guida Bradt di Tim
Clancy del 2004 sulla Bosnia-Erzegovina per ogni sezione del
libro (che è diviso per aree regionali) compare un paragrafo
intitolato What to see, nel quale sono suggeriti i percorsi da
seguire e i luoghi da visitare, quelli da non perdere. Ma chi decide
che cosa è degno di essere visto e cosa invece no? E con quale
criterio? To see or not to see? Con questa scherzosa storpiatura
del celebre dubbio amletico, intendo evidenziare come spesso
l'essere, nel senso di esistere, si riduca alla mera questione di
essere visti. Se mi fossi ritenuto soddisfatto del mio primo 'giro
turistico', ad esempio non avrei mai visto il gigantesco mercato a
cielo aperto collocato nella zona periferica a ovest della città,
verso l'aeroporto, dove nella totale illegalità (mi è stato suggerito
di tenere d'occhio le tasche del mio zaino) viene venduto qualsiasi
tipo di mercanzia immaginabile, dalle forcine per capelli ai cd
pirata degli artisti più disparati (dai Bijelo Dugme a Eminem), ai
mobili, i materassi, le automobili e chissà cos'altro. Solo per
vedere quel posto non basta un giorno intero; una specie di
Louvre del mercato nero.
In sintesi Sarajevo non è semplicemente l'oggetto dato di
un'osservazione discreta, bensì può essere molte cose diverse a
seconda di come intendiamo guardarla.
Oggi in questa città il
potere per molti versi è appannaggio di un'élite che si identifica
con la storia del popolo musulmano di Bosnia e con la recente
formulazione di un'identità etnica dei bošnjaki2 . Quest'ultima
presupponendo dei caratteri di omogeneità che non le sono propri3
e ricercando nel paesaggio concreto delle conferme che esso le
concede nella misura in cui sono gli stessi cittadini a produrle
concretamente e rappresentativamente. Così la moltiplicazione ad
esempio dei luoghi di culto islamici e lo stanziamento di fondi per
permetterne la ristrutturazione o conservazione (mentre ad opere
pubbliche di forse più immediata urgenza viene lasciato poco
spazio) non viene solo incontro alle reali esigenze demografiche
(molti abitanti non musulmani hanno abbandonato la città o più
semplicemente non vi sono tornati), ma testimonia la
concentrazione del potere nelle mani dei partiti nazionalisti.
Primo tra tutti quello che per dieci anni è stato capeggiato dalla
figura carismatica di Alija Izetbegovic (morto recentemente), il
quale in epoca iugoslava era più volte stato arrestato con l'accusa
di estremismo islamico4 . Dopo l'opera di smemorizzazione del
paesaggio avvenuta per il tramite della distruzione da parte del
nemico (che di solito non era uno straniero, ma un concittadino,
un vicino di casa, un'insider di quello stesso paesaggio), ora il
paesaggio viene rimemorizzato sopra le macerie, privilegiando
alcuni aspetti identitari radicati in un passato etnico costruito
politicamente, ma fortemente influenzati dagli interessi del
presente. È il bisogno di proclamare la propria esistenza,
stringendosi attorno a quei tratti identitari la cui stessa
sopravvivenza era stata minacciata. Questi tratti oggi sono
Rompere la cornice - Il 2005 è stato per molti versi l'anno della
memoria. Il 27 gennaio (anniversario della liberazione di
Auschwitz da parte dei sovietici) per la prima volta dopo
sessant'anni, su iniziativa del segretario generale Kofi Annan,
l'Assemblea generale dell'ONU ha ricordato la Shoah con una
sessione straordinaria; il 10 febbraio (in seguito all'approvazione
di una legge che istituisce un 'Giorno del ricordo') è stata celebrata
in Italia la commemorazione delle vittime delle foibe del 1947. Il
presidente Berlusconi ha esortato pubblicamente a "non
dimenticare"5 ; il 6 e il 9 agosto abbiamo ricordato la tragedia
delle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, anch'essa
avvenuta sessant'anni fa; dall'11 al 19 luglio è stato il decimo
anniversario della strage dei musulmani di Srebrenica.
In tutti
questi casi diversi tra loro, ma tutti aventi a che fare con la
commemorazione di crimini atroci, la memoria è sicuramente
stata il tema centrale. Allo stesso modo il 15 dicembre scorso è
caduta la decima ricorrenza degli accordi tenuti negli Stati Uniti a
Dayton, Ohio, nel 1995 e conclusisi con la firma della pace (la
cosiddetta 'pace fredda') da parte dei contendenti del conflitto ex
iugoslavo. Questa data viene convenzionalmente fatta coincidere
22
emergere paradossalmente quasi un desiderio di normalità, così le
ossa possono essere riordinate assieme ai tappeti. Un ritorno alla
quotidianità dopo la sofferenza, rispolverando il passato assieme
al presente.
Il ricorso alle immagini fotografiche è particolarmente adatto per
un discorso sulla memoria, perché, come suggerisce Susan Sontag
(2003), sebbene oggi i film esercitino una sorta di predominio,
quando si ricorda le fotografie sono più incisive, in quanto la
memoria spesso ricorre al fermo-immagine. Tale caratteristica del
resto è probabilmente quella che più la accomuna alla produzione
delle identità e dei paesaggi che le rappresentano. Anderson
(1991), parlandoci del nazionalismo cita Gellner quando afferma
che esso "inventa le nazioni dove esse non esistono" (Gellner,
1964 p. 169). Tiene a precisare però che Gellner così finisce per
assimilare il concetto di invenzione a quello di falsità e non a
quello di immaginazione e creazione. In proposito Ugo Fabietti
sosterrebbe che:
con la fine dell'assedio di Sarajevo (seppure alcuni scontri armati
si protrassero anche l'anno successivo).
Dunque è stato il momento di 'ricordare Sarajevo'. Ma non si è
trattato solo di un proposito episodico suggerito da una data
significativa. Ancora prima che la guerra di Bosnia fosse
terminata siamo stati, come europei, americani, occidentali,
ripetutamente esortati, scongiurati dall'urlo "Non dimenticate
Se l'immaginazione consiste […] nel rappresentarsi realtà che non
sono esperite nella pratica quotidiana, essa consente tuttavia di
pensarsi in congiunzione ad altri soggetti aventi lo stesso tipo di
immaginario. Politiche, espressioni collettive, in altre parole
"identità", nascono da questo contesto o si rafforzano in esso
come entità nuove, come "comunità immaginate" (Fabietti 1999,
pp.264-265).
Fig. 1: Roger Richards
Cioè egli dà maggiore rilevanza all'accezione positiva del termine
'finzione'. Gellner non può fare altrettanto; la sua idiosincrasia per
il relativismo lo induce a considerare gli oggetti che si presentano
alla sua analisi semplicemente come veri o falsi ("finti" in senso
negativo, moderno). E il tipo di verità che egli predilige è
giocoforza univoco, cartesiano. Ora poiché il paesaggio, come si è visto, può
incorporare la rappresentazione di un'identità, con
Cosgrove è il caso di dire
che:
Sarajevo!". Sì è trattato di un vero e proprio slogan, lanciato
durante la guerra nella speranza di un intervento delle forze
internazionali e riprodotto con continuità anche dopo Dayton, fino
ad oggi. Prima non dovevamo dimenticarci di salvarla e adesso ci
viene chiesto di ricordare l'orrore a cui è stata sottoposta. Ad
esempio in figura 1 e 2 il messaggio è chiaro grazie al preciso
potere esplicativo della parola. Le immagini della donna che
corre, viene da pensare sotto le posizioni dei cecchini, del Cristo
scalfito dai proiettili (copertina di un libro fotografico di Roger
Richards) e delle torri di Momo i Uzeir6 bersagliate dall'artiglieria
nemica, sono esempi degli orrori che per l'appunto siamo
implorati di ricordare.
Mentre le figure 3 e 4 estendono l'attenzione alla sofferenza patita
nel resto della Bosnia. In particolare la prima raffigura un murale
dipinto in una via di Sarajevo. Il dolore dei cittadini della capitale
così viene stretto a quello delle 'madri di Srebrenica'. La seconda
è parte di un lavoro fotografico di Zijah Gafic (famoso,
giovanissimo, già pluripremiato fotografo che ha avuto la
fortuna/sfortuna di essere bosniaco al momento giusto) intitolato
"In cerca di identità". Tratta il tema della 'riesumazione dei morti'
per l'identificazione delle persone scomparse in Bosnia.
Gafic gioca sul concetto oscillante tra identità personale e identità
collettiva e per farlo ci sottopone le immagini crude e scioccanti
degli scheletri umani disseppelliti per l'operazione di
riconoscimento attraverso il dna, confrontato con quello dei
parenti delle vittime. In basso a destra vediamo riportato alla luce
ciò che resta dei corpi e alle loro spalle un tappeto steso,
probabilmente lavato o appena sbattuto. Da questa figura sembra
Il paesaggio è un concetto
ideologico. Esso rappresenta un modo in cui certe
classi di persone hanno
significato se stesse e il
loro mndo attraverso la
loro relazione immaginata
con la natura (Cosgrove
1990, p.35).
Per Keith e Pile (1993)
Fig. 2: Cefal, Resistenze
l'identità è sempre parziale
e dipendente da un insieme di relazioni che "non consentono di
dare vita ad un sistema chiuso", eppure spesso è rappresentata
come perfettamente coerente, chiusa e completamente scibile. Al
23
contrario essi ribadiscono come la sua costruzione sia legata al
soggetto e al contesto storico di riferimento. Un contesto in cui
avvengono lotte politiche, sociali, economiche e che dunque è
estremamente mutevole. E in modo analogo Farinelli scrive:
stabilità e immobilità. I luoghi cioè in cui sono avvenute battaglie
fondamentali per una particolare identità, in cui gli eroi del
passato si sono distinti per le loro gesta e dove gli antenati sono
stati seppelliti, agiscono come tracce di memoria. L'identità di un
gruppo si forma così attraverso quella selezione di ricordi che
Sebbene inconsapevolmente, l'investigazione si limita a "portare vengono scelti come validi per il fine di enfatizzare i caratteri nei
a stabilità il mutevole",
quali il gruppo stesso si
senza però "lasciare che il
differenzia dagli altri.
movimento sia movimenQuesta identità appare
to", come invece Heidegger
inalterabile nei suoi tratti
al contrario prescriveva
fondanti e legittima l'ordine
(Farinelli 1991, p.10).
del presente poggiando sul
passato, ossia, in un circolo
ermeneutico, il passato
È quanto auspica Cosgrove
(1990) per il paesaggio:
plasma il presente, che a sua
rompere la cornice del
volta sceglie cosa ricordare
quadro e inserirlo nel
del passato in vista di un
processo storico7 . Altrimenfuturo. Ciò comporta spesso
ti è come se un agnostico,
un utilizzo politico, più o
incontrando un cattolico
meno consapevole, della
praticante, gli intimasse, se
memoria con lo scopo di
Dio davvero esiste, di
garantire la conservazione
Fig. 3: Claudio Todisco - Don't forget Srebrenica, agosto 2004
giurarlo su ciò che ha di più
di uno status quo (o anche
caro; e l'altro rispondesse: "E va bene, se ci tieni… lo giurerò su di sostituirlo con uno nuovo).
Dio.", non fa una piega, ma è un vicolo cieco, una tautologia.
In questo senso la memoria è prodotta in funzione degli interessi
del presente, in dipendenza dei quali si preferisce ricordare alcune
L'identità è sempre un processo incompleto […] questo processo cose, relegandone altre all'oblio. Spesso ne risultano
viene fermato per rivelare un'identità che somiglia al fotofinish di rappresentazioni paesaggistiche atte a privilegiare i tratti culturali
una corsa di cavalli al galoppo. Potrebbe trattarsi di una 'vera' riconosciuti come propri ed a smemorizzare quelli degli 'altri'. E
rappresentazione di quel momento, ma per il fatto di aver poiché questi paesaggi, pur essendo delle costruzioni mentali,
congelato, appunto, un momento, essa rinnega la presenza stessa influenzano direttamente la vita reale, spesso smemorizzare non
del movimento. […] Perciò […] l'atto di rappresentare significa decostruire
l'incessante processo di formazione dell'identità si basa su un testualmente,
ma
momento di chiusura arbitraria che è simultaneamente vero e distruggere fisicamente
falso. (Keith e Pile, in Minca 2001, p.67).
le tracce di questi
cosiddetti 'altri'. Altre
Sull'onda di simili affermazioni e in seguito a quanto sostenuto volte semplicemente
sulla memoria e sul suo ricorso al fermo-immagine ci si può disseminare ovunque
chiedere dunque se anch'essa non sia tanto una registrazione pura segni del proprio potere
e semplice dei fatti del passato, quanto piuttosto il risultato di tentando di adombrare
un'opera selettiva di rappresentazione.
Per Fabietti e Matera quelli del potere altrui
infatti (1999) la memoria è una costruzione culturale, elaborata attraverso la dimentiattraverso una selezione sociale del ricordo ed è strettamente canza8 .
legata ai discorsi sull'identità.
Questo concetto richiama la Se è vero che i ricordi
'memoria collettiva' di Maurice Halbwachs (1987) e non tanto appartengono ad una
quello dei ricordi individuali. Questi ultimi per Sontag sono dimensione
dell'inirriproducibili e muoiono assieme all'individuo, mentre la dividuo incommensuraFig. 4: Zijah Gafic - In cerca di identità
memoria collettiva non è un ricordo, bensì un patto attraverso il bile con quella degli
quale ci si accorda su che cosa è importante e su come sono andati altri, è anche vero che in società un vasto numero di ricordi
i fatti. La memoria collettiva di Halbwachs è quella di un passato vengono fissati attraverso l'uso di supporti che ne permettono la
condiviso, interpretato attraverso le esigenze degli attori sociali condivisione. La scrittura ad esempio. Sempre Fabietti (1999) cita
del presente. Essa, come vale anche per il paesaggio, è mutevole Platone nel Fedro:
e riprodotta in continuazione e, come per il paesaggio, gli
elementi dello spazio e del tempo le forniscono un'immagine di Fidandosi della scrittura [gli uomini] si abitueranno a ricordare
24
dal di fuori mediante segni estranei, non dal di dentro e da se
medesimi (Platone, "Fedro", in Fabietti 1999, p. 113).
L'unica via di purificazione è superare il trauma nella misura in
cui, di nuovo con Magris:
Cioè la scrittura, che in Platone troviamo nell'accezione greca di
'farmaco della memoria', in tal senso è intesa sia come 'medicina',
sia come 'veleno'9 , cioè essa è da un lato conservativa nei
confronti della memoria e dall'altro produce uno scarto di
significato.
Un altro potente supporto della memoria è la fotografia. Forse
anche a quest'ultima Platone avrebbe attribuito la stessa duplice
proprietà, soprattutto nel caso in cui le avesse riconosciuto una
dimensione artistica.
La memoria guarda avanti; si porta con sé il passato, ma per
salvarlo, come si raccolgono i feriti e i caduti rimasti indietro, per
portarlo in quella patria, in quella casa natale che ognuno, dice
Bloch, crede nella sua nostalgia di vedere nell'infanzia e che si
trova invece nel futuro, alla fine del viaggio (Magris, ibid.).
È quanto prescrive Todorov con la sua 'memoria esemplare',
rievocare il passato, non per esserne schiavi in ogni momento del
presente, ma per comprendere i torti che si sono subiti all'interno
di una visione più generale, in cui il male che si è patito è un
esempio di quali misfatti gli uomini possono spingersi a
commettere.
Ciò che più spesso accade tuttavia, è che le vittime di una
violenza non vogliano condividere la propria specifica sofferenza
come un generico esempio da riversare nel calderone dei mali del
mondo. Il proprio dolore viene concepito come unico,
incomparabile. Così a Parigi, quando alcuni manifesti hanno
paragonato la pulizia etnica attuata dai serbi ai campi di
concentramento nazisti e Miloševic a Hitler, si sono alzate molte
proteste, rimarcando la differenza tra il genocidio sistematico di
una popolazione in quanto considerata inferiore da un punto di
vista razziale e l'epurazione etnica col fine di creare degli statinazione omogenei. In questo modo non si introducono le lezioni
del passato in un discorso più articolato e ampio su come
prevenire il male nel presente sulla base delle esperienze
precedentemente vissute.
Ecco perché gli abitanti di Sarajevo, quando il fotoreporter Paul
Lowe allestì nel 1994 una mostra in cui, accanto agli scatti
dell'assedio, espose alcune foto che aveva scattato
precedentemente in Somalia, non solo rimasero delusi, ma
addirittura si offesero (cfr. Sontag, 2003). Al di là di una probabile
forma di razzismo latente, ciò che premeva loro era che il dolore
dei cittadini di Sarajevo fosse rappresentato nella sua unicità.
L'assedio della loro città non poteva essere ridotto alla categoria
di mero esempio. Un simile atteggiamento nei confronti di un
torto subito, non permettendo un distacco dalla materialità
dell'evento, può suscitare reazioni vendicative nei confronti della
popolazione serba nella sua indistinta totalità, prolungando la
catena delle violenze. Karl Jaspers (interrogandosi sulle
responsabilità del popolo tedesco durante la II guerra mondiale) si
chiese se non fosse una colpa persino il fatto di essere ancora vivi.
Ma egli non considerava i tedeschi un popolo malvagio, riteneva
anzi che come loro altri potessero commettere errori del genere.
Agli abitanti di Sarajevo probabilmente suggerirebbe dunque che,
come i serbi, altri potrebbero commettere delle atrocità simili. O
addirittura denunzierebbe l'omissione dei ricordi sulle nefandezze
commesse analogamente dai croati e dagli stessi musulmani10 .
Secondo Sontag rimanere impassibili di fronte alle fotografie
delle tragedie della guerra a causa del bombardamento mediatico
di queste immagini al quale siamo sottoposti, non significa
necessariamente essere insensibili. Al contrario proprio esserne
Sarajevo come esempio - Dunque, abbiamo detto, la memoria è
costruita culturalmente, forma l'identità procurandole dei
riferimenti spazio-temporali ed è fissata e condivisa per mezzo di
alcuni supporti di fruizione collettiva. Dato però che come
costruzione essa può assecondare determinati interessi, non è
escluso che, come vuole Tzvetan Todorov (1995), di essa non
venga fatto abuso. Nel 'Giorno del ricordo' delle foibe Claudio
Magris, pur favorevole al recupero di quei fatti a lungo trascurati,
così ammonisce circa l'uso che si fa della memoria:
C'è tuttavia pure un ricordo negativo che pretende di legare
irreparabilmente gli uomini al passato, di pietrificarli come il
volto di Medusa. Una memoria rancorosa che incatena l'animo al
ricordo bruciante di tutti i torti subiti, pure lontani, magari vecchi
di secoli, e alla necessità di presentare il loro conto anche a eredi
o presunti eredi che non ne hanno colpa alcuna, di vendicarli
indiscriminatamente, perpetuando così la catena di violenze e
vendette, alimentando nuove tragedie (Magris, Corriere della
sera, 10 febbraio 2005, p.35).
È la distinzione che Todorov fa tra 'memoria letterale' e 'memoria
esemplare': La prima, in pratica, non permette al passato di
passare, legandolo simbolicamente ad un luogo, un paesaggio, un
evento. Il presente è impregnato di passato e il trauma per un male
subito non viene superato. Oltretutto il ricordo di questo male, che
non viene elaborato attraverso il percorso catartico del lutto,
diventa il motivo di un legittimato rancore, che può ricercare uno
sfogo ritenuto altrettanto legittimo nella vendetta. In un'intervista
pubblicata su Repubblica il 24 gennaio 2005 (giorno di apertura
della settimana della memoria della liberazione di Auschwitz) il
premio Nobel Elie Wiesel (sopravvissuto all'Olocausto e autorità
della cultura ebraica, invitato a parlare alla commemorazione
dell'ONU) ad una domanda sull'oblio risponde:
Ricordo che nei primi anni dopo la guerra i sopravvissuti non
amavano parlare. […] Fu tentazione non di dimenticare, ma di
rimuovere (Tarquini, La Repubblica, 24 gennaio 2005, p.13).
È l'incomunicabilità del trauma che produce 'afasia', l'impotenza
nel parlare. Cioè esso resta al livello di un'emozione e non
essendo simbolizzato non può essere eliminato, ma solo rimosso.
25
stupiti significherebbe non avere nessun grado di coscienza della
realtà, né aver ancora maturato un qualche tipo di riflessività.
Quella stessa riflessività che Hannah Arendt auspica come
capacità di pensare in grado di orientare le azioni umane, per
esimersi dall'applicazione del male. Non il male della cattiveria e
del sadismo, ma il 'male banale' di chi applica le leggi o le
convenzioni senza porsi la questione di cosa stia davvero facendo
e se sarà in grado di sopportarne il rimorso.
Superare il trauma significa non indugiare sulla specifica violenza
di un evento, ma comprenderne la pericolosità generica. Perciò,
scrive Sontag, "Le foto strazianti […] non sono di grande aiuto,
se il nostro compito è quello di capire". Le immagini in cui
compare esplicitamente per iscritto la richiesta di non dimenticare
sono interessanti perché intrattengono un rapporto singolare con
la propria 'attualità'. Parlandoci del ricordo esse ci dicono adesso
qualcosa che riguarda il passato. Per il fatto stesso che ci chiedono
di ricordare, ammettono che il paesaggio da loro offerto è quello
di alcuni anni fa. Tuttavia sono aggiornate nel senso che spiegano
come mai oggi, dieci anni dopo la fine dell'assedio, vengano
ancora prodotte immagini della devastazione. Invece vi è un altro
tipo di immagini che, se da un lato sono comunque attuali perché
appartengono ad una visione a noi contemporanea, dall'altro
rappresentano un paesaggio congelato nel 1995 e lo fanno senza
la preoccupazione di ammetterlo. Si tratta delle cartoline,
fotografie, vignette etc. della 'Sarajevo u ratu' (Sarajevo in
guerra), nelle quali ancora vediamo una città di macerie e palazzi
sventrati dai colpi di mortaio (fig. 5), di persone che vivono
senz'acqua, né viveri o medicine, né corrente elettrica, di cimiteri
arrangiati negli stadi delle squadre di calcio locali (Fig. 6). Una
persona che non fosse mai stata in Bosnia e ricevesse una
cartolina del genere non è affatto detto che si chiederebbe se la
situazione nel 2005 sia
ancora
quella
raffigurata. Potrebbe
tranquillamente
acquisirla come una
perfetta riproduzione
del presente.
La memoria fa parte
del presente e ci
racconta il tempo già
trascorso in relazione
agli interessi che oggi
hanno il sopravvento,
quindi il discorso sia
testuale, sia eidetico
sulla questione del
ricordo è indicativo
Fig. 6: Roger Richards esso stesso di un 'modo
di vedere'. Le città della Bosnia-Erzego- vina sono disseminate di
scritte che intimano di non dimenticare: Don't forget, non
dimenticate Sarajevo, non dimenticate Srebrenica, è anche inciso
in alcune pietre qua e là prima dell'imbocco del ponte di Mostar,
da entrambi i lati. Il fatto che sia scritto in inglese è indice forse
che i destinatari del messaggio siamo noi occidentali, tuttavia
alcune immagini, in particolare ad esempio la crudezza di
fotografie come quelle sottoposteci da Gafic come da tanti altri11
Fig. 5: Cartolina - Sarajevo u ratu
sui corpi delle vittime, rischiano di concentrare l'attenzione degli
abitanti di una realtà controversa come quella di Sarajevo (in cui
l'ordine dopo dieci anni di 'pace' è ancora garantito da soldati
stranieri) su un passato ancora ingombrante, anziché propositivo.
Forse ha davvero ragione Sontag a dire che fare pace vuol dire
dimenticare. Ma la potenza di quelle immagini continua a
ripeterci: non dimenticate! Un'aura di severità appesantisce i
luoghi ove è scolpito nella roccia questo monito, o semplicemente dipinto su un muro. Perché non dimenticare, in vista di
quale intenzione futura? La forza di queste parole, la loro grevità
mette in soggezione, sembra esprimere un giudizio paterno nei
confronti del comportamento futuro di chi legge e non solo un
desiderio di consapevolezza. C'è scritto 'Don't forget', ma si legge
'Don't
forgive'.
Dimenticare sarebbe
folle forse, ma non
perdonare
potrebbe
esserlo altrettanto. Se il
risultato fosse una
riproduzione
delle
divergenze, tanto più
'legittimata'
dalla
rivendicazione
del
passato
e
dalla
'riesumazione dei torti',
allora non perdonare
significherebbe proprio
dimenticare,
avere
scordato a che cosa
l'odio e il terrore,
Kosevo soccer field, 1996
alimentati con dovizia,
abbiano già portato. Il miglior auspicio, per fortuna sostenuto da
una parte di musulmani di Bosnia, è quello di 'perdonare, ma non
dimenticare'. Se del resto come ho detto la scelta dell'inglese per
queste scritte indica che sono rivolte agli stranieri, la speranza è
che in fondo esse siano spoglie di qualsiasi richiamo alla vendetta
26
state accanto12 Il komšiluk (buon vicinato) viene ancora
rispolverato qua e là, persino con un bagliore di fierezza negli
occhi, davanti ad uno straniero che parli di fratellanza, ma è
evidente che ha perduto il suo antico vigore.
La memoria somiglia ad una macchina fotografica: per qualcosa
che cattura, c'è sempre qualcosa che si lascia sfuggire. E il
paesaggio, sovente, offre un nascondiglio alla sua preda.
indirizzato ai cittadini bosniaco-erzegovesi e che rivelino il
tentativo di mettere in circolo la propria esperienza di dolore
all'interno di un insieme globale di condivisione da parte dei
popoli della Terra. Ricordare, dunque, ma non per suggerire
rimproveri provenienti dal passato e lanciarli oltre un confine
immaginato, che divide i due lati di una stessa città, di una stessa
via, in cui i numeri civici in verde, opposti a quelli blu, sembrano
dire: Cari vicini, ieri, oggi, domani voi ci state vicini, ma non ci
Note
1
Avrei raccolto immagini per oltre seicento scatti nel corso di due differenti soggiorni, uno estivo ed uno invernale.
La traduzione più frequente in italiano adotta il termine 'bosgnacchi', tuttavia, date le difficoltà nel descrivere una realtà controversa
e ancora in cantiere come quella dei musulmani di Bosnia dopo la guerra, probabilmente adottare il vocabolo bosniaco preciso nel
quale solo una parte di essi (sebbene diffusamente) si riconosce, evita di incorrere in rischi di fraintendimento circa l'effettiva
appartenenza o meno a questo gruppo.
3
Basti pensare alla grande quantità di matrimoni misti durante il periodo iugoslavo.
4
Nonostante la nota avversione che il potere comunista nutriva nei confronti della religione, va detto che Izetbegovic, il quale durante
il conflitto ebbe una sua buona parte di responsabilità, già in molte occasioni e in particolare nella sua 'Dichiarazione Islamica' (1970)
prima della sua ascesa politica manifestò il desiderio, per altro consapevolmente utopico, di istituire uno stato islamico. Tuttavia
bisogna ricordare che questi pur preoccupanti precedenti, non hanno successivamente mai trovato uno sfogo analogo all'interno dei
programmi politici del suo partito, che anzi ha sovente promosso l'idea di una Bosnia-Erzegovina multietnica.
5
Cfr. Giulio Benedetti, Corriere della sera, 10 febbraio 2005, p.11.
6
Come vengono soprannominate le torri gemelle dell'UNIS, dal nome dei due protagonisti di un famoso testo umoristico.
7
In questo modo egli vuole fare riferimento al debito che il paesaggio, inteso come oggetto della scienza geografica, conserva nei
confronti dell'arte e in particolare della pittura di paesaggio, che fiorì dapprima tra le opere dei fiamminghi e dei rinascimentali del
Nord-Italia nel XV secolo, per poi diffondersi in Europa fino al XIX e all'avvento della fotografia.
8
È l'esempio della toponomastica: se nella Bibbia è scritto che "omne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius"
(Bibbia, Genesi, 2,19) cioè Dio, la Verità stessa, anziché occuparsene personalmente, ha lasciato che fosse un uomo, secondo la propria
volontà e discrezione a dare un nome alle creature viventi, ebbene si potrebbe dire che, con il paesaggio, l'uomo abbia esteso il proprio
potere di 'nominare' anche ai luoghi.
9
Dal gr. farmacon. La scrittura per Platone implicava la qualità negativa della riduzione di significato, tuttavia egli non rinunciò a
conservare il proprio pensiero attraverso di essa, a differenza di Socrate, suo maestro, che non ha lasciato testi scritti e di cui molto
sappiamo proprio grazie a Platone.
10
Come quando protestò per il fatto che a Norimberga tra i giudici vi fosse anche la Russia, che a suo avviso non riconosceva i diritti
su cui il processo stesso era fondato, facendone nient'altro che un processo sui vinti da parte dei vincitori.
11
Come ad esempio Tarik Samarah, fotografo dei corpi di Srebrenica, sudanese che vive da anni a Sarajevo e collabora con giornali
importanti, uno su tutti Dani.
12
La distinzione tra la parte di Sarajevo appartenente alla Federazione croato-musulmana e quella fetta che amministrativamente fa
riferimento alla Republika Srpska è impercettibile a prima vista. Facendo attenzione è possibile notare tuttavia come in alcune vie,
divise da un confine invisibile, i numeri civici siano colorati differentemente da un lato all'altro della strada per indicare la separazione.
2
27
Bibliografia
Anderson, Benedict, Comunità immaginate, Manifesto Libri, Roma 1996 (ed. or. London-New York 1991).
Arendt, Hannah, La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 1963.
Benedetti, Giulio, Il giorno delle foibe. Ciampi: ricordi, non rancori, Corriere della sera, 10 febbraio 2005.
Bibbia, Genesi, La Sacra Bibbia. testo latino della volgata, Editoriale Domus, Milano 1997.
Clancy, Tim, Bosnia & Herzegovina, The Bradt Travel Guide, England 2004.
Cosgrove, Danis, Realtà sociali e paesaggio simbolico, Unicopoli, Milano 1990.
Fabietti, Ugo, Antropologia culturale: L'esperienza e l'interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1999.
Fabietti, Ugo e Vincenzo Matera, Memorie e identità: Simboli e strategie del ricordo, Meltemi, Roma 1999.
Farinelli, Franco, L'arguzia del paesaggio, in Casabella n. 575, Mondadori, Milano, 1991.
Gafic, Zijah, In cerca di identità, Galleria Grazia Neri, Milano, 2003.
Gellner, Ernst, Thought and Change, Weidenfeld and Nicholson, London, 1964.
Halbwachs, Maurice, La memoria collettiva, Milano 1987.
Jaspers, Karl, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Cortina, Milano, 1996.
Keith, Michael e S.Pile, Place and the Politics of Identity, Routledge, UK, 1993.
Magris, Claudio, La memoria senza ossessione, Corriere della sera, 10 febbraio 2005.
Minca, Claudio, a cura di, Introduzione alla geografia postmoderna, CEDAM, Padova, 2001.
Richards, Roger, Remember Sarajevo, The Digital Journalist.
Sontag, Susan, Davanti al dolore degli altri, Mondadori, Milano 2003.
Tarquini, Andrea, "Racconto la mia memoria - il mondo non può dimenticare", La Repubblica, 24 gennaio 2005.
Todorov, Tzvetan, Les oabus de la memoire, Ipermedium, Napoli, 1996.
Cimitero musulmano di recente formazione dedicato alle vittime del conflitto balcanico
Sarajevo, gennaio 2004 - foto di Fabio Vicini
28
Identità mobili tra emigrazione,
immigrazione, accoglienza
di Paolo Benini
Il passaggio di persone da un posto all'altro del pianeta è probabilmente uno dei fenomeni più antichi della storia del genere umano. Il
popolamento stesso del pianeta è avvenuto attraverso processi di nomadismo. La gran parte della storia umana è la storia di popolazioni
non agricole, storia di cacciatori e raccoglitori e di grandi migrazioni.
Alla luce delle problematiche attuali, le migrazioni sono diventate una questione "nazionale", vale a dire lette e governate secondo uno
schema generale che identifica il processo come lo spostamento di persone da un paese di emigrazione a uno di immigrazione. Tema
rilevante è diventato l'appartenenza a una nazione, linea di demarcazione fondamentale tra chi può considerasi cittadino di un paese a
tutti gli effetti e chi risiede nello stesso, ma è vincolato da un permesso.
In molti paesi, tra cui l'Italia, la presenza di stranieri ha aperto un processo di confronto-scontro con "stranieri" che, al di là delle
risposte di discriminazione o accoglienza, svela aspetti importanti della nozione stessa d'identità individuale e collettiva.
Menzionerò ora una seconda fonte di fragilità dell'identità: il confronto con l'altro
avvertito come una minaccia. È un dato di fatto che l'altro, in quanto altro, viene percepito
come un pericolo per la propria identità, per l'identità nostra, collettiva, come per
l'identità mia, individuale. Possiamo stupircene, certo: dobbiamo ammettere, allora, che la
nostra identità è fragile al punto da non poter sopportare, da non poter tollerare che altri
abbiano dei modi diversi dai nostri di organizzare la propria vita, di comprendersi,
d'iscrivere la loro propria identità nella trama del vivere insieme? È così. Sono appunto le
umiliazioni, le ferite reali o immaginarie alla stima di sé, sotto i colpi dell'alterità mal
tollerata, che conducono dall'accoglienza al rigetto, all'esclusione, il rapporto che il sé
intrattiene con l'altro. (Ricoeur P., 2000b)
dall'Albania. Nella seconda metà degli anni 90' la grande novità è
costituita dai ricongiungimenti familiari. La popolazione
femminile aumenta gradualmente; compare come soggetto "la
famiglia immigrata".
Sin dagli esordi del fenomeno migratorio, i Servizi e le istituzioni
si ritrovano in una situazione "avanzata". Diversi bisogni come
regolarizzare la propria permanenza, imparare la lingua, curarsi,
avere una formazione, garantire la scolarizzazione ai figli,
risolvere problemi socio-abitativi, etc., portano la maggior parte
dei migranti a prendere contatto con un qualche tipo di Servizio o
istituzione. Soprattutto il passaggio da un'immigrazione definita
"da lavoro", cioè di soli lavoratori, a un'immigrazione di
"popolamento", cioè di famiglie, ha reso meno "invisibile" la
presenza dei migranti e ha notevolmente incrementato i contatti
all'interno dei Servizi e delle Istituzioni. L'incremento oltre che
quantitativo, è stato soprattutto qualitativo, nel senso che la
presenza di gruppi familiari ha finito per svelare ciò che forse era
prevedibile sin dall'arrivo dei primi migranti: se la funzione
principale delle migrazioni è economica, cioè finalizzata alla
ricerca di uno standard di vita garantito da un reddito, le persone
che emigrano e immigrano non vivono di solo lavoro.
Attualmente, una delle caratteristica del fenomeno migratorio in
Emigrazione - immigrazione - accoglienza
Nonostante la lunga tradizione dell'Italia in tema d'emigrazione
(entro e fuori i confini nazionali), l'interesse o la preoccupazione
per le diversità culturali non sarebbero stati neppure pensabili
prima che, dagli anni '80, l'immigrazione da parte di persone
d'altri paesi influenzasse la società italiana.
Questo fenomeno relativamente recente, soprattutto rispetto ad
altri paesi europei, ha avuto un'evoluzione propria, che è andata di
pari passo all'evoluzione delle risposte d'accoglienza da parte di
Servizi, istituzioni. Una presenza "visibile" di persone provenienti
in gran parte dal nord e centro Africa, inizia negli anni '80. Sono
in stragrande maggioranza uomini alla ricerca di un lavoro o
impegnati nel piccolo commercio. Per tutto il decennio, le
risposte collocano al centro il problema dell'"alfabetizzazione",
vale a dire dell'apprendimento della lingua italiana, nell'ottica
generale che pone la conoscenza della lingua come condizione di
base per l'inserimento sociale (con particolare attenzione al
mondo del lavoro).
Nella prima metà degli anni '90 la questione che viene alla ribalta
è quella della prima accoglienza. E' il periodo degli sbarchi in
massa, la cui immagine forse più efficace è l'approdo, nei porti
della Puglia, di navi stracolme di persone provenienti
29
Italia sembra essere la presenza e l'arrivo consistente di minori.
Alcuni di loro sono affidati ad uno solo genitore, o a un parente
(con una tutela giuridica quindi da definire). Nei Servizi, i bisogni
degli adolescenti migranti hanno dato avvio a una riflessione sulle
risposte riguardanti la fascia dell'età adolescenziale, a partire dalla
necessità di gestire casi di disagio "nuovi", la cui difficoltà
consiste, in generale, nel riconoscere e distinguere aspetti del
disagio riconducibili alla dimensione culturale e aspetti più
propriamente psicodiagnostici. La vulnerabilità psicologica
(emotiva e cognitiva) degli adolescenti e, in generale, dei minori
migranti è legata ai maggiori rischi, rispetto all'età adulta, di
"scissioni" e conflitti tra il mondo culturale dei genitori e quindi
della cultura di provenienza e il mondo esterno della scuola, dei
pari, dei media, etc.
Un'altra caratteristica attuale riguarda i flussi di immigrazione
clandestina. In realtà è difficile chiarire se, negli ultimi anni, la
novità sia effettivamente tale tipologia d'immigrazione o
l'attenzione sociale e politica riservata a essa. Al centro delle
risposte a tale fenomeno si colloca la questione della "sicurezza
sociale", con accentuazioni e connotazioni diverse, che vanno
dalla strenua difesa del proprio e il rispetto dei diritti fondamentali
delle persone.
L'immigrazione è un dato di fatto dei nostri tempi, è un fenomeno
problematico, ma che porta con sé notevoli opportunità sul piano
sociale economico e culturale, sia per i migranti sia per la società
d'accoglienza. In termini di possibilità il patrimonio generato è
consistente, anche se la convivenza genera diverse questioni,
legate alla complessità sia dei fenomeni migratori, sia della
società d'accoglienza. Le poste in gioco sono tante e non si
limitano alla sfera delle relazioni sociali. Il fatto che nel mondo
attualmente molte persone lascino un paese e si stabiliscano in un
altro è anche un'importante questione politica, nel senso che mette
in gioco la definizione di chi fa parte di un certo sistema sociale e
chi ne è fuori, chi può entrare a farne parte e chi no (Dal Lago,
1998).
Le trasformazioni accelerate del mondo contemporaneo e il
problema scottante del disequilibrio d'opportunità e diritti
richiedono sempre più una riflessione sulla questione dei rapporti
con gli "altri". Una questione che, pur riguardando ovviamente
l'intera dimensione dei rapporti sociali, è messa in risalto dalla
migrazione, un aspetto della vita sociale contemporanea che
genera rapporti con "altri", percepiti come "stranieri".
E' del tutto ovvio che lo "straniero" susciti un minimo di
diffidenza in chi si trova a abitare già un luogo e cioè nei cittadini
del paese d'accoglienza, anche se questo può avvenire in ugual
modo tra persone culturalmente affini, per esempio tra immigrati
di lungo corso e neo-arrivati. Non è l'iniziale diffidenza che
costituisce problema, bensì il rischio che essa subisca una
"metamorfosi" verso forme di paura, chiusura, contrapposizione e
discriminazione, o verso forme meno forti, ma comunque tendenti
a suggerire il controllo e l'ordine sociale come unica possibilità di
convivenza.
Benché le ideologie basate sulla discriminazione sociale siano
ormai considerate visioni culturalmente arretrate1, è lo stesso
elevato il rischio di un loro ritorno sotto diverse spoglie. Un
ritorno che può essere reso con l'idea di un irrigidimento dei
confini tra uno "spazio domestico" e tutto ciò che, percepito come
"altro", può minacciarlo (Escobar, 1997).
La questione dell'"altro" è di una certa complessità. Un accenno
alla ricerca antropologica (la scienza sociale che più di altre ha
reso questa questione il suo principale oggetto intellettuale), può
essere utile per chiarire questa molteplicità.
Augé
(1992)
individua
come
carattere
distintivo
dell'antropologia, rispetto alle altre scienze sociali, l'interesse a
trattare nello stesso tempo e in più sensi la questione dell'altro.
«Essa tratta tutti gli altri: l'altro esotico, definito in rapporto a un
"noi" che si suppone identico (noi Francesi, Europei,
Occidentali); l'altro degli altri, cioè l'altro etnico o culturale che si
definisce in rapporto a un insieme d'altri supposti identici, un
"essi" il più delle volte riassunto con un nome di etnia; l'altro
sociale, l'altro interno in riferimento al quale s'istituisce un
sistema di differenze che comincia con la divisione dei sessi ma
che definisce anche, in termini familiari, politici, economici, i
posti rispettivi degli uni e degli altri, di modo che non è possibile
parlare di una posizione nel sistema (maggiore, cadetto, minore
fra due, principale, cliente, prigioniero…) senza riferirsi a un
certo numero d'altri. L'altro intimo, infine, da non confondere con
il precedente, che è presente nel cuore di tutti i sistemi di pensiero
e la cui rappresentazione, universale, risponde al fatto che
l'individualità assoluta è impensabile…. In alcuni sistemi studiati
dall'etnologia, le rappresentazioni dell'alterità intima ne situano la
necessità al centro stesso dell'individualità, impedendo così d'un
sol tratto di dissociare la questione dell'identità collettiva da
quella dell'identità individuale».(ivi, Pag. 22)
Vorrei considerare la dimensione sociale e politica del rapporto
con l'altro (un altro che è straniero e migrante), mentre in un
precedente lavoro2 ho tentato un'analisi sulla dimensione "intima"
del rapporto, quella relativa ai sistemi di significato sottostanti ai
processi d'identità e relazione
Fenomeno migratorio e immagini sociali
Attualmente, il fenomeno delle migrazioni internazionali ha
assunto una dimensione planetaria e riguarda numerosi paesi in
qualità di luoghi di emigrazione, di immigrazione e di transito.
L'O.I.M. (Organizzazione Internazionale sulle Migrazioni)
calcola che ci siano 185 milioni di migranti "volontari" o
"forzati"; persone che assumono la residenza o che restano, per un
periodo esteso nel tempo, in un altro paese. Gli scenari illustrati
dall'O.I.M indicano l'Italia al quart'ultimo posto come paese di
immigrazione tra i paesi dell'OCSE, ma con un trend di crescita
tra i più alti.
I migranti internazionali appartengono a due ampie categorie:
volontari e forzati. La prima comprende le persone che si
spostano all'estero per motivi di lavoro, di studio, per
ricongiungimento familiare o per altre ragioni personali. La
seconda è costituita da persone che lasciano il loro paese per
30
fuggire da persecuzioni, conflitti, repressioni, disastri naturali,
degrado ecologico e da tutte le altre ragioni che costituiscono una
minaccia per la loro vita, la loro libertà o il loro sostentamento.
La suddivisione è concettuale e riguarda soprattutto i motivi della
migrazione. Di fatto non esiste uno schema preciso di
differenziazione, ma una moltitudine di situazioni che cambiano
nel tempo. Per esempio, nel farsi dell'esperienza migratoria la
distinzione tra volontari e forzati può sfumare o addirittura
confondersi: un migrante volontario può vedere forzata la sua
permanenza nel paese d'immigrazione per cambiamenti avvenuti
nel suo paese, come un migrante forzato può trasformare una fuga
obbligata in un volontario progetto di vita in un altro paese.
Non solo le migrazioni hanno una diffusione mondiale, ma sono
anche un fenomeno storico. Considerando gli ultimi due secoli, la
storia italiana si presta come esempio. Dalla seconda metà
dell'Ottocento ad oggi sono emigrati circa 28 milioni di italiani
(Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti, Argentina, Libia,
Tunisia sono alcune delle mete) e ancora oggi 4 milioni di essi
vivono all'estero. Nonostante ciò, è solo dagli anni '80, con la
trasformazione da paese di emigrazione a paese di immigrazione
e di transito verso altri paesi europei, che il fenomeno migratorio
si è progressivamente costituito come interessante oggetto di
discorso.
Di fatto, i discorsi insistono quasi esclusivamente su una sola
delle due facce del fenomeno: l'immigrazione. L'altra faccia,
costituita dall'emigrazione, rimane spesso nell'ombra anche se,
nella struttura del fenomeno, è cronologicamente anteriore. E'
facile riconoscere una sproporzione considerevole tra il
linguaggio relativo ai due concetti complementari di
immigrazione e emigrazione. Si parla prevalentemente di persone
immigrate, di politiche sull'immigrazione, di servizi per immigrati
etc., quasi a significare che l'interesse nei loro riguardi è motivato
e si limita alla loro presenza sul nostro territorio nazionale e non
si estende alle ragioni della loro emigrazione. A riguardo, Sayad
(1999) esprime una diffidenza di fondo verso una certa
sociologia, molto diffusa in ambito europeo, che sembra avere
come principale finalità la conoscenza degli immigrati per poterli
meglio gestire. Egli propende invece per una sociologia che
s'interroghi sulla dimensione globale del fenomeno migratorio,
che consideri le ragioni e i processi sottostanti alla scelta di certe
persone di emigrare dal loro paese, in connessione ai meccanismi
che rendono disponibili "posti" per loro in altri paesi.
Se da un lato il meccanismo d'interesse che scaturisce
dall'immigrazione più che dall'emigrazione appare ovvio,
dall'altro cela una questione importante, che riguarda il paese
d'accoglienza e i suoi abitanti più che i migranti: la loro presenza
porta a costruire discorsi che sappiano tenere sotto controllo
questa "singolarità".
Analizzando l'emigrazione algerina verso la Francia, Sayad
(1999) individua la problematica dell'ordine sociale e del suo
mantenimento come traiettoria prevalentemente seguita dai
discorsi politici e istituzionali sull'immigrazione, da parte della
società francese. Nella parte del suo lavoro dedicata alla
dimensione politica delle migrazioni, Sayad parla di un "pensiero
di stato", cioè di una forma di pensiero che concepisce
l'immigrazione secondo categorie fondamentalmente nazionali,
atte a tenere sotto controllo la presenza di "corpi estranei" che
possono turbare o mettere a rischio l'ordine sociale e politico.
«Questo modo di pensare è contenuto interamente nella linea di
demarcazione, invisibile o appena percettibile, ma dagli effetti
considerevoli, che separa radicalmente i "nazionali" dai "non
nazionali": cioè, da una parte, quelli che possiedono naturalmente
o, come dicono i giuristi, che "hanno di stato" la nazionalità del
paese (il loro paese), cioè dello stato di cui sono cittadini e del
territorio su cui si esercita la sovranità di questo stato; e, dall'altra,
quelli che non possiedono la nazionalità del paese in cui
risiedono…Anche per tutte queste ragioni si può dire che pensare
l'immigrazione significa pensare lo stato e che "lo stato pensa se
stesso pensando l'immigrazione». (ivi, 1999, pag. 368)
Ovviamente, non è possibile paragonare linearmente le due
situazioni. Per ragioni storiche, politiche e culturali la questione
della "nazionalità" in Francia si pone in modo diverso che in
Italia. Ma potrebbe comunque essere che, anche nel nostro paese,
discorsi prodotti a favore di una comprensione dei migranti,
siano, in realtà, funzionali alla società d'immigrazione; in altre
parole, possano rispondere alla necessità di gestire la presenza di
persone utili alla struttura economico-produttiva, che però, nello
stesso tempo, sembrano mettere in discussione l'ordine sociale.
L'allarme suscitato nell'opinione pubblica dalla questione
migratoria può essere visto come un riflesso di quest'ambiguità.
Un allarme amplificato dall'opera dei media che, se da un lato
pongono spesso l'accento sulla necessità della presenza degli
immigrati per il mondo del lavoro, dall'altro evidenziano episodi
di devianza e criminalità in cui essi sono coinvolti. La
rappresentazione sociale suscitata considera il migrante come la
personificazione di un bisogno economico, sempre però a rischio,
reale o potenziale, di commettere reati. E' così che il senso
comune prefigura i migranti come gruppo dannoso e colpevole
prima ancora che facciano qualcosa (Dal Lago, 1999). In tempi
recenti, la scia lasciata dagli atti terroristici a partire
dall'abbattimento delle "Torri Gemelle" di New York ha reso
acuta la tendenza a considerare la questione migratoria
prevalentemente in termini di sicurezza, coltivando ancor più le
premesse perché l'immagine dell'immigrato possa funzionare da
"capro espiatorio" di tensioni sociali.
Su un piano diverso, l'allarme suscitato dai processi migratori
trova connessioni con l'idea di un "paradigma immunitario" quale
forma centrale e regolativa dell'attuale biopolitica (Esposito R.,
2002). Questo tipo di riflessione individua come strategie
"immunitarie", per esempio, le campagne contro le malattie
epidemiche, gli investimenti per i programmi informatici
antivirus, il "controllo" dei flussi migratori. L'aspetto comune di
queste strategie consiste nel proteggere il corpo (individuale,
elettronico, sociale) dal rischio di un contatto che, nella
fattispecie, potrebbe portare alla morte, bloccare il normale
funzionamento o mettere in discussione un sistema di relazioni.
31
Un "corpo" che si preserva solo a condizione di difendersi
dall'incognita del "contagio", cioè della messa in gioco di ciò che
è custodito in un'identità certa.
carattere di universalità dei "diritti civili", alla base del modello di
convivenza democratica. Si può anche chiudere il discorso
appellandosi a una sua legittimità, sulla base di un diverso status
di cittadinanza, come dire che la questione dei diritti e delle
possibilità si pone in modo diverso tra "noi" (cittadini del paese
ospitante) e "loro" (immigrati). Un'operazione di questo tipo
nasconde però, a mio parere, il rischio che questa
diversificazione, alla lunga, possa compromettere l'esercizio
stesso dei diritti da parte di tutti.
Per quanto riguarda le "origini" di un'idea di alterità vissuta come
possibile minaccia identitaria , mi affido ad alcune riflessioni.
Il primo riferimento è agli studi filosofici di Ricoeur sull'identità
e, soprattutto, sugli elementi che la rendono fragile e quindi da
difendere.
E' nota l'idea di Ricoeur (1990) secondo cui, nella cultura
occidentale, i discorsi sull'identità sono ardui poiché quest'ultima
è implicitamente collegata a due nozioni differenti.
Una prima nozione d'identità che ha a che fare con ciò che non
cambia. E' un modello d'identità che fa riferimento alla
dimensione della persona immutabile nel tempo (Ricoeur cita,
come esempio a riguardo, il codice genetico).
Una seconda nozione d'identità che fa invece riferimento a ciò
che ci permette di essere o sentirci quello che siamo nonostante
tutti i cambiamenti (di desideri, inclinazioni, sentimenti,
condizioni) che avvengono nella nostra esistenza. E' un idea
d'identità che rende il tentativo di ricondurre la discontinuità del
caso alla coerenza di una storia di vita. Questa dimensione
dell'identità assomiglia a una promessa, nel senso della volontà di
mantenere fede a un'idea di se stessi: manteniamo o cerchiamo di
mantenere un'idea di chi siamo, nonostante tutti i cambiamenti,
allo scopo di dare forma accettabile e vivibile alla nostra
esistenza.
Ricoeur denomina le due nozioni rispettivamente "identità idem"
e "identità ipse".C'è quindi un rapporto con il tempo di
invariabilità e un rapporto che ha a che fare con il divenire
inesorabile a cui siamo esposti, un duplice rapporto che si traduce
in quella che Ricoeur definisce "identità narrativa" , cioè la
capacità, oscillando tra i due poli, di mantenere tracce del nostro
passato, legarle a un'idea di futuro e ricomporre l'esperienza di
vita mutevole di ognuno di noi nell'unità di senso di una storia.
La connotazione "narrativa" dell'identità pone nel cuore della
riflessione temi quali: la memoria, la storia, il senso, il racconto,
che si ritrovano in tutta l'opera di Ricoeur, come in buona parte
degli studi a carattere filosofico che hanno trattato il tema
dell'identità (Arciero G., 2002), ma soprattutto abbina la questione
dell'identità a quella del riconoscimento dell'altro.
Nelle sue riflessioni sulla memoria (base dell'identità), Ricoeur
(2000a) si muove costantemente tra il livello della memoria
individuale e della memoria collettiva, argomentando
un'indissolubile legame tra i due livelli. Così facendo riconosce
un legame altrettanto stretto tra identità individuale e collettiva. Il
tema della memoria e quindi dell'identità può essere posto in
termini personali ma è arduo disconoscere come essa sia da
sempre interrelata con la memoria e quindi l'identità degli altri.
L'altro come minaccia
Nei discorsi che tendono a evocare il pericolo rappresentato dalla
presenza di stranieri l'altro non è negato, ma è definito
esclusivamente in rapporto a se stessi collocati al centro. C'è l'idea
di un interno e di un esterno, da cui scaturisce l'idea del cattivo e
del nemico.
E' utile sottolineare che questo "pensiero degli opposti" tende a
creare il conflitto e tale conflitto alimenta e struttura un pensiero
di questo tipo. Una spirale che porta a giustificare culturalmente
la ricerca del dominio da parte del proprio gruppo, comunità,
paese, adducendo a diversità incompatibili e a conflitti inevitabili
I conflitti che riguardano il rapporto con stranieri sono forse
inevitabili. Se da una parte (quella dei migranti) le difficoltà di
inserimento e di concretizzazione di un'accettabile livello di vita
sono all'ordine del giorno, dall'altra (quella degli "ospitanti") tale
livello di vivibilità appare sempre meno scontato. In un tale
contesto in cui, in generale, il benessere appare alla portata di
tutti, ma spesso non risulta effettivamente raggiungibile, le
singole persone, le famiglie, le comunità, non di rado entrano in
conflitto, si chiudono e si contrappongono.
La mia impressione però è che i conflitti con stranieri non abbiano
un grado di inevitabilità maggiore di quello che si ritrova, per
esempio, nei conflitti tra rivali politici, colleghi di lavoro,
condomini, familiari, etc.. La differenza sta forse nel pregiudizio
che, nel caso di rapporti con stranieri, i conflitti prima o poi ci
saranno, date le diversità "culturali" in campo. Un'attesa che
spesso funziona come aspettativa che si autoavvera.
Analizzando i diversi conflitti "interculturali", partendo dai
contesti specifici in cui essi si creano, più che da supposte
diversità culturali, si scoprirebbe probabilmente che la maggior
parte delle ragioni non sono molto diverse da quelle che
contrappongono "non stranieri. In altre parole, è possibile che nel
rapporto con "stranieri" i piccoli e grandi conflitti svelino
significati che oltrepassano le ragioni specifiche del contendere,
per slittare verso una dimensione che ha a che fare con la
definizione di un "noi" (occidentali, comunitari, italiani, …) e di
un "loro" (extracomunitari, islamici, africani….).
Ci si potrebbe chiedere, a riguardo, se anche l'idea stessa di
"multiculturalismo" non contenga in sé il rischio di questo
slittamento: evocando la necessità di riconoscere le diverse
culture, non si finisca invece per fissarle attraverso un pensiero
che traccia nette differenze tra esse e crea quindi le premesse per
una loro contrapposizione.
L'interrogativo di fondo riguarda quindi la percezione dell'alterità
come possibile minaccia della propria identità (individuale e
collettiva): cosa genera e da cosa scaturisce tale percezione ?
In generale, l'idea dell'altro come minaccia genera un pensiero
che legittima un restringimento degli spazi sociali e di diritto. E'
agevole riconoscere che qualsiasi differenziazione tra le parti (tra
chi accoglie e chi migra) costituisce una contraddizione rispetto al
32
Le lenti proposte da Ricoeur rendono impossibile pensare
all'identità come a un'entità sostanziale e immutevole,
suggeriscono piuttosto un'idea d'identità che prende forma, in un
movimento continuo, tra la dimensione costante di se stessi e il
continuo fluire della propria esistenza, tra un'idea di sé e un'idea
di collettività a cui si sente di appartenere.
Questa complessa dinamica, che noi gestiamo facendo ricorso a
costruzioni narrative, contiene implicitamente alcuni elementi
forti di fragilità (Ricoeur, 2000b)
Una prima fonte di fragilità consiste nel difficile rapporto con il
tempo. E' agevole riconoscere che "mantenere una promessa", per
restare fedeli a se stessi è spesso un'impresa difficile, che può
spingere le persone ad ancorarsi a un'identità rigida immutabile,
la stessa che si ritrova nei discorsi che sanciscono il suolo o
l'appartenenza etnica come elemento cardine dell'identità.
dell'identità comune. Un discorso che si pone al servizio di una
"chiusura identitaria della comunità", che legittima l'idea di
preservarla e difenderla da minacce esterne.
L'ultima causa di fragilità a proposito d'identità è "l'eredità della
violenza fondatrice"
«Quelli che celebriamo a titolo di "avvenimenti fondatori", altro
non sono - in ultima analisi - che atti violenti legittimati a cose
fatte da uno Stato di diritto precario, e - al limite - dalla loro
antichità». (Ricoeur, 2000b, par III)
In questo caso l'idea cardine è che l'identità collettiva (di una
comunità, un paese, una nazione) si basa su racconti di guerre,
scontri, vittorie che, ovviamente, contemplano , tra i personaggi,
amici e nemici. Ricoeur sostiene che, se al livello delle relazioni
private ci sono ampi spazi di mediazione, al livello di Stati, lo
schema amico-nemico ancora prevale. Questo equivale a dire che
la memoria e quindi l'identità collettiva non rinuncia alla nozione
di "nemico". Le guerre, ma soprattutto l'idea di legittimità
all'omicidio del nemico che esse presuppongono, sono
palesemente una testimonianza di questa oscura fragilità.
Questi elementi di fragilità, contribuiscono a chiarire i motivi per
cui lo "straniero" funziona, soprattutto a livello collettivo, come
immagine del pericolo da cui difendersi.
Il secondo riferimento è a studi antropologici. Il fuoco si sposta
sul terreno delle "differenze". Analizzando la questione del senso
sociale inteso come senso delle relazioni, Augé (1994) riconosce
che esso si distribuisce su due assi. Sul primo (denominabile asse
delle appartenenze o dell'identità) si definiscono le relazioni che
un individuo ha all'interno delle collettività a cui partecipa, a cui
sono legate diverse identità di classe (il termine è usato nel senso
logico, cioè denomina l'appartenenza, per esempio, a un dato
paese, a una comunità linguistica, a una famiglia…). Sul secondo
(denominabile asse delle relazioni o dell'alterità) si definiscono le
relazioni con altri individui al di fuori di queste collettività. Il
primo asse mette in gioco principalmente le categorie di
individuale/collettivo, mentre il secondo le categorie più astratte
di medesimo/altro in chiave sia individuale, sia collettiva. Augé
non considera l'alterità un elemento in gioco solo nelle relazioni
riconducibili al secondo asse (è evidente, per esempio, che c'è
dell'alterità anche tra persone della stessa famiglia), ma
suggerisce che in esse l'alterità tende a essere rappresentata in
chiave di "altro culturale" più che in chiave di "altro individuale".
Questa prospettiva contribuisce a chiarire come mai nei rapporti
con "stranieri" le diversità sono rappresentate prevalentemente in
termini di "differenze culturali". Non si tratta di stabilire se queste
differenze sono più o meno effettive e operanti, ma di riconoscere
che esse tendono a oscurare rappresentazioni in chiave di
"differenze individuali", generalmente in gioco nei rapporti
interni alle proprie collettività. Un'ipotesi possibile è che
indebolire la polarità medesimo/altro, riconoscendo all'altro
"lontano" un'alterità simile a quella riconosciuta all'altro "vicino",
costituisca una forte perturbazione per l'universo simbolico
sottostante le relazioni di appartenenza e identità.
«Dirò che la tentazione identitaria, la "follia identitaria", come
dice Jacques Le Goff consiste nel ripiegarsi dell'identità-ipse
sull'identità-idem, o se preferite, nello scivolamento, nella deriva
dalla duttilità propria della capacità di restare fedeli a se stessi,
mantenendo una promessa, alla rigidità inflessibile di un
carattere, nel senso quasi tipografico del termine». (Ricoeur,
2000b, par. II)
Penso che assumere, per esempio, l'appartenenza nazionale come
elemento distintivo assoluto d'identità sveli questo elemento di
fragilità.
Una seconda fonte di fragilità è il difficile rapporto con l'altro, che
genera difesa, rigetto, invidia, tutte reazioni, in un certo qual
modo, comprensibili e paragonabili, sul piano biologico, alle
difese immunitarie. Un aspetto assolutamente da considerare è,
tuttavia, che il senso di minaccia rappresentato dall'altro arriva ad
assumere un rilievo spropositato a livello collettivo.
«Anche le collettività hanno un problema di difesa immunitaria,
quasi biologica. È appunto a questo livello di grande dimensione
che si lasciano leggere fenomeni che non hanno affatto
equivalenti, sul piano personale, […] Si tratta di fenomeni di
manipolazione che si possono attribuire a un fattore inquietante e
multiforme che si frappone fra la rivendicazione identitaria e le
espressioni pubbliche della memoria. Questo fenomeno ha un
legame stretto con l'ideologia, il cui meccanismo resta volentieri
dissimulato; a differenza dell'utopia, con la quale l'ideologia suole
essere accoppiata, esso rimane inconfessabile; si maschera
trasformandosi in denuncia contro gli avversari nella
competizione fra le ideologie; è sempre l'altro che s'infogna
nell'ideologia». (Ricoeur, 2000b, par II)
Ciò che Ricoeur spiega è che l'ideologia e gli ideologi
intervengono nel processo di identificazione di una collettività a
livello narrativo, con strategie selettive di rievocazione o oblio
che autorizzano alcuni elementi della storia e ne escludono altri,
in funzione di un discorso chiuso, definito, che costruisce un
insieme selezionato di elementi storici presentati come basi certe
33
E' implicito che in una visione rigida dell'alterità si tende a
oggettivare una cultura nazionale o, su scala ingrandita, una
cultura di un'area transnazionale, ma questo significa trascurare la
complessità di reti sociali e posizioni individuali che non si
lasciano mai completamente derivare dalla cultura definita. L'idea
di una cultura unitaria e distinta, legata a una memoria di
fondazione e a una delimitazione sociale del luogo rivendicato
come proprio, appare una semplificazione che risponde
all'esigenza di delineare una frontiera certa tra l'universo di
identità (di posizioni riconosciute e relazioni interne istituite) e il
mondo esterno, assimilato all'estraneità, che minaccia
potenzialmente il proprio.
Ci sono sicuramente altre riflessioni utili a districare il difficile
tema dell'identità e della minaccia costituita dall'altro. Penso che
gli studi citati siano però sufficienti per evidenziare il carattere di
fragilità dei processi identitari. Paradossalmente, più tale fragilità
si manifesta, più l'idea di un'identità forte s'impone,
accompagnata dall'idea di difendere dalla minaccia esterna uno
"spazio domestico", in cui sia agevole riconoscersi e riconoscere
l'altro vicino.
Penso che orientarsi verso lidi diversi da quello costituito da uno
"spazio domestico" necessariamente da difendere, possa generare
insicurezza e spaesamento, ma penso anche che tale rotta possa
essere utile per crearsi contesti di maggiore vivibilità. Forse,
azzardando un po', può essere utile anche per mantenersi liberi o
disfarsi dai pensieri "silenziosi" che, nella storia dell'umanità,
hanno sorretto pratiche ora considerate aberranti come il razzismo
o la shoah. Non è la lontananza storica a metterci al riparo da
queste e altre catastrofi, piuttosto l'interesse e il rispetto per ciò
che "si fa presente" e appare "diverso", da sempre base per
vantaggiosi cambiamenti.
Uno sguardo storico rafforza l'idea che le "diversità",
incontrandosi tra loro, alimentino processi evolutivi e creativi.
Considerando, per esempio, la storia dei popoli europei (vedi
Bocchi G. Ceruti M., 1994), nonostante i nazionalismi vecchi e
nuovi, le istanze regionaliste e federaliste, la volontà dell'ultimo
secolo di disegnare i confini nazionali su base etnica, si può
riconoscere come le diversità (culturali, linguistiche, religiose,
etc.), entrando in relazione, abbiano dato vita a unioni, divisioni,
trasformazioni, intrecci che costituiscono la risorsa principale
della vivacità stessa della civiltà europea. Una "cultura", un
popolo che non attinge allo scambio reciproco può anche avere
una certa egemonia per un periodo, ma è orientato verso la
riproduzione di se stesso e quindi verso l'isolamento.
in modo "incarnato", vale a dire trasferendosi là dove si pensa di
poter trovare possibilità di vita migliore. In questo senso, la
condizione di migrante è un'"anomalia", rispetto a un sistema
economico e sociale che prevede lo spostamento piuttosto
agevole di flussi finanziari e insediamenti produttivi in tutto il
mondo, ma che non prevede con la stessa facilità lo spostamento
di persone. Un sistema che cerca di governare (nel migliore dei
casi) o contrastare la volontà di molte persone di migrare verso
certi paesi, poiché la loro presenza in essi può costituire un
problema.
Analizzando la nozione di "luogo antropologico", cioè la
"costruzione concreta e simbolica dello spazio" a cui, coloro che
vi vivono, attribuiscono valore identitario, relazionale e storico,
Augé (1992) ribalta i termini della questione. Se i migranti sono
percepiti come potenziale minaccia non è dovuto tanto alla loro
presenza, che susciterebbe la preoccupazione di difendere
condizioni acquisite, valori territoriali e "identità", bensì
soprattutto alla loro assenza dal luogo di origine.
«Se gli immigrati allarmano tanto (spesso assai astrattamente) gli
"indigeni" è forse innanzi tutto perché essi dimostrano la relatività
delle certezze iscritte nel suolo. E' l'emigrato ciò che nel
personaggio dell'immigrato li allarma e li affascina allo stesso
tempo». (ivi, Pag. 109)
Come dire che, se s'immagina un legame determinante tra luogo
e identità culturale, allora la presenza di persone che hanno
volontariamente rinunciato al loro luogo, appare una trasgressione
minacciosa all'ordine simbolico dell'appartenenza.
Volendo sintetizzare le due prospettive, si potrebbe dire che la
presenza dei migranti, unita alla loro scelta di lasciare il posto di
origine suscita timori poiché evoca, da una parte, la necessità di
mettere in comune ciò che si è soliti considerare a propria
esclusiva disposizione (le abitazioni, i posti di lavoro, i Servizi,
gli spazi pubblici e sociali, i mezzi di trasporto, le strade, etc.);
dall'altra, evoca la relatività di un senso di appartenenza che si
esprime attraverso il linguaggio del luogo e delle radici. Se così
fosse, il quadro dei rapporti sociali, in un contesto di migrazioni,
assume connotati complessi, che vedono intrecciarsi una
dimensione politica (la definizione di chi ha accesso a determinati
luoghi e risorse e a quali condizioni) e una dimensione
epistemologica rappresentata dall'incontro con persone "altre",
nel duplice senso di persone culturalmente diverse e di persone
disposte a vivere l'ignoto rappresentato dalla lontananza dal
proprio luogo di origine.
Il fenomeno migratorio appare, nello stesso tempo, uno scandalo
(di una presenza che si rende visibile là dove non dovrebbe
essere) e una testimonianza (di una possibilità di riscatto e di vita
lontano dal proprio luogo). Indipendentemente dalle reazioni che
suscita (senso di minaccia o curiosità) esso svolge un'importante
"funzione specchio" (Palidda, 2002), può cioè rivelare
contraddizioni, modelli organizzativi, riferimenti relazionali e
aspetti culturali impliciti della società di "accoglienza". Il
riconoscimento dell'utilità di questa funzione dipende dal
Anomali viaggiatori
La migrazione di milioni di persone dal proprio paese, con il
conseguente loro inserimento nei diversi contesti (urbani, sociali,
abitativi, di Servizio, …) di un altro paese, è una sorta di
testimonianza delle disparità su scala mondiale e,
contemporaneamente, di una possibilità di riscatto, che consiste
nel farsi presente in un contesto sociale (quello d'immigrazione),
allo scopo di poter condividere la creazione e l'utilizzo di risorse.
Una testimonianza di una volontà di praticare la "globalizzazione"
34
pensiero che si vuole porre alla base dei rapporti tra paesi, culture,
gruppi e persone. Una concezione etnocentrica delle relazioni
esclude ovviamente l'utilità di autoconoscenza e di ricerca sugli
impliciti che reggono le forme sociali di convivenza; mentre l'idea
che per una società e per i suoi abitanti sia utile tenere aperta
l'opportunità di modificarsi valorizza l'occasione offerta
dall'incontro.
Penso che l'incontro con persone "atipiche" per quanto riguarda il
diritto di cittadinanza, la lingua, le abitudini di vita, i modi di
esprimersi e posizionarsi nei contesti sociali, offra la possibilità e,
in parte, "costringa" a riflettere anche su se stessi. L'incontro con
questa "anomalia", sia che la si voglia controllare o annullare, sia
che la si voglia conoscere e incontrare, mette fortemente in gioco
la propria visione dell'altro e di se stessi e la visione sociale dei
rapporti. Un coinvolgimento che, per chi vuole, crea le condizioni
per una pratica riflessiva che riconosce l'identità e la relazione con
l'altro come le due facce di un medesimo processo che mette a
confronto ogni individualità e ogni collettività con l'immagine del
mondo in cui vive.
Note
1
Un recente dossier del "Correo de la UNESCO" (2001) illustra come il razzismo istituzionale, ultimo sostegno del mito
dell'inferiorità congenita di alcune razze, è finito con l'apartheid. Attualmente il razzismo appare totalmente screditato, grazie a una
serie di progressi compiuti dalla comunità internazionale, a partire dall'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
nel 1948. Nel contesto occidentale, sotto la pressione delle campagne antirazziste, il mito della superiorità razziale ha perso parte del
suo potere, almeno quella forza che ha permesso di regolare rigidamente, in modo sbilanciato e per lungo tempo le relazioni tra
gruppi, la forza che è stata, per esempio, necessaria per gestire la tratta dei neri o lo sterminio degli ebrei.
2
Vedi "Processi migratori e relazioni sociali. Uno sguardo su se stessi attraverso l'altro". Animazione sociale n.10 ottobre 2003.
Bibliografia
AA.VV. (2001) Racismo: un mal sin fronteras, in El Correo de la UNESCO settembre 2001.
Arciero G. (2002) Studi e dialoghi sull'identità personale. Riflessioni sull'esperienza umana, Bollati Boringhieri, Torino.
Augé M. (1992) Non-lieux, trad. dal Francese di Rolland D. Nonluoghi introduzione ad una antropologia della surmodernità,
Elèuthera 1993.
Augé M. (1994) Le sens des autres. Actualitè de l'anthropologie, Librairie Arthème Fayard, trad. it. di Soldati A., Il senso degli altri.
Attualità dell'antropologia, Bollati Boringhieri, 2000.
Bocchi G. Ceruti M. (1994) Solidarietà o barbarie, Cortina.
Escobar R. (1997) Metamorfosi della paura, Il Mulino.
Esposito R. (2002) Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi.
Dal Lago, a cura di (1998) Lo straniero e il nemico, Costa e Nolan.
Dal Lago (1999) Nonpersone. L'esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli .
Palidda S. (2002) Introduzione all'edizione italiana, in Sayad A. La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze
dell'immigrato, Cortina 2002.
Ricoeur P. (1990) Soi-méme comme un autre, trad it. Sé come un altro, Jaca Book 1993.
Ricoeur P. (2000a) La mémoire, l'histoire, l'oubli, Editions si Seuil, Paris, trad. It. La memoria, la storia, l'oblio, Cortina 2003.
Ricoeur P. (2000b) L'identità fragile. Rispetto dell'altro e identità culturale, in Alternative, n° 5, 2004.
Sayad A. (1999) La double absence, tr. it. a cura di Palidda S. La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze
dell'immigrato, Cortina 2002.
35
I fenomeni migratori
Metodo e prospettiva critica di Abdelmalek Sayad
di Paolo Borghi
agente estraneo de-politicizzato, a "malato immaginario"4. Alcuni
etnografi direbbero che in fondo le migrazioni algerine in Francia
(e i migranti algerini) di cui parla Sayad, sono il frutto di un suo
approccio, di un suo punto di vista, di un testo in cui l'autore
scrive ciò che ha interpretato di ciò che i suoi interlocutori gli
hanno saputo e voluto dire. Sarebbe quindi una pura costruzione
intellettuale, se volessimo portare fino ad un relativismo estremo
l'approccio ermeneutico? Per capire la prospettiva di Sayad ci
vengono in aiuto le sue stesse parole. Da un lato fa una critica
esplicita ai discorsi ufficiali e dominanti della società
interrogandosi sulla necessità di costruire una prospettiva
scientifica:
L'aspetto che richiama immediatamente l'attenzione nella lettura
di “La doppia assenza”1 è la tensione etico-politica che pervade
ogni pagina di quest'opera. Un'ostinata voglia di capire e di fare
giustizia anche e prima di tutto rispetto a quelle scienze sociali
che masticano, definiscono e consumano i propri oggetti di
ricerca come fossero semplice carburante per la propria
legittimazione, rispetto ad un certo tipo di scienza sociale in
qualche modo organica e adattabile alle esigenze del potere e
strumento indispensabile al suo esercizio. Dalla scelta di
autoescludersi dai percorsi accademici, di non incasellarsi in
qualcuna delle scuole di pensiero, allineate e non, scaturisce tutta
l'originalità e la solitudine intellettuale dell'opera di Sayad.
Efficace è il ritratto che ne fa Salvatore Palidda nell'introduzione
all'edizione italiana:
"[…] forse bisogna chiedersi perché si parla e in che modo si
parla di questo soggetto, l'immigrato. Non è un paradosso
affermare che l'immigrato, colui di cui si parla, è in realtà
l'immigrato così com'è stato rappresentato e determinato, o come
viene pensato e definito. Non esiste oggetto sociale più fortemente
determinato dalla percezione che ne abbiamo, percezione che a
sua volta determinata dalla definizione astratta a priori che ci
siamo dati della popolazione degli immigrati come oggetto. Dato
che il discorso sull'oggetto fa parte dell'oggetto di studio e
richiede di essere considerato tale, bisogna rompere con la
fenomenologia per trasformare in problema sociologico ciò che
rappresentava solo un problema sociale, atto a provocare
indignazione o scandalo ma non tale da originare uno studio
scientifico"5.
"La sua critica sia degli aspetti brutali sia di quelli paternalistici
del colonialismo francese non si confonde mai con
l'anticolonialismo sedicente marxista, né con quello dei
terzomondisti allineati al "grande fratello" sovietico, né ancora
con quello dei non-allineati poi finiti allo sbando o a destra. Lo
spirito critico di Sayad assomiglia piuttosto a quello di Hannah
Arendt: lui non poteva essere populista, non sarebbe mai stato
l'"intellettuale organico" né dei Cabili, né dell'Algeria libera,
tanto meno di un partito o di un'ideologia. Come un Foucault del
colonialismo e delle migrazioni, tutta la sua opera si è sviluppata
nella costante analisi critica dell'esercizio del potere e del modo
in cui il potere stesso viene assorbito dai corpi e dalle menti,
attraverso la sua interiorizzazione da parte dei dominanti"2.
Dall'altro definisce le modalità di accesso alla sfera dei simboli e
delle prospettive dei migranti attraverso un approccio etnografico:
Di fronte alla complessità dell'approccio al fenomeno migratorio
proposto da Sayad si può non essere d'accordo su alcuni aspetti
del suo ragionamento, ma non si può fare a meno di riconoscerne
la tenacia analitica che crea un persuasivo "effetto verità" difficile
da confutare. Frutto delle ricerche di una vita, l'opera di Sayad
travalica l'asfittico rigore metodologico che annulla l'elasticità
indispensabile ad una profonda ed efficace analisi critica.
Etnografia e sociologia si intrecciano: le lunghe interviste
riportate nel testo sono "testimonianze esemplari"3 diventando
così strumento per generalizzazioni autorevoli ed argomentate, i
dati statistici sui flussi migratori, sulle rimesse degli immigrati, le
condizioni storico-politiche che interagiscono con l'andamento
dei progetti migratori invece contribuiscono a creare uno sguardo
d'insieme sul fenomeno rendendone esplicita la complessità
restituita a quei "corpi migranti" la cui esistenza viene ridotta dal
sapere-potere dominante a semplice forza lavoro, a problema, ad
"C'è qualcosa che può consentire e incoraggiare l'uso del
discorso raccolto, raccolto senza dubbio in piena fiducia (cioè
dimenticando la relazione da intervistato a intervistatore e, a
tratti, la relazione simmetrica da intervistatore a intervistato.
Questo 'oblio' è senza dubbio la condizione della fiducia ma
anche in modo più certo, l'effetto dello stabilirsi della fiducia).
Questo qualcosa è una specie di sollievo, perfino di gioia visibile
benché effimera, che è seguita dal momento decisivo in cui le
parole più dolorose, quelle più 'trattenute', sono state
pronunciate. Come hanno confessato lo stesso intervistato e i suoi
testimoni, è stato 'come un velo che si è sollevato'"6.
La sociologia quindi, o meglio la socio-antropologia7 (prendendo
a prestito la definizione di O. De Sardan), ha per Sayad una
36
funzione che travalica la scienza, ambito in cui egli stesso la
colloca. Parlare di migranti e di emigrazione in un contesto in cui
il discorso dominante riduce i migranti ad "immigrati", equivale
ad una denuncia forte e greve di conseguenze oltre che a definire
un nuovo ambito scientifico. Parlare di "emigrazione" equivale a
una sorta di riscatto (postumo?) di una figura sociale che
concentra su di sé gli effetti della violenza sociale che si manifesta
nelle strutture oggettive entro cui si muovono l'individuo e le
classi di individui con le loro soggettività. La scelta politica di
parlare delle forme di esclusione, di riduzione e subordinazione
dei migranti, delle "assenze" da loro vissute, determina la
prospettiva adottata da Sayad e ad esse e alla sua autorevolezza
fanno riferimento anche coloro che scelgono di studiare i migranti
da altre prospettive. Ruba Salih8 ad esempio si concentra sulle
problematiche legate alla gestione di una doppia identità del
migrante che torna al paese d'origine, o Bruno Riccio che parla
addirittura di una "doppia presenza" dei migranti9. Riuscire a
valutare le conseguenze della prospettiva scelta da Sayad, nei suoi
pregi e nei suoi limiti, è assai difficile o paradossalmente troppo
facile. Quando si sceglie di non separare la dimensione politica da
quella analitica si compie un gesto sovversivo che mette in
discussione anche il ruolo della stessa "scienza" che parla degli
altri, che li definisce. I detrattori di questa prospettiva si
richiamano solitamente al rispetto della "scientificità" della
ricerca, ma generalmente occultano dietro una pretesa obiettività
le aspettative e le esigenze dei loro committenti che fanno politica
ed utilizzano anche la "scienza" come strumento:
invariabilmente prigioniero delle maglie della sua cultura
d'origine. Una sociologia che invece si preoccupi di allargare il
suo orizzonte d'indagine potrebbe far luce su molti aspetti per
troppo tempo "dimenticati":
"soltanto la ricostruzione integrale delle traiettorie degli emigrati
può rivelare il sistema completo delle determinazioni che, avendo
agito prima dell'emigrazione e avendo continuato ad agire in una
forma modificata durante l'immigrazione, hanno condotto
l'emigrato all'attuale punto conclusivo"11.
In questa prospettiva quindi l'"immigrazione" diventa solo una
fase di un percorso più ampio in cui si possono riconoscere
variabili d'origine12 e variabili di conclusione13. Focalizzarsi sulle
traiettorie dei migranti e sulle loro specificità significa eliminare
quella che Sayad chiama "l'immagine stereotipata della noria"14,
quell'immagine dell'immigrazione ridotta a flusso e riflusso di
esseri umani sempre nuovi ed identici: contadini maschi che
emigrano per un periodo limitato.
Se quest'immagine corrisponde almeno in parte alla prima fase
della migrazione algerina in Francia (fino al 1945 circa), la sua
permanenza in forma di stereotipo risponde alle esigenze di più
parti: al paese d'origine, al paese d'approdo, agli immigrati stessi,
riproducendo l'idea di una emigrazione inoffensiva che non turba
l'ordine:
"Non l'ordine contadino della società d'origine, che per
assicurare la propria salvaguardia e la propria riproduzione, è
costretta a 'delegare' alcuni membri dell'emigrazione. Non
l'ordine morale, politico e sociale del paese d'accoglienza, che
può ricevere e utilizzare gli emigrati tanto facilmente e in numero
tanto elevato da permettersi di trattarli come se non facessero
altro che 'transitare'. Non l'ordine degli emigrati stessi che divisi
tra due paesi, due universi sociali, due condizioni divergenti sotto
ogni aspetto, si sforzano di mascherare e mascherarsi le
contraddizioni della propria situazione, convincendosi del suo
carattere 'provvisorio' quando essa ha una grande possibilità di
diventare definitiva o di estendersi alla vita attiva"15.
"[…] il modo più pernicioso di sovvertire l'immigrazione,
assicurando il dominio più totale che può essere esercitato su di
essa, è spoliticizzarla. Ora, il modo migliore di spoliticizzare un
problema sociale è quello di tecnicizzarlo o di farlo rifluire
totalmente nel campo della morale"10.
Sarebbe troppo semplice quindi screditare la prospettiva di Sayad,
tacciandola di eccessiva politicizzazione; è necessario accettare il
suo sguardo, particolare e di parte, per poterlo leggere
proficuamente ed eventualmente criticare.
Tre sono le fasi dell'emigrazione algerina in Francia così come
definite da Sayad. In questo percorso diacronico il migrante
risulta diventare progressivamente espulso (o autoespulso) prima
dalla società d'origine (fase di "decontadinizzazione" e di
proletarizzazione) poi dalla stessa società francese, come risultato
di una mancata assimilazione.
Le tre "età" dell'emigrazione
Una delle questioni di fondo su cui si concentra il discorso di
Sayad riguarda la necessità di affrontare il fenomeno migratorio
considerando anche le condizioni d'origine del migrante.
Diversamente, la negazione di questa dimensione porta ad
adottare un inevitabilmente sguardo etnocentrico. Il migrante
algerino, oggetto, o meglio soggetto principe dell'opera di Sayad,
viene ridotto dalla scienza sociale istituzionale ad "immigrante",
cioè colui che acquisisce una sua (limitata) visibilità solo nel
momento in cui arriva nella società di destinazione e viene
"misurato", studiato, sezionato, classificato in base alle sue
capacità di adattarsi alle norme e alle prassi di tale società. Risulta
inevitabile che questo tipo di sguardo produca un sapere che gioca
sulle manchevolezze e sulle incapacità dell'immigrato
Prima fase: un'emigrazione "ordinata"16
Come si accennava poco sopra, la prima fase dell'emigrazione
algerina scaturì dalla necessità di fornire alla società contadina,
principale e quasi esclusivo contesto da cui ebbe inizio
l'emigrazione, i mezzi per continuare a riprodursi. In questo
ambito l'emigrazione assunse un significato ben preciso: scelta
temporanea, limitata nel tempo, reversibile perché legata ai tempi
37
dettati dall'attività agricola, funzionale al perpetuarsi delle attività
contadine e quindi della società contadina stessa. L'emigrante
conservava quindi, agli occhi degli altri membri della società,
un'immagine positiva in quanto soggetto deputato "socialmente"
ad acquisire risorse indispensabili e proprio in virtù di questo
compito fondamentale, veniva scelto fra gli uomini "di fiducia".
Significativa a tale proposito è l'intervista ad un anziano riportata
da Sayad:
"Chi mandi al mercato per comperare e per vendere? Mandi
qualcuno di cui ti fidi. Non ci mandi un bambino che può 'farsi
prendere in giro', che si lascia sedurre fino all'inganno: lo fai
accompagnare da qualcuno di cui sei certo. Non ci mandi
neanche quello che rischia di abusare di te, perché ritornerà con
le mani vuote […] La Francia è come il mercato, è un altro
mercato, un grande mercato che dura più di una giornata…"17.
In questa prima fase quindi frequenza e durata dell'emigrazione
sono definiti dai ritmi e dalle esigenze della società d'origine e la
reiterazione dell'emigrazione da parte dello stesso soggetto è
comunque considerata come un atto unico: "Siamo come le pulci,
non appena abbiamo riscaldato il nostro posto saltiamo via"18.
L'individuo non compie una scelta egoistica, di rottura, anzi si
trova nella situazione di poter contribuire alla sopravvivenza della
sua comunità ed il periodo di lontananza è vissuto come una
prova: il "contadino autentico" (bou-niya)19 deve dimostrare di
riuscire a rimanere legato alla sua comunità, al thamourth20
(famiglia, gruppo agnatizio, villaggio, comunità nel suo insieme)
continuando a pensare e ad agire come un vero contadino. Questa
forma di resistenza, sostiene Sayad, si manifesta anche e
soprattutto nella forte coesione della comunità dei migranti,
proiettati verso il ritorno al proprio paese. L'esperienza
dell'emigrazione-immigrazione è vissuta come l'elghorba21
(l'esilio) lontano dal kanoun22 (il focolare domestico) ed i suoi
aspetti più problematici e contraddittori vengono giustificati
collocandoli all'interno di un'attività provvisoria e "falsa" ma
necessaria al sostentamento delle attività agricole, centrali per la
comunità d'origine. Il ritorno del migrante quindi si configura
come una "reintegrazione"23 che prevede nella sua ritualità la
visita alla terra coltivata, al bestiame, alla comunità. Emigrare per
poter acquistare bestiame o coltivare il terreno è una questione
d'onore (nif24).
Seconda fase: la decontadinizzazione
Nel passaggio dalla prima alla seconda generazione di migranti si
consuma, secondo Sayad, il processo di "decontadinizzazione": il
progetto di migrazione cessa di essere inscritto in una strategia
collettiva per diventare espressione dell'aspirazione ad un
individualismo economico e sociale mutuato dalla società
d'immigrazione:
"Mentre il primo emigrato poteva continuare a pensare se stesso
come contadino anche se non aveva la possibilità di comportarsi
realmente da contadino, l'emigrato della 'generazione' successiva
ha smesso di essere contadino nello spirito e nelle intenzioni,
indipendentemente dall'emigrazione e spesso molto prima di
essere emigrato"25.
Un aspetto interessante che viene rilevato in corrispondenza di
questo passaggio generazionale, collocabile intorno alla periodo
successivo alla seconda guerra mondiale, è la progressiva
diminuzione dell'età media della popolazione algerina immigrata
in Francia, segno probabile di differenti progettualità insite nella
migrazione. Gli anni '60 vedono una forte espansione della
popolazione urbana nelle principali città algerine che diventano la
prima tappa della migrazione verso la Francia.
Contemporaneamente si diffonde una nuova forma di relazione
tra i soggetti migranti e la loro comunità d'origine. Ora gli aiuti
alla famiglia rimasta in Algeria si fanno più regolari
(generalmente a cadenza mensile), le rimesse servono a "coprire
bisogni identificabili e prevedibili"26 a differenza della fase
precedente in cui il migrante raccoglieva l'intera somma di denaro
da spedire in Algeria o addirittura lavorava per ripagare il debito
contratto al suo arrivo in Francia, quella somma di denaro che
veniva prontamente spedita alla famiglia e necessaria all'attività
agricola. In questa fase il periodo di permanenza in Francia si
allunga e soprattutto il rientro in Algeria viene calcolato in
funzione dei ritmi dell'attività industriale. L'identità sociale del
migrante si definisce sempre di più in funzione della sua
condizione di immigrato-lavoratore anziché rispetto a quella di
contadino-emigrato; anche in questo caso Sayad riporta delle
interviste "esemplari" che raffigurano schiettamente l'immagine
che gli emigranti hanno di loro stessi e sottolinea quanto
complessa e carica di significazione possa essere la relazione fra
chi è rimasto e chi se ne è andato, fra chi è rimasto e chi torna:
"Se per caso l'emigrato 'in vacanza' accetta di partecipare ai
lavori agricoli e ad altri atti di devozione contadina (vista alle
terre, riti agrari), è a condizione che lo possa fare 'a modo suo',
in quanto 'emigrato', cioè a suo piacimento (un po' per gioco e un
po' per esibizione,) e secondo le 'abitudini francesi'"27.
L'emigrato che ritorna per le vacanze è un "invitato a casa
propria"28. Il testo di Sayad non si sofferma su ciò che potremmo
chiamare "etnografia dei ritorni", tema toccato da Ruba Salih nel
trattare le problematiche legate alla gestione di una doppia
identità (quella della quotidianità nel paese di immigrazione e
quella ostentata e attesa nel paese di provenienza) che le donne
marocchine si trovano a gestire nel momento in cui tornano in
Marocco per far visita ai familiari. Questi ed altri sono gli spazi
dell'etnografia, spazi d'indagine che anche il testo di Sayad
suggerisce.
Terza fase: completamento della proletarizzazione
E' questa la fase in cui si completa il distacco dalla comunità di
origine iniziato già in precedenza con la decontadinizzazione e la
38
proletarizzazione dei migranti. Anche in questo frangente la rete
degli emigrati costituisce un punto di riferimento indispensabile
per risolvere le problematiche dei nuovi migranti e allo stesso
tempo si configura come struttura di intermediazione con la
società d'origine, mantenendo viva la necessità di alimentarne i
legami e ricordando gli obblighi verso di essa: per i migranti di
prima generazione ciò si traduce in un rinnovato ricordo e
sacrificio in favore della terra e della comunità contadina, per
quelli di seconda generazione in un più circoscritto obbligo verso
la famiglia la cui struttura gerarchica risulta comunque cambiata
rispetto al passato. Se nei decenni precedenti il linguaggio
comune rimarcava gli obblighi dei figli verso i padri, ora nella
retorica quotidiana vengono esplicitati anche gli obblighi dei
genitori verso i figli, i primi diventano "assistiti", i secondi
"protettori". La comunità dei migranti è per l'immigrato una sorta
di "proiezione in Francia del 'grande paese' di cui è originario
l'emigrato"29 mantenendo in vita quel senso di provvisorietà della
condizione del migrante che occulta la più realistica condizione di
migrante a vita. Lo stralcio di intervista riportata qui di seguito
esprime efficacemente quale possa essere l'idea che l'emigrato ha
di se stesso:
tratti salienti, per altre migrazioni. Potrebbe essere interessante
fare un confronto puntuale fra il modello proposto da Sayad ed i
modelli di Böhning30 e di Castles e Miller31. Se il pregio di tali
modelli è di costruire, attraverso un processo di astrazione, un
percorso diacronico leggibile e coerente per un fenomeno così
complesso e centrale, quale è quello della migrazione, lo stesso
processo di astrazione lascia aperte molte questioni, in primo
luogo la sua legittimità quando si dispiega in una forma
totalizzante e onnicomprensiva. In un'ipotetica comparazione dei
diversi modelli, si potrebbero rilevare molte incongruenze, anche
limitandosi ad analizzarne i tratti salienti. L'esemplarità di cui
parla Sayad a proposito della migrazione algerina in Francia va
ricondotta non tanto ad una rappresentatività strumentale che
legittimerebbe una sua applicazione a fenomeni migratori legati
ad altri contesti sociali, politici ed economici, ma ad
un'esemplarità rappresentativa della "condizione umana" del
migrante. La forza di tale modello scaturisce sia dalla scelta
coraggiosa di trattare il fenomeno migratorio come una questione
anche politica, sia dando voce ai migranti stessi attraverso le
interviste riportate nel testo che dedicando più attenzione alle
condizioni sociali, economiche, politiche nella società d'origine.
Molte sono le ragioni che spingono nella direzione di una socioetnografia delle migrazioni. "Migrazioni" al plurale perché il
fenomeno è sempre più esteso, differenziato e rapido, socioetnografia perché all'analisi delle variabili macro sociali è
necessario affiancare uno studio puntuale dei contesti locali in cui
le comunità di migranti (se di comunità si può parlare) e la società
che le accoglie (se è lecito parlare di un'unica società e soprattutto
di "accoglienza") prendono forma. La dimensione etnografica
della ricerca potrebbe inoltre essere indispensabile a scardinare
alcune delle immagini modellizzanti della stessa ricerca
sociologica.
"L'emigrato è questo: è sempre avanti nel tempo: 'poi', 'in seguito'
[…] Uomini che hanno il diritto di essere a casa loro per un mese,
è tutto qui, sono uomini un mese all'anno in vita loro, per tutto il
tempo che resta non si sa quello che sono: un uomo non è questo,
nella loro vita non c'è niente che sia degno di un uomo. […]
Uomini ma uomini senza donne: le loro mogli sono senza mariti.
Non sono vedove perché i mariti sono in vita. I loro figli sono
senza padri, orfani mentre i padri sono in vita".
Sayad insiste sull'eccezionalità dell'emigrazione algerina in
Francia elevandola a modello significativo ed esplicativo, nei suoi
39
Note
1
Abdelmalek Sayad, “La doppia assenza”, Milano, Raffaello Cortina, 2002
Salvatore Palidda in “Introduzione all'edizione Italiana”, ibidem, pp. VII-VIII.
3
Vedi p.46, ibidem
4
Si veda in particolare il denso capitolo intitolato “La malattia, la sofferenza, il corpo”, ibidem, pp. 239-285
5
ibidem, p. 239
6
ibidem pp. 217-218
7
Faccio qui riferimento alla definizione di socio-antropologia che da J.P.O. De Sardan, definizione che credo si avvicini per molti
aspetti alla prospettiva di Sayad, nonostante sia stata pensata nell'ambito dell'antropologia dello sviluppo e non per l'analisi dei
fenomeni migratori: "J'entends par 'socio-anthropologie' l'étude empirique multidimensionelle de groupes sociaux contemporains et
de leurs interactions , dans une perspective diachronique, et combinant l'analyse des pratiques et celle des représentations. La
socio-anthropologie ainsi concue se distingue de la sociologie quantitativiste à base d'enquêtes lourdes par questionnaires comme
de l'ethnologie patrimonialiste focalisée sur l'informateur privilégié […] La socio-anthropologie fusionne les traditions de la
sociologie de terrain (École de Chicaco) et de l'anthropologie de terrain (ethnographie) pour tenter une analyse intensive et in situ
des dynamiques de reproduction/transformation d'ensembles sociaux de nature diverses, prenant en compte les comportements des
acteurs, comme les significations qu'ils accordent à leurs comportements". J.P.O De Sardan, Anthropologie et développement. Essai
en socio-anthropologie du changement social, Paris, Karthala, 1995, p. 10.
8
Ruba Salih, “Shifting Meanings of "Home". Consumption and identity in Moroccan women's transnational practices between Italy
and Morocco”.
9
Nell'ambito del ciclo di Seminari di Antropologia del Medio Oriente e del Mondo Musulmano (SAMOMU), Università di Milano
Bicocca, aprile-maggio 2005
10
A. Sayad, op. cit. pp. 296-297
11
ibidem, p. 45
12
“Insieme di caratteristiche sociali, disposizioni e atteggiamenti socialmente determinati di cui gli emigrati erano già portatori
prima dell'ingresso in Francia”, ibidem, p. 45
13
“differenze che separano gli immigrati nella stessa Francia”, ibidem, p. 46
14
Il termine noria in francese (ma anche in italiano e spagnolo) indica la macchina per portare verso l'alto acqua o materiali
incoerenti (sabbia, cereali e sim.) costituita da una serie di secchie fissate a una catena senza fine che scorre tra due tamburi rotanti
posti uno in alto e uno in basso. In spagnolo lo stesso termine significa anche “ruota panoramica”. L'immagine evocata, forse
involontariamente, risulta pertanto efficace nell'indicare un'immigrazione fissata una volta per tutte in uno stereotipo/punto di vista
che la rende rassicurante socialmente, controllabile emotivamente, identica a se stessa nel tempo, priva di spessore degno di essere
indagato più a fondo, come una ruota panoramica che gira all'infinito su se stessa rimanendo fissa nella stesso punto.
15
ibidem, p. 47
16
Ovvero regolata e controllata dalla comunità d'origine, beneficiaria principale del lavoro dei migranti. Ibidem, p. 53
17
ibidem, pp. 49-50
18
ibidem, p. 51
19
ibidem, p. 51
20
ibidem, p. 51
21
ibidem, p. 52
22
ibidem, p. 52
23
ibidem, p. 53
24
ibidem, p. 53
25
ibidem, p. 57
26
ibidem, p. 61
27
ibidem, p. 71
28
ibidem, p. 71
29
ibidem, p. 81
30
Propone un modello suddiviso in quattro fasi:
- la prima è caratterizzata da grandi tassi di mobilità e da un'elevata partecipazione al mercato del lavoro. I gruppi di migranti in
arrivo sono di dimensioni ridotte, provengono dalle zone più industrializzate del paese d'origine e sono composti prevalentemente da
maschi, giovani, celibi. La loro permanenza è di breve durata.
- Nella seconda fase cresce l'età media mentre la distribuzione di genere resta costante. Si allarga il bacino di reclutamento dei nuovi
2
40
migranti e rimane alto il tasso di attività lavorativa, la durata del soggiorno tende ad aumentare.
- La terza fase è caratterizzata dalla stabilizzazione della popolazione immigrata: aumenta la popolazione femminile, si sviluppano i
ricongiungimenti familiari, diminuisce il tasso di attività lavorativa in funzione di un incremento della popolazione in età minorile.
Diminuisce il tasso di qualificazione dei migranti in virtù di una maggior facilità a migrare grazie alle reti sociali di supporto e alla
tradizione migratoria che si consolida.
- L'immigrazione si consolida e si radica sul territorio. Si allunga la permanenza, aumentano i ricongiungimenti familiari, sorgono
“istituzioni etniche” (scuole, negozi, associazioni, centri religiosi) e si sviluppa l'imprenditoria.
W.R. Böhning, “Studies in international labour migration”, London, ILO-Mac-Millan, 1984.
31
Simile al modello di Böhning, dedica più attenzione all'azione delle reti sociali e alle di inclusione ed esclusione messe in atto
dalla società di immigrazione.
- Prima fase le migrazioni sono temporanee e caratterizzate da un forte orientamento verso il luogo d'origine.
- Seconda fase: prolungamento del soggiorno e sviluppo delle reti sociali sulla base della parentela e sulla provenienza geografica.
- Terza fase: incremento dei ricongiungimenti familiari e sviluppo di comunità etniche con proprie istituzioni (negozi, servizi, etc.)
- Quarta fase: insediamento permanente, consolidamento dello status legale (eventualmente legato all'acquisizione della
cittadinanza), permanenza della marginalizzazione socio-economica.
S. Castles e M.J. Miller, “The age of Migration: International Population Movements in the modern World”, New York, Guilford
Press, 1993.
Bibliografia
- AA.VV., Tra due rive, la nuova immigrazione a Milano, Milano, Franco Angeli, 1994
- Ambrosini, Maurizio, Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2005
- Dal Lago Alessandro, I nostri riti quotidiani, Genova, Costa & Nolan, 1995
- Delle Donne, Marcella (a cura di), Relazioni etniche, stereotipi e pregiudizi, Roma, 1998
- Salih Ruba, Shifting Meanings of "Home". Consumption and identity in Moroccan women's transnational practices between Italy
and Morocco
- Sayad, Abdelmalek, La doppia assenza, Milano, Raffaello Cortina, 2002
Emeka Okereke (1980 - ),
fotografo nigeriano, è
membro di Depth of Field,
circolo artistico di giovani
fotografi della capitale
nigeriana. Attualmente
vive e lavora a Lagos.
Emeka Okereke, Sans Titre, Banlieue di Parigi.
(http://tirage-photo.typepad.com/photonumerique_/2005/11/banlieues_des_m.html)
41
dossier
Università e sapere
Eppure, anche con gli occhi bendati, io ti parlerò.
Sebbene tu sia luce, prorompi dalle tenebre, ma io sono
tenebre che prorompono dalla luce, che prorompono da te!
(H. Melville, Moby Dick)
’intenzione che ha sostenuto il disegno editoriale di Achab è sempre stata quella di costituire un forum liberato dai vincoli
accademici e biografici, dagli steccati disciplinari: il tentativo di aprire uno spazio inedito per l'antropologia. Per questa ragione,
ad esempio, abbiamo evitato di sottolineare la posizione accademica degli autori che hanno pubblicato i loro articoli, così come,
l'anno scorso, abbiamo deciso di togliere la dicitura "studentesca" dal sottotitolo della rivista. Cancellare quel sottotitolo che indicava
un'identità troppo essenzializzata ci era parso un modo per affermare la singolarità del nostro progetto.
Prendendo ora a prestito la terminologia di Foucault, potremmo parlare di un tentativo, seppur in-esperto, di realizzare un'eterotopia:
un contro-luogo, un'utopia che si realizza in un luogo reale e in cui questo stesso reale è rappresentato ma anche contestato e
sovvertito. Del resto, una rivista i cui promotori fanno propria l'idea che l'antropologia sia un sapere critico, tanto della società cui
appartiene quanto di se stessa, non poteva che essere un luogo altro, un'etero-topia, appunto. Ma se Achab è un contro-luogo, qual è
il luogo a cui si oppone, da cui si staglia e che ne delimita, di riflesso, i contorni?
Achab è forse pensabile come uno dei margini che fioriscono dalla superficie dell'istituzione che ne permette l'esistenza, dal luogo del
contro-luogo-Achab: l'Università. Il rapporto non è semplicemente di complementarietà come le risposte non sono indissolubilmente
legate ad una domanda o le possibili enunciazioni ai loro corrispettivi enunciati. Achab nasce dall'iniziativa di un gruppo di studenti
universitari e non è dunque estranea al suo luogo. Come il caquetoir certiano, anche Achab è un luogo di chiacchiera; germinare di
tentativi e di tensioni che cercano di tradurre un desiderio, e che creano eventi dialogici in cui convergono gli affetti e le emozioni di
chi vi si sofferma. Si tratta di "stratagemmi", di "sabotaggi" con cui rifare o disfare i giochi istituiti da altri, "un'arte di mettere a segno
dei colpi, un piacere nell'aggirare le regole" (de Certeau, L'invenzione del quotidiano). Destrezza che però, esercitandosi nei labirinti
del potere, corre sempre il rischio di ricadere, come il boomerang, su coloro che la agiscono, conquistati dal fascino irresistibile di
una volontà di potenza. Ogni impegno che si organizza e occupa uno spazio discorsivo, nel fare ciò manifesta anche un potere, grande
o piccolo che sia, potere di includere o di escludere, potere che quindi inevitabilmente si carica degli interessi contingenti di chi può
esercitarlo.
Dedicare questo numero all'Università, accogliendo la proposta di Paola Di Cori di aprire un dibattito - a partire dal testo di Michel
de Certaeu, Che cos'è un seminario? - significa infine riaffermare che il politico è parte dei discorsi di Achab, sottolineando così la
sua inquietudine militante più radicale, e la riflessività che tale impegno comporta.
L
la Redazione
'idea di mettere in circolazione le pagine di Michel de Certeau su Che cos'è un seminario? aveva come scopo quello di suscitare
qualche reazione invitando un certo numero di abitanti di quel mondo stralunato che è diventata l'università italiana, a collocarsi
a una certa distanza dalla valanga di avvertenze, istruzioni e critiche più o meno condivisibili, che da anni si sono abbattute sulla
riforma e sugli assai poco lusinghieri risultati ottenuti finora. Considero salutare, per quanto è possibile, provare una sana ripugnanza
di fronte ai programmi insensati, alla modulistica invasiva e al diffondersi di nomenclature bancarie che costituiscono la quotidianità
del lavoro accademico, per abbandonarsi - forse con un pizzico di ribellismo infantile - alla tentazione di resistere… giocando con idee
e comportamenti 'impropri' rispetto a quegli altri; e ancor più importante mi sembra il compito di costruire degli spazi dove possa
muoversi con qualche agio chi ha scelto nella vita un'occupazione intellettuale, chi prova il sollievo liberatorio di dire, scrivere, fare
qualcosa che piace veramente (Non sarebbe poi questo lo scopo del nostro lavoro? Non è forse vero che in questa università siamo
infelici perché capiamo di stare istupidendoci a lavorare da stupidi, circondati da immense distese di stupidità ministeriale, poiché
L
42
capiamo di contribuire solo a riprodurre altri stupidi più giovani ?)
La varietà di toni e di temi che caratterizzano gli articoli pubblicati qui di seguito è senz'altro un risultato incoraggiante, oltre a riflettere
la straordinaria capacità di Certeau di ravvivare consuetudini e atmosfere letargiche, indicando direzioni di lavoro insospettate e forse
ancora possibili, finanche in condizioni che francamente è difficile considerare con benevolenza.
Vorrei quindi esprimere il mio profondo ringraziamento alla redazione di "Achab" che ha accolto l'invito e a tutte/i coloro che con tanta
generosità hanno voluto contribuire al gioco di resistenza commentando esperienze o abbandonandosi a estemporanee riflessioni di
svariata natura. E' di buon auspicio il fatto che accanto allo spirito critico e autocritico che caratterizza alcuni tra questi scritti, ve ne
siano altri nei quali compare piacevolissimo il gusto divertito di chi finalmente si concede di sogghignare in libertà.
Certeau è mancato nel gennaio 1986, e questa pubblicazione vuole anche essere un omaggio e un ricordo a vent'anni dalla morte. Ci
piace immaginare che l'animatore di tanti memorabili seminari avrebbe gradito il tono alquanto informale della iniziativa.
Paola Di Cori
Introduzione
Un seminario... è come un vocabolario
fatto di parole senza definizioni1
di Paola Di Cori
diversa6.
Essendo nato nel 1925, Certeau ha 43 anni nel '68, e sebbene
profondamente segnato dagli eventi del maggio, sarebbe un errore
pensare che la sua formazione fino a quella data sia stata
all'improvviso abbandonata o messa da parte, o che i lavori
successivi non portino le tracce di un lunghissimo e impegnativo
apprendistato religioso, teologico, filologico, storico. Entrato
nella Compagnia di Gesù nel 1950, aveva preso i voti nel 1963; e
pur usufruendo di un'amplissima libertà di movimenti e di
scrittura, sarebbe rimasto legato all'istituzione gesuitica fino alla
morte, avvenuta nel 1986. Ma intanto segue fin dall'inizio i
seminari di Lacan e nel 1964 fa parte integrante, insieme ad altri
sacerdoti cattolici, della fondazione dell'École freudienne. Nel
corso degli anni Cinquanta e Sessanta collabora alla rivista
"Christus"; si laurea con una tesi su Pierre Favre, uno dei primi
compagni di Ignazio di Loyola, e si concentra sulla storia
dell'ordine cui appartiene. Pubblica il Mémorial di Fabre7; si
dedica alla cura della Guida spirituale e della monumentale
corrispondenza di Jean-Joseph Surin, un gesuita del XVII secolo,
la cui opera si rivela uno strumento fondamentale per
approfondire la mistica cristiana tra il XIV° e il XVII° secolo, di
cui diventa uno dei massimi specialisti8. Sarà proprio attraverso lo
studio appassionato degli scritti di Surin (mistico, folle
melanconico per molti anni, autorità spirituale protagonista della
lotta contro le 'diavolerie' di Loudun), oltre alle letture dei grandi
mistici spagnoli, tedeschi e fiamminghi, che Certeau raffinerà le
proprie conoscenze di retorica e semiotica. Di queste farà ampio
uando Certeau accetta di intervenire in una rivista di studenti
di antropologia parigini su cosa sia un seminario, e il suo
contributo viene ripubblicato l'anno successivo come articolo su
"Esprit", siamo nel 19772. Quasi un decennio è ormai trascorso
dal maggio '68 che lui stesso aveva immediatamente definito
come un momento in cui si era verificata la "presa di parola" così infatti si intitola il volumetto dove sono raccolte pagine
scritte quasi di getto all'indomani di quel mese portentoso3. Per
sottolineare il concetto con una forza ancora maggiore, il 2°
capitolo ha un incipit divenuto molto famoso, dove viene stabilita
una immediata corrispondenza con l'ormai lontana presa della
Bastiglia4: la parola, inaccessibile come una prigione circondata
da altissimi bastioni, è stata finalmente espugnata.
Il libro riconsidera la portata degli eventi che avevano
caratterizzato il maggio - l'occupazione delle università, le
assemblee, gli scioperi in ogni settore della vita pubblica, gli
scontri per le strade con la polizia, le sperimentazioni ardite in
ogni campo della vita artistica, lavorativa, educativa e privata all'interno di una serie di rivoluzioni di tipo simbolico e
linguistico. Certeau non si limita al commento politico e alla mera
considerazione intorno a specifici fatti accaduti, ma è
immediatamente attratto dalle profonde trasformazioni che ha
potuto constatare nell'uso del linguaggio: sono cambiati i modi di
usare le aule, le strade, le fabbriche e i teatri; ma sono cambiate
soprattutto le parole e la loro utilizzazione5. Il linguaggio è ormai
un'altra cosa da ciò che era prima che si producesse l'esplosione
che ha travolto le vite di tutti; dopo il maggio, si parla in maniera
Q
43
uso nell'analisi di glossolalie e di forme del linguaggio visionarie
e 'anomali' - quello delle orsoline possedute dal diavolo, di San
Juan de la Cruz, di malati mentali come il presidente Schreber, del
patois parlato ai tempi della rivoluzione9.
Il primo lavoro pubblicato fuori dal circuito gesuitico è lo studio
dell'episodio di possessione che si verificò agli inizi del '600 nel
convento di Loudun, già molto noto e reso popolare nel
dopoguerra da un testo di Aldous Huxley del 1952, da due film (di
Kawalerowicz e di Ken Russell, rispettivamente del 1961 e 1970),
da un'opera di Penderecki del '6910; seguirono poi i saggi di
metodologia della ricerca storica11; il volume iniziale della Fabula
mistica12, la prima parte della grande ricerca su L'invenzione del
quotidiano13, che tanta importanza avrebbe avuto nello sviluppo
degli studi culturali nel mondo anglofono; e poi alcune notevoli
raccolte, due delle quali furono pubblicate in inglese e in italiano
- quest'ultima dopo la sua scomparsa14. Instancabile nel mostrare,
con innumerevoli esempi messi a disposizione dalla sua
sconfinata erudizione, la capacità della lingua di farsi veicolo
potenziale di significati inusuali o ancora da scoprire, in tutti
questi testi ad emergere è la straordinaria plasticità del linguaggio
- di cui Certeau sottolinea la natura duttile, assorbente, porosa,
sempre aperta ad accogliere nuove sfumature di senso. Leggeva di
prima mano i testi degli amati mistici nelle lingue originali, e ne
parlava diverse; nei suoi viaggi di insegnamento e di studio negli
Stati Uniti, nell'America Latina, in Italia, era diventato sensibile
alle tante sfumature e intonazioni dialettali dei paesi in cui
soggiornava.
Sono note le difficoltà che presenta la scrittura certiana; gli effetti
talvolta perfino vertiginosi che suscita anche solo un breve
commento (si pensi ai densi paragrafi dei saggi raccolti in Il
parlare angelico15, alla Fabula mistica, o al testo abbagliante
scritto in punto di morte intitolata Extase blanche16): la prosa di
Certeau produce effetti di profondo disorientamento, quasi fosse
un tentativo di comunicare in forma scritta quanto l'autore stesso
ha provato di fronte alla lettura di Böhme, Silesius o Teresa
d'Avila.
L'analisi in dettaglio delle figure retoriche che per anni ha
accompagnato la lettura dei carteggi di Surin, dei poemi di Juan
de la Cruz, delle visioni di Hadewijch di Anversa ha contribuito a
modellare uno stile prosastico assai particolare; la lingua dei
mistici è stata assimilata da Certeau al punto che ha finito per
entrare a far parte integrante di una forma mentis e di una scrittura
che anziché al medioevo o all'età barocca appartengono al secolo
XX°, e avrebbero segnato in maniera inconfondibile l'opera dello
studioso per tutta la vita.
Alcuni testi sembrano riguardare oggetti ed esperienze
ampiamente conosciuti, o a prima vista assai comuni (fare storia,
i viaggi in Brasile alla fine del '500, camminare in città); ma
bastano poche righe per accorgersi che si tratta di tutt'altro. Fin
dai primi paragrafi è necessario rileggere quasi subito quanto si è
appena letto per paura di non averne compreso bene il significato.
Eravamo convinti di andare in una certa direzione e invece ci
siamo perduti; non siamo più dove credevamo di essere, e al posto
di un panorama ritenuto familiare stiamo guardando un paesaggio
sconosciuto, qualcosa che sembra stagliarsi davanti ai nostri occhi
per la prima volta.
E' ciò che accade anche con Che cos'è un seminario?. Dopo
averle lette è difficile entrare in un'aula universitaria senza
pensare a queste pagine che sceglievano una situazione in
apparenza banale, comune a tanti studenti e insegnanti, e la dispiegavano davanti ai nostri occhi, come fosse un rotolo di fogli
continui, sistemati l'uno sull'altro, che inavvertitamente avevamo
scambiato per un piccolo libro; e invece ecco a un certo punto
qualcuno sollevare la parte superiore del rotolo e cominciare a
squadernarlo in tutta la sua estensione.
Prima di leggere non avevamo pensato in quella maniera su quasi
nessuno dei punti sollevati da Certeau; dopo la lettura, ci
rendiamo subito conto che il nostro orizzonte si è allargato a
dismisura e anche se prima non avevamo neanche percepito
l'ampiezza dei problemi in gioco, ora questi ci sembrano
riconoscibili, addirittura familiari; o per meglio dire, connotati da
una 'perturbante' familiarità, come si conviene a chi ha una
assidua frequentazione con i testi freudiani. I dettagli continuano
tuttavia a sfuggirci e siamo costretti a rileggere più volte il testo
perché non riusciamo a ricordarne i diversi passaggi; (e noi che
credevamo di averlo finalmente assimilato e capito già dalla
seconda lettura…). Ma il risultato è simile a quel che si prova con
un racconto di Borges, il quale affascina anche per l'impossibilità
di ricordare in forma ordinata le sequenze dell'argomentazione,
che si allineano con implacabile e irreale precisione come su uno
schermo dove a mano a mano che le leggiamo tendono a
cancellarsi.
Il fatto è che si tratta di una prosa dominata dal gioco delle
opposizioni. I contrasti tra visibile e invisibile, tra luce e ombra,
tra una cosa e il suo rovescio, si riversano sulla pagina attraverso
un incessante susseguirsi di ossimori, metalepsi, chiasmi,
paradossismi, antitesi, metafore. Le citazioni in questo senso si
moltiplicano nella scrittura certiana: da Hadewijch di Anversa ("la
presenza dell'assenza", il "lontano-vicino"; "ebbra di un vino che
non ha bevuto"); da Juan de la Cruz ("la musica silenziosa",
l'"insensatezza gloriosa", la "follia celestiale"); da Ruysbroeck (il
"concerto silenzioso"); da Teresa d'Avila (il "felice naufragio").
Le parole che Certeau scrive per commentare tali espressioni
subiscono un contagio, l'intera pagina ne rimane imbevuta. Tra
l'enunciazione mistica e la lingua comune si verifica un incessante
travaso e passaggio; immagini e formule derivate dall'esperienza
estatica e religiosa irrompono nel mondo esterno a queste,
impregnandolo di sé; e anche le coordinate spazio-temporali non
rispettano più le gerarchie tradizionali. Si cammina senza meta
per le strade di New York alla fine degli anni '70 come ci si
abbandona a un errare smarrito per i corridoi di un convento
spagnolo del '500. Le tante pagine sull'esperienza mistica sono
scritte negli stessi mesi e anni di quelle dedicate al patois nel
XVIII° secolo, a Jules Verne o a Freud. Si sta ragionando di
storiografia, ma è come se le immagini dominanti fossero quelle
utilizzate dai mistici, la cui peculiarità è sempre quella di
esprimere di non sapere: "Entréme donde no supe,/y quédeme no
sabiendo…Este saber no sabiendo", scrive Juan de la Cruz; no
44
sabe, no se que, aggiunge Teresa d'Avila.
Nello scrivere di storia, del '68, o delle pratiche di lettura nella
società contemporanea, si affrontano tutti questi temi e altri
ancora, come con l'intenzione di comunicare lo stupore di chi si
sta inoltrando per la prima volta in un terreno ignoto; guarda
qualcosa che credeva di conoscere, e si rende conto di stare
considerandola con altri occhi; la scrittura serve da guida al lettore
nelle operazioni da fare, diverse da prima, e indica come
procedere - quasi si stessero seguendo i passaggi degli Esercizi
spirituali ignaziani, che Certeau descrive infatti nel modo
seguente:
certiana tra lavori che non riguardano l'esperienza mistica (quelli
che hanno determinato la fortuna di Certeau fuori da ambiti
propriamente religiosi) e quelli che invece la pongono al centro
dell'attenzione.
Questi saggi, che accompagnano la lunga elaborazione della
Fabula mistica, pubblicata due anni dopo la prima parte
dell'Invenzione del quotidiano, non solo sottolineano quanto fosse
intensa e profonda da parte di Certeau la conoscenza, fino
all'assimilazione, dell'universo mistico, ma consente di chiarire
alcuni termini chiave per rintracciare l'esistenza di un sotto-testo
presente nelle pagine sul seminario. In particolare là dove il
saggio affronta le questioni di proprio e improprio, di ordinario e
di eccezionale, di luogo e non-luogo - vale a dire le nozioni
centrali del mondo mistico. Come osserva Certeau, anziché
riguardare esperienze eccezionali o straordinarie, ciò che la
mistica cerca di fare è di rovesciare la distinzione tra normale e
anormale.
Il mistico esiste in uno stato di perenne a-topia, vive 'perdendosi'
incessantemente; non sente mai di trovarsi in un luogo specifico,
perché il proprio corpo ne attraversa molti passando dall'uno
all'altro in un processo continuo di spossessamento, nè riconosce
dimore definitive. Riprendendo da India Song le parole di
Marguerite Duras sulla mendicante che si avvia verso il Gange
"dove ha trovato come perdersi", Certeau scrive che "la letteratura
mistica offre percorsi a chi 'domanda un'indicazione per perdersi'
(…) In essa si impara 'come non tornare indietro'."20 Sentirsi in un
corpo posseduto, ragiona Certeau fedele agli insegnamenti
lacaniani, vuol dire percepirsi sempre come altro, che cerca ciò
che eccede e fa diventare altro: "Non c'è in nessun luogo
adeguazione del Soggetto e del Reale: questo è in definitiva il
principio (la "fede") sul quale si fonda il discorso (e cioè la nonidentità a sé) del "credente" mistico."21 Ma non è forse questo
anche il principio che guida l'odierna consapevolezza sulla
soggettività in epoca contemporanea? Non è forse vero che
perdersi è diventata la condizione comune in un mondo di nonluoghi?22
Nei suoi scritti e nella sua attività instancabile di viaggiatore
curioso, di studioso e docente, Certeau ci invita a un doppio
movimento, cui in genere non siamo abituati. A cercare il normale
nell'anomalo e l'eccezionalità in ciò che è comune; in poche
parole: a dissolvere la divisione tra proprio e non proprio. Siamo
infatti interpellati a guardarci intorno per vedere cosa c'è là dove
in apparenza non sembrerebbe esserci nulla di insolito, di nuovo,
di inconsueto. Ciò che si presenta come comune e ordinario ripete instancabilmente un saggio dietro l'altro fino alla messa a
punto de L'invenzione del quotidiano - non lo è affatto. Non c'è
passività, ottusa ricezione, docile acquiescenza, nei passanti che
camminano per le strade, in coloro che guardano la televisione, in
chi legge un romanzo popolare, cucina il pranzo di ogni giorno,
sale e scende dall'autobus, va a scuola; c'è invece una intera
'poetica', nel senso (letterale, da poesis) di una pratica del fare.
Nella cosiddetta 'gente comune' viene dispiegata intelligenza
creativa, astuzia, costruzione di tattiche e di strategie; dietro
quanto appare ordinario e consueto della vita quotidiana, c'è
"Il 'procedimento' ignaziano implica un 'desiderante' - colui che si
raccoglie in ritiro, spinto da un desiderio e alla ricerca di una
decisione da prendere -, e (…) lo conduce dal luogo in cui si trova
all'inizio, a un luogo di più grande verità, attraverso una
educazione che si realizza nei termini di pratiche effettive. (…)
Gli procura dei punti di riferimento, e non la storia del viaggio."17
Prendiamo un brano da La scrittura della storia dove le figure del
linguaggio si stagliano con particolare evidenza, anche perché
sottolineate dall'uso abbondante del corsivo, delle virgolette, dei
neologismi, che contribuiscono a dilatare la semanticità delle
parole, e a produrre l'effetto di una prosa fatta di vocaboli il cui
significato è altro rispetto a quello abituale, e da cercare altrove;
dove ciò che si legge trova la propria definizione per contrasto
con quanto ci si potrebbe attendere secondo l'uso comune; in esso
lo spaesamento di chi legge è dovuto alla mancanza di una
direzione ben definita. Il testo non ha un centro, né un punto di
arrivo ben determinato, né dei protagonisti fissi.
"Da una parte, nel senso etnologico e quasi religioso del termine,
la scrittura svolge il ruolo di un rito di sepoltura; esorcizza la
morte introducendola nel discorso. Dall'altra, ha una funzione
simbolizzatrice; permette a una società di situarsi dandosi nel
linguaggio un passato, e apre così al presente un proprio spazio:
"contrassegnare" un passato significa fare un posto al morto, ma
anche ridistribuire lo spazio dei possibili, determinare
negativamente quello che c'è da fare, e dunque utilizzare la
narratività che seppellisce i morti come mezzo per fissare un
posto ai vivi. La sistemazione degli assenti è il rovescio di una
normatività che si rivolge al lettore vivente e che instaura una
relazione didattica tra il mittente e il destinatario.
Nel testo, il passato occupa il posto del soggetto-re. E' stata
operata una conversione scritturale. Laddove la ricerca effettuava
una critica dei modelli attuali, la scrittura costruisce una 'tomba'
per il morto."18
Negli scritti su L'enunciazione mistica e su Il corpo fogliato pubblicati rispettivamente nel 1976 e nel 1977, lo stesso anno
delle pagine di Che cos'è un seminario? - Certeau affronta il
rapporto tra mistica e corpo, e i modi in cui nell'esperienza mistica
il corpo viene metaforizzato, rappresentato come una grammatica
di figure, quasi un concentrato di tropi19. Si tratta di testi centrali
per capire il processo di osmosi che si è prodotto nella scrittura
45
movimento e non stasi. Così è anche per i luoghi e i modi
dell'imparare, segnati dall'erranza, ma soprattutto della continua
messa in discussione di una illusoria 'proprietà' definitiva dei
luoghi, sui quali occorre esercitarsi in una attività spossessante,
creandovi delle fenditure, delle alterazioni, rendendoli 'osceni':
"Insomma - dichiara in una delle frasi chiave di Che cos'è un
seminario? - "noi inficiamo il luogo "proprio", come i bambini
reintroducono la loro storia nel testo adulto riempiendolo di
macchie e di pasticci". Qui sembra quasi di sentire echeggiare
quel che Fachinelli osservava nel '68 con impareggiabile
acutezza, negli articoli per "L'erba voglio" e "Quaderni
piacentini" a proposito della distinzione tra "gruppo di bisogno" e
"gruppo di desiderio"23.
(Viene da dire a questo proposito che l'aspetto desolante della
situazione attuale è il fatto che non si riesce a soddisfare né l'una
né l'altra di queste due tipologie.)
Che cos'è un seminario? si colloca in un periodo dove altri illustri
contemporanei di Certeau organizzano e ragionano sulla struttura
seminariale - come è il caso di Roland Barthes24, e naturalmente
come fa "il Grande Jacques", secondo la godibile parodia che
Pontalis offre dei seminari lacaniani25. La novità di Certeau
consiste nel rovesciare i presupposti di queste analisi, le rende
infatti 'poco importanti' nell'evidenziare la non-eccezionalità di
ciò che si fa, preoccupato com'è di sottolineare che "le procedure
della ricerca non sono fondamentalmente distinte dalle procedure
o dalle 'maniere di fare' comuni". Di qui l'insistenza sulla
costruzione di uno spazio particolare, che consenta di muoversi
tra una pluralità di luoghi, dentro e fuori l'istituzione, e di
considerare il passaggio attraverso università, scuole, centri
esterni a queste, come se il lavoro da intraprendere consistesse
nella compilazione di un dizionario, in apparenza poco utile, nel
quale le definizioni sono provvisorie, labili, mutanti, evanescenti.
Al giorno d'oggi le parole che adoperiamo, i concetti di cui ci
serviamo, sembrano infatti aver perso la loro forza di un tempo,
come ci viene suggerito dalla odierna proliferazione di lessici e
dizionari, introduzioni a, glossari ed enciclopedie; dall'ansia degli
aggiornamenti, delle appendici che includono centinaia di
neologismi raccolti soltanto negli ultimi mesi; a sottolineare il
fatto che da un anno all'altro le parole sembrano esser diventate
sempre più rarefatte e indefinite, come più di un secolo fa
Hofmannstahl aveva già anticipato nella Lettera a Lord Chandos.
Anche se sono passati quasi trent'anni dalla pubblicazione
dell'articolo di Certeau, alcune delle indicazioni più importanti
che esso contiene non hanno perso un briciolo di validità.
Centrale, da questo punto di vista, è l'affermazione per la quale il
vero scopo dei luoghi 'impropri' e del movimento incessante tra
luoghi, non è di andare verso una progressiva neutralizzazione
delle soggettività, bensì quello di costruire "connessioni nel
mantenimento delle differenze".
Per chi continua a credere che il momento della 'presa della
parola' abbia segnato una svolta fondamentale nel rovesciare le
gerarchie dominanti nel modo con cui si impara e si insegna; per
chi pensa che ancor più dirompente sia stata la rottura della finta
neutralità della cultura fallocentrica provocata dal femminismo,
questo rimane un obiettivo di lavoro irrinunciabile, oltre che una
premessa di vita26.
Note
1
Tutte le opere citate in nota senza l'indicazione dell'autore sono di Michel de
Certeau.
2
Cfr. la nota introduttiva di Luce Giard al testo di Certeau Che cos'è un
seminario?, apparsa su l' "école" dicembre 2004.
3
Nel 1994, Luce Giard - la studiosa responsabile dell'edizione critica delle opere
di Certeau - ha dato alle stampe una versione riveduta del libro del '68,
corredandola di una densa introduzione in cui spiega le circostanze biografiche e
storiche che fanno da sfondo alla composizione de La presa della parola. La
ristampa è accompagnata da alcuni scritti meno noti di Certeau ma caratterizzati
da una straordinaria capacità di anticipare argomenti che solo di recente sono
diventati centrali nel dibattito culturale contemporaneo. Le parti aggiunte in questa
nuova edizione si intitolano rispettivamente "Le Americhe: il risveglio politico",
"L'ordinario della comunicazione", "Economie etniche". Cfr. La prise de parole et
autres écrits politiques, édition établie et présentée par Luce Giard, Paris, Seuil,
1994
4
La prise de parole, cit.: "En mai dernier, on a pris la parole comme on a pris la
Bastille en 1789", p. 40.
5
La presa di parola è uno di quei rari libri che - pur concepito sull'onda dei grandi
rivolgimenti che caratterizzarono quell'annus mirabilis, e il cui forte impatto
sull'intera società francese risuona in ogni paragrafo - non è affatto uno scritto
d'occasione. Al contrario, chi legge queste pagine a distanza di 35 anni è colpito
dalla straordinaria freschezza con cui Certeau descrive e interpreta le circostanze
di quella che nel primo capitolo viene definita come "rivoluzione simbolica" : il
potere di parlare e di prendere la parola. E' questo il vero e proprio avvenimento
spartiacque tra una società ancora legata a gerarchie e forme di comunicazione
tradizionali, e il contesto entro cui tutti viviamo attualmente, e che siamo ormai
abituati a chiamare globale, dominato dall'informatica e dalle nuove tecnologie
comunicative.
6
Un'analisi degli avvenimenti che hanno caratterizzato il '68 in Italia, che può
essere accostata, per intelligenza e profondità, a quella di Certeau, è senz'altro
costituita dai numerosi articoli e considerazioni di Elvio Fachinelli. Cfr. in
particolare la raccolta Intorno al '68, a cura di Marco Conci e Francesco
Marchioro, Bolsena, Massari, 1998.
7
Le Mémoriel de Pierre Favre, Paris, Desclée de Brouwer, 1960.
Guide spirituel de Jean-Joseph Surin, Paris, Desclée de Brouwer, 1963;
Correspondance de Jean-Joseph Surin, Paris, Desclée de Brouwer, 1966.
8
9
Une politique de la langue. La Révolution française et les patois, in
collaborazione con Dominique Julia e Jacques Revel, Paris, Gallimard, 1975.
10
La Possession de Loudun, Paris, Juillard, 1970
11
L'operazione storica, Urbino, Argalia, 1973; L'Absent de l'histoire, Paris, Mame,
1973; L'écriture de l'histoire, Paris, Gallimard, 1975 (trad. it. Roma, 1977).
12
La Fable mystique, XVI-XVII siècle, Paris, Gallimard, 1982 (trad. it. Bologna,
1987).
13
L'Invention du quotidien. T. I, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1980 (trad. it.
Roma, 2001).
14
Heterologies, a cura di Wlad Godzich, Manchester, Manchester university press,
1986 e Il parlare angelico. Figure per una poetica della lingua (secoli XVI e
XVII), a cura di Carlo Ossola, Firenze, Olschki, 1989.
15
Cit. nella nota precedente.
46
16
morivano negli anni intorno al '68, interrogandosi sulle oscillazioni che ne
determinavano espansioni e contrazioni, ascese e cadute: "…il modo meglio
Incluso nella raccolta La faiblesse de croire, Paris, 1987, Seuil, pp. 307-310.
Lo spazio del desiderio. Gli "Esercizi spirituali" di Loyola, in Il parlare
angelico, cit. pp. 95-109, pag. 96.
17
codificato di appagare il desiderio del gruppo è quello di incarnarlo nella figura del
leader. Qui non importa se si tratti di una persona o di un valore. Nel momento in
cui il leader tende ad esaurire in sé il desiderio collettivo, il gruppo cambia
carattere. Da gruppo di desiderio, come potremmo chiamarlo, esso tende a farsi
gruppo di bisogno. E questo richiama allora all'interno del gruppo tutti i problemi
18
La scrittura della storia, Roma, il Pensiero scientifico, 1977, p. 119. Si tratta
dell'ultimo paragrafo della Ia. Parte, dedicata a "L'operazione storiografica".
19
Entrambi questi saggi sono inclusi nella raccolta Il parlare angelico, cit.
Riferimento importante del periodo in cui scrive Il corpo fogliato è il saggio di
Derrida sulla metafora nel testo filosofico La mitologia bianca, incluso in Margini
della filosofia, Torino, Einaudi, 1997 (ediz. orig. 1972), pp. 273-349.
20
L'enunciazione mistica, cit., pp.51-52.
che la sua costituzione intendeva appunto risolvere." (p. 112) Anche Certeau parla
di "spazio del desiderio" a proposito degli "Esercizi spirituali"; cfr. la nota
precedente.
21
24
Il corpo fogliato, cit., p. 153; corsivo del testo.
Cfr. Franco La Cecla, Perdersi. L'uomo senza ambiente, Roma-Bari, Laterza,
1988. Ci sarebbe molto da commentare sulla nozione di non-luogo in Certeau,
certamente colui che più ha contribuito ad articolarne le caratteristiche fin dalla
Cfr. Roland Barthes, Al seminario, in ID., Il brusio della lingua, Torino, Einaudi,
1988, pp. 343-352 (ed. orig. 1984); lo scritto di Barthes è stato pubblicato per la
prima volta sulla rivista "l'Arc" nel 1974.
25
Cfr. Jean-Baptiste Pontalis, L'Amour des commencements, Paris, Gallimard,
1986, capitolo 9.
22
fine degli anni '60. A questo proposito occorrerebbe ricordare, oltre a quelli citati,
anche il saggio prima richiamato sugli "Esercizi spirituali" di S.Ignazio di Loyola,
comparso sulla rivista "Christus" nel 1973, vero tour de force certiano intorno
all'opposizione tra spazio e luogo. Cfr. Lo spazio del desiderio. Gli "Esercizi
26
Di grande interesse su questo punto è il saggio della studioso femminista bulgara
Miclena Nikolchina sul ruolo svolto da un seminario di filosofia tenuto
all'università di Sofia nel periodo del passaggio dal regime totalitario alla
democrazia. Cfr. il suo The Seminar: Mode d'emploi, Impure Spaces in the Light
spirituali" di Loyola, cit., in particolare le pagg.97-99.
23
Elvio Fachinelli, Il desiderio dissidente, in Il bambino dalle uova d'oro, Milano,
Feltrinelli, 1974, pp.pp. 107-113; l'articolo era uscito su "Quaderni piacentini",
of Late Totalitarianism, in Joan W. Scott e Debra Keates (a cura di), Going Public.
Feminism and the Shifting Boundaries of the Private Sphere, Urban and
Champaign, University of Illinois Press, 2004, pp.359-387.
n.33, febbraio 1968. In questo articolo, Fachinelli analizzava le dinamiche
collettive all'interno delle aggregazioni che in numero infinito nascevano e
Che cos'è un seminario?*
Un caquetoir (luogo di chiacchiere)
di Michel de Certeau
Un caquetoir (luogo di chiacchiere)
Un Seminario è un laboratorio comune che permette a ciascuno
dei partecipanti d'articolare le proprie pratiche e conoscenze. È
come se ciascuno vi apportasse il "dizionario" dei suoi materiali,
delle sue esperienze, delle sue idee e che, per l'effetto di scambi
necessariamente parziali e d'ipotesi teoriche necessariamente
provvisorie, gli diventasse possibile produrre delle frasi con
questo ricco vocabolario, cioè di "ricamare" o di organizzare in
discorsi le sue informazioni, le sue questioni, i suoi progetti, etc.
Questo luogo di scambi instauratori potrebbe essere comparato a
quello che, nella Loira, si chiama un caquetoir, appuntamento
settimanale sulla piazza principale, laboratorio plurale, dove dei
"passanti" si fermano la domenica per produrre nello stesso tempo
un linguaggio comune e dei discorsi personali. Un Seminario
mette così in causa una politica della parola, come vedremo.
Tuttavia in rapporto al caquetoir presenta la differenza di non
essere il solo appuntamento per le chiacchiere ma solamente un
luogo di linguaggio tra molti altri in una rete che non comporta
più né piazza principale né centro.
Così gli effetti della produzione del discorso che mette in atto non
sono che tangenziali in rapporto alla ricchezza crescente e
silenziosa dei viaggiatori che si fermano un momento in questa
stazione. Mi sembra che il primo compito, in un Seminario, sia di
rispettare ciò che non viene detto, e ancora di più ciò che vi
succede all'insaputa, dunque di moderare la propria voglia di
articolare, forzare, coordinare gli interventi di ciascuno: vengono
*L’articolo è stato pubblicato per la prima volta in francese nella rivista studentesca La brochure ethnologique, n°3, maggio 1977, ed è stato recentemente editto in italiano sulla rivista
"école", numero di dicembre, 2004. Il copyright del testo di Michel de Certeau in tutte le lingue è di Luce Giard. Traduzione dal francese di Luigi Montano (ndr).
47
da troppo lontano per poter essere interpretati; vanno troppo
lontano per poter essere circoscritti in un "luogo comune".
Se il "caquetoir" di Parigi VII crea degli eventi, come tu dicevi,
può essere perché noi cerchiamo, e, da parte mia, io cerco di
"tenerlo" (come si "tiene" una direzione) tra due modi di dare a un
Seminario un'identità ripetitiva che esclude l'esperienza del
tempo: l'uno, didattico, suppone che il luogo è costituito da un
discorso professorale o dal prestigio di un maestro, cioè dalla
forza di un testo o dall'autorità di una voce; l'altro, festoso e quasi
estatico, pretende di produrre il luogo tramite il puro scambio dei
sentimenti e delle convinzioni, e infine tramite la ricerca di una
trasparenza di espressioni comuni. Tutti e due sopprimono le
differenze al lavoro in un collettivo, - il primo schiacciandole
sotto la legge di un padre, il secondo cancellandole illusoriamente
nel lirismo indefinito di una comunione quasi materna. Si tratta di
due tipi di unità imposta, l'uno troppo "freddo" (che esclude la
parola dei partecipanti), l'altro troppo "caldo" (che esclude le
differenze di posizione, di storia e di metodo che resistono al
fervore della comunicazione).
L'esperienza del tempo comincia in un gruppo con l'esplicitazione
della sua pluralità. Occorre riconoscersi differenti (di una
differenza che non può essere superata da nessuna posizione
magisteriale, da nessun discorso particolare, da nessun fervore
festoso) perché un Seminario si trasformi in una storia comune e
parziale (un lavoro sulle e tra differenze) e perché la parola vi
divenga lo strumento di una politica (l'elemento linguistico di
conflitti, di accordi, di sorprese, in somma di procedure "democratiche").
Certi nostri Seminari hanno conosciuto dei momenti di euforia
contagiosa o di "dinamiche di gruppo", e anche dei momenti in
cui veniva la richiesta che, dal mio punto di vista particolare, io
collocassi e raccogliessi in un discorso gli interventi dei
partecipanti. Se da una parte è normale che ciò accada, tuttavia
non dovrebbe essere la norma, perché ciò compromette quella
che, in un gruppo, può essere esperienza politica della parola (dei
rapporti discreti di forza), creazione di eventi nel tempo (delle
"nascite" grazie alla relazione con l'altro) e produzione di un
linguaggio dialogico (una comunicazione relativa a delle
differenze mantenute) - tre elementi che vanno alla pari.
La mia posizione sarà dunque piuttosto quella di esplicitare la mia
posizione (invece di nasconderla sotto un discorso supposto
capace di inglobare tutti gli altri), di mostrarne le conseguenze
possibili, teoriche e pratiche, nella discussione di gruppo, e di
reagire reciprocamente a quelli che intervengono in modo
interrogativo che li spinga ad esprimere la loro differenza e a
trovare nelle suggestioni che io posso fare il mezzo per formularla
più chiaramente. I "modelli" teorici proposti hanno per funzione
di delineare dei limiti (la particolarità della mia questione), e di
rendere possibile degli scarti (l'espressione di altre esperienze e di
altre questioni). In questo modo si avvia il lavoro comune che
crea degli eventi: una serie di differenziazioni permette a ciascuno
di specificare passo dopo passo il proprio cammino nella massa
delle informazioni che si scambiano.
Lavori di pratiche
Alla fine, che cos'è un seminario? Cos'è stato il nostro? Come
pensare la nostra pratica? Oscillando tra la storia di ciò che
abbiamo già fatto e l'utopia di ciò che si dovrà fare, zigzagando in
questo tra-due, vorrei soltanto fissare alcuni punti che possano
essere sulla carta i segnali del nostro viaggio.
1) Parto dal postulato che per quanto concerne il nostro lavoro
l'Università non è più il luogo né un luogo di ricerca. Per alcuni
di noi non è né il campo di un confronto tecnico e professionale
con il reale, né l'oggetto d'investimenti politici, intellettuali, o
amorosi. Nel nostro gruppo, le pratiche effettive di ciascuno si
svolgono fuori di Parigi VII. D'altra parte, nello spazio pubblico e
marginale che è diventata l'Università, si possono effettuare degli
incontri regolari, capaci di creare uno scarto in rapporto ai luoghi
differenti da cui veniamo e dove lavoriamo. Altrimenti detto, un
Seminario può produrre dei modi di prendere le distanze in
rapporto ai nostri compiti e delle possibilità di ritornarvi in modo
differente. Nel lavoro di ciascuno, apre una porta di uscita e di
rientro. È una specie di cursore che cambia con discrezione il o i
luoghi delle nostre pratiche effettive in scene dalle quali ci si può
distaccare per pensare e rivederne l'azione. Permette dunque un
lavoro ai bordi (sui bordi). Questo cursore non si potrà costituire
come un doppione speculare dei luoghi abitati, come uno spazio
dove essi potrebbero essere progettati e espressi: non è né il
contrario né lo specchio della scena ma un margine che rende
possibile qualche operazione di correzione sul testo. Ancor meno
è un luogo autonomo in cui un sapere potrebbe costruirsi in pace.
Introduce solamente un gioco nell'opaca normatività dei luoghi di
lavoro.
Questo gioco di (e sui) luoghi apre uno spazio critico. Ha una
doppia condizione di possibilità: a)per non trasformarsi in una
lusinga, in spettacolo illusorio, in un simulacro di sapere, la
pratica del gruppo deve essere determinata dall'elaborazione dei
suoi rapporti con la sua "esteriorità", o piuttosto dalla sua
situazione di non essere che una procedura di uscita e di rientro
relativa a delle localizzazioni sociali, professionali, familiari, etc;
b)ma esso "esercita" questa funzione di scarto critico a causa
dell'incrocio di esperienze che vi entrano e vi escono, vale a dire
per un lavoro di confronto tra delle ricerche che il Seminario non
crea. Cioè, i discorsi del gruppo sono definiti sia dal fatto di
essere separati o privati delle pratiche e dei luoghi che
analizziamo insieme, sia da una pratica della parola, da una
gestione comune dei nostri scambi socio-linguistici.
2) In questo spazio appartato (questo studio quasi insulare, al 5°
piano di Parigi VII), quali erano, quali potevano essere le nostre
pratiche?
Generalmente parlando, hanno per caratteristica di salvaguardare
a questo posto il ruolo di essere un luogo di transito. Non hanno
dunque come finalità la costruzione di un sapere con le pietre
portate da ciascuno e di edificare così un luogo proprio. Al
contrario, come degli "svincoli" stradali o di shifters linguistici,
sono delle procedure di "passaggio all'altro" o di alterazioni.
Vengono a restaurare nel luogo (che si dice "proprio") del sapere
48
le sue relazioni con il suo contrario che comporta al tempo stesso
una disappropriazione e una oscenità. Insomma, noi inficiamo il
luogo "proprio", come i bambini reintroducono la loro storia nel
testo adulto riempiendolo di macchie e di pasticci. Un modello di
questa operazione è fornito da Freud il ritorno di ciò che è stato
rimosso: nel posto che si è voluto "proprio" grazie ad una
eliminazione dell'altro, ecco che il rimosso riappare come
qualcosa che ritorna e altera, "macchia" e ossessiona i luoghi.
Questo modello è servito da punto di partenza al nostro Seminario
di quest'anno, perché comporta molte implicazioni che mettono in
causa diverse specie di luoghi propri (il luogo proprio del
soggetto del sapere in rapporto all'oggetto studiato, il luogo
proprio di una scientificità in rapporto a delle pratiche sociali o
letterarie, etc.), e permette di analizzare i ritorni dell'altro nello
stesso spazio che si è creduto autonomo. Due momenti di questo
processo sono, in particolare, nettamente articolati: da una parte,
una distinzione o separazione tra il "proprio" e il "non-proprio";
dall'altra parte il miscuglio e come la "bastardaggine" di ciò che
accade lì dove sopraggiungono dei fantasmi che non dovrebbero
trovarsi là.
Il nostro metodo potrebbe avere per fondamento una teoria della
bastardaggine. Non che essa abbia per scopo di trasgredire e
attraversare le frontiere stabilite. Si tratta piuttosto di rendere
conto di ciò che accade effettivamente: il coinvolgimento del
soggetto nel suo studio, il ritorno della finzione nella scintificità,
la porosità tra le procedure "tecniche" e i modi di fare "comuni",
le ambivalenze dei luoghi, etc. Fenomeni di passaggio, di
combinazioni, di relazioni tra elementi differenti nello stesso
spazio, etc., chiedono di essere analizzati per se stessi, alfine che
una teoria espliciti le regole e i modelli conformi a ciò che
realmente è l'esperienza della ricerca. Bisogna trovare un rigore
proporzionato a questa promiscuità o bastardaggine dei fatti, e
smetterla di giustapporre all'esperienza di lavoro una definizione
onirica e atopica dei campi "propri".
Nella pratica di un Seminario, si colgono delle procedure d'analisi
e dei modi d'interrogazione che occorre specificare
maggiormente: l'alternarsi tra le sedute dedicate a delle
esposizioni su dei modelli teorici e le sedute riservate a dei
racconti storiografie di ricerche concrete (il che rende possibile
degli effetti delle une sulle altre senza confonderle); il privilegio
accordato alla narratività come strumento di analisi, in quanto è
un'interconnessione di dati osservati e di investimenti soggettivi e
anche la combinazione di una teoria esplicativa referenziale e
delle sue eccezzioni; l'esame dei conflitti di potere impliciti negli
scambi di parole; l'esplicitazione della storia (una pluralità di
strati e di interazioni) che è rinchiusa in uno stesso luogo, e che fa
in realtà di ciascun luogo un'esperienza ambivalente del tempo;
l'eterogeneità nell'atto dell'enunciazione e il sistema di enunciati
in cui essa si produce, etc.
Tutti questi procedimenti rinviano all'oggetto della nostra ricerca.
Il fatto è che le pratiche della nostra analisi non possono essere
eterogenee alla pratiche socio-culturali che studiamo. Questa
posizione di principio è legata al fatto che il Seminario non
costituisce un luogo "proprio" e che le procedure della ricerca
non sono dunque fondamentalmente distinte dalle procedure o
dalle "maniere di fare" comuni. Dal solo punto di vista
metodologico è stato importante che il Seminario viaggiasse fuori
da Parigi VII, come abbiamo fatto, per esempio, ritrovandoci in
diversi altri luoghi - nel caso in cui ci fossero delle riunioni
ulteriori non previste dal calendario universitario. Oltre al fatto
che queste "uscite" permettevano delle esperienze più concrete e
degli scambi più liberi, esse spezzavano la "finzione" seduttrice di
un luogo e di un tempo propri. Esplicitavano o restauravano la
relazione del nostro lavoro con la sua "esteriorità". Attraversando
le frontiere artificiali tra le pratiche di un Seminario e le pratiche
che ne sono in principio escluse (mangiare, bere, parlare della
storia personale legata ad un lavoro, fare l'esperienza di una rete
locale in cui s'iscrive una ricerca, etc.), facilitano una
chiarificazione reciproca delle nostre "maniere" di studiare e delle
maniere di fare che studiamo. Ci eliminavano dunque l'illusione
di una specificità scientifica che è in gran parte sostenuta dal solo
fatto di riunirsi in un luogo universitario e stimolavano tramite la
percezioni di aspetti ignorati l'esigenza di analizzare l'astuta
complessità delle più semplici pratiche.
3) Quanto alle pratiche socio-culturali, oggetto del Seminario,
esse non designavano evidentemente dei comportamenti obiettivi,
bensì delle operazioni trasformatrici: delle maniere di leggere (di
produrre un senso attraversando un testo), di dirsi in una lingua
che non è la propria, di truccarsi (di crearsi un volto nel codice
delle simulazioni sociali), di organizzarsi delle traiettorie in un
ordine urbano costituito, di "fare dei tagli" nell'intreccio di una
politica locale o di un sistema famigliare, etc. Ciascuna di queste
pratiche è un'arte di giocare in uno spazio imposto (un ordine) e
con una congiuntura (delle "occasioni"). Ho chiamato tattiche
questi modi di "rigirare" i fatti imposti da un sistema dominante e
di crearvi un gioco per delle combinazioni temporanee. Le
distinguo dalle strategie, che indicano la capacità di isolare un
luogo autonomo di potere, di esplicitarvi un volere proprio, e di
calcolare dei rapporti di forza con un "ambiente" circoscritto. Il
nostro proposito era di analizzare queste tattiche, manipolazioni
instabili e relazioni stabili, astuzie legate ad un non-potere e
all'istante, operazioni complesse fondate su un "flair", e di
domandarci quali modelli teorici e quali tipi di scrittura potessero
renderne conto. Questione tanto più importante perchè queste
"tattiche" costituiscono l'immensa maggioranza delle pratiche
sociali, e perché l'osservazione scientifica non ne conserva spesso
che ciò che è conforme ai suoi schemi procedurali, supposti più
razionali ma in tutti i casi semplificativi.
Iniziato dalle ricerche sulla cultura popolare e sul funzionamento
effettivo delle rappresentazioni, questo lavoro pone delle
questioni: la creatività dei "consumatori", poeti e artisti
sconosciuti; la relazione di questa arte di "fare dei tagli" con il
sistema dentro il quale si sviluppa; l'omologia con le con le
"precise azioni" sociali e politiche; l'esperienza del tempo che
implica una pertinenza dell'istante in queste tattiche; il rapporto di
queste astuzie con i luoghi in cui si producono e che possono
essere analizzati come dei puzzles di frammenti stratificati che
49
giocano gli uni sugli altri; la funzione di queste tattiche,
suscettibili di essere considerate come delle articolazioni
operative tra dei sistemi (codificazioni prodotte) e dei corpi
(luoghi opachi e determinati, di bisogni e di piaceri); le
rivoluzioni silenziose prodotte da questa attività brulicante, etc.
Ma tutte queste questioni compongono il vocio del nostro
caquetoir.
di ciò che si fa, gli stessi "tagli" relativi ad una congiuntura e a dei
destinatari, etc. Ma la parvenza delle istituzioni scientifiche (e
tutte le iniziazioni necessarie ad una aggregazione) fa passare le
pratiche interne per qualitativamente superiori alle pratiche
"esterne" e protegge questa differenza. Può essere, in questa
prospettiva e malgrado il terrorismo primario che ha generato in
Lyssenko, che si debba ritornare al principio iniziale della
"scienza proletaria": vale a dire che esiste una scienza delle
pratiche dell'operaio o della casalinga come del ricercatore, e che
non si può gerarchizzare la loro competenza in base a criteri
sociali.
b) Il lavoro di restituire la sua legittimità socio-culturale e di dare
figura teorica a queste "maniere di fare" comuni ha portata
politica, nella misura in cui esse contribuiscono a fornire dei
riferimenti per un'azione collettiva. La presa di coscienza politica
di esperienze sociali per lungo tempo ridotte al silenzio ha sempre
avuto per condizione di possibilità la produzione di analisi
tecniche, di esplicitazioni teoriche rivalutazioni simboliche. Così
è stato per delle culture oppresse o per dei comportamenti
repressi. Da questo punto di vista, la nostra ricerca, legata ad altre,
senza dubbio non è direttamente un'azione politica, ma le prepara
degli strumenti. D'altra parte essa s'inscrive necessariamente in
una rete di impegni politici preliminari e congiunti.
c) Proprio per il suo oggetto come per le sue prospettive, questo
progetto non potrà essere circoscritto in un luogo universitario.
Esso implica un gioco su una pluralità di luoghi. Il passaggio
periodico per una scala di università non rappresenta che una
punteggiatura di momenti critici nel testo delle nostre attività
sociali. Questa operazione universitaria non può, mi sembra,
essere "gestita" nella sua funzione marginale, dalla sola
autocritica né dalla sola elucidazione dei suoi necessari rapporti
con le esperienze che l'attraversano di tanto in tanto; le occorre
essere legata in maniera più strutturale con dei luoghi d'azione e
con delle effettive collettività. Occorrerà dunque considerare delle
relazioni più strette tra unità universitarie e nuclei sociali
fortemente impiantati - le prime più aperte gli altri più stabili. Non
per una confusione di generi, che è sempre nefasta, ma in vista di
connessioni nel mantenimento delle differenze. Ne abbiamo
parlato a proposito delle relazioni possibili tra l'UER di etnoantropologia e altri luoghi. Ci sono sicuramente altre formule. Se,
come io credo, la teoria si colloca sempre in uno scarto in
rapporto all'istituzione, essa troverà in questa struttura plurale la
sua condizione di possibilità.
Luoghi della ricerca
D'altra parte bisogna sottolineare che, in rapporto al CNRS o ad
altre istituzioni spesso formate da luoghi inaccessibili per
privilegiati senza responsabilità sociale e senza una regolare
relazione con il crescente flusso delle ricerche degli studenti, le
università offrono spazi di confronto permanenti con le domande
e le innovazioni che i "ricercatori" patentati non percepiscono più.
Mi sono sistemato a Parigi VII per questo. Alle grandi scuole
"famigliari" o alle strutture insulari della Ricerca, "home" per
un'intelligenza tranquilla da sola, preferisco questi luoghi
universitari (del resto lentamente proletarizzati in rapporto ad una
élite che gli sta di fronte): lì è possibile una viva collaborazione
con tutti quelli che, anche se la loro presenza è già l'effetto di una
selezione, arrivano viaggiando tra esigenze, esperienze e
ambizioni venute da tutte le parti, da molto lontano. Certo, la
"miseria" dilaga in questi luoghi. Ma proprio per questa ragione
può essere che l'intellettuale trovi in questa collaborazione
un'altra figura sociale e un altro ruolo tecnico, molto più che nelle
celle ad aria condizionata in cui si giudica con disprezzo la
degradazione delle università.
Detto ciò, le università non saprebbero essere trasformate in case
chiuse del sapere o di un potere del sapere. Del resto è da un bel
pezzo che, almeno nei UER di scienze umane, gli studenti e molti
insegnanti lo sanno. Lo dicevamo poc'anzi a proposito di un
Seminario particolare, si tratta piuttosto di cercare come il lavoro
che si fa là, pubblico e marginale, possa articolarsi sull'insieme
delle pratiche sociali. Questa connessione verrà fuori da
costrizioni economiche, esperienze scientifiche e da confronti
politici. Per terminare sottolineerei soltanto tre punti che risaltano
dalla nostra ricerca particolare.
a) Un lavoro teorico e tecnico (la critica ideologica non è
sufficiente) si deve basare sul taglio sociale sul quale si articola la
costituzione di campi intellettuali "propri": la separazione tra ciò
che è "scientifico" e ciò che non lo è. Così l'analisi delle pratiche
o "maniere di fare" come noi le interpretiamo mostra, da una parte
e dall'altra di questa frontiera, la presenza dello stesso tipo di cosa
50
Contributi
“Un’utopia?”
di Franca Balsamo*
La ricchezza dello scritto di De Certeau (ma anche la limpidezza
e la grazia dell'introduzione) richiederebbero una riflessione non
di un momento, e allora, senza andare a vedere quale sia in
francese il termine tradotto in italiano con "proprio" - ma
immagino sia quel "propre" che in francese ha un doppio
significato, non solo di "proprio" ma anche di "pulito", il che forse
riempirebbe il significato di uno "spazio proprio" di altre
sfumature piuttosto intriganti, - hanno stimolato semplicemente
alcune, non direi neanche riflessioni, quanto piuttosto quasi libere
associazioni sul "seminario" così come mi sono suggerite dalla
lettura di Che cos'è un seminario? - e soprattutto dopo
l'esperienza infelice del mio corso di quest'anno di sociologia
della famiglia a Psicologia (università di Torino).
Quello che mi ha dato la lettura di Certeau è stata la
consapevolezza di essere stata quest'anno una pessima
insegnante, perché non sono stata capace di utilizzare quel tempo
e quello spazio per favorire una comunicazione libera, uno
scambio "contaminante", come quella di cui lui parla. Non ho
saputo lasciare il tempo alle studentesse, offrire loro pienamente
quel tempo alle loro parole. Cercavo di "insegnare" a essere
critiche, ma pretendevo "criticità" in un contesto dove la relazione
era del tutto asimmetrica e in fondo la mia comunicazione non
poteva che essere paradossale: siate critiche! in un certo senso
dicevano le mie parole (un po' come il paradosso del "siate
libere!"). Risposta, ovviamente: il silenzio. E la mia frustrazione.
C'è da dire che il contesto in cui si lavora oggi all'università non
è, e meno che mai può essere, quello seminariale. Non è favorito,
direi anzi che è quasi impedito. Non si può fare un seminario con
60/70 persone stipate in banchi ordinati in righe come quelle di un
esercito (alla fine della lezione potremmo dire: "rompete le
righe"!). Anche alla facoltà di psicologia dove pensavo che si
fosse un po' più attenti al "setting" , lo spazio della comunicazione
è questo: una grandissima aula, alta, vuota, dove per farsi sentire
bisogna usare il microfono… , oppure per stare un po' vicino
anche fisicamente alle allieve/i bisogna, come peripatetici
(patetici), camminare tra i banchi per decine di metri - e in un
posto così è chiaro che quasi tutte/i, intimoriti, si assiepano verso
il fondo, nelle ultime file, cercano di annullare la loro presenza.
Bell'inizio per una comunicazione (quasi tra fantasmi). Fatta
eccezione per due occasioni, nella prima li ho fatti lavorare tra
loro in piccoli gruppi attraverso una sorta di gioco di ruoli
(aspettative di "figli", "figlie", "madri", padri", gli uni verso gli
altri); e poi, l'ultima lezione, in cui eravamo poche (meno di venti)
e lo stimolo è stato il video che portava le voci e le esperienze
"altre" di "altre". Allora finalmente, l'ultima lezione, mi hanno
regalato il loro pensiero e le loro emozioni (ragazze e ragazzi
ricchissimi cui io ho fatto perdere troppo tempo).
Dunque seminario. Che cosa è/è stato seminario nella mia
esperienza.
Prima immagine: spazio privilegiato nella comunicazione
universitaria delle femministe (no, non ho tempo di pensare
all'iniziativa degli anni '80 a Torino chiamata Tematiche
Femminili, che forse erano la cosa che più si è avvicinata nella
mia esperienza all'idea di seminario. Già in auge nel 68 come
spazio di una comunicazione considerata particolarmente "buona"
(lo abbiamo ereditato da lì? o dalla letteratura sui più famosi
seminari di Lacan? O da entrambi? Quali i percorsi? Per me sono
state nel percorso a Torino anche le "contaminazioni", gli
imbarbarimenti della comunicazione accademica che venivano
dalla fabbrica e dal sindacato attraverso le 150 ore - da pensarci a
quello stile che intersecava dubbiosa e balbettante autocoscienza
con assertività e proclami ideologici).
Si trattava di uno spazio spurio, al margine, sul margine (poco
definito) tra comunicazione pubblica e privata: tra (e non più) la
comunicazione dell'insegnante/docente - che sa, gerarchicamente
distante, up, che conferma e riproduce la gerarchia delle
conoscenze, a partire dalla propria, come "buona" e desiderabile
vs la "non conoscenza" degli altri soggetti, gli "alunni" (qui il
genere sparisce, con rare eccezioni), comunicazione accademica,
pubblica - e quella sperimentata nel movimento femminista del
piccolo gruppo dove lo scambio è (era) tutto e su tutto (ma
soprattutto su di sé - poi quella cosa lì è stata sempre più criticata
come "autoreferenzialità"), dove ci si "contaminava" (dunque ne
parlava già Certeau tanto prima che questa parola fosse
inflazionata e quasi inutilizzabile?) l'un l'altra, spazio a volte del
delirio incontrollato. Ma anche e prima di allora per le donne, lo
scambio "libero" era quello della chiacchiera (chit-chat, etc…), da
"sempre" (?) luogo della comunicazione considerata "tipicamente
femminile" e come tale squalificata (luogo di una comunicazione
non rilevante - a meno di essere poi riscoperta da sociologi e
antropologi come luogo privilegiato non solo del controllo sociale
ma della creazione appunto di quei fondamenti comunicativi affettivamente segnati - che sono la materia con cui si
costruiscono e si consolidano tutte le organizzazioni). Spazio
troppo libero di scambio affettivo (e insieme razionale) - che
Certeau consegna al luogo fusionale del materno…- non
condivido, - luogo semplicemente meno praticato dagli uomini (e
luogo soprattutto esclusivo, proibito al maschile, haram,
direbbero in arabo).
Il luogo della libera chiacchiera è a mio avviso un luogo rilevante
di una pratica di conoscenza, di massima costruzione dei legami
sociali, del tessuto sociale, della conciliazione delle differenze,
51
delle opposizioni, di riduzione delle tensioni, di controllo delle
paure, di conoscenza intima dell'altra e attraverso l'altro degli
altri-altri, ma ha il difetto - a livello della comunicazione pubblica
e dunque del "riconoscimento" - di essere luogo gestito dalle
donne, che hanno una conoscenza profonda radicata antica e
sempre attuale dei suoi meccanismi. Ma è un luogo estremo,
troppo radicale.
Lo spazio del seminario sta a metà strada tra il luogo della
chiacchiera privata, il "fuori", della vita "comune", dell'incontro
fortuito, della riunione di amiche, dell'informale e quello
veramente formalizzato della comunicazione accademica, con
tanto di cattedra, di registro, di registrazione "poliziesca" delle
presenze e delle assenza, luogo massimo del potere - dove piccoli
esseri hanno ottenuto, per aver vinto un concorso, a volte nei modi
che sappiamo, di poter avere questo potere su altri esseri umani
non "più deboli", ma resi tali dal contesto, deprivati delle loro
conoscenze umane dallo stile autoritario dell'organizzazione. Qui
si insegna: qualcuno recita la sua parte, mostra quanto è bravo,
quanto la sa bene - se la sa, -, si aspetta un "riconoscimento":
diviso tra questo "riconoscimento" speciale di sé e l'idea che gli
altri (le/gli studenti) siano sacche quasi vuote (non hanno letto
Simone de Beauvoir!, non sanno chi è Sartre!, non conoscono
Nancy Chodorow né Juliet Mitchell, hanno appena sentito
nominare Melanie Klein, mai sentito Eric Neumann, dei
sociologici conoscono solo il nome di Parsons e vagamente forse
Weber - figuriamoci de Certeau), sacchi vuoti da riempire. E giù
parole, lezioni, concetti, collegamenti, passioni verbali e
concettuali, giù giù dentro i sacchi - e infine la verifica: quanto è
rimasto dentro? Quanto conoscono ora delle teorie della famiglia?
Quante domande hanno immagazzinato, quante incertezze?
E mentre tu parli sono lì con i loro quadernetti in mano che
scrivono, scrivono, cercano di immagazzinare il più possibile per
farti piacere, in modo poi da avere a loro volta il piacere di avere
un voto, un numero, possibilmente alto così da far piacere anche
ai loro genitori, così da essere tutti contenti/e, così da finire in
fretta, da passare in fretta, senza sostare, di corsa, inconsapevoli,
questo spazio - dove avranno acquisito un pezzo di carta, una
certificazione di qualità - come quella delle macchine, - la
certificazione di essere ora dei "buoni sociologi/scienziati sociali"
- dei buoni disoccupati. Avranno attraversato questo spazio
correndo per uscire in fretta con la mente proiettata sull'uscita, su
un altro tempo, sul futuro, sul quel tempo che non arriverà mai.
Il seminario, al contrario, dovrebbe essere dunque uno spazioluogo dove ci si ferma al tempo presente, dove si cerca di far
circolare la conoscenza complessa di ciascuno con quella di
ciascun altro (quella della memoria, delle proprie rilevanze
pubbliche e private, delle proprie passioni intellettuali e non, delle
proprie emozioni e conoscenze… ) - luogo di circolazione e di
scambio alla pari, di influenze reciproche ("contaminazioni",
appunto Certeau), spazio di comunicazioni di soggetti seminudi,
spogliati dalle necessità/paura/dovere di essere giudicati/
valutati/pesati ecc. - ma questa è una utopia. A volte succede, a
volte no: il seminario è tutto ciò che succede, ma non si può
nascondere che cruciale è il ruolo del/dei/della conduttrice - il suo
potenziale potere, la sua autorità e autorevolezza (e il suo peso
rispetto all'appartenenza di genere è tutto ancora da esplorare).
Dipende dalla composizione delle persone maschi/femmine/età e
da ogni loro caratteristica sociale, personale, individuale - ovvio:
ogni seminario è diverso da ciascun altro (ancora più ovvio ma
dovrebbe essere tranquillizzante).
Troppo spesso oggi si abusa del termine seminario: l'università è
strapiena di ore e di spazi in cui due o tre persone tengono una
dotta/erudita conferenza, cui seguono alcune dotte o timide
domande, dove un/una coordinatrice sintetizza, interpreta,
ringrazia e chiude un tempo in cui tutte le persone convenute
avrebbero avuto qualcosa da comunicare sull'argomento o su sé,
ma che altri (l'autorità) non era interessato ad ascoltare. Non
abbiamo rispettato quei silenzi come comunicazione autonoma, li
abbiamo imposti, costretti. Utopia? Abbiamo ancora bisogno di
utopie che ci indichino una direzione sensata. Ortona nell'ultima
intervista che ha rilasciato conclude la settima e ultima cassetta
con queste parole: finché anche una sola persona non vede
rispettati i propri diritti non si può parlare di democrazia (parole
riferite dalla figlia Carla).
Il seminario, luogo dove le persone si scambiano e si contagiano
reciprocamente del proprio essere, pensiero, sentimento…:
"riconoscimento" può essere un mezzo di formazione della
democrazia, ma solo se diventa uno spazio in cui tutti/e fino
all'ultima possono e si sentono liberi di esprimersi, azzerando le
gerarchie (e tanto più le caste, gerarchie irrigidite nel tempo) del
sapere.
Ma quello che un seminario - dove si sviluppa la comunicazione
informale del piccolo gruppo, al confine tra libera chiacchiera
quotidiana e comunicazione formalizzata, - deve affrontare è il
rischio che la comunicazione affettiva, informale, può favorire,
insieme alla libertà, anche la riproduzione, si sa, di forme di
potere poco visibile, di dipendenze psicologiche, di illibertà, la
riproduzione di gerarchie "sottili", di schiavitù. Allora il
seminario deve essere in grado di muoversi con aggiustamenti
continui (può essere un soggetto collettivo?), in una mobilità
permanente tra l'informale e le regole condivise della
comunicazione (es. turni della parola, tempo di parola per tutti regole che tuttavia vanno di continuo rinegoziate, riverificate e
riaffermate… con tempi lunghissimi di necessaria
metacomunicazione), regole che nello stesso tempo non siano
così rigide da scoraggiare (come gabbie/barriere del flusso) la
comunicazione libera, semplice… ma allo stesso tempo nemmeno
così sciolte/inesistenti da permettere che si formino leadership
carismatiche che ci portano molto lontano dall'apprendimento
della comunicazione e della partecipazione democratica e della
libertà.
*
52
Università di Torino
Facoltà in conflitto
di Matteo Bonazzi*
Man kann nur philosophieren lernen 1
1798. Kant risponde alle accuse di irresponsabilità mossegli da
Federico Guglielmo II scrivendo un celebre testo, il Conflitto
delle facoltà 2, nel quale dà fondamento, struttura e articola i
diversi ordini che devono assicurare il corretto funzionamento del
sistema universitario. Da una parte le facoltà superiori (Teologia,
Diritto e Medicina), che perseguono obiettivi politici; dall'altra la
facoltà inferiore (Filosofia) che si cura soltanto della libertà, cioè
della ragione. Tale divisione non è priva di condizionamenti reali.
Essa risponde, infatti, alle esigenze politiche del governo, che
necessità delle tre facoltà superiori per poter garantire il
perseguimento del bene eterno (teologia), la realizzazione del
bene civile (diritto) e il raggiungimento del bene del corpo, la
salute (medicina). Le tre facoltà superiori devono rendere conto al
governo perché agiscono all'interno della sfera pubblica del
sapere-potere. Viceversa la facoltà inferiore di filosofia non ha
nessun vincolo - almeno apparentemente. Essa può e deve seguire
soltanto i dettami della libera ragion pura proprio perché i suoi
effetti di sapere restano inscritti all'interno della sfera privata potremmo dire - dell'Università, senza interagire con lo spazio
della verità pubblica.
1980. Jacques Derrida pronuncia all'Università di Columbia una
conferenza dal titolo, "Mochlos" o il conflitto delle facoltà 3, nella
quale propone una rilettura de-costruttiva del suddetto testo di
Kant. Secondo Derrida, l'aspetto fondamentale dell'impostazione
proposta da Kant risiede nella possibilità di separare in maniera
certa l'ambito della sfera pubblica, del sapere controllato dal
potere, dall'ambito della sfera privata, del sapere controllato dalla
libera ragione. È con questa netta separazione - grazie a questo
limite tracciato in maniera chiara e precisa - che è possibile
circoscrivere il luogo proprio della filosofia, nonché l'istituzione
che ne deve garantire di diritto l'effettualità. Tale limitazione fa sì
che sia possibile individuare all'interno del potere un altro potere
che conserverebbe la propria piena libertà precludendosi in
anticipo l'accesso allo spazio pubblico dell'azione: "Il suo [della
ragione] potere - ricorda Derrida - è in effetti limitato al poterpensare e giudicare, al poter-dire, ma non necessariamente dire in
pubblico poiché si tratterebbe là di un'azione, d'un potere
esecutivo che è negato all'Università"4. Pertanto si darebbero due
tipi di linguaggio: quello della verità e quello dell'azione. Il primo
puro, teorico, scientifico e relegato allo spazio della coscienza; il
secondo spurio - perché contaminato dall'esigenza del potere
governativo, dalla censura - pratico, e dedicato allo spazio
pubblico della prassi comune. L'uno luogo dell'istituzione
filosofica, l'altro luogo delle facoltà superiori.
Affinché le cose stiano come Kant vorrebbe, è necessario prima
di tutto isolare e delimitare la possibilità di questo spazio
puramente teorico nel quale gettare le fondamenta dell'istituzione
filosofica. Per far questo, Kant tende a ridurre il più possibile
l'equivocità del discorso pubblico fino a relegare paradossalmente
la filosofia e il suo sapere universale all'interno di un ambito quasi
privato. Qui però la decostruzione trova la faglia reale, mostrando
la servitù a cui è sottoposta la libera ragione nel luogo
dell'istituzione. Che ne è, infatti, di quello stesso gesto col quale
Kant traccia il limite che separa la pura libertà della ragione dal
contaminato e pratico sapere pubblico? Quale diritto si nasconde
qui dietro, nel mentre che si cerca di dare un diritto al sapere
filosofico - e dunque al libero ragionare -, di stabilirne un luogo
legittimo di fronte e al di là della censura del governo? Come
scrive Derrida: "Effettivamente, l'Università nel suo insieme è
responsabile davanti ad un'istanza non universitaria […] Se non
può aversi un concetto puro dell'Università, se all'interno
dell'Università non può aversi un concetto puro e puramente
razionale dell'Università, questo è semplicemente perché […]
l'Università è fondata. Un evento di fondazione non può essere
semplicemente compreso nella logica di ciò che esso fonda. La
fondazione di un diritto non è un evento giuridico. L'origine del
principio di ragione,
che è pure implicato all'origine
dell'Università, non è affatto razionale. La fondazione di una
istituzione universitaria non è un evento universitario"5.
C'è allora, potremmo chiederci, un'istituzione libera da censura?
Tale questione implica immediatamente anche la seguente: è
possibile un'istituzione filosofica e dunque un'istituzione in cui
praticare il libero ragionare? Di fronte a queste domande, Kant
tenta costantemente di allontanare e di rimuovere ogni fattore
censurante fino a raggiungere uno spazio puro nel quale far valere
la sola legge di ragione. Come però fa presente Derrida, non ha
molto senso domandarsi se l'istituzione utilizzi o subisca la
censura: di fatto l'istituzione, come l'università, non potrebbe
neanche sussistere fuor di censura. Infatti, se le leggi pure della
ragione pratica, kantianamente, non obbligano dall'esterno, con
un'imposizione, bensì muovono dall'interno con una libera
necessità di tipo morale, il passaggio alla sfera del diritto e della
coercizione - e dunque anche alla localizzazione istituzionalizzata
del sapere - dipende semmai dal male radicale che abita
nell'uomo. A causa della sua finitudine e della sua fallibilità
l'uomo è costretto a seguire il diritto e non soltanto la libera
morale. Sicché potremmo dire con Derrida: "senza il principio del
male nell'uomo non ci sarebbe alcuna università"6. Questo è il
fondamento non-universitario dell'università, nonché la
responsabilità altra che in esso si nasconde.
Il male radicale dell'uomo rappresenta una sorta di luogo liminare
che rende conto, fuor di ragione, dell'opposizione tra sapere e
potere, tra teoria e prassi, metafisica e tecnica. Qui giace
inindagato l'evento non filosofico della filosofia. Ma chi ne può
parlare, a questo punto? Chi può comprende il senso del male
radicale che fonda le fondamenta del sapere universitario e delle
53
sue partizioni? Come scrive Derrida: "Le tre facoltà superiori
hanno tutte e tre un'interpretazione specifica del male radicale.
Ma esse falliscono tutte e tre a comprenderlo poiché negano la
libertà concependo questo male come semplicemente 'ereditario':
malattia ereditaria per la Facoltà di Medicina, debito ereditario
per la Facoltà di Diritto, peccato ereditario per la Facoltà di
Teologia"7. Pertanto, soltanto la facoltà inferiore, l'istituzione
filosofica, sarebbe il luogo adatto in cui svolgere la domanda sul
male radicale, al di là delle sue riduzioni "ereditarie". Eppure, con
male radicale qui si allude ad un luogo che, come abbiamo visto,
fonda le fondamenta del sistema universitario presentato da Kant,
e di conseguenza in un modo o nell'altro anche le sfonda, le
eccede, le travalica. Chi pensa il male radicale non pensa più
soltanto e semplicemente all'interno dell'istituzione filosofica, tra
le mura della facoltà inferiore. Paradossalmente il filosofo,
proprio quando decide di essere tale, abbandona la propria dimora
per avventurarsi, senza più certezza alcuna sull'esito del proprio
cammino, in una terra straniera, dove non valgono più le
rassicuranti partizioni proposte da Kant, ma dove però esse
trovano origine. In eterno cammino verso il male radicale nel
mentre che traccia i confini del proprio libero ragionare, così
potremmo rappresentarci il filosofo, dentro e fuori le sue
istituzioni, né dentro né fuori, sul margine, in bilico8.
Dov'è, dunque, il nostro maestro-filosofo? Se ci aggiriamo per gli
spazi dell'Università sappiamo di trovarlo nel Dipartimento che
gli compete, ma poi, in maniera piuttosto paradossale, la sua
presenza si ripete un po' ovunque: andiamo a Medicina ed ecco
che lo rincontriamo anche lì, così a Teologia e anche a Diritto. In
realtà questa sua ubiquità si spiega facilmente se ci si rende conto
che il filosofo non ha luogo: "Questo maestro di verità commenta Derrida - in verità non esiste, non si trova in nessun
luogo, non ha luogo, non è presente, non è là (da), non c'è Dasein
di questo maestro filosofo"9.
Il maestro di ragion pura non ha luogo, né ha un luogo la sua
filosofia, che poi, a quanto pare, proprio sua non è. Ciononostante
nel Dipartimento di filosofia un maestro si dà, ed è il maestro del
filosofare. Questa è la specificità della sua disciplina: "essa si
insegna senza apprendersi. Questo insegnamento è un noninsegnamento"10. Il maestro di filosofia entra in scena occupando
sempre impropriamente lo spazio che gli viene assegnato
dall'istituzione. Ma questo e non altri è il maestro di ragion pura,
che non può quindi insegnare dei contenuti se non insegnando
prima di tutto degli atti. Egli insegna a filosofare e non la
filosofia, perché la filosofia non c'è. Il che non significa che non
si dia della filosofia nel filosofare. Double-bind, come dice
Derrida: "L'essenza della filosofia esclude l'insegnamento,
l'essenza del filosofare lo esige"11.
La testimonianza decostruttiva che lascia tracce dei propri atti
mancati sulla scena del filosofare allude allo spazio vuoto che
chiama alla filosofia. Ma questa chiamata non può che essere
esibita attraverso gli atti. Mai si farà contenuto di una
comunicazione verbale. Sicché il filosofare riguarda prima di
tutto le performances che vengono messe in scena. E qui con
performativo Derrida intende quella gestualità che traccia il
nostro comune stare al mondo, ben prima della metafisica
opposizione tra teoria e prassi, constatativo e performativo. Tale
performatività ci riguarda tutti - dentro e fuori le istituzioni proprio perché tocca il limite della nostra finitudine, si installa sul
margine ek-sistenziale del nostro Dasein e su questo insiste
testimoniando del male radicale che ci abita nel più profondo. Di
questo noi siamo responsabili prima di tutto. Per questo, in
ultimo, l'insegnamento della filosofia è questione etica:
"Noi siamo qui in questo luogo in cui la responsabilità fondatrice
passa per degli atti o delle performances - che non sono soltanto
degli atti di linguaggio nel senso stretto o ristretto, e che, per non
essere evidentemente più degli enunciati constatativi regolati su
una certa determinazione della verità, non sono forse più
semplicemente dei performativi linguistici; quest'ultima
opposizione (constatativo/performativo) resta ancora troppo
intimamente programmata dalla legge filosofico-universitaria detto altrimenti, dalla ragione - che bisogna qui interrogare. […]
Precisamente perché non ha mai riguardato solamente dei
contenuti di senso, la decostruzione dovrebbe non essere
separabile da questa problematica politico-istituzionale e
reclamare una nuova interrogazione sulla responsabilità, una
interrogazione che non si affidi più necessariamente ai codici del
politico e dell'etico ereditati"12.
Note
*
Università degli Studi di Milano.
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Werkausgabe Band IV, Suhrkamp,
Frankfurt, 1968, p.699.
1
2
I. Kant, Der Streit der Fakultäten, Werkausgabe XI, Suhrkamp, Frankfurt 1968,
trad. it., Conflitto delle facoltà, Morcelliana, Brescia 1994.
3
Conferenza pronunciata in inglese da J. Derrida il 17 aprile 1980 all'Università
di Columbia (New York), in occasione del centenario della Graduate School e
dopo la consegna di un Dottorato Honoris Causa [Apparsa in Philosophie, n.2,
aprile 1984, tr. it., J. Derrida, "'Mochlos' o il conflitto delle facoltà", in Del diritto
alla filosofia, Abramo editore, Catanzaro 1999, pp.185-223].
4
Ibidem, p. 203, corsivo nostro.
5
Ibidem, p. 189 e p. 219, passim.
6
J. Derrida, "Cattedra vacante: censura, maestria e magistralità", in Del diritto alla
filosofia, op. cit., p. 141.
7
Ibidem, p. 147.
8
Cfr. J. Derrida, "Dialogo con Jacques Derrida", in Annuario dell'Associazione
degli Studenti di Filosofia dell'Università di Milano 1999-2000, Cuem, Milano
2002, pp. 133-140.
J. Derrida, "Cattedra vacante: censura, maestria e magistralità", op. cit., p. 151.
10
Ibidem, p. 150.
11
Ibidem, p. 158.
12
J. Derrida , "'Mochlos' o il conflitto delle facoltà", op. cit., p. 209 e pp. 219-20,
9
passim.
54
Riflessioni sulle riforme universitarie (1989-2005)
di Stefano Boni*
Il percorso intellettuale che porta alla docenza universitaria è in
genere marcato da una profonda cesura. Dopo anni di ricerca
specialistica (quelli della tesi, del dottorato, delle borse postdottorato) in cui ti viene chiesto di elaborare un sapere innovativo
- di offrire un contributo specifico - in un particolare ambito della
conoscenza, sei introdotto all'insegnamento. Vieni presentato ad
una classe e ti viene chiesto di contribuire alla formazione di
studenti. Quale apporto fornire? Come impostare il discorso?
Cosa significa contribuire alla formazione di percorsi intellettuali
che sono diversificati? Quali sono le tecniche pedagogiche che
permettono di stimolare negli studenti nuovi percorsi analitici?
Queste domande affollano la mente del docente alle prime armi,
anche se - come me - ha avuto la fortuna di affiancare gli anziani
nei primi tentativi didattici.
Ci si rende conto che la promozione del 'sapere' si può intendere
in modi divergenti.
Si può cercare di comunicare una serie di nozioni, informazioni,
tecniche e verificare che queste siano apprese correttamente. In
questo senso la formazione è intesa come un 'plasmare' e un
'riempire' gli studenti con la finalità di generare saperi omogenei
e garantiti, perlomeno nei loro tratti essenziali. Il percorso
formativo è definito in maniera anonima, modulato in maniera
coercitiva, cadenzato in calendari rigidi e veloci. Spesso questa
procedura pedagogica è finalizzata a produrre professionalità da
immettere sul mercato del lavoro. L'università diventa il luogo di
corsi di formazione professionalizanti che recepiscono le
sollecitazioni e rispondono alle esigenze aziendali. La didattica
universitaria si trasforma (apre e cancella corsi, istituisce corsi di
laurea, spartisce finanziamenti, indirizza la ricerca) in funzione
delle necessità del mercato del lavoro. In antropologia, si
potrebbe pensare ad un percorso formativo impostato su questi
criteri per produrre mediatori culturali o esperti in cooperazione
internazionale. Una volta prodotte queste professionalità, il loro
inserimento nel mondo dell'impiego sarebbe funzionale e non
traumatico: il percorso universitario avrebbe già predisposto lo
studente ad essere un professionista, secondo i canoni richiesti
dall'azienda. L'impianto delle riforme universitarie (avviate da
Ruberti, perfezionate da Berlinguer e culminate nella Moratti
seguendo una medesima tendenza che prescinde dai governi che
si sono succeduti in questi ultimi quindici anni) è stato teso ad
affermare questo modo il intendere di sapere, non solo nelle
università, ma in tutto l'apparato scolastico. La sottrazione agli
studenti della possibilità di determinare il proprio percorso di
studio (mediante corsi di laurea in cui la scelta soggettiva ha
sempre meno peso), la modularizzazione (ovvero una drastica
riduzione delle ore dei corsi con conseguente impoverimento di
un percorso di riflessione), l'entrata dei privati nei consigli di
amministrazione, l'impoverimento degli enti di ricerca pubblica,
la possibilità per le aziende di istituire corsi, la contabilizzazione
del percorso formativo in termini di crediti con la mortificazione
delle tesi sono alcuni dei sintomi di questa trasformazione.
L'aumento spropositato delle tasse universitarie (circa 2000% in
quindici anni) è coerente con questa logica: l'università genera un
sapere che verrà gratificato con salari adeguati, quindi il futuro
lavoratore paga per la sua professionalizzazione. La
precarizzazione della docenza e della ricerca, un fenomeno che ha
visto una crescita esponenziale in questi ultimi dieci anni,
rappresenta l'estensione ai formatori - i docenti - delle inevitabili
leggi del mercato nel terzo millennio che già interessano i
'formati'.
Un modo radicalmente diverso di intendere il percorso formativo
consiste nel cercare di stimolare percorsi di riflessione che non
hanno un fine pre-determinato se non la problematizzazione dei
concetti, la riflessione sulle metodologie, il confronto tra
paradigmi analitici, l'attenta valutazione di pregi e difetti delle
opere. Questo percorso vive di stimoli, di riflessione e di
confronto; non può essere costretto in paradigmi predeterminati di
un sapere cumulativo e certo. Deve essere attento alle specificità
dello studente e deve rispettarlo lasciandogli la possibilità di
determinare i tempi e le modalità della sua formazione; lo scopo
non è la costruzione di professionalità tecniche ma di una
consapevolezza critica. Il sapere non è finalizzato ad essere
immediatamente spendibile nelle imprese ma può svolgere una
benefica opera di controllo, proprio perché è estraneo alla logica
del profitto che pervade il settore privato. La trasmissione di
conoscenze è pubblica nel senso che dovrebbe essere accessibile
a tutti (e non solo a chi sta per entrare nel mondo del lavoro), nel
senso che richiede una riflessione allargata (come il seminario alla
de Certeau) e nel senso che genera benefici pubblici, soggettività
consapevoli.
Un chimico che lavora per una impresa petrolifera deve limitarsi
ad avere le competenze che consentono a quella azienda di
utilizzare la sua opera per trarne profitto o deve avere una
coscienza ambientale più generale che gli permette di opporsi ad
operazioni che generano profitto aziendale ma anche danni
ecologici? La facoltà di Economia e Commercio deve essere
centrata sullo studio delle diverse modalità di produzione e sulle
teorie a riguardo o deve essere pensata come un corso di
formazione per bancari? Nel momento - questo in cui viviamo in cui si stanno smantellando sistematicamente tutte le forme di
ricerca pubblica, chi si farà carico del monitoraggio indipendente
di una una società aziendalizzata?
L'antropologia e la storia ci insegnano che ormai da qualche
secolo si è affermata una educazione produttivista. L'economia,
ormai scissa da altri ambiti del sociale, ha acquisito una forza
propulsiva propria che assoggetta e trasforma gli altri campi
dell'agire umano, cercando di renderli funzionali ad una continua
crescita produttiva. Rifiutare che l'università entri in questo
meccanismo travolgente, significa - in quest'epoca di certezze svolgere un'operazione squisitamente antropologica: svelare le
55
logiche di un pensiero egemonico che si vorrebbe indiscutibile e
proporre un'alternativa culturale. Alternativa che rimarrà
aspirazione frustrata - visione antropologica perdente, pratica
culturale potenziale, ciò che si immagina perché non c'è - fino a
quando non avrà la forza, pratica, di imporsi.
Il percorso delle riforme universitarie rafforza la consapevolezza
esperienziale che viviamo in un'epoca di impotenza democratica.
Il cittadino può seguire i percorsi delle leggi; può denunciare le
logiche che sottendono le trasformazioni; si può mobilitare per
esprimere il suo dissenso; può organizzare manifestazioni e
occupazioni; quelli meno potenti spingono la protesta al limite
della legalità, chi ha contatti più autorevoli tenta di intervenire per
avanzare le modifiche che più gli fanno comodo. Tutto questo è
ammesso - anzi previsto - nella consapevolezza che l'autorità
democraticamente eletta segue comunque una sua logica
ineluttabile, nella consapevolezza che i cambiamenti di
schieramenti politici al governo non segneranno forti
discontinuità rispetto al progetto complessivo. Non si ritiene
necessario confrontarsi con il corpo docente e studentesco
nell'elaborazione delle riforme. La legge entrata in vigore è frutto
di elaborazioni dei potentati accademici, di trattative tra partiti
nelle commissioni parlamentari, di misteriose riformulazioni del
testo da parte del ministero, di voti di fiducia, delle assenze dei
parlamentari al momento del voto in aula. La nostra quotidianità
- la struttura in cui avviene il processo formativo in cui docenti e
studenti sono coinvolti - è ridotta a soggetto passivo -pace
Foucault - di fronte alle logiche della democrazia parlamentare.
Rimane la parola dissenziente, atto debole, attualmente incapace
- da sola - di generare la trasformazione antropologica che
potrebbe portare all'affermarsi di una università in cui il sapere è
dialogico, libero dalle leggi del mercato, pubblico e partecipato.
*
Università di Modena e Reggio Emilia
Il risveglio delle metafore
di Davide Borrelli*
potremmo dire che il sapere funziona letteralmente come una
"metafora", un principio di mobilità permanente che opera come
un dispositivo di dislocazione di territori mentali.
La metafora, come si sa, è quella figura retorica che reca nel suo
codice genetico la qualità di "portare oltre", cioè di attraversare i
confini degli ordini dei significati per combinarne i tratti in
maniera inedita ed imprevedibile. Talvolta però accade che una
metafora possa smarrire la sua energia dinamica e cristallizzarsi
intorno ad un determinato significato, tanto che a chi se ne serve
può capitare di dimenticare la sua originaria natura metaforica e
cominciare ad utilizzarla come se fosse invece la definizione
letterale corrispondente in senso proprio a quel particolare
referente semantico. E' il caso per esempio di quando utilizziamo
espressioni come "piede del tavolo" o "collo della bottiglia". Si
dice in queste circostanze che la metafora si è assopita, cioè ha
perduto la sua effervescenza ermeneutica per dare luogo a quella
che nel linguaggio della retorica si definisce una catacresi.
Ebbene, potremmo dire che se il sapere è dell'ordine del
metaforico, spesso l'insegnamento si risolve in un processo di
catacresizzazione della conoscenza, facendo smarrire tutto il
carattere processuale ed euristico delle metafore sotto il peso delle
tradizioni, degli apparati e dei linguaggi disciplinari. Nessun
gesto può risultare più ostile al sapere e contrario alla sua
autentica vocazione "metaforica" che decidere di trasformarlo in
un universo di discorso cristallizzato o in un repertorio simbolico
istituzionalizzato.
La forma seminariale descritta da Michel de Certeau è un luogo
dove alle metafore della conoscenza viene impedito di assopirsi e
dove le catacresi del senso sono sistematicamente risvegliate,
In tempi di controverse riforme dell'università e di affrettati
progetti di riforma delle riforme appena approvate, lo scritto di
Michel de Certeau sulla forma seminario ha il merito di
sollecitarci ad una riflessione quanto mai opportuna su che cosa
significa e qual è la posta in gioco dell'insieme delle pratiche che
definiscono la funzione dell'insegnamento. Che tipo di segno si
lascia quando si in-segna? Questo è il genere di domande che
dovrebbe porsi un legislatore non incauto ogni volta che si
accinge a porre mano a complesse e spesso confuse operazioni di
ingegneria accademica.
Perché il "seminario" come luogo emblematico della riproduzione
culturale, innanzitutto? Perché, cioè, una pratica di insegnamento
che viene definita in relazione all'atto di spargere "semi" piuttosto
che di capitalizzare e raccogliere frutti? E come si valuta, del
resto, l'efficacia formativa di un seminario, visto che la sua attività
non consiste nel fornire prodotti osservabili, ma nel disseminare
possibilità? E visto che il suo metodo conduce meno ad
individuare un senso che a dispiegare dei sensi, intesi come
orientamenti di marcia, méth-odoi appunto nell'accezione
etimologica del termine? E visto che il suo obiettivo, infine, non
si pone il problema di raggiungere delle mete ma piuttosto si
gioca tutto all'interno dei percorsi e delle modalità che ne
garantiscono la praticabilità?
Il sapere non è qualcosa che si possa mai pensare di
padroneggiare una volta per tutte. L'idea di sapere che affiora
dalla pratica del seminario così come ce la racconta de Certeau, si
avvicina piuttosto all'immagine di un vettore di trasporto che ci
permette di transitare attraverso una fitta e multiforme trama di
linguaggi, esperienze, sensibilità e forme di vita. In questo senso
56
rimesse in circolo e fatte pulsare di nuova vita. E questo perché il
seminario non presenta la conoscenza come un oggetto che si
trasmette, ma come un ambiente che reca le tracce delle storie e
delle soggettività di coloro che lo hanno abitato. Per usare una
terminologia certiana, diremmo che la conoscenza non si sa
strategicamente, piuttosto si vive tatticamente. Che il seminario
costituisca l'ambiente più idoneo per riscoprire la qualità
metaforica di ogni sapere è il messaggio che con grande lucidità
ed acume ci consegna de Certeau, non cessando mai di ricordarci
che per il soggetto della conoscenza la posta in gioco non è mai
l'individuazione di un senso proprio (cioè appropriato) delle cose
bensì il riconoscimento del proprio senso in esse, del modo
d'essere in cui le interpreta, le declina e le fa proprie.
*
Università di Lecce
Il seminario: spazio di confine tra il "centro" di produzione del sapere e
l' "erranza" intellettuale.
di Barbara Caputo*
Mi chiedo cosa ne penserebbe de Certeau, intellettuale che ha
dedicato consistente parte del suo lavoro alle modalità
"antidisciplinari" di sottrazione all'imposizione dell'ordine del
discorso, e alla strutturazione dei tempi e dei luoghi che la rende
possibile se, nel riflettere sulla sua concezione di seminario,
faccio riferimento a un saggio d'ispirazione strutturalista come
quello di Jean-Pierre Vernant su Hestia ed Hermes. Credo che non
me ne vorrebbe, da quell'intellettuale che ha costituito la sua
riflessione al confine dei saperi e apporti disciplinari più diversi,
comparendo insieme a Lacan tra i fondatori dell École freudienne
di Parigi, e proficuamente avvalendosi della nozione di métis
greca formulata da Detienne e Vernant per forgiare il suo concetto
di ruses quotidiennes.
Ritengo proficuo avvalermi delle figure mitologiche di Hestia ed
Hermes, discostandomi dalla minuziosa interpretazione
storicamente contestualizzata, in quanto rappresentazioni
costituenti influenza e traccia delle istituzioni sociali della Grecia
arcaica, soprattutto nel loro valore di metafore dal valore
euristico, aperte a una pluralità di interpretazioni, e alla relazione
strutturale tra le due figure, che rimanda alla tensione tra il centro
e il percorso, tra il ripiegamento interno sui valori del gruppo,
l'apertura allo straniero e l'erranza che arricchisce il gruppo
stesso.
Se Hestia costituisce il punto centrale, a partire dal quale lo spazio
umano si organizza, per Hermes non vi è niente "di fisso, di
stabile, di permanente, di circoscritto, né di chiuso. Egli
rappresenta, nello spazio e nel mondo umano, il movimento, il
passaggio, il mutamento di stato, le transizioni, i contatti tra
elementi estranei". Per Hermes il ladro non esistono "né serratura,
né recinto, né confine". Una tensione che non ha mai fine, e che
forse ben può adattarsi a quella tensione tra l'ordine spaziale che
proietta e riproduce le strutture di potere, la circoscrizione di
luoghi distinti dove la legge del "proprio" regna - strategia non
discorsiva che crea le condizioni per la produzione del discorso, e
del disciplinamento dei corpi - e la figura dell'erranza tanto cara a
Foucault e a de Certeau.
Hestia ed Hermes costituiscono due qualità costitutive dello
spazio, due possibilità insite in esso e in interrelazione dinamica.
Si tratta di quel centro dotato di valore privilegiato per la carica
simbolica conferita ai valori che gli si condensano intorno, che
non è pensabile se non nella continua relazione alla possibilità
dell'apertura, e dell'arricchimento che deriva dal movimento e
dallo sconfinamento, dal crescere esponendosi anche al rischio
della perdita, o forse della messa alla prova, dei valori del
"centro". Alla stessa Hestia, non bisogna dimenticarlo, spetta
l'accoglienza presso il focolare domestico dello straniero. Vedo in
questa opposizione non solo la tensione creativa tra il centro di
produzione di sapere dell'università e lo spazio di erranza,
creatività intellettuale non strutturata del seminario, ma anche la
natura stessa del lavoro dell'antropologo, per definizione
costantemente "sulla frontiera", da un lato quindi pronto a
rimettere continuamente in discussione le sue coordinate teoriche
ed epistemologiche, dall'altro a fare da tramite, mediatore,
traduttore e introduttore della voce dell'Altro e dell'Altro stesso:
figura non solo del passaggio di frontiera dunque, ma anche
dell'accoglienza. Proprio in questa tensione tra centro, in questo
caso accademico e movimento, l'antropologo si deve sentire a
causa di ciò forse più spinto di altri a riflettere sulla traduzione e
trasposizione nello spazio seminariale dell'accoglienza dell'Altro,
e del suo discorso creativo e innovativo, costituendo ciò che
Certeau definiva con lo stesso termine con cui designava i suoi
gruppi di ricerca, dei cercles d'interlocution, che costituiscano
possibilità di libere pratiche antidogmatiche e "antidisciplinari",
buissonnières: pratiche "artistiche" e creative che "giocano"
l'ordine disciplinare.
La mia intenzione era dunque di rinvenire, o forse costruire, un
qualche trait d'union tra il discorso di Certeau, che nell'analisi ed
elegia delle pratiques d'espace come liberi discorsi anti-strutturali
trova una delle sue più felici declinazioni, e i poli spaziali
mitologici di Vernant. Il "centro" può sfuggire alla
cristallizzazione solo aprendosi al movimento, all'accoglienza
dello straniero, agli atti di "delinquenza" che nel libero
57
movimento tra spazi diversi - perché i centri sono molteplici - e
nella manipolazione sovversiva delle regole d'uso, apre la via alla
costituzione di liberi discorsi, e in questi la libertà, pluralità,
continua innovazione e creazione intellettuale, e il discorso in atto
di libertà.
Vi è tuttavia un punto su cui non mi trovo d'accordo con Certeau,
vale a dire la connotazione nettamente negativa che egli sembra
talvolta conferire al luogo "permanente", che non può essere
inteso se non come sito di produzione di potere. Nel suo saggio
Che cos'è un seminario, i legami del discorso circoscritto con
quelli del pensiero più generale e maturo esposto in L'invention du
quotidien appaiono evidenti. Se Certeau ha il merito di ridare
visibilità, potere e valore alle microtattiche quotidiane di
resistenza, egli la definisce però in buona parte come un' "estetica
del colpo", un'arte che si limita a cogliere occasioni, e che,
costituendo luoghi sempre transitori e aperti, così come lui
pensava i suoi cercles d'interlocution, non edifica costruzioni di
resistenza, e non elegge il luogo stesso a posta in gioco di lotte,
come luogo dove lo svelamento della doxa e dei processi di
imposizione degli schemi classificatori divenga possibilità
permanente, e aperta alla discussione e agli interventi esterni
all'accademia. Lo stesso Foucault, nel suo disegnare quell'arazzo
di metafore che costituiscono tante possibili eterotopie, non
ricorreva solo alla figura della nave, ma anche a quella del teatro,
che può ospitare sullo stesso sfondo molteplici scenari, o del
giardino orientale, ricomposizione della molteplicità che
costituisce il cosmo. Ogni spazio, ogni pratica, ogni narrazione,
costituiscono un campo di significati in cui possono
contemporaneamente sussistere differenti livelli simbolici e
semantici, diverse memorie, diverse funzioni e discorsi, che non
rimandano necessariamente al gioco di un potere o a (talvolta)
mute e puntiformi, sfuggenti strategie di resistenza, in un rapporto
di reciproca esclusione. La frontiera sussiste in questo spazio di
apertura del mondo accademico alla discussione e alla messa in
discussione, alla rinuncia all'imposizione di un ordine dogmatico,
e all'inclusione degli esponenti di punti di vista e azioni sociali tra
i più diversi. Luce Giard enumera alcuni dei soggetti con i quali
Certeau ebbe l'occasione di intessere un proficuo dialogo negli
anni di intensa ricerca sociale: "militanti di quartiere che si
mobilizzavano contro le grandi operazioni di pianificazione
urbana decise da un potere tecnocratico, educatori in ambito
carcerario o nelle periferie diseredate, associazioni di aiuto agli
immigrati, architetti responsabili dell'edificazione di nuove città
nella regione parigina, giovani donne che cercavano di prendere
in gestione la loro salute, minoranze che difendevano una
tradizione e una lingua regionali contro lo Stato centralizzatore e
unificatore etc." (Giard 1990: 25). E la lista potrebbe allungarsi
ancora.
Il seminario non deve limitarsi a mio avviso ad essere evento di
trasgressione errante e fuggitiva, quanto piuttosto "straniero"
sempre insidiato nel centro, apertura che presiede a una tensione
continua tra centro ed esterno, e che può farsi, e deve mirare, a
una messa in discussione permanente delle logiche di costituzione
del potere accademico in forma di discorso che tende a imporre
un ordine, ponendone le premesse per continue interrogazioni
critiche.
Chi conduce il seminario stesso ha una gran parte di
responsabilità nel realizzare questa concezione. L'antropologo,
che è colui che sul campo è chiamato a mettere da parte prestigio,
e capitale simbolico e culturale di cui gode nello spazio
accademico, confondendosi con i soggetti della sua ricerca (ai
quali, dell'accademia poco spesso importa), e avendo tanto più
successo in essa quanto più condivide tempo, pratiche, cognizioni
e sentimenti con gli altri, costituendo sulla comune esperienza
condivisa, sul dialogo e sullo scambio la ricchezza e la riuscita del
suo lavoro, deve sentirsi in prima persona coinvolto a far sì che
questa sua "trasgressione" dagli schemi classificatori sociali e
questo suo "sconfinamento" non siano un "decentramento" di
pratiche destinato a rimanere ben circoscritto, in uno spazio che
rimarrebbe in questo caso "periferico", marginale e, au but du
compte, interiorizzato. Ma la riuscita piena del seminario sarà nel
costituire la frontiera, il segno visibile forse più di altri degli
attraversamenti e di trasformazioni multidirezionali, entrando
sempre più in tensione costruttiva con l'ordine del luogo
universitario. Qui pratiche, saperi, discorsi e punti di vista si
devono incontrare su un piano di dialogo paritario e di reciproco
arricchimento, di continua creazione di nuovi discorsi,
proliferazione di parole che innova e amplia continuamente le
possibilità offerte dalla langue accademica e disciplinare, parole
che entra ed esce dallo spazio universitario e circola
costantemente al suo esterno.
Ritengo che questa visione concordi in parte con quanto afferma
Bourdieu, in Esquisse pour une auto-analyse (preferisco il titolo
originario alla pur creativa traduzione, di magrittiano sapore,
Questa non è un'autobiografia): "La forza dei gruppi integrati, il
cui limite (e il cui modello pratico) è la famiglia conforme, deriva
in gran parte (…) da una complicità fondamentale nel fantasma
collettivo, che assicura a ciascuno dei membri l'esperienza di
un'esaltazione dell'io, principio di una solidarietà radicata
nell'adesione all'immagine del gruppo come immagine incantata
di sé" (Bourdieu 2005: 18). Dove andrebbe a finire dunque
l'umiltà metodologica del ricercatore sociale, se egli non
assumesse la sua emicità ad impegno etico primario nelle mura
accademiche, consentendo la creatività discorsiva, l'ingresso e il
confronto con i discorsi altri e degli altri?
Lo svolgimento di un seminario andrebbe improntato al modello
dell'isonomia, l'equilibrio tra forze fisiche su cui poggia l'ordine
cosmologico secondo Anassimandro, e che si sarebbe tradotto per
Vernant, nella polis ateniese di Clistene, nella scomparsa di un
punto centrale privilegiato. Chi coordina un seminario deve
essere, uso ancora le parole di Bourdieu, "il lavoro permanente di
incoraggiamento e di unificazione che spetta all'animatore, sorta
di direttore d'orchestra e di regista, se non, più modestamente, di
allenatore" (ibid: 28), o ancora di suggeritore, indicatore di
direzioni, che può, e deve mettere in circolo, il suo sapere e la sua
esperienza.
Il modello che Certeau proponeva per le pratiche di resistenza
sociale, per quelle arti che "giocano" l'ordine, era il ritorno
58
all'altro, o essere complementari, a seconda dei casi. E ci
sarebbero ancora i modelli di dono assolutamente gratuito
proposti da Jacques Derrida o Remo Guidieri. Anche il modello
del dono, coerentemente con quello del seminario qui proposto,
deve godere dunque di una sua apertura alla pluralità e creatività
dei discorsi, al loro confronto e alla loro circolazione.
all'economia del dono, quale forma di détournement e di "etica
sociopolitica" opponentesi al potere dominante, al discorso
ideologico, e alla circoscrizione progressiva di tempi e di luoghi.
Nel far questo egli si richiamava espressamente al potlatch nella
sua lettura maussiana, intendendolo come gioco basato sulla
reciprocità e su di un "obbligo di dare" (Mauss 2002: 65).
Credo che il modello del dono si attagli mirabilmente a una idea
di seminario, che fondi una sua etica della tenacità su una "nobile
gara", dove la competizione va intesa non come un superare
l'altro, ma come superarsi reciprocamente nel dono, inteso come
contributo arricchente e fondamentale alla riuscita del seminario
stesso, "obbligo a ridistribuire tutto ciò che si è avuto, (…) di cui
si è stati beneficiari (ibid: 68). Un obbligo che è anche questo di
apertura all' Altro (come d'altra parte il kula), e che, per
continuare con le metafore, "non ha neppure senso (…) se non è
fatto a persone diverse dai componenti della famiglia, del clan o
della fratria. Bisogna invitare chi può e vuole o viene ad assistere
alla festa, al potlàc" (ibid: 68-69. Il corsivo è mio). Il riferimento
maussiano all'obbligo di redistribuire può rimandare a un
differente senso o linguaggio del dono, quello di Jacques Godbut,
che porta alla donazione in senso verticale, da una generazione
all'altra, comportando un debito positivo che non contempla
esigenza di restituzione a breve scadenza, ma piuttosto la
trasmissione dell'eredità alla generazione successiva. E, nel caso
del seminario, non penso che i due modelli si escludano
reciprocamente, ma piuttosto che possano coesistere l'uno accanto
*
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Riferimenti bibliografici
Pierre Bourdieu, 2005: Questa non è un'autobiografia. Elementi per un'autoanalisi,
Feltrinelli, Milano.
Michel De Certeau, 1980: L'invention du quotidien, Gallimard, Paris.
Jacques Derrida, 1996 : Donare il tempo. La moneta falsa, Cortina, Milano.
Luce Giard, 1980: "Histoire d'une recherche", in De Certeau, M, L'invention du
quotidien, Gallimard, Paris.
Remo Guidieri, 1999 : Ulisse senza patria, l'ancora led mediterraneo, Napoli.
Jacques Godbut, 1998 : Il linguaggio del dono, Bollati Boringhieri, Torino
Michel Foucault, 1994: "Eterotopia", in Millepiani, n. 2, Mimesis, Milano.
Marcel Mauss, 2002: Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società
arcaiche, Einaudi, Torino.
Jean-Pierre Vernant, 1970: L'organizzazione dello spazio, in Mito e pensiero
presso i Greci, Einaudi, Torino.
Quei discorsi 'inconcludenti'
di Elena Gagliasso Luoni*
Alla Facoltà di Filosofia dell'Università de 'la Sapienza' di Roma
(tra il 1989 e il 1996) ho avuto la fortuna di praticare due
seminari di studio. Due esperienze a carattere assai diverso, ma di
cui voglio parlare insieme. La loro evoluzione dinamica, più che
i contenuti, qui c'interessa: nascita, sviluppo e successivo
'declino', in quanto gruppi informali, dal momento che entrambi
sono diventati successivamente qualcosaltro, di più strutturato.
Si è trattato del 'Gruppo di interesse in Filosofia della Biologia',
nato spontaneamente come sotto-settore della Silfs (Società
Italiana di Logica e Filosofia della Scienza) e rapidamente resosi
autonomo, e del 'Gruppo Donne & Filosofia' che ha messo a
ragionare di femminismo e filosofia studentesse e docenti
insieme.
Analoga la loro nascita, assolutamente informale. Analogo, dopo
un po' di anni, il loro esaurirsi come semplice seminario ristretto
per passare a prove più impegnative: in un caso una Scuola di
Specializzazione Estiva in Storia e Filosofia delle Bioscienze1, e
un motore di convegni, pubblicazioni, ricerche finanziate;
nell'altro, una Rivista semestrale, Sofia. Materiali di filosofia e
cultura di donne, che ha sviluppato le sue pubblicazioni per
svariati anni.
Nel primo caso s'era trattato di una sorta di 'piccola sfida', lanciata
da alcuni di noi, filosofi e storici della biologia, per vedere se si
sarebbe riusciti a parlare tra filosofi, epistemologi, storici delle
scienze del vivente, biologi, neurofisiologi, naturalisti2. Parlare
nel senso proprio di dire e farsi capire, tradurre gerghi
specialistici, condividere sistemi culturali diversi e produrre un
contesto, un setting direi, in cui, liberi da status accademico, da
target, da reciproche esibizioni di appartenenza di scuola, ci si
metteva in gioco. Ci si 'contaminava'. Ecco, intanto, il primo
punto di risonanza che incrocia il discorso di de Certeau:
contaminazione, meticciato, o come provocatoriamente egli
scriveva, bastardaggine, ma anche, e di converso, un mettere
meglio a fuoco "il proprio dal non-proprio".
Nel corso degli incontri mensili, di sabato mattina, non uscivamo
certo, dopo queste contaminazioni, uguali a come eravamo
arrivati. Si producevano effettivamente quelle "porte di uscita e
rientro" che de Certeau mette a tema: "dei modi per prendere le
distanze in rapporto ai nostri compiti e delle possibilità di
ritornarvi in modo differente". Non c'era un centro
programmatico di lavoro, ma una libertà di mettere in gioco
letture, idee, critiche reciproche, esperienze, vuoi di laboratorio,
59
vuoi di didattica. A volte una lettura comune, più spesso
l'estenuante giustificazione inconclusa di quale avrebbe dovuto
essere un tema prioritario per il gruppo: insomma discorsi e
metadiscorsi, mentre la filigrana dei modi di pensare di ciascuno
e i propri linguaggi specialistici si intrecciavano con il modo di
pensare degli altri. Dopo, al ristorante a San Lorenzo, si
continuava, mai d'accordo, sempre spostati ciascuno dal proprio
nucleo di sicurezze. Divertendoci. 'Divertendoci' anche nel senso
più profondo del termine: 'di/vertere'= uscire dal percorso noto.
Era quello lo scarto critico di esperienze e il confronto "tra
ricerche che non è il seminario a creare". Poi chi si era sobbarcato,
per questo puro gusto, il viaggio dalle città fuori Roma era
accompagnato alla Stazione o proseguiva la giornata come nostro
ospite.
Nel gruppo si sono saldate alcune amicizie, ci si è conosciuti a
fondo nelle idee e negli stili personali come raramente ci si
conosce tra colleghi e affini.
Il gruppo delle ragazze-filosofe era invece partito, come si dice,
'dal basso'. Alcune studentesse erano venute a coinvolgerci, noi
più grandi e docenti, per discutere di femminismo dentro
l'Università, a partire da testi di filosofe ed epistemologhe francesi
e anglosassoni e dalla concreta possibilità di invitarne alcune3.
In questo altro gruppo, più uniforme dal punto di vista
disciplinare, le differenze erano insite nel ruolo: studentesse,
dottorande, docenti. Ma dopo poco lo si dimenticava. Anzi la
tensione inespressa era a compattare maggiormente una, già data,
omogenità di genere, confrontandola con gli studi del 'pensiero
della differenza', linea teorica egemone in Italia in quegli anni.
Una richiesta implicita di riferimento di genere che fosse positivo
e non marginalizzato restava inevasa (noi docenti allora si era
semplici ricercatrici). Ma il gruppo funzionava bene, tenendo
insieme riferimenti testuali e narrazione in prima persona,
misurandosi con lo studio di filosofe teoriche o di epistemologhe
contemporanee che non avevano un luogo deputato nella struttura
dei corsi ufficiali. Ma insieme prendendone le distanze attraverso
il proprio bagaglio filosofico più classico: un andirivieni
insomma. Così si sfatavano omogenità inesistenti, mentre alla
competenza di ciascuna sul proprio terreno filosofico si
affiancava "l'esame dei conflitti di potere impliciti nello scambio
di parole", e, quindi, la necessità di proteggere l'entità-seminario
nel proliferare delle divergenze di posizioni. Si leggeva dunque, si
discuteva, e si trattava con le nostre differenze, di formazione e
gusti filosofici, senz'altro con minore disinvoltura e più
passionalità manifesta che nell'altro gruppo.
Un pensiero diacritico insomma sulla duplice scelta di fare 'della
filosofia' e di assumersi (se, come, quanto, con che rischi)
l'identità di essere delle filosofe e non dei soggetti neutri. Si
scrivevano brevi testi a circolazione interna, senza finalità di
stampa, che mettevano a nudo idiosicrasie e appassionamenti
teorici: quasi un compitino, 'Io e la filosofia', non era in realtà
naivetè scolastica, ma spazio per dire alle altre (e a se stesse) su
un percorso di autoriconoscimento.
Per entrambe i gruppi sto parlando di una fase che, secondo
un'ottica funzionale accademica, possiamo definire iniziale, di
radicamento, a cui ne è successa, come s'è detto, un'altra,
maggiormente ordinata, più riconosciuta, con un accesso
allargato, compiti e responsabilità precise e una visibilità più
autorevole.
Ma, nel soffermarmi su questa fase germinale, penso che non è un
caso che in tutti e due i contesti, una maturazione e un accesso più
istituzionale di un qualche successo si sono accompagnati a una
diminuzione di passione dell'esserci e del fare insieme. Ciò non
solo per l'ovvietà del fatto che gran parte del tempo insieme era
scandito, anzi incalzato, da impegni più organizzativi, accademici
o redazionali (nonché finanziari), ma anche perché -mi sembra
ora di poterlo riconoscere meglio- il cuore della fecondità
intellettuale, creativa e relazionale, stava proprio dentro quella
dimensione di non spendibilità immediata, di quasi inesistente
'ottimizzazione': in una parola di spreco. Spreco dal punto di vista
di ritorni concreti, quasi una gratuità imbarazzante, dedicata a noi
stessi, che non sempre si può accettare e praticare.
Dunque un prima e un dopo. Due fasi nella storia di questi due
gruppi che sarebbe davvero riduttivo contrapporre solo secondo
un criterio romantico di un prima più libero e autentico e di un
dopo inevitabilmente più imbrigliato da regole, o disciplinamenti
con "funzione restrittiva e costrittiva"4. Sono un prima e un dopo
piuttosto come bilanciamento mai saturo tra spreco e
ottimizzazione quelli che un seminario nato spontaneo incontra.
Come accade per la vita di ciascuno e per la ridondanza
molteplice e senza finalità programmatiche di tutto ciò che è
vivente, anche un seminario di questo genere (come cosa viva,
come rete di relazioni e saperi, non nato per ragioni accademiche)
incontra questo bilanciarsi -e sbilanciarsi- tra una gratuità 'inutile'
dal punto di vista istituzionale e un ritaglio e rarefazione di
potenzialità, obbligati dal suo corroborarsi.
Per come è fatta l'Università, ma forse, direi, qualsiasi istituzione,
un seminario che non trova esiti di crescita in visibilità e
spendibilità (a qualsiasi livello si voglia intendere ciò, dalla
costruzione di pubblicazioni, agli incontri congressuali, alle
didattiche più o meno specialistiche) può solo fidare nelle
dinamiche del gruppo, nella sua intelligenza locale e diffusa e
soprattutto nell'eventualità storica e contestuale di fasi propizie;
scorci che si possono aprire come oasi, legittimando l'esercizio
dell'intelligenza 'senza alcuno scopo di carriera'. Fasi sporadiche
però, non normalità accademica. Anzi, di converso, è anche la
trasformazione in qualcosa di più impegnativo e solido che
permette di considerare a posteriori questi gruppi come fecondi,
dal momento che il loro stato più informale e magmatico non
sarebbe potuto durare, come tale, sul lungo periodo.
Il segno che esperienze simili lasciano è siglato dall'apertura.
Apertura mentale e relazionale. Con quanto di irrisolto, di
affasciante anche, ma di lontano dai sistemi di rassicurazione è
peculiare delle esplorazioni non centralizzate o nettamente
finalizzate. Esplorazioni fatte per noi da discorsi mai si
concludevano. Così, per qualcuno, proprio per l'esperienza che vi
si è vissuta dentro, quel tipo e quella fase del seminario ha fatto
cambiare senso al disvalore connotativo solitamente legato alla
in/concludenza di un discorso.
60
Note
Massimo Stanzione e la sottoscritta.
3
Furono infatti invitate le filosofe Luce Irigaray da Parigi e Rosi Braidotti da
Utrecht.
*
Università di Roma “La Sapienza”
Indico il sito: http://www.gedy.it/unicivica.
2
Tra i biologi Pietro Omodeo (Università di Siena), Marcello Buiatti (Università
di Firenze), Saverio Forestiero, Guido Modiano, Francesco Amaldi (Roma 'Tor
Vergata'). Neurofisiologi: Aldo Fasolo (Università di Torino), Umberto di Porzio,
1
4
L'espressione è di Foucault (M. Foucault, L'ordine del discorso, Einaudi, Milano,
1972 (ed. or. 1970), pp.29. E inevitabile è ricordare l'intero apparato della sua
analisi, ovvero quei meccanismi di controllo ed esclusione visti in relazione alle
discipline, ma usabili anche nel caso di istituzionalizzazioni ben più blande:
"…principio di controllo della produzione di discorso (…) che fissa dei limiti col
gioco d'una identità che ha la forma di una permanente riattualizzazione delle
regole" (ibidem).
Paolo Bazzicalupo (ISBN di Napoli). Storica delle neuroscienze Carmela
Morabito (Università di Chieti) e storico della medicina Gilberto Corbellini (La
Sapienza). Filosofi della Scienza: Vittorio Somenzi, Barbara Continenza,
A proposito di giocatori
di Alberto Giasanti*
Che cos'è il Giuoco delle perle di vetro? L'invenzione viene
attribuita ad un musicologo che costruisce, sull'esempio dei
pallottolieri per bambini, un telaio con alcune dozzine di fili tesi,
sui quali allineare perle di vetro di grandezza, forma e colori
diversi. I fili corrispondono al rigo musicale e le perle alle note.
Con le perle di vetro si compongono frasi o temi musicali che poi
vengono modificati, sviluppati, modulati o contrapposti ad altri
temi. Un gioco pratico per gli studenti di musica lasciato presto
andare in disuso, ma ripreso dai matematici che lo utilizzano per
esprimere fatti matematici con segni e abbreviazioni particolari.
Da quel momento in poi pare che il Giuoco venga accolto e
applicato in tutti i campi delle scienze, creando ciascuna un
linguaggio di formule, abbreviazioni e possibili combinazioni.
Così il Giuoco assume un proprio linguaggio e proprie norme, ma
limitatamente a ciascuna disciplina e in qualche modo rimane
ancora prigioniero dei recinti e delle barriere che ogni scienza
particolare si costruisce. Incomincia però ad affascinare molti tra
studiosi, studenti, accademie, ordini professionali, artisti, letterati,
filosofi, sino a farlo diventare un'arte e una scienza elevata,
presentandosi come l'unione mistica di tutti i membri
dell'Universitas Litterarum o come una sorta di "teatro magico".
Ora non basta più seguire intellettualmente le successioni di idee
e il mosaico spirituale di un Giuoco con attenzione particolare e
con l'esercizio della memoria, occorre anche una profonda
dedizione dell'anima. In questo modo il Giuoco si arricchisce di
nuove funzioni con gli elementi della contemplazione e della
meditazione e diventa una festa pubblica: una specie di
linguaggio universale con il quale i giocatori delle perle di vetro
sono in grado di esprimere valori mediante simboli e di metterli
in reciproco rapporto. A questo punto diventa necessario un
Magister Ludi che possa presiedere al Giuoco delle perle di vetro
e un luogo dove possa essere coltivato e sviluppato: la Provincia
pedagogica che diviene il villaggio dei giocatori, la sede delle
varie scuole e il luogo di residenza del Maestro del giuoco.
Da qui inizia la storia di Josef Knecht, nel Giuoco delle perle di
vetro di Hermann Hesse, che, dopo un lungo percorso di
individuazione tutto teso al raggiungimento dei gradi più alti di
spiritualità, viene nominato nuovo Magister Ludi, accorgendosi in
quello stesso momento che la Provincia pedagogica non gli basta
più. E' necessario fare esperienza del mondo fuori, risvegliarsi
alla vita profana, affrontare difficoltà, dolori e privazioni, scoprire
antitesi ardite per potere alla fine riunire anima e corpo,
spiritualità e animalità, intelletto ed emozioni e viverli come poli
di un'unità. Abbandona allora la carica di Maestro del Giuoco e
ritorna nel mondo per morire e rinascere in un giuoco continuo di
profondità abissali e di altezze senza fine, di ombre bianche e di
ombre nere, di angeli e di demoni dove le doppie nature sono gli
specchi non riconosciuti delle nostre società.
Ho sempre pensato, sin dai miei primi anni di insegnamento
universitario in Sicilia e di esperienza delle "150 ore" nei paesi
bracciantili dei Nebrodi, che la provincia pedagogica hessiana
fosse un luogo da costruire insieme a tutti coloro, uomini e donne,
che intendevano riconoscersi come giocatori delle perle di vetro e
che l'università potesse essere il territorio nel quale praticare il
giuoco della conoscenza dove studenti e docenti agiscano,
ciascuno per la sua parte, l'esperienza libertaria del sapere così
che si possa consolidare una forma di resistenza contro il potere,
imparando a vivere la vita in modo consapevole. Cosa non facile
e non data una volta per tutte, come ci dice Giuseppe Pontremoli
nel suo Elogio delle azioni spregevoli, ma compito quotidiano che
si deve continuare a ripetere poiché l'invincibile ansia di
conformismo, di cui parlava Pasolini nelle Lettere luterane, è
sempre in agguato nel profondo delle nostre coscienze.
Uno spazio critico in cui esserci come persone intere e nel quale
affrontare con passione i contenuti formativi, ma perseguendo
qualsiasi possibile sconsacrazione e preparandosi sempre a tradire
il potere. Per capire il significato di "persone intere" o di "restare
intero" mi servirò di un esempio. A chiusura di un seminario
sull'ombra tenuto qualche anno fa avevo chiesto ad un gruppo di
studenti di sociologia di mettere in evidenza gli aspetti dell'ombra
più significativi e alcuni di loro avevano prodotto una serie di
disegni in sequenza. Nel primo era rappresentato un bambino
61
disegnato tutto intero, mentre i disegni successivi
rappresentavano quello stesso bambino privato di qualche parte
del corpo, man mano che passava dai primi anni di vita con i
genitori alla socializzazione nei vari ordini di scuola, dalle
elementari all'università. L'ultimo disegno rappresentava solo la
testa: il resto del corpo si era dissolto. Perché? Man mano che il
bambino cresceva, il sacco con dentro le sue ombre si ingrandiva
e si appesantiva fino ad un livello di insopportabilità tale per cui
al bambino, diventato adulto, non restava che tagliare il nodo
scorsoio che lo legava al sacco e all'ombra, pensando in questo
modo di liberarsi per sempre dei suoi lati oscuri e di conservare
solo quelli luminosi. Ma così facendo perdeva tutta la sua
corporeità e spariva come essere umano per assumere la veste di
automa appiattito e governato dalla sola testa. Automi che
potranno ricoprire ruoli sociali e professionali di potere o, al
contrario, ruoli subordinati ai primi, ma in entrambi i ruoli si
sentiranno, comunque, deresponsabilizzati e disumanizzati in
quanto svuotati di quelle ombre che nel tempo avevano proiettato,
con apparente soddisfazione, sugli altri.
Cerchiamo allora di non diventare poliziotti di noi stessi, ma di
trovare una modalità di vivere la vita come un percorso di
individuazione dove la pigrizia si coniuga con l'energia e dove,
per diventare responsabili delle proprie scelte, si paga il prezzo
del dubbio, dell'inquietudine, dell'incertezza, della provvisorietà.
Un percorso insomma tra borgo e bosco, stando attenti a non
soffermarsi troppo a lungo nell'uno e nell'altro luogo.
E' in grado oggi l'università di indicare dei percorsi di conoscenza
critica o ha ragione Kafka quando, nei Racconti, esprime l'idea
che l'educazione mira solo a respingere l'assalto delle persone
ignoranti alla città e poi a introdurre quelle stesse persone
umiliate nella menzogna?
*
Università degli Studi di Milan-Bicocca
L'università, l'istituzione e i suoi margini
di Michele Parodi*
Du bonheur qui n'est que de l'anxiété différée. Du bonheur bleuté,
d'une insubordination admirable, qui s'élance du plaisir, pulvérise
le present et toutes ses instances.1
È pensabile un'università critica? In che modo l'operare di
ognuno si iscrive e posiziona nelle maglie di un ordinamento per
sua necessità rigido e burocratico? Come è possibile nei margini
dell'istituzione esprimere il proprio disagio, la propria curiosità,
una creatività in grado di confrontarsi e confondersi con i
regolamenti, le gerarchie, le rivalità che l'istituzione produce?
Alla fine dei nostri sforzi, osservava Basaglia nel 1965, in un
intervento dal titolo Potere ed istituzionalizzazione, "ci si
incontra tutti allo stesso punto, di fronte allo stesso problema:
davanti alla necessità di un'organizzazione e all'impossibilità di
concretarla, davanti al bisogno di formulare un abbozzo di
sistema cui riferirsi, per subito trascenderlo; al desiderio di
provocare dall'alto gli avvenimenti e alla necessità di attendere
che essi si elaborino e si sviluppino dalla base"2 . Il problema è
anche quello di "come" organizzare un lavoro comune in cui
riconoscere reciprocamente la propria umanità in cammino, di
come immaginare una riflessione che si vorrebbe ininterrotta:
invenzione di "un modo di organizzare ciò che non può e non
deve essere organizzato"3 .
Per rispondere alle precedenti domande - a fronte del recente
proliferare di Master, Scuole di Specializzazione, corsi di
aggiornamento, che segnalano un'intensificazione e un
potenziamento delle forme di privilegio selettivo, a favore, come
è sempre stato, dei ceti più ricchi - potremmo iniziare col
chiederci se l'università debba continuare a circoscrivere le sue
attività alla produzione, trasmissione di conoscenze
specialistiche, e rimanere la custode di un insieme di
qualificazioni di professioni specifiche, oppure se non sia un suo
peculiare compito anche quello di decostruire incessantemente i
sistemi di saperi e i regimi discorsivi che contribuisce a formare
nell'esercizio delle sue "funzioni" - decostruire cioè se stessa.
Come dichiarava, con grande chiarezza, Ivan Illich, "la
scolarizzazione […] è il rituale di una società impegnata nel
progresso e nello sviluppo. Essa crea quei miti che per una
società consumistica sono una necessità. Per esempio ti fa
credere che l'apprendimento può essere diviso in varie parti e
quantificato, o che è qualcosa che acquisisci solo attraverso un
processo. Un processo nel quale tu sei il consumatore e qualcun
altro l'organizzatore, e tu collabori producendo la cosa che
consumi e interiorizzi"4 . La scolarizzazione secondo questa
prospettiva può essere pensata come il rituale di fabbricazione di
una credenza occidentale: "Il rituale che crea un mito su cui la
società contemporanea poi costruisce se stessa. Ne deriva, per
esempio, una società che crede nella conoscenza e nel
confezionamento
della
conoscenza,
che
crede
nell'invecchiamento della conoscenza e nella necessità di
aggiungere conoscenza a conoscenza, che crede nella
conoscenza come valore - non come bene, ma come valore - e
che quindi la concepisce in termini commerciali. […] È un
investimento di capitale, ma è anche una forma di controllo
sociale, di stratificazione, è la creazione di una società di classe
suddivisa in sedici livelli con un numero sempre minore di
62
dell'apprendimento istituzionale - i corpi, i piaceri, i saperi, nella
loro molteplicità e nelle loro possibilità di resistenza. Secondo
Foucault, i punti del contrattacco devono essere i corpi e i
piaceri9. Un corpo sempre incompiuto e mobile che dissipa la
regola, la definizione, e la sua stessa identità: corpo erotico,
danza - come quella di Salomè per il re Erode10.
Contro ogni burocratizzazione e ogni perdita di senso si tratta di
far valere un'operosità e una parola aperta ad un mondo vitale,
apertura all'evento e alla sua irriducibilità: decostruzione dei
regimi discorsivi, dei dispositivi incorporati e liberazione
dell'espressività dei corpi.
È vero, però, che non ci si libera nella solitudine, in
un'individualità astratta. Soli non si può che asservirsi ai
meccanismi che ci dominano. Allora, diventa importante
motivare soggettività individuali verso un'organica soggettività
creatrice, formazione non di una felicità solipsistica, ma di una
felicità partecipata. Ricerca di una felicità non trascendente ma
espressione di un lavoro collettivo efficace, pratico: dipendenza
correlativa in cui sviluppare la propria singolarità cercando in
un'operosità condivisa gli strumenti della propria emancipazione
e del proprio riconoscimento. Ciò può avvenire per tramite di
una sperimentazione quotidiana fatta di incontri, di prove, di
contatti che cercano con coraggio di stabilire relazioni
dialogiche, affetti, piuttosto che distanze, gerarchie, imposizioni
efficentiste e totalitarie. Allora, nel rapporto dialogico, la
differenza si fa creativa, e l'invenzione del quotidiano dà forma a
percorsi di vita; un pensiero che non accettando la dicotomia
mondo/uomini, io/altro, riconosce tra loro una solidarietà,
«percepisce la realtà come processo, e la capta in costante
divenire e non come qualcosa di statico. Non si scinde
dall'azione. "Si bagna" costantemente nella temporalità, i cui
rischi non teme»11.
Certo, "l'esperienza del tempo comincia in un gruppo con
l'esplicitazione della sua pluralità. Occorre riconoscersi
differenti, (…) perché la parola vi divenga lo strumento di una
politica (l'elemento linguistico di conflitti, di accordi, di
sorprese, insomma di procedure demo-cratiche)"12, perché un
agire pratico e teorico consenta la creazione di eventi nel tempo,
delineando limiti che producono degli scarti. Questi scarti
("luoghi di alterazioni") permettono di prendere le distanze dai
nostri compiti, rendendo possibile ritornarvi in modo differente.
Bisogna trovare un rigore adeguato a questa bastardaggine:
alternarsi di esposizioni teoriche e racconti, storiografie
interconnessione di osservazioni e investimenti personali,
combinazione di una teoria esplicativa e di un esame dei conflitti
di potere impliciti in un dialogo. "Mangiare, bere, parlare della
storia personale legata ad un lavoro", ad una tecnica, ad una
metodologia. Pratiche trasformatrici che operano dei "tagli" in
grado di articolare tra loro dei sistemi codificati e dei corpi
(luoghi opachi e provvisori di bisogni e piaceri). Rivoluzione
silenziosa prodotta da un'attività brulicante13.
Se l'antropologia ha compreso i limiti di pratiche di campo
incapaci di riconoscere l'Alterità dell'altro e la poieticità della
coevità dell'incontro etnografico, un'analoga svolta andrebbe
emarginati quanto più si sale. […] Il sistema crea studenti
perfettamente abituati al fatto che ciò che imparano dev'essere
loro insegnato, e che nulla di ciò che viene loro insegnato
dev'essere realmente preso sul serio"5 .
Per ostacolare i congegni disciplinari che costituiscono la
struttura portante di uno scenario così preoccupante (in alcuni
aspetti superato da forme più complesse e mobili di gestione del
sapere, forme però che sorgono e si sviluppano a partire dalla
crisi di questo panorama), Illich, nei lavori successivi a
Descolarizzare la società, ha segnalato la necessità di costruire e
affermare, nel proprio lavoro di studenti-docenti-ricercatori,
rapporti di comunanza, modalità di lavoro comune: una politica
dell'amicizia come pratica, come modo di concepire i rapporti e
di stare dentro le cose, forme di produttività e di convivialità che
si oppongono alla pervasività dei dispositivi di potere.
Su questa medesima linea d'azione, Michel De Certeau,
nell'articolo qui presentato, sottolinea l'importanza di inventare
nuove politiche della parola, nuove forme conviviali capaci di
restaurare la relazione tra il lavoro teorico e la sua "esteriorità",
politiche in grado di fare l'esperienza di una rete locale dove
inscrivere lo studio, la conoscenza e la sua trasmissione, in grado
di innestare la radicalità della ricerca ad una com-partecipazione
effettiva ai problemi che emergono da un territorio. Ciò
configura la possibilità di creare legami più stretti "tra unità
universitarie e nuclei sociali fortemente impiantati […]. Non per
una confusione di generi, che è sempre nefasta, ma in vista di
connessioni nel mantenimento delle differenze"6.
La ricerca sociale per sua natura si svolge nel tempo, in una
processualità che implica la cura dell'altro, della sua Alterità e
della sua esistenza. Cura dell'altro che significa, allora, anche
cura della propria Alterità, della propria esistenza.
Se ora torniamo ad esaminare le argomentazioni di Illich e le
fonti della sua ispirazione, piegando al campo dell'istruzione, con
una parafrasi forse irriverente, i ragionamenti di Foucault sulla
sessualità, possiamo individuare nella società moderna e
contemporanea, un crescente incitamento ad un desiderio di
istruzione gratuito e formale, un imperativo che crea
quell'elemento immaginario che è il "sapere" - la finzione dei
dotti come "significante unico e significato universale"7 - con
l'ironia di un dispositivo che «ci fa credere che ne va della nostra
"liberazione"»8. In questa prospettiva, tutte le tecniche di
sviamento, di micro-sovversione, sperimentate dai giovani nella
scuola e nell'università, possono essere osservate con uno
sguardo differente, strumenti e "furberie" di gruppi che non
avendo un luogo proprio, devono districarsi in una rete di forze e
di rappresentazioni stabilite: ripiegamenti disincantati per lo più
fallimentari, ma anche tentativi ostinati che cercano gli inneschi,
le circostanze imponderabili, i punti di non ritorno, dove il
possibile torni a fluire.
Il bersaglio polemico qui non può essere certo l'istruzione, la
scuola, la conoscenza, ma il dispositivo ed il desiderio
(artificiale) dell'istruzione e del sapere: bisogna liberarsi
dall'istanza dell'istruzione se si vuole far valere contro gli appigli
del potere - con un rovesciamento tattico dei meccanismi
63
compiuta nel costruire relazioni dialogiche tra chi è impegnato a
trasmettere il sapere di una disciplina e chi è interessato ad
appropriarsi criticamente dei suoi strumenti conoscitivi.
Relazioni che permettano di cogliere le rispettive distanze, le
differenze anche istituzionali dei rispettivi ruoli, ma soprattutto
le differenti motivazioni che orientano le ricerche proposte dai
docenti e quelle a cui aspirano gli studenti, rendendo il loro
sguardo capace di incrociarsi e trasformarsi con quello dell'altro.
Potrebbero emergere allora domande che i "ricercatori patentati"
non percepiscono più, domande ancorate ai luoghi concreti in cui
si spendono vite concrete e alle responsabilità che l'appartenenza
ad un territorio sociale impone.
Come dichiarò Alain Touraine nel 1968 durante il movimento di
Nanterre: "Quanto più l'università sarà moderna e scientifica
tanto più sarà impegnata, politica e ideologica. […] Ma se la
politica dovesse uscire dall'università, allora ne uscirei anch'io".
Si tratta di impegnarsi nel riscattare l'istituzione pagando il
rischio della sua libertà, del salto nel buio che si deve compiere
nel perenne sforzo di emanciparsi da ogni vincolo e da ogni
sovrastruttura irrigidita.
Camminando per i corridoi della Bicocca, come nelle hall di un
aeroporto, mi accorgo come lo spazio che mi circonda assuma le
figure inquietanti di un nonluogo, un campo caratterizzato da una
non appartenenza politica, in cui ogni possibilità di
risignificazione dello spazio è sospesa e congelata. Gli studenti
vanno e vengono, stazionano brevemente nei crocicchi dove
ancora è possibile fissare un appuntamento. Scendono nella
mensa dove una folla di corpi costretti in spazi esigui è nutrita e
sfamata. Visione forse apocalittica e ideologica, la cui stranezza
segnala, tuttavia, l'incapacità di sorprenderci di ciò che è
incorporato alle nostre pratiche quotidiane.
Aggiungiamo, per concludere con le parole ibride di Augè e de
Certeau, che un nonluogo "non esiste mai sotto una forma pura;
dei luoghi vi si ricompongono; delle relazioni vi si
ricostituiscono; «le astuzie millenarie» dell'«invenzione del
quotidiano» e delle «arti del fare», di cui Michel de Certeau ha
proposto analisi così sottili, vi possono aprire un cammino e
dispiegarvi le loro strategie"14.
Note
*
1
Università degli Studi di Milan-Bicocca
René Char, Fogli d'Ipnos, Einaudi, Torino, 1968 [1948], 145, p. 80.
2
F. Basaglia, "Potere ed istituzionalizzazione", in Scritti I, 1953-1968, Einaudi,
1981 [1965], pp. 292-293.
3
Ibidem, p. 292.
4
"Il mito dell'istruzione", in D. Cayley, Conversazioni con Ivan Illich, Elèuthera,
2003 [1988].
5
Ibidem.
6
M. de Certeau, Che cos'è un seminario?, in questo numero di Achab.
7
8
M. Foucault, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano, 2001 [1976], p. 137.
Ibidem, p. 142.
9
Ibidem, p. 140.
M. G. Tundo, "Il corpo impuro della luna", in AAVV, Il Corpo narrato. Annali
della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bari, Terza serie, 1985, VII, 2,
10
Fasano, Schena editore, pp. 153-161.
P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Mondadori, 1971 [1970], p. 111.
11
12
de Certeau, op. cit.
Ibidem.
14
M. Augé, Nonluoghi [titolo originale Non-lieux], Elèuthera, 1993 [1992], p. 74;
cfr. M. de Certeau, L'invenzione del quotidiano. I Arti del fare, Edizioni Lavoro,
13
Roma, 2001 [1990].
Costruire insieme la conoscenza per formarsi
di Clotilde Pontecorvo*
La definizione di De Certeau di un seminario come "un
laboratorio comune che permette a ciascuno dei partecipanti
d'articolare le proprie pratiche e conoscenze. È come se ciascuno
vi apportasse il "dizionario" dei suoi materiali, delle sue
esperienze, delle sue idee e che, per l'effetto di scambi
necessariamente parziali e d'ipotesi teoriche necessariamente
provvisorie, gli diventasse possibile produrre delle frasi con
questo ricco vocabolario, cioè di "ricamare" o di organizzare in
discorsi le sue informazioni, le sue questioni, i suoi progetti ".
Questa presentazione definisce una proposta che sembra quasi
scandalosa nell'Università italiana di oggi, dove almeno nelle
Facoltà umanistiche che vengono prescelte dagli studenti come
quella in cui io insegno (Psicologia2 di Roma1, laurea in
psicologia dello sviluppo e dell'educazione, sia triennale sia
specialistica) i numeri dei frequentanti sono sempre intorno alle
100-150 persone, e gli iscritti (quindi gli esami , senza contare i
fuori corso) sono intorno a 300 unità per corso di laurea. Sembra
scandalosa perché non sembra possibile, nemmeno dal punto di
vista spaziale per non dire temporale, poter organizzare qualcosa
che assomigli, seppur lontanamente, a un seminario quale quello
prospettato da De Certeau.
Prescindo per ora dall'organizzazione didattica attuale e faccio
riferimento a un'esperienza didattica positiva di qualche anno fa
quando, conducendo con pochissimi finanziamenti di Ateneo una
ricerca osservativa su un gran numero di cene di famiglie italiane
che si poneva addirittura uno scopo comparativo con un'analoga
ricerca condotta dall'illustre antropologa Elinor Ochs (2006) a
Los Angeles con ben altre risorse. Sottolineo questo aspetto
perché forse questi vincoli pratici stringenti mi hanno spinto ad
allargare a un gruppo di laureandi il parterre dei ricercatori che è
64
stato composto solo successivamente da quattro brillanti
dottorandi e da una postdoc che nel frattempo è riuscita a
divenire ricercatrice.
Si è così definito un gruppo di ricerca e di apprendimento dove
tutti avevano molto da imparare, compresa me stessa, che pur
essendo la docente ufficiale, non avevo avuto fino ad allora
nessuna esperienza diretta dell'approccio e della metodologia
conversazionale. Forse questo è stato un punto di forza del
gruppo, in cui tutti dovevamo imparare una grande innovazione,
anche chi come me avrebbe dovuto saperne di più. In realtà
sapevano molto più di me la post-doc che era Alessandra Fasulo
che aveva trascorso un periodo di studio all'UCLA e uno dei
dottorandi che era Laura Sterponi (ora Teacher Associate
all'Università di Berkeley) che, appena prima del suo dottorato
da noi, aveva già effettuato un periodo di studio all'UCLA, con
una borsa di perfezionamento post-lauream, ed ha poi continuato
a lavorare lì. Il gruppo era composto in forma stabile da me e da
Fasulo, che è diventata ricercatrice nel corso della ricerca, e in
modo fluttuante da coloro che si sono laureati fra i primi su temi
connessi alla ricerca generale: Silvia Amendola, Francesca
Riccio, Deny Menghini, Dafne Arbib, Ilana Raccah, Laura
Antonelli, Sabine Pirchio, Francesco Arcidiacono, Vivian
Liberati, Barbara Maroni, Marilena Fatigante (gli/le ultimi/e
cinque successivamente come dottorandi). La peculiarità di
quello che non oso chiamare "seminario", ma che era senz'altro
un gruppo di ricerca, di studio e di formazione è stata la presenza
di tante relazioni didattiche a vari livelli. Senza entrare troppo nei
particolari, una utile peculiarità è stata che, spesso, i nuovi
laureandi sono stati introdotti alla metodologia della ricerca da
uno dei più vecchi laureati, dopo neodottorandi, che ha appreso
i criteri e le regola della trascrizione attraverso specifici corsi ad
hoc tenuti dai primi laureati: questo ha positivamente
moltiplicato i rappporti didattici, rendendoli più accessibili e
ridimensionando la percezione dell'autorità, a volte eccessiva,
del professore, che può ostacolare l'attività di pensiero di tutti.
Non voglio fare l'elogio della mia ignoranza, ma la gestione è
stata effettivamente democratica, perché sul nuovo aspetto che
veniva studiato dalla singola laureanda, era lei e talvolta il suo
tutor paritetico che ne sapevano di più e tutto il gruppo si sentiva
di poter intervenire liberamente, quando si analizzavano insieme
sequenze interattive, significative a illustrare aspetti rilevanti
delle categorie proposte. E forse questa è stata la parte più
formativa del lavoro del gupppo di ricerca, anche se non va
trascurato il lavoro formativo dell'educatore-pari più competente.
Considero questa la parte più positiva del mio lavoro formativo
di questi ultimi anni.. Perché è difficile da farsi ora? E' quasi
impossibile immaginarlo con dei numeri che si contano a
centinaia. Richiede che su di un'area di ricerca converga un certo
numero di laureandi, direi non superiore a sei-otto unità, in una
unità di tempo di almeno nove mesi. E che ci sia un numero
adeguato di figure intermedie: dottorandi o post-doc, anche se
non ci sono più borse o retribuzioni per nessuno. E' chiaro che il
gruppo può essere tenuto insieme se c'è un comune forte
interesse di ricerca. Sto tentando di riattivarlo con una nuova
ricerca sulla vita quotidiana di famiglie romane, che dovrebbe
avere una nuova fase di analisi e di confronto nel prossimo anno,
con laureandi quinquennalisti.
Non mi è ancora mai riuscito di farlo con gli studenti triennali,
forse perché, pur avendo impostato delle raccolte sistematiche di
dati su due argomenti, che si collegano al mio corso del 3° anno
di Psicologia dell'alfabetizzazione (lettura interattiva di libri da
parte di bambini tra la scuola dell'infanzia e la prima elementare;
attività di scrittura agli inizi della scolarità), non ho ora un mio
specifico progetto di ricerca sulla emergent literacy.
Questa è forse una condizione necessaria affinché si produca un
lavoro seminariale reale e paritetico. A me pare che sia
indispensabile che tutti abbiano una reale motivazione
conoscitiva rispetto all'argomento di studio, come si è creata in
un piccolo gruppo di ricerca in corso sulle cene in famiglie con
bambini che hanno difficoltà di comunicazione, condotto con la
dottoressa Hufty del Centro Synapsi, con due post-doc, tre
laureande e alcune famiglie romane, molto aperte e disponbili.
Per riassumere, mentre mi pare quasi impossibile mettere
insieme più docenti in un seminario, laddove è più realizzabile
un gruppo con partecipanti a diversi livelli di formazione e tenuti
insieme da un forte interesse di sapere e di capire un oggetto di
ricerca reale: solo questo garantisce una buona esperienza di
formazione simmetrica. E' questo che ci chiede l'istituzione? No,
ci chiede per lo più di fare due o tre corsi di 35-40 ore ciascuno:
si migliora la cosa se facciamo un corso di 60-70 ore, come si
prospetta ora per diminuire la frammentazione e per far fare
meno esami agli studenti? Io non lo credo affatto. Mi pare che
bisogna avere il coraggio di diminuire la quantità di ore di
lezione frontale e di aumentare invece l'attività seminariale e di
approfondimento dei docenti e degli studenti insieme. Se siamo
convinti che si apprende solo quando si è implicati in modo
diretto, personale e attivo, i docenti si devono porre
essenzialmente come guida per l'altrui attività; dobbiamo pensare
di introdurre dei grandi cambiamenti nella didattica universitaria,
anche in termini generali. Le presentazioni di un corso ordinario,
fatte dai docenti, si dovrebbero ridurre drasticamente in numero.
E soprattutto dovrebbero dare agli studenti gli strumenti e il
tempo necessario per capire di che si tratta con la loro testa, con
i loro interessi e mezzi di comprensione e di coinvolgimento.
Certo, il contrario di quello che mi è stato chiesto l'anno scorso:
di fare due corsi di 32 ore, ciascuno in quattro settimane. Un
carico costretto ed eccessivo per me, senza alcuna possibilità di
sedimentazione culturale per gli studenti, che non hanno
nemmeno avuto il tempo o la voglia di consultare un testo o
intervistare un bambino. In questo senso non serve nemmeno
molto lo svolgimento di esercitazioni pratiche durante il corso,
che io faccio quasi ad ogni lezione. Resta sempre una modalità
teleguidata e non autonoma, come invece dovrebbe essere ogni
vero apprendimento. Ma è un
altro discorso da sviluppare in un'altra sede.
*
65
Università di Roma1 "la Sapienza"
Transiti e Contraddizioni
Riprendere il seminario di Michel de Certeau perché l'università non si metta in sosta
di Chiara Rabbiosi*
Un paio di anni fa mi è capitato di frequentare alcune lezioni
presso l'UF di Antropologie, Etnologie et Science des Religions
dell'università di Paris 7, il dipartimento nato da quello in cui
aveva insegnato De Certeau, e nel quale gli eredi viventi di una
certa epoca (il '68) e di certi maestri (nonostante i tentativi di
non esserlo) cercano di portare avanti quel certo modo di
insegnare (…e di pensare). Allora, frequentando l'università
come studentessa, non sapevo che quello fosse il luogo dove
Michel de Certeau aveva discusso e pensato con altri studenti
come me. Eppure del fatto che quel dipartimento fosse sui
generis, io e i miei altri colleghi-studenti ce ne eravamo accorti
subito. In modo particolare, venendo dall'università italiana, il
fatto di trovarmi in un aula in cui regnava una confusione di
modi e di modalità di essere studenti - una confusione di età, di
provenienze disciplinari e di percorsi di vita e di insegnamento
fatta di molta presenza di parola e quasi totale assenza di
manuali e citazioni, di continuità tra insegnante e studente -,
l'effetto dell'impatto con questo ambiente è stato a dir poco
bouleversant.
Ammetto, talvolta persino fastidioso: trovarsi all'improvviso
senza i confini e senza le etichette alle quali ero stata
socializzata ad essere studente è stata una fortissima e
inaspettata esperienza di straniamento. Le lezioni a Paris 7 per
me sono state una vera e propria esperienza di "campo", sebbene
estremamente vicine se misurate in chilometri di distanza da
casa.
I ricordi di questa esperienza e la lettura del saggio di Michel Di
Certeau riproposto mi hanno portato oggi, nel mentre in cui mi
trovo in un altro stadio di un personale percorso accademico, a
riflettere non solo su cosa sia un seminario, ma sul suo
(potenziale) ruolo all'interno dell'università considerando
quest'ultima come un'arena politica e come un'istituzione che
con una certa ipocrisia guarda, parla e cerca "cose" nel "mondo",
escludendo da questa vista sé stessa.
Il seminario, nelle parole di De Certeau, può essere pensato e
possibilmente agito come "un luogo di transito". Questo breve
intervento vorrebbe sottolineare l'importanza di questo aspetto e
della presenza di luoghi specificatamente preposti ai dibattiti
altrimenti transitori e contradditori. Allo stesso tempo, il
seminario, così come pensato da De Certeau, è strumento e
veicolo affinché si realizzino tutta una serie di transiti che
necessitano anche di uno spazio ufficializzato al fine di
esorcizzare il continuo rischio di baronato presente all'interno
delle università, la mancanza di dialogo tra le discipline
accademiche e la sterilità nella creatività. Rischi che
lederebbero sia il ruolo di insegnamento sia quello di ricerca che
l'istituzione università e i suoi componenti ricoprono.
Transiti tra didattica e ricerca - dal punto di vista degli studenti,
dei ricercatori e dei professori; tra gli aspetti da una parte
gerarchici e élitisti dell'università come istituzione e dall'altra
quelli legati alla sua dimensione pubblica e libertaria; tra
concetti vicini e lontani dall'esperienza (riprendendo, magari
impropriamente, la celebre espressione di Geertz), che
coinvolgono non solo il transito tra mondi indagati e lavori
prodotti, ma anche tra la dimensione privata e informale e quella
pubblica e "scientifica" dei ricercatori; tra regioni disciplinari,
perché come l'uomo non può esistere senza entrare in contatto
con i suoi simili e con questi reciprocamente contaminarsi,
nemmeno le discipline accademiche potrebbero esistere o
sopravvivere barricate all'interno dei propri specifici paradigmi.
Seminari come transito "tra dentro e fuori"
Che l'università possa esistere al di fuori di una ortodossia o di
una ideologia che la caratterizzi è difficilmente immaginabile.
Né si è mai verificato, sia che l'ortodossia o l'ideologia al cuore
dell'istituzione/idea università vivesse fiancheggiando la cornice
definitoria di un certo quando e di un certo dove, sia nei casi in
cui fosse invece in contrasto con l'ideologia dominante.
Essendo anch'essa un prodotto storico e culturale, l'università
tanto quanto idea quanto come istituzione - due facce della
stessa medaglia - ha assunto nel tempo e nello spazio forme e
modi diversi. In quanto istituzione agisce, subisce e riproduce
inevitabilmente "regole" (e "discorso") a sé propri: etichette,
linguaggi, modalità e gerarchie a sé specifiche. Allo stesso
tempo, come idea - che peraltro affonda la sua specificità
proprio nelle sue stesse origini - ha (dovrebbe avere) un
carattere fortemente pubblico, libertario e critico.
Tutti gli attori che gravitano tra le ribalte e i retroscena di questo
"mondo" - un mondo fatto di biblioteche, aule e uffici abitati da
studiosi/insegnanti chiamati professori raggruppati nelle varie
facoltà, studenti che lavorano a vario livello per raggiungere
diplomi, personale tecnico, amministrativo e di servizio che
permettono il funzionamento della struttura - dovrebbero a mio
avviso avere un certo "dovere morale" consistente nel porsi
sempre in modo tale da tenere il più lontano possibile la
possibilità che l'università-come-istituzione si trasformi in
università-come-istituzione-totale.
Il seminario così come impostato da De Certeau è (potrebbe
essere) strumento attraverso il quale orientarsi in questa
battaglia, luogo in cui si realizza la mediazione tra la rigidità
dell'istituzione e la fluidità dell'idea.
Il seminario di De Certeau non ha paura della critica, nemmeno
quando è rivolta al mondo e al sapere accademico stesso.
Invece, nella attualità della vita quotidiana accademica questa
critica sembra possibile soltanto negli interstizi siano questi
66
materiali o immateriali: nelle parole delle chiacchiere sfuggenti
nei corridoi e fuori dalle aule, oppure chiuse a chiave negli uffici
privati dei dipartimenti. E' come se questo tipo di critica
autoriflessiva, a differenza di altra, fosse rischiosa da registrare
e recepire,pertanto sempre forzatamente transitoria.
Se nell'interpretazione di Luce Giard il seminario di De Certeau
si concretizzava come un luogo aperto, multiplo e
contraddittorio, affascinante è la possibilità di utilizzare la
contraddizione in chiave positiva, come strumento per fare
critica. D'altronde la contraddizione è per forza di cose insita in
qualsiasi disciplina o scienza che metta al centro della sua
ricerca l'uomo, poiché l'uomo è - tutto sommato - un animale
molto lontano dall'essere razionale. Forse Michel Leiris
esagerava quando teorizzava che "c'est par la subjectivité
(portée à son paroxisme) qu'on touche à l'objectivité" (1981, p.
263) ma certo una certa dose di esplicitazione della soggettività
e della propria posizione nell'università-come-istituzione è
tutt'al più recepita come ostacolo a una presunta scientificità,
della quale si riconosce l'inesistenza ma alla quale comunque si
aspira.
Ancora di più, parlare delle mille contraddizioni all'interno delle
singole discipline, delle lotte intestine all'interno di uno stesso
dipartimento, dell'aridità degli steccati disciplinari nonché del
fatto che inevitabilmente rapporti di potere regolino il
funzionamento di questo specifico mondo (così proprio come
quello "reale"), non ha posto in alcuno spazio ufficiale, come se
questi argomenti non fossero paragonabili che a mere
"chiacchiere da bar" prive di importanza. Eppure gli etnografi
non riconoscono che queste chiacchiere sono altrettanto dense
di informazione?
Il seminario di De Certeau è per sua stessa ammissione il luogo
delle chiacchiere, un caquetoir, proprio per questo motivo.
Altra continua necessità di mediazione "tra dentro e dentro" il
mondo universitario, è quella che riguarda insegnamento e
ricerca. L'insegnamento - trasmissione e produzione di
conoscenza - è la funzione più antica e decisiva dell'università
ma il ruolo e il contenuto nonché le modalità con cui, e
attraverso cui, questa funzione prende forma subiscono
mutamenti. Il seminario è una modalità (tra altre e altrettanto
importanti) in cui si esercita l'insegnamento: attraverso
l'esplicitazione, la discussione e la messa in questione dei saperi
di chi vi partecipa. E, certamente, grazie alla guida, per quanto
attiva e partecipata, di un insegnante. La con-partecipazione dei
saperi inevitabilmente produce anche nuove affiliazioni del
sapere stesso e pertanto diventa ricerca.
Tuttavia non è possibile che questa disciplina sia considerata
come la sola a dover esercitare questo tipo di conoscenza, né che
sola si arroghi il potere di farlo (come le altre discipline non
esisterebbero senza lo spirito di cui è quella più permeata,
nemmeno questa esisterebbe senza il contributo delle altre) . Se
si può facilmente riconoscere il bisogno di limiti e di confini,
tanto per ragioni identitarie quanto per ragioni burocratiche
(perché anche le discipline accademiche si inseriscono
nell'arena politica che è l'università, fatta di giochi di potere al
fine di allocarsi "risorse" di vario genere, in primo luogo
economiche), non credo che la rivendicazione degli stessi sia
fertile ai fini della ricerca. Rivendicare la propria collocazione,
la propria identità e le proprie radici accademiche si avvicina di
molto alle stesse rivendicazioni mosse dai movimenti politici
autonomisti, oggetto di ottima critica antropologica e
sociologica.
Mi sembra che si tratti di un'altra contraddizione-tabù che
rischia di costituire un limite alla capacità creativa e allo spirito
critico così importanti per le discipline umanistiche e sociali in
senso lato. Ma qui mi fermo perché come de Certeau ci insegna
"la critica ideologica non è sufficiente". Il buon senso dovrebbe
riuscire ad avere la meglio sull'ideologia.
Transito tra alto e basso
Il seminario è anche luogo di transito tra alto e basso: per De
Certeau il sapere arriva per forza di cose dal basso, nel senso che
è figlio dell'umanità tutta. In questo si pone in conflitto con un
certo élitismo accademico che sebbene negli ultimi anni sia
andato a smussare i propri confini sociali e culturali, corre
sempre il rischio di rifugiarsi in sé stesso. Così è qui più che in
ogni altro spazio sociale che è richiesta la necessità di sforzarsi
nel non cedere davanti a facili corporativismi, che rischiano di
alienare le comunità accademiche dal resto della società globale
della
quale
sono
anch'esse
parte.
Perdendosi
nell'autoreferenzialità i discorsi prodotti sarebbero allora sì
paragonabili alle chiacchiere da bar, nel senso più negativo che
a queste si può attribuire: quelle chiacchiere basate sugli
stereotipi e sui luoghi comuni, sul fare del proprio l'unico e
universalmente valido mondo possibile.
Il seminario di De Certeau rappresenta la possibilità di mediare
tra le contraddizioni che coinvolgono il mondo accademico,
esplicitando l'esistenza delle contraddizioni stesse. Rileggere
questo saggio oggi è anche ribadire questioni banali perché che
la critica e la comunicazione possano essere fertili alla ricerca e
allo sviluppo tanto di un'idea quanto di una istituzione, quale
quella universitaria può essere intesa, è banale. Eppure
continuamente attuale e utile.
Così è buffo (e insieme amaro) notare la contraddizione più
evidente: che a rileggere oggi questo saggio, figlio di una certa
epoca, le critiche, la voglia di cambiamento, la necessità di
maggiore comunicazione che esso emana, sono da girare a
coloro che un tempo sono stati studenti e che oggi sono parte del
mondo accademico sotto altre vesti, probabilmente più
Transito tra dentro e fuori
Il sapere che sta alla base di qualsiasi "fare università",
soprattutto quando questo fare è agito da discipline che per
ragion d'essere mettono al centro l'anthropos ("oggetto comune
di domande convergenti" (Fischler, 1992, p.12), per definizione
deve muovere da uno spirito antropologico che condivide con la
disciplina che definisce sé stessa Antropologia in senso stretto.
67
prestigiose: non sono proprio loro la generazione che più di ogni
altri aveva in quella contingenza reclamato la necessità del
rinnovamento e dell'autocritica anche all'interno del mondo
accademico proprio scagliandosi verso quelle stesse figure che
oggi loro hanno sostituito?
*
Riferimenti bibliografici
Fischler, C., 1992, L'onnivoro. Il piacere di mangiare nella storia e nella
scienza, Milano, Arnoldo Mondatori Editore.
Leiris M., 1981, L'Afrique fantôme, Paris, Gallimard.
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Totò, il Jazz e la Scienza: Un Metalogo
di Francesco Ronzon*
Palomar, antropologo) Hai visto quella parte del film "I soliti
Ignoti" in cui Totò incontra gli altri membri della banda per
elaborare i dettagli del colpo ?
Cetina).
Thelonius, musicista jazz.) …Perché mi fai questa domanda?
P.) Si tratta di una vecchia questione che ha origine col dibattito
aperto da Karl Popper sulla logica delle scoperte scientifiche.
Rispetto alla visione astratta e normativa proposta da Popper,
questi studiosi sostengono che l'operare del mondo scientifico
vada analizzato in modo etnografico alla stessa stregua della vita
quotidiana di un qualsiasi gruppo sociale: usi, valori, mitologie,
comunità di pratiche, criteri di interazione tra uomini e con gli
strumenti. Più che elaborare un'immagine ideale della scienza
costoro cercano di rendere visibile ciò che accade effettivamente
quando ci si riunisce in un gruppo di ricerca. E questo a partire
dall'ipotesi che le procedure della ricerca non sono
fondamentalmente distinte dalle procedure o dalle "maniere di
fare" comuni. Si tratta di indagare il mondo degli intellettuali e
dei ricercatori come se si trattasse di una tribù. O, se preferisci,
come se si avesse a che fare con un gruppo di artisti, di burocrati
o di contadini ad alto livello di specializzazione tecnologica.
T.) Ovvero…
P.) Così… stavo leggendo un saggio di Michel de Certeau sul
tema del Seminario e mi è venuto in mente l'intricato e grottesco
dialogo creato dai vari personaggi: il boxeur, l'immigrato
siciliano, il bullo di periferia, il fotografo fallito…
T.) E' un bel saggio. Gli ho dato un occhiata di recente tra un
esercizio di solfeggio e l'altro. E' scritto con un linguaggio molto
"artistico". Parla di come l'Università non dovrebbe essere un
luogo di verità assolute ma un'occasione di indagine e
formazione intellettuale. Di quanto sia importante dare voce a
più posizioni teoriche e a differenti esperienze personali. E della
necessità di uscire dalle "torri d'avorio" ponendosi interrogativi
rilevanti per la società nel suo insieme. Mi sembra tutto molto
condivisibile. Ma dov'é il problema ?
P.) Non puoi capire, per voi jazzisti è tutto più facile.
Improvvisate! Basta lasciarsi andare all'estro del momento ed il
gioco è fatto… Per noi ricercatori è diverso.
T.) Stop! Fermati!! Non sono abituato a tutte queste parole.
Fammi degli esempi pratici. Io ti illustro alcuni stili che hanno
fatto la storia del jazz e tu mi dici a cosa dovrebbero
assomigliare...
T.) Ti sbagli. Sei prevenuto. Guarda che per improvvisare
bisogna aver studiato un bel po'. Molto più di quello che serve
per suonare leggendo uno spartito. E' necessario aver introiettato
un certo insieme di modelli musicali di riferimento. Bisogna che
padroneggi il tuo strumento al punto da poter eseguire delle frasi
inventate in tempo reale. Inoltre, devi essere sempre attento e
sensibile a ciò che inventano gli altri musicisti perché quasi
niente è deciso in anticipo. Insomma, ti dirò, il jazz è una musica
imbevuta sino al midollo di ricerca e sperimentazione.
P.) O.K. Mi sembra un approccio un po'eterodosso ma va' avanti
…Ti ascolto.
T.) Vediamo… Il primo esempio potrebbe essere lo swing degli
anni '20 (ad es. Glenn Miller). Qui le esecuzioni erano orientate
in modo rigoroso dallo spartito con solo piccoli spazi lasciati
all'improvvisazione (molto fedele, peraltro, alla melodia base).
P.) Bhè, questo mi fa venire in mente la ricerca standard. Quella
che applica in modo sistematico dei modelli già strutturati a
delle situazioni simili. E' un po'quello che è avvenuto con il
marxismo, lo strutturalismo e il funzionalismo. Quando erano le
"idee forti" del momento tutte le realtà sociali studiate erano
P.) Effettivamente da come me ne parli, il jazz sembra molto
simile al mondo della ricerca. Anzi, mi fai venire in mente
proprio quanto dicono da anni i cosiddetti etnografi della
scienza nei loro laboratory studies (ad es. K. Lynch, K. Knorr-
68
interpretate in rigida osservanza a queste ortodossie
accademiche.
conto del ruolo centrale svolto dall'interattività pratica nella
didattica. Hai presente tutti quegli stage, master e laboratori ?
T.) …Poi negli anni '40 arriva il be-bop (ad es. Charlie Parker).
Il riferimento alla tonalità è ancora forte ma l'attenzione si
sposta dalle note base degli accordi (I, IV, V) alle loro estensioni
superiori (none, quarte, quinte diminuite, e così via).
T.) Ma allora di cosa ti lagni.… Pensa invece che noi musicisti
siamo ancora costretti a sorbirci lagne come Michael Bublè.
Quello non è un jazzista. E' un buon cantante da piano-bar.
Diavolo!! Non è l'uso di una blue note o di un intervallo di
tritono a fare il jazz. E' il modo con cui articoli l'insieme della
tua pratica musicale. E questo non è un problema che riguarda
tanto la mera scelta formale delle note quanto l'intenzionalità in
base alle quali orienti le tue interazioni con gli altri musicisti e
con il tuo strumento. Lo scopo del gioco jazzistico è usare
l'improvvisazione per indagare il campo delle possibilità
musicali. Inoltre, quando Billy Holyday cantava Strange Fruit,
John Coltrane suonava Alabama o Max Roach incideva
Freedom Now Suite, la loro musica non si limitava a creare un
mero sottofondo ma parlava delle lotte per i diritti civili di
quegli anni. Il jazz ha sempre avuto caratteristiche affini a quelle
della vita ordinaria, non è mai stato estraneo né esterno a chi vi
prendeva parte.
P.) Buffo. Sembra lo stato dell'antropologia inglese degli anni
'40 e '50. I temi e le prospettive di indagine erano state fissate
negli anni precedenti ma gli studiosi si adoperavano a
scandagliarne gli aspetti meno battuti. Ad esempio, il tema
dell'ordine sociale restava centrale ma veniva indagato a partire
dalle situazioni di disordine. E' tutto qui?
T.) No…Nei tardi anni '50 entra in gioco anche il modale (ad es.
il Miles Davis di A Kind of Blue). In questo stile il riferimento
non è più il giro armonico ma il tipo di scala prescelto (modo
frigio, misolidio e così via). Abbattendo larga parte dei vincoli
armonici vi è più spazio per le esplorazioni ritmiche e
melodiche.
P.) Non ti illudere. Non è tutto oro quello che luccica. In teoria
l'idea di un'Università composta di laboratori legati alla vita
reale non era affatto male. Ma una volta messa in pratica anche
da noi il progetto ha subito mostrato la corda. A tutt'oggi la
direzione intrapresa sembra più quella dei manuali di know-how
che non quella di un'educazione della propria abilità (skill) ad
operare in modo innovativo e sperimentale. E così facendo si
vanifica proprio quel senso di gioco, creatività e impegno
sociale di cui parla il saggio di de Certeau.
P.) Questo caso è un po' più complicato. Si potrebbe paragonarlo
ad una situazione di ricerca in cui sono fissate solo le aree più
generali ma senza che siano prescritti gli aspetti più specifici.
Un po' come dire che si deve per forza lavorare su certe aree
tematiche (antropologia medica, antropologia economica) o
geografiche (Africa, Meso-America) ma senza che vi sia un
criterio troppo rigido nella scelta dei paradigmi interpretativi di
riferimento (modelli generativi, approcci ermeneutici, analisi
delle narrazioni…).
T.) Vedi che mi dai ragione. Io te l'avevo detto sin dall'inizio.
Anche nel caso dell'improvvisazione non si nasce già
"imparati". Per quanto voi intellettuali continuiate a crederlo, la
capacità di operare in maniera creativa non è affatto frutto del
solo "genio individuale". E'anche e soprattutto frutto un'abilità
che si educa e si sviluppa nella pratica. Sudando. Sbuffando.
Provando. Rischiando. Inoltre, come sempre, ci vuole anche
qualcuno che dia il buon esempio. Per fortuna che nel jazz gli
esempi sono innumerevoli. In un intervista rilasciata pochi mesi
prima della morte, l'alto-sassofonista Steve Lacy raccontava un
aneddoto sul celebre pianista mio omonimo, Thelonious Monk.
Diceva che se un suo musicista suonava in maniera troppo
perfetta, lui si metteva al pianoforte e incasinava tutto, per
vedere che sarebbe successo. In egual modo anche Miles Davis,
il noto trombettista, nella sua autobiografia dice che a un certo
punto della sua vita ha smesso di suonare tutte quelle ballad
(brani lenti e d'atmosfera) per cui era famoso e ha iniziato a
ibridare la sua musica con il funky (la novità musicale per i
giovani afro-americani degli anni'60) per evitare di chiudersi e
sclerotizzarsi in quel tipo di jazz che egli stesso aveva
contribuito a plasmare. E potrei andare avanti così per ore…
T.) L'ultima grande rivoluzione stilistica è stata infine quella
introdotta dal free jazz (ad es. Ornette Coleman) e
dall'improvvisazione radicale Nord-Europea (ad es. Derek
Bailey). In quest'ambito i modelli ritmico-tonali degli anni
precedenti sono solo un lontano punto di riferimento (tra i tanti)
e l'attenzione si sposta tutta sull'interplay (capacità di reagire in
tempo reale agli stimoli forniti dagli altri musicisti) e sulla grana
e il colore del suono in quanto tale. E' un approccio molto libero
e orizzontale. Non c'è l'usuale separazione tra solista e
accompagnatori, si basa molto sulle individualità coinvolte e
l'organizzazione sonora poggia molto sulla capacità di instaurare
di volta in volta un dialogo paritetico all'interno delle varie
performance. Per questo l'esito finale risulta sempre un po'aspro
da sentire. Ma è molto vitale…
P.) Se la metti così, mi sembra che il tipo di seminario descritto
nel saggio di de Certeau assomigli proprio a quest'ultima
tradizione. Anche lì si parla infatti di inclusione di tutti i
partecipanti, si pone più attenzione al modus operandi che non
all'opus operatum, e si conferisce un forte valore alla varietà e
differenza delle posizioni in gioco. A pensarci bene è curioso.
Anche nell'ambito universitario negli ultimi anni ci si è resi
P.) Magari fosse tutto così facile. Se parli di innovazione nel
69
mondo dell'Università sei costretto a chiamare in causa anche
l'etica, la politica e l'economia della ricerca in Italia. E qui la
questione si fa ben cupa. Soprattutto nel campo delle scienze
umane. I fondi sono praticamente inesistenti. Le istituzioni
pubbliche non fanno ricerca e, se la fanno, la fanno male, di
corsa e la usano come mera decorazione per avvalorare
decisioni politiche già prese. Anche l'avanzamento nella carriera
accademica presuppone pubblicazioni frequenti. Le pretendono
tutti e in tempi brevi: colleghi, commissioni per i concorsi, enti
finanziatori. Ma operare in una dimensione euristica non
implica affatto garantire un buon risultato in tempi rapidi.
Quando si sperimenta si deve accettare l'idea che l'impresa
possa fallire gli obiettivi preposti. La disponibilità al fallimento
non sempre conduce al progresso. E' solo il presupposto del
progresso. Il cuore del problema è che però che si tratta di un
rischio inevitabile e necessario. L'ossessione del successo - e
quindi la scelta di seguire strade sicure e già battute - espone
quasi sempre al rischio della stagnazione.
T.) Mmm… Allora vuol dire che sono tempi difficili per tutti,
vecchio mio!
*
Università di Verona, Accademia di Belle Arti G. B. Cignaroli
Riferimenti Bibliografici
Bateson, G: 1994 Mente e Natura, tr. It. Milano, Adelphi
Berliner, P.1994 Thinking in Jazz. The Infinite Art of Improvisation, Chicago
Studies in Ethnomusicology, Chicago, University of Chicago Press.
Knorr-Cetina, K.
1999 Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge, Cambridge,
Harvard University Press.
Ronzon, F., C. Grasseni
2005 Pratiche e Cognizione. Note di Ecologia della Cultura, Roma, Meltemi.
*****
Tiziano - Salomè con la testa del Battista
Ringraziamenti
La redazione ringrazia Luce Giard per aver consentito la pubblicazione del saggio di Certeau, Luigi Mantuano per aver concesso
l’utilizzo della sua traduzione italiana, ed in modo particolare Paola Di Cori per l’entusiasmo dimostrato nel proporci e promuovere
questa iniziativa, e per l’aiuto fornitoci nel collezionare alcuni dei contributi qui raccolti. Si ringraziano infine tutti gli autori degli
interventi per aver accolto il nostro invito.
70
Altrevoci
Riflessioni da Bomalang’ombe*
di Edoardo Occa
Dopo otto mesi di lavoro nel villaggio di Bomalang'ombe, situato
negli altopiani meridionali della Tanzania, si cominciano a
delineare in modo lucido le problematiche comportate dal gestire
un progetto integrato di cooperazione allo sviluppo. Nel nostro
caso, mia moglie Laura ed io rileviamo come uno degli snodi
maggiormente significativi di questa esperienza professionale ed
umana sia acquisire la capacità di leggere con attenzione e di
conseguenza rielaborare, attraverso griglie interpretative puntuali
il meno possibile autoreferenziali, i feed-back che ci giungono ora
dopo ora dalle persone con cui lavoriamo. Il progetto di cui
facciamo parte, essendo ripartito in diverse attività, le quali
richiedono ognuna un approccio, una sensibilità e competenze
differenti (elettrificazione pubblica e privata, gestione della
fornitura di acqua potabile, microcredito, seminari formativi su
svariate tematiche, management di una piccola fabbrica di
conserve ad altri prodotti, programma di institutional building con
l'amministrazione del villaggio), comporta la necessità,
innanzitutto, di cogliere i tempi necessari alla popolazione per
metabolizzare le innovazioni introdotte nella quotidianità, le
quali, ristrutturando i meccanismi tradizionali di aggregazione,
disarticolano pratiche ed usanze antiche per produrre nuovi
significati, nuovi gesti, nuovi saperi.
Da sottolineare inoltre, come interventi tanto differenti
richiedano, da parte nostra, la capacità di saper plasmare i
contenuti attraverso codici comportamentali molteplici, cosa non
sempre agevole in quanto, parallelamente ad ogni "intuizione" cui
si pensa di essere giunti, ecco presentarsi un nuovo ordine di
problemi col quale confrontarsi. Particolarmente stimolanti sono,
a questo riguardo, le pratiche interpretative di traduzione che la
popolazione locale mette in atto nei confronti di una qualsiasi
proposta che viene loro presentata; la gestione del servizio di
fornitura di acqua potabile, per esempio, essendo uno dei servizi
per il quale vengono spese le maggiori risorse in termini di tempo
e di progettazione, libera una serie di dinamiche decisamente
stimolanti. Mi riferisco alla difficoltà di far passare il messaggio
della assoluta necessità di pagare la pur irrisoria cifra richiesta per
l'utilizzo (illimitato) di acqua potabile, alla totalità della comunità.
Una soluzione, seppur parziale, è stata, al momento, quella di
coinvolgere nella presa in carico di responsabilità collettiva gli
anziani del villaggio, i quali, in quanto autorità morali tuttora
indiscusse (sebbene anche questa istituzione abbia subito - nel
corso dei 25 anni di collettivizzazione delle terre e di delega nella
gestione delle controversie quotidiane imposta dal sistema di
socialismo africano ideato e realizzato da Nyerere - un forte
riassetto di ordine simbolico prima ancora che esecutivo), hanno
accettato di buon grado di prendere parte (e si tratta di una parte
rilevante) nel processo di sensibilizzazione nei confronti della
popolazione la quale, a sua volta, pare, al momento, aver risposto
con discreto entusiasmo all'appello fatto. Questo parziale
successo crediamo dipenda dal meccanismo volto a richiamare la
coesione sociale suscitato dal coinvolgimento di figure le quali,
accettando di lavorare su un livello strategico assolutamente
paritario con l'ente promotore del servizio, hanno fatto si che
almeno in parte si sia ridotto il senso di estraniamento di cui
tutt'ora, seppur dopo 14 anni di presenza continuata sul territorio,
l'organizzazione per la quale lavoriamo, risente. Per chiarire
meglio l'affermazione appena fatta qui sopra, cercando di
delineare i rapporti di potere che si sono instaurati tra noi e gli
anziani del villaggio, bisogna ammettere che in realtà un certo
scarto relazionale immancabilmente si è mantenuto tra gli anziani
e l'organizzazione promotrice, nel senso che la dimensione
prettamente operativa all'interno della quale ci muoviamo
all'interno del villaggio, come NGO che si occupa dei servizi,
viene filtrata dallo sguardo, spesso oggettivante e non
particolarmente dialogico, di queste figure, dinamica che
comporta uno scivolamento di senso tra la rappresentazione
classica, e forse un po'statica, dell'organismo di cooperazione
considerato occupare un ruolo di maggior potere a causa delle
risorse che mette a disposizione, e la restituzione della percezione
del proprio lavoro che viene agita ed esperita dalla controparte.
Un altro fattore destabilizzante, nei confronti della ricerca di una
piena e partecipata sostenibilità, riguarda la formula stessa della
presenza sul territorio da parte nostra, in quanto NGO; circa ogni
due anni, infatti, il personale responsabile in loco cambia, e
questo genera inevitabilmente scompensi nella gerarchia delle
priorità progettuali e nei rapporti interpersonali con la comunità;
sottolineo questo in quanto, sebbene ognuno di noi cerchi di
svolgere il proprio compito con il massimo rigore professionale,
il fattore-umano-comportamentale-adattativo di ciascun
cooperante si declina ogni volta sotto personalissimi schemi di
riferimento, i quali non possono che venir registrati e ricalibrati
ogni volta dalla controparte, all'insegna dei medesimi codici
comunicativi. Questo comporta, secondo noi, l'insorgere di una
sorta di "schizofrenia del progetto di cooperazione", causata della
situazione in cui input differenti vengono forniti e
successivamente squalificati da figure (noi che lavoriamo nel
progetto) che, nella lettura della popolazione, sono spesso invece
assunti come un'unità difficilmente districabile in singole
soggettività.
Questa situazione di apparente "doppio vincolo" rischia a volte di
71
grida, scherzi e risate, miscuglio buffissimo di timore ed
eccitazione verso questo "strano" personaggio che si aggira tra le
loro capanne… 3.
Scusate l'intermezzo che potrebbe sembrare forse un po'
demagogico, ma per dare anche solo una parvenza reale
dell'esperienza che stiamo vivendo mi sembrava doveroso
intercalare su uno degli aspetti personali più gioiosi, vivificanti e
divertenti.
creare un circolo ermeneutico dal quale è difficoltoso uscire, per
dipanare il quale si necessita di notevoli risorse in termini di
tempo ed energie.
Al di là di queste note, devo proprio dire che la gente wahehe1 è
stata, fino ad oggi, generosa nel dispensare stimoli ed emozioni,
dubbi ed incertezze, e nel fungere da strumento di crescita e
cambiamento interiore.
Permettetemi di dire soltanto come sia davvero impagabile, di
ritorno da un ennesima lunghissima kikao2, di ritorno verso casa,
essere rincorso e letteralmente accerchiato da un nugolo di
festanti bimbi, (dai quali cerco, finora senza troppo successo, di
imparare il dialetto kihehe), e di essere accompagnato dalle loro
Bomalang'ombe, Tanzania
ottobre 2005
Note
* La prima relazione da Bomalag'ombe, di Edoardo Occa, è apparsa in "Achab", Numero V, Giugno 2005 [N.d.R].
1
In kiswahili, wa è il prefisso da apporre, al plurale, ai sostantivi appartenenti alla classe di nomi che indicano esseri animati, come
appunto gli uomini e gli animali, mentre hehe non è altro che la traslitterazione del grido di guerra che veniva urlato per impressionare
gli avversari "He! He! He! He!". Anche su questo sarebbe estremamente interessante soffermarsi più a lungo, infatti il nome wahehe
e stato attribuito a questa tribù, appunto, da vari occasionali avversari che in battaglia sentivano scagliarsi contro quel grido.
Comprendere dunque come il processo di costruzione dell'identità di questa tribù, a cominciare dal nome, sia il contributo di un'alterità
- e quale alterita' di maggior rilevanza simbolica dei propri avversari in guerra - è sintomatico della natura intimamente dinamica e
pluridimensionale di qualsivoglia processo antropopoietico.
2
"Riunione". Le procedure formali da seguire in ogni incontro ufficiale sono a volte estenuanti, retaggio forse di una forma di ritualità
specifica, ma sicuramente anche dell'indottrinamento di stampo "maoista africano".
3
Altra nota etimologicamente ricca di spunti: mzungu, vocabolo usato per indicare il bianco, l'europeo, deriva dal verbo kuzunguka,
che si potrebbe tradurre, più o meno propriamente, "gironzolare, andare a spasso, spostarsi continuamente". In Tanzania, a parte le
comunità Maasai, che comunque non vengono riconosciute come tanzaniane in quanto di ceppo nilotico, non esistono comunità
nomadi; l'aver immediatamente associato l'immagine del "bianco" al continuo peregrinare è cosa che meriterebbe venire investigata
ulteriormente.
72
Visitate il nuovo sito di Achab:
www.achabrivista.it
La rivista è interamente scaricabile dal sito
Maurizio Gjivovich, I mille volti dell’indipendenza - Tiblisi (Georgia), Aprile 2005
(sito internet: www.gjivovich.it)
Note per la consegna e la stesura degli articoli.
Gli articoli dvono essere in formato Word o Rich Text Format (.rtf). Si consiglia di usare il carattere times
o times new roman corpo 12.
L'articolo deve avere una lunghezza minima di 3 cartelle e massima di 15 (interlinea 1,5; corpo 12).
Si consiglia di ridurre al minimo le note che non dovranno essere inserite in automatico ma digitate come
testo alla fine dell'articolo. Nel testo il numero della nota deve essere inserito mettendolo tra parentesi.
Gli articoli devono essere spediti al seguente indirizzo: [email protected]. La redazione provvederà a
contattare gli autori.
D’Angelo, L. - Il giorno prima dello sgombero - Fototestimonianze, Milano, 2005