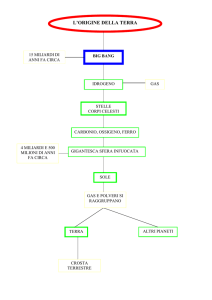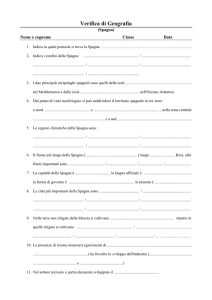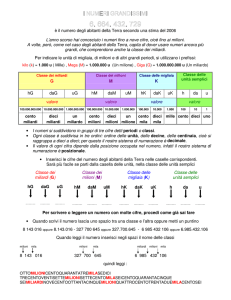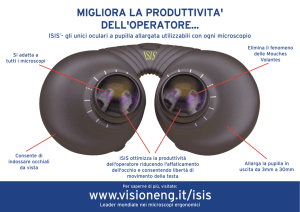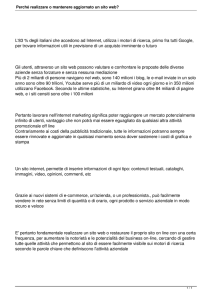PRIMO PIANO
Martedì 26 Maggio 2015
11
Per almeno due anni tutti dicevano fate come Madrid se volete far riprendere l’economia
Fate come la Spagna! Oppure no?
Dopo le elezioni l’esaltazione deve essere ridimensionata
DI
STEFANO CINGOLANI
R
icordate il refrain che ci
ha spaccato i timpani
per almeno due anni?
Fate come la Spagna.
La Spagna sì che ha affrontato
la crisi. La Spagna sì che è una
democrazia: si vota, si vince, si
perde, si decide. E l’austerità? In
Spagna paga: ecco qua il ritorno
alla crescita. E i disoccupati? E
salari e stipendi massacrati?
Quisquilie. E un debito pubblico triplicato? Pinzillacchere. E il
deficit che ancor oggi è il doppio
di quel che prevede Maastricht?
Inezie. E poi è tutto certificato,
tutto consentito, tutto bollinato
dall’Unione europea. Chissà se
oggi, dopo i risultati clamorosi
(anche se non inattesi) alle elezioni locali, qualcuno dei soloni
filo-spagnoli avrà la onestà di
ammettere che forse tutti quei
peana erano quanto meno eccessivi. Ciò vale per gli austeri
di centro-sinistra, ma anche per
il centro-destra che ha portato
ad esempio Madrid perché è andata alle elezioni (e ha vinto la
destra) invece di avventurarsi
in governi tecnocratici. In realtà, nell’un caso e nell’altro, eletti
o no, i governi dei Paesi deboli
sono stati guidati dall’esterno,
dai mercati, da Bruxelles e da
Francoforte, hanno compiuto
sforzi e sacrifici, ma non hanno
risolto i loro problemi economici
e politici.
L’economia innanzitutto.
Le Figaro ha pubblicato un
articolo perfidamente oggettivo
mettendo insieme un po’ di cifre. La Spagna ha attraversato
tre crisi: quella immobiliare nel
2008 che ha innescato la crisi
finanziaria la quale a sua volta
ha provocato la crisi bancaria e
il collasso del 2012. A quel punto, la Ue ha autorizzato, anzi
concordato, un salvataggio delle banche che ha contribuito in
modo determinante all’esplodere del debito pubblico già gonfiato dalla necessità di pagare sussidi e assistenza ai disoccupati.
In Spagna, il mercato del lavoro
è stato liberalizzato e i salari si
sono abbassati molto più che in
altri Paesi (esclusa la Grecia).
Come effetto immediato, ciò ha
provocato una disoccupazione
salita al 27% nel 2013. La svalutazione salariale ha dato slancio
alle esportazioni cresciute dai
12 miliardi di euro del 2009 ai
20 miliardi del primo trimestre
di quest’anno, anche se la bilancia con l’estero rimane negativa: meno 1,84% del pil. Certo,
il saldo è migliorato rispetto al
2009, tuttavia conta molto anche la contrazione dell’import
negli anni di recessione della
domanda interna.
E i parametri di bilancio?
Il disavanzo pubblico resta ancora doppio rispetto al mitico
tetto del 3% al quale è tenacemente inchiodata l’Italia. Ciò
consente di attutire gli effetti
sociali della crisi, anche se non
basta a sedare lo scontento che,
dopo alcuni anni di protesta vociante, ma politicamente sterile,
ha trovato uno sbocco politico.
Ecco l’altro corno del dilemma.
Perché solo gli sciocchi ragionano di politica economica senza
ragionare di politica tout court.
In Grecia abbiamo visto come è
andata: ha vinto un partito che
non è solo radicalmente di sinistra, ma si è rivelato un circolo
di dilettanti allo sbaraglio che
sta portando il Paese (e forse
l’intera Europa) dentro un nuovo gorgo finanziario, economico
e politico. In Spagna, Podemos
e Ciudadanos non sembrano
molto diversi. Lasciamo il beneficio d’inventario al bel Pablo Iglesias e ad Ada Colau
che ha sbancato Barcellona.
Tuttavia, dubbio e scetticismo
s’impongono.
Quale lezione si può trarre? Facciamo parlare i banchieri centrali e andiamo in
Portogallo al Forum di Sintra. I
giornali italiani hanno dato ampio spazio al discorso di Mario
Draghi che, infatti, ha fatto da
spartiacque. Il presidente della Bce ha chiesto che i governi
si diano una mossa, perché la
banca centrale sta esaurendo le
munizioni. In questo ha inter-
pretato lo stato d’animo di tutti i
suoi colleghi. Il governatore della Banca del Giappone Horohiko Kuroda ha tirato gli orecchi
al premier Shintaro Abe perché la cosiddetta Abenomics si
è rivelata più fumo che realtà e
tocca alla banca centrale stampare ancor più moneta.
Ma pochi hanno scritto
che lo stesso Draghi è finito
sotto tiro. Lo ha attaccato apertamente Larry Summers
il quale insieme a Olivier
Blanchard, capo economista
uscente del Fondo monetario,
e al suo braccio destro Eugenio Cerutti, ha presentato un
paper che rivela la crescente
inefficacia degli stimoli delle
banche centrali: «La fede nella
loro abilità di raggiungere il loro
obiettivo è aumentata, mentre
l’abilità di centrare il bersaglio
è diminuita». Ciò vale per i
prezzi perché si è lasciato che
scivolassero verso la deflazione
e ancor più per lo sviluppo, soprattutto in Europa: sei milioni di posti di lavoro sono stati
perduti nell’area euro dal 2008
e difficilmente saranno recuperati come ha ammesso Draghi.
La spiegazione della Bce è che
ciò accade perché il mercato
del lavoro resta troppo rigido e
non sono state fatte le riforme.
Per Summers non è sufficiente:
bisogna aumentare la domanda interna e ciò nell’area euro
spetta alla Germania. È facile
prevedere che a fine settimana, al vertice del G7 a Dresda,
il governo tedesco sarà messo di
nuovo all’indice, anche se il ministro delle Finanze Wolfgang
Schaüble ha già messo le mani
avanti.
Ma la sferzata più bruciante è venuta da Stanley
Fischer, numero due della
Federal Reserve, decano dei
banchieri centrali e professore
di Draghi al Mit negli anni ‘70.
Fischer si è rivolto al suo ex allievo con ironia: «Caro Mario, va
bene parlare di riforme strutturali di tanto in tanto, ma non
puoi farne l’argomento principale ogni volta che intervieni in
pubblico». È vero, il mercato del
lavoro americano è unificato e
ben più flessibile di quello europeo, però per il vecchio studioso,
autore del più diffuso manuale
di macroeconomia, a tirare la
carretta è sempre la domanda
aggregata (consumi più investimenti). La Fed si è data anche
un obiettivo di crescita e sta per
raggiungerlo, mentre l’inflazione è ancora troppo bassa, anche
se negli Usa non c’è deflazione.
L’unico obiettivo della Bce, invece, è l’inflazione e finora lo ha
mancato.
Il marasma politico in cui
cade adesso anche la Spagna
non fa che dargli ragione.
Formiche.net
TORRE DI CONTROLLO
È mai possibile che la ministra Pinotti possa fare meglio
del Pentagono contro l’Isis in Iraq? Dati su cui riflettere
DI
S
TINO OLDANI
arà mai possibile che Roberta
Pinotti riesca là dove hanno
fallito Barack Obama e il
Pentagono? «L’Italia, se ci sarà
bisogno, è pronta a dare un aiuto ancora più forte contro l’Isis» ha detto la
ministra della Difesa. «Sono già pronti
240 dei 280 soldati che invieremo in
Iraq per dare una mano alla lotta che
l’esercito iracheno e i curdi stanno conducendo contro lo Stato islamico». Non
è noto se la ministra Pinotti, prima di
affermazioni tanto impegnative, fosse
stata messa al corrente di quanto aveva
appena dichiarato il segretario Usa della Difesa, Ashton Carter, intervistato
dalla Cnn, proprio sulla scarsa voglia
di combattere dell’esercito iracheno.
Nel tentativo evidente di soccorrere
il presidente Obama, che pochi giorni
prima aveva annunciato un’inesistente
vittoria sull’Isis, coprendosi di ridicolo
di fronte al mondo, il ministro Usa della Difesa ha spiegato la perdita del controllo della città strategica di Ramadi,
in Iraq, con queste parole: «Quello che
è successo, a quanto pare, è che le forze
irachene non hanno mostrato alcuna
volontà di combattere l’Isis e di difendersi. Possiamo addestrarli, possiamo
dargli equipaggiamenti, ovviamente
non possiamo dargli la voglia di combattere».
Ma se la situazione è questa, che
senso ha mandare 280 soldati italiani
in Iraq? Che cosa fa credere alla ministra Pinotti che i nostri addestratori
militari siano più bravi dei loro colleghi
americani nel convincere i soldati iracheni a sfidare sul campo i tagliagole
dello Stato islamico? Mistero. «Fra le
nazioni, l’Italia è quella che ha fornito
un contingente fra i più significativi,
proprio perché abbiamo compreso la
gravità del rischio», ha sottolineato la
Pinotti. «Quello dell’Isis è un punto su
cui la comunità occidentale si gioca il
futuro e la convivenza civile con l’Oriente: l’Isis è una minaccia per il mondo
che vuole vivere senza oppressioni e
terrorismo». Giusto. Ma per sconfiggere l’Isis, che dispone di milizie sempre
più numerose e bene armate, ed è ricco
dei pozzi petroliferi conquistati, le belle
parole servono a ben poco. Basteranno
240 addestratori? Non è disfattismo,
ma è lecito dubitarne.
Sul piano delle motivazioni,
è bene ricordare che la stragrande maggioranza dei giovani italiani
(66,7%) che hanno fatto domanda per
partecipare al concorso militare di Vfp1
(Volontario in ferma prefissata di un
anno) erano disoccupati provenienti dal
Sud e dalle isole. Più o meno la stessa
percentuale si registra per chi si propone per una ferma volontaria di quattro
anni (Vfp4), con l’obiettivo di un posto
fisso per qualche anno e uno stipendio
di 800 euro al mese. Il risultato è che
l’esercito italiano (102 mila unità) è
composto da personale proveniente per
il 50,8% dal Mezzogiorno, e per il 20,7%
dalle isole (Sicilia e Sardegna).
Il sito linkiesta.it, che ha intervistato numerosi volontari Vfp1 e Vfp4,
rivela che la maggioranza si arruola
per sfuggire alla disoccupazione, spesso
con il miraggio dei 3.500 euro di stipendio, dati a chi partecipa alle missioni
all’estero, le più rischiose. Molti lo fanno
perché hanno già moglie e figli da mantenere, altri per comprare la casa. Dopo
il congedo, i più tentato di reinserirsi
nella società, anche con lavori umili. Ma
non di rado capita che molti, delusi, si
arruolino di nuovo, avendone l’età, pur
di avere un salario sicuro rispetto ai lavori in fabbrica o nell’edilizia. Piaccia o
meno, al netto della retorica, la realtà
è questa: abbiamo un esercito fatto da
giovani che cercano in primo luogo un
rimedio alla disoccupazione. E nessuno
di loro ha veramente la passione per
le armi, tantomeno voglia di battersi
con l’Isis. Quanto ai 240 addestratori,
sono forse sono più motivati dei soldati
iracheni che dovrebbero convincere a
combattere? Il dubbio è grande.
Poi c’è la questione delle risorse economiche. Giovedì 21 maggio è
uscito il «Documento programmatico
pluriennale per la Difesa per il triennio
2015-2017», che negli ambienti militari
ha suscitato non poche preoccupazioni
per le continue riduzioni di spesa. Il
budget 2015 della Difesa si attesta a
13,1 miliardi, di cui 9,6 per gli stipendi
del personale militare e civile (73,3%),
2,3 miliardi per gli investimenti (18%)
e 1,1 per l’esercizio (8,7%). A causa dei
tagli imposti dai vincoli del bilancio statale e dalla crisi, la spesa complessiva
scenderà sotto i 13 miliardi nel 2016
(12,3 miliardi), per risalire di poco nel
2017 (12,7 miliardi). Il grosso della
spesa (oltre i 9 miliardi) resterà quella
destinata al personale, che sommando
le tre forze armate conta più di 174
mila unità, di cui circa 90 mila sono
ufficiali e sottufficiali. Più comandanti
che comandati.
Il divario organizzativo con gli
Usa è clamoroso. In Italia vi sono circa seicento fra generali e ammiragli,
mentre gli Stati Uniti, che vantano un
apparato militare di un milione 400
mila uomini, hanno appena 900 ufficiali dello stesso livello. Per contro, da
noi l’eccellenza militare, pronta per le
operazioni sul campo, è ridotta ai minimi termini, tra 12 e 15 mila unità,
di cui 5 mila impiegate nelle 28 missioni all’estero. In pratica, un esercito
per lo più di burocrati con le stellette.
Una realtà che, per giudizio unanime
degli analisti militari, va cambiata al
più presto.