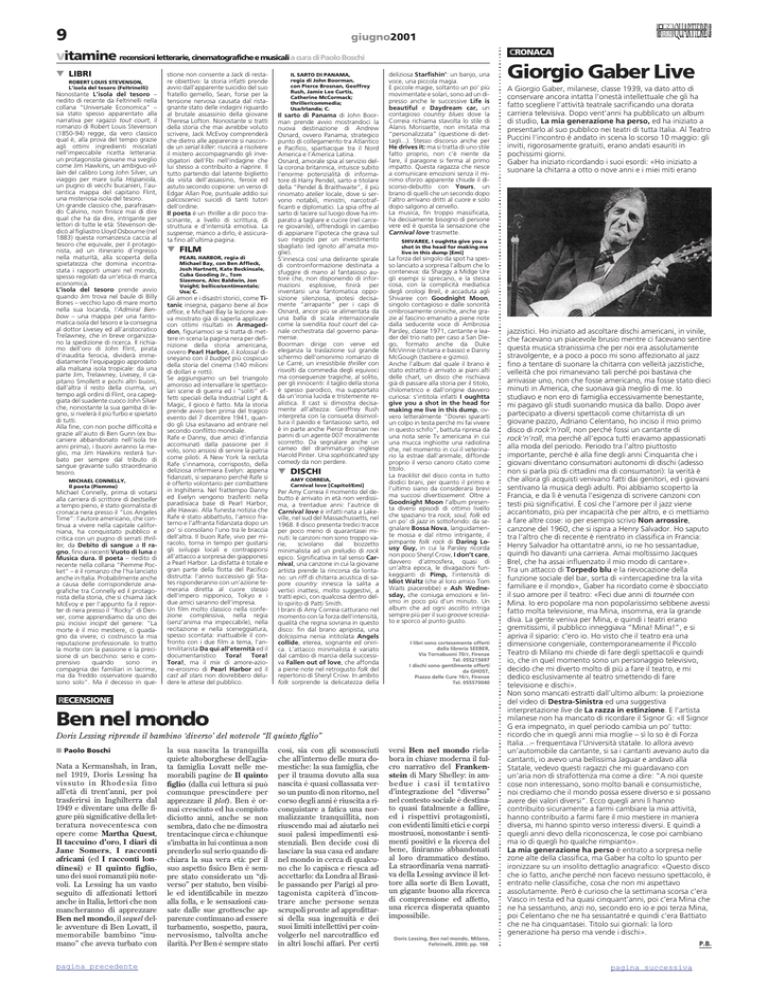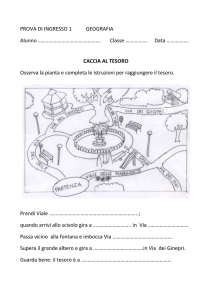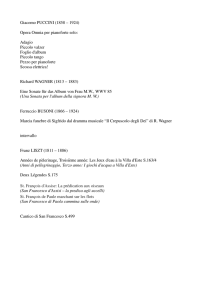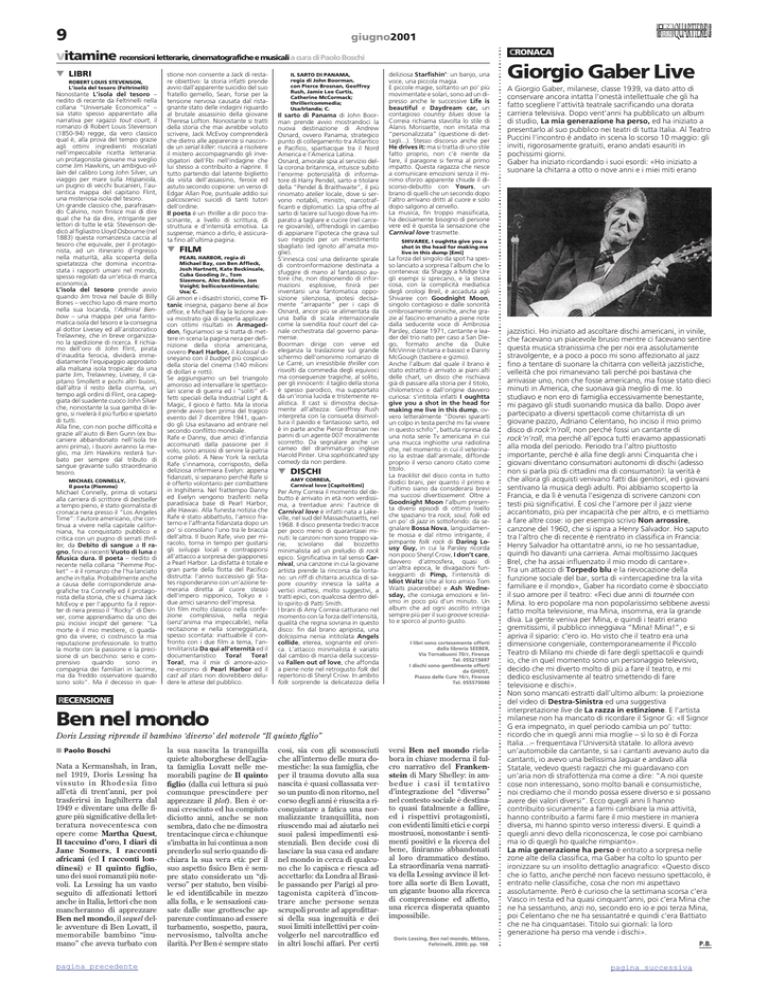
9
giugno2001
CRONACA
vitamine recensioniletterarie,cinematograficheemusicali acuradiPaoloBoschi
t LIBRI
ROBERT LOUIS STEVENSON,
Lisola del tesoro (Feltrinelli)
Nonostante L’isola del tesoro
riedito di recente da Feltrinelli nella
collana Universale Economica
sia stato spesso apparentato alla
narrativa per ragazzi tout court, il
romanzo di Robert Louis Stevenson
(1850-94) regge, da vero classico
qual è, alla prova del tempo grazie
agli ottimi ingredienti miscelati
nellimpeccabile ricetta letteraria:
un protagonista giovane ma sveglio
come Jim Hawkins, un ambiguo villain del calibro Long John Silver, un
viaggio per mare sulla Hispaniola,
un pugno di vecchi bucanieri, lautentica mappa del capitano Flint,
una misteriosa isola del tesoro.
Un grande classico che, parafrasando Calvino, non finisce mai di dire
qual che ha da dire, intrigante per
lettori di tutte le età: Stevenson dedicò al figliastro Lloyd Osbourne (nel
1883) questa romanzesca caccia al
tesoro che equivale, per il protagonista, ad un itinerario dingresso
nella maturità, alla scoperta della
spietatezza che domina incontrastata i rapporti umani nel mondo,
spesso regolati da unetica di marca
economica.
L’isola del tesoro prende avvio
quando Jim trova nel baule di Billy
Bones vecchio lupo di mare morto
nella sua locanda, lAdmiral Benbow una mappa per una fantomatica isola del tesoro e la consegna
al dottor Livesey ed allaristocratico
Trelawney, che in breve organizzano la spedizione di ricerca. Il richiamo delloro di John Flint, pirata
dinaudita ferocia, dividerà immediatamente lequipaggio approdato
alla malsana isola tropicale: da una
parte Jim, Trelawney, Livesey, il capitano Smollett e pochi altri buoni,
dallaltra il resto della ciurma, un
tempo agli ordini di Flint, ora capeggiata del suadente cuoco John Silver
che, nonostante la sua gamba di legno, si rivelerà il più furbo e spietato
di tutti.
Alla fine, con non poche difficoltà e
grazie allaiuto di Ben Gunn (ex bucaniere abbandonato nellisola tre
anni prima), i buoni avranno la meglio, ma Jim Hawkins resterà turbato per sempre dal tributo di
sangue gravante sullo straordinario
tesoro.
MICHAEL CONNELLY,
Il poeta (Piemme)
Michael Connelly, prima di votarsi
alla carriera di scrittore di bestseller
a tempo pieno, è stato giornalista di
cronaca nera presso il Los Angeles
Time: lautore americano, che continua a vivere nella capitale californiana, ha conquistato pubblico e
critica con un pugno di serrati thriller, da Debito di sangue a Il ragno, fino ai recenti Vuoto di luna e
Musica dura. Il poeta riedito di
recente nella collana Piemme Pocket è il romanzo che lha lanciato
anche in Italia. Probabilmente anche
a causa delle corrispondenze anagrafiche tra Connelly ed il protagonista della storia, che si chiama Jack
McEvoy e per lappunto fa il reporter di nera presso il Rocky di Denver, come apprendiamo da uno dei
più incisivi incipit del genere: La
morte è il mio mestiere, ci guadagno da vivere, ci costruisco la mia
reputazione professionale. Io tratto
la morte con la passione e la precisione di un becchino: serio e comprensivo
quando
sono
in
compagnia dei familiari in lacrime,
ma da freddo osservatore quando
sono solo. Ma il decesso in que-
stione non consente a Jack di restare obiettivo: la storia infatti prende
avvio dallapparente suicidio del suo
fratello gemello, Sean, forse per la
tensione nervosa causata dal ristagnante stato delle indagini riguardo
al brutale assassinio della giovane
Theresa Lofton. Nonostante si tratti
della storia che mai avrebbe voluto
scrivere, Jack McEvoy comprenderà
che dietro alle apparenze si nasconde un serial killer: riuscirà a risolvere
il mistero accompagnando gli investigatori dellFbi nellindagine che
lui stesso a contribuito a riaprire. Il
tutto partendo dal latente biglietto
da visita dellassassino, feroce ed
astuto secondo copione: un verso di
Edgar Allan Poe, puntuale addio sui
palcoscenici suicidi di tanti tutori
dellordine.
Il poeta è un thriller a dir poco trascinante, a livello di scrittura, di
struttura e dintensità emotiva. La
suspense, manco a dirlo, è assicurata fino allultima pagina.
t FILM
PEARL HARBOR, regia di
Michael Bay, con Ben Affleck,
Josh Hartnett, Kate Beckinsale,
Cuba Gooding Jr., Tom
Sizemore, Alec Baldwin, Jon
Voight; bellico/sentimentale;
Usa; C.
Gli amori e i disastri storici, come Titanic insegna, pagano bene al box
office, e Michael Bay la lezione aveva mostrato già di saperla applicare
con ottimi risultati in Armageddon, figuriamoci se si tratta di mettere in scena la pagina nera per definizione della storia americana,
ovvero Pearl Harbor, il kolossal disneyano con il budget più cospicuo
della storia del cinema (140 milioni
di dollari e rotti).
Se aggiungiamo un bel triangolo
amoroso ad intervallare le spettacolari scene di guerra ed i soliti effetti speciali della Industrial Light &
Magic, il gioco è fatto. Ma la storia
prende avvio ben prima del tragico
evento del 7 dicembre 1941, quando gli Usa esitavano ad entrare nel
secondo conflitto mondiale.
Rafe e Danny, due amici dinfanzia
accomunati dalla passione per il
volo, sono ansiosi di servire la patria
come piloti. A New York la recluta
Rafe sinnamora, corrisposto, della
deliziosa infermiera Evelyn: appena
fidanzati, si separano perché Rafe si
è offerto volontario per combattere
in Inghilterra. Nel frattempo Danny
ed Evelyn vengono trasferiti nella
paradisiaca base di Pearl Harbor,
alle Hawaii. Alla funesta notizia che
Rafe è stato abbattuto, lamico fraterno e laffranta fidanzata dopo un
po si consolano luno tra le braccia
dellaltra. Il buon Rafe, vivo per miracolo, torna in tempo per gustarsi
gli sviluppi locali e contrapporsi
allattacco a sorpresa dei giapponesi
a Pearl Harbor. La disfatta è totale e
gran parte della flotta del Pacifico
distrutta: lanno successivo gli States risponderanno con unazione temeraria diretta al cuore stesso
dellimpero nipponico, Tokyo e i
due amici saranno dellimpresa.
Un film molto classico nella confezione complessiva, nella regia
(senzanima ma impeccabile), nella
recitazione e nella sceneggiatura,
spesso scontata: inattuabile il confronto con i due film a tema, lantimilitarista Da qui alleternità ed il
documentaristico Tora! Tora!
Tora!, ma il mix di amore-azione-eroismo di Pearl Harbor ed il
cast all stars non dovrebbero deludere le attese del pubblico.
IL SARTO DI PANAMA,
regia di John Boorman,
con Pierce Brosnan, Geoffrey
Rush, Jamie Lee Curtis,
Catherine McCormack;
thriller/commedia;
Usa/Irlanda; C.
Il sarto di Panama di John Boorman prende avvio mostrandoci la
nuova destinazione di Andrew
Osnard, ovvero Panama, strategico
punto di collegamento tra Atlantico
e Pacifico, spartiacque tra il Nord
America e lAmerica Latina.
Osnard, amorale spia al servizio della corona britannica, intuisce subito
lenorme potenzialità di informatore di Harry Pendel, sarto e titolare
della Pendel & Braithwaite, il più
rinomato atelier locale, dove si servono notabili, ministri, narcotrafficanti e diplomatici. La spia offre al
sarto di tacere sul luogo dove ha imparato a tagliare e cucire (nel carcere giovanile), offrendogli in cambio
di appianare lipoteca che grava sul
suo negozio per un investimento
sbagliato (ed ignoto allamata moglie).
Sinnesca così una delirante spirale
di controinformazione destinata a
sfuggire di mano al fantasioso autore che, non disponendo di informazioni esplosive, finirà per
inventarsi una fantomatica opposizione silenziosa, ipotesi decisamente arrapante per i capi di
Osnard, ancor più se alimentata da
una balla di scala internazionale
come la svendita tout court del canale orchestrata dal governo panamense.
Boorman dirige con verve ed
eleganza la traslazione sul grande
schermo dellomonimo romanzo di
Le Carré, un irresistibile thriller con
risvolti da commedia degli equivoci
ma conseguenze tragiche, al solito,
per gli innocenti: il taglio della storia
è spesso parodico, ma supportato
da unironia lucida e tristemente realistica. Il cast si dimostra decisamente allaltezza: Geoffrey Rush
interpreta con la consueta disinvoltura il pavido e fantasioso sarto, ed
è in parte anche Pierce Brosnan nei
panni di un agente 007 moralmente
scorretto. Da segnalare anche un
cameo del drammaturgo inglese
Harold Pinter. Una sophisticated spy
comedy da non perdere.
t DISCHI
AMY CORREIA,
Carnival love [Capitol/Emi]
Per Amy Correia il momento del debutto è arrivato in età non verdissima, a trentadue anni: lautrice di
Carnival love è infatti nata a Lakeville, nel sud del Massachussetts, nel
1968. Il disco presenta tredici tracce
per poco meno di quarantasei minuti: le canzoni non sono troppo varie,
scivolano
dal
bozzetto
minimalista ad un preludio di rock
epico. Significativa in tal senso Carnival, una canzone in cui la giovane
artista prende la rincorsa da lontano: un riff di chitarra acustica di sapore country innesca la salita a
vertici inattesi, molto suggestivi, a
tratti epici, con qualcosa dentro dello spirito di Patti Smith.
I brani di Amy Correia catturano nel
momento con la forza dellintensità,
qualità che regna sovrana in questo
disco: fin dal brano apripista, una
dolcissima nenia intitolata Angels
collide, eterea, sognante ed onirica. Lattacco minimalista è variato
dal cambio di marcia della successiva Fallen out of love, che affonda
a piene note nel retrogusto folk del
repertorio di Sheryl Crow. In ambito
folk sorprende la delicatezza della
deliziosa Starfishin: un banjo, una
voce, una piccola magia.
E piccole magie, soltanto un po più
movimentate e solari, sono ad un dipresso anche le successive Life is
beautiful e Daydream car, un
contagioso country blues dove la
Correia richiama stavolta lo stile di
Alanis Morissette, non imitata ma
personalizzata (questione di dettagli...). Stesso discorso anche per
He drives it: ma si tratta di uno stile
fatto proprio, non cè niente da
fare, il paragone si ferma al primo
impatto. Questa ragazza che riesce
a comunicare emozioni senza il minimo sforzo apparente chiude il discorso-debutto con Yours, un
brano di quelli che un secondo dopo
laltro arrivano dritti al cuore e solo
dopo salgono al cervello.
La musica, fin troppo massificata,
ha decisamente bisogno di persone
vere ed è questa la sensazione che
Carnival love trasmette.
La forza del singolo da spot ha spesso lanciato a sorpresa lalbum che lo
conteneva: da Shaggy a Midge Ure
gli esempi si sprecano, e la stessa
cosa, con la complicità mediatica
degli orologi Breil, è accaduta agli
Shivaree con Goodnight Moon,
singolo contagioso e dalle sonorità
ombrosamente oniriche, anche grazie al fascino emanato a piene note
dalla seducente voce di Ambrosia
Parsley, classe 1971, cantante e leader del trio nato per caso a San Diego, formato anche da Duke
McVinnie (chitarra e basso) e Danny
McGough (tastiere e gizmo).
Anche lalbum dal quale il brano è
stato estratto è arrivato ai piani alti
delle chart, un disco che rischiava
già di passare alla storia per il titolo,
chilometrico e dallorigine davvero
curiosa: sintitola infatti I oughtta
give you a shot in the head for
making me live in this dump, ovvero letteralmente Dovrei spararti
un colpo in testa perché mi fai vivere
in questo schifo, battuta ripresa da
una nota serie Tv americana in cui
una mucca inghiotte una radiolina
che, nel momento in cui il veterinario la estrae dallanimale, diffonde
proprio il verso canoro citato come
titolo.
La tracklist del disco conta in tutto
dodici brani, per quanto il primo e
lultimo siano da considerarsi brevi
ma succosi divertissement. Oltre a
Goodnight Moon lalbum presenta diversi episodi di ottimo livello
che spaziano tra rock, soul, folk ed
un po di jazz in sottofondo: da segnalare Bossa Nova, languidamente mossa e dal ritmo intrigante, il
pimpante folk rock di Daring Lousy Guy, in cui la Parsley ricorda
non poco Sheryl Crow, I don’t care,
davvero datmosfera, quasi di
unaltra epoca, le divagazioni funkeggianti di Pimp, lintensità di
Idiot Waltz (che al loro amico Tom
Waits piacerebbe) e Ash Wednesday, che coniuga emozioni e lirismo in poco più dun minuto. Un
album che ad ogni ascolto intriga
sempre più per il suo groove screziato e sporco al punto giusto.
I libri sono cortesemente offerti
dalla libreria SEEBER,
Via Tornabuoni 70/r, Firenze
Tel. 055215697
I dischi sono gentilmente offerti
da GHOST,
Piazza delle Cure 16/r, Firenze
Tel. 055570040
Ben nel mondo
Doris Lessing riprende il bambino ‘diverso’ del notevole “Il quinto figlio”
n Paolo Boschi
pagina precedente
la sua nascita la tranquilla
quiete altoborghese dell’agiata famiglia Lovatt nelle memorabili pagine de Il quinto
figlio (dalla cui lettura si può
comunque prescindere per
apprezzare il plot). Ben è ormai cresciuto ed ha compiuto
diciotto anni, anche se non
sembra, dato che ne dimostra
trentacinque circa e chiunque
s’imbatta in lui continua a non
prenderlo sul serio quando dichiara la sua vera età: per il
suo aspetto fisico Ben è sempre stato considerato un “diverso” per statuto, ben visibile ed identificabile in mezzo
alla folla, e le sensazioni causate dalle sue grottesche apparenze continuano ad essere
turbamento, sospetto, paura,
nervosismo, talvolta anche
ilarità. Per Ben è sempre stato
così, sia con gli sconosciuti
che all’interno delle mura domestiche: la sua famiglia, che
per il trauma dovuto alla sua
nascita è quasi collassata verso un punto di non ritorno, nel
corso degli anni è riuscita a riconquistare a fatica una normalizzante tranquillità, non
riuscendo mai ad aiutarlo nei
suoi palesi impedimenti esistenziali. Ben decide così di
lasciare la sua casa ed andare
nel mondo in cerca di qualcuno che lo capisca e riesca ad
accettarlo: da Londra al Brasile passando per Parigi al protagonista capiterà d’incontrare anche persone senza
scrupoli pronte ad approfittarsi della sua ingenuità e dei
suoi limiti intellettivi per coinvolgerlo nel narcotraffico ed
in altri loschi affari. Per certi
A Giorgio Gaber, milanese, classe 1939, va dato atto di
conservare ancora intatta lonestà intellettuale che gli ha
fatto scegliere lattività teatrale sacrificando una dorata
carriera televisiva. Dopo ventanni ha pubblicato un album
di studio, La mia generazione ha perso, ed ha iniziato a
presentarlo al suo pubblico nei teatri di tutta Italia. Al Teatro
Puccini lincontro è andato in scena lo scorso 10 maggio: gli
inviti, rigorosamente gratuiti, erano andati esauriti in
pochissimi giorni.
Gaber ha iniziato ricordando i suoi esordi: «Ho iniziato a
suonare la chitarra a otto o nove anni e i miei miti erano
SHIVAREE, I oughtta give you a
shot in the head for making me
live in this dump [Emi]
RECENSIONE
Nata a Kermanshah, in Iran,
nel 1919, Doris Lessing ha
vissuto in Rhodesia fino
all’età di trent’anni, per poi
trasferirsi in Inghilterra dal
1949 e diventare una delle figure più significative della letteratura novecentesca con
opere come Martha Quest,
Il taccuino d’oro, I diari di
Jane Somers, I racconti
africani (ed I racconti londinesi) e Il quinto figlio,
uno dei suoi romanzi più notevoli. La Lessing ha un vasto
seguito di affezionati lettori
anche in Italia, lettori che non
mancheranno di apprezzare
Ben nel mondo, il sequel delle avventure di Ben Lovatt, il
memorabile bambino “inumano” che aveva turbato con
Giorgio Gaber Live
versi Ben nel mondo rielabora in chiave moderna il fulcro narrativo del Frankenstein di Mary Shelley: in ambedue i casi il tentativo
d’integrazione del “diverso”
nel contesto sociale è destinato quasi fatalmente a fallire,
ed i rispettivi protagonisti,
con evidenti limiti etici e corpi
mostruosi, nonostante i sentimenti positivi e la ricerca del
bene, finiranno abbandonati
al loro drammatico destino.
La straordinaria vena narrativa della Lessing avvince il lettore alla sorte di Ben Lovatt,
un gigante buono alla ricerca
di comprensione ed affetto,
una ricerca disperata quanto
impossibile.
Doris Lessing, Ben nel mondo, Milano,
Feltrinelli, 2000; pp. 168
jazzistici. Ho iniziato ad ascoltare dischi americani, in vinile,
che facevano un piacevole brusio mentre ci facevano sentire
questa musica stranissima che per noi era assolutamente
stravolgente, e a poco a poco mi sono affezionato al jazz
fino a tentare di suonare la chitarra con velleità jazzistiche,
velleità che poi rimanevano tali perché poi bastava che
arrivasse uno, non che fosse americano, ma fosse stato dieci
minuti in America, che suonava già meglio di me. Io
studiavo e non ero di famiglia eccessivamente benestante,
mi pagavo gli studi suonando musica da ballo. Dopo aver
partecipato a diversi spettacoli come chitarrista di un
giovane pazzo, Adriano Celentano, ho inciso il mio primo
disco di rocknroll, non perché fossi un cantante di
rocknroll, ma perché allepoca tutti eravamo appassionati
alla moda del periodo. Periodo tra laltro piuttosto
importante, perché è alla fine degli anni Cinquanta che i
giovani diventano consumatori autonomi di dischi (adesso
non si parla più di cittadini ma di consumatori): la verità è
che allora gli acquisti venivano fatti dai genitori, ed i giovani
sentivano la musica degli adulti. Poi abbiamo scoperto la
Francia, e da lì è venuta lesigenza di scrivere canzoni con
testi più significativi. È così che lamore per il jazz viene
accantonato, più per incapacità che per altro, e ci mettiamo
a fare altre cose: io per esempio scrivo Non arrossire,
canzone del 1960, che si ispira a Henry Salvador. Ho saputo
tra laltro che di recente è rientrato in classifica in Francia:
Henry Salvador ha ottantatré anni, io ne ho sessantadue,
quindi ho davanti una carriera. Amai moltissimo Jacques
Brel, che ha assai influenzato il mio modo di cantare».
Tra un attacco di Torpedo blu e la rievocazione della
funzione sociale del bar, sorta di «intercapedine tra la vita
familiare e il mondo», Gaber ha ricordato come è sbocciato
il suo amore per il teatro: «Feci due anni di tournée con
Mina. Io ero popolare ma non popolarissimo sebbene avessi
fatto molta televisione, ma Mina, insomma, era la grande
diva. La gente veniva per Mina, e quindi i teatri erano
gremitissimi, il pubblico inneggiava Mina! Mina!, e si
apriva il sipario: cero io. Ho visto che il teatro era una
dimensione congeniale, contemporaneamente il Piccolo
Teatro di Milano mi chiede di fare degli spettacoli e quindi
io, che in quel momento sono un personaggio televisivo,
decido che mi diverto molto di più a fare il teatro, e mi
dedico esclusivamente al teatro smettendo di fare
televisione e dischi».
Non sono mancati estratti dallultimo album: la proiezione
del video di Destra-Sinistra ed una suggestiva
interpretazione live de La razza in estinzione. E lartista
milanese non ha mancato di ricordare il Signor G: «Il Signor
G era impegnato, in quel periodo cambia un po tutto:
ricordo che in quegli anni mia moglie sì lo so è di Forza
Italia
frequentava lUniversità statale. Io allora avevo
unautomobile da cantante, si sa i cantanti avevano auto da
cantanti, io avevo una bellissima Jaguar e andavo alla
Statale, vedevo questi ragazzi che mi guardavano con
unaria non di strafottenza ma come a dire: A noi queste
cose non interessano, sono molto banali e consumistiche,
noi crediamo che il mondo possa essere diverso e si possano
avere dei valori diversi. Ecco quegli anni lì hanno
contribuito sicuramente a farmi cambiare la mia attività,
hanno contribuito a farmi fare il mio mestiere in maniera
diversa, mi hanno spinto verso interessi diversi. E quindi a
quegli anni devo della riconoscenza, le cose poi cambiano
ma io di quegli ho qualche rimpianto».
La mia generazione ha perso è entrato a sorpresa nelle
zone alte della classifica, ma Gaber ha colto lo spunto per
ironizzare su un insolito dettaglio anagrafico: «Questo disco
che io fatto, anche perché non facevo nessuno spettacolo, è
entrato nelle classifiche, cosa che non mi aspettavo
assolutamente. Però è curioso che la settimana scorsa cera
Vasco in testa ed ha quasi cinquantanni, poi cera Mina che
ne ha sessantuno, anzi no, secondo ero io e poi terza Mina,
poi Celentano che ne ha sessantatré e quindi cera Battiato
che ne ha cinquantasei. Titolo sui giornali: la loro
generazione ha perso ma vende i dischi».
P.B.
pagina successiva