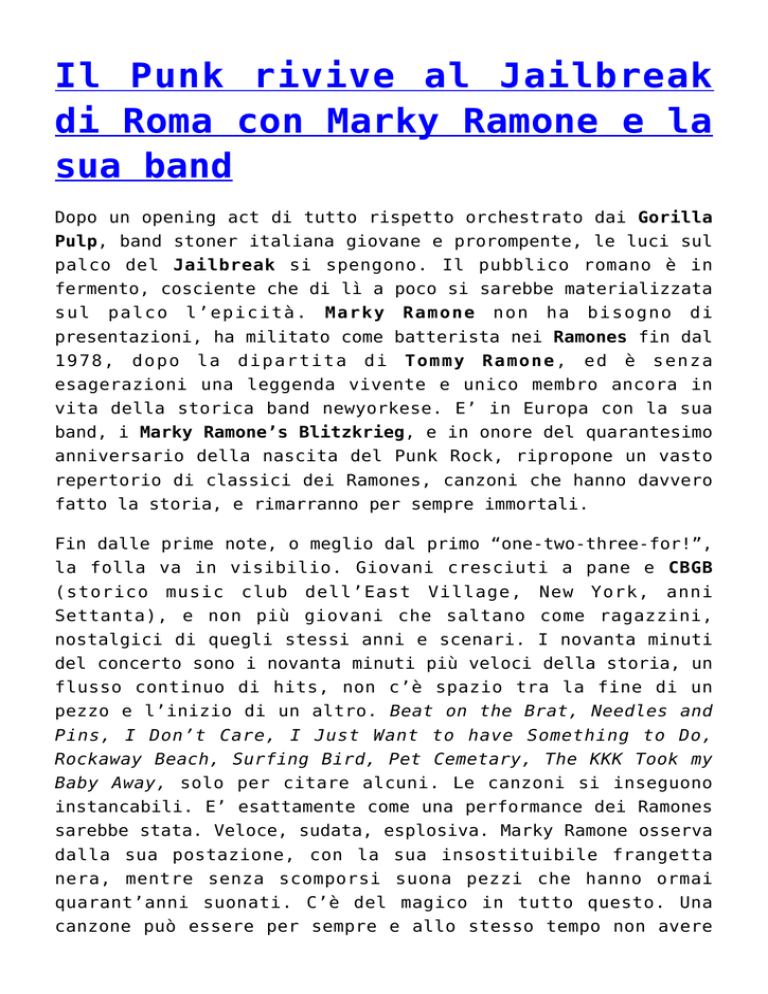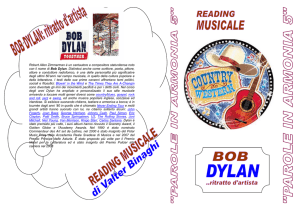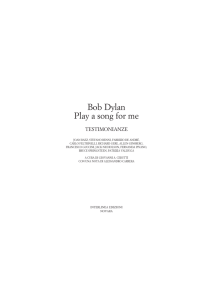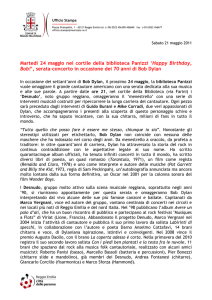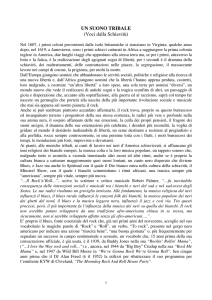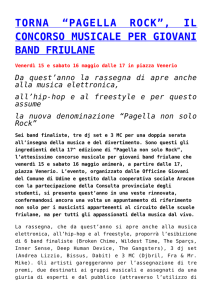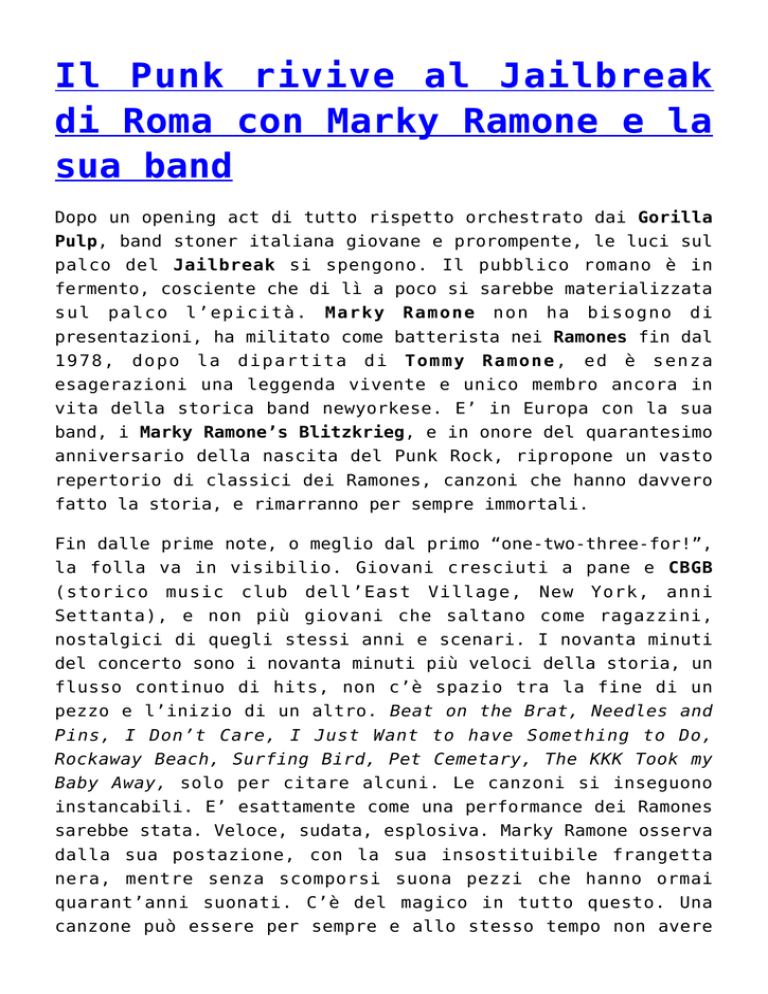
Il Punk rivive al Jailbreak
di Roma con Marky Ramone e la
sua band
Dopo un opening act di tutto rispetto orchestrato dai Gorilla
Pulp, band stoner italiana giovane e prorompente, le luci sul
palco del Jailbreak si spengono. Il pubblico romano è in
fermento, cosciente che di lì a poco si sarebbe materializzata
sul palco l’epicità. Marky Ramone non ha bisogno di
presentazioni, ha militato come batterista nei Ramones fin dal
1978, dopo la dipartita di Tommy Ramone, ed è senza
esagerazioni una leggenda vivente e unico membro ancora in
vita della storica band newyorkese. E’ in Europa con la sua
band, i Marky Ramone’s Blitzkrieg, e in onore del quarantesimo
anniversario della nascita del Punk Rock, ripropone un vasto
repertorio di classici dei Ramones, canzoni che hanno davvero
fatto la storia, e rimarranno per sempre immortali.
Fin dalle prime note, o meglio dal primo “one-two-three-for!”,
la folla va in visibilio. Giovani cresciuti a pane e CBGB
(storico music club dell’East Village, New York, anni
Settanta), e non più giovani che saltano come ragazzini,
nostalgici di quegli stessi anni e scenari. I novanta minuti
del concerto sono i novanta minuti più veloci della storia, un
flusso continuo di hits, non c’è spazio tra la fine di un
pezzo e l’inizio di un altro. Beat on the Brat, Needles and
Pins, I Don’t Care, I Just Want to have Something to Do,
Rockaway Beach, Surfing Bird, Pet Cemetary, The KKK Took my
Baby Away, solo per citare alcuni. Le canzoni si inseguono
instancabili. E’ esattamente come una performance dei Ramones
sarebbe stata. Veloce, sudata, esplosiva. Marky Ramone osserva
dalla sua postazione, con la sua insostituibile frangetta
nera, mentre senza scomporsi suona pezzi che hanno ormai
quarant’anni suonati. C’è del magico in tutto questo. Una
canzone può essere per sempre e allo stesso tempo non avere
età. Può essere semplice, fatta di tre accordi, eppure essere
determinante per un’esistenza intera. Per generazioni intere.
Sebbene l’attenzione ricada inevitabilmente su Mark, è
doveroso riconoscere la bravura e solidità della band che lo
supporta ormai da anni, perfettamente all’altezza di
riprodurre in maniera impeccabile, fedele, e per questo
apprezzatissima, il sound inconfondibile dei Ramones. Una
menzione a parte merita senza dubbio Ken Stringfellow, il
cantante, per l’impressionante somiglianza stilistica e vocale
con l’indimenticabile Joey Ramone. Ken che ci ha fatti
emozionare e per un attimo, il peso di un’assenza incolmabile
nel mondo della musica e non solo, è parso più sopportabile.
Che dire, come al solito, come solo la musica sa fare, si va
via un po’ strapazzati, rimescolati emotivamente. Il Jailbreak
si svuota, fuori l’aria è frizzante. Una leggenda ci ha appena
salutati con una bellissima What a Wonderful World. E’ tempo
di andare…hey, ho! Let’s go!
di Giorgia Atzeni
Bob Dylan, discorso intorno
ad uno dei maggiori poeti di
questo secolo
“Non ci riesco a suonarla Francis… mi sono scordato le
parole…”. Così, ubriaco fradicio e assiso fra i bidoni
dell’immondizia, il Dexter Gordon di Round Midnight regala una
verità che i suoi colleghi delle generazioni successive paiono
aver scordato: la musicalità delle parole. Quando vogliono
liquidare il mondo del rock e della canzone, affermare la
superiorità del proprio idioma, i jazzisti ricorrono spesso al
medesimo luogo comune: quella è musica che non sta in piedi da
sola, non basta a se stessa, per essere apprezzata e ricordata
ha bisogno delle parole. Nel momento in cui ha scelto di
diventare “arte”, il jazz ha adottato l’opzione asemantica, di
“linguaggio dei sentimenti”, per dirla con Susan Langer, gioco
di passioni ed emozioni svincolato dai significati. O forse,
più che una scelta, è stata una contingenza, l’esaurimento di
un ciclo storico. Dove sono finiti, dopo gli anni Cinquanta,
gli autori in grado di scrivere “frasi ritmiche” come quelle
di Lush Life (“where one relaxes on the axes of the wheel of
life, to get the feel of life, from jazz and cocktails”), di
I’ve Got a Feeling I’m Fallin’, di Lullaby of Birdland, o di
quella stessa Autumn in New York che il povero Dexter non
riusciva a ricordare? Maestri dell’allitterazione (così
importante nella poesia anglo-americana, sia dotta che
popolare: da John Donne fino a Louis McNeice), oltre che dei
contenuti, nipotini del reverendo Gerard Manley Hopkins più
che di Jelly Roll Morton. A loro, i vari Mel Tormé, Billie
Holiday, Ella Fitzgerlad, Nat King Cole, prestavano voci
esperte nel “rubato”, nell’anticipo e nel ritardo sul tempo,
capaci di adagiarsi morbide sulla frase, o, per contro, di
“pulsarci” dentro come il piatto di una batteria.
Il rock ha ereditato dal jazz tante cose. La varietà genetica,
anzitutto. Oltre alla vocazione ad essere “musica d’uso”,
funzionale al commento, all’immagine, e alla danza, agevolata
in questo dalla prevalenza dell’elemento ritmico, da una certa
spiccata “fisicità”. Forse ha ereditato anche la percezione
di quell’implicita musicalità del “discorso”, sottile, più
difficile da cogliere proprio perché ingombra di significati
diretti. Nelle sue espressioni migliori, infatti, il rapporto
di simbiosi fra testo e musica si traduce in un reciproco
arricchimento dei linguaggi e dei processi ideativi. Anche nel
rock, autore ed esecutore sono spesso una sola e stessa
persona, e, come nel jazz, la lettura dell’opera altrui è
talvolta assai disinibita, il testo si trasforma in puro
pretesto, tanto è distante dall’originale. Di questa
particolarissima schiera di moderni poeti, il più grande è Bob
Dylan, che ha sviluppato come nessun altro l’arte spericolata
di mettere insieme parole che si attraggono fra loro come le
note, navigando in quella zona di confine fra il talkin’ blues
e T.S. Eliot che è una delle tante fascinose stranezze della
poesia di questo secolo. Solo che mentre Eliot recitava le sue
poesie con deliberata piattezza, con una voce del tutto atona
e neutrale, Dylan le ha radicalmente modificate ad ogni nuova
“lettura”, spostando in ogni concerto accenti, intonazioni,
timbro vocale, talvolta perfino omettendo intere strofe. Così
trattandole, appunto, come degli standard jazzistici, e
implicitamente incoraggiando ognuno a fare altrettanto, a
riprodurre quelle opere con la stessa libertà con cui sono
state concepite. Lo sa bene Springsteen, ad esempio, che, per
“eccesso di rispetto”, di Dylan non ha mai interpretato le
canzoni. Con l’unica eccezione di Chimes of Freedom. Ma l’ha
fatto mutuando l’arrangiamento con cui la lanciarono i Byrds,
che cantavano solo tre strofe delle sei di cui si componeva.
La versione di Springsteen ne prevede invece quattro… Delle
tre versioni, oltretutto, nessuna (neppure quella di Dylan!)
rispetta interamente il testo pubblicato. Come dire, fatene
ciò che volete, di quest’inno ai “countless, confused,
accused, misused, strung out ones and worse”, per i quali le
“campane della libertà” non hanno mai suonato. Giocate pure
con le frasi, senza inibizioni né limiti.
Per Dylan, la libertà nell’uso delle parole, l’allentamento
del vincolo “logico”, agevolano non poco la ricerca della
musicalità, e derivano anche dal radicamento in una tradizione
letteraria recente che quel vincolo ha allentato da tempo, e
che arriva fino a Ginsberg. Se nello stream of consciousness
di Joyce i concetti si inseguono disordinati, nell’apparente
delirio dylaniano la struttura letteraria convenzionale si
frantuma ulteriormente: ogni parola è un concetto e può
richiamarne un’altra anche per semplice assonanza (o
dissonanza), perché il pensiero stesso cerca di liberarsi
nella rivoluzione psichedelica, nell’allargamento della
consapevolezza, condita di un istinto visionario degno di
William Blake. Nella loro magnifica ambiguità, i difficili
testi dylaniani sembrano a tutti accessibili, proprio perché
si prestano a diversi gradi di lettura ed alle più disparate
interpretazioni. Non tutti possono decifrare il “colto” W.H.
Auden, ma ogni under 23 occidentale si sente in diritto di
decifrare il colto Bob Dylan, che di Auden si nutre
abbondantemente, ma traveste la sua Età dell’Ansia da
“cantilena”, la nasconde dietro un assetto sconnesso che non
richiede necessariamente l’individuazione dei meccanismi
associativi, del vezzo delle citazioni. Occorre forse sapere
chi fosse la Sad Eyed Lady of the Lowlands per godere della
musica contenuta in questo verso? No davvero. Che “senso” ha
lo spremi agrumi piangente (“the lonsome orangegrinder cries”)
di I Want You? Forse nessuno. E ancora: “Mona Lisa must a’ had
the highway blues”, “Way out in the wilderness a cold coyote
calls”, “One of us must know”: talvolta i versi dylaniani
raccontano magnifiche storie, ma spesso sono soprattutto suoni
che evocano immagini, suggestioni tirate da catene di parole
quasi ipnotiche…
Dylan non è solo uno dei maggiori poeti anglosassoni di questo
secolo, ma è anche l’ultimo erede di quella Tin Pan Alley che
tanto disprezzava (esplicitamente in Bob Dylan’s Blues), di
quella fabbrica di canzoni che ognuno poteva adattare alle
necessità del proprio umore, della propria voce, del proprio
strumento. Buone per tutte le stagioni, oltretutto. A molti
grandi poeti degli anni Sessanta è toccata la strana sorte di
diventare delle hit discografiche, per poi essere
completamente dimenticati: pochissimi si ricordano di Keith
Reid, o di Pete Brown (autori rispettivamente dei testi di
Procol Harum e Cream). Le lyrics dylaniane, al contrario, sono
diventate evergreen malgrado le intenzioni dell’autore,
disposte a lasciarsi vivere in bocca a personaggi tanto
distanti quanto i Guns ‘n Roses (Knockin’ on Heaven’s Door) e
George Harrison (If Not for You), appunto. Il repertorio
dylaniano è ormai diventato quasi una “proprietà collettiva”,
nello spirito di quella tradizione dei folksinger dalla quale
Dylan indubbiamente proviene, attraverso la mediazione di
Woody Guthrie. Per cantare Dylan non occorre una bella voce,
perché la sua non lo è; per suonarlo non serve essere
musicisti esperti, perché sono pochi accordi semplici
semplici, che si prestano alle più svariate elaborazioni. Per
possedere Dylan basta essere dei poeti, e chi può negare che
lo siamo tutti?
di Filippo Bianchi
[Articolo tratto da L’Unità, 1992]
Nobel per la letteratura a
Bob Dylan
L’Accademia di Svezia ha fatto quest’anno una scelta inedita:
ha assegnato il Nobel per la letteratura al cantautore Bob
Dylan, un personaggio che ha tracciato un solco nella musica
contemporanea, dando voce ai venti di cambiamento culturale
degli anni Sessanta e Settanta e all’America degli esclusi,
quella messa ai margini del sogno a stelle e strisce.
Nella motivazione il Comitato di Stoccolma riconosce a Dylan –
al secolo Robert Allen Zimmerman – di aver “creato una nuova
poetica espressiva all’interno della grande tradizione canora
americana”. Una tradizione che affonda le sue radici nel blues
dolente dei neri, nel country e nel folk dei pionieri e dei
vagabondi americani, fondendoli in maniera unica con l’energia
nascente del rock n’ roll. La sua narrativa musicale ha
mantenuto vivo lo spirito popolare delle ballate di protesta
di Woody Guthrie e di altri artisti come T Bone Burnett, è
culminata nell’incontro tra la musica americana degli hobo e
la narrativa colta, la poesia, la letteratura e la
sperimentazione della beat generation. Il suo nome d’arte
“Dylan” è infatti ispirato allo scrittore gallese Dylan
Thomas.
Canzoni come The Times They Are a-Changing, Like a Rolling
Stone, Blowin’ in the Wind, sono diventate inni del movimento
controculturale di fine anni Sessanta, quello dei figli dei
fiori, del festival di Woodstock, dei pacifisti che
protestavano contro la guerra in Vietnam. La sua musica, nata
dalla voce esile e da una chitarra essenziale, veicola
messaggi di impegno sociale e politico.
La sua carriera comunque ha superato quegli anni effervescenti
e per alcuni distruttivi, continuando per decenni e
proseguendo anche oggi. Tantissimi i concerti, diverse le
esibizioni insieme ad altri nomi di spicco per la promozione
dei diritti civili, tra cui la compagna del passato Joan Baez.
Con il passare degli anni ha collezionato riconoscimenti anche
fuori dall’ambito strettamente musicale, come un Oscar nel
2001 per Things Have Changed, migliore canzone originale nel
film Wonder Boys, il Pulitzer nel 2008 con menzione speciale,
per il “profondo impatto sulla musica e la cultura popolare
d’America”, e la Presidential Medal of Freedom, la più alta
onorificenza insignita dal presidente degli Stati Uniti Barack
Obama. La rivista Rolling Stone l’ha consacrato con il secondo
posto tra i 100 migliori artisti, il settimo tra i migliori
cantanti, con 10 dei suoi album tra i migliori e 12 canzoni
nella classifica delle più apprezzate.
Dopo anni di tentativi, ora arriva anche l’incoronazione tra i
grandi della letteratura nella sua espressione più ampia e
alta, quale “grande poeta della tradizione in inglese”. Come
spiega il comitato per il Nobel nella motivazione: “Se andate
indietro nel tempo, diciamo 2 mila e 500 anni, scoprite che
Omero e Saffo scrivevano testi poetici composti per essere
ascoltati”, “per essere messi in scena spesso accompagnati da
strumenti musicali”: “è lo stesso per Bob Dylan”.
di Valentino Salvatore
Alan Parsons a Villa Ada, la
leggenda del rock festeggia i
40 anni di carriera
Ci risiamo. Questa volta la bellissima location di Villa Ada
ci regala un altro viaggio, ci porta da un’altra parte,
nell’Inghilterra degli anni Settanta.
Alan Parsons entra, anticipato dai musicisti della band,
elegante come sempre, con la sua giacca e la sciarpa al collo,
nonostante i tanti gradi dell’estate romana.
Nella sua imponenza fisica, nel suo sguardo fiero, traspare
tutta la grandezza delle cose fatte in passato, quest’anno
festeggia quarant’anni di onorata carriera. Alan Parsons non è
un musicista in senso canonico, nasce come ingegnere del suono
ed il suo nome è legato ad alcune delle più grandi produzioni
rock di tutti i tempi, basti pensare a The Dark Side of the
Moon dei Pink Floyd e Abbey Road dei Beatles, solo per citarne
alcune.
L’incontro con Eric Woolfson, musicista scozzese, da vita ad
uno dei progetti musicali più interessanti di tutti i tempi, e
porta i due ad essere considerati tra i maggiori
rappresentanti del progressive rock britannico, insieme a
gruppi quali Pink Floyd appunto, King Crimson, e Jethro Tull.
Cosi come l’idea che sta alla base dei concept album del
“Project” anche il concerto di ieri sera comincia con una
strumentale ed affascinantissima I robot, tratta dall’omonimo
album del 1977, che lascia piano piano spazio alle lyrics di
un altrettanto seducente Damned If I Do, dall’album Eve del
1979, cantata da un Pj Olsson in grandissima forma.
Si procede così a suon di hits – il tour è Greatest Hits 2016
appunto – che infiammano un pubblico che a stento riesce a
rimanere seduto. Un pubblico sorprendentemente eterogeneo,
composto tanto da ultra sessantenni quanto da giovani di
almeno tre generazioni prima. Il potere coinvolgente della
musica.
L’atmosfera si affievolisce leggermente a metà concerto, con
canzoni forse un po’ più lente, ma che non lasciano mai dubbio
alcuno sulla bravura estrema di tutti i componenti del gruppo,
ci tengo a precisare, per poi impennare nuovamente verso la
fine, con una bellissima Sirius, tratta da Eye in the Sky del
1982, forse l’album più acclamato della band. Segue il brano
omonimo, cantato davvero da tutto il pubblico, che ormai si
alza in piedi, rapito dall’atmosfera.
Alan Parsons ringrazia sentitamente, cimentandosi anche con
qualche parola di italiano, e ci saluta con una travolgente
Games People Play ( da The Turn of a Friendly Card, 1980).
E mentre il pubblico ancora emozionato si dirige verso
l’uscita, nel cielo di Villa Ada riecheggia ancora la frase
“Where do we go from here…”.
Grazie Alan, penso torneremo tutti negli anni Duemila, dopo
questo splendido viaggio indietro nel tempo.
di Giorgia Atzeni
Foto di Andrea Cavallini
Bruce Springsteen annulla
concerto in North Carolina:
“No a legge anti-gay”
Bruce Springsteen, da decenni icona del rock impegnato targato
Usa, annulla un concerto previsto domani a Greensboro, in
North Carolina, con la sua fidata E Street Band. Una decisione
annunciata dal Boss su Facebook per protestare contro una
legge appena introdotta, discriminatoria verso le persone
omosessuali, bisessuali e transgender. Il gesto eclatante di
Springsteen ha contribuito a puntare i riflettori su un caso
che a detta di molti fa tornare lo stato americano a un clima
da segregazione.
Il governatore repubblicano Pat McCory ha firmato proprio
giovedì una norma (House Bill 2, Public Facility and Security
Act) che vieta agli enti locali di intervenire autonomamente
per contrastare le discriminazioni basate su orientamento e
identità sessale. Lo stato, attualmente amministrato dai
conservatori, avoca a sé questa facoltà di fatto impedendo
alle amministrazioni locali più progressiste di intervenire.
La decisione infatti è stata presa in tempi da record per
bloccare un’ordinanza della città di Charlotte, che dal primo
aprile eliminava le discriminazioni contro gay, lesbiche e
trans per l’assegnazione di alloggi e l’utilizzo di servizi
pubblici. La nuova controversa legge inoltre impone alle
persone transessuali di entrare solo in bagni o ambienti come
spogliatoi riservati al proprio sesso biologico, cioè quello
riportato nel certificato di nascita. Per giustificare questa
scelta, i promotori hanno sostenuto che era un modo per
tutelare donne, ragazze e bambini da maniaci sessuali e
salvaguardarne la privacy. La legge è passata alla Camera con
83 sì e 25 no al Senato con 32 voti a favore e nessun
contrario (dato che i democratici, per protesta, hanno
lasciato l’aula).
Pubblicato da Bruce Springsteen su Venerdì 8 aprile 2016
“Il North Carolina ha appena approvato l’HB2”, scrive
Springsteen nel comunicato, “descritto dai media come la legge
‘sul bagno’”. La norma “prescrive quali bagni le persone
transgender possono usare”. Questo è l’aspetto che
prevedibilmente ha attirato polemiche, ironie e attenzione dei
media. Ma c’è ben altro: “la legge intacca anche il diritto
dei cittadini lgbt di fare causa quando i loro diritti umani
sono negati sul posto di lavoro”, fa notare il cantante.
“Nessun altro gruppo di cittadini del North Carolina deve
portare questo fardello. A mio avviso”, sostiene, “è un
tentativo da parte di persone che non sopportano il progresso
che la nostra nazione ha compiuto nel riconoscere i diritti
umani di tutti i cittadini, di ribaltare tale progresso”. Il
riferimento è all’ok dato dalla Corte Suprema al matrimonio
gay in tutti gli Usa, cui diversi stati a maggioranza
repubblicana cercano di opporsi con legislazioni che
permettono a funzionari pubblici e aziende private di non
fornire servizi agli omosessuali appellandosi alla “libertà
religiosa” o all’obiezione di coscienza.
Springsteen non è il solo ad aver manifestato la sua
contrarietà: le organizzazioni per la tutela dei diritti
civili si sono mobilitate. Anche diversi responsabili di
aziende come American Airlines,Apple, Facebook, Google, IBM
hanno firmato un appello. David Schulman, Ceo di Paypal, ha
annunciato che un investimento di 3,6 milioni di dollari
destinato al North Carolina per creare strutture e centinaia
di posti di lavoro finirà altrove. Sui social si diffonde
l’hashtag ironico #PeeingForPat, con foto di water e l’invito
a chiamare l’ufficio del governatore (appunto, Pat McCory) per
chiedere se si sta usando il bagno a norma di legge.
“Sento che è il momento per me e la band di mostrare
solidarietà a coloro che lottano per la libertà. Quindi, con
le più profonde scuse verso i nostri devoti fan di Greensboro,
abbiamo cancellato il nostro show, previsto per domenica 10
aprile”, fa sapere. “Alcune cose sono più importanti di un
concerto rock e questa lotta contro il pregiudizio e
l’intolleranza – che avviene mentre scrivo – è una di queste.”
– conclude il Boss – “È il mezzo più forte che ho per far
sentire la mia voce contro quelli che continuano a farci
tornare indietro invece di andare avanti.”
di Valentino Salvatore
Il rock di ‘Janis’
Mostra di Venezia
“Janis Joplin era – ed è ancora – una forza della
musica, una pioniera del rock amata da milioni di
(…) Guardare le immagini di Janis che si
un’esperienza semplicemente incantevole” Amy
alla
natura nella
appassionati
esibisce è
Berg
Arriva alla settantaduesima Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia la pellicola dedicata a Janis
Joplin, l’icona che ha
rivoluzionato la storia del
rock conquistando il mondo
con il suo inconfondibile
sound. Janis verrà presentato
fuori
concorso
nella
Selezione Ufficiale della
Mostra, domani, 6 settembre,
in anteprima mondiale, prima
di arrivare nelle sale italiane grazie ad I Wonder Pictures e
Unipol Biografilm Collection il prossimo 8 ottobre.
Un ritratto dell’artista a tutto tondo realizzato, in un arco
di tempo lungo sette anni, dalla regista candidata al Premio
Oscar Amy Berg, che ricostruisce la turbolenta storia della
Joplin – segnata da eccessi e da relazioni sentimentali
tormentate – attraverso immagini inedite e le emozionanti
lettere che l’artista scrisse alla sua famiglia, ai suoi
amici, ai suoi amanti prima della sua prematura scomparsa, a
soli 27 anni.
La Joplin entrò nel mito, come voce della sua generazione: con
Janis la regista mostra l’artista, la sua indimenticabile
voce, ma anche la donna, dolce, sensibile e allo stesso tempo
forte e tormentata. A prestare voce alle parole della Joplin,
Cat Power, acclamata come una delle migliori cantautrici della
scena alternative rock contemporanea.
L’Italia sarà il primo Paese nel mondo in cui Janis sarà
distribuito, il prossimo giovedì 8 ottobre, per commemorare il
quarantacinquesimo anniversario della scomparsa della
cantante, avvenuta il 4 ottobre del 1970.