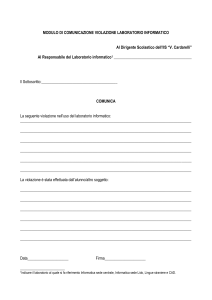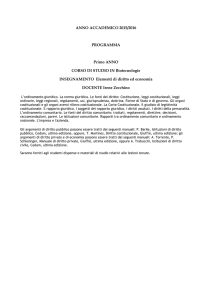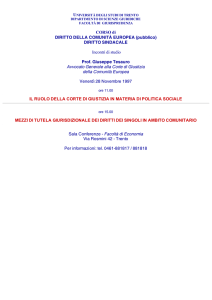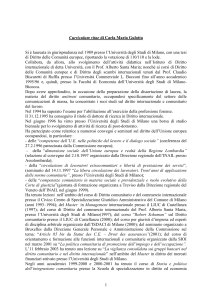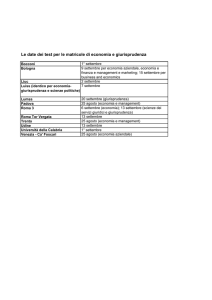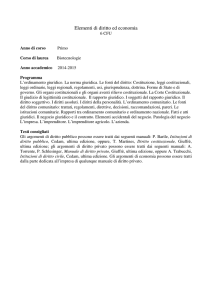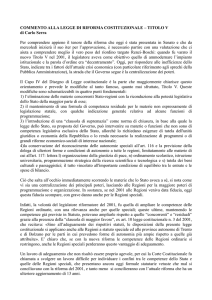LA RESPONSABILITA’ DELLO STATO PER ATTIVITA’
LEGISLATIVA NON ESISTE.
Nota a Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23730 del 22/11/2016, Est. Di Amato.
di Mattia Caputo
Sommario.
1. Il casus decisus. 2. Il parallelo con la responsabilità dello Stato per omesso o tardivo
recepimento di norme comunitarie. 3. La risposta della Suprema Corte: la responsabilità per
attività legislativa dello Stato non esiste. 4. Riflessioni a margine: il principio di separazione
dei poteri comporta l’immunità giurisdizionale.
1. Il casus decisus.
L’amministrazione fallimentare di una società citava in giudizio la regione Marche affinché
l’autorità giudiziaria ne accertasse la responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e, per l’effetto,
la condannasse al risarcimento del danno, per aver emanato legge regionale n. 25 del 2011, poi
dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 20131.
Parte attrice assumeva di essere stata una florida azienda nel campo dell’installazione e collaudo
di apparecchiature di telefonia fissa e mobile, e che a seguito dell’entrata in vigore delle norme
restrittive di tale attività introdotte dalla legge n. 25 del 2011, avrebbe patito un improvviso arresto
dell’attività produttiva, soffrendo così ingenti perdite e pregiudizi economici.
Nella prospettazione dell’amministrazione fallimentare, dunque, l’adozione da parte della regione
Marche di un atto legislativo successivamente dichiarato incostituzionale dal Giudice delle leggi
avrebbe integrato gli estremi di un illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo
della convenuta di risarcire il danno cagionato mediante l’adozione della legge regionale
costituzionalmente illegittima.
In primo grado il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, condannando la regione Marche
al risarcimento del danno; in sede di gravame la Corte d’Appello riformava la sentenza di prime
cure perché, pur ravvisando una responsabilità dell’ente regionale assimilabile a quella dello Stato
per mancata, inesatta o tardiva trasposizione di direttive dell’UE, non sarebbe stato sussistente nel
caso di specie un diritto tutelabile in giudizio.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione l’amministrazione
fallimentare sulla base di sei motivi di ricorso, ed in particolare perché la Corte d’Appello, sebbene
avesse ravvisato la sussistenza di una responsabilità legislativa della regione Marche, avrebbe poi
motivato illogicamente circa l’inapplicabilità del disposto dell’art. 28 Cost. alla fattispecie
concreta.
2. Il parallelo con la responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento
di norme comunitarie.
1
La legge regionale n. 25 del 2011 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del riparto di competenze
legislative tra Stato e Regioni, avendo la regione Marche legiferato in una materia, quella dell’ambiente, che l’articolo 117,
comma 2, lett. s) riserva alla potestà legislativa esclusiva statuale.
1
Il caso al vaglio della Suprema Corte presenta, almeno prima facie, delle analogie con la
responsabilità dello Stato-legislatore per l’omesso, tardivo o erroneo recepimento di norme
comunitarie non direttamente applicabili nell’ordinamento interno2.
Il filo conduttore che collega le due ipotesi è certamente rinvenibile nella circostanza che in
entrambi i casi il pregiudizio patito dai cittadini italiani deriva da un cattivo esercizio del potere
legislativo.
Tuttavia, a ben vedere, il parallelo tra la responsabilità per attività legislativa dello Stato censurata
poi dalla Corte Costituzionale e quella per violazione di norme comunitarie si esaurisce qui.
Per comprendere appieno le differenze tra le due fattispecie, si rende necessario ripercorrere, pur
brevemente, l’evoluzione che la responsabilità dello Stato per violazione di norme comunitarie ha
attraversato.
Infatti, l’obiettivo principale della giurisprudenza della CGE nell'elaborazione del rimedio
giurisdizionale che prevede la possibilità di condannare gli Stati membri dell'Unione Europea a
risarcire i singoli che siano stati danneggiati dal mancato rispetto, da parte degli stessi, degli
obblighi imposti dal diritto comunitario, è quello di garantire il più possibile l’effettività del diritto
comunitario all'interno degli ordinamenti degli Stati membri.
In questo contesto si inserisce la sentenza Francovich3, con cui la Corte di Lussemburgo ha
ammesso per la prima volta la configurabilità di una responsabilità a carico degli Stati membri per
i danni causati ai singoli cittadini per la violazione dei propri obblighi comunitari.
La CGE in quell’occasione individuò tre ragioni sottese all’ammissibilità di una responsabilità
degli Stati membri nei confronti dei loro cittadini: in primo luogo vi è la necessità di garantire
piena efficacia alle norme di diritto comunitario e piena tutela dei diritti che esse attribuiscono
ai singoli negli ordinamenti interni.
In secondo luogo il rispetto dell'art. 5 del TCE (ora art. 10 del TFUE), che sancisce il dovere di
leale cooperazione a carico dei Paesi membri nel dare esecuzione agli obblighi comunitari;
pertanto gli Stati che, pur facendo parte dell’UE, non collaborino nell’attuarne le norme, non
collaborano lealmente, venendo meno così ai loro doveri assunti pattiziamente.
Infine, la CGE diede ingresso alla responsabilità degli Stati membri per violazione di norme
comunitarie attraverso l’operazione ermeneutica di applicazione analogica della disciplina prevista
dall’art. 288 TCE, che prevede la responsabilità delle istituzioni comunitarie per i danni
cagionati ai cittadini degli Stati membri.
Nella ricostruzione della Corte di Giustizia Europea è necessaria la compresenza di una serie di
presupposti perché lo Stato membro possa essere condannato al ristoro del danno nei confronti
dei singoli. Più precisamente, ci si deve trovare in presenza di una direttiva comunitaria attributiva
di diritti ai singoli, è necessario che la violazione in cui sia incorso lo Stato membro sia grave e
2
Partendo dal presupposto che gli strumenti originariamente previsti dagli accordi istitutivi non fossero sufficienti a garantire la
corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario, la Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Van Gend en Loos del
1962 (Corte di giustizia 5 febbraio 1963, causa 26/62), non ha esitato a desumere dai principi generali del diritto comunitario
tutta una serie di corollari che, consolidatisi via via nel tempo, hanno assunto anch'essi il ruolo di principi cardine
dell'ordinamento comunitario. Ci si riferisce, da un lato, alla nozione di effetto diretto (vale a dire l’idoneità della norma
comunitaria ad incidere direttamente sulle posizioni giuridiche interne allo stato membro, potendo il singolo azionarle
direttamente innanzi al giudice nazionale), sia esso orizzontale (nei riguardi dei privati) che verticale (nei confronti dello Stato o
enti pubblici), di cui non vi era alcuna menzione nei trattati istitutivi e dall’altro, quella di supremazia (c.d. primauté) del diritto
comunitario.
3 CGE 19/11/1991. Il caso: lo Stato italiano aveva omesso di dare tempestivamente attuazione alla direttiva del Consiglio n. 80/97
sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, e fu
dichiarato inadempiente dalla Corte di Giustizia. Alcuni soggetti che si trovavano in condizioni tali da far scattare la garanzia
prevista dalla direttiva comunitaria agirono in giudizio chiedendo che lo Stato italiano fosse condannato a corrispondere loro il
trattamento previsto dall'atto comunitario, o, in subordine, il risarcimento dei danni.
2
manifesta (cd. “violazione sufficientemente qualificata4”), e deve sussistere un nesso di causalità
tra la violazione perpetrata dallo Stato ed il danno subito dal cittadino.
I Giudici comunitari lasciarono però alla discrezionalità dei singoli Stati membri la determinazione
delle regole formali e procedurali per l'esercizio di tali azioni risarcitorie, purché sia assicurato il
rispetto del principio di non discriminazione5 e di effettività6.
Da questo punto di vista è opportuno rilevare, a conferma dell’assoluta peculiarità della fattispecie,
che in giurisprudenza si è discusso sulla natura della posizione giuridica soggettiva del privato
che intende promuovere l’azione di risarcimento del danno contro lo Stato inadempiente; in
particolare, ci si è posto il problema se si tratti di una posizione qualificabile come di diritto
soggettivo oppure di interesse legittimo (con le ovvie conseguenze in punto di riparto di
giurisdizione).
Dopo alcune pronunce di segno contrastante, l’interpretazione pretoria si è definitivamente
assestata sulla tesi della natura di diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva vantata dal
singolo7: ciò perché, si è osservato, in caso di trasposizione di direttive comunitarie non selfexecuting8, lo Stato italiano non ha alcun margine di discrezionalità in ordine alla possibilità di
recepire o no tali norme, ma ha un vero e proprio obbligo, cui fa da contraltare il diritto soggettivo
dei cittadini a vedere (correttamente) trasposte nel sistema giuridico interno le norme di conio
sovranazionale.
Ne consegue che nel caso in cui venga avanzata una domanda di risarcimento danni per violazione
da parte dello Stato italiano degli obblighi di origine comunitaria, la giurisdizione spetta al giudice
ordinario.
Ad ogni modo la fattispecie dell’illecito del legislatore scaturente dalla violazione del diritto
comunitario presenta forti eccentricità, poiché essa è totalmente riconducibile al diritto
comunitario, con l’accertamento della sussistenza dei presupposti di tale responsabilità che,
pertanto, viene svolta alla stregua delle norme comunitarie9.
Non è un caso, allora, che la dottrina ha definito tale illecito come “interfacciale” in quanto “si
configura con particolari caratteri di complementarità, poiché esso non è né compiutamente
comunitario, né compiutamente nazionale, trovando la sua origine, piuttosto, dall’interazione tra
queste due fonti”10.
La Corte di Giustizia Europea, dopo la sentenza Francovich, ha precisato cosa dovesse intendersi per “violazione grave e
manifesta”, stabilendo che essa può essere rilevata sulla base di una serie di indici sintomatici (analoghi a quelli relativi alla
responsabilità delle Istituzioni comunitarie). Tali indici sono il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l’ampiezza
del potere discrezionale dello Stato, il carattere intenzionale e volontario della trasgressione commessa, il mantenere un
comportamento lesivo anche a seguito di un intervento chiarificatore della Corte in ordine alla norma comunitaria di riferimento,
così come dopo l’avvio della procedura di inadempimento.
5 Tale principio sancisce che, nonostante l’ampia discrezionalità degli Stati membri nel recepimento delle norme comunitarie,
essi devono comunque sempre garantire ai singoli la possibilità di far valere le proprie pretese di origine comunitaria alle stesse
condizioni in cui avrebbero potuto farne valere altre analoghe, ma basate su norme nazionali.
6 In base a questo principio l'esercizio dei diritti attribuiti ai cittadini degli Stati membri da una norma di derivazione comunitaria
non deve essere reso eccessivamente difficile o addirittura impossibile.
7 Ex multis Cass. Civ., SS.UU. n. 2203 del 4 febbraio 2005 e Cass. Civ., SS.UU., n. 6719 del 2 maggio 2003; Cass. Civ., SS.UU.,
n. 13909 del 25 giugno 2011.
8 Il principio della responsabilità dello Stato-legislatore si applica non solo alle direttive comunitarie non autoesecutive, ma più in
generale a tutte le norme di origine comunitaria non direttamente applicabili.
9 Così, ad esempio, il nesso di causalità fra la violazione dell’obbligo e il danno non deve essere valutato secondo le regole del
diritto interno, ma mediante il riferimento al diritto comunitario ed, in particolare, alla giurisprudenza della Corte di giustizia in
tema di responsabilità extracontrattuale della Unione Europea; quanto all’elemento soggettivo, invece, a differenza di quanto
sancisce il paradigma dell’art. 2043 c.c. non occorre l’accertamento né del dolo né della colpa dello Stato, trattandosi di una
responsabilità oggettiva.
10 E.SCODITTI, Il sistema multi-livello di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttiva comunitaria, “Il
principio the king can do no wrong”.
4
3
Un altro autore, ancora, ha affermato, con una definizione particolarmente evocativa, che nella
responsabilità dello Stato per violazione di norme comunitarie “la testa si trova nel diritto
comunitario” e “le gambe negli ordinamenti degli stati membri”11.
La responsabilità dello Stato per omessa, tardiva o erronea attività legislativa in contrasto con il
diritto comunitario, ha dunque natura ibrida, a mezza via tra il diritto comunitario e quello interno:
il primo ne individua i presupposti di operatività, mentre rientrano nelle competenze
dell’ordinamento interno le conseguenze da ricollegare alla fattispecie di responsabilità, con il
giudice nazionale che dovrà fare riferimento alle regole del diritto interno per la determinazione
dell’entità del risarcimento, la designazione del soggetto passivo dell’obbligo, l’identificazione
della procedura (determinazione del giudice competente, disciplina dei mezzi di ricorso e dei
correlativi termini di decadenza) e la fissazione dei termini di prescrizione del diritto al ristoro
patrimoniale.
Sulla base di questi presupposti la giurisprudenza interna si è dunque occupata di individuare
l’esatta natura giuridica di tale responsabilità: problema questo, non già meramente teorico,
ma gravido di importanti ricadute applicative, specie in punto di disciplina applicabile12.
Un filone interpretativo assolutamente minoritario ed estremo13, muovendo dal presupposto che la
funzione legislativa è espressione di potere politico libero nei fini, come tale sottratto a
qualsiasi sindacato giurisdizionale, ha ritenuto che a fronte all'esercizio del potere politico non
sono configurabili situazioni soggettive dei singoli protette, per cui deve escludersi radicalmente
che dalle norme dell'ordinamento comunitario possa farsi derivare, nel sistema ordinamentale
italiano, il diritto del singolo al corretto esercizio del potere legislativo e, comunque, la
qualificazione in termini di illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., da imputare allo Stato-persona.
Un secondo orientamento, consolidato, qualificava invece la fattispecie de qua in termini di illecito
aquiliano ex art. 2043 c.c., rendendo così applicabile la disciplina prevista dal codice civile per la
responsabilità extracontrattuale.
Questa tesi si fondava sull’argomento per cui l’articolo 2043 del codice civile costituisce una
clausola generale, aperta, in grado di ricomprendere tutte quelle condotte che si pongano in
contrasto con il divieto del neminem laedere; inoltre, si osservava che la responsabilità in esame
non potesse che essere extracontrattuale, dal momento che nessun vincolo giuridico di tipo
contrattuale avvince tra loro lo Stato ed i cittadini che, pertanto, rispetto al primo sarebbero terzi.
La giurisprudenza più recente14, a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 9147 del 17 aprile
2009 ha qualificato il cd. “illecito del legislatore” come derivante dalla violazione di
un’obbligazione ex lege di natura indennitaria15, aderendo così alla tesi, fino ad allora
11
A.DI MAJO, Responsabilità e danni nelle violazioni ad opera dello Stato, in Europa e diritto privato, 1998, p. 748.
12
La disciplina della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) diverge infatti significativamente da quella
della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), con l’azione risarcitoria che nella prima che si prescrive in 5 anni, di
norma consente il ristoro anche dei danni imprevedibili ed impone al danneggiato che agisca in giudizio di provare
tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, soggettiva ed oggettiva, dell’illecito. Nella responsabilità ex contractu,
al contrario, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel più lungo termine ordinario decennale, il danneggiato
non ha di norma diritto ad ottenere il ristoro dei danni imprevedibili, e l’attore in giudizio deve provare solo la fonte
(legale o negoziale) da cui deriva il suo diritto ed il danno patito, ed allegare l’inadempimento dell’altro contraente.
13
14
Così Cass., Sez. I, 10617 del 28 novembre 1996; Cass. 4915 del 2003
Cass. Civ., Sez. III, n. 23568 dell’11 novembre 2011; Cass. Civ., Sez. III, n. 1917 del 9 febbraio 2012.
15
Naturale precipitato della soluzione accolta dalle Sezioni Unite Civili per cui la responsabilità dello Stato ha
natura giuridica di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., è il suo assoggettamento alle relative regole; ciò ad
eccezione del profilo del termine di prescrizione, dal momento che la legge di stabilità per il 2012 (l. n. 183 del
2011) ha stabilito che il diritto al risarcimento dei danni patiti per effetto della tardiva, omessa o erronea attuazione
di direttive comunitarie è soggetto al termine prescrizionale breve di 5 anni previsto dall’art. 2947 c.c. a far data dal
momento in cui si era verificato il fatto dal quale derivavano i diritti. La successiva giurisprudenza (ex multis Cass.
Civ., Sez. Lavoro, n. 1850 dell’8 febbraio 2012) ha comunque stabilito che la legge di stabilità per il 2012 ha
carattere innovativo e, come tale, non si applica retroattivamente.
4
minoritaria, secondo cui sussisterebbe un autentico obbligo legale per lo Stato membro di
predisporre i mezzi necessari per garantire gli obiettivi di tutela posti dal diritto comunitario.
Tale impostazione prende le mosse dalla considerazione che lo Stato membro si obbliga nei
riguardi dello ordinamento comunitario al conseguimento di un risultato, e ciò perché: “stante il
carattere autonomo e distinto tra i due ordinamenti, comunitario e interno, il comportamento del
legislatore è suscettibile di essere qualificato come antigiuridico nell'ambito dell'ordinamento
comunitario, ma non alla stregua dell'ordinamento interno, secondo principi fondamentali che
risultano evidenti nella stessa Costituzione”.
In caso di omessa, tardiva o erronea trasposizione di norme comunitarie non direttamente
applicabili nell’ordinamento interno, dunque, lo Stato tiene una condotta illecita solo sul piano
sovranazionale, venendo meno agli obblighi sovranazionali assunti pattiziamente (oggi
cristallizzati nel primo comma dell’art. 117 Cost.), mentre sul terreno del diritto interno non vi è
alcun illecito, ma una responsabilità da attività lecita derivante dalla violazione di un’obbligazione
a carattere indennitario ex art. 1173 c.c., che dà luogo dunque non ad un’obbligazione di tipo
risarcitorio, bensì a carattere indennitario.
3. La risposta della Suprema Corte: la responsabilità per attività legislativa
dello Stato non esiste.
Alla luce di questo flash-back è ora possibile comprendere al meglio la decisione della Suprema
Corte nella sentenza n, 23730 del 2016.
La Terza Sezione della Cassazione Civile si è trovata ad affrontare una questione del tutto nuova
in giurisprudenza e di sicuro interesse, al confine tra il fondamentale principio di separazione dei
poteri (legislativo e giudiziario) e le istanze di tutela (risarcitoria) dei cittadini.
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente amministrazione
fallimentare attraverso un iter argomentativo solido e convincente.
Innanzitutto la Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile la tesi, accolta in primo grado ed
in appello, secondo cui la fattispecie concreta sarebbe assimilabile allo schema della violazione,
da parte del legislatore statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, con
conseguente applicabilità dei presupposti individuati dalla giurisprudenza della CGE nelle storiche
sentenze “Francovich” del 1990, “Brasserie du pecheur” e “Factortame” del 1996.
La Suprema Corte ha infatti ricordato che sul punto le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 9147
del 2009, hanno risolto il contrasto interpretativo relativo alla natura giuridica della responsabilità
dello Stato-legislatore in caso di violazione di obblighi sovranazionali-comunitari, accogliendo la
tesi della responsabilità dello Stato per inadempimento di un’obbligazione indennitaria ex lege,
ripudiando così la soluzione della responsabilità per attività illecita e antigiuridica.
In quell’occasione le SS.UU. stabilirono che dovesse escludersi radicalmente qualsiasi diritto
soggettivo dei cittadini al corretto esercizio del potere legislativo, poiché questo si caratterizza
per essere assolutamente libero nei fini e, dunque, sottratto a qualsiasi sindacato giurisdizionale, e
come tale inidoneo ad integrare alcuna responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.
L’antigiuridicità della condotta dello Stato per omessa, tardiva o erronea trasposizione di norme
comunitarie non direttamente applicabili non risiede dunque nella violazione di norme interne o
costituzionali, bensì nella violazione in cui incorre lo Stato italiano rispetto all’ordinamento
comunitario, che si colloca in una posizione di sovraordinazione.
Con maggiore impegno esplicativo, la responsabilità dello Stato in questo caso si giustifica in virtù
della primauté del diritto comunitario su quello italiano, nonché del principio di leale
collaborazione tra Stati membri, per cui la condotta dello Stato italiano può essere considerata non
iure soltanto sul piano sovranazionale, ma non su quello interno.
5
Per la Suprema Corte, invece, laddove la presunta responsabilità dello Stato o delle Regioni si
fondi sull’esercizio del potere legislativo censurata poi dalla Corte Costituzionale si è al cospetto
di una fattispecie del tutto differente da quella derivante dalla violazione dei vincoli comunitari,
per il semplice motivo che in questo caso manca la distinzione tra ordinamenti che fonda
l’ammissibilità della tutela risarcitoria del cittadino nei confronti dello Stato che non abbia
(correttamente) adempiuto agli obblighi cui è tenuto in forza dell’adesione all’UE.
Dunque, l’unico elemento di illiceità ed antigiuridicità che sorregge una tutela risarcitoria, rectius
indennitaria, in caso di omessa, erronea o tardiva trasposizione di norme comunitarie non
direttamente applicabili nell’ordinamento interno, risiede nella violazione in cui incorre lo Statolegislatore italiano nei confronti dell’ordinamento comunitario, cioè dell’Unione Europea,
sovraordinata rispetto ad esso.
Poiché l’ordinamento comunitario manca nel caso di responsabilità basata sulla illegittimità
costituzionale di un atto legislativo per il mancato rispetto della Carta Costituzionale, viene meno
qualsiasi parametro di riferimento idoneo a qualificare la condotta dello Stato, o delle Regioni,
come illecito o antigiuridico.
Nell’unitarietà della fattispecie vagliata dai Giudici della Nomofilachia, in cui vi è da parte del
legislatore una semplice violazione di norme interne, seppur costituzionali, non si rinviene quel
termine di riferimento, quale il sistema sovranazionale-comunitario, in grado di colorare di illiceità
la condotta dello Stato.
Tale argomento, unito alla libertà della funzione politica e legislativa cristallizzata negli articoli
68, comma 116, e 122, comma 417, della Grundnorm, implica secondo la Cassazione l’assenza di
qualsivoglia ingiustizia che possa ricondurre il danno patito dalla parte ricorrente nell’alveo
dell’illecito civile.
Ciò si spiega, secondo la Suprema Corte, anche alla luce della giurisprudenza granitica che esclude
la sindacabilità dell’attività e degli atti in cui si estrinseca la funzione legislativa, mentre della
legge stessa, e più nello specifico l’art. 7, comma 1, del c.p.a.18, che preclude qualsiasi sindacato
del giudice amministrativo sugli atti politici.
4. Riflessioni a margine: il principio di separazione dei poteri comporta
l’immunità giurisdizionale.
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte rappresenta un’assoluta novità nel panorama
giurisprudenziale italiano, ovvero quella della configurabilità della responsabilità dello Stato e
delle Regioni per attività legislativa costituzionalmente illegittima.
In disparte l’indubbio interesse che tale quaestio iuris suscita, la pronuncia che si annota
costituisce uno spunto per riflettere circa una tematica di portata più generale, ovvero quella dei
rapporti tra il principio di separazione dei poteri e le istanze di tutela dei singoli cittadini.
Si tratta con tutta evidenza di due convitati di pietra del nostro sistema ordinamentale – e più in
generale di tutti i moderni Stati di diritto– che devono trovare tra loro un giusto punto di equilibrio.
Da una parte, infatti, vi è la necessità, di rispettare il principio di separazione dei poteri, autentica
pietra angolare dell’ordinamento, di evitare sconfinamenti del potere giudiziario in ambiti riservati
L’art. 68, comma 1, della Costituzione nel prevedere che “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni” sancisce la c.d. “immunità parlamentare” per eventuali
reati che dovessero essere commessi dai parlamentari nell’espletamento delle loro funzioni.
17 L’art. 122, comma 4, della Costituzione stabilisce che “I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”, prevedendo così un’immunità analoga a quella dei membri del
Parlamento anche per i consiglieri regionali, affinché essi possa liberamente espletare le loro prerogative legislative.
18 Questa disposizione statuisce: “Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere
politico”.
16
6
a quello legislativo, dall’altra sta il bisogno di assicurare una tutela piena, adeguata ed effettiva ai
consociati, restringendo quanto più possibile ogni limitazione al diritto di difesa.
Nell complesse e delicate dinamiche relazionali tra questi due valori di primario rilievo, però,
sembra uscire vincitore soltanto il principio di separazione dei poteri: e ciò non tanto perché la
giurisprudenza non sia sensibile alle richieste di tutela avanzate dai singoli nei confronti dello Stato
che non operi correttamente nell’esercizio delle sue funzioni legislative, bensì per il timore, invero
non infondato, di pericolosi interventi sostitutivi o correttivi del potere giudiziario a scapito di
quello legislativo.
In questo modo si coglie perché la libertà nei fini di un atto o, in senso più lato, di un’attività, quale
quella legislativa, escluda in radice la configurabilità di un illecito da parte dello Stato o delle
Regioni, nell’adozione di atti legislativi, che vengano poi censurati come incostituzionali dal
Giudice delle leggi.
Il fatto che l’attività legislativa non debba perseguire fini predeterminati, dovendo attenersi invece
solo ai limiti procedurali19 e valoriali20 sanciti dalla Carta Costituzionale, fa sì che essa non sia
sindacabile da parte dell’autorità giudiziaria che, altrimenti, finirebbe di fatto per interferire in
modo illegittimo ed arbitrario con il potere legislativo, riservato di norma al Parlamento21.
Del resto, la circostanza che il potere di legiferare non abbia degli scopi predeterminati da
conseguire, essendo esso stesso ad individuare tali fini, implica altresì l’assenza di qualsiasi
parametro normativo alla stregua del quale sarebbe possibile per il potere giudiziario verificare la
legittimità di tali atti.
In altri termini, l’assenza di un paradigma di legittimità cui l’attività legislativa deve conformarsi
quanto agli scopi, fa sì che la discrezionalità di cui gode il potere legislativo è così ampia, da
divenire di fatto, salvo casi eccezionali22, intoccabile per la magistratura.
Vista in questi termini, la questione della configurabilità di una responsabilità legislativa dello
Stato non poteva che avere risposta negativa da parte della Suprema Corte, poiché la libertà nei
fini che contraddistingue tale attività è totalmente incompatibile con l’antigiuridicità delle scelte e
delle condotte serbate dallo Stato nell’emanazione di atti legislativi.
Sotto questo angolo visuale appare anche corretta la distinzione effettuata dalla Terza Sezione
Civile tra responsabilità dello Stato per attività legislativa non conforme alle norme interne (sia
pure costituzionali) e responsabilità per attività legislativa difforme dalle norme comunitarie: la
separazione e sovraordinazione tra ordinamento comunitario ed interno, infatti, è il solo elemento
in grado di colorare, seppure solo a livello sovranazionale, l’attività legislativa di antigiuridicità.
Poiché il dualismo tra ordinamenti difetta del tutto in caso di norme legislative interne illegittime
per contrasto con i parametri costituzionali, anch’essi interni, ne consegue che alcuna
antigiuridicità o illiceità è ascrivibile allo Stato, che ha semplicemente esercitato male un potere
che non è vincolato nei fini.
In questo senso si pensi alle sentenze n. 5 e 32 del 2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di norme penali rispettivamente per violazione dei criteri della delega conferita dal Parlamento al Governo (art. 76
Cost.) e per l’assenza del requisito dell’omogeneità tra l’oggetto del decreto-legge n. 272 del 2005 e della relativa legge di
conversione n. 49 del 2006.
20 Per il rispetto di criteri sostanziali e valoriali sanciti dalla Costituzione si pensi a tutte quelle pronunce (ad esempio in materia
di recidiva) con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di atti legislativi per violazione del canone
della ragionevolezza previsto dall’art. 3 della Carta Costituzionale.
19
21
Eccezion fatta per i decreti legislativi (art. 76 Cost.) ed i decreti-legge (art. 77 Cost.), dove il potere legislativo è
esercitato in via eccezionale dal Governo, ovvero dal potere esecutivo, ma pur sempre con il controllo preventivo
(con l’indicazione dell’oggetto, dei criteri e principi nel caso di decreti delegati) o successivo (in sede di conversione
del decreto-legge) ad opera del Parlamento.
Emblematico della tendenziale assoluta libertà di cui gode il potere legislativo, ad esempio in materia penale, è l’atteggiamento
della Corte Costituzionale rispetto alle scelte del legislatore in punto di dosimetria sanzionatoria, nonché circa le immunità: in
entrambi i casi, infatti, il Giudice delle leggi ha stigmatizzato le scelte legislative solo in casi estremi, di soluzioni normative
manifestamente irragionevoli, o che trasmodino in un ingiustificato privilegio soltanto per alcune categorie di soggetti.
22
7
La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza 23730 del 2016 risulta così essere
espressione del più totale rispetto da parte del potere giudiziario del principio di separazione dei
poteri, che non può essere toccato, nemmeno in nome dell’effettività e della pienezza della tutela
dei cittadini.
Una scelta giurisprudenziale di tipo diverso, infatti, finirebbe di fatto per porre dei pericolosi limiti
al legislatore, che si troverebbe in buona sostanza a svolgere un’attività che non sarebbe più
realmente libera nei fini, laddove lo Stato fosse tenuto a risarcire i danni patiti dai singoli per
effetto degli atti normativi da esso adottati.
Con maggiore impegno esplicativo, quindi, ammettere una responsabilità per attività legislativa
dello Stato, vorrebbe dire da un lato attribuire al potere giudiziario la facoltà di sindacare scelte
assolutamente libere quanto ai fini, dall’altro far pendere sullo Stato la “spada di Damocle” della
condanna al risarcimento dei danni, che potrebbe facilmente risolversi in una limitazione di un
potere che, invece, è per antonomasia libero.
Senza trascurare, poi, che il potere legislativo non è comunque esente da forme di controllo,
essendo assoggettato sia al controllo di legittimità costituzionale, sia al controllo del corpo
elettorale attraverso l’esercizio del diritto di voto.
Ad ogni modo il rispetto del canone fondamentale della separazione dei poteri non viene
interpretato ed applicato dalla giurisprudenza in modo rigido ed assoluto, come dimostra
l’interpretazione pretoria consolidata in giustizia amministrativa circa la nozione di “atto politico”.
La questione dell’esatta individuazione della natura politica o amministrativa di un atto è di
particolare importanza, dal momento che ai sensi dell’art. 7, comma 1, del c.p.a.23, gli amministrati
non possono impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti o i provvedimenti adottati dal
Governo nell’esercizio del potere politico.
La dottrina e la giurisprudenza, dopo aver a lungo dibattuto 24 sulla ratio dell’esclusione del
sindacato giurisdizionale del g.a. sugli atti connotati da “politicità”, sono giunte alla conclusione
per cui gli atti politici non sono stigmatizzabili in sede giurisdizionale perché liberi nei fini,
diversamente da quanto accade per gli atti amministrativi, che anche ove siano espressione di
discrezionalità amministrativa, sono pur sempre preordinati alla realizzazione degli scopi stabiliti
dal potere politico.
In quanto liberi nei fini, dunque, gli atti politici non sono suscettibili del vaglio dell’autorità
giudiziaria che, altrimenti, si sostituirebbe al potere esecutivo, in aperta violazione del principio di
separazione dei poteri.
Tuttavia la giurisprudenza amministrativa, preoccupata dalla categoria degli atti politici, che sono
sostanzialmente sottratti a qualsiasi controllo di tipo giurisdizionale25, con conseguente
obliterazione totale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dei cittadini che da essi si assumono lesi, ha
dato un’interpretazione particolarmente restrittiva di tale tipologia di atti.
Per i giudici amministrativi26si ha quindi atto politico solo ed esclusivamente quando ricorrono tre
requisiti: il primo, soggettivo, per cui l’atto deve provenire da un organo di vertice della p.a.,
individuato tra quelli preposti dalla Costituzione all’indirizzo ed alla direzione della cosa pubblica,
e il secondo, oggettivo, che si verifica quando l’atto riguarda la costituzione, la salvaguardia ed il
La disposizione riproduce l’abrogato articolo 31 del R.D. n. 1054 del 26 giugno 1924 (Testo unico sulle leggi del Consiglio di
Stato), che così disponeva: “il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o
provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”.
24 In un primo momento si è infatti teorizzato che gli atti politici non fossero impugnabili davanti al giudice amministrativo
perché essi non possono in alcun modo pregiudicare la sfera giuridica dei singoli.
25 Trattandosi di atti non legislativi, infatti, non è ammesso neanche il controllo di costituzionalità sugli atti politici.
26 Tra le tante pronunce: C.d.S., Sez. IV, n. 217 del 29 febbraio 1996; C.d.S., Sez. IV, n. 1397 del 12 marzo 2001; C.d.S., Sez. V,
n. 209 del 23 gennaio 2007; Corte Cost., sent. n. 81 del 2013; Cass. Civ., SS.UU., n. 16305 del 28 giugno 2013; Cass. Civ.,
SS.UU., n. 10416 del 14 maggio 2014.
23
8
funzionamento dei pubblici poteri, nella loro organica struttura e nella loro coordinata
applicazione.
Il terzo requisito infine consiste nella libertà dei fini dell’atto politico, che si differenzia così da
quello amministrativo27.
Il timore della giurisprudenza amministrativa che ad una nozione lata di “atto politico” corrisponda
specularmente un ampio vuoto di tutela per i cittadini (con violazione del disposto degli artt. 24 e
113 Cost.) si è così palesato in quel progressivo processo di erosione dell’atto politico, che ha
portato al conio pretorio della figura attizia degli “atti di alta amministrazione” che, pur fungendo
da cerniera tra funzione di governo ed attività amministrativa in senso stretto, si caratterizzano per
non essere “a motivo libero” ma massimamente) discrezionali e, dunque, sono sindacabili dal
g.a.28.
La giurisprudenza amministrativa, dilatando in via interpretativa la categoria degli atti di alta
amministrazione29, ha ridotto in modo inversamente proporzionale la nozione di “atto politico”,
che viene intesa estremamente restrittivo, facendovi rientrare soltanto per quegli atti che, in buona
sostanza, provengano da soggetti che svolgono un ruolo primario nella mappatura costituzionale
e che si occupano di regolare vicende di primaria rilevanza dei pubblici poteri, ovvero di gestire i
livelli supremi della res pubblica senza perseguire fini prestabiliti.
Alla luce di quanto detto risulta evidente, allora, come la giurisprudenza – civile, costituzionale ed
amministrativa – operi in modo pienamente rispettoso del principio di separazione dei poteri,
districandosi in modo corretto sul pericoloso filo di rasoio rappresentato da un lato dall’esercizio
dell’attività giurisdizionale in funzione della tutela dei singoli, e dall’altro dal muro invalicabile
degli altri poteri dello Stato, cioè quello legislativo ed esecutivo.
La soluzione di fondo accolta dall’interpretazione giurisprudenziale, confermata dalla sentenza n.
23730 del 2016 della Cassazione Civile, è dunque quella di guardare agli scopi cui è
teleologicamente orientato il potere da sindacare: se questo è privo di fini predeterminati, in
modo espresso o desumibile dal sistema, nessun controllo giurisdizionale è immaginabile, pena
l’invasione di campo della magistratura in ambiti che le sono preclusi.
Il potere legislativo fissa le regole e stabilisce gli scopi cui la macchina pubblica deve tendere,
mentre quello giudiziario applica le leggi emanate dal Parlamento e ne garantisce il rispetto.
Laddove, invece, il potere da controllare sia teso a realizzare scopi già fissati, non vi è alcun
pericolo di interferenze indebite tra poteri dello Stato e, pertanto, si riespande il diritto inviolabile
di difesa (artt. 24 Cost., 1 c.p.a.), che impone di consentire sempre una qualche forma di protezione
per i consociati, sia che ciò avvenga sub specie di tutela demolitoria (come nel caso
dell’impugnazione innanzi al g.a.), sia che avvenga mediante la tutela risarcitoria per equivalente
(come nel caso dell’azione risarcitoria innanzi al g.o. o al g.a.).
Dunque, solo ove vi sia realmente la necessità di rispettare i delicati e precari equilibri imposti dal
principio della divisione dei poteri statuali scatta l’area dell’immunità giurisdizionale; laddove,
invece, non vi sia una reale esigenza di rispettare la sfera riservata ad altri poteri dello Stato, come
nel caso degli atti di alta amministrazione, non vi è più alcuno spazio per l’immunità
giurisdizionale che, altrimenti, finirebbe per trasformarsi in una vera e propria “impunità
giurisdizionale”, in spregio al fondamentale principio di legalità, che vieta che i poteri siano
legibus soluti.
27
Sul punto di recente le Sezioni Unite della Cassazione Civile con la sentenza n. 10319 del 19 maggio 2016, hanno ribadito che
“non ha natura di atto politico quello che, seppur emesso nell’esercizio di ampia discrezionalità, è vincolato a un fine desumibile
dal sistema normativo…”.
28 Per la distinzione tra atti politici ed atti di alta amministrazione, sottratti all’area dell’immunità giurisdizionale: Cass. Civ.,
SS.UU., n. 21581 del 19 ottobre 2011; Cass. Civ., SS.UU., n. 10416 del 14 maggio 2014.
29
Rientrano negli atti di alta amministrazione, tra gli altri, gli atti di nomina dei dirigenti apicali della pubblica
amministrazione, la revoca del consigliere comunale, nonché gli atti di macro organizzazione.
9
Nonostante l’indubbia correttezza della decisione che si annota sotto il profilo tecnico, pare
opportuno, a parere di chi scrive, rilevare come la sentenza n. 23730 del 2016 presenti però un
profilo di criticità.
Infatti, pur nella diversità dei presupposti che caratterizzano l’attività legislativa dello Stato
italiano nel caso in cui debba conformarsi agli obblighi di derivazione sovranazionale rispetto a
quella che deve rispettare le norme interne di rango costituzionale, sembra evidente che la
soluzione accolta dalla Suprema Corte finisca per creare una distonia tra le due ipotesi.
Infatti, mentre nel caso in cui il legislatore sia incorso nella violazione di norme comunitarie i
cittadini italiani hanno diritto al ristoro dei pregiudizi da essi patiti, lo stesso rimedio non viene
riconosciuto nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività legislativa, ad essere violate siano le norme
nazionali, ancorché costituzionali.
L’interpretazione offerta dalla Suprema Corte finisce dunque per dare vita ad una sorta di
“discriminazione al rovescio”, in cui ad essere trattata in modo deteriore è la situazione giuridica
soggettiva di derivazione interna, che non può ricevere tutela risarcitoria in caso di violazione di
norme nazionali da parte del legislatore.
La disarmonia del sistema risulta ancora più evidente se solo si pensi, seppur in altro ambito, che
le Sezioni Unite Penali nel 2014 con la sentenza “Gatto” n. 42858, hanno sancito che il giudicato
di condanna deve cadere anche in caso di illegittimità costituzionale di norme non incriminatrici,
anche perché, tra l’altro, non ammettere una siffatta possibilità vorrebbe dire dare luogo ad una
irragionevole discriminazione tra violazioni convenzionali (cioè della CEDU), nel qual caso il
giudicato soccomb30e, e violazioni costituzionali, dove invece il giudicato di condanna sarebbe
intangibile, prevalendo le connesse esigenze di certezza.
Le Sezioni Unite Penali con la sentenza “Ercolano” n. 18821 del 7 maggio 2014 hanno infatti composto il
contrasto giurisprudenziale relativo alla sorte del giudicato penale di condanna in caso di incostituzionalità per
violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. derivante dal mancato rispetto del parametro interposto della CEDU,
accogliendo la tesi per cui in questi casi il giudicato va scardinato dal giudice dell’esecuzione.
30
10