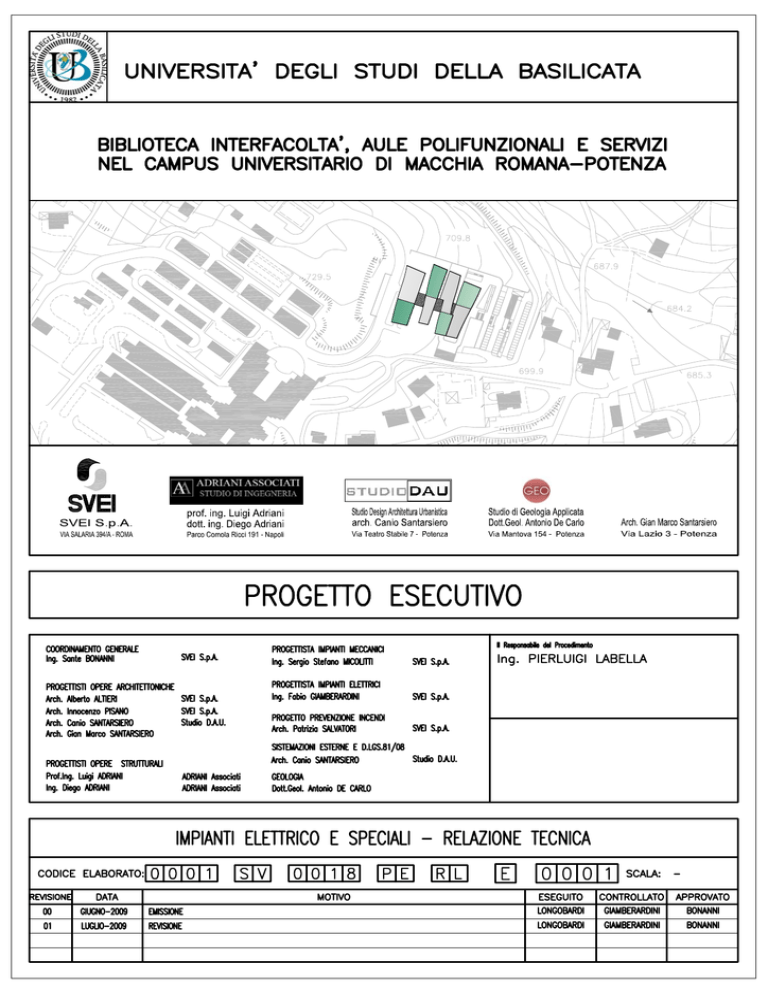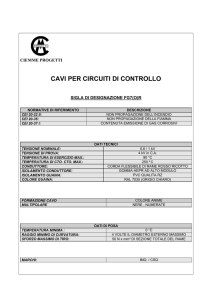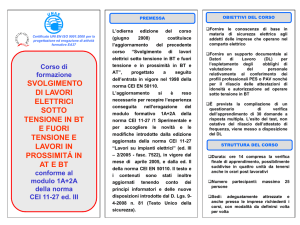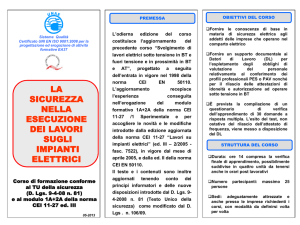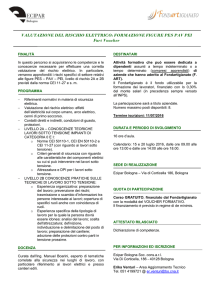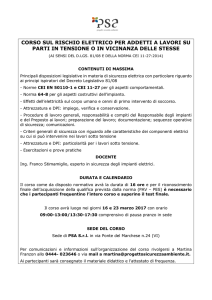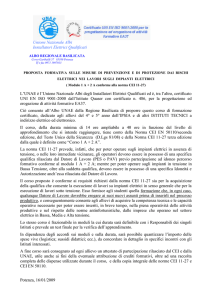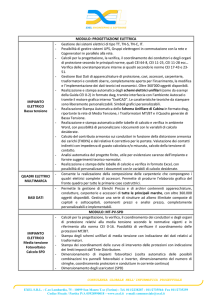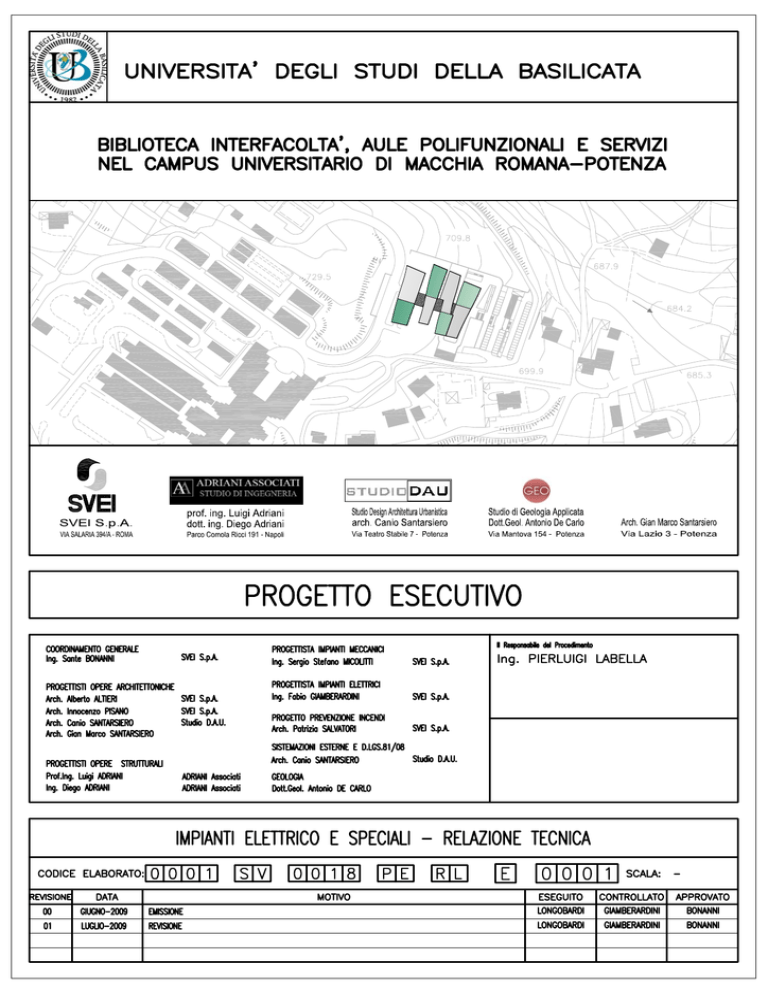
RELAZIONE TECNICA PER GLI IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
PROGETTO ESECUTIVO
1
IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.12
1.13
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.15
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
DATI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE, LEGGI E REGOLAMENTI
CARATTERISTICHE DELLE ALIMENTAZIONI
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.
DIMENSIONAMENTO DEI GENERATORI DI ENERGIA
COEFFICENTI DI UTILIZZAZIONE
DIMENSIONAMENTO DEI CIRCUITI
COEFFICIENTI DI CONTEMPORANEITA'
CADUTA DI TENSIONE
CALCOLO DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO
PROTEZIONI DELLE CONDUTTURE E DEI CIRCUITI DAI
CONTATTI DIRETTI, INDIRETTI E DAI SOVRACCARICHI
CONTATTI DIRETTI
CONTATTI INDIRETTI
SOVRACORRENTI
NORME DI CARATTERE GENERALE SULLA SCELTA E SUL
DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI
CONDUTTURE ELETTRICHE
QUADRI ELETTRICI
VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA ALL’INTERNO DEI
QUADRI ELETTRICI
DATI ILLUMINOTECNICI DI CALCOLO
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA E
COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI E COORDINAMENTO CON LE
PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DELLE
STRUTTURE CONTRO I FULMINI
PRINCIPI GENERALI
COMPONENTI DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IMPIANTO DI PROTEZIONE LPS
DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE E
SPEGNIMENTO INCENDI AUTOMATICI
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTO ELETTRICO
ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT
QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
RIFASAMENTO AUTOMATICO E FISSO
COMMUTAZIONE RETE NORMALE – RETE DI EMERGENZA
SISTEMI DI AUTOPRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE
GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'
SISTEMI AUTONOMI DI ALIMENTAZIONE AD INVERTER
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
DISTRIBUZIONE PRIMARIA
QUADRI SECONDARI DI ZONA
DISTRIBUZIONE SECONDARIA
DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
NORMALE E DI SICUREZZA
CORPI ILLUMINANTI
DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTO PRESE E FORZA
MOTRICE
2
4
6
11
11
12
12
12
13
13
15
19
19
19
21
23
23
23
26
27
28
31
32
36
37
40
49
54
54
54
55
55
56
56
56
59
59
59
59
60
60
61
62
2.6.7
2.6.8
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
IMPIANTO DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE CONTRO I
FULMINI
ILLUMINAZIONE ESTERNA
BARRIERE TAGLIAFIAMMA
RIMOZIONE DI IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI ESISTENTI
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI SPECIALI
IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO TV
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI
IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EVACUAZIONE
IMPIANTO DI CHIAMATA DISABILI
3
63
64
65
66
68
69
69
70
70
79
83
83
83
84
88
1.
DATI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE
Sono qui di seguito riportati i dati generali di progettazione, le descrizioni e la
consistenza degli impianti elettrici e speciali, relativi alla realizzazione dell’edificio
destinato a Biblioteca interfacoltà dei servizi e di un blocco polifunzionale presso il
Campus di Macchia Romana in Potenza.
L’edificio in oggetto conterrà gli ambienti destinati a svolgere le seguenti attività:
1. Locali biblioteca
2. Aule
3. Uffici
4. Mensa e cucina
5. Asilo nido
6. Locali tecnologici.
Gli impianti a cui si fa riferimento nella presente relazione e negli elaborati di
progetto allegati, sono di seguito elencati:
1) Impianto elettrico:
• Adeguamento Cabina di Trasformazione MT-BT esistente
• Quadro elettrico generale
• Sistemi di autoproduzione dell'energia elettrica
4
• Predisposizione per sistema di autoproduzione dell’energia elettrica mediante
impianto fotovoltaico
• Distribuzione dell'Energia Elettrica
• Corpi illuminanti e utenze
• Impianto di terra e collegamenti equipotenziali
• Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
• Illuminazione esterna
2) Impianti speciali:
• Impianto di cablaggio strutturato
• Impianto di rivelazione incendi
• Impianto Videocitofonico
• Predisposizione per impianto TV
• Predisposizione per Impianto di controllo accessi
• Impianto di diffusione sonora
• Impianto di chiamata disabili
Lo studio degli impianti elettrici e speciali, è stato effettuato alla luce della direttiva
del committente.
5
1.1
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE, LEGGI E REGOLAMENTI
Gli impianti ed i componenti devono rispondere alla regola dell'arte (Legge 186 del
1.3.68).
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di Legge e dei regolamenti vigenti alla data del contratto
ed in particolare devono essere conformi:
- le prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità locali;
- le prescrizioni e indicazioni del Ministero delle Telecomunicazioni, della
Telecom o dell’ente distributore per l’impianto telefonico e il cablaggio
strutturato;
- le prescrizioni del Capitolato del Ministero LL.PP.;
- le seguenti disposizioni di Legge e Norme CEI:
.CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici;
.CEI 11-1 e varianti: Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente
alternata;
.CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica.
Linea in cavo;
.CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità
collegati a reti di I e II categoria;
.CEI EN 60909-0 - CEI 11-25: Correnti di cortocircuito nelle reti trifasi a
corrente alternata – Parte 0: Calcolo delle correnti;
.CEI 11-28: Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito
nelle reti radiali a bassa tensione;
.CEI 11-35: Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d’utente;
.CEI EN 60439-1 - CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bassa tensione (quadri BT)- Parte 1: Apparecchiature soggette
a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo
(ANS);
.CEI EN 60439-3 - CEI 17-13/3 e varianti: Apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per basse tensioni (quadri BT) Parte 3:
Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD);
.CEI 17-43: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS);
6
.CEI EN 60947-4-1 - CEI 17-50: Apparecchiature a bassa tensione Parte 4-1:
Contattori e avviatori - Contattori e avviatori elettromeccanici;
.CEI 17-70: Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione;
.CEI-UNEL 35011;V1 - Cavi per energia e segnalamento - Sigle di
designazione;
.CEI 20-13 e varianti: Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni
nominali da 1 a 30 kV;
.CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non
superiore a 450/750V;
.CEI 20-38/1 e variante: Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e a
basso sviluppo di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte I Tensione nominale
Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;
.CEI 20-38/2 e variante: Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e a
basso sviluppo di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte 2 Tensione
nominale Uo/U superiore a 0,6/1 kV;
.CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi a bassa tensione;
.CEI 20-45: Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con
tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;
.CEI EN 60423 - CEI 23-26: Tubi per installazioni elettriche - Diametri esterni
dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori;
.CEI 23-31: Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e
portapparecchi;
.CEI 23-32: Sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori ad
uso portacavi e portapparecchi per soffitto e parete;
.CEI EN 60934 - CEI 23-33: Interruttori automatici per apparecchiature;
.CEI EN 50086-1 - CEI 23-39 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni
elettriche. - Parte 1: Prescrizioni generali
.CEI EN 61008-1 - CEI 23-42: Interruttori differenziali senza sganciatori di
sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali;
.CEI EN 61009-1 - CEI 23-44: Interruttori differenziali con sganciatori di
sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1:
Prescrizioni generali
.CEI EN 50086-2-4 - CEI 23-46 - Sistemi di canalizzazione per cavi
Sistemi di tubi - Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati
.CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri
di distribuzione per installazione fissa per uso domestico o similare;
7
.CEI EN 60079-10 - CEI 31-30: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive
per la presenza di gas - Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi CEI
30-38/1 e variante: Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio e a
basso sviluppo di fumi dei gas tossici e corrosivi; Parte I Tensione nominale
Uo/U non superiore a 0,6/1 kV;
.CEI EN 60079-14 - CEI 31-33: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive
per la presenza di gas Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di
esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere);
.CEI 31-35: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per
la presenza di gas - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10
(CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi;
.CEI EN 60598-1 - CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione - Parte 1:
Prescrizioni generali e prove;
.CEI EN 60598-2-22 - CEI 34-22: Apparecchi di illuminazione. Parte 2°:
Requisiti particolari. Apparecchi di illuminazione di emergenza;
.CEI EN 60099-1 – CEI 37-1: Scaricatori;
.CEI 64-7: Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari;
.CEI 64-8/1/../7: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
.CEI 64-12: Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario;
.CEI 64-50: Guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di
trasmissione dati - Criteri generali;
.CEI 64-52: Guida alla esecuzione degli impianti elettrici negli edifici scolastici;
.CEI EN 60529 – CEI 70-1 e varianti: Gradi di protezione degli involucri
(codice IP);
.CEI 79-1: Impianti antintrusione, antifurto e antiaggressione, e relative
apparecchiature;
.CEI 81-3: Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico;
.CEI EN 62305-1 - CEI 81-10/1: Protezione contro i fulmini; Parte 1: Principi
generali;
.CEI EN 62305-2 – CEI 81-10/2: Protezione contro i fulmini; Parte 2:
Valutazione del rischio;
.CEI EN 62305-3 – CEI 81-10/3: Protezione contro i fulmini; Parte 3: Danno
materiale alle strutture e pericolo per le persone;
8
.CEI EN 62305-4 – CEI 81-10/4: Protezione contro i fulmini; Parte 4: Impianti
elettrici ed elettronici nelle strutture;
.CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8 per la compatibilità elettromagnetica
(EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.
.CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti
sulla rete dal convertitore c.c./c.a.,
.CEI EN 61000-3-2 – CEI 110-31: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica
(apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
.CEI-UNEL 35024/1: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria;
.UNI EN 54-2: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio;
.UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione d'incendio;
.UNI EN 12464-1: Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in
interni;
- Legge 791 del 18.10.77: Attuazione della direttiva del consiglio delle
Comunità Europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
- Legge 186 del 1.3.68: Disposizioni concernenti la produzione dei materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrotecnici e
elettronici.
- DPR 380 del 6 Giugno 2001: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.
- Decreto Ministero Sviluppo Economico n.37 del 22 Gennaio 2008:
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici.
- DECRETO 22 ottobre 2007: Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a
servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di
servizi.
- Decreto Ministero dell’Interno 26 Agosto 1992: Norme di prevenzione incendi
per l’edilizia scolastica
- D.M. del 15.12.78: Designazione del Comitato Elettrotecnico Italiano quali
organismo italiano di normalizzazione elettrotecnico ed elettronico.
9
- D.M. del 23.07.79: Designazione degli organismi incaricati di rilasciare
certificati e marchi ai sensi della Legge 18.10.77 n.791.
- D.L. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,
concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori
pubblici;
Gli elaborati grafici dovranno essere redatti con l'uso dei "segni grafici" in accordo
alle Norme CEI.
10
1.2
CARATTERISTICHE DELLE ALIMENTAZIONI
Energia normale
L'energia normale di funzionamento dell'impianto è prelevata da una Cabina
elettrica di trasformazione esistente MT-BT di proprietà del committente avente le
seguenti caratteristiche elettriche:
Tensione nominale :
Frequenza :
Potenza di c.c. al punto di consegna :
Tempo d'intervento guasto verso terra :
Corrente di guasto a terra:
20 kV trifase
50 Hz
500 MVA
1 sec
125 A
N.B.:I valori indicati devono essere verificati dall’appaltatore presso l’ente
distributore al momento di inizio dei lavori.
Energia di riserva
L'energia elettrica di riserva è del tipo automatico, disponibile in un tempo ad
interruzione lunga, autoprodotta alla tensione nominale di 400/230V - 50 Hz trifase
più neutro con un fattore di potenza pari a cosϕ=0,8.
Energia di sicurezza
L'energia elettrica di sicurezza è di tipo automatico, con caratteristiche di continuità,
prodotta alla tensione nominale di 400/230 V - 50 Hz trifase più neutro con
cosϕ=0,8, o di 230 V - 50 Hz monofase con cosϕ=0,9; o di 24 V - 50 Hz monofase
con cosϕ=0,8.
1.3
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.
La distribuzione dell'energia normale di rete si realizza alimentando l'impianto
attraverso una cabina elettrica di trasformazione, di proprietà del committente, con
un sistema TN-S di I categoria secondo le Norme CEI 64-8 alla tensione nominale
di 400/230 V trifase più neutro - 50 Hz.
La distribuzione dell'energia di riserva, prodotta tramite un Gruppo Elettrogeno, ha
caratteristiche elettriche identiche a quelle dell’energia normale.
La distribuzione dell'energia di sicurezza prodotta mediante Gruppi Statici di
Continuità, è realizzata con un sistema TN-S di I categoria secondo la normativa
CEI 64-8 alla tensione nominale di 400/230 V-50Hz trifase più neutro o mediante
Gruppi autonomi di alimentazione ad inverter in Classe II alla tensione nominale di
230 V-50 Hz monofase.
11
1.4
DIMENSIONAMENTO DEI GENERATORI DI ENERGIA
Il dimensionamento dei Trasformatori, è effettuato considerando la sommatoria del
carico contemporaneo medio.
Il dimensionamento del Gruppo Statico di Continuità, è effettuato considerando la
sommatoria del carico contemporaneo medio.
Il dimensionamento dei Gruppi autonomi di alimentazione ad inverter, è effettuato
considerando la potenza nominale di targa dell'utenza da alimentare.
1.5
COEFFICENTI DI UTILIZZAZIONE
I coefficienti di utilizzazione applicati alle potenze nominali di targa delle utenze, per
il calcolo della potenza media utilizzata, sono qui di seguito enunciati:
Corpi Illuminanti: Ku = 1
da applicarsi alla potenza nominale di targa del corpo illuminante, comprensivo
della potenza assorbita dall'eventuale reattore, con un cosϕ=0,9.
Presa bipasso 2x10/16A+T/230V : Ku = 0,08
con un cosϕ=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x230x0,9x0,08 ≅ 250 W
Presa UNEL o Universale 2x10/16A+T/230V : Ku = 0,08
con un cosϕ=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x230x0,9x0,08 ≅ 250 W
Presa modulare interbloccata 2x10/16A+T/230V : Ku = 0,35
con un cosϕ=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x230x0,9x0,35 ≅ 1.200 W
Presa 2x16A+T/230V tipo CEE : Ku = 0,5
con un cosϕ=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x230x0,9x0,5 ≅ 1.500 W
Presa 3x16A+N+T/400V tipo CEE : Ku = 0,3
con un cosϕ=0,9; per una potenza media utilizzata per ogni presa pari a:
16x√3x400x0,9x0,3 ≅ 3.000 W
Per l'alimentazione di utenze specifiche si prevederà un coefficiente di utilizzazione
uguale a Ku = 1, pari quindi alla potenza nominale di targa dell’apparecchiature.
1.6
DIMENSIONAMENTO DEI CIRCUITI
Le sezioni dei conduttori e dei cavi sono determinate in base ai seguenti criteri:
- portata nominale della corrente del cavo o del conduttore “Iz”
- corrente assorbita dal carico del circuito “Ib”
- energia specifica passante nel cavo o nel conduttore
- caduta di tensione
- caratteristiche di posa della linea.
12
I circuiti che alimentano le linee luce, prese e FM, uscenti dai Quadri secondari di
zona, sono dimensionati così come di seguito prescritto:
Il carico per ogni Circuito Luce, al quale viene applicato il coefficiente di
contemporaneità, non potrà essere superiore a 2.000 W.
Il carico per ogni Circuito Prese, al quale viene applicato il coefficiente di
contemporaneità, non potrà essere superiore a 3.000 W.
Il carico per ogni Circuito Forza Motrice, al quale viene applicato il coefficiente di
contemporaneità, non potrà essere superiore a 3.000 W.
Per carichi superiori a 3.000 W e per linee che alimentano utenze specifiche, sono
previsti degli appositi circuiti.
Inoltre devono essere protette singolarmente le seguenti utenze:
- le derivazioni all'esterno;
- le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezion fatta per quelli umidi;
- i motori;
- le prese a spina per l'alimentazione di utenze specifiche.
1.7
COEFFICIENTI DI CONTEMPORANEITA'
I coefficienti di contemporaneità, applicati ai circuiti che alimentano le utenze e ai
quadri o sezioni di questi, per il calcolo della potenza contemporanea media, sono
qui di seguito riportati in questa tabella:
UTENZE
NORMALE
RISERVA
SICUREZZA
Linea Luce
Linea Prese
Linea FM
Linea Utenze
1,0
0,5
0,5
1
1,0
0,5
0,5
1
1,0
0,5
0,5
1
QUADRI
Sezione Luce
Sezione FM
Quadro di Zona
QGBT
1
0,7
1
0,6
1
0,7
1
0,8
1
0,7
1
1
1.8
CADUTA DI TENSIONE
I valori unitari di resistenza e reattanza utilizzati per il calcolo delle cadute di
tensione sono tratti dalla normativa UNEL 35012-70.
La formula utilizzata per il calcolo della c.d.t. è la nota relazione approssimata:
Δv = VP − VF = K ⋅ I ⋅ ( R ⋅ cos ϕ + X ⋅ senϕ )
Dove:
Δv = è la caduta di tensione
13
VP = è la tensione ad inizio linea di carico
VF = è la tensione ad fine linea di carico
K = è un coefficiente che vale “1” se la linea è trifase e vale “2” se la linea è
monofase.
Ovvero la nota relazione approssimata:
Δv% = K ⋅
RP + XQ
V2
Δv% = è la caduta di tensione percentuale
R = è la resistenza di linea
X = è la reattanza di linea
P = è la potenza attiva di linea di arrivo
Q = è la potenza reattiva di linea di arrivo
V = è la tensione di esercizio
K = è un coefficiente che vale “1” se la linea è trifase e vale “2” se la linea è
monofase.
Questa relazione pone in evidenza l’influenza che la potenza reattiva ha sulla c.d.t.
Dai morsetti dei Trasformatori o dei Generatori di Energia, considerati il punto di
origine dell'energia, fino ad una qualsiasi utenza, il valore della caduta di tensione
non deve superare il 4% (CEI 64-8.525).
Pertanto si hanno le seguenti cadute di tensione, previste nella suddivisione
funzionale dell'impianto:
- dai Trasformatori al QGBT : 0,5%
- dal QGBT ai Quadri secondari di zona : 1%
- dai Quadri secondari di zona alle Utenze Prese o Luce : 1,5%
- dal QGBT ai Quadri Ascensori : 2%
- dal QGBT ai Quadri delle Centrali Tecnologiche : 2%
La maggior parte degli apparecchi utilizzatori sia per il servizio di illuminazione che
di forza motrice tollerano fluttuazioni della tensione di esercizio del +/-10%. Le
apparecchiature elettroniche (televisori, PC, ecc.) che non potrebbero sopportare
tale variazioni di tensione sono normalmente dotati di uno stabilizzatore elettronico
di tensione incorporato che forniscono tensioni ben regolate (entro il +/-0,5-1%) con
scarti della tensione di alimentazione fino al +/-15%. Tali apparecchiature in altri
casi sono alimentate da circuiti di sicurezza (gruppi statici di continuità).
14
1.9
CALCOLO DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO
Il calcolo delle correnti di corto circuito, trifase, bifase e monofase è indispensabile
per un corretto dimensionamento dell'impianto ed in particolar modo per la scelta
dei quadri elettrici, dei loro componenti e del potere d'interruzione da adottare per gli
interruttori.
Il calcolo teorico, effettuato in accordo alle prescrizioni delle norme CEI 11-25 e CEI
11-28, determina le correnti relative ai diversi tipi di corto circuito.
Il calcolo delle correnti di corto circuito è possibile realizzarlo, qualsiasi sia la
complessità della rete in esame, applicando il metodo dei componenti simmetrici,
che permette di ricondurre qualsiasi terna di vettori tra di loro squilibrati e
dissimmetrici, in modulo e fase, a dei valori tra loro simmetrici.
Data pertanto una terna di vettori Za, Zb, Zc, valgono per questi, le seguenti
relazioni:
1
⋅ (Z a + Z b + Z c )
3
1
Z a1 = ⋅ (Z a + a ⋅ Z b + a 2 ⋅ Z c )
3
1
Z a2 = ⋅ Z a + a 2 ⋅ Z b + a ⋅ Z c
3
Z a0 =
(
inoltre:
)
sequenza omopolare
sequenza diretta
sequenza inversa
Z a = Z a1 + Z a 2 + Z a 0
Z b = a 2 ⋅ Z a1 + a ⋅ Z a 2 + Z a 0
Z c = a ⋅ Z a1 + a 2 ⋅ Z a 2 + Z a 0
E' possibile allora, ricavarsi gli schemi dei circuiti equivalenti, alla sequenza diretta,
inversa, ed omopolare.
Si ricorda che la rete alla sequenza diretta è indicata nelle normali reti considerate
usualmente simmetriche, in esse le resistenze e le reattanze dei componenti hanno
i valori normalmente noti e ogni macchina sincrona, viene considerata come una
sorgente di f.e.m.; la rete alla sequenza inversa è molto simile a quella della
sorgente positiva: è identica per quanto riguarda il numero di rami e i valori delle
impedenze, ma non comprende sorgenti di f.e.m., in quanto nelle macchine
sincrone si generano soltanto tensioni alla sequenza positiva; la rete alla sequenza
omopolare è anch'essa priva di generatori di f.e.m., ma le sue impedenze sono
differenti da quelle delle reti alle sequenze diretta ed inversa, infatti in questo caso
le impedenze dei componenti dipendono dal tipo di collegamento dei loro
avvolgimenti interni.
Le formule che ci permettono di calcolare le correnti di corto circuito nei vari tipi di
guasto da considerare in un sistema trifase sono:
corto circuito monofase:
IccM =
3 ⋅U
Z 1 + Z 2 + Z 0 + 3Z
15
dove:
IccM : corrente di corto circuito di guasto su una fase (A)
U
: tensione nominale concatenata nel punto di guasto (V)
Z1
: impedenza alla sequenza diretta (ohm)
Z2
: impedenza alla sequenza inversa (ohm)
Z0
: impedenza alla sequenza omopolare (ohm)
Z
: impedenza che eventualmente si interpone tra il punto di guasto e la terra
(ohm)
corto circuito bifase isolato:
IccBI =
− jU
Z1+Z 2+Z
dove:
j
: operatore che ruota di 90° il vettore in senso antiorario [in forma
trigonometrica vale (cos 90°+j sen 90°)].
corto circuito bifase con terra:
IccBT =
− jU ⋅ (3Z + Z 0 − aZ 2 )
3Z ( Z 1 + Z 2 ) + Z 1 ⋅ Z 2 + Z 1 ⋅ Z 0 + Z 2 ⋅ Z 0
dove:
a
: operatore che ruota di 120° il vettore in senso antiorario ( in forma
trigonometrica vale (cos 120° + jsen 120°)= -0,5+j0,866 )
corto circuito trifase:
Icc =
U
3 ⋅ (Z1 + Z )
Calcolo delle correnti di corto circuito in una rete BT
E' possibile calcolare la corrente di corto circuito presunta trifase, bifase e monofase
in un qualsiasi punto dell’impianto in bassa tensione, tenendo presente che in
questo caso, è possibile assumere il contributo dato alla sequenza omopolare, ai fini
del calcolo, pari a quella della sequenza diretta ed inversa.
La corrente di corto circuito trifase presunta è data dalla relazione approssimata:
I cc =
3⋅
(R
U
+ Rt + Rc1 + Rc 2 + .. + Rcn ) + (X q + X t + X c1 + X c 2 + .. + X cn )
2
q
2
+ I km
dove:
U
: tensione nominale concatenata nel punto di guasto (V)
Rq
: resistenza equivalente del generatore ideale all’origine dell’impianto (ohm)
Rt
: resistenza del trasformatore (ohm)
Rc
: resistenza del tratto di linea (ohm)
Xq
: reattanza equivalente del generatore ideale all’origine dell’impianto (ohm)
16
Xt
Xc
: reattanza del trasformatore (ohm)
: reattanza del tratto di linea (ohm)
Ikm
: contributo dato dai motori asincroni alla corrente di c.c.
In questa relazione tutte le impedenze della rete sul lato alta tensione sono
ricondotte al livello bassa tensione. Ciò si ottiene per mezzo del rapporto di
trasformazione nominale tr, dalla relazione:
tr =
Un
U
dove:
tr
: rapporto di trasformazione nominale tra la tensione base di riferimento e
quella relativa alla tensione nel punto in esame
Un
: è la tensione nominale concatenata di esercizio nel punto in esame della rete
(kV)
U
: è la tensione nominale concatenata di riferimento (kV)
Inoltre:
cos ϕcc =
dove:
cos cc
Rq + Rt + Rc1 + Rc 2 + .. + Rcn
Z q + Z t + Z c1 + Z c 2 + .. + Z cn
: coseno dell’angolo della corrente di c.c.
Il valore di cresta Ip desunto dalla norma CEI 11-25 e CEI 11-28 della corrente di
corto circuito è pari a:
I p = k ⋅ 2 ⋅ I cc
dove:
k ≅ 1,02 + 0,98 ⋅ l
− 3*
R
X
ed inoltre:
Rq + Rt + Rc1 + Rc 2 + .. + Rcn
f
R
* c
=
X
X q + X t + X c1 + X c 2 + .. + X cn f n
dove:
fc
: frequenza della sorgente equivalente pari a 20Hz
fn
: frequenza della rete pari a 50Hz
per la corrente di corto circuito bifase isolato si ha:
I ccB =
2⋅
(R
U
+ Rt + Rc1 + Rc 2 + .. + Rcn ) + (X q + X t + X c1 + X c 2 + .. + X cn )
2
q
ovvero:
17
2
I ccB = I cc ⋅
3
2
per la corrente di corto circuito monofase in un sistema TN si ha:
I ccM =
3⋅
(R
U
+ Rt + Rc1 + Rc 2 + .. + Rcn + R PE ) + (X q + X t + X c1 + X c 2 + .. + X cn + X PE )
2
q
2
dove:
Rpe : resistenza del conduttore di protezione
Xpe : reattanza del conduttore di protezione
Per il calcolo della corrente minime di guasto di corto circuito si ha:
I cc ( MIN ) =
3⋅
(R
U
qm
+ Rt + 1,5 Rc1 + 1,5 Rc 2 + .. + 1,5 Rcn
) + (X
2
+ X t + X c1 + X c 2 + .. + X cn )
2
qm
dove: Rqm, Xqm vanno calcolati assumendo il valore di "c" pari a 0,95 per valori di
tensione fino a 400V, da 400V a 1000V vale 1,00, per valori compresi tra 1 kV e 35
kV vale 1,00 e per valori compresi da 35 kV a 380 kV vale 1,00.
18
1.10
PROTEZIONI DELLE CONDUTTURE E DEI CIRCUITI DAI CONTATTI
DIRETTI, INDIRETTI E DAI SOVRACCARICHI
I conduttori che costituiscono l'impianto devono essere protetti contro le
sovracorrenti causate dai sovraccarichi e dai contatti diretti e indiretti (corto circuiti ).
I concetti che qui di seguito si espongono sono in accordo alla Norma CEI 64-8.
1.10.1
CONTATTI DIRETTI
La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le
persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive del sistema. I
componenti accessibili, salvo quelli che si trovano in locali o luoghi riservati
esclusivamente a personale addestrato, devono avere una protezione totale dai
contatti diretti.
Gli isolamenti impiegati devono essere idonei alle tensioni del sistema elettrico e in
grado di sopportare gli sforzi meccanici derivanti dal normale impiego. Le parti
attive devono essere poste entro contenitori in grado di garantire la protezione in
tutte le direzioni o dietro barriere interposte lungo la direzione di accessibilità. In
entrambi i casi deve essere assicurato un grado di protezione minimo IP2X nel caso
che le parti attive non siano a portata di mano, mentre dovranno avere un grado di
protezione minimo IP4X nel caso queste siano a portata di mano come da Norma
CEI 70-1, o con un isolamento capace di sopportare una tensione di prova pari a
500V in corrente alternata per un minuto.
In condizioni ambientali ordinarie, la protezione contro i contatti diretti si ritiene
assicurata, anche se le parti attive sono nude, soltanto se la tensione nominale non
supera i 25V valore efficace in corrente alternata o 60V in corrente continua.
Gli involucri o le barriere poste a protezione dai contatti diretti potranno essere
rimosse soltanto con una delle seguenti disposizioni:
- mediante l'uso di una chiave o di un attrezzo;
- mediante l'apertura con interblocco e sezionamento delle parti attive oggetto della
protezione;
- mediante l'interposizione di una barriere intermedia con grado di protezione IP2X.
L'impiego degli interruttori differenziali, con correnti differenziali nominali non
superiori a 30mA, sono da considerarsi come protezioni addizionali.
1.10.2
CONTATTI INDIRETTI
La protezione contro i contatti indiretti, consiste nel prendere le misure intese a
proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che
normalmente non sono in tensione ma che lo possono essere in caso di cedimento
dell’isolamento principale.
I sistemi di protezione da assumersi in questo caso possono dividersi in due
categorie:
- Protezioni senza interruzioni automatica del circuito;
- Protezioni con interruzione automatica del circuito.
La prima categoria può a sua volta suddividersi nei seguenti tipi di protezioni:
- Protezioni con l'impiego di componenti di Classe II o con un isolamento
equivalente.
19
- Protezioni a bassissima tensione di sicurezza SELV: la tensione in questo caso
non supera il valore di 50V in corrente alternata e di 120V in corrente continua, (
per locali adibiti ad uso medico il valore della tensione deve essere di 25V in
corrente alternata e 60V in corrente continua). La separazione elettrica è ottenuta
mediante un trasformatore di isolamento o di una sorgente equivalente; (nei
locali per chirurgia il trasformatore d’isolamento deve avere un limite di potenza
di 10 kVA, per contenere la corrente di dispersione).
La protezione con interruzione automatica del circuito è di gran lunga la più usata
negli impianti utilizzatori in bassa tensione.
Per la sua realizzazione si adottano organi di protezione (quali interruttori automatici
di massima corrente a tempo inverso, differenziali o fusibili) e di impianti
equipotenziali di terra.
Questo mezzo è sicuro però soltanto se realizzato con corretti criteri di scelta dei
materiali e del loro dimensionamento, altrimenti non soltanto perde la sua efficacia
ma può diventare fonte di pericolo.
- Protezioni in sistemi di I Categoria con propria Cabina di trasformazione, sistema
TN.
Per questi sistemi con propria cabina di trasformazione nei quali il neutro è
connesso a terra e fa parte del medesimo impianto di terra al quale saranno
collegate tutte le masse e le masse estranee dell'impianto si ha dall'analisi del
circuito equivalente di guasto per il rapporto Uo/Vcu quanto segue:
⎛ Zf
U0
= 1+ ⎜
⎜Z
Vcu
⎝ pe
⎞
⎟
⎟
⎠
dove Zf è l'impedenza del conduttore di fase e Zpe è l'impedenza del conduttore di
protezione.
Il circuito di guasto in questo caso si comporta come un generatore ideale di
tensione: il contatto della persona non altera la tensione preesistente sulla massa.
Il rapporto Uo/Vcu cresce e quindi il pericolo diminuisce al diminuire della resistenza
del conduttore di protezione PE.
Anche in questo caso pur potendo nella migliore delle ipotesi dimensionare un
conduttore di protezione con un valore di impedenza pari a quella del conduttore di
fase non potrà realizzarsi la condizione che assicuri una limitazione alla tensione di
sicurezza.
Nei sistemi TN è indispensabile l'installazione di dispositivi automatici
atti ad interrompere le correnti di guasto.
La condizione che deve essere verificata e che nasce dalla relazione sopra vista è
data da:
Z S ⋅ I a (t ) ≤ U 0
dove:
Uo : è la tensione nominale in c.a. valore efficace tra fase e terra;
Zs : è l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore
attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la
sorgente;
20
Ia(t):è la corrente di intervento, entro il tempo definito dalla tabella che segue
secondo la Norma CEI 64-8 (nel caso Uo=230 V t=0,4 s) del dispositivo di
protezione; tempi di interruzione pari a 5 s sono ammessi per i circuiti di
distribuzione.
Tempo di
interruzione
(sec)
0,8
0,4
0,2
0,1
Uo(V)
120
230
400
>400
Ne consegue che indipendentemente dall'impedenza di terra, la protezione contro le
tensioni di contatto può essere effettuata con la installazione di dispositivi di
massima corrente a tempo inverso.
Questo finora visto è il caso di un guasto franco a terra, senza interposizioni di
ulteriori resistenze tra la fase e il conduttore di protezione. Nel caso si frapponga
una resistenza, il guasto potrebbe determinare una corrente di sovraccarico
insufficiente a far intervenire tempestivamente l'interruttore magneto-termico.
Anche in questo caso può risultare necessario lo utilizzazione degli interruttori
differenziali, tenendo presente che ciò è possibile solo nel caso di sistema TN-S.
1.10.3
SOVRACORRENTI
I conduttori devono essere scelti in modo tale che le loro portate Iz siano superiori
alle correnti di impiego.
Le apparecchiature di protezione da installare devono avere correnti nominali In
comprese fra le correnti di impiego dei conduttori Ib e le loro portate nominali Iz e
correnti funzionali If minori o uguali a 1,45 volte le portate Iz.
Devono essere pertanto soddisfatte le due relazioni:
Ib ≤ In ≤ IZ
I f ≤ 1,45 ⋅ I Z
Le apparecchiature di protezione, inoltre, devono interrompere le correnti di corto
circuito che possono verificarsi nell'impianto, in tempi sufficientemente brevi, al
massimo 5 secondi, per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano
temperature pericolose secondo la relazione:
I 2 ⋅t ≤ K 2 ⋅ S2
dove:
I2t
: è l’integrale di Joule per la durata del corto circuito
K2S2 : è l’energia specifica passante nel cavo.
I
: valore efficace della corrente di corto circuito (A)
t
: tempo d’intervento del dispositivo di protezione (sec)
K
: fattore che tiene conto delle caratteristiche del conduttore
S
: sezione del conduttore (mm2)
Il fattore K può essere determinato in base alla CEI 64-8, con la relazione seguente:
21
K=
Qc ⋅ ( B + 20)
ρ
⎛ ϑ f − ϑo
⋅ ln⎜⎜1 +
B + ϑo
⎝
⎞
⎟⎟
⎠
dove:
Qc
:
B
:
ρ
:
θo
θf
:
:
capacità termica per unità di volume del materiale conduttore (J/°C mm3);
per il rame vale 3,45*10-3
inverso del coefficiente di temperatura della resistività a 0°C per il
conduttore (°C); per il rame vale 234,5
resistività elettrica del materiale del conduttore a 20°C (Ω mm); per il rame
vale 17,241*10-6
temperatura iniziale del conduttore (°C)
temperatura finale del conduttore (°C)
Per i corto circuiti di durata non superiore a 5 secondi, il tempo t necessario
affinché una data corrente di cortocircuito porti i conduttori dalla
temperatura massima ammissibile in servizio ordinario alla temperatura
limite può essere calcolato, in prima approssimazione, con la formula:
⎛S⎞
t = K ⋅⎜ ⎟
⎝I⎠
dove:
I
:
corrente effettiva di corto circuito espressa in valore efficace (A)
Materiale
isolante
T
PVC
Gomma
ordinaria
Gomma
butilica
EPR XLPE
Servizi
o
Ordinar
io
T
70°C
60°C
Corto
Circuito
K
160°C
200°C
115
135
85°C
220°C
135
90°C
250°C
143
Si verifica infine che la corrente di corto circuito per guasto franco all'estremità della
conduttura più lontana dal punto di alimentazione sia superiore alla corrente di
intervento istantaneo dell'interruttore di protezione. E' possibile verificare pertanto la
massima lunghezza protetta impostando la seguente relazione:
⎛ f ⋅ Uo ⋅ S
L = ⎜⎜
⎝ v ⋅ z ⋅ ρ ⋅ 2 ⋅ Im
dove:
L
:
lunghezza protetta (m)
22
⎞ ⎛ 2 ⋅ Sn ⎞
⎟⎟ ⋅ ⎜⎜
⎟⎟ ⋅ c
⎠ ⎝ (n ⋅ S ) + Sn ⎠
f
:
Uo
S
Sn
v
:
:
:
:
z
:
ρ
:
Im
n
c
:
:
:
fattore che tiene conto del presumibile abbassamento della tensione nel
punto di allaccio per effetto del corto circuito pari a 0,8
tensione tra fase e terra (V)
sezione del conduttore mm²
sezione del conduttore di neutro mm² se presente
fattore che tiene conto dell'aumento di temperatura durante il corto circuito
pari a 1,5
fattore che tiene conto del valore di tolleranza ammesso dalla normativa
sulla corrente d'intervento degli sganciatori pari a 1,2
resistività specifica del materiale conduttore a 20°C (Ωmm²/m); per il rame
è pari 0,018.
valore della corrente d'intervento dello sganciatore (A)
numero di conduttori per fase
fattore che tiene conto del valore della reattanza per cavi di sezione
superiore a 95 mm²; c=0,9 per 120 mm²; c=0,85 per 150 mm²; c=0,80 per
185 mm²; c=0,75 per 240 mm²
Inoltre i dispositivi di protezione devono avere un potere d'interruzione almeno
uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto d'installazione o una
protezione del tipo di back-up.
1.11
NORME DI CARATTERE GENERALE SULLA SCELTA E SUL
DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI
1.11.1
CONDUTTURE ELETTRICHE
I conduttori e i cavi sono in genere del tipo non propagante l'incendio a ridotta
emissione di gas tossici e corrosivi.
I conduttori sono posati in tubazioni rigide o flessibili pesanti di PVC
autoestinguente o in canaline di PVC autoestinguente o di acciaio zincato chiuse o
forate; per queste ultime sono necessari collegamenti equipotenziali.
Il riempimento delle tubazioni previsto è al massimo pari al 70% della loro sezione
totale, mentre per le canaline è del 50%.
1.11.2
QUADRI ELETTRICI
I quadri elettrici sono dimensionati in accordo alle prescrizioni date dalle Norme CEI
17-13/1 e 17-13/3.
Per essi devono essere definite le caratteristiche elettriche e meccaniche al fine di
stabilirne i limiti per un corretto e sicuro impiego e precisamente:
Ue
tensione nominale di funzionamento: definita come la tensione tra le fasi
per la quale bisogna indicarne i limiti (massimo e minimo di impiego);
f
Ui
frequenza di esercizio della rete
tensione nominale d'isolamento: definita come la tensione alla quale si fa
riferimento ai fini delle distanze di isolamento e delle prove di rigidità
dielettrica;
23
In
correnti nominali: sono le correnti fissate per il funzionamento corretto di
ciascun circuito, senza che le sovratemperature delle diverse parti superino i
seguenti valori:
morsetti 70 °C
organi di comando manuali 15 °C se metallici
organi di comando manuali 25 °C se isolati
involucri e coperture 30 °C se metallici
involucri e coperture 40 °C se isolati
In particolare è di fondamentale importanza indicare la corrente nominale per
la quale sono dimensionate le sbarre principali e le sbarre di distribuzione o i
conduttori principali e di distribuzione del quadro.
Ine corrente nominale in entrata: si intende la corrente nominale del dispositivo di
protezione o di manovra in entrata “In” moltiplicato per il fattore di utilizzo pari
a 0,85; si ha: Ine=In*0,85;
Inu
corrente nominale in uscita: si intende la somma delle correnti nominali dei
dispositivi di protezione e di manovra dei circuiti in uscita, destinati ad essere
utilizzati contemporaneamente;
Inq
corrente nominale del quadro: si assume il valore più basso tra la corrente
nominale in entrata e la corrente nominale in uscita; nel caso particolare che
non esista un dispositivo di protezione o di manovra in entrata, si assume
Inq=Inu;
Icw
corrente di breve durata ammissibile: sono le correnti transitorie massime
(valore efficace) che ciascun circuito può sopportare, per brevi tempi definiti (1
sec); nel caso che il circuito non sia munito di dispositivo di protezione è
necessario verificare ed indicare l'intensità e la durata della corrente;
Icm corrente nominale di picco ammissibile: sono le correnti transitorie massime di
picco che ciascun circuito può sopportare; a questa grandezza corrisponde
per i componenti il potere di chiusura nominale in corto circuito (valore di
cresta);
Icu
corrente di corto circuito nominale ammissibili: sono le correnti presunte di
corto circuito massime ammissibili dell'apparecchiatura assiemata; a questa
corrisponde per le apparecchiature il potere di interruzione nominale limite in
corto circuito;
Ics
corrente di corto circuito nominale condizionata: sono le correnti presunte di
corto circuito che possono stabilirsi in un circuito protetto da dispositivo, che
interrompono in tempi e modalità tali da assicurarne la tenuta agli sforzi
termici ed elettrodinamici; a tale grandezza corrisponde il potere di
interruzione nominale di servizio in corto circuito;
Tipo e numero di identificazione dei circuiti;
TN-S,TN-C,TT,IT: sistema di messa a terra
Forma tipo di segregazione in base alla norma CEI 17-13/1
Misure di protezione per le persone dai contatti diretti e indiretti
24
IPXX Grado di protezione del quadro
Verifica dei limiti di sovratemperatura
Dimensioni e peso del quadro elettrico
Le caratteristiche viste sopra sono quelle che vanno riportate sul quadro come
"DATI DI TARGA" insieme al nome del costruttore.
I circuiti che alimentano le utenze luce e FM, sono protetti contro i sovraccarichi e i
contatti indiretti da interruttori magnetotermici differenziali, correttamente
dimensionati per la corrente di corto circuito Ics nel punto in analisi dell'impianto e
coordinati con l'impedenza dell'anello di guasto di terra.
Le utenze di Classe II sono protette con interruttori magnetotermici.
Gli interruttori generali dei Quadri secondari di zona che raggruppano sezioni luce
e/o prese e FM, sono di tipo non automatico. A monte degli interruttori sono previste
delle lampade spia complete di fusibili.
Gli interruttori che proteggono circuiti di sicurezza sono sovradimensionati del 50%
riguardo ai sovraccarichi.
Gli interruttori del Quadro Generale di Bassa Tensione che sono a protezione delle
linee che alimentano i Quadri secondari di zona sono di tipo fisso scatolato
magnetotermico con attacchi posteriori e con sganciatore elettronico, completi di
contatti ausiliari.
Gli interruttori generali del Quadro Generale di Bassa Tensione sono di tipo
magnetotermico dimensionati in modo da essere a protezione dei generatori di
energia elettrica, completi di contatti ausiliari.
I circuiti ausiliari di alimentazione sono protetti mediante un sezionatore di manovra
con fusibile.
Le macchine rotanti, direttamente alimentate sono protette mediante il
coordinamento di un interruttore solo magnetico coordinato con un contattore ed un
relè termico di protezione dai sovraccarichi; completi di contatti ausiliari e di tre
lampade di segnalazione (marcia, arresto, scattato termico).
Tutti gli interruttori sono dimensionati in modo tale da sopportare la corrente di corto
circuito Ics, nel punto preso in analisi, così come previsto dalle Normative CEI e
IEC.
Gli interruttori inoltre, sono dimensionati in modo da realizzare una protezione di
tipo selettivo; nel caso ciò non sia possibile, dovrà in ogni caso verificarsi una
protezione di back-up.
25
1.11.3
VERIFICA DELLA SOVRATEMPERATURA
QUADRI ELETTRICI
ALL’INTERNO
DEI
E’ necessario verificare, in accordo alle Norme CEI 17-13/1 per quel che riguarda i
quadri di tipo AS e ASN e CEI 23-51 per i quadri di tipo ASD, che le temperature
all’interno dei quadri elettrici non superino valori pericolosi e che gli involucri siano
capaci di smaltire il calore generato dai componenti in esso installati.
La Norma CEI EN 60439-1 prescrive, tra le prove di tipo, la prova di riscaldamento.
E' comunque permesso, per alcuni tipi di assieme per cui è difficile e non
economicamente giustificabile eseguire la prova di riscaldamento, effettuare un
calcolo delle sovratemperature mediante estrapolazione dei dati risultanti dalle
prove effettuate su altri sistemi. Tali assiemi sono quindi denominati
"apparecchiature non di serie" (ANS). I fattori ed i coefficienti utilizzabili sono stati
dedotti da misure effettuate su numerose apparecchiature e la validità del metodo è
stata verificata mediante confronto con i risultati di prova. Pertanto il metodo
utilizzato è uno dei possibili metodi e può essere usato per la verifica della
conformità ai requisiti di cui al par. 8.2.1. della Norma CEI EN 60439-1.
Il metodo di calcolo proposto è scrupolosamente conforme alla Norma CEI 17-43
applicabile ad ANS chiuse in involucri o a scomparti separati senza ventilazione
forzata; per il calcolo con ventilazione forzata ci si attiene alle indicazioni della
norma CEI EN 60439-1. Alla temperatura di regime l'influenza dei materiali e lo
spessore delle pareti abitualmente adottate per gli involucri, è trascurabile.
26
1.12
DATI ILLUMINOTECNICI DI CALCOLO
I calcoli illuminotecnici sono effettuati in accordo alla normativa UNI EN 12464-1.
I valori di illuminamento medio previsti nei singoli ambienti sono non inferiori a quelli
indicati in tabella.
In accordo a quanto prescritto dalla su citata norma, per l'uniformità
dell'illuminamento, è previsto un rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio,
nel locale e nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo
(piano di riferimento), non minore a 0,7.
Nelle aree di un locale di lavoro, che non sono sede del compito visivo, il valore
medio dell'illuminamento non deve essere mai minore di 2/3 del valore medio
dell'illuminamento nella zona sede del compito visivo.
Nel caso di locali adiacenti alla zona del locale dove si svolge un determinato
compito visivo, l’uniformità dell’illuminamento non deve essere minore a 0,5.
Il valore dell'illuminamento è calcolato ad una altezza del piano di lavoro pari a
0,8m.
Per l'illuminazione di sicurezza e l'illuminazione stradale il valore viene calcolato alla
quota di calpestio.
Per il calcolo dei valori di illuminamenti sono assunti i seguenti coefficienti:
- Coefficienti di riflessione mediati:
Soffitto
: 70%
Pareti
: 30%
Pavimento : 10%
I fattori di manutenzione, dovuto all'impolveramento degli apparecchi ed il
deprezzamento della lampada dovuto al suo naturale invecchiamento sono estratti
dalla normativa UNI per cicli manutentivi di 12 mesi.
- Fattore di deprezzamento ordinario: 0,8
- Fattore di manutenzione: 0,8
Il calcolo d'illuminamento è stato effettuato con il metodo del calcolo del flusso totale
e del calcolo punto-punto.
ILLUMINA –
MENTO
MEDIO
ABBAGLIA MENTO
RESA DI
COLORE
Em (lx)
500
200
200
200
200
200
500
200
300
500
500
20
5
50
UGRL
19
22
22
22
22
25
22
25
22
19
19
22
Ra
80
80
80
80
80
60
80
80
80
80
80
20
80
TIPO DI LOCALE
Uffici
Servizi WC
Scale e corridoi
Atri
Mensa e Bar
Centrali tecnologiche
Cucina
Deposito
Soggiorno e Sale
Biblioteca
Aula
Illuminazione esterna
Luce di sicurezza
Luce notturna
27
dove:
Em: Illuminamento medio mantenuto – Valore al di sotto del quale l’illuminamento
medio, su di una specifica superficie, non può mai scendere.
UGRL: Abbagliamento molesto, direttamente prodotto dagli apparecchi di un
impianto di illuminazione di interni, deve essere valutato utilizzando il metodo
gabellare CIE dell’indice unificato di abbagliamento UGR.
Ra: Resa di colore, fornisce un’indicazione obiettiva delle proprietà di una sorgente
luminosa. Questo valore diminuisce al diminuire della qualità della resa di colore.
1.13
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI
EQUIPOTENZIALI E COORDINAMENTO CON LE PROTEZIONI
CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI
L'impianto di terra previsto è stato dimensionato in base ai criteri delle Norme CEI
64-8, CEI 64-12 e CEI 11-1.
L'impianto di terra è stato calcolato e dimensionato coordinandolo con gli organi di
protezione, in modo da limitare il valore della tensione di contatto in caso di guasto
o di cedimento dell'isolante principale al valore di sicurezza di 50V.
Il calcolo della rete di dispersione terrà conto del contributo dato dalla corda di
rame, ad intimo contatto con il terreno e dei picchetti dispersori, oltre al dispersore
naturale costituito dai ferri delle armature di fondazione.
Il contributo dato dall’elemento dispersore orizzontale costituito dalla corda di rame
nudo sarà data dalla seguente relazione:
Rto =
Rto
ρ
r
a
s
⎡ ⎛ 8r ⎞
ρ
⎛ 8r ⎞⎤
⋅ ⎢ln⎜ ⎟ + ln⎜ ⎟⎥
2
4 ⋅π ⋅ r ⎣ ⎝ a ⎠
⎝ 2 s ⎠⎦
: resistività teorica della corda disperdente
: resistività del terreno espresso in ohm/m
: raggio equivalente dell'anello in m
: raggio del conduttore dispersore in m
: profondità di posa nel terreno m
dove:
b2 +h2
r=
2
b
h
: lato maggiore dell'anello dispersore in m
: lato minore dell'anello dispersore in m
Il contributo dato dagli elementi dispersori verticali costituiti dagli spandenti di terra
sarà invece dato dalla seguente relazione:
28
Rv =
ρ
⎛ 4⋅ L ⎞
⋅ ⎜ ln
− 1⎟
4 ⋅ π ⋅ L ⎝ ro
⎠
dove:
Rv : resistività teorica di un picchetto
ρ
: resistività del terreno espresso in ohm/m
L
: lunghezza del picchetto in m
ro
: raggio del picchetto in m
L'interdistanza ottimale tra i picchetti è compresa tra i 15 e i 20 metri per ottenere il
massimo del contributo di tutti gli elementi costituenti l'anello ed una configurazione
assimilabile ad un parallelo, evitando così il sovrapposizioni dei campi di influenza.
Il contributo totale Rpt dato dai picchetti essendo questi in numero di “n” è pari a:
Rtv =
Rv
n
Infine contribuiranno anche gli elementi naturali costituiti dai ferri di armatura delle
fondazioni mediante la seguente relazione:
Rf =
ρ
π ⋅1,57 ⋅ 3 V
dove: “V” (m³) è il volume del calcestruzzo armato di fondazione a contatto con il
terreno.
Il valore teorico calcolato per la resistenza di terra Rt è pari a:
Rt =
Rto ⋅ Rtv ⋅ Rf
(Rto ⋅ Rtv ) + (Rtv ⋅ Rf) + (Rto ⋅ Rf)
La relazione che con buona approssimazione si può adottare per il calcolo della
resistenza di terra in un sistema dispersore di tipo magliato è una relazione
semplificata che ci fornirà un valore alquanto cautelativo:
Rt =
ρ
4⋅r
Nel sistema TN è prevista una cabina di trasformazione propria e si ha un impianto
di terra comune con la terra del neutro di cabina.
La relazione che in questo caso deve essere verificata è:
Z S ⋅ I a (t ) ≤ U 0
dove:
Uo : è la tensione nominale tra fase e terra;
Zs : è l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore
attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di
guasto e la sorgente;
29
Ia(t):
è la corrente di intervento in un tempo t del dispositivo di protezione a
massima corrente.
Nel caso l’impianto elettrico venga alimentato a tensione maggiore di 1 kV (con
cabina propria di trasformazione), l’impianto di terra deve essere dimensionato in
accordo con le prescrizioni della Norma CEI 11-1.
In tal caso l’impianto di terra deve:
- avere sufficiente resistenza meccanica ed alla corrosione (le sezioni minime
sono indicate nella Norme CEI 11-1 allegato A).
- essere capace di sopportare le sollecitazioni termiche, in relazione alle correnti
di guasto ed ai tempi di durata del guasto (le sezioni dei conduttori di terra sono
indicate nella Norma CEI 11-1 allegato B).
- contenere le tensioni di passo e contatto nei limiti ammessi.
La condizione che deve essere soddisfatta è:
U E = RE ⋅ I F ≤ 1 ⋅ U TP
Dove:
RE = resistenza di terra (Ω)
UE = tensione totale di terra (V)
UTP = tensione di contatto ammissibile (V)
IF = corrente che fluisce dal circuito principale verso terra, o verso parti collegate a
terra, nel punto di guasto (corrente di guasto, A).
La corrente di guasto a terra IF ed il tempo di eliminazione del guasto tF nel sistema
a tensione maggiore 1 kV vengono forniti, su richiesta, dal distributore dell’energia
elettrica.
Nel caso in cui il sistema elettrico BT si interamente compreso all’interno di un
dispersore di AT a “rete magliata”, la precedente condizione da soddisfare diventa:
U E = R E ⋅ I F ≤ 1,5 ⋅ U TP
La tensione totale di terra (UE) e le tensioni di contatto ammissibili (UTP), noto il
tempo di eliminazione del guasto (tF) devono essere scelte tra quelle indicate nella
tabella seguente:
tF
(sec)
≥ 10
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,2
UTP
(V)
80
103
120
130
155
220
500
In questo caso è possibile coordinare il dispositivo di protezione con l'impedenza
dell'anello di guasto dell'impianto di terra, anche se si può in ogni caso adottare
l'uso di interruttori magnetotermici differenziali.
30
Conduttore di terra
Il conduttore di terra deve essere realizzato mediante un conduttore tipo N07, non
propagante l'incendio di colore giallo-verde, protetto meccanicamente mediante
tubazione e di sezione minima di 16 mmq, calcolata con la formula che segue:
I 2 ∗t
143
Sp =
dove:
Sp : è la sezione del conduttore di terra
I
: è il valore efficace della corrente di guasto che percorre il conduttore
t
: tempo di intervento del dispositivo di interruzione
Conduttore di protezione
La sezione del conduttore di protezione è calcolata in base alla sezione del
conduttore di fase da proteggere nel modo che segue:
- per S ≤ 16 mmq si avrà Sp = S
- per 16 < S ≤ 35 mmq si avrà 16 mmq
- per S > 35 mmq si avrà Sp = S/2
Nel caso di sistema TN-C il conduttore di protezione non deve essere inferiore a 10
mmq.
Conduttore equipotenziale
I conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà
di quella del conduttore di protezione principale dell'impianto, con un minimo di 6
mmq ed un massimo di 25 mmq.
I conduttori equipotenziali supplementari che connettono due masse devono avere
una sezione non inferiore a quella del conduttore di protezione di sezione minore.
I conduttori equipotenziali supplementari che connettono una massa a una massa
estranea devono avere una sezione non inferiore a metà della sezione del
corrispondente conduttore di protezione.
I conduttori equipotenziali supplementari che connettono due masse estranee o che
connettono una massa estranea all'impianto di terra, devono avere una sezione non
inferiore a 2,5 mmq se è prevista una protezione meccanica.
1.14
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DELLE
STRUTTURE CONTRO I FULMINI
L'impianto di protezione delle strutture contro i fulmini è dimensionato in base ai
criteri esposti nelle Norme CEI EN 62305-1, CEI EN 62305-2, CEI EN 62305-3, CEI
EN 62305-4.
L'obbligatorietà della sua realizzazione è resa necessaria nel caso in cui la
valutazione del rischio evidenzi la pericolosità dei fulmini per la loro azione diretta e
indiretta.
31
1.14.1
PRINCIPI GENERALI
La corrente di fulmine è la causa del danno ed i suoi effetti dipendono dalla
localizzazione del punto di impatto rispetto alla struttura:
- S1: fulmine sulla struttura
- S2: fulmine vicino alla struttura
- S3: fulmine sui servizi entranti nella struttura
- S4: fulmine in prossimità dei servizi entranti nella struttura
Un fulmine che colpisce una struttura può causare danni alla struttura stessa e ai
suoi occupanti ed al suo contenuto, compresi i guasti agli impianti interni. I danni ed
i guasti possono estendersi anche nelle vicinanze della struttura e possono talvolta
interessare l’ambiente. Le dimensioni di detta estensione dipendono dalle
caratteristiche della struttura e da quelle del fulmine.
Le principali caratteristiche di una struttura rilevanti ai fini degli effetti di un fulmine
comprendono:
- costruzione
- funzione
- occupanti e contenuto
- servizi entranti
- esistenza di misure di protezione
- estensione del pericolo
Il fulmine può essere causa di tre principali tipi di danno:
- D1: danni ad esseri viventi dovuto a tensione di contatto e di passo;
- D2: danni materiali (incendio, esplosione, distruzione meccanica, rilascio di
sostanze chimiche) dovuti agli effetti della corrente di fulmine, scariche disruptive
incluse;
- D3: guasti agli impianti interni dovuti al LEMP (effetti elettromagnetici della
corrente di fulmine);
Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre differenti
perdite nell’oggetto da proteggere. Il tipo di perdita che può verificarsi dipende dalle
caratteristiche dell’oggetto stesso.
La norma considera i seguenti tipi di perdita:
• Perdite che possono verificarsi in una struttura
- L1 : perdita di vite umane
- L2 : perdita di servizio pubblico
- L3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile
- L4 : perdita economica (struttura e suo contenuto, servizi e perdita di attività).
• Perdite che possono verificarsi in un servizio
- L’2 : perdita di servizio pubblico
- L’4 : perdita economica (servizi e perdita di attività).
Le perdite di tipo L1, L2 ed L3 possono essere considerate perdite di valori sociali
mentre la perdita di tipo L4 è esclusivamente una perdita economica.
La corrispondenza tra sorgenti di danno, tipo di danno e perdita è riportato nella
Tabella 1 per le strutture ed in Tabella 2 per i servizi.
32
TABELLA 1
Danni e perdite in una struttura in funzione dei diversi punti d’impatto del fulmine.
TABELLA 2
Danni e perdite in un servizio in funzione dei diversi punti d’impatto del fulmine
I tipi di perdita risultanti dai tipi di danno ed i rischi corrispondenti sono riportati nella
figura che segue.
33
I criteri utilizzati per effettuare la valutazione del rischio, sono quelli esposti nella
Norma CEI 62305-2, mentre le misure di protezione adottate, atte a ridurre il rischio
del danno sono riportate nelle altre norme.
La necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto deve essere valutata al
fine di ridurre le perdite dei valori sociali L1, L2 e L3.
Al fine di valutare se la protezione sia o meno necessaria, deve essere effettuata la
valutazione del rischio.
Devono essere considerati i seguenti rischi, corrispondenti ai tipi di perdita:
- R1 : perdita di vite umane
- R2 : perdita di servizio pubblico
- R3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile
La protezione contro il fulmine é necessaria se il rischio R (R1, R2 ed R3) é
superiore al livello di rischio tollerabile RT
R > RT
In questo caso devono essere adottate misure di protezione al fine di ridurre il
rischio R (R1, R2 ed R3) al valore di rischio tollerabile RT
R ≤ RT
Se uno o più tipi di perdita possono verificarsi nell’oggetto da proteggere, la
condizione R ≤ RT deve essere soddisfatta per ciascun tipo di perdita (L1, L2 e L3).
La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale
è responsabilità dei competenti comitati nazionali. Un’autorità competente può
richiedere la protezione contro il fulmine per specifiche applicazioni senza che sia
effettuata la valutazione del rischio. In questo caso il livello di protezione richiesto
34
deve essere specificato dall’autorità competente. In alcuni casi la valutazione del
rischio può essere effettuata al fine di giustificare dette prescrizioni.
Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto, può risultare
utile valutare i benefici economici derivanti dall’adozione di misure di protezione atti
a ridurre le perdite economiche L4.
In questo caso dovrebbe essere definito il valore del rischio di perdita economica
R4. La definizione di R4 permette di valutare il costo della perdita economica con e
senza le misure di protezione.
I criteri per la valutazione del rischio e per la scelta delle misure di protezione più
appropriate sono riportati nella CEI EN 62305-2.
Le misure di protezione, adottate per ridurre detti danni e le conseguenti perdite,
devono essere progettate con riferimento all’insieme di parametri della corrente di
fulmine contro la quale è richiesta la protezione (Livello di protezione contro il
fulmine – LPL : numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della
corrente di fulmine, relativo alla probabilità che i correlati valori massimo e minimo di
progetto non siano superati in natura).
La Norma prevede quattro livelli di protezione (da I a IV). Per ciascun LPL è fissato
un insieme di parametri, minimi e massimi, della corrente di fulmine.
TABELLA 3
Valori massimi dei parametri di fulmine e dei corrispondenti livelli di protezione
(LPL)
TABELLA 4
Valori minimi dei parametri di fulmine e relativi raggi della sfera rotolante
corrispondenti ai livelli di protezione
35
Dalla distribuzione statistica può essere determinata una probabilità pesata tale per
cui i parametri della corrente di fulmine siano rispettivamente minori dei valori
massimi e maggiori dei valori minimi definiti per ciascun livello di protezione (Tabella
5).
TABELLA 5
PROBABILITA’ CHE I PARAMETRI DELLA
CORRENTE DI FULMINE SIANO
Inferiori ai valori massimi definiti nella tabella 3
Superiori ai valori minimi definiti nella tabella 4
I
0,99
0,99
LIVELLO DI PROTEZIONE
II
III
IV
0,98
0,97
0,97
0,97
0,91
0,84
Probabilità per i limiti dei parametri della corrente di fulmine
Le misure di protezione sono efficaci contro i fulmini i cui parametri di corrente siano
nel campo di variazione definito dal LPL assunto nel progetto.
1.14.2
COMPONENTI DEL RISCHIO
Il rischio, definito nella Norma come la probabile perdita media annua dovuta al
fulmine in una struttura e in un servizio, dipende da:
– il numero annuo di fulmini che interessano la struttura ed il servizio;
– la probabilità che un fulmine interessi la struttura o al servizio provochi danno;
– l’ammontare medio della perdita conseguente.
La probabilità di danno da fulmine dipende dalla struttura, dal servizio, dalle
caratteristiche della corrente di fulmine, nonché dal tipo e dall’efficienza delle misure
di protezione adottate.
Quando si desideri evitare comunque possibili rischi, la decisione di adottare misure
di protezione contro il fulmine può essere presa indipendentemente dal risultato di
qualsivoglia valutazione del rischio (CEI EN 62305-2 “Introduzione”).
Il tipo di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell’oggetto stesso
ed al suo contenuto e sono riporatete nella seguente tabella:
TABELLA 6
Rischio in una struttura per ciascun tipo di danno e di perdita
Dove:
RS : Rischio della struttura per danno ad esseri viventi
36
RF : Rischio della struttura per danno materiale
RO : Rischio di guasto degli impianti interni alla struttura
Il rischio “R” è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di
perdita che può verificarsi in una struttura o in servizio deve essere valutato il
relativo rischio.
I rischi da valutare in una struttura possono essere:
– R1: rischio di perdita di vite umane;
– R2: rischio di perdita di servizio pubblico;
– R3: rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile;
– R4: rischio di perdita economica
I rischi da valutare in un servizio possono essere:
– R’2: rischio di perdita di servizio pubblico;
– R’4: rischio di perdita economica
Per valutare i rischi “R”, devono essere definiti e calcolati le relative componenti di
rischio (rischi parziali dipendenti dalla sorgente e dal tipo di danno).
Ciascun rischio R è la somma delle sue componenti di rischio.
Nell’effettuare la somma le componenti di rischio devono essere raggruppate
secondo la sorgente di danno ed il tipo di danno.
1.14.3
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La scelta delle misure di protezione da adottare in un impianto contro le scariche
atmosferiche va effettuata applicando la seguente procedura:
– identificazione dell’oggetto da proteggere e delle sue caratteristiche;
– identificazione di tutti i tipi di perdita nell’oggetto e dei corrispondenti rischi R (R1,
R2, R3 ed R4);
– determinazione del rischio R per ciascun tipo di perdita (R1, R2, R3 ed R4);
– valutazione della necessità della protezione effettuando il confronto tra i rischi R1,
R2, e R3 per una struttura (R’2 per un servizio) con il rischio tollerabile RT;
– valutazione della convenienza economica della protezione effettuando il confronto
tra il costo totale della perdita con e senza le misure di protezione. In questo caso
deve essere effettuata la valutazione della componente di rischio R4 per una
struttura (R’4 per un servizio) al fine di determinare detti costi (vedere Allegato G
della norme CEI EN 62305-2).
La struttura da considerare comprende:
– la struttura stessa;
– gli impianti nella struttura;
– il contenuto della struttura;
– le persone nella struttura e quelle nella fascia fino a 3 m all’esterno della struttura;
– l’ambiente circostante interessato da un danno alla struttura.
La protezione non comprende i servizi esterni connessi alla struttura.
Il servizio da considerare é la connessione fisica tra:
– la centrale di commutazione e l’edificio dell’utente o tra due centrali di
commutazione o tra due edifici d’utente, per le linee di telecomunicazione (TLC);
– la centrale di commutazione o l’edificio dell’utente ed il nodo di distribuzione o tra
due nodi, per le linee di telecomunicazione (TLC);
37
– la sottostazione ad alta tensione (MT) e l’edificio dell’utilizzatore, per le linee di
energia;
– la stazione principale di distribuzione e l’edificio dell’utilizzatore, per le tubazioni.
Il servizio da considerare comprende gli apparati lungo la linea e quelli alle
estremità, quali:
– multiplexer, amplificatori di energia, unità di rete ottiche, contatori, apparati
terminali, ecc.;
– interruttori, sistemi di protezione contro le sovracorrenti, contatori, ecc.;
– sistemi di controllo, sistemi di sicurezza, contatori, ecc.
La protezione non comprende gli apparati dell’utente o qualsivoglia struttura
connessa alle estremità del servizio.
La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale
è responsabilità dei competenti comitati nazionali.
Valori rappresentativi di rischio tollerabile RT, quando il fulmine coinvolge la perdita
di vite umane o perdite sociali o culturali, sono riportati nella tabella seguente.
Tipo di perdita
Perdita di vite umane o danni permanenti
Perdita di servizio pubblico
Perdita di patrimonio culturale insostituibile
RT (anni1
)
10-5
10-3
10-3
Procedura per valutare la necessità del rischio
In conformità con la CEI EN 62305-1, nella valutazione della necessità della
protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati i seguenti
rischi:
– rischi R1, R2 e R3 per una struttura;
– rischi R’1 and R’2 per un servizio.
Per ciascun rischio considerato devono essere effettuati i seguenti passi:
– identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio;
– calcolo della componente di rischio identificata RX;
– calcolo del rischio totale R;
– identificazione del rischio tollerabile RT;
– confronto del rischio R con quello tollerabile RT.
Se R ≤ RT la protezione contro il fulmine non é necessaria.
Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R ≤ RT per
tutti i rischi a cui é interessato l’oggetto.
Procedura per valutare la convenienza economica della protezione
Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura o di un
servizio, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla messa in
opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4.
La valutazione della componente di rischio R4 per una struttura (R’4 per un
Servizio) permette all’utilizzatore di comparare i costi della perdita economica con e
senza le misure di protezione.
La procedura per accertare la convenienza economica richiede:
– identificazione delle componenti RX che costituiscono il rischio R4 per una
struttura (R’4 per un Servizio);
– il calcolo della componente di rischio identificata RX in assenza di misure di
protezione nuove o addizionali;
– il calcolo del costo annuale della perdita dovuta a ciascuna componente di rischio
RX;
– il calcolo del costo annuale CL della perdita totale in assenza delle misure di
protezione;
38
– adozione delle misure di protezione scelte;
– il calcolo della componente di rischio RX in presenza delle misure di protezione
scelte;
– il calcolo del costo annuale della perdita residua dovuta a ciascuna componente di
rischio RX nella struttura o sevizio protetto;
– il calcolo del totale costo annuale CRL della perdita residua in presenza delle
misure di protezione scelte;
– il calcolo del costo annuale CPM delle misure di protezione scelte;
– confronto dei costi.
Se CL < CRL + CPM, la protezione contro il fulmine può essere ritenuta non
conveniente.
Se CL ≥ CRL + CPM, la protezione contro il fulmine può consentire risparmi
nell’arco di vita della struttura.
TABELLA 13
Procedura per la scelta delle misure di protezione in una struttura
39
TABELLA 14
Procedura per la scelta delle misure di protezione in un servzio
Equazioni di base
Ciascuna componente di rischio RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW and RZ, può essere
calcolata mediante la seguente equazione generale:
R X = N X ⋅ PX ⋅ LX
(20)
dove:
NX é il numero di eventi pericolosi; Il numero NX di eventi pericolosi dipende dalla
densità d fulmini al suolo (Ng) e dalle caratteristiche geometriche dell’oggetto da
proteggere, dai suoi dintorni e dal suolo.
PX é la probabilità di danno alla struttura; La probabilità di danno PX dipende e dalle
caratteristiche dell’oggetto da proteggere e dalle misure di protezione adottate.
LX é la perdita conseguente; La perdita conseguente LX dipende dall’uso a cui
l’oggetto è destinato, la presenza di persone, il tipo di servizio pubblico, il valore dei
beni danneggiati e dalle misure di protezione adottate per limitare l’ammontare della
perdita.
1.14.4
IMPIANTO DI PROTEZIONE LPS
La più importante ed efficace misura di protezione per le strutture nel caso che il
rischio R sia superiore al livello del rischio tollerabbile RT è costituita dall’impianto di
40
protezione contro il fulmine (LPS). Inoltre sarà necessario limitare i danni agli esseri
viventi causati dalle tensioni di contatto e di passo.
L’impianto è normalmente composto da una parte di protezione esterno e una di
protezione interno.
L’impianto di protezione esterno ha lo scopo di:
a) intercettare i fulmini diretti sulla struttura (con un sistema di captatori);
b) condurre a terra senza danni la corrente di fulmine (con un sistema di calate);
c) disperdere a terra la corrente di fulmine (con un sistema di dispersori).
L’impianto di protezione interno ha lo scopo di prevenire le scariche
pericolose nella struttura utilizzando connessioni equipotenziali o distanze di
sicurezza (e quindi isolamento elettrico) tra i componenti dell’LPS esterno ed altri
elementi metallici interni alla struttura.
Le principali misure di protezione contro i danni agli esseri viventi dovuti alle
tensioni di contatto e di passo hanno lo scopo di:
1) ridurre la corrente pericolosa che può fluire nel corpo mediante l’isolamento delle
parti conduttrici esposte e/o incrementando la resistività superficiale del suolo;
2) ridurre la possibilità che si manifestino pericolose tensioni di contatto e di passo
utilizzando barriere e/o cartelli ammonitori.
Le caratteristiche di un LPS sono determinate dalla struttura che deve essere
protetta dal livello di protezione prefissato.
La Norma CEI definisce quattro classi di LPS (da I a IV) corrispondenti ai livelli di
protezione LPL.
Tabella 1
Corrispondenza tra il livello di protezione (LPL) e la classe dell’LPS (CEI EN 623051)
Ciascuna classe di LPS è caratterizzata da:
a) Dati dipendenti dalla classe di LPS:
– parametri del fulmine;
– raggio della sfera rotolante, dimensione del lato di maglia e angolo di protezione;
– distanza tipica tra le calate e tra i conduttori ad anello;
– distanza di sicurezza per evitare le scariche pericolose;
– lunghezza minima degli elementi del dispersore;
b) Dati indipendenti dalla classe di LPS:
– conduttori equipotenziali;
– spessore minimo delle lastre e delle tubazioni metalliche del sistema di captatori;
– materiali e condizioni d’impiego dei materiali costituenti l’LPS;
– calate e di dispersori;
– dimensioni minime dei conduttori equipotenziali.
41
La classe dell’LPS richiesto deve essere scelta sulla base della valutazione del
rischio.
L’LPS esterno ha la funzione di intercettare i fulmini sulla struttura compresi quelli
sulle facciate laterali, e di condurre la corrente di fulmine dal punto d’impatto a terra.
L’LPS esterno ha anche la funzione di disperdere la corrente nel terreno senza che
si verifichino danni termici o meccanici e scariche pericolose in quanto in grado di
innescare incendi o esplosioni.
Nella maggioranza dei casi l’LPS esterno dovrebbe essere appoggiato alla struttura
che deve essere protetta.
L’uso di un LPS esterno isolato dovrebbe essere preso in considerazione quando gli
effetti termici ed esplosivi nel punto d’impatto, o nei conduttori percorsi dalla
corrente di fulmine, possono causare danno alla struttura o al suo contenuto. Ne
sono esempi tipici le strutture con copertura combustibile, le strutture con pareti
combustibili ed le aree con pericolo di esplosione e d’incendio.
Un LPS isolato può essere inoltre preso in considerazione quando la suscettibilità
del contenuto richieda la riduzione del campo elettromagnetico irradiato associato
alle correnti di fulmine nelle calate.
I componenti naturali costituiti da elementi metallici che sono parte integrante della
struttura e che non possono essere modificati (p.e. ferri d’armatura interconnessi,
l’intelaiatura metallica di una struttura) possono essere usati come elementi del
LPS.
Gli altri componenti metallici dovrebbe essere considerati solo come elementi
aggiuntivi dell’LPS.
La probabilità che un fulmine penetri nella struttura è considerevolmente ridotta
dalla presenza di un sistema di captatori opportunamente progettato.
Il sistema di captatori può essere costituito da qualsivoglia combinazione dei
seguenti elementi:
a) aste (comprese le antenne);
b) funi sospese all’estremità;
c) conduttori disposti in modo da formare maglie
I componenti del sistema di captatori installati su una struttura devono essere
posizionati in corrispondenza degli spigoli, dei punti esposti e dei bordi (in
particolare quelli ai livelli più elevati delle facciate) secondo uno o più dei seguenti
metodi.
Metodi accettabili per determinare il posizionamento del sistema di captatori sono:
– metodo dell’angolo di protezione;
– metodo della sfera rotolante;
– metodo della maglia.
Il metodo della sfera rotolante è adatto in ogni caso.
I valori dell’angolo di protezione, del raggio della sfera rotolante e della dimensione
del lato di magliatura sono riportati in Tab. 1.
42
Tabella 1
Valori massimi del raggio della sfera rotolante, del lato di magliatura e dell’angolo di
protezione in funzione della classe dell’LPS
Componenti naturali
Dovrebbero essere usati come componenti naturali del sistema di captatori e,
quindi, entrare a far parte del LPS, i seguenti elementi di una struttura:
a) lastre metalliche di copertura della struttura da proteggere a condizione che:
– la continuità elettrica tra le parti sia resa durevole (ad esempio: tramite
brasatura forte, saldatura, pressione, avvitamento o bullonatura);
– lo spessore delle lastre metalliche non sia inferiore al valore t’ fornito in Tabella
2 se non è necessario prendere precauzioni contro la perforazione della
copertura o l’incendio dei materiali combustibili sottostanti;
– lo spessore delle lastre metalliche non sia inferiore al valore t fornito in Tabella 2
se è necessario prendere precauzioni contro la perforazione o contro il
fenomeno di punto caldo;
– non siano rivestite in materiale isolante.
Tabella 2
Spessore minimo delle lastre metalliche o delle tubazioni metalliche usate come
captatori
b) componenti metallici costruttivi di tetti (capriate metalliche, ferri di armatura
elettricamente continui, ecc.), al di sotto di una copertura non metallica, purché
quest’ultima parte possa essere esclusa dalla struttura da proteggere;
c) parti metalliche come gronde, ornamenti, ringhiere, ecc., la cui sezione
trasversale non sia inferiore a quella specificata per i captatori normali;
d) tubazioni e serbatoi metallici sul tetto, a condizione che essi siano costruiti con
materiali aventi spessore e sezione in accordo con la normativa;
e) tubazioni e serbatoi metallici contenenti miscele facilmente combustibili o
esplosive, a condizione che essi siano costruiti con materiali aventi spessore non
inferiori all’appropriato valore di t fra quelli riportati in Tab. 2 e che la
sovratemperatura della superficie interna in corrispondenza del punto d’impatto non
costituisca pericolo.
43
Se le condizioni relative allo spessore non sono rispettate, le tubazioni o i serbatoi
devono essere integrati nelle strutture da proteggere.
Al fine di ridurre la probabilità che la corrente di fulmine che fluisce nell’LPS
provochi danno, le calate devono essere disposte in modo che dal punto d’impatto a
terra:
a) esistano più percorsi paralleli per la corrente;
b) le lunghezze dei percorsi della corrente siano ridotte al minimo;
c) le connessioni equipotenziali alle parti conduttrici della struttura siano realizzate
con le modalità prescritte.
NOTA 1 E considerata una buona pratica collegare tra loro le calate con conduttori ad anello a livello
del suolo e ogni 10 ÷ 20 m di altezza secondo quanto riportato nella Tab. 3.
La geometria delle calate e dei conduttori ad anello influenza la distanza di
sicurezza.
Nota 2 L’installazione di quante più calate possibili, equidistanti lungo il perimetro ed, interconnesse
mediante conduttori ad anello, riduce la probabilità di scariche pericolose e facilita la protezione degli
impianti interni. Questa condizione è già soddisfatta nelle strutture con intelaiatura metallica e nelle
strutture in calcestruzzo armato in cui i ferri d’armatura siano elettricamente continui. Tipici valori della
distanza tra le calate e tra i conduttori ad anello sono riportati nella Tab.3.
Posizionamento di un LPS non isolato
Il numero di calate di un LPS non isolato non deve essere inferiore a due e le calate
dovrebbero essere distribuite lungo il perimetro della struttura da proteggere,
compatibilmente con i limiti architettonici e pratici.
È preferibile che le calate siano fra loro equidistanti lungo il perimetro. Tipici valori
della distanza tra le calate sono riportati nella Tab. 3.
Tabella 3
Tipici valori della distanza tra le calate e tra i conduttori ad anello in funzione della
classe dell’LPS
Componenti naturali
Dovrebbero essere utilizzate come calate naturali le seguenti parti della struttura:
a) i corpi metallici a patto che:
– la continuità elettrica tra le varie parti sia realizzata in modo durevole;
– le loro dimensioni siano almeno uguali a quanto prescritto nella Tab. 4 per le
calate normali
È vietato l’uso come calate naturali di tubazioni che trasportano miscele in
concentrazioni comprese entro i limiti di infiammabilità o esplosive, se la
guarnizione interposta tra le flange non è metallica o se le flange affacciate non
sono in altro modo tra loro connesse.
NOTA 1 I corpi metallici possono essere rivestiti con materiale isolante.
b) gli elementi portanti della struttura elettricamente continui
44
NOTA 2 Nelle strutture prefabbricate é importante realizzare punti di interconnessione tra i ferri
dell’armatura. È altresì importante che la struttura prefabbricata abbia connessioni conduttrici tra detti
punti. I diversi elementi dovrebbero essere connessi tra loro in sito durante l’assemblaggio.
NOTA 3 Nel caso di strutture prefabbricate si dovrebbe fare attenzione che il rischio meccanico dovuto
sia alla corrente di fulmine, sia alle conseguenze della connessione al LPS non diventi inaccettabile.
c) I ferri di armatura elettricamente continui delle strutture in cemento armato
NOTA 4 Non sono necessari conduttori ad anello se sono utilizzati come calate l’ossatura di una
struttura metallica o i ferri di armatura interconnessi.
d) Gli elementi, i profilati e i supporti delle facciate metalliche, a condizione che:
– le loro dimensioni siano in accordo con quanto richiesto per le calate normali ed il
loro spessore non sia inferiore a 0,5 mm;
– la continuità elettrica nella direzione verticale sia in accordo con quanto richiesto.
Tabella 4
Materiali, configurazioni e sezioni minime dei conduttori e delle aste del sistema di
captatori e dei conduttori delle calate
La realizzazione di un LPS su una struttura esistente deve essere sempre valutata
tenendo presente che altre misure di protezione possono offrire lo stesso livello di
protezione con un costo minore.
Bisogna inoltre valutare sia gli effetti elettrici che quelli meccanici della scarica di
fulmine e di compatibilità elettromagnetica (EMC).
45
Pianificazione, implementazione e verifica interessano diversi campi tecnici e
richiedono il coordinamento di tutte le parti coinvolte per assicurare il
raggiungimento del prefissato livello di protezione con il minimo costo ed il minor
sforzo.
Connessioni ai ferri d’armatura
La continuità dei ferri d’armatura dovrebbe essere effettuata mediante morsetti a
compressione o saldature.
NOTA Dovrebbero essere utilizzati i morsetti a compressione conformi alla serie di norme.
La saldatura dei ferri d’armatura è permessa solo con il consenso dal responsabile
dei lavori civili. La saldatura dei ferri d’armatura dovrebbe estendersi per una
lunghezza di almeno 30 mm.
46
Figura 1 – Saldatura dei ferri d’armatura, se consentita
La connessione dei corpi metallici esterni all’LPS dovrebbe essere effettuata
mediante un conduttore addizionale che fuoriesce dal calcestruzzo nel punto
stabilito, o da un conduttore o da una piastra che lo attraversa ed è connessa ai ferri
d’armatura mediante saldatura o morsetto a compressione.
Quando la connessione tra i ferri d’armatura ed il conduttore è effettuata per mezzo
di un morsetto a compressione, per ragioni di sicurezza (considerato che la
giunzione non può essere ispezionata dopo la gettata di calcestruzzo) dovrebbero
essere utilizzati due conduttori (o un conduttore con due morsetti su due diversi
ferri). Se la giunzione è tra due metalli diversi, la zona della giunzione è opportuno
sia impermeabilizzata.
I conduttori dovrebbero essere dimensionati per la frazione di corrente di fulmine
che fluisce nel punto di connessione.
Figura 2 – Esempi di connessioni con morsetti a compressione
47
Continuità dei ferri d’armatura
I ferri di armatura di una struttura in calcestruzzo armato sono considerati continui
se la maggior parte delle interconnessioni tra i ferri verticali e quelli orizzontali è
effettuata mediante saldatura, o comunque in modo sicuro. La connessione dei ferri
verticali deve essere effettuata mediante saldatura, sovrapposizione dei ferri per un
minimo di 20 volte il loro diametro o in altro modo sicuro. Per le strutture di nuova
costruzione, la connessione tra i ferri d’armatura deve essere specificata dal
progettista o dall’installatore in cooperazione con il costruttore ed il responsabile
delle opere civili.
Per le strutture che utilizzano i ferri d’armatura del calcestruzzo (comprese le
strutture prefabbricate e quelle in cemento armato precompresso), la continuità
elettrica dei ferri d’armatura deve essere verificata mediante misure elettriche tra la
sommità e la base della struttura. La resistenza elettrica totale, misurata con
strumentazione atta allo scopo, dovrebbe essere inferiore a 0,2 . Se detto valore
non fosse raggiunto, o se non risultasse fattibile la misura, i ferri d’armatura non
devono essere utilizzati come calate naturali. In questo caso è necessaria
l’installazione di calate esterne. Nel caso di strutture in calcestruzzo armato
prefabbricate, deve essere verificata la continuità elettrica dei ferri d’armatura tra gli
elementi prefabbricati contigui.
48
1.15
DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE E
SPEGNIMENTO INCENDI AUTOMATICI
Il calcolo del dimensionamento dell’impianto di rivelazione incendi e della centrale è
effettuato in accordo alle normative UNI EN 54-2 e UNI 9795.
Il numero dei rivelatori da prevedersi e la loro tipologia, che realizzano la copertura
dell’impianto antincendio è definita in base alle indicazioni forniteci dalla norma.
I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo di
incendio prevedibile nell’area sorvegliata, fin dallo stadio iniziale evitando falsi
allarmi.
La determinazione del numero dei rivelatori necessari e della loro posizione deve
essere effettuata in funzione dei seguenti parametri:
- tipo di rivelatori;
- superficie ed altezza del locale;
- forma del soffitto o della copertura quando questa costituisce il soffitto;
- condizioni di aerazione e di ventilazione del locale.
I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio, oggetto della presente norma
devono in ogni caso comprendere:
- rivelatori automatici d’incendio;
- punti di segnalazione manuale;
- centrale di controllo e segnalazione;
- apparecchiatura di alimentazione;
- dispositivi di allarme incendio.
Nei sistemi fissi di segnalazione manuale sono assenti i rivelatori automatici
d’incendio.
Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di
rivelazione.
All’interno di un’area sorvegliata devono essere direttamente sorvegliate da
rivelatori anche le seguenti parti:
- locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e
comunicazione, nonché vani corsa degli elevatori, ascensori e montacarichi;
- cortili interni coperti;
- cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici;
- condotti di condizionamento dell’aria e condotti di aerazione e di ventilazione;
- spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati.
I rivelatori sono previsti in ciascun locale facente parte dell’area sorvegliata, con le
sole seguenti eccezioni qualora non contengano sostanze infiammabili, rifiuti,
materiali combustibili e cavi elettrici ad eccezione per questi ultimi, di quelli
strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime:
- piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il
deposito di materiali combustibili o rifiuti;
- condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m2, a condizione che siano
correttamente protetti contro l’incendio e siano opportunamente compartimentati;
- banchine di carico scoperte (senza tetto);
- locali protetti da impianti di spegnimento automatici e separati dalle altre aree da
strutture resistenti all’incendio;
- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti
sopraelevati, che:
49
- abbiano altezza minore di 800 mm, superficie non maggiore di 100 m2, dimensioni
lineari non maggiori di 25 m, siano totalmente rivestiti all’interno con materiale
incombustibile (classe 0), non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi
di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min);
- vani scale compartimentati;
- vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un
compartimento sorvegliato dal sistema di rivelazione.
L’area sorvegliata deve essere suddivisa in zone, in modo tale che, quando un
rivelatore interviene, sia possibile individuarne facilmente la zona di appartenenza.
Le zone devono essere delimitate in modo che sia possibile localizzare rapidamente
e senza incertezze il focolaio d’incendio.
Ciascuna zona deve comprendere non più di un piano del fabbricato, con
l’eccezione dei seguenti casi: vani scala, vani di ascensori e montacarichi, edifici di
piccole dimensioni a più piani, ciascuno dei quali può costituire un’unica zona
distinta.
La superficie a pavimento di ciascuna zona non deve essere maggiore di 1600 m2.
Più locali non possono appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e
se:
- il loro numero non è maggiore di 10, la loro superficie complessiva non è maggiore
di 600 m2 e gli accessi danno sul medesimo disimpegno,
oppure:
- il loro numero non è maggiore di 20, la loro superficie complessiva non è maggiore
di 1000 m2 ed in prossimità degli accessi sono installati segnalatori ottici di allarme
chiaramente visibili, che consentono l’immediata individuazione del locale dal quale
proviene l’allarme.
I rivelatori installati sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli e
nelle canalette per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell’aria, di
aerazione e di ventilazione devono appartenere a zone distinte. Diversamente
occorre che sia possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i
rivelatori sono intervenuti per primi.
Se una medesima linea di rivelatori serve più zone e il numero di rivelatori è
maggiore di 32, la linea deve essere ad anello chiuso e dotata di opportuni
dispositivi di isolamento in conformità alla UNI EN 54-2.
In una zona possono essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti
purché i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di controllo e
segnalazione.
I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio devono essere completati con un
sistema di segnalazione manuale costituito da punti di segnalazione manuale
disposti come di seguito specificato:
- I sistemi fissi di segnalazione manuale d’incendio devono essere suddivisi in zone
secondo i criteri indicati.
- In ciascuna zona deve essere installato un numero di punti di segnalazione
manuale tale che almeno uno possa essere raggiunto da ogni parte della zona
stessa con un percorso non maggiore di 40 m.
- In ogni caso i punti di segnalazione manuale devono essere almeno due.
- Alcuni dei punti di segnalazione manuale previsti vanno installati lungo le vie di
esodo.
- I punti di segnalazione manuale vanno installati in posizione chiaramente visibile e
facilmente accessibile, ad un’altezza compresa tra 1 m e 1,4 m.
- I punti di segnalazione manuale possono essere collegati ai circuiti dei rivelatori
automatici purché i rispettivi segnali siano univocamente identificabili alla centrale di
controllo e segnalazione.
50
- I guasti e/o l’esclusione dei rivelatori automatici non devono mettere fuori servizio
quelli di segnalazione manuale e viceversa.
Criteri di scelta dei rivelatori
I rivelatori devono essere conformi alla UNI EN 54.
Nella scelta dei rivelatori devono essere presi in considerazione i seguenti elementi
basilari:
- le condizioni ambientali (moti dell’aria, umidità, temperatura, vibrazioni, presenza
di sostanze corrosive, presenza di sostanze infiammabili che possono determinare
rischi di esplosione, ecc.) e la natura dell’incendio nella sua fase iniziale, mettendole
in relazione con le caratteristiche di funzionamento dei rivelatori, riportati nei relativi
certificati di prova;
- la configurazione geometrica dell’ambiente in cui i rivelatori operano, tenendo
presente i limiti specificati
- le funzioni particolari richieste al sistema (per esempio: azionamento di una
installazione di estinzione d’incendio, esodo di persone, ecc.).
Nel caso di rivelatori termovelocimetrici di calore la distribuzione dei medesimi è
data dalle seguenti tabelle:
Mentre nel caso di rivelatori ottici di fumo valgono le tabelle seguenti:
51
Particolare attenzione deve essere posta nell’installazione dei rivelatori di fumo,
dove:
- la velocità dell’aria è normalmente maggiore di 1 m/s;
- la velocità dell’aria possa essere occasionalmente maggiore di 5 m/s.
La distanza tra i rivelatori e le pareti del locale sorvegliato non deve essere minore
di 0,5 m, a meno che siano installati in corridoi, cunicoli, condotti tecnici o simili di
larghezza minore di 1 m.
Nei locali con soffitto (o copertura) a correnti o a travi in vista i rivelatori devono
essere installati all’interno dei riquadri delimitati da detti elementi, oppure sulla
faccia inferiore di questi ultimi.
Nei locali in cui la circolazione d’aria risulta elevata, cioè al disopra dei normali valori
adottati per gli impianti di benessere (per esempio: nei centri di elaborazione dati,
nelle sale quadri, ecc.), il numero di rivelatori di fumo installati a soffitto, o sotto
eventuali controsoffitti, deve essere opportunamente aumentato per compensare
l’eccessiva diluizione del fumo stesso. Detto numero deve essere determinato
moltiplicando quello calcolato, per il coefficiente indicato nella tabella seguente:
52
Nei locali direttamente sorvegliati, gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i
pavimenti sopraelevati, qualunque sia la loro altezza e dimensione, se contengono
cavi elettrici e/o supporti di messaggi codificati e/o presentano rischio di incendio in
questi devono essere installati i rivelatori di incendio.
In detti spazi, se la loro altezza è maggiore di 1 m, il numero di rivelatori necessari
deve essere calcolato come se si trattasse di un locale. Se l’altezza non è maggiore
di 1 m, il numero di rivelatori da installare è quello determinato secondo la tabella
seguente:
La Centrale di rivelazione incendi e spegnimento è del tipo idoneo a gestire un
impianto di rivelazione a zone o ad indirizzo individuale intelligente.
Per ogni zona è previsto un loop al quale vengono collegati fino a 20 rivelatori di
uno stesso tipo.
Nel caso di Centrale a rivelazione di tipo ad indirizzo individuale intelligente su ogni
porta seriale sono colleganti fino a 99 rivelatori di uno stesso tipo.
53
2
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTO ELETTRICO
2.1
ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT
Nella cabina sono installati:
1) Il Quadro di MT che è del tipo prefabbricato protetto a scomparti normalizzati, da
interno, a semplice sistema di sbarre con tensione di isolamento fino a 24 kV ed un
livello di corto circuito di 500 MVA costituito da:
- scomparto di arrivo della linea mediante sezionatore rotativo di manovra
sottocarico controsbarra;
- scomparto di partenza della linea mediante sezionatore rotativo di manovra
sottocarico controsbarra;
- scomparto di riserva mediante sezionatore rotativo di manovra sottocarico
controsbarra;
- scomparto per interruttore generale del tipo VOR;
- scomparti per il contenimento del trasformatore.
Il quadro di MT è esistente ed in buono stato e sarà necessaria soltanto la
sostituzione dell’attuale trasformatore per adeguare l’impianto alle nuove esigenze.
2) Il trasformatore avrà una potenzialità atta a sopperire il carico totale dello
impianto elettrico e fornirà ai morsetti dell'avvolgimento secondario una tensione a
vuoto trifase con neutro di 400/230V-50 Hz. Il trasformatore avrà una potenzialità
pari a 400 kVA. La tensione nominale a vuoto sui morsetti degli avvolgimento
secondario del trasformatore sarà posta pari a 420V per compensare la c.d.t. da
vuoto a carico.
3) E’ prevista la rimozione dell’attuale Quadro Generale di Bassa Tensione e la sua
sostituzione con un nuovo Quadro del tipo protetto, a parziale segregazione delle
apparecchiature, (Forma 3b secondo la Norma CEI 17-13/1), per la protezione ed il
controllo delle alimentazioni ai Quadri Secondari e di zona, composto dalla Sezione
Normale di rete, dalla Sezione di Riserva (Emergenza) e dalla Sezione di Sicurezza
FM.
2.2
QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE
Il Quadro Generale di Bassa Tensione è del tipo Power Center, a totale
segregazione delle apparecchiature, ( Forma 3b secondo la Norma CEI 17-13/1),
con tutti gli interruttori di tipo scatolato fisso con attacchi posteriori e sganciatore
elettronico, per la protezione ed il controllo del Quadro e delle alimentazioni ai
Quadri Secondari e di zona, composto dalla Sezione Normale di rete, dalla Sezione
di Riserva.
E’ previsto separatamente da questo un quadro per la Sezione di Sicurezza.
Il QGBT alimenterà i seguenti Quadri:
- Quadro livello 716
- Quadro livello 721
- Quadro livello 726,11
- Quadro livello 730,30
- Quadro Mensa
- Quadro Cucina
- Quadro Asilo
54
- Quadro Centrale Termica
- Quadro Centrale Idrica
- Quadro Centrale Antincendio
- Gruppo Frigorifero
- n.6 Quadri UTA
- Quadro di cabina elettrica
- n.3 Quadri Ascensori
Il cavo è del tipo non propagante l'incendio posato in canaletta chiusa in PVC o in
tubazione rigida pesante in PVC autoestinguente.
2.3
RIFASAMENTO AUTOMATICO E FISSO
Nel Quadro Generale di Bassa Tensione è installata una sezione per il rifasamento
automatico in presenza di armoniche, per la correzione del fattore di potenza
complessivo dell'impianto ad un valore non inferiore a cosϕ=0,9.
L'impianto di rifasamento è costituito essenzialmente da:
- sezionatore blocco-porta con fusibili di protezione delle apparecchiature
- centralina automatica di controllo del fattore di potenza
- serie di condensatori di rifasamento
- contattori per l'inserzione automatica dei condensatori con resistenze di scarica ed
induttanze di blocco delle armoniche.
Inoltre è previsto anche un rifasamento fisso per ogni trasformatore, costituito da
batteria di condensatori, della potenzialità pari a 80kVAr.
2.4
COMMUTAZIONE RETE NORMALE – RETE DI EMERGENZA
La commutazione rete normale-rete di emergenza è stata prevista all’interno del
quadro generale di bassa tensione utilizzando una coppia di interruttori motorizzati
ed interbloccati così da rendere possibile la manovra anche sottocarico. Gli
interruttori previsti possiedono tutti un potere di interruzione minimo superiore alla
corrente di corto circuito simmetrica massima presunta derivante dai calcoli di
dimensionamento degli impianti.
Dal quadro QGBT è alimentato direttamente anche il gruppo di pompaggio della rete
di pressurizzazione idrica antincendio. Ai gruppi di pressurizzazione giungeranno
due linee (ridondanti) in cavo resistente al fuoco FTG10, con posa in tubazione
dedicata incassata a pavimento, quindi protette dal fuoco con grado di protezione
conforme a quanto richiesto dalle coesistenti norme UNI 9490 e UNI EN 12845.
55
2.5
SISTEMI DI AUTOPRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
2.5.1
GRUPPO ELETTROGENO ESISTENTE
L'alimentazione di riserva è realizzata mediante un Gruppo Elettrogeno esistente ad
avviamento automatico, installato in apposito locale, adiacente alla Cabina di
Trasformazione, in accordo alle Normative e Legislazioni vigenti (Decreto 22 ottobre
2007) della potenzialità di 250 kVA, completo di Quadro per telecomando,
commutazione e controllo, serbatoio di servizio da 120 l.
La potenzialità del gruppo è tale da sopperire al carico totale dell'impianto in
condizioni di riserva ad una tensione trifase con neutro di 400/230 V-50 Hz.
L'inserimento del gruppo al mancare della tensione di rete o all'abbassarsi di essa al
85%, è effettuato entro 10 sec. e sia l'inserimento sia il ripristino sull'alimentazione
di rete avverrà in modo automatico, mediante un gruppo di commutazione retegruppo posto sul quadro generale.
Il gruppo elettrogeno è dotato di una cofanatura di insonorizzazione da interno o da
esterno per la protezione dagli agenti atmosferici e per l’abbattimento del rumore nei
limiti consentiti in accordo al DPR 1 Marzo 1991 a valori di circa 50 dBA.
2.5.2
GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'
L'alimentazione di sicurezza è realizzata mediante un Gruppo Statico di Continuità
installato nella Cabina di Trasformazione, in accordo alle Normative e Legislazioni
vigenti, completo di Batteria ad accumulatori di tipo al piombo ermetico poste in
armadio con un’autonomia di 15’ della potenzialità di 30 kVA.
La potenzialità del gruppo è tale da sopperire al carico totale dell'impianto in
condizioni di sicurezza ad una tensione trifase con neutro di 400/230 V-50 Hz o
monofase 230 V.
Il sistema statico di continuità (UPS) ha una configurazione a doppia conversione
con by-pass di tipo intelligente. Nel modo normale di funzionamento, il carico è
alimentato a ciclo continuo dalla combinazione raddrizzatore/invertitore con struttura
a doppia conversione, ovvero c.a. - c.c. - c.c. - c.a.
Quando l’alimentazione c.a. d’ingresso non rientra nelle tolleranze preimpostate
dell’UPS, questo entra nel modo di funzionamento da batteria, nel quale la
combinazione batteria/invertitore continuerà a supportare il carico fino
all’esaurimento dell’energia immagazzinata (autonomia) o fino al rientro della
alimentazione di ingresso entro le tolleranze ammesse dall’UPS.
L’UPS a doppia conversione è talvolta definito come “On-Line”, in quanto il carico è
sempre
alimentato
dall’invertitore,
indipendentemente
dalla
condizione
dell’alimentazione c.a. d’ingresso.
56
UPS a doppia conversione e by-pass
Il sistema statico di continuità in riferimento alla norma CEI EN 62040-3 che
stabilisce la classificazione degli UPS in base alle loro prestazioni, ha il seguente
“codice di classificazione”: VFI-SS-111
dove:
- VFI: (Voltage and Frequency Independent) indica che l’uscita dell’UPS è
indipendente dalle variazioni della tensione di alimentazione (rete) e le variazioni
di frequenza sono controllate entro i limiti prescritti dalla norma IEC EN 61000-22 (la norma definisce i livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa
frequenza sulle reti pubbliche a Bassa Tensione prima del collegamento di un
carico). Questo tipo di UPS può anche funzionare come convertitore di
frequenza.
- SS: definisce la forma d’onda d’ingresso e d’uscita durante il funzionamento
normale e da batteria che è sinusoidale (THDu < 8%)
57
-
111: definisce la prestazione dinamica della tensione d’uscita alle variazioni di
carico in tre diverse condizioni:
a) variazione delle modalità operative (normale e da batteria),
b) inserzione del carico lineare a gradini in modalità normale e da batteria,
c) inserzione del carico non-lineare a gradini in modalità normale e da
batteria.
Per ciascuna di queste condizioni la prestazione dinamica può variare tra 1
(nessuna interruzione) e 3.
Il sistema funziona tramite un inverter a IGBT basato su microprocessore e con la
tecnologia del controllo vettoriale è possibile migliorare le prestazioni dell’inverter.
L’affidabilità del sistema è migliorata da un by-pass statico elettronico indipendente.
UPS fornisce un’alimentazione AC di alta qualità agli apparecchi elettronici e
presenta i seguenti vantaggi:
• miglioramento della qualità dell’alimentazione
• elevata attenuazione dei disturbi RFI
• compatibilità totale con tutti i carichi
• protezione dalle interruzioni di alimentazione
• gestione totale della batteria.
UPS è in grado di fornire automaticamente alimentazione affidabile entro i limiti
prestabiliti e senza interruzione, in caso di guasti o mancanza rete. La durata
dell’alimentazione ausiliaria, vale a dire l’autonomia nel caso di guasto alla rete,
sarà garantita dalle batterie per 1h a pieno carico.
La continuità dell’alimentazione al carico è maggiormente garantita dal bypass
attraverso un commutatore automatico in caso di:
a) Guasto dell’UPS;
b) Correnti di spunto o correnti di corto circuito;
c) Sovraccarico;
d) Manutenzione.
L’UPS è costituito dai seguenti componenti principali:
• Raddrizzatore/caricabatteria/interruttore batteria elettronico
• Inverter a IGBT (transistore bipolare a porta isolata)
• Elaboratore digitale di segnale (DSP)
• Commutatore statico e rete di riserva
• Interruttore di by-pass manuale
• Appositi armadi batteria
Il funzionamento ed il controllo dell’UPS si avvalgono di una logica controllata da
microprocessore. Un display illuminato a cristalli liquidi (LCD), con quaranta
caratteri, mostra indicazioni, misure e allarmi, oltre all’autonomia della batteria. Le
operazioni di avvio, spegnimento, trasferimento manuale del carico su bypass e
ritorno da bypass sono chiaramente spiegate sul display attraverso routine di
operatività guidata.
L’UPS è dotato dei dispositivi di controllo, strumenti ed indicatori necessari
all’operatore per monitorare lo stato e le prestazioni del sistema ed adottare le
misure appropriate. Inoltre, sono disponibili delle interfacce che consentono di
estendere il monitoraggio ed il controllo anche in remoto.
Il locale ove è prevista l’installazione di questo sistema sarà dotato di un impianto di
climatizzazione autonomo, adeguatamente dimensionato e ridondato.
58
2.5.3
SISTEMI AUTONOMI DI ALIMENTAZIONE AD INVERTER
L'illuminazione di sicurezza, è realizzata mediante l'uso di Gruppi autonomi di
alimentazione ad inverter ed accumulatori al piombo o Ni-Cd, cablati direttamente
sulle apparecchiature di illuminazione funzionanti sia in modo permanente sia come
nel caso di apparecchi per l'indicazione delle vie d'esodo in modo non permanente
ad una tensione monofase di 230 V-50 Hz con un'autonomia minima di 1 h.
2.6
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
La distribuzione dell'energia elettrica è di tipo radiale, suddivisa in distribuzione
primaria, Quadri Secondari di zona e distribuzione secondaria.
2.6.1
DISTRIBUZIONE PRIMARIA
La distribuzione primaria include i collegamenti e le canalizzazioni tra il Quadro
Generale di Bassa Tensione e i Quadri Secondari di distribuzione alle varie zone.
Le alimentazioni sono realizzate in cavo multipolare, con tensioni di isolamento fino
a 600/1000 V, posate in canalette di tipo chiuso o forato di adeguate dimensioni
(con un riempimento del 50%), o in tubazioni di PVC pesante autoestinguente,
posate in vista o in traccia (con un riempimento del 70%).
Le linee di alimentazione delle sezioni dei quadri di energia normale o di riserva, a
meno delle alimentazioni di carichi in emergenza (gruppi di pressurizzazione,
ascensori di emergenza) sono realizzate in cavo multipolare di tipo G7 a bassa
emissione di gas tossici e corrosivi, posati in canalette o tubazioni separate da
quelle per la distribuzione in energia normale.
Le linee di alimentazione delle sezioni dei quadri di energia di sicurezza
(alimentazione da generatori centralizzato UPS) e di emergenza (gruppi di
pressurizzazione, ascensori di emergenza) sono realizzate in cavo multipolare di
tipo TG10 20-45 a bassissima emissione di gas tossici e corrosivi resistenti al fuoco,
posati in canalette o tubazioni separate da quelle per la distribuzione in energia
normale.
Per la distribuzione mediante tubazioni, si utilizzano anche delle scatole di
derivazione di transito del tipo in resina autoestinguente da incasso o sporgente,
poste almeno ogni 10 metri.
I cavi che alimentano i quadri all'interno di ambienti con apparecchiature
d'informatica sono di tipo G7 non propagante l'incendio e schermati.
I cavi all'esterno sono posati in tubazioni di tipo underground direttamente interrate.
2.6.2
QUADRI SECONDARI DI ZONA
Ogni zona funzionale è dotata di un proprio Quadro, del tipo protetto ad armadio o
del tipo a parete senza alcuna segregazione delle apparecchiature (Forma 1
59
seconda Norma CEI 17-13/1) contenente, le apparecchiature di controllo,
protezione e comando dei circuiti che alimentano gli utilizzatori.
I Quadri Secondari in genere sono dotati di un interruttore generale non automatico
e lampade spia di segnalazione, per ogni sezione di esso, dal quale si derivano due
sotto-sezioni ciascuna protetta da un interruttore magnetotermico per
l'alimentazione delle utenze luce, la prima, mentre la seconda alimenta le utenze
energia e forza motrice.
Le linee che alimentano i circuiti in partenza dal Quadro sono protette da interruttori
magnetotermici differenziali con sensibilità di 30 mA.
2.6.3
DISTRIBUZIONE SECONDARIA
La distribuzione secondaria include, i collegamenti e le canalizzazioni che dai
Quadri Secondari di zona raggiungono le varie utenze luce, energia e forza motrice.
I circuiti luce, energia e forza motrice sono realizzati con conduttore unipolare tipo
N07 non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, per
tensioni di esercizio 450/750 V e con sezioni minime agli utilizzatori di 1,5 mmq per i
circuiti luce e 2,5 mmq per i circuiti energia e forza motrice, posati in canalette
chiuse di PVC (con un grado di riempimento del 50%) o in tubazioni in PVC rigido
pesante autoestinguente se posate in vista o flessibile di tipo autoestinguente se
posate in traccia (con un grado di riempimento del 70%).
Per la distribuzione sono utilizzate anche scatole di derivazione e da frutto del tipo
in resina autoestinguente da incasso o sporgente.
Le scatole di derivazione sono complete di morsettiere, poste almeno ogni 10 metri.
Per la distribuzione sottopavimento si adotta l'uso di tubazione in PVC rigido o
flessibile di tipo pesante e scatole di smistamento o di derivazione, il tutto
direttamente affogato nel massetto in cls di sottofondo del pavimento.
I circuiti luce di sicurezza alimentati mediante un generatore centralizzato (UPS)
sono realizzate con un multipolare di tipo TG10 20-45 a bassissima emissione di
gas tossici e corrosivi resistenti al fuoco, di sezione minima all’utilizzatore pari a 1,5
mmq posanti in canalette o tubazioni.
I circuiti per l'energia di I Categoria hanno necessariamente una distribuzione
separata dai circuiti di 0 Categoria, di segnalazione comando e controllo e dai
circuiti di sicurezza.
In ambienti umidi o bagnati e all'esterno sono usati per la distribuzione secondaria,
dei cavi multipolari di tipo G7, come già visto per la distribuzione primaria.
I cavi all'esterno sono posati in tubazioni di tipo underground direttamente interrati.
2.6.4
DISTRIBUZIONE SECONDARIA
NORMALE E DI SICUREZZA
60
IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE
Illuminazione normale
L’impianto di illuminazione sarà conforme alla norma UNI EN 12464 e realizzato in
modo da garantire i livelli di illuminamento richiesti.
L'impianto di illuminazione é eseguito principalmente con le modalità di seguito
descritte:
• dorsale principale in conduttore unipolare in rame isolati in gomma PVC non
propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo N07
posato in tubazione di tipo pesante rigida o flessibile posta nel controsoffitto
o in traccia;
• cassette di derivazione in materiale plastico autoestinguente, idonee per
ambienti a maggior rischio in caso di incendio, con coperchio fissato tramite
viti e passacavi, complete di morsetti a mantello per l’attestazione dei cavi e
dei conduttori;
• raccordi e manicotti con grado di protezione IP44 che assicurino una
maggiore robustezza dell’impianto nel suo insieme.
• circuito terminale in conduttore unipolare in rame N07 non propagante
l’incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, posato in tubazione di
PVC pesante flessibile ad incasso;
• tratto finale all'apparecchio di illuminazione posto in controsoffitto con cavo
multipolare flessibile e prestazioni caratteristiche come sopra indicato;
• comando locale tramite interruttori, deviatori o pulsanti in contenitore da
incasso.
Illuminazione di sicurezza
L’illuminazione di sicurezza è garantita da gruppi autonomi ad inverter installati sugli
apparecchi destinati a questo scopo.
Il sistema di illuminazione di sicurezza sarà in grado di garantire un illuminamento
medio di 5 lux in tutti i locali dell’edificio ove sia prevista la presenza di persone,
salvo diverse prescrizioni normativelegate a situazioni o a locali particolari.
Per la segnalazione delle vie di esodo saranno previsti apparecchi illuminanti con
gruppo autonomo di sicurezza ad inverter, equipaggiati con pittogrammi indicanti le
vie di fuga.
2.6.5
CORPI ILLUMINANTI
I corpi illuminanti da installare nei vari ambienti sono, di volta in volta scelti, in
funzione di molteplici criteri qui, di seguito elencati:
- il grado di protezione previsto per l'ambiente in esame
- il tipo di ottica necessario all'ambiente in funzione delle attività che in esso si
svolgono
- il tipo di ambiente e la qualità di arredamento che in esso si vogliono realizzare
- il tipo di esecuzione da adottare, se sporgente o da incasso.
Le caratteristiche dei corpi illuminanti principalmente previsti nei vari ambienti sono
qui di seguito elencate:
•
Aule e Biblioteca: plafoniere a file di canale luminoso con reattori
ferromagnetici e starter o corpi illuminanti da parete con lampade alogene.
61
•
Corridoi e atri: plafoniere con schermo chiuso trasparente di tipo da incasso,
se questi sono controsoffittati, o corpi illuminanti di tipo sospeso negli altri casi,
complete di reattori a basso consumo.
•
Illuminazione di sicurezza: nei corridoi, nelle scale, nelle vie d'esodo e negli
ambienti con possibile affollamento, sono previsti dei corpi illuminanti cablati con
gruppi autonomi di alimentazione e plafoniere per la segnaletica, anche queste
autolalimentate e poste in modo ben visibile.
•
Uffici: plafoniere con schermo lamellare in alluminio di tipo da incasso darklight alimentate con reattori a basso consumo.
2.6.6
DISTRIBUZIONE
MOTRICE
SECONDARIA
IMPIANTO
PRESE
E
FORZA
La rete di distribuzione prese e forza motrice comprende:
• l'alimentazione delle utenze forza motrice;
• le prese di tipo civile e di tipo industriale.
Impianto per Utenze di Forza Motrice
L'impianto che consente di alimentare le utenze di forza motrice è eseguito
principalmente con le modalità di seguito descritte:
• l’alimentazione dell’utenza è realizzata in cavo multipolare isolati in gomma
EPR non propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi
di tipo FG7 (le alimentazioni degli apparati di sicurezza sono in cavo
multipolare con conduttori in rame isolati in gomma EPR sotto guaina
termoplastica non propagante l'incendio a bassissima emissione di gas
tossici e corrosivi e resistenti al fuoco di tipo FTG10), mediante un’unica
tratta che dal dispositivo di protezione posto sul quadro, si attesta ad un
sezionatore o ad una presa di tipo industriale CEE posta in prossimità
dell’utenza medesima;
• la dorsale principale è posata in canalina di acciaio zincato o passerella
portacavi in fili d’acciaio;
• le cassette di derivazione sono in materiale plastico autoestinguente, idonee
per ambienti a maggior rischio in caso di incendio, con coperchio fissato
tramite viti e passacavi;
• i raccordi e manicotti sono con grado di protezione IP44, per assicurare una
maggiore robustezza dell’impianto nel suo insieme.
• i tratti verticali ed orizzontali che si derivano dalla canalina per raggiungere
l’utenza sono realizzati medinate tubazione di PVC pesante flessibile ad
incasso o mediante tubazione di PVC pesante rigido posto sporgente a
vista;
• il tratto finale che dal dispositivo di sezionamento (sezionatore o presa
industriale CEE) si collega all’utenza F.M., è realizzato in cavo multipolare
flessibile con conduttori di rame isolati in gomma EPR sotto guaina
termoplastica non propagante l'incendio a bassissima emissione di gas
tossici e corrosivi di tipo FG7, senza alcuna protezione o protette mediante
una tubazione isolanta di guaina spiralata in materiale termoplastico a base
di PVC rigido pesante per la guaina esterna e in acciaio zincato per la
spirale interna.
Impianto per prese di tipo civile e di tipo industriale
L'impianto prese è eseguito principalmente con le modalità di seguito descritte:
62
• dorsale principale in conduttore unipolare di rame isolati in gomma PVC sotto
guaina termoplastica non propagante l'incendio a bassissima emissione di
gas tossici e corrosivi, tipo N07 posato in tubazione rigida o flessibile di tipo
pesante;
• cassette di derivazione in materiale plastico autoestinguente, idonee per
ambienti a maggior rischio in caso di incendio, con coperchio fissato tramite
viti e passacavi, complete di morsetti a mantello per l’attestazione dei cavi e
dei conduttori;
• raccordi e manicotti con grado di protezione IP44, che assicurino una
maggiore robustezza dell’impianto nel suo insieme.
• circuito terminale fino alla presa, in conduttore unipolare di rame con isolante
elastomerico di qualità N07 non propagante l’incendio a bassa emissione di
gas tossici e corrosivi, posato in tubazione di PVC pesante flessibile ad
incasso o in tubazione di PVC pesante rigida posta sporgente in vista;
• eventuale comando locale tramite interruttori, in contenitore da incasso.
Il conduttore di protezione sarà inglobato nella formazione del cavo quando
possibile.
All’interno di ogni locale saranno previste prese elettriche in quantità tale da rendere
i locali funzionali e flessibili per il futuro.
Le prese saranno incassate nelle pareti o applicate a vista alle pareti, secondo il tipo
e la natura del locale in cui sono installate.
Gli utilizzatori di potenza unitaria superiori a 1.000 W saranno dotati di un proprio
interruttore di protezione e/o con interruttore di interblocco.
2.6.7
APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE
Prese di tipo civile
Le prese di tipo civile utilizzate sono del tipo modulare per installazione dentro
scatole modulari portafrutto ad incasso o sporgenti a parete o dentro torrette poste
a pavimento.
Le scatole porta frutto sono idonee per la protezione dalle parti sotto tensione.
Gli alveoli delle prese sono segregati con grado di protezione 2.1 e con i morsetti di
fissaggio dei cavi, posti posteriormente e di dimensioni sufficienti per il
collegamento di conduttori da 2,5 e 4 mmq.
Le caratteristiche elettriche sono:
- tensione nominale 250V/50Hz
- corrente nominale 10A e 16A
Tutte le prese sono corredate di spinotto centrale per il collegamento dell'utenza al
conduttore di terra.
Le prese di tipo civile devono essere conformi alle Norme CEI 20-35.
Le prese utilizzate sono delle seguenti tipologie:
P11:
Presa 2x10A+T
P17:
Presa 2x16A+T
P30:
Presa UNEL o SHUKO 2x16A+T
P17/11:
Presa bipasso 2x10/16A+T
P30/17/11:
Presa universale 2x10/16A+T
63
Le prese di tipo civile sono utilizzate normalmente nei luoghi ove previste, in gruppi
di prese che uniscono prese sia di tipo universale che bipasso, per rendere più
flessibile il loro utilizzo.
I gruppi prese sono normalmente alimentati sia con energia normale o di
emergenza, sia con energia di sicurezza.
Prese di tipo industriale
Le prese di tipo industriale utilizzate sono del tipo CEE a spina interbloccata, per
installazione sporgente a parete o da incasso per posa dentro centralina di
distribuzione.
Le prese a spina interbloccata tipo CEE sono realizzate in resina ad isolamento
totale, con elevata resistenza agli urti, al calore ed agli agenti corrosivi, conforme
alle norme CEI 23-12, costituita da custodia, interruttore di blocco, portavalvole con
fusibili e presa.
Le caratteristiche elettriche sono:
- tensione nominale 250V/50Hz o 400V/50Hz
- corrente nominale 16A, 32A e 63A
- grado di protezione IP65
2.6.8
IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI
Gli impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici comprendono principalmente:
• linee e collegamenti per le alimentazioni delle utenze meccaniche quali
pompe, unità di trattamento aria, gruppo frigo, apparecchiature tecnologiche
varie indicate sugli schemi elettrici e sui disegni meccanici.
• tubazioni e canalizzazioni per la distribuzione dei cavi di potenza, di comando
e quelli dell’impianto di regolazione.
• quadri di protezione, comando e distribuzione (compreso ausiliari, relè,
selettori e quanto necessario per l’interfacciamento con il sistema di controllo
e regolazione.
• prove di funzionamento.
Sono invece a carico dell’impiantista meccanico i collegamenti, i cavi, le
apparecchiature e i quadri di contenimento che riguardano l’impianto di regolazione
e supervisione.
I cavi saranno multipolari con conduttori di rame isolati in gomma EPR sotto guaina
termoplastica di qualità antifiamma, non propagante l'incendio secondo le norme
CEI 20-22 tipo FG7(O)R se posati all’esterno dell’edificio e a bassa emissione di
fumi e gas tossici tipo FG7(O)M1 se posati internamente. Il conduttore di protezione
sarà inglobato nella formazione del cavo.
I cavi saranno posati su passerella portacavi in fili d’acciaio per la parte dorsale e in
tubazioni rigide e/o flessibili in pvc per la parte terminale.
Accanto ad ogni motore sarà posato un interruttore di manovra sezionatore sotto
carico in custodia stagna, adatto ad aprire tutte le fasi attive; il circuito terminale
dall'interruttore al motore sarà eseguito con guaina flessibile.
64
2.7
IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
L'impianto è realizzato in conformità alle Norme CEI 64-8, CEI 64-12 e CEI 11-1.
Intorno al perimetro dell'edificio si realizza una rete ad anello costituita da una corda
di rame nudo, di adeguata sezione, interrata ad intimo contatto con il terreno, che
collega i dispersori a picchetto infissi nel terreno, posti dentro pozzetti ispezionabili.
A tale rete di dispersione si collegano tramite uno o più conduttori di terra, il nodo di
terra della Cabina di trasformazione, l'impianto di terra della Cabina e l'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche.
Al nodo di terra sono realizzati i seguenti collegamenti:
- il neutro del centro stella dei trasformatori;
- il neutro dei generatori ausiliari di riserva e di sicurezza;
- l'impianto di terra a protezione della Cabina di trasformazione;
- i conduttori di protezione del Quadro Generale di Bassa Tensione, dei Quadri
Secondari di zona, delle utenze e delle masse;
- i conduttori equipotenziali che collegano tutte le masse dell’edificio, quali le
carpenterie dei quadri metallici, le canaline metalliche e tutte quelle parti
conduttrice relative all’impianto elettrico che possono a seguito di guasti avere un
potenziale elettrico diverso da zero.
- i conduttori equipotenziali che collegano tutte le masse estranee dell'edificio, quali
le tubazioni di adduzione degli impianti idrico e di riscaldamento o
climatizzazione, intercettate agli ingressi di ogni ambiente;
I conduttori adottati per l'impianto di terra sono di tipo unipolare N07 non propagante
l'incendio, di colore giallo-verde e di sezione dimensionata secondo normativa.
65
2.8
IMPIANTO DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE CONTRO I
FULMINI
Il dimensionamento dell'impianto di protezione delle strutture contro i fulmini è stato
effettuato in base ai criteri esposti nelle Norme CEI EN 62305-1, CEI EN 62305-2,
CEI EN 62305-3, CEI EN 62305-4.
L'obbligatorietà della sua realizzazione è resa necessaria nel caso in cui la
valutazione del rischio evidenzi la pericolosità dei fulmini per la loro azione diretta e
indiretta.
I tipi di perdita risultanti dai tipi di danno ed i rischi corrispondenti sono riportati nella
figura che segue.
Al fine di valutare se la protezione sia o meno necessaria, deve essere effettuata la
valutazione del rischio.
Devono essere considerati i seguenti rischi, corrispondenti ai tipi di perdita:
- R1 : perdita di vite umane
- R2 : perdita di servizio pubblico
- R3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile
La protezione contro il fulmine é necessaria se il rischio R (R1, R2 ed R3) é
superiore al livello di rischio tollerabile RT
R > RT
In questo caso devono essere adottate misure di protezione al fine di ridurre il
rischio R (R1, R2 ed R3) al valore di rischio tollerabile RT
R ≤ RT
66
Se uno o più tipi di perdita possono verificarsi nell’oggetto da proteggere, la
condizione R ≤ RT deve essere soddisfatta per ciascun tipo di perdita (L1, L2 e L3).
Le funzioni di un impianto di protezione esterno sono:
- intercettare il fulmine sulla struttura (mediante il sistema di captatori)
- condurre a terra in modo sicuro le correnti di fulmine (mediante il sistema di calate)
- disperdere le correnti sopraccitate nel suolo (mediante il sistema di dispersori).
La funzione di un impianto di protezione interno è quella di prevenire scariche
pericolose all’interno della struttura utilizzando collegamenti equipotenziali o
rispettando la distanza di sicurezza, “s”, (e quindi realizzando un isolamento
elettrico) tra i componenti dell’LPS e gli altri elementi conduttori interni alla struttura.
Sono definiti, mediante un insieme di regole costruttive, quattro tipi di LPS (I, II, III e
IV) basati sui corrispondenti LPL. Ciascun insieme comprende regole di costruzione
dipendenti dal LPL (es.: raggio della sfera rotolante, larghezza delle maglie, ecc.) e
regole indipendenti dal LPL (es.: sezioni, materiali, ecc.).
Se è installato un LPS, l’equipotenzializzazione è una misura di protezione
importante per ridurre i rischi di incendio, di esplosione e di danno agli esseri
viventi.
I provvedimenti atti a limitare lo sviluppo e la propagazione dell’incendio, quali la
compartimentazione antincendio, estintori, idranti, impianti d’allarme e di
spegnimento, possono ridurre i danni materiali.
Vie di fuga protette assicurano la protezione delle persone.
Se la resistività superficiale del suolo all’esterno della struttura e del pavimento
interno alla struttura stessa non è sufficientemente elevata esiste il pericolo di
danno agli esseri viventi per le tensioni di contatto e di passo che può essere
ridotta:
- esternamente alla struttura, mediante l’isolamento delle parti conduttive esposte,
l’equipotenzializzazione realizzata con un dispersore magliato, barriere e cartelli
ammonitori;
- internamente alla struttura, mediante l’equipotenzializzazione dei servizi nel punto
di ingresso nella struttura.
L’equipotenzializzazione non è efficace contro le tensioni di contatto.
Un incremento della resistività superficiale del suolo all’interno ed all’esterno della
struttura può ridurre il rischio per gli esseri viventi (Art. 8 della CEI EN 62305-3).
Un’efficace protezione contro le sovratensioni responsabili dei guasti negli impianti
interni può anche essere ottenuta mediante un sistema di SPD che limiti l’ampiezza
delle sovratensioni a valori inferiori alla tensione nominale di tenuta del sistema da
proteggere.
Gli SPD devono essere scelti in accordo con le prescrizioni della CEI EN 62305-4.
Una protezione molto efficace per i cavi interrati è costituita da schermi metallici
continui di spessore adeguato o in condotti metallici.
Percorsi ed apparati ridondanti, gruppi autonomi di generazione, sistemi di
continuità, sistemi di accumulo dei fluidi e rivelazione automatica dei guasti sono
misure di protezione efficaci per ridurre la perdita dell’attività del servizio.
67
Un incremento della tensione di tenuta degli isolamenti degli apparati e dei cavi è
un’efficace misura di protezione contro i guasti dovuti a sovratensioni.
Il rischio, definito nella Norma come la probabile perdita media annua dovuta al
fulmine in una struttura e in un servizio, dipende da:
– il numero annuo di fulmini che interessano la struttura ed il servizio;
– la probabilità che un fulmine interessi la struttura o al servizio provochi danno;
– l’ammontare medio della perdita conseguente.
La probabilità di danno da fulmine dipende dalla struttura, dal servizio, dalle
caratteristiche della corrente di fulmine, nonché dal tipo e dall’efficienza delle misure
di protezione adottate.
L’applicazione di tali considerazioni e la valutazione del rischio sulla struttura in
oggetto da proteggere ha evidenziato la necessità di realizzare una protezione con
un LPL di I livello ed una protezione mediante un sistema di SPD da installare sui
quadri elettrici e sulle linee entranti.
L'impianto di protezione delle strutture contro i fulmini è del tipo LPS a gabbia di
Faraday ed è costituito da una rete di captazione del tipo a maglia in tondino di
rame di livello II, posta in opera sulla copertura dell'edificio su appositi supporti
correttamente distanziati.
Il collegamento tra la maglia di captazione e le discese mediante i ferri dei pilastri
sono realizzate mediante morsetti a compressione.
Le calate sono sezionabili, per consentire la misurazione dei valori di terra e
collegate all'anello dell'impianto di terra.
Sono connesse inoltre alla rete di captazione anche le seguenti masse estranee:
- elementi metallici o infissi metallici posti in copertura
- infissi posti in facciata ed ad una distanza dei ferri dei pilastri o delle calate
inferiore a quello calcolato e pertanto consentito.
2.9
ILLUMINAZIONE ESTERNA
L'illuminazione della viabilità esterna e perimetrale del complesso, è realizzata
mediante un impianto costituito da armature per illuminazione delle zone a verde
poste su pali di altezza pari a 3,5m f.t. dotate di lampade al Na a.p., alimentati dal
quadro posto in cabina di trasformazione e comandati da interruttori crepuscolari.
Il collegamento elettrico per questi dispositivi viene realizzato mediante un cavo
multipolare di tipo G7, posato in tubazioni di tipo underground.
68
2.10
BARRIERE TAGLIAFIAMMA
Le aperture realizzate in corrispondenza di compartimentazioni antincendio, sulle
pareti o sui solai, per il passaggio delle condutture e delle canalizzazioni, devono
essere ripristinate in accordo con il grado di resistenza all’incendio prescritto (REI
120/180),
per
il
rispettivo
elemento
costruttivo
dell’edificio
prima
dell’attraversamento (Norma ISO 834), mediante barriere tagliafuoco di tipo passivo.
2.11
RIMOZIONE DI IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI ESISTENTI
E’ prevista la rimozione di tutti gli impianti elettrico e speciali esistenti ed in
particolare:
• rimozione dei quadri elettrici secondari di alimentazione e della quota parte del
quadro principale di distribuzione
• rimozione di tutte le linee di alimentazione dei quadri elettrici delle utenze luce
e delle utenze FM (cavi, conduttori, scatole da incasso, scatole sporgenti,
canaline di qualsiasi tipo, tubazioni sia da incasso che sporgenti).
• rimozione di tutti i corpi illuminanti
• rimozione di tutte le apparecchiature di comando e di utilizzazione.
• rimozione di tutti gli impianti speciali in ogni loro parte e componente.
Compreso lo scarrettamento dei materiali mediante mezzi meccanici e a mano ed il
trasporto alla discarica autorizzata di tali materiali ed il frazionamento del distacco e
di allaccio delle nuove linee e delle nuove apparecchiature, per la continuità
eventuale dell'esercizio.
69
3
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI SPECIALI
3.1
IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO
Il cablaggio strutturato è il supporto fisico sul quale basare il trasporto delle
segnalazioni fonia/dati.
E’ pertanto di fondamentale importanza realizzare un cablaggio strutturato secondo
le tecnologie più evolute che assicuri la compatibilità con i sistemi operativi di rete
più diffusi e consenta l’evoluzione della rete anche in ambito ATM.
L’architettura dell’impianto prevedere una struttura a topologia di tipo stellare, che
consenta evoluzioni future e presenta le seguenti performance:
•
Connettività fisica omogenea per tutta la rete;
•
Prestazioni in termini di velocità adeguata alle esigenze attuali e future;
•
Possibilità di seguire le evoluzioni tecnologiche;
•
Facilità di gestione e d’espansione delle rete, sia in caso di spostamenti, che
d’interruzioni o malfunzionamenti;
•
Conformità alle raccomandazioni internazionali e nazionali riguardo al
materiale utilizzato e alle procedure d’installazione e collaudo;
•
Supporto di protocolli Standard di comunicazione;
•
Possibilità di far evolvere le applicazioni supportate senza modificare la
struttura portante dell’infrastruttura.
•
Semplicità nella gestione, nella riconfigurazione e nell’espansione della rete,
nonché nella manutenzione per la ricerca e la riparazione di guasti.
•
Segmentabilità del cablaggio per realizzare reti locali dati a specifica diversa;
•
Facilità d’estensioni in senso lato (realizzazione d’altri punti di concentrazione,
collegamento con eventuali altri piani, corpi d’edificio e/o sedi esterne ecc..)
La realizzazione di una rete di comunicazione multimediale a cablaggio strutturato,
consente il collegamento dei punti utenza dislocati nell’edificio e l’integrazione tra le
varie strutture ambientali su cui costruire e far evolvere l’intera area degli impianti
esistenti nell’edificio.
L’impianto di cablaggio dovrà interfacciarsi con gli impianti, i sistemi e i gestori di
vario tipo esistenti quali:
- utenze telefoniche;
- utenze per la trasmissione dati
- server di sistema per la supervisione gestionale e di controllo degli impianti
elettrici e meccanici;
- server di sistemi per la rivelazione automatica dell’incendio;
- server di sistemi antintrusione ed antieffrazione;
- server di sistemi per il controllo accessi;
L’introduzione di un tale sistema consentirà di migliorare i flussi di lavoro ripensando
ed ottimizzando il modo in cui le informazioni verranno raccolte, immagazzinate,
distribuite ed usate.
I vantaggi di cui si usufruirà sono i seguenti:
- Migliore accessibilità e disponibilità dell’informazione e dei dati;
- Diminuzione del tempo impiegato nell’inserimento dei dati;
- Diminuzione dell’incidenza degli errori umani;
Essendo, ormai, requisito importante la possibilità di riorganizzare e spostare il
personale, introdurre nuovi servizi, semplicemente modificando le connessioni su di
70
un pannello di commutazione, piuttosto che con costosi interventi di rifacimento
della cablatura negli uffici dell’edificio, sarà realizzato il concetto di gruppi di lavoro
distribuiti e LAN virtuali.
SCHEMA DI PRINCIPIO RETE LAN
L’architettura grantirà la continua migrazione del sistema acquisito in linea con gli
Standard emergenti e le nuove tecnologie, consentendo l’inserimento di moduli
Hardware e Software orientati alla fornitura di Funzioni/Servizi necessari al
soddisfacimento delle reali necessità.
Il cablaggio dovrà essere conforme alla normativa TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801 ed
EN 50173. Ad esse si dovrà fare riferimento per quanto riguarda le norme di
installazione, la topologia, i mezzi trasmissivi, le tecniche di identificazione dei cavi,
la documentazione e le caratteristiche tecniche dei prodotti impiegati.
Il cablaggio strutturato, in linea con quanto sopra descritto e con il futuristico
modello di rete multimediale, sarà di tipo Giga Ethernet 1000 Mbit/sec, con
protocollo SNMP in categoria 6.
La struttura logica del sistema può essere così suddivisa:
- Apparati attivi Networking
- Hardware/software per Networking management
- Piattaforma software di Networking management
- Firewall/router per accesso su rete internet
- Firewall/router per policies access controller tra rete internet e rete LAN
- Centrale telefonica ISDN
L’impianto nell’ambito di un edificio, ha la sua origine da un armadio concentratore
primario “BD” (Building distributor) nodo di centro stella, posto nella “sala controllo”
a livello 726,11, al quale si collegheranno tramite apposite canalizzazioni, gli armadi
concentratori di piano “FD” (Floor distributor) ed i server per la gestione ed il
controllo degli impianti.
Il nodo di centro stella sarà costituito da uno o più switch dotati di un adeguato
throughput (capacità di trasmissione effettivamente utilizzata espresso in bit/s) ed
avere un architettura modulare per garantire scalabilità e consentire
l’implementazione di configurazione ridondante per garantire l’affidabbilità di
servizio del sistema.
Tenendo conto delle dimensioni e della struttura dell’edificio da cablare, verranno
realizzati punti di concentrazione per il cablaggio orizzontale (distributori di piano
FD), individuando precisamente la loro posizione, così da distribuire il cablaggio in
modo equilibrato, ovvero ognuno di essi supporterà le prese necessarie a cablare in
modo strutturato ogni singolo piano.
Il sistema di cablaggio strutturato dovrà essere idoneo a supportare connessioni
per: - Token Ring (4-16 Mbit/s), - Ethernet (10 BaseT-100 BaseT) ecc. Con
standard IEEE 802.5, IEEE 802.3, - Local Talk - SNA-IBM - ISDN - RS-232 - RS422 - Voce (Digitale PCM - ISDN ed Analogica) - FDDI/TPDDI/CDDI (100 Mbit/s) ATM (155 Mbit/s) ecc.
DORSALE DATI
71
Le dorsali dati dovranno essere realizzate, solo ed esclusivamente, con cavi in fibra
ottica multimodali o monomodali. Questi dovranno avere un numero di fibre
adeguato a garantire tutti i collegamenti previsti dalle architetture logiche adottate
(stellare e/o a matrice), tenendo inoltre conto degli sviluppi futuri e delle necessarie
fibre di scorta, per singola tratta.
Inoltre dovranno essere realizzati dei percorsi fisici appropriati al fine di garantire
un‘adeguata ridondanza dell’intero impianto.
Il cavo ottico utilizzato nell’applicazione all’interno degli edifici è di tipo:
•
multimodale 50/125 micron tipo tight, LSZH
I patch panel , in funzione del tipo di cavo utilizzato, ospiteranno moduli con bussole
SC (come raccomandato dagli standard EIA/TIA 568B e ISO/IEC 11801).
L’attestazione dei cavi ottici di dorsale deve avvenire su pannelli ottici adatti al
montaggio su rack 19” (1U o superiore).
Il permutatore utilizzato avrà una struttura componibile che permette la massima
flessibilità d’impiego. I moduli con le bussole ottiche avranno una modularità di 6
connettori SC ogni modulo con la possibilità di inserimento ed estrazione dal fronte
del pannello; il cassetto estraibile darà la possibilità di accedere frontalmente alla
parte interna.
Il pannello di attestazione per fibra ottica sarà utilizzato all’interno degli armadi per
l’attestazione della fibra di dorsale. Le interconnessioni saranno realizzate
utilizzando bretelle di permutazione di tipologia omogenea alla fibra installata,
collegate agli apparati attivi e/o altre tratte di dorsale e/o postazioni di lavoro. Sulla
parte frontale del pannello, in corrispondenza di ogni bussola sarà posizionata una
etichetta identificativa della fibra connettorizzata.
Le bretelle di raccordo agli apparati attivi dovranno essere del tipo bifibra
multimodale 50/125 micron e dotate ai due estremi di opportuni connettori ceramici,
di tipo SC, rispettando nel collegamento agli apparati la polarizzazione delle fibre.
La lunghezza della bretella dovrà essere finalizzata in dipendenza delle distanze
medie di permutazione, con lunghezza minima 1 metro. In questo caso saranno
utilizzate bretelle da 2m.
Ciascuna fibra della bretella, sarà singolarmente protetta con rivestimento di tipo
Tight, costituito da filo aramidico e guaina termoplastica ed avrà le stesse
caratteristiche ottiche del cavo installato.
DORSALE FONIA
72
Le dorsali fonia sono costituite da cavi multicoppia in cat. 3 da 100 ohm, 24 AWG
che vanno connessi alle due estremità sui dei permutatori tipo 110. Tali cavi hanno
origine dal permutatore della centrale telefonica e terminano sui permutatori negli
armadi situati nei locali tecnici di edificio e/o di piano. Per l’attestazione dei cavi
multicoppia UTP necessari per il raccordo fonia dal PABX verso gli armadi di
distribuzione, potranno essere utilizzate strisce di permutazione tipo 110, con una
connessione di tipo stellare.
Il cavo multicoppia di dorsale fonia dovrà essere dimensionato considerando
almeno 1,5 coppie per ogni postazione di lavoro presente. Per l’attestazione dei
cavi multicoppia UTP Cat. 3 o superiore necessari per il raccordo fonia dal PABX
verso gli armadi di distribuzione, saranno utilizzate strisce di permutazione 110.
Cavo multicoppia Cat 3 o superiore
1
110 Cross Connect
1Wiring
0
Connecting block 3cp.
4 cp. e 5 cp.
Questa soluzione consente di ottimizzare l’utilizzo delle coppie dei cavi di dorsale
fonia. Tutte le coppie presenti potranno essere efficientemente utilizzate sia per
l’attivazione di apparecchi analogici, sia per apparecchi ISDN o numerici a 4 fili.
NelIa realizzazione delle dorsali fonia, i cavi in rame da impiegare dovranno avere
sempre le caratteristiche tecniche minime, di seguito riportate:
Tipo di cavo : 50, 100 coppie con conduttori in rame elettrolitico ricotto stagnato
24AWG e con codice colori secondo tabella CEI UNEL 00724.
Guaina esterna : colore grigio RAL 7035, costruita con guaine e isolanti di tipo
LS0H, conforme alle normative IEC 60332.1(CE 20-35), CEI 20-22/III.
Distanze: dal PABX al BD
di scorta in ogni armadio)
= 30mt cavo multicoppia per fonia (compresi 5metri
Distanze: dal PABX al FD
di scorta in ogni armadio)
= 50mt cavo multicoppia per fonia (compresi 5metri
CABLAGGIO ORIZZONTALE
Il cablaggio orizzontale dovrà essere di tipo strutturato con tipologia a stella e sarà
costituito dal collegamento tra l’armadio concentratore di piano “FD” e il punto di
utenza “PDL”.
73
stazione di lavoro
concentratore
FD
TR
Max 90 m
Patch cod postazione di lavoro
cavo di apparato + patch cord nell’FD +patch cord postazione di lavoro ≤10 m
Particolari del cablaggio orizzontale
La distribuzione orizzontale comprenderà il collegamento tra ciascuna postazione di
lavoro “PDL” (punto di utenza) e l’armadio concentratore di piano “FD”.
La distribuzione orizzontale ai piani della rete dati e fonia sarà eseguita con utilizzo
di cavo UTP LSZH (doppino twistato) a 4cp coppie categoria 6 che consentirà la
connessione tra le prese d’utente “PDL” ed il relativo armadio concentratore “FD”,
posto ad una distanza max di 90 m. (Max 100 m. comprese le bretelle in rame).
Ciascuna postazione di lavoro “PDL” (punto di utenza) sarà costituita da n.3 prese
RJ45 categoria 6 secondo specifiche di componente EIA/TIA 568-B.2 e EIA/TIA
568-B.2-1, da utilizzare sia per la rete dati (n.2 prese), che per la rete fonia (n.1
presa), complete di scatola portafrutto a tre moduli, supporto e placca, incassate a
parete o poste su torretta a pavimento o postazioni di lavoro dotate di n.3 prese di
cui una presa di tipo EDP collegata con cavo da 2 f.o.
Le prese RJ45 cat.6 dovranno essere di tipo modulare e provviste di icone colorate
asportabili per l’identificazione esterna del servizio dati/fonia ad esse collegato.
A completamento della presa telematica il collegamento tra i connettori posti sulla
placca e il terminale d’utente, dovrà essere costituito da una bretella di raccordo
(Patch Cord) di lunghezza di 3 metri.
La bretella dovrà essere costituita da un cavo a 4cp UTP con impedenza
caratteristica 100 , in rame a filamenti 24-AWG e rispondente alla Categoria 6 con
guaina di protezione ritardante la fiamma (PVC).
Le bretelle RJ45-RJ45 saranno dotati alle due estremità di connettori RJ45 Cat. 6
per la completa connettorizzazione delle 4cp; la tecnologia utilizzata dal costruttore
del sistema passivo permette l’ottimizzazione dell’attestazione del cavo di patch sul
plug, mantenendo separate le coppie fino al punto di attestazione e riducendo al
minimo l’effetto della diafonia tra le coppie, così da rispettare, per i componenti in
Categoria 6 le specifiche richieste dello standard EIA/TIA 568-B.2 - EIA/TIA 568B.2-1. Il plug è iconabile al fine di identificare il servizio ad esso collegato.
74
ARMADIO CONCENTRATORE DI RETE
Tutti gli armadi di rete (armadio di centro stella “BD” e armadi di piano “FD”),
dovranno avere un’organizzazione interna che garantisca un ordinato montaggio di
tutti i componenti installati. Pertanto a tale scopo si dovranno prevedere tutti gli
accessori necessari, quali: passacavo, pannelli ciechi, etc.
Le caratteristiche principali degli armadi sono:
•
Massima accessibilità sia durante il cablaggio sia durante la manutenzione,
grazie alla possibilità di asportare, con semplici e veloci operazioni, i pannelli
laterali ed la porta posteriore.
•
Facilità di allestimento di complessi di armadi affiancati, grazie all'asportabilità
delle pareti laterali.
•
Possibilità del cambiamento del senso di apertura;
•
Possibilità di regolazione del telaio 19'' in relazione alle apparecchiature da
installare.
•
Quattro montanti regolabili da 19"
•
IP 20 : IEC/EN 60529, IK 08 : IEC/EN 62262
•
Ampi spazi laterali tali da consentire anche le installazioni che necessitano
che di grandi quantitativi di cavi.
•
Colore nero, RAL 7021
Per gli armadi di rete andrà sempre prevista l’alimentazione elettrica, che sarà
diversificata in funzione del tipo di armadio e dalla sua ubicazione.
Tutte le linee elettriche devono rispettare, per il dimensionamento e la
documentazione, quanto previsto dalla normativa e legislazione vigente e la
funzionalità dell'impianto è sempre garantita da una stazione di energia di sicurezza
che alimenta gli armadi.
I cavi saranno posati e fascettati nella parte posteriore del permutatore dividendoli a
gruppi fino al raggiungimento del punto di attestazione, onde evitare che il cavo
degradi le sue caratteristiche a causa di eccessive curvature. Il permutatore dovrà
essere dotato di una guida di sostegno e di ancoraggio dei cavi da terminare.
All’interno dell’armadio sono utilizzati accessori che garantiscano le condizioni
ottimali di funzionamento e gestione del cablaggio (ventole termostatate, ripiani,
conaline passacavi verticali, etc).
L’armadio concentratore di rete conterrà sia gli apparati passivi che quelli attivi
dell’impianto.
75
76
APPARATI PASSIVI
All’interno dell’armadio di rete sono posti gli apparati passivi di adeguate
caratteristiche in categoria 6 per il corretto funzionamento dell’impianto.
Cassetti ottici
In ogni armadio è posizionato un cassetto ottico (patch fibre cabinet) per
l’attestazione del cavo ottico di dorsale (l’armadio BD sarà collegato con un cavo sa
6 f.o. proveniete dagli armadi FD con 5 m di scorta).
Il cassetto ottico si collega a sua volta agli apparati attivi del sistema mediante le
bretelle ottiche bifibra SC/SC (optical jumper patching).
Il cassetto ottico avrà una struttura in lamiera metallica verniciata di spessore
10/10mm, parte frontale provvista di supporto per rack 19”, altezza 1U, sul quale
sono inseriti gli adattaori multimodali o monomodali, con le bussole per
l’attestamento delle fibre ottiche o delle bretelle ottiche.
Il sistema inoltre garantisce i corretti raggi di curvatura dei cavi e delle bretelle
grazie alle strutture dedicate di gestione del cablaggio sia interne che esterne. I
cassetti ottici permettono connessioni estremamente flessibili, attraverso una vasta
gamma di adattatori di diversa modularità con bussole LC, SC, ST, FC e MT-RJ per
applicazioni monomodali o multimodali.
Pannelli di permutazione RJ45
Il pannello di permutazione RJ45 orizzontale (patch panel) è utilizzato all’interno
degli armadi per l’attestazione di cavi UTP con le relative bretelle di permutazione
RJ45 (patch cord) verso apparati e/o altre tratte di cavo. Il permutatore avrà una
struttura in lamiera metallica verniciata di spessore 10/10mm, parte frontale
provvista di supporto per rack 19”, altezza 1U con 24 o 48 prese RJ45 di Categoria
6 conformi alla normativa di riferimento EIA/TIA 568-B.2 - EIA/TIA 568-B.2-1.
Le prese RJ45 dovranno avere la possibilità di ospitare icone colorate asportabili
per l’identificazione esterna del servizio dati/fonia ad esse collegato. In alternativa
alle icone potranno essere utilizzati sportellini colorati antipolvere, anch’essi
asportabili e con l’identificativo del servizio dati/fonia connesso alla presa. Le prese
RJ45 saranno provviste di sistema di connessione delle coppie in tecnica IDC
(Insulation Displacement Contact), con etichettatura anteriore e posteriore
(opzionale) per l’identificazione della postazione di lavoro connesse. Posteriormente
i pannelli dovranno avere una barra di fissaggio per i cavi collegati, che garantisca il
corretto supporto e il rispetto dei raggi di curvatura richiesti dagli standard.
Le bretelle di permutazione RJ45 sono realizzate con cavi UTP categoria 6,
intestate da entrambi i lati su Plug RJ45. Le lunghezze, che dovranno essere
standard, saranno scelte in modo adeguato per garantire un’organizzazione
ordinata dell’armadio di permutazione.
Pannelli di permutazione telefonico 110
Il pannello di permutazione telefonico 110 orizzontale (subrack) è utilizzato
all’interno degli armadi per l’attestazione di cavi UTP con le relative bretelle di
permutazione telefoniche 110/RJ45 (patch cord 110/RJ45) verso i pannelli di
permutazione RJ45. Al pannello di permutazione telefonico 110 si attesterà inoltre
la dorsale fonia costituita da cavo multicoppia in cat. 3 da 100 ohm, 24 AWG
proveniente dal permutatore della centrale telefonica.
Il permutatore avrà una struttura in lamiera metallica verniciata di spessore
10/10mm, parte frontale provvista di supporto per rack 19”, altezza 1U, sulla quale
saranno inserite le strisce di permutazione di tipo 110 da 50, 100 o 300 coppie e
prevedono etichettature ed ingresso dei cavi posteriormente. Le striscie 110
77
utilizzano una tecnica di feedback del segnale, interna al connettore C6 110C4 per
controllare la diafonia senza compromettere l’impedenza e sono conformi alla
categoria 6 ed alla normativa di riferimento EIA/TIA 568-B.2-1.
APPARATI ATTIVI
Gli apparati attivi sono esclusi da questo progetto, per consentire in futuro le scelte
più appropriate suglli apparati da installare. L’armadio di rete potrà contenere anche
gli apparati attivi di adeguate caratteristiche.
78
3.2
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO
Il progetto degli impianti di rivelazione prevede la protezione di tutti i locali, di tutte le
zone comuni e dei locali tecnici (centrali tecnologiche e per apparati; sale macchine
ascensori; etc.). La copertura antincendio sarà estesa ai volumi interni, ai
controsoffitti, ai cavedi, ai falsi pavimenti e dove il passaggio di impianti elettrici
eleva il rischio di eventi indesiderati.
I rivelatori risultano distribuiti in maniera da coprire direttamente, ognuno, una
superficie secondo le modalità d’installazione, come definito dalle specifiche norme.
Verranno inoltre analizzati i volumi dell’aria ripresa negli ambienti e trattati dagli
impianti di condizionamento con l’installazione di rivelatori a camera d’analisi posti a
controllo dei tratti principali delle distribuzioni aria.
Il sistema é di tipo modulare, flessibile, di facile ampliabilità, che permette di
eseguire le future evoluzioni degli spazi con interventi minimi su quanto predisposto
(centrali e linee di rivelazione che gestiscono componenti ognuno con una propria
“intelligenza” e che quindi sono in grado di minimizzare i problemi derivanti da
usura, falsi allarmi, condizioni ambientali particolari o sfavorevoli). E’ necessario
che il sistema di rivelazione controlli in modo automatico e/o previo il consenso
dell’operatore dalla “sala controllo”, le procedure da attuare in caso d’incendio,
specificatamente per quanto riguarda i comandi per gli organi di attuazione, per
l’invio delle segnalazioni di allarme ai specifici comparti ed interventi per la
disalimentazione elettrica di apparati o di sezioni di impianto.
Tramite la centrale di rivelazione incendi che gestisce i moduli di attuazione
collegati sui loop dell’impianto di rivelazione incendio é possibile tramite specifici
comandi eseguire le seguenti funzionalità e procedure in caso di incendio:
1.
effettuare lo spegnimento automatico dei ventilatori dell’impianto di
condizionamento delle aree interessate dall’incendio;
2.
effettuare manualmente da parte del personale addetto o dei Vigili del Fuoco il
distacco dei carichi elettrici nelle zone interessate dall’incendio, con l’apertura
degli interruttori posti sul Quadro Generale di Bassa Tensione che alimentano
i quadri elettrici generali di edificio e delle utenze tecnologiche interessate.
Non dovranno essere mai distaccati i circuiti che alimentano le luci di
sicurezza e la linea che alimenta il quadro elettrico della centrale antincendio;
tali circuiti di sicurezza dovranno essere realizzati in cavo tipo FTG10 non
propagante l'incendio e resistente al fuoco secondo la norma CEI 20-45;
3.
effettuare automaticamente il rilascio dei magneti di tenuta porta nelle zone
interessate dall’incendio;
4.
attivare automaticamente le centraline per il controllo dei filtri di
soprapressione;
5.
controllare automaticamente l’apertura e chiusura delle serrande tagliafuoco
poste sulle canalizzazioni dell’impianto d’estrazione fumi;
6.
inviare segnalazioni agli avvisatori ottici-acustici e sirene delle zone
interessate dall’incendio o inviare messaggi preregistati all’impianto di
diffusione sonora;
Le procedure possono inserire ritardi, calibrati sui reali tempi d’intervento del
personale predisposto per la verifica dell’evento segnalato, ridicendo la possibilità di
disservizi derivanti da falsi allarmi. I responsabili, acquisito l’allarme in centrale di
rivelazione e verificato localmente l’evento, possono operare o il reset della centrale
con l’annullamento delle attuazioni programmate o mantenere lo stato d’allarme.
79
Nel corso della realizzazione verranno strettamente osservati gli aspetti delle
installazioni legati alla “sicurezza”, in particolare per quanto relativo alla messa a
terra di tutte le masse estranee ed alla ricompartimentazione di tutte le aperture
eventualmente effettuate sulle pareti con le caratteristiche di resistenza prescritte.
L'impianto di rivelazione incendi ha origine dalla Centrale di rivelazione che è di tipo
elettronico per impianti ad indirizzamento individuale analogico, dotata di
alimentatore autonomo di sicurezza, dalla quale si derivano un numero di linee
chiuse sulla centrale stessa “loop”, pari al numero di zone da controllare e da
servire, che diramandosi da questa effettuano il collegamento di tutte le
apparecchiature in campo e sono in grado di assicurare un colloquio costante con la
centrale anche in caso di interruzione grave e/o di corto-circuito in un punto del
percorso.
Ogni linea risulta connessa a formare un circuito chiuso ad anello sulla centrale di
allarme (loop di rivelazione; collegamento in Classe A): il trasferimento dei dati e
delle segnalazioni di anomalia o di allarme, nei due tronchi in cui verrebbe a
suddividersi una linea a seguito del guasto, é comunque garantita grazie alla
presenza di opportuni dispositivi, contenuti normalmente in alcuni elementi della
catena di rivelazione. Gli isolatori realizzano la terminazione dei rami della linea
interrotta; in ogni caso, in ossequio alle normative vigenti, é garantita una perdita
massima di rivelatori (nel tratto non più connesso alla centrale) non superiore a 30
unità.
Per aumentare la sicurezza dell’impianto e garantire la continuità del servizio, si
sono preferite in generale soluzioni con percorsi di andata e ritorno dalla/alla
centrale di allarme in passaggi differenti per raggiungere le zone controllate del
complesso.
La centrale è configurata per la gestione, il controllo ed il comando dei seguenti
dispositivi:
- i rivelatori ottici di fumo idonei a rivelare negli ambienti, nelle zone comuni, nei
controsoffitti, nei falsi pavimenti, nei cavedi, nei vani ascensori e nelle
canalizzazioni dell’impianto di condizionamento da proteggere il fumo generato
da un principio di incendio; questi sono collegati alla centrale mediante un cavo
twistato bipolare del tipo non propagante l'incendio posato in canalina chiusa di
PVC o in tubazione rigida pesante di PVC autoestinguente e scatole di
derivazione o di transito almeno una ogni 10m;
- i rivelatori termovelocimetrici idonei a monitorare negli ambienti, la temperatura e
la velocità con cui essa varia causata da un principio di incendio; questi sono
collegati alla centrale mediante un cavo twistato bipolare del tipo non propagante
l'incendio posato in canalina chiusa di PVC o in tubazione rigida pesante di PVC
autoestinguente e scatole di derivazione o di transito almeno una ogni 10m;
- ripetitori luminosi, posti all'esterno di ambienti protetti, all'interno dei quali non è
previsto l’impianto di spegnimento a gas FM200; collegati ai rivelatori interni
dell'ambiente protetto mediante un cavo twistato bipolare del tipo non propagante
l'incendio, posato in canalina chiusa di PVC autoestinguente o in tubazione rigida
pesante di PVC autoestinguente e scatole di derivazione;
- ripetitori luminosi a led posti all’esterno in corrispondenza dei rivelatori posti
all’interno dei controsoffitti, dei falsi pavimenti e delle canalizzazioni per l’impianto
di condizionamento; questi sono collegati al rivelatore corrispondente mediante
un cavo twistato bipolare del tipo non propagante l'incendio posato in tubazione
flessibile pesante di PVC autoestinguente;
80
- i pulsanti di allarme posti in prossimità delle scale, delle uscite di sicurezza e delle
vie di esodo; collegati alla centrale mediante un cavo twistato bipolare del tipo
non propagante l’incendio che utilizzano le stesse canalizzazioni dei rivelatori;
- le sirene di allarme sia da interno che da esterno e i segnalatori ottico-acustici di
allarme, posti nelle varie zone dell'impianto e collegate alla centrale mediante un
cavo di tipo FTG10OM1 non propagante l'incendio resistente al fuoco secondo la
norma CEI 20-45, posato in canalina chiusa di PVC o in tubazione rigida pesante
di PVC autoestinguente e scatole di derivazione di transito almeno una ogni 10
m;
- le serrande tagliafuoco dell’impianto di climatizzazione, comandate direttamente
dalla centrale o indirettamente mediante un comando della medesima su circuiti
alimentati in sicurezza sui quadri elettrici di zona mediante un cavo di tipo
FTG10OM1 non propagante l'incendio resistente al fuoco secondo la norma CEI
20-45, posato in canalina chiusa di PVC o in tubazione rigida pesante di PVC
autoestinguente e scatole di derivazione di transito almeno una ogni 10 m;
- gli elettromagneti di sblocco porte normalmente aperte, comandate direttamente
dalla centrale o indirettamente mediante un comando della medesima su circuiti
alimentati in sicurezza sui quadri elettrici di zona mediante un cavo di tipo
FTG10OM1 non propagante l'incendio resistente al fuoco secondo la norma CEI
20-45, posato in canalina chiusa di PVC o in tubazione rigida pesante di PVC
autoestinguente e scatole di derivazione di transito almeno una ogni 10 m;
- le unità di comando manuale/automatico nelle zone ove è previsto lo spegnimento;
collegate alla centrale mediante un cavo twistato per rivelazioni incendi e un cavo
di tipo TG10 non propaganti l'incendio resistente al fuoco CEI 20-45 posati in
canalina chiusa di PVC o in tubazione rigida pesante di PVC autoestinguente e
scatole di transito almeno una ogni 10 m; tali unità sono in grado anche di
controllare lo stato di apertura o chiusura degli infissi, di pilotare la chiusura
motorizzata dei medesimi, di riportare in centrale gli stati di funzionamento, il
comando di accensione dei pannelli di segnalazione sia interni che esterni al
locale e l’apertura delle elettrovalvole per lo spegnimento in funzionamento
automatico.
- il programmatore telefonico per la chiamata dei numeri registrati in caso di allarme.
Si prevede anche un impianto di diffusione sonora, per gli annunci registrati o
comunicati a viva voce inerenti alle modalità di evacuazione in caso di incendio.
Nel qual caso pertanto si verificasse un principio d’incendio in un determinata zona
il/i rivelatore/i che sono posti al controllo della medesima comunicano alla centrale
di rivelazione incendi lo stato di preallarme ed il successivo stato di allarme ripetuto
anche su eventuali postazioni remote.
E’ anche possibile comunicare l’allarme mediante i pulsanti manuali di allarme.
La centrale di rivelazione incendi è posta in apposito locale sorvegliato “sala
controllo”.
Le aree controllate sono qui di seguito descritte:
Nelle Centrali Tecnologiche ove c'è sviluppo di calore e nelle autorimesse è previsto
l’uso di rivelatori termovelocimetrici.
Nei corridoi di zone nelle quali gli ambienti non sono protetti singolarmente sono
installati dei rivelatori ottici di fumo.
81
Nella mensa, nelle aule, nelle biblioteche e negli ambienti in genere dove può
verificarsi affollamento sono previsti dei rivelatori ottici.
Negli ambienti dove c’è il controsoffitto sono posti dei rivelatori all'interno dello
stesso.
Negli ambienti dove è previsto il pavimento flottante, sono posti dei rivelatori
all'interno del sottopavimento.
82
3.3
IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
L'impianto videocitofonico è realizzato per mettere in comunicazione e controllare
una o più postazioni di ingresso esterne di chiamata, con uno o più postazioni
interne di tipo a portiere elettrico o intercomunicante.
L'impianto è costituito essenzialmente da:
- postazioni videocitofoniche esterne
- postazioni videocitofoniche interne con apriporta
- alimentatore per impianto videocitofonico
- unità di commutazione per impianto di portiere o intercomunicante
- cavo di collegamento tra le postazioni del tipo coassiale RG59 e multipolare FROR
e di alimentazione per la centralina del tipo multipolare G7 non propagante
l'incendio a ridotta emissione di gas tossici e corrosivi, posati in tubazioni di tipo
underground o in canalette chiuse di PVC o in tubazioni del tipo rigido pesante di
PVC autoestinguente, con scatole di derivazione di transito;
L'impianto previsto per permette il controllare dalla portineria l'ingresso principale.
3.4
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO TV
E’ prevista la predisposte nei locali mensa di una presa TV costituita da: tubazioni in
PVC autoestinguente e scatole di derivazione che costituiranno una dorsale
primaria di collegamento con gli apparati di ricezione TV (non previsti quest’ultimi in
progetto).
3.5
PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI
In prossimità degli ingressi saranno predisposte delle canalizzazioni: tubazioni in
PVC autoestinguente e scatole di derivazione che costituiranno una dorsale
primaria di collegamento con il locale posto di controllo al livello 721.
83
3.6
IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EVACUAZIONE
L’impianto di diffusione sonora di evacuazione è del tipo a controllo digitale.
I principali requisiti che l’impianto è in grado di soddisfare sono i seguenti:
- funzionalità e utilizzo semplice e sicuro;
- operatività continua nel tempo senza interruzioni;
- affidabilità;
- possibilità di interfacciarsi con altri impianti;
Il sistema è stato progettato e strutturato per minimizzare l’effetto di possibili guasti
o malfunzionamenti e dovrà essere realizzato con i necessari livelli di autodiagnosi
per rispondere alla norma EN 60849 (CEI 100-55). Sempre in accordo a tale norma
dovrà essere possibile effettuare un monitoraggio funzionale e di stato del sistema
per controllarne la completa funzionalità e immediatamente rilevare i possibili guasti
o malfunzionamenti.
L’impianto di diffusione sonora consentirà l’invio di messaggi a viva voce nelle zone
frequentate dal pubblico e in tutti i locali di servizio dell’impianto, oltre a diffondere
musica di sottofondo o messaggi automatici di allarme.
In accordo alla norma CEI 100-55 lo scopo principale del sistema sarà quello di
consentire un’evacuazione guidata e controllata dello stabile in caso di incendio o di
altra situazione di emergenza che lo richieda. Il sistema sarà interfacciabile alla
centrale antincendio e potrà essere programmato per trasmettere i seguenti tipi di
segnali:
-
19 tipi diversi di allarmi selezionabili in fase di programmazione
messaggio preregistrato di allerta
messaggio preregistrato di evacuazione
messaggi a viva voce con priorità assoluta.
Tutte le funzioni sono svolte dalla postazione operatore (Postazione di supervisione
a controllo digitale con display).
In ogni zona (reparto) dovrà essere possibile (se richiesto) collegare un sistema
amplificato autonomo con radio, CD e base microfonica per la diffusione locale
della musica di sottofondo e per effettuare degli annunci locali a viva voce.
Il sistema autonomo resterà comunque subordinato al sistema principale per quanto
riguarda la gestione delle priorità in caso di situazione di emergenza.
Tutti i componenti coinvolti nella gestione degli eventuali segnali di emergenza
saranno controllati e continuamente monitorati dalla CPU di sistema. Dovranno
essere indicati eventuali guasti o malfunzionamenti di tali apparecchiature entro 100
secondi da quando si sono manifestati (come richiesto dalla norma CEI 100-55).
Oltre alle apparecchiature occorre controllare e supervisionare l’integrità del
‘percorso critico’. Tale percorso è inteso come il percorso del segnale audio a
partire dalla capsula del microfono d'emergenza e/o dal generatore di messaggi,
fino alla linea altoparlanti attraverso la catena di amplificazione: qualsiasi guasto
relativo alla capsula del microfono, al suo cavo di collegamento alla centrale, agli
amplificatori ed alla linea altoparlanti deve essere segnalato nel modo previsto.
In definitiva il sistema consentirà di effettuare, tramite rete di altoparlanti, la
diffusione delle seguenti tipologie di segnali (elencate in ordine di priorità
crescente):
- diffusione di musica di sottofondo, nei reparti dove richiesta (livello di priorità
basso)
- chiamata a viva voce, nella zona (reparto) di propria competenza, da parte della
84
postazione microfonica dedicata (dove richiesto)
- chiamata a viva voce (a zona o gruppi di zone), nelle zone frequentate dal
pubblico e in tutta l'area di servizio della struttura; utilizzo delle console di
supervisione senza la chiave di emergenza inserita
- diffusione di messaggi automatici di allarme e/o sicurezza (a zona o gruppi di
zone)
- chiamate d’emergenza a viva voce (a zona o gruppi di zone); utilizzo delle
console di supervisione con chiave di emergenza inserita (priorità massima)
Architettura e operatività
Nel complesso il sistema di diffusione sonora è costituito da:
- Unità centrale di amplificazione dotata di controllore digitale che provvede a tutte
le funzioni di comando e controllo del sistema (la centrale può controllare fino a 36
zone e sarà predisposta per 18)
- Postazione operatore principale di supervisione a controllo digitale connessa
all’unità centrale
- Sistema amplificato autonomo con radio, CD e base microfonica per musica e
annunci locali (reparti)
- Rete altoparlanti per la sonorizzazione delle varie aree servite dall’impianto.
L’architettura dell’unità centrale di amplificazione si basa su un sistema modulare,
flessibile, facilmente espandibile, con la possibilità di diffondere messaggi di servizio
ed emergenza ed interfacciabile alla centrale rivelazione incendi in conformità con la
normativa EN 60849 (CEI 100-55).
Il sistema prevede l’impiego di un cestello di segnale nel quale potranno alloggiare
fino ad un massimo di 10 moduli. Nel cestello di segnale vengono alloggiati i moduli
di ingresso/uscita, selettori di zona, uscita linea, alimentatori, ecc. Sui bus della
scheda madre viaggiano le linee di alimentazione, i segnali audio, la linea di
comunicazione seriale ed i segnali di servizio (priorità, abilitazioni, ecc.). Il cestello
di segnale è fissato su delle guide scorrevoli che ne permettono l’estrazione dal rack
in modo da poter accedere al suo interno senza doverlo rimuovere completamente;
l’installazione e la manutenzione dei moduli risulta così estremamente agevole e
funzionale. I moduli riportano nella parte frontale i comandi, le indicazioni e le
regolazioni principali mentre nella parte posteriore sono alloggiate tutte le prese e le
morsettiere di collegamento; i moduli vengono facilmente inseriti nel cestello dalla
parte superiore senza la necessità di alcuna operazione di cablaggio all’interno del
cestello stesso.
Il sistema consente la diffusione tramite altoparlanti di messaggi, comunicazioni di
servizio (eventualmente anche d’allarme) all’interno delle aree di sonorizzazione
richieste, per un totale di 6 zone di diffusione. La centrale è comunque predisposta
per il controllo fino a 18 zone.
Tutte le funzioni del sistema sono svolte dalla consolle di comando e supervisione.
Le chiamate servono le 6 linee audio separate (una in corrispondenza di ogni zona
da sonorizzare) con la possibilità di attivarle contemporaneamente o a gruppi, sia
per comunicazioni di servizio, di annuncio o di ricerca persone, che per eventuali
messaggi di allarme da emettere in particolari situazioni di emergenza. Ogni linea
audio è quindi collegata ai rispettivi amplificatori di zona (il numero e la potenza
degli amplificatori utilizzati per ciascuna zona dipende dal numero e dalla potenza
degli altoparlanti installati in quella particolare zona).
A seconda delle circostanze l’operatore potrà perciò effettuare, dalla postazione
microfonica, sia chiamate di zona corrispondenti alla linea (o al gruppo di linee)
85
dove intende indirizzare il proprio messaggio, sia una chiamata generale che
comprenda tutte le zone dell’impianto.
La console digitale di supervisione, sarà dotata di un microfono controllato, di un
ampio display LCD e di tastiera esadecimale, per consentire di effettuare tutte le
numerose funzioni di gestione dell’impianto. Due moduli di estensione
aggiungeranno alla console 24 tasti per effettuare rapidamente le chiamate e
visualizzare continuamente tramite Led lo stato delle varie zone.
Tramite la console sarà possibile:
- Visualizzare i login dei guasti e degli allarmi con data/ora/minuti
- Effettuare chiamate di servizio sulle singole zone o su gruppi di zone
- Controllare lo stato di tutto l’impianto.
Una chiave di sicurezza consentirà al personale autorizzato di:
- Azzerare le eventuali segnalazioni di allarme: l’evento viene registrato in memoria
con data/ora/minuti
- Inviare messaggi preregistrati di evacuazione e di allarme in zone particolari:
l’evento viene registrato in memoria con data/ora/minuti
- Inviare messaggi di evacuazione e allerta a viva voce.
In corrispondenza ad uno stato di guasto, un “buzzer” incorporato nella console
fornirà un segnale acustico che potrà essere azzerato tramite la tastiera o la chiave
di sicurezza.
I messaggi preregistrati di evacuazione e di allerta saranno gestiti da un apposito
modulo. Questo disporrà di due messaggi preregistrati completamente controllati e
diagnosticati, idonei per impianti di evacuazione secondo la norma EN 60849 (CEI
100-55). In caso di pericolo sarà possibile la riproduzione contemporanea dei due
messaggi su zone differenti. L’invio dei messaggi potrà avvenire in modo
automatico (comandato da un contatto della centrale antincendio) o manuale tramite
consolle di supervisione.
Tutti i segnali audio di emergenza (console di supervisione e messaggi preregistrati)
dovranno essere indirizzati tramite apposite schede di routing. Tali moduli
gestiscono, sotto il controllo della CPU del sistema modulare, l’instradamento dei
segnali di emergenza verso gli amplificatori. Il modulo avrà 6 ingressi di programma
e 6 uscite per altrettanti amplificatori. In condizioni di normale funzionamento (non in
emergenza) i segnali applicati a tali ingressi verranno riportati fedelmente alle
uscite. In condizioni di emergenza, i segnali VES (segnali audio di emergenza il cui
percorso dovrà essere completamente diagnosticato) presenti sul bus del sistema
verranno prelevati ed instradati alle uscite secondo la programmazione
memorizzata nella CPU di controllo. Tramite tale modulo sarà possibile l'invio
contemporaneo, su zone diverse, dei messaggi preregistrati di allerta e di
evacuazione.
La centrale di controllo audio è interfacciata con la centrale rilevazione incendi
tramite contatti I/O (schede 8 ingressi/8 uscite); utilizzando i contatti in ingresso e/o
le uscite digitali è possibile ricevere comandi e se necessario attivare eventuali
segnali di emergenza esterni. E’ possibile programmare ogni contatto in fase di
start-up, affinché si possa inviare il messaggio di evacuazione nelle zone di pericolo
e, contemporaneamente, inviare anche il messaggio di allerta nelle zone limitrofe.
Utilizzando un PC connesso al sistema, grazie ad un software dedicato sarà
possibile interloquire con il sistema, scambiando dati relativi alla configurazione e
86
rilevando gli eventuali guasti accorsi durante il funzionamento.
Il sistema dovrà gestire e pilotare 6 zone.
Ogni zona è servita da un’unità di potenza di tipo modulare da 60,120 o 240 W RMS
(in funzione della potenza richiesta) con uscita a tensione costante (100/70/50 Volt),
dotata di protezione termica sugli stadi finali, sistema di ventilazione forzata e
scheda seriale per il controllo diagnostico remoto.
E’ stato previsto un amplificatore di riserva in commutazione automatica in caso di
guasto dell’apparato principale. Una scheda di supervisione modulare consente il
controllo fino a 4 amplificatori più uno di riserva. Dovrà essere possibile raggruppare
tale controllo su un numero più elevato di amplificatori (4/8/12 ecc.) e uno di riserva.
Tutte le apparecchiature saranno montate in appositi armadi standard rack 19”. La
centrale rack montata e collaudata, dovrà essere fornita completa di pannelli di
areazione, di pannelli di chiusura per gli spazi inutilizzati, di porte anteriori con
frontale trasparente e serratura a chiave e di porte di chiusura posteriori.
L’alimentazione elettrica del sistema è garantita da un gruppo statico di continuità.
Rete altoparlanti.
Considerate le caratteristiche tecnico-funzionali dell’impianto ed anche il fatto che in
particolari situazioni potrebbero essere emessi messaggi di allarme, per avere una
copertura acustica ottimale si deve necessariamente ricorrere ad una
sonorizzazione distribuita nelle varie aree; tale soluzione garantisce una
distribuzione ottimale dei livelli di pressione sonora dei vari segnali audio diffusi
assicurando al tempo stesso un buon livello di intelligibilità del parlato.
Le linee altoparlanti devono essere testate in accordo alle normative IEC 60849
(CEI 100-55) (integrità e dispersione verso terra). Oltre alla misura dell’impedenza
di linea dovrà essere inserita una scheda di fine linea in grado di garantire e
controllare l’effettiva integrità della stessa. Il collegamento delle linee altoparlanti
dovrà essere realizzato in parallelo, in cavo twistato resistente al fuoco.
Gli altoparlanti utilizzati sono da interno per montaggio sporgente a parete o a
plafone da incasso, realizzati in ABS autoestinguente. La potenza sarà di 6W
(regolabile 6-3-1,5 W). La pressione acustica massima (potenza nominale/1m) di 96
dB.
87
3.7
IMPIANTO DI CHIAMATA DISABILI
L'impianto è realizzato per consentire dai bagni per disabili la chiamata presso un
unica postazione ricevente.
L'impianto è costituito essenzialmente:
- pannello ottico e acustico la segnalazione della chiamata, completo di relè di
scambio per la ripetizione e comandi per l'accettazione e l'annullamento della
medesima;
- posto di chiamata interno all’ambiente realizzato mediante pulsante a tirante e
segnalazione di avvenuta chiamata;
- ripetizione del segnale all'esterno dell'ambiente realizzato con spia luminosa e
pulsante per l'annullamento della chiamata;
- i collegamenti elettrici sono realizzati con cavo multipolare di tipo FG7 con
tensione di isolamento 0,6/1 kV; il cavo è del tipo non propagante l'incendio a ridotta
emissione di gas tossici e corrosivi, posato in tubazione rigida o flessibile pesante in
PVC autoestinguente, con scatole di derivazione di transito, poste almeno una ogni
10 m.
88