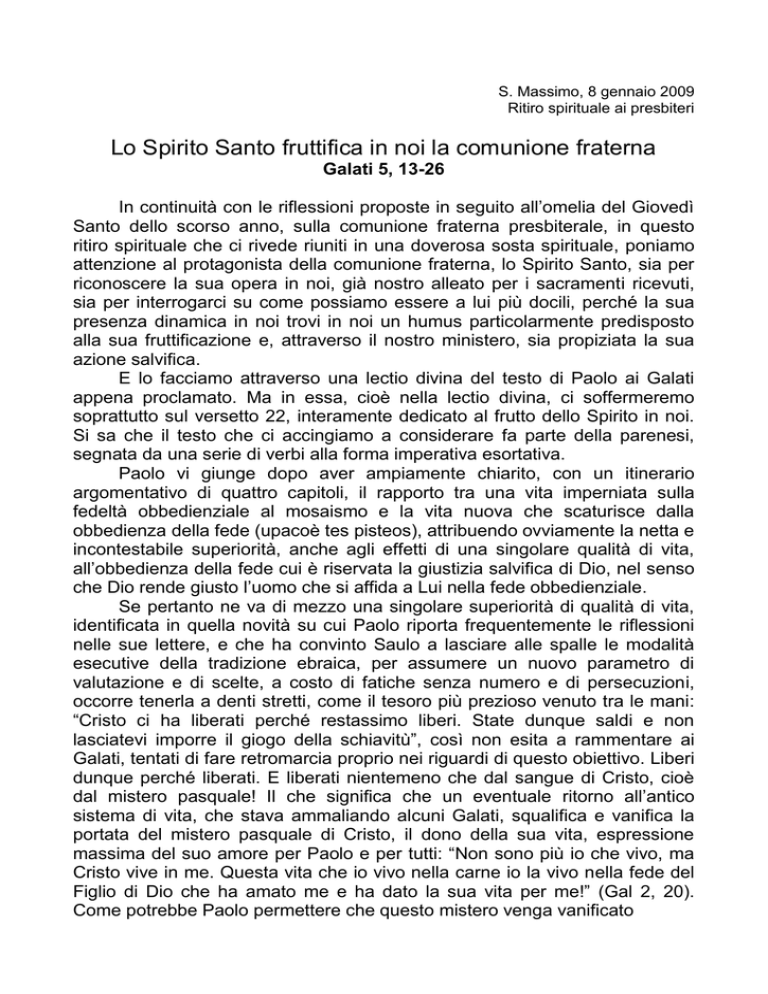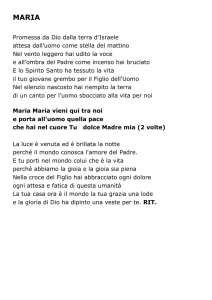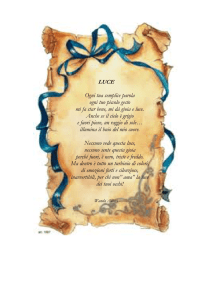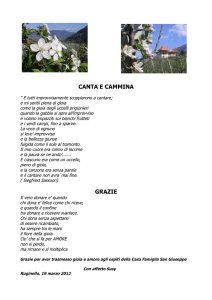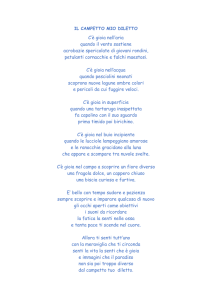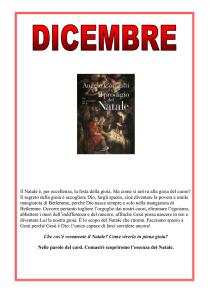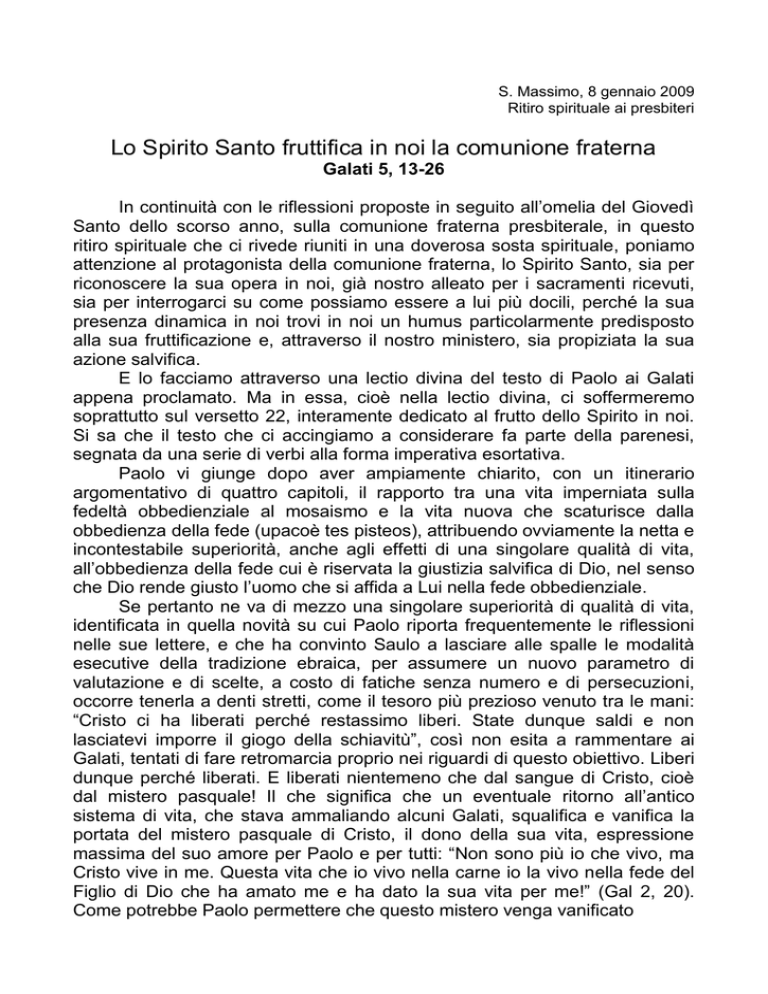
S. Massimo, 8 gennaio 2009
Ritiro spirituale ai presbiteri
Lo Spirito Santo fruttifica in noi la comunione fraterna
Galati 5, 13-26
In continuità con le riflessioni proposte in seguito all’omelia del Giovedì
Santo dello scorso anno, sulla comunione fraterna presbiterale, in questo
ritiro spirituale che ci rivede riuniti in una doverosa sosta spirituale, poniamo
attenzione al protagonista della comunione fraterna, lo Spirito Santo, sia per
riconoscere la sua opera in noi, già nostro alleato per i sacramenti ricevuti,
sia per interrogarci su come possiamo essere a lui più docili, perché la sua
presenza dinamica in noi trovi in noi un humus particolarmente predisposto
alla sua fruttificazione e, attraverso il nostro ministero, sia propiziata la sua
azione salvifica.
E lo facciamo attraverso una lectio divina del testo di Paolo ai Galati
appena proclamato. Ma in essa, cioè nella lectio divina, ci soffermeremo
soprattutto sul versetto 22, interamente dedicato al frutto dello Spirito in noi.
Si sa che il testo che ci accingiamo a considerare fa parte della parenesi,
segnata da una serie di verbi alla forma imperativa esortativa.
Paolo vi giunge dopo aver ampiamente chiarito, con un itinerario
argomentativo di quattro capitoli, il rapporto tra una vita imperniata sulla
fedeltà obbedienziale al mosaismo e la vita nuova che scaturisce dalla
obbedienza della fede (upacoè tes pisteos), attribuendo ovviamente la netta e
incontestabile superiorità, anche agli effetti di una singolare qualità di vita,
all’obbedienza della fede cui è riservata la giustizia salvifica di Dio, nel senso
che Dio rende giusto l’uomo che si affida a Lui nella fede obbedienziale.
Se pertanto ne va di mezzo una singolare superiorità di qualità di vita,
identificata in quella novità su cui Paolo riporta frequentemente le riflessioni
nelle sue lettere, e che ha convinto Saulo a lasciare alle spalle le modalità
esecutive della tradizione ebraica, per assumere un nuovo parametro di
valutazione e di scelte, a costo di fatiche senza numero e di persecuzioni,
occorre tenerla a denti stretti, come il tesoro più prezioso venuto tra le mani:
“Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque saldi e non
lasciatevi imporre il giogo della schiavitù”, così non esita a rammentare ai
Galati, tentati di fare retromarcia proprio nei riguardi di questo obiettivo. Liberi
dunque perché liberati. E liberati nientemeno che dal sangue di Cristo, cioè
dal mistero pasquale! Il che significa che un eventuale ritorno all’antico
sistema di vita, che stava ammaliando alcuni Galati, squalifica e vanifica la
portata del mistero pasquale di Cristo, il dono della sua vita, espressione
massima del suo amore per Paolo e per tutti: “Non sono più io che vivo, ma
Cristo vive in me. Questa vita che io vivo nella carne io la vivo nella fede del
Figlio di Dio che ha amato me e ha dato la sua vita per me!” (Gal 2, 20).
Come potrebbe Paolo permettere che questo mistero venga vanificato
proprio in lui e in coloro presso i quali lo aveva
presentato con tanta passione da dire loro: “O stolti Galati, chi mai vi ha
ammaliati, proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo
crocifisso?” (Gal 3, 1). Ben si giustifica allora il primo imperativo esortativo:
“State dunque saldi”. Nessun imperativo esortativo in Paolo è moralistico. È
consequenziale alla teologia.
Al versetto 13, che ha dato avvio alla lettura proposta, in una
formulazione che sa di negativo, ci offre la chiave di ingresso nella logica che
introduce in pieno l’azione dello Spirito nel credente. Paolo che ribadisce
ancora una volta il senso del dono della liberazione dal sistema del
mosaismo, mette in guardia dal pericolo di vivere nel libertinaggio, che nel
termine “carne” trova la sua traduzione più convincente. Riascoltando tra
poco le manifestazioni della carne, potremmo dire che corrisponde al vivere
secondo la logica del più abietto paganesimo, di cui Paolo da un anticipo al
versetto 15: “Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non
distruggervi del tutto gli uni gli altri!”. Frase tra l’ironia pungente e l’amarezza
sconfortata. Da sola vale un esame di coscienza. Per tutti i credenti. Anche
per i diaconi, i presbiteri e i vescovi: quanto male ci si fa nel mordersi e
divorarsi a vicenda!
Proprio a questo punto Paolo dà la virata: per non vivere secondo la
carne, ma “mediante la carità essere (siate) a servizio gli uni degli altri”, quale
espressione della pienezza della legge, occorre “camminare secondo lo
Spirito”. Carne e Spirito dunque. Rappresentano due logiche culturali, due
orientamenti di vita, due prospettive, due sensibilità riconoscibili dal termine
“desiderio”, inclinazione, propensione. Dialettiche, antitetiche. Irriducibili. Il
dissidio vissuto nella interiorità di ciascuno di noi, evidenziato da Paolo al cap
7° Rm, tra i due mondi è incolmabile: “queste cose si oppongono a vicenda”.
Paolo esorta a camminare nella direzione dello Spirito, lasciandoci
ispirare e guidare dallo Spirito: “Se vi lasciate guidare dallo Spirito…” (v. 18),
non siete più sotto una legge che detta dall’esterno i comportamenti legalisti e
che vi rende esecutori di precetti, ma appunto sotto la legge interiore dello
Spirito che dimorando nel credente, dal Battesimo, sospinge a seguire le
leggi intrinseche del proprio essere. Tale versetto ci rimanda
spontaneamente alla lettera ai Romani: “Tutti quelli che si lasciano guidare
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8, 14). Lo Spirito è guida dei
figli di Dio, nella direzione che conduce alla destinazione degna dell’uomo,
conforme al progetto di amore di Dio!
Fatte queste premesse, Paolo non esita a guardare in faccia il mondo
della carne con le sue efflorescenze da marciume etico-morale, poiché ha la
possibilità di prospettare l’alternativa: “Del resto le opere della carne sono
ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie,
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e
cose del genere”. Atteggiamenti tutti che ostruiscono la via della salvezza.
Ovviamente, non è detto che ne siamo in tutto immunizzati su tutto
il fronte che spesso è da Caporetto.
Ma a Paolo preme giungere al cuore delle questioni. Nessun credente
in Cristo è condannato a soccombere alla logica della carne. Al contrario è
chiamato e abilitato a lasciar produrre il “frutto dello Spirito”! Non ci sfugge la
precisione terminologica di Paolo: anche se di fatto ne fa una enumerazione
precisa, in numero di nove, vede in unità la fruttificazione. Come dicesse:
l’azione di guida dello Spirito, immagine che trapassa a quella non meno
significativa di agricoltore che sottostà al versetto 22, si concretizza nel
rendere il credente capace di agire in modo divino, proprio a partire dal primo
frutto, che sta all’inizio dell’elenco come il “la” dell’intera melodia, l’amore!
A questo punto conviene soffermare la nostra riflessione proprio sul
frutto, polivalente, dello Spirito, cercando di esemplificare in riferimento alla
vita concreta dell’essere presbiteri, specialmente, ma non solo, se ancora
nell’esercizio del ministero diretto, benché, come accennato, trovi riferimento
abbastanza puntuale anche alla vita dei presbiteri che per malattia, infermità
o anzianità servono diversamente la Chiesa di Dio che è in Verona.
Questo frutto molteplice, a grappolo, segnala in modo inconfondibile
l’azione dello Spirito in noi ed è indice di quanto la comunione fraterna sta
realizzandosi nel nostro presbiterio. Insomma, la comunione fraterna in gran
parte passa da questi atteggiamenti, frutto dell’azione dello Spirito in noi,
docilmente assecondata, bandendo con risolutezza il loro contrario.
Anzitutto, l’ Amore. Evidentemente si tratta di “agàpe”, in conformità a
Rm 5, 5: “la speranza non delude perché l’Amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato”. Dunque è proprio il
frutto primo dello Spirito in noi. Quanto più siamo inondati e conquistati da
questo amore, pura gratuità, tanto più ci viene, per così dire, spontaneo e
naturale trasmettere agli altri autenticità di amore, come da un esubero in noi.
Il che equivale a dire: chi si sente amato e riconosce di essere amato, si
predispone ad amare, con l’amore di cui si sente raggiunto. E lo fa con
purezza di spirito, con autenticità. Senza mai scadere in gesti puramente
fittizi, come ci ammonisce Paolo nella lettera ai Romani: “Un amore non
ipocrita” (Rm 12, 9). E la vita di comunione fraterna si rivitalizza ogni volta
che consentiamo allo Spirito di fruttificare in noi Amore per farne dono ai
confratelli in primo luogo e ai laici. Praticamente non facciamo altro che
evitare di ostruire il suo flusso di Amore vero che ha come destinatari le
persone che condividono le nostre giornate, e di consentirgli di raggiungere
tutti. Quale responsabilità sta sulle nostre spalle a tale riguardo: l’Amore di
Dio, riversato in noi dallo Spirito, può stagnare in noi o essere un dono, nella
reciprocità, ai fratelli! La vita di comunione fraterna è qualificata esattamente
dalla presenza di un tale Amore. Quando c’è e non viene in nulla ostacolato
la vita d’insieme viene trasformata in vita fraterna, proprio in
obbedienza e sintonia con il comando di Gesù condensato nell’Ultima Cena:
“un comandamento nuovo dono a voi: amatevi gli uni gli altri, poiché (e come)
io amo in continuità voi (verbo al perfetto: azione che viene avviata nel
passato e perdura nel presente). Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli se vi amerete gli uni gli altri” (Gv 13, 34-35). Teniamo presente che
ognuno di noi è amato singolarmente da Gesù con lo stesso amore con cui
Egli è amato dal Padre e Lui ama il Padre. Di conseguenza, quando ci
amiamo tra di noi, viviamo l’amore trinitario e sperimentiamo in concreto chi è
Dio, cioè crediamo davvero in Lui. Quando invece ne impediamo la
realizzazione di fatto siamo atei, cioè senza Dio, dal momento che Dio è
Amore (cfr 1 Gv 4, 8.16). Come a dire, autorizzati da Giacomo e non meno
da Paolo, che una fede senza le opere dell’Amore è atea, è morta (cfr. Gc 2,
26: “la fede senza le opere è morta”; Gal 5, 6: “la fede che opera per mezzo
dell’amore”).
Ciò che segue nella elencazione delle fruttificazioni porta il sigillo
dell’agape, tant’è vero che, anche nella espressione verbale e non solo nella
sostanza, almeno alcuni sostantivi che appaiono nell’elenco di Gal 5, 22 si
ritrovano come aggettivi qualificativi dell’agape in 1 Cor 13, 4 ss.
Il secondo frutto, manifestazione certa che in noi già opera l’Amore, è la
gioia. Karà, in greco, la cui matrice verbale è quel kairo da cui il kaire Maria!
Si sa quanto è difficile renderne in lingua italiana tutta la densità di senso.
Tentiamo di renderlo con una circonlocuzione: “trovarsi una interiorità
interamente armoniosa, perché posseduta da Dio”. Come è avvenuto in
Maria “piena di Grazia”. Per rendercene più convinti, basta il riferimento a
qualche frammento di salmo: “cerca la gioia nel Signore” (Sal 37, 4); “verrò al
Dio della mia gioia” (Sal 43, 4); “fammi sentire gioia e letizia” (Sal 51, 10);
“servite il Signore nella gioia” (sal 100, 2)”; “La mia gioia è nel Signore” (Sal
104, 34); “Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia…la tua legge è la mia gioia”
(Sal 119, 14.77). Oppure facciamo riferimento a qualcuno tra i più significativi
testi del NT imperniati sulla realtà della gioia. Oltre quello già citato di Lc 1, 28
aggiungiamo: “Vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo” (Lc
2, 10); “Al vedere la stella i Magi provarono una grandissima gioia” (Mt 2, 10);
“pieno di gioia vende tutti i suoi averi (Mt 13, 44); la gioia del ritrovo della
pecora perduta, della dramma smarrita, del figlio prodigo… c’è più gioia in
cielo per un solo peccatore che si pente (cfr Lc 15); “Zaccheo accolse Gesù
pieno di gioia” (Lc 19, 6); “La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”
(Gv 15, 11); “la vostra afflizione si tramuterà in gioia” (Gv 16, 20); “perché
abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia” (Gv 17, 13); “la vostra
afflizione si tramuterà in gioia (Gv 16, 20); “le donne con timore e gioia
grande (Mt 28, 8); “I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo” (At 13,
52);
“ho provato grande gioia nel Signore” (Fil 4, 10); “Siate nella
gioia, ve lo ripeto, siate nella gioia” (Fil 4, 4); “avendo accolto la parola con la
gioia dello Spirito” (1 Ts 1, 6); “siamo i collaboratori della vostra gioia…sono
pervaso di gioia (2 Cor 1, 24. 7,4); “il regno di Dio è gioia nello Spirito Santo”
(Rm 14, 17); “il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia” (Rm 15, 13).
La gioia dunque nasce dal nostro rapporto con il Signore della gioia. A
garantircela non è la salute, la carriera, le soddisfazioni pastorali, ma l’essere
nel Signore. Può avere tratti di buon umore, ma non vi si identifica. È un
atteggiamento dello Spirito, frutto dello Spirito, che produce armonia vibrante
nel cuore dell’uomo, e ha una notevole ricaduta, nelle parole e nei
comportamenti, anche su chi condivide le nostre giornate. In particolare, il
presbitero che consente allo Spirito di far fruttificare in lui la gioia dello Spirito
fa germinare attorno a lui gioia e bisogno di gioia. Un prete gioioso è una
benedizione. E propizia in modo fecondissimo lo spirito di comunione
fraterna.
Il terzo: la pace. Eirene in greco.
Non si tratta di un vago e poco sofferto irenismo, tipico del generico
embrassons nous. Risponde piuttosto all’esito dell’abbinamento con la ricerca
della gloria di Dio, come evidenzia l’evangelista Luca: “Gloria a Dio nel più
alto dei cieli – cioè nella trascendenza assoluta – e pace in terra agli uomini
destinatari della benevolenza di Dio”. Chi ricerca la gloria di Dio e non la
propria gloria è destinatario del dono della pace. Proprio nella misura in cui
dichiara a se stesso che ciò che gli interessa e gli sta a cuore non è se stesso
ma ciò che interessa e sta a cuore a Dio. Essere in pace anzitutto con Dio,
per effetto della gratuità della sua giustificazione (Rm 5, 1: “Noi siamo in pace
con Dio”), di conseguenza con se stessi e di riverbero con gli altri. Un cuore
in pace sente come bisogno vitale quello di trasmettere sentimenti di pace,
ricordando la beatitudine del discorso della montagna: “Beati i portatori di
pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5, 9).
Quanto la pace sia anzitutto dono è confermato dalla Parola di Dio che
sulla pace intesse pagine luminose. Per citarne alcuni flash. Un salmo: “Il
Signore ha messo pace nei tuoi confini” (Sal 147, 14). Dunque il dono della
pace c’è e ci precede, scendendo dall’alto della gratuità di Dio; all’uomo il
compito di corrispondervi.
E le consolanti parole di Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non
come la da il mondo o la do a voi” (Gv 14, 27); “Pace a voi” (Gv 20, 19.26). E
quelle di Paolo! Paolo abbina grazia e pace infinite volte, ma ne assume il
termine anche in autonomia: “Fatevi un punto di onore di vivere in pace” (1 Ts
4, 11); “Vivete in pace tra voi” (1 Ts 5, 13); “La pace di Cristo regni nei vostri
cuori” (Col 3, 15); “Egli è la nostra pace” (Ef 2, 14); “solleciti nel conservare il
vincolo della pace” (Ef 4, 3); “vivete in pace con tutti” (Rm 12, 18).
Come presbiteri siamo ministri della pace. Nella celebrazione
dell’Eucaristia da noi presieduta e nel sacramento della riconciliazione come
vertice. Ma poi nella ferialità, essere portatori di pace nelle famiglie, tra gruppi
e associazioni, tra i collaboratori. Saremmo efficaci se portiamo sempre, ad
ogni costo, la pace tra confratelli, perseguendola con le vie della pace, il
dialogo, il perdono…
Segue la pazienza. È noto che il termine italiano ha come riferimento in
Paolo due termini greci: upomoné e macrothymia. L’upomoné sta ad indicare
la sottomissione (sto sotto il giogo) tipica dell’animale da soma. Dunque è più
legata al senso della pazienza che occorre ad uno schiavo, quando lì, nella
immediatezza, deve eseguire gli ordini ricevuti, fossero pure forche caudine.
In realtà nel testo di Galati 5, 22 Paolo usa il termine macrothymia. Il termine
evoca la capacità del contadino di sopportare ogni genere di fatica grazie alla
sua lungimiranza. Egli mostra un animo abituato a commisurare le fatiche con
l’obiettivo (cfr Gc 5, 7: “L’agricoltore aspetta pazientemente il prezioso frutto
della terra”). Letteralmente significa: animo che guarda in lunghezza. A tale
proposito lo stesso Paolo, che usa non di rado il termine (ad es. in Ef 4, 2:
“con ogni umiltà e mansuetudine, sopportandovi a vicenda nell’amore con la
pazienza”), nella prima ai Corinti ne fa una qualificazione dell’agape: “l’agape
ha pazienza” (macrothymei: 1 Cor 13, 4), come Dio ha pazienza (e ce lo
ricordano gli infiniti testi salmodicia. Ad es. Sal 145, 8: “paziente e
misericordioso è il Signore”, ripreso dalla seconda di Pietro 3, 9: “Dio non
ritarda a compiere le sue promesse, ma usa pazienza verso di noi, non
volendo che alcuno perisca”), e nella seconda a Timoteo non esita a
sospingere la pazienza fino all’eroismo: ”Un servo del Signore dev’essere
paziente nelle offese subite” (2 Tm 2, 24).
Quanto costi anche ai presbiteri la pazienza, ognuno di noi ne ha
consolidata esperienza. Ma essendo prima di tutto frutto in noi dello Spirito
che ci fa partecipi della pazienza lungimirante di Dio ci incoraggiamo, consci
dei benefici che se ne ricavano. Delle impazienze ci pentiamo sempre. Dalle
pazienze portate, anche stringendo i denti, abbiamo sempre ricavato buoni
esiti.
Benevolenza. Xrestotes, in greco. Non è il semplice volersi bene. Ma la
ricerca di ciò che è bene. Letteralmente evoca l’essere benigno, utile,
propizio favorevole. Ed è una ulteriore caratteristica dell’agape, come
evidenzia Paolo nella prima ai Corinti: “l’agape è benevola!”.
È evidente che anche in questo atteggiamento scorgiamo il tratto divino
della benevolenza, come risulta ad esempio nel testo della lettera a Tito:
“quando si è fatta visibile la benevolenza (Xrestotes) e la filantropia di Dio
salvatore nostro” (Tt 2, 4). Dunque Paolo coniuga la benevolenza di Dio con
la sua simpatia per l’uomo. Se è benevolo verso l’uomo è perché l’uomo gli è
caro al punto da farsi Lui stesso uomo, nel Figlio.
Nei confronti dei confratelli, ma anche dei fedeli, ci guidi
sempre quel credito di benevolenza che ci fa scorgere nei fratelli persone
destinatarie prima di tutto della benevolenza stessa di Dio, memori comunque
delle esortazioni di Paolo: “Siate benevoli gli uni verso gli altri” (Ef 4, 32). E la
comunione fraterna avrà una marcia in più.
Bontà. Agathosune, in greco. Il termine agathos ci è noto: buono! In che
cosa poi consista la bontà ci è meno facile decifrarlo. Sta di fatto che anche
quando Gesù viene interpellato su chi è il prossimo e viene definito
dall’interlocutore “maestro buono”, corregge precisando che l’attribuzione di
buono è una esclusiva di Dio: “Uno solo è buono: Dio!” (cfr Mc 10, 17-18),
non certo per stornare l’attribuzione da sé ma per far intuire che anche in Lui
c’erano i tratti del divino, appunto quelli connessi con la bontà. Buono è il
samaritano che si prende cura di un estraneo ( e non a caso Gesù fa seguire
la narrazione di quella parabola). Noi potremmo definirlo: un uomo dal cuore
sensibile, pronto a soccorrere, anche a costo di rimetterci in termini di purità
legale, di tempo e di denaro. Non è il bonario bonaccione, incapace di fare il
male, ma colui che si dispone a fare il bene secondo l’assioma di Paolo: “Non
lasciarti vincere dal male ma vinci il male con il bene” (Rm 12, 21) . In questo
senso la bontà è atteggiamento, frutto dello Spirito, particolarmente
confacente al presbitero, chiamato a fare il bene, evitando ogni
comportamento e ogni parola che possa ferire, facendo del male ai fedeli,
che difficilmente dimenticano una parola e un gesto non buoni, e anche al
confratello.
Fedeltà. Pistis, in greco. “Dio è fedele” (Sal 31, 6; 86, 11; 146, 6); “Il
Signore è fedele” (2 Ts 3,3); “colui che vi chiama è fedele” (1 Ts 5, 24; cfr
anche 1 Cor 1, 9. 10, 3). E tutti sanno che il termine in ebraico evoca il senso
della stabilità della roccia. Insomma di Dio ci si può fidare perché rimane
fedele al suo patto anche quando l’uomo si mostra infedele. È comunque un
forte richiamo per noi. Potremo infatti dichiararci veri discepoli di Gesù, se
saremo a lui fedeli: “se rimanete fedeli alla mia parola, sarete miei discepoli”
(Gv 8, 31). Come amministratori dei beni di Dio ci è chiesta la fedeltà:
“All’amministratore è richiesto che sia fedele” (1 Cor 4, 2). Saremo giudicati
sulla fedeltà: “Bene servo buono e fedele” (Mt 25, 21s).
Sta di fatto che di una persona si misura la maturità sulla sua capacità
di fedeltà. Lo si può dire nei confronti della fedeltà coniugale come della
fedeltà al propria vocazione di ministero ordinato o della consacrazione a Dio
mediante i tre voti canonici. Ma lo si può dire anche nei confronti della parola
data, in genere, della riservatezza di cose di cui si è venuti a conoscenza per
svariate vie, degli orari stabiliti, in segno di rispetto, di un impegno assunto.
Saper di poter contare su confratelli di parola, fedeli a Dio e ai propri impegni
personali e pastorali, è garanzia di riuscita nella strada della comunione
fraterna.
Mitezza. Prautes, in greco. In Mt 5, 4 i miti vengono detti
beati, come eco del salmo: “I miti possederanno la terra” (sal 37, 11). Sempre
in Matteo, ma al capitolo 11, 29, Gesù stesso si autodefinisce “mite e umile di
cuore”, esempio paradigmatico per tutti gli affaticati e oppressi. E Paolo: “Un
servo del Signore deve essere mite con tutti” (2 Tm 2, 24).
Certo, mite non è l’arrendevole. Semmai è colui che sa prendere
avvenimenti e persone dal verso giusto e nei tempi giusti. Non precipita nulla,
men che meno le decisioni importanti, anche se non le rimanda all’infinito.
Non si lascia turbare da nulla: gli basta Dio come Signore. E poiché proprio in
Gesù mitezza si coniuga con umiltà, ovviamente anche per noi presbiteri non
possono che stare insieme. Se siamo umili siamo anche miti. E non
pretendiamo che gli altri siano fatti a nostra immagine e somiglianza, un
nostro clone o che ci dia sempre ragione, ma li accogliamo per quello che
sono e nella condizione, fisica, psichica e spirituale in cui si trovano, evitando
ogni forma di sbrigatezza che fa dell’altro più un oggetto di incomodo, su cui
riversare all’occorrenza i propri malumori, che una persona, confratello, da
prendere dal verso giusto, nell’ora giusta, come fa il Signore con ciascuno di
noi.
Dominio di sé. Egcrateia, in greco. Letteralmente: essere padrone di sé,
capace di esercitare il potere su di sé, temperante, moderato. Dunque
sapersi moderare in tutto. Usando di tutto ma con quella moderazione che ci
fa liberi da tutto e ci fa usare le cose per quanto servono, senza mai divenirne
sudditi e schiavi. È la capacità di mettere solidi argini agli impeti delle
passioni impulsive, che si vogliono contenere, appunto con quella virtù che si
chiama continenza o castità, che impedisce esondazioni devastanti. Sapersi
dominare e dare delle regole, nell’uso dei tempi razionalizzati, del cibo, del
divertimento, delle relazioni, delle parole… è garanzia di corretto rapporto con
le persone che favorisce notevolmente la comunione fraterna. Frutto
certamente di grande impegno personale, ma, prima di tutto e come sua
origine feconda, dell’azione dello Spirito in noi.
Così abbiamo passato in rassegna i nove frutti dello Spirito. Ci siamo
resi conto che ognuno è un trattato di teologia biblica. E che sono a grappolo
o a polittico. Uno nell’altro di cui di volta in volta è ulteriore germinazione.
Poter dire che una persona sta manifestando in grande i frutti dell’azione
dello Spirito in lei significa constatarne la santità, che altro non è se non la
forma alta della vita cristiana, nel suo produrre tutti i frutti dello Spirito. In
favore della crescita del Corpo ecclesiale di Cristo. Non a caso Paolo, pochi
versetti dopo, in Gal 6, 2 dirà: “Portate i pesi gli uni degli altri”. Come a dire:
lasciate che lo Spirito operante in voi si faccia carico, attraverso di voi, delle
condizioni di difficoltà dei fratelli.
In tal modo la comunione fraterna altro non risulta essere se non la
docilità allo Spirito Santo che è in noi.