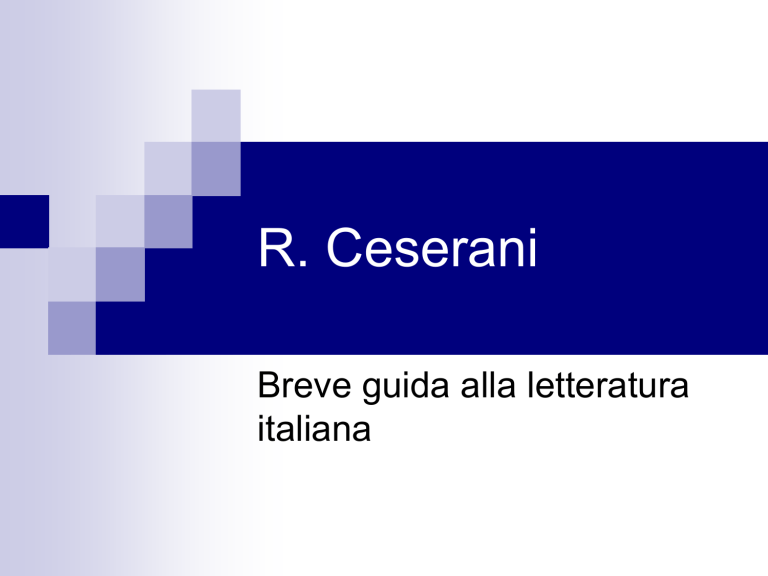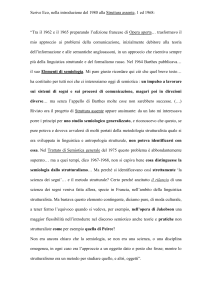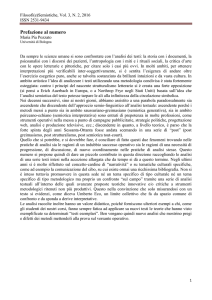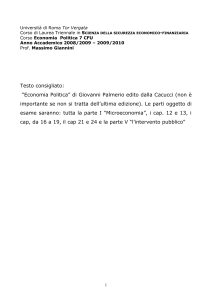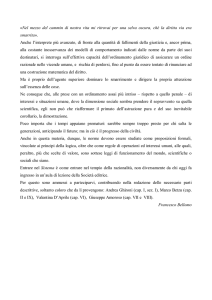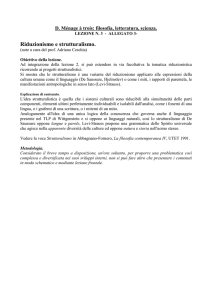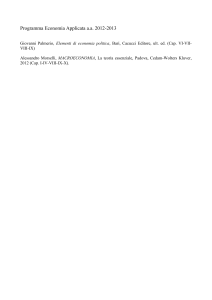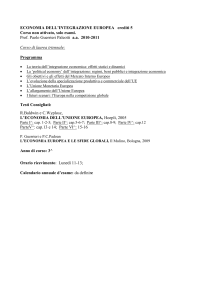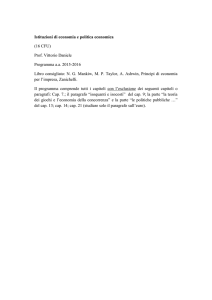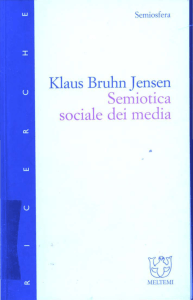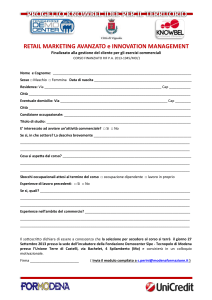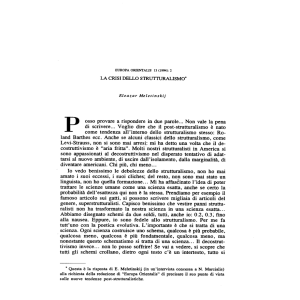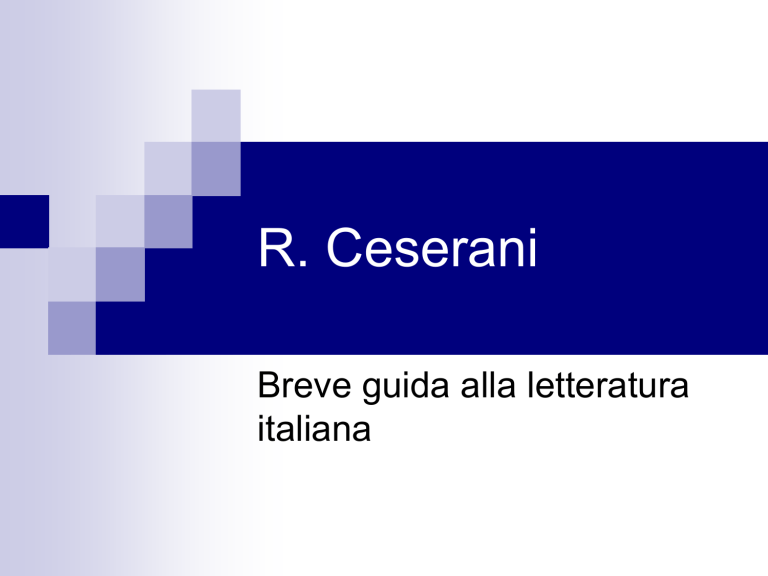
R. Ceserani
Breve guida alla letteratura
italiana
1a domanda
Cos’è la letteratura?
Letteratura come soggetto autonomo
2. Letteratura come parte del più vasto campo
della comunicazione e della realtà
1.
…risposte
Basta scorrere l’indice:
Cap.
2: testo e contesto
Cap. 3: La complessità dei testi letterari
Cap. 4: Il testo poetico
Cap. 5: il testo narrativo
Cap. 6: il testo e i lettori
Cap. 7: dimensione storica della letteratura
In altre parole:
Autore
testo
Critica letteraria
lettore
La letteratura come fenomeno complesso:
“ è proprio la molteplicità e la varietà delle
domande una delle condizioni
fondamentali per affrontare in modo non
dogmatico il fenomeno multiforme della
letteratura” (p. 12).
Due tipi di testo
“densa e intricata stratificazione di
significati”
Sperimentazione
Pubblico
e innovazione linguistica
ampio
“senza grande quantità di significati”
Strategie
retoriche e linguistiche semplici
Pubblico più ristretto
Testo e contesto
Come valore assoluto (
strutturalismo)
Ma:
Tynjanov: serie parallele (formalista)
Goldmann: omologie (sociologica)
Lotman: isomorfismi o semiosfere
(semiotica)
Lotman
“raccordi isomorfismi, fra testo e contesto
non sul piano dei contenuti o delle forme,
ma piuttosto su quello delle modalità e
delle regole che a ogni livello, nel sistema
tematico e formale del testo e nei sistemi
confinanti, organizzano le conoscenze,
facendone un insieme coerente”
Esempio:
Tasso, G.L., XII: Tancredi e Clorinda
La rappresentazione della scena finale del
duello manifesta il convergere di amore e
morte all’insegna dell’atto sessuale come
violenza e peccato
Così come nella morale dell’epoca
Struttura profonda:
Impossibilità
di soddisfare il desiderio, perché
inteso
Come peccato
Come eterodossia
Come inconciliabilità degli opposti (sulla linea
parmenideo-manichea)
La critica nell’ultimo secolo
1. Centralità dell’autore (da metà ‘800 fino
agli anni ‘20)
2. centralità del testo (fine anni ‘20- anni ‘70)
3. centralità del lettore (anni ‘70 >)
1. La centralità dell’autore
a. Autore come soggetto psicologico
b. Autore come soggetto storico
c. Autore come soggetto lirico
1.a. Soggetto psicologico
Vedi
Saint-Beuve, Charles- Augustine de
poi: psicanalisi (Freud)
1.b. Come soggetto storico
Francesco De Sanctis, Storia della
letteratura italiana, Napoli, Morano, 18701871
idealismo di sinistra
storicismo
moderno
(Sapegno, Binni)
(Muscetta, Petronio)
1.c. Come soggetto lirico
B. Croce, Estetica, Bari, Laterza, 1901
Id., La letteratura della nuova Italia, Bari,
Laterza, 1914-15.
Idealismo
concretezza
storicistica
classicismo
Mario Sansone
2. La centralità del testo
a. Circolo di Praga
b. formalismo russo
c. critica strutturalista (
d. critica stilistica
e. Narratologia
f. New Criticism
strutturalismo)
2.a. Circolo linguistico di Praga
Costituito nel 1926 da Vilém Mathesius, da
Roman Jakobson e da altri
1929 Théses du Circle Linguistique de
Prague
teoria strutturalista
2.c. strutturalismo
Origine: strutturalismo linguistico: teorie di
Ferdinand de Saussure
significante/significato
langue/parole
diacronia/sincronia
qualsiasi fenomeno culturale ha significato
entro un sistema di differenze
strutturalismo
Applicato anche a:
antropologia
(Claude Lévi-Strauss)
psicologia (Jean Piaget)
teoria sociale (matrice marxista: Louis
Althusser)
sistemi della moda (Roland Barthes)
psicanalisi (Jacques Lacan)
semantica (Greimas)
studiosi francesi, anni ‘60
Critica strutturalista
Sistema della convenzioni, analogie e
differenze vs. singole e circostanziate
occorrenze attribuibili alla natura o alla
storia
attenzione per la costituzione linguistica
del testo, la strutturazione e stratificazione
interna, le specificità di “codice”
non perché, ma come funziona un testo
Critica strutturalista in Italia
D’Arco Silvio Avalle
Umberto Eco
Cesare Segre
Maria Corti
Marcello Pagnini
Critica
semiotica
Tradizione italiana:
In realtà mai testo e contesto sono del
tutto separati
Critica
marxista (parole chiave: ideologia,
egemonia)
Si veda negli USA:
New Historicism
Cultural Studies
Tra oralità e scrittura
McLuhan:
1. Oralità: premoderno, comunità organiche
e omogenee
2. Stampa: moderno, individualismo, Stato
3. TV: villaggio globale, comunità integrata
L’oralità:
Disgiunta dalla scrittura?
Basta verificare le strutture (v. “Donna
Lombarda” o “Cenerentola”)
Dall’oralità alla scrittura:
Il problema del testo: la filologia
Dalla scrittura alla lettura:
L’interpretazione
Stilistica
Strutturalistica
e semiotica
Decostruzionista
tematica
psicoanalitica